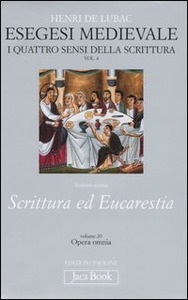
GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana".
mercoledì 2 maggio 2007."CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16).
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- THE CLOISTERS (MANHATTAN): LA TEOLOGIA DELL’INCARNAZIONE NELLA ANNUNCIAZIONE DEL TRITTICO DI MERODE (ROBERT CAMPIN, 1425).
- GIUSEPPE dà a suo Figlio, GESÙ (= "Dio" salva), il NOME del Suo "Dio", e Gesù rivela che il Nome di "Dio" è "Amore" (Agape, Charitas)!!!
Un incontro e un dialogo:
 Come ti chiami?
Come ti chiami?
 Gesù.
Gesù.
 Gesù?!
Gesù?!
 E di "Chi" sei figlio?
E di "Chi" sei figlio?
 Sono figlio dell’Amore di Maria e di Giuseppe.
Sono figlio dell’Amore di Maria e di Giuseppe.
 Ma chi ha deciso di chiamarti così?
Ma chi ha deciso di chiamarti così?
 Il mio papà, Giuseppe (Mt. 1, 18-25!!!).
Il mio papà, Giuseppe (Mt. 1, 18-25!!!).
 Cosa significa il tuo Nome?
Cosa significa il tuo Nome?
 Significa “Amore salva”, cioè che l’Amore di due persone, Maria e Giuseppe, mi ha salvato!
Significa “Amore salva”, cioè che l’Amore di due persone, Maria e Giuseppe, mi ha salvato!
 E’ bellissimo! Bene! Grazie e buona giornata!
E’ bellissimo! Bene! Grazie e buona giornata!
 Buona giornata!
Buona giornata!
GESU’:
E VOI "CHI" DITE CHE "IO SONO"?!
ET VOUS QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS?!
Pietro:
"Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo"
GESÙ:
"Beato sei tu, Simone figlio di Giona, poiché non è la carne né il sangue che ti hanno fatto questa rivelazione, ma il Padre mio che sta nei cieli" - AMORE (Agape, Charitas).
- Marta: Io credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio.
- In quel tempo, molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?».
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?».
 Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gv 11,19-27
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gv 11,19-27
- "Signore, insegnaci a pregare" (Lc., 11.1)
 O AMORE,
O AMORE,
 SPIRITO SANTO,
SPIRITO SANTO,
 PADRE NOSTRO,
PADRE NOSTRO,
 CHE SEI NEI CIELI,
CHE SEI NEI CIELI,
 SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,
 VENGA IL TUO REGNO,
VENGA IL TUO REGNO,
 SIA FATTA LA TUA VOLONTA’
SIA FATTA LA TUA VOLONTA’
 COME IN CIELO COSI’ IN TERRA.
COME IN CIELO COSI’ IN TERRA.
 TU CI DAI OGGI IL NOSTRO PANE PIU’ SOSTANZIOSO,
TU CI DAI OGGI IL NOSTRO PANE PIU’ SOSTANZIOSO,
 E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
 COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI.
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI.
 TU NON CI INDUCI IN TENTAZIONE
TU NON CI INDUCI IN TENTAZIONE
 MA CI LIBERI DAL MALE.
MA CI LIBERI DAL MALE.
 COSI E’: COSI SIA.
COSI E’: COSI SIA.
 AMEN.
AMEN.
GESÙ:
E TU "CHI" DICI CHE IO SONO?
IO: "JE SUiS ... "CHRETIEN" - Io sono ... christiano, non "CRETIN"O ... e non "cattolico- romano"!!! Non sono un figlio di "mammasantissima"!!! Il tuo messaggio è un buon-messaggio (eu-angélo) per me, per mia madre "Maria" e mio padre "Giuseppe", e per tutto il mio il prossimo, non un messaggio (V-an-gélo) - venduto a "caro-prezzo" ("caritas") - di Violenza e di Vittoria su mio padre "Giuseppe" e su tutto il prossimo, considerato un nemico, da van-gelizzare e mandare all’inferno: Va-n-gélo!!!
Federico La Sala
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
- UN’ANTROPOLOGIA "EDIPICA", ZOPPA E CIECA. IN NOME DI GESU’, FIGLIO DEL "DIO" DI MARIA (- E GIUSEPPE?!), SOLO GLI "UOMINI" POSSONO ESSERE "SACERDOTI", NON LE "DONNE":
- "Grazie a te, donna-consacrata, che sull’esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all’amore di Dio, aiutando la Chiesa e l’intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta “sponsale”, che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura" (Giovanni Paolo II, Lettera alle Donne,1995, n. 2).
- MARIA NELLA COMUNITÀ UMANA: «NUOVA EVA»(Domenico Bertetto)
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- THE CLOISTERS (MANHATTAN): LA TEOLOGIA DELL’INCARNAZIONE NELLA ANNUNCIAZIONE DEL TRITTICO DI MERODE (ROBERT CAMPIN, 1425).
Perche’ non possiamo non dirci "cristiani", e non cretini!!! Lettera a L’Unità
di Federico La Sala *
Caro Direttore
devo dirlo (e spero che la cosa sia accolta con attenzione) ma anche sul sillogismo di Pera ( «La separazione fra Stato e religione non può essere una cesura [dunque non ci può essere separazione, ndr]. Lo Stato moderno e democratico si fonda sempre su principi etici. Dunque i valori cristiani non possono essere relegati in un ghetto. Ciò spiega ciò che è capitato a Rocco Buttiglione» Marcello Pera, Presidente del Senato, 15 ottobre), l’Unità ha preso un’altra cantonata. Pera sbaglia (come Buttiglione), ma il ragionamento non è sbagliato - ci rifletta tre secondi!
Il problema esiste (e togliamo il monopolio del tema ai gerarchi degli integralisti di tutto il mondo - basta con la colonizzazione del cielo, anche in senso metaforico)! Già dall’ ’89 (tanto per porre un termine), il confine tra Stato e religione era saltato.... e noi continuiamo a non capire! La Svolta di Salerno era su questa strada ... e ne sapeva di più Togliatti e il vecchio Pci!
Se vogliamo che la democrazia viva non possiamo non ripensare la questione di "Dio" e - oltre Croce - non possiamo non dirci "cristiani", non cretini! E’ in gioco l’idea stessa di cittadino sovrano e cittadina sovrana!
Basta con l’opposizione speculare e la dipendenza dalla Chiesa Cattolica! Riprendere la strada di Kant e del coraggio di pensare: usciamo dallo stato di minorità ... e del risentimento!
Nessun essere umano sulla Terra è senza "padre" e senza "madre"(non accechiamoci - ricordiamo Edipo e Freud!!!) - tutti e tutte siamo figli e figlie dell’ Unità e dell’Unione di due esseri umani sia sul piano biologico (e la famiglia non è - riduttivamente - una "società naturale", come continua a predicare il Papa e la Chiesa cattolica Romana!) sia (cosa ancor più decisiva) sul piano culturale (= costituzionale!!!). Ripartiamo da qui.... e ricominciamo a contare!!!
*IL DIALOGO, Mercoledì, 20 ottobre 2004
 LASCIATEMI ANDARE ANCHE QUESTO E’ AMORE!!!
LASCIATEMI ANDARE ANCHE QUESTO E’ AMORE!!!
Sulla "risposta", per approfondimenti, sul sito, cfr.:
 DEPORRE LE ARMI. UNA LETTERA DEL 2002
DEPORRE LE ARMI. UNA LETTERA DEL 2002
 BASTA CON LA "MALA-EDUCAZIONE"!!!
BASTA CON LA "MALA-EDUCAZIONE"!!!
 "DEUS CARITAS EST". RETTIFICARE I NOMI
"DEUS CARITAS EST". RETTIFICARE I NOMI
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).
- LA "COMPAGNIA DELLA CHARITA’ dei cortigiani"! Sul tema, cfr. Adriano Prosperi, "Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari", Einaudi, Torino, 1996, tutto il "Capitolo primo. La fede italiana", pp. 16-34.
 L’EU-ANGELO E’ LA PAROLA DELLA PACE E PER LA PACE ... NON PER LA GUERRA E LE CROCIATE!!!
L’EU-ANGELO E’ LA PAROLA DELLA PACE E PER LA PACE ... NON PER LA GUERRA E LE CROCIATE!!!
 DONNE, UOMINI, E VIOLENZA. PARLIAMO DI "FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI, E VIOLENZA. PARLIAMO DI "FEMMINICIDIO".
 IL PROGRAMMA DI KANT. LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA.
IL PROGRAMMA DI KANT. LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA.
 "NUOVA ALLEANZA"?!: RESTITUIRE L’ANELLO A GIUSEPPE!!!
"NUOVA ALLEANZA"?!: RESTITUIRE L’ANELLO A GIUSEPPE!!!
- CARMELITANI SCALZI ED ECUMENISMO: STORIA E MEMORIA. -Ritrovato nel salernitano "file" perduto del tardo Rinascimento
- L’eletto - Thomas Mann: "Edipo Papa. Il regno di Edipo è di questa terra, ma può diventare anche quello dei cieli. Se allo sconosciuto padre terreno si sostituisce il Padre onnipotente che ha bisogno di un grande figlio perché lo rappresenti nel mondo" (Lea Ritter Santini, Introduzione, Oscar Mondadori 1979).
 PER L’ITALIA, "DUE SOLI". Per una "sana laicità", un sano cristianesimo!!!
PER L’ITALIA, "DUE SOLI". Per una "sana laicità", un sano cristianesimo!!!
Federico La Sala
Forum
-
>STORIA DELL’ARTE E ANTROPOLOGIA HAMLETICA: IL "PRESEPE" DELLO "STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE) NON PIACE! LA "MADONNA DELLA GATTA" DI FEDERICO BAROCCI E LA "TRAPPOLA PER TOPI" ("THA MOUSETRAP") DI "AMLETO"22 luglio 2024, di Federico La Sala
TEATRO METATEATRO E SERENDIPITY:
UNA SORPRENDENTE LEZIONE DI FILOLOGIA HAMLETICA
SULLE RAGIONI DEL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE)!
- Una nota di commento in omaggio all’anima profetica ("prophetic soul") di Salvo Salvatore Micciché, un invito a rileggere l’#Amleto, e un grande "grazie" a Les Chatons Romantiques *
Il #gatto, una vera e propria "#trappola per #topi" ("The mousetrap"), ne ha mangiati tanti di "gatti", che ora non riesce più a "funzionare", nemmeno a muoversi, e dorme solo dalla mattina alla sera, e per tutta la notte, davanti allo #specchio!
- NOTA: AD "AMLETO", IL "PRESEPE" DELLO "STATO DI DANIMARCA" NON PIACE! SHAKESPEARE, IL MOSCHETTIERE DELL’ INGHILTERRA DELLA REGINA #ELISABETTA).
NOTE:
- ANTROPOLOGIA HAMLETICA, FILOSOFIA E STORIA DELL’ARTE. LA "MADONNA DELLA GATTA" di Federico Barocci (Urbino 1528/1535 - 30 settembre 1612): "Visita di Sant’Elisabetta, con San Giovanni Battista e San Zaccaria, alla Madonna col Bambino e San Giuseppe, detta "Madonna della gatta" (Galleria degli Uffizi).
- ENIGMI D’ARTE. Federico Barocci e il mistero della Madonna della Gatta" (Redazione "StileArte", 27 NOVEMBRE 2018).
-
> MA CHI ERA COSTUI?! --- SHAKESPEARE, LA DOMANDA (LA "QUESTION") DI "AMLETO", E E IL CASO DEL "PIFFERARIO" DELLO "STATO DI DANIMARCA".8 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, STORIA, E METATEATRO (SHAKESPEARE).
"THE MOUSETRAP" ("LA TRAPPOLA PER TOPI") DI "AMLETO" E IL CASO DEL "PIFFERARIO" DELLO "STATO DI DANIMARCA".
"SAPERE AUDE!" (Q. ORAZIO F. ; KANT, 1784; M. FOUCAULT, 1984). AL DI LA’ DEL MACHIAVELLISMO E DELL’ #ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO PLATONICO-PAOLINO, a mio parere, ciò che resta del "discorso filosofico della #modernità" (J. Habermas), come ha riepilogato Kant alla fine del suo lungo lavoro di critica delle pretese della "olimpica" #ragione "pura", è proprio quanto indicava quel "Socrate pazzo" di Diogene ("Amleto"): la domanda antropologica, vale a dire il gioco del "gatto" e del "topo" (Shakespeare, "Hamlet", III. 4. 203-212), la questione "hamletica" del "come nascono i bambini" (e non solo)!
NOTE:
- STORIA FILOSOFIA E LETTERATURA: "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (GALILEO, 1632).
 RICONSIDERARE #UmaNA-MENTE, ANTROPOLOGICA-#MENTE, "LA NOSTRA #SEMENZA" (INF. XXVI, 118) E PORTARSI AL DI LA’ DEL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE), FUORI DALL’ #INFERNO EPISTEMOLOGICO, E RIPRENDERE LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO A #GALILEOGALILEI, 1611).
RICONSIDERARE #UmaNA-MENTE, ANTROPOLOGICA-#MENTE, "LA NOSTRA #SEMENZA" (INF. XXVI, 118) E PORTARSI AL DI LA’ DEL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE), FUORI DALL’ #INFERNO EPISTEMOLOGICO, E RIPRENDERE LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO A #GALILEOGALILEI, 1611).
- STORIA FILOSOFIA E LETTERATURA: "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (GALILEO, 1632).
-
> GESÙ, IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA! ----IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS: UN PROBLEMA DI LEGALITA’. Con Aristotele, Dante, e Shakespeare, oltre la tragedia.19 giugno 2024, di Federico La Sala
"SHAKESPEARE GLOBE", ELIOCENTRISMO, E "RIVOLUZIONE COPERNICANA" (KANT): FILOSOFIA (GIUSTIZIA - LOGOS), CRISTIANESIMO (AMORE - "AGAPE"), E CATTOLICESIMO (NICEA 325 -2025). Con (Parmenide ed Eraclito e) Aristotele, oltre: "In principio era il Logos" (Gv. I.1) - non un Logo.
- Una nota di commento a margine della "pretesa" di confinare l’opera di #Shakespeare (come di #Dante Alighieri) nella interpretazione e tradizione "cattolico-paolina" del messaggio evangelico.
- Un omaggio al lavoro in progress di Paul Adrian Fried ("Patrick Grey on Shakespeare, Christianity, and Aristotle’s Poetics" - June 18, 2024).
PREMESSO CHE la #question #hamletica è storica e storiografica e che, per comprendere il lavoro di Shakespeare, forse, è opportuno pensare il rapporto tra "Shakespeare, Christianity, and Aristotele’s Poetics" all’interno di un contesto europeo segnato dalla Riforma Protestante, dalla Riforma Anglicana, e dell’attacco cattolico-spagnolo all’Inghilterra della Regina e Papessa, Elisabetta I, figlia di Enrico VIII, e dalla Rivoluzione astronomica e scientifica, aperta dall’opera di Copernico, e rilanciata alla grande da Tommaso Campanella e da Giordano Bruno, condannato come eretico e bruciato sul rogo (17 febbraio 1600).
CONSIDERANDO IL CONTRIBUTO (ASSOLUTAMENTE "MODERNO", COME HA SCRITTO UNA VOLTA LO STORICO DELLA FILOSOFIA GILSON) DEL COSIDDETTO #MEDIOEVO DELLA "PRIMA #RINASCITA" (GRAZIE A FRANCESCO D’ASSISI, GIOACCHINO DA FIORE, E DANTE ALIGHIERI) E IL RAPPORTO DI DANTE CON "IL #MAESTRO DI COLOR CHE SANNO" (Inf. IV, 131), c’è da dire e da pensare che tra Aristotele e Shakespeare (come con lo stesso Dante) c’è molta amicizia, nello spirito dell’antico e nuovo Logos (e non del #Logo di una azienda personale).
NEL PORRE AL CENTRO DELL’#AMLETO la questione antropologica (e cristologica), Shakespeare pone "aristotelicamente" un problema di #legalità e di #giustizia e di #verità: la #critica al "nuovo" Re e Padre, che è un impostore, un mentitore, e un assassino, e l’introduzione nell’opera teatrale moderna (lo stesso "Hamlet") di un’opera teatrale "aristotelica", "The Mousetrap" ("La trappola per topi"). La Rivoluzione inglese è già iniziata...
SCIOLTO QUESTO NODO E, DANDO A SHAKESPEARE CIO’ CHE DI SHAKESPEARE E DI ARISTOTELE CIO’ CHE E DI ARISTOTELE, e, ancora, chiarito che il principe "Amleto" è figlio del "Re Amleto" e della "Regina Gertrude", si può senz’altro condividere l’opinione che "[...] for Aristotle, tragedy is amoral: it’s like the process of legal discovery that occurs in a court of law." (Patrick Grey).
NOTA:
- STORIA E STORIOGRAFIA: "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929). DOPO DUEMILA ANNI E PIU’ IN COMPAGNIA DEL "#CATTOLICESIMO-ROMANO", “Sembra che una gran malinconia si sia impossessata in tutti i popoli del #Mediterraneo” (S. Freud," L’uomo Mosè e la religione monoteistica, 1939).
-
> GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. --- "LA GINESTRA" RICORDA LA SCELTA (Gv. III, 19): GIACOMO LEOPARDI, NELL’ORIZZONTE COPERNICANO DI KANT E DI FREUD.15 giugno 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, STORIA E LETTERATURA, E (DISAGIO DELLA) CIVILTA’: GIACOMO LEOPARDI, NELL’ORIZZONTE COPERNICANO DI KANT E DI FREUD. Una nota a sua memoria...
RICORDARE che Giacomo Leopardi (Recanati, 29 giugno 1798 - Napoli, 14 giugno 1837 ), a introduzione del testo della "Ginestra o il fiore del deserto" (1836), abbia premesso le parole riprese dall’evangelo di Giovanni (III,19) "Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἂνθρωποι/ μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς ("E gli uomini amarono/ piuttosto le tenebre che la luce" (Giovanni III, 19), è una valutazione radicale di denuncia della scelta fatta.
 Il "giudizio" della "lenta ginestra" sull’umanità che ha amato (v. "ἠγάπησαν") le tenebre e non la luce, dice di una #negazione dell’ ἀγάπη, dello stesso «amore» cristiano, che in qualche modo richiama le considerazioni fatte da Kant nella "Fine di tutte le cose" ) e, al contempo, anche le riflessioni di Freud sulla svolta data da Paolo di Tarso nella "gestione" del messagio evangelico: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).
Il "giudizio" della "lenta ginestra" sull’umanità che ha amato (v. "ἠγάπησαν") le tenebre e non la luce, dice di una #negazione dell’ ἀγάπη, dello stesso «amore» cristiano, che in qualche modo richiama le considerazioni fatte da Kant nella "Fine di tutte le cose" ) e, al contempo, anche le riflessioni di Freud sulla svolta data da Paolo di Tarso nella "gestione" del messagio evangelico: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).NOTE:
- MEMORIA E POESIA: LA GINESTRA. "La ginestra o Il fiore del deserto è la penultima lirica di Giacomo #Leopardi, scritta nella primavera del 1836 a Torre del Greco nella villa Ferrigni e pubblicata postuma nell’edizione dei Canti nel 1845. [...]".
- Storia dell’#astronomia dalle orgini al duemila e oltre (di Leopardi Giacomo, Hack Margherita )
-
> GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- FILOLOGIA E ARCHITETTURA ANTROPOLOGICA: "APRIRE GLI OCCHI" (S. FREUD, 1899), PER CARITÀ.6 marzo 2024, di Federico La Sala
EPOCALISSE: "APRIRE GLI OCCHI" (S. #FREUD, 1899), PER #CARITÀ! #FILOLOGIA E #ARCHITETTURA FILOSOFICA E ANTROPOLOGICA (#KANT2024).
#DANTEDI’, 25 MARZO 2024: UNA NOTA SULLA TRASVALUTAZIONE STORICA DELLA "VIOLENTA CARITÀ" ("VIOLENTAE CHARITATIS") DI RICCARDO DI SAN VITTORE.
STORIA E LETTERATURA. Nel bimillenario percorso planetario del #cattolicesimo romano (#Nicea 325-2025), la "#diritta via" (#Dante Alighieri) del filologico legame significante e significato tra il luogo dell’#amore e il luogo dell’#occhio ("Ubi amor, ibi oculus") è stata smarrita insieme con l’#acca ("h").
Incredibilmente, e inauditamente, l’amore, la #charitas dello stesso #Riccardo di San Vittore ("Riccardo /che a considerar fu più che #viro", più che uomo, come scrive Dante nel X del "Paradiso") è diventata la parola-chiave della teologia della ricchezza materiale e spirituale: la "caritas", senza più "h", senza più l’acca, è diventata semplicemente #Mammona, il dio ("#Deus #caritas est") dell’#economia mondiale, garante del "buon-andamento" del #carro delle borse e del #caro-prezzo del #mercato: la religione del #capitalismo, vecchio e nuovo (come aveva capito Karl #Marx, #WalterBenjamin, e, ovviamente, #DanteAlighieri).
-
> LA SACRA FAMIGLIA (E IL MATRIMONIO DI GIUSEPPE E MARIA) E UN IMPORTANTE "SVILUPPO" PASTORALE DELLA "MADRE CHIESA": LA DECISIONE DI PAPA FRANCESCO DI APPROVARE LA "FIDUCIA SUPPLICANS".19 dicembre 2023, di Federico La Sala
Documento vaticano.
Coppie “di fatto” e dello stesso sesso, sì alla benedizione
 Con “Fiducia supplicans” del Dicastero per la Dottrina della Fede, approvata dal Papa, possibile benedire coppie formate da persone dello stesso sesso ma al di fuori di qualsiasi ritualizzazione
Con “Fiducia supplicans” del Dicastero per la Dottrina della Fede, approvata dal Papa, possibile benedire coppie formate da persone dello stesso sesso ma al di fuori di qualsiasi ritualizzazionedi Luciano Moia (Avvenire, lunedì 18 dicembre 2023)
Sul tema delle benedizione per le coppie irregolari o dello stesso sesso «non si debbono aspettare altre risposte su eventuali modalità per normare dettagli o aspetti pratici». La Dichiarazione firmata oggi dal cardinale Fernandez va intesa insomma come la parola finale sulla questione e va considerata come sufficiente «per orientare il prudente e paterno discernimento dei ministri ordinati a tal proposito». Una sottolineatura importante, quella indicata nel documento del Dicastero per la dottrina della fede. Quanto espresso in questo testo dev’essere considerato sufficiente, sia dal punto sostanziale, sia da quello formale.
 E qui le coordinate sono esplicite: nessuna forma rituale propria della liturgia, ma preghiere spontanee con benedizioni impartite in contesti “non ufficiali”, come durante un pellegrinaggio, una visita ad un santuario, un incontro con un sacerdote, cogliendo il meglio «dalle viscere della pietà popolare» che sa individuare le strade più opportune per «invocare lo Spirito Santo».
E qui le coordinate sono esplicite: nessuna forma rituale propria della liturgia, ma preghiere spontanee con benedizioni impartite in contesti “non ufficiali”, come durante un pellegrinaggio, una visita ad un santuario, un incontro con un sacerdote, cogliendo il meglio «dalle viscere della pietà popolare» che sa individuare le strade più opportune per «invocare lo Spirito Santo».Non si tratta di una “semplice ripetizione” di quanto già detto all’inizio di ottobre, prima dell’avvio del Sinodo. La Dichiarazione sul senso pastorale delle benedizioni per le coppie irregolari e dello stesso sesso,
Dietro al nuovo testo c’è insomma una «riflessione teologica basata sulla visione pastorale di papa Francesco» che «implica un vero e proprio sviluppo rispetto a quanto è stato detto sulle benedizioni nel Magistero e nei testi ufficiali della Chiesa». È sulla parola “sviluppo” che dobbiamo soffermarci per comprendere il senso delle nove pagine firmate dal prefetto del Dicastero, il cardinale Victor Manuel Fernandez, e «approvate con la sua firma» dal Papa.
Uno “sviluppo” che ci fa comprendere, più sul piano pastorale che su quello dottrinale, che è possibile benedire le coppie in situazioni irregolare e le coppie dello stesso sesso «senza convalidare ufficialmente il loro status o modificare in alcun modo l’insegnamento perenne della Chiesa sul matrimonio».
Una contraddizione? Tutt’altro. Dietro questo ragionamento c’è un percorso coerente avviato da papa Francesco già nei due Sinodi sulla famiglia e poi nell’Esortazione Amoris laetitia: «Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo. Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino» (AL 297).
Quindi, se l’obiettivo è quello di “integrare tutti”, di aiutare ciascuno «a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale», è evidente che - come si legge nel nuovo documento - vanno accolti tutti coloro che adorano «il Signore con tanti gesti di profonda fiducia nella sua misericordia e che con questo atteggiamento viene costantemente a chiedere alla madre Chiesa una benedizione».
Un punto fermo che dovrebbe apparire esplicito alla luce del magistero di papa Francesco e, soprattutto, ai principi del Vangelo ma che, ammette il cardinale Fernandez, «ha suscitato non poche e diverse reazioni» quando è stato sintetizzato nel precedente Responsum ad dubium. «Alcuni hanno accolto con plauso la chiarezza di questo documento e la sua coerenza con il costante insegnamento della Chiesa», ma altri non hanno condiviso o non l’hanno ritenuto sufficientemente chiara. Da qui la necessità di una “seconda puntata” per entrare meglio nel dettaglio della questione e illustrare con più ampiezza il pensiero del Papa.
Proprio per evitare fraintendimenti il testo mette subito in chiaro che l’obiettivo non è quello di far confusione tra il matrimonio tra uomo e donna e altri tipi di unione. Il matrimonio è un sacramento che prevede un’unione «esclusiva, stabile e indissolubile tra un uomo e una donna, naturalmente aperte a generare figli». E su questo punto la dottrina resta ferma.
Altra cosa è la benedizione, considerata «tra i sacramentali più diffusi» - non sacramenti - gesti cioè che ci conducono «a cogliere la presenza di Dio in tutte le vicende della vita» e hanno per destinatari «persone, oggetti di culto e di devozione, immagini sacre, luoghi di vita, di lavoro e di sofferenza, frutti della terra e della fatica umana, e tutte le realtà create che rimandano al Creatore le quali, con la loro bellezza, lo lodano e lo benedicono».
A questo punto la grande domanda. L’amore di una coppia irregolare o dello stesso sesso rimanda al Creatore? Può diventare inno di lode e di benedizione? Finora la risposta della Chiesa è sempre stata negativa, perché - ribadisce il documento - ha da sempre «considerato moralmente leciti soltanto quei rapporti sessuali che sono vissuti all’interno del matrimoni».
Il discorso si sarebbe potuto chiudere qui se l’insegnamento di papa Francesco, ripreso nella Dichiarazione del cardinale Fernandez, non ampliasse il senso della benedizione, sollecitando quello sviluppo innovativo che riflette l’impegno di una Chiesa davvero in uscita, attenta a cogliere e a sostenere la fatica di tutte le periferie esistenziali.
Quindi una benedizione subordinata a «troppi prerequisiti di carattere morale» - come quelli previsti per un sacramento - finirebbe per porre in ombra «la forza incondizionata dell’amore di Dio», quando proprio papa Francesco «ci ha esortato a “non perdere la carità pastorale che deve attraversare tutte le nostre decisioni e atteggiamenti” ed evitare di “essere giudici che solo negano, respingono, escludono”».
Ecco allora la necessità - come appunto fa la Dichiarazione - di ripercorrere le benedizioni secondo la voce della Scrittura per andare a cogliere quelle numerose ed esplicite tracce di misericordia divina che ci fanno riconoscere il gesto di benedire come «dono sovrabbondante e incondizionato». E questo, secondo la ricognizione sintetizzata nel documento, è vero sia nell’Antico sia nel Nuovo Testamento dove la benedizione non è soltanto ascendente «in riferimento al Padre», ma anche discendente «riversata sugli altri come gesto di grazia, protezione e bontà».
 Ecco perché la benedizione dev’essere intesa anche come messaggio di «inclusione, solidarietà e pacificazione», ma anche di «conforto, custodia e incoraggiamento che esprime l’abbraccio misericordioso di Dio e la maternità della Chiesa e che invita il fedele ad avere gli stessi sentimenti di Dio verso i propri fratelli e sorelle». Nessuno escluso. Opportuno ribadirlo.
Ecco perché papa Francesco sollecita a comprendere il senso della benedizione come «risorsa pastorale da valorizzare» piuttosto che come rischio e problema anche per le coppie irregolari e per quelle dello stesso sesso. L’importante è, appunto, evitare confusioni con il sacramento del matrimonio.
Ecco perché la benedizione dev’essere intesa anche come messaggio di «inclusione, solidarietà e pacificazione», ma anche di «conforto, custodia e incoraggiamento che esprime l’abbraccio misericordioso di Dio e la maternità della Chiesa e che invita il fedele ad avere gli stessi sentimenti di Dio verso i propri fratelli e sorelle». Nessuno escluso. Opportuno ribadirlo.
Ecco perché papa Francesco sollecita a comprendere il senso della benedizione come «risorsa pastorale da valorizzare» piuttosto che come rischio e problema anche per le coppie irregolari e per quelle dello stesso sesso. L’importante è, appunto, evitare confusioni con il sacramento del matrimonio.Ecco perché papa Francesco sollecita a comprendere il valore della benedizione come “risorsa pastorale da valorizzare” piuttosto che come rischio e problema anche per le coppie irregolari e per quelle dello stesso sesso.
L’importante è, appunto, evitare confusioni con il sacramento del matrimonio. Opportuna quindi una benedizione non ritualizzata per evitare di confonderla con un atto liturgico o semi-liturgico, che «priverebbe i ministri della libertà e della spontaneità nell’accompagnamento pastorale della vita delle persone». Per questa ragione non si deve promuovere né prevedere «un rituale per le benedizioni di coppie in una situazione irregolare, ma non si deve neppure impedire o proibire la vicinanza della Chiesa ad ogni situazione in cui si chieda l’aiuto di Dio attraverso una semplice benedizione».
Cosa chiedere quindi nella breve preghiera che precede la benedizione? «La pace, la salute, uno spirito di pazienza, dialogo e aiuto vicendevole, ma anche la luce e la forza di Dio per poter compiere pienamente la sua volontà».
 E se, sempre con il proposito di evitare confusioni, vanno evitati «abiti, gesti e parole propri di un matrimonio», non bisogna mai dimenticare che «ricevere una benedizione può essere il bene possibile in alcune situazioni» e che «ogni fratello e ogni sorella potranno sentirsi nella Chiesa sempre pellegrini, sempre mendicanti, sempre amati e, malgrado tutto, sempre benedetti».
E se, sempre con il proposito di evitare confusioni, vanno evitati «abiti, gesti e parole propri di un matrimonio», non bisogna mai dimenticare che «ricevere una benedizione può essere il bene possibile in alcune situazioni» e che «ogni fratello e ogni sorella potranno sentirsi nella Chiesa sempre pellegrini, sempre mendicanti, sempre amati e, malgrado tutto, sempre benedetti». -
> GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- STORIA DELL’ARTE: DUE NOTE A MARGINE DELLA TRADIZIONE ICONOGRAFICA DEL BASTONE FIORITO DI SAN GIUSEPPE E DEL TEMA DELL’ANNUNCIAZIONE.11 novembre 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI ("INTERPRETAZIONE DEI SOGNI"), E LETTERATURA ("IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI").
DUE NOTE A MARGINE DELLA TRADIZIONE ICONOGRAFICA DEL BASTONE FIORITO DI SAN GIUSEPPE E DEL TEMA DELL’ANNUNCIAZIONE NELLA STORIA DELL’ARTE:
A. - LA STORIA DI UN’ANTICA MEMORIA CARMELITANA PROVENIENTE DAL SUSSEX...
"Bastone fiorito di San Giuseppe venerato a Napoli": [....] Sulla collina di San Potito a Napoli la Congregazione di San Giuseppe dei Nudi detiene una collezione di reliquie unica in Italia. Tra queste, la più importante si trova in un una bella teca di legno cedrino: il bastone fiorito appartenuto a san Giuseppe. Secondo la tradizione Giuseppe, come altri pretendenti (ciascuno munito di una verga), aveva chiesto a Dio un segno su chi dovesse sposare la Vergine Maria, e proprio il bastone di Giuseppe germogliò e fiorì miracolosamente. Venerato da quasi tre secoli, il bastone-reliquia è stato rubato in un convento di padri carmelitani del Sussex, in Inghilterra, dove si trovava esposto fin dal XIII secolo. Alla fine la reliquia si è fermata a Napoli nel 1712 come dono al cantante d’opera Giuseppe Grimaldi, detto Nicolino. Quest’ultimo acconciò a casa propria l’esposizione del bastone per la pubblica venerazione a partire dal 1714. Il 17 gennaio 1795, la reliquia fu definitivamente trasferita nella chiesa di San Giuseppe dei Nudi. (cfr. Marzena Wilkanowicz-Devoud, "Dove si trovano le reliquie di san Giuseppe?", Aleteia, 09.06.2021).
B - VITA E POESIA: LA NASCITA DI UN ESSERE UMANO. Un bastone fiorito in generale sembra plausibile, e particolarmente adatta al contesto di un’ Annunciazione? Certamente! A mio parere, tutto il tradizionale storico contesto iconografico sul tema dell’Annunciazione appare chiaramente collegato alla figura di Giuseppe e alla cosiddetta "radice Iesse" (Is., 11:1), all’albero di Jesse, alla "Casa di Davide" ("De Domo David") della tradizione ebraica e, al contempo, al senso stesso del messaggio evangelico ("eu-angelico"), al problema di tutti i problemi, al come nascono gli esseri umani, al "come nascono i bambini: vale a dire, alla lezione di Francesco di Assisi (1223), al presepe e alle sue figure fondamentali, memoria di Adamo ed Eva - e Caino, di Giuseppe e Maria - e Gesù.
- P. S. - Kafka: "[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" (F. Kafka, Lettera a Helli Hermann, autunno 1921).
-
> GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- UNA LEZIONE DI ANTROPOLOGIA CRISTOCENTRICA: Giovanni Paolo II ha insegnato a non aver paura di dirsi cristiani (di Giovanni Battista Re).20 ottobre 2023, di Federico La Sala
PER UN’ANTROPOLOGIA E UNA TEOLOGIA CRISTIANA, OLTRE LA COSMOTEANDRIA "CATTOLICO-COSTANTINIANA" (NICEA 325-2025) *
Il 16 ottobre di 45 anni fa l’elezione di san Giovanni Paolo II
Ha insegnato a non aver paura di dirsi cristiani
[di Giovanni Battista Re (L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023
Il 16 ottobre di 45 anni fa, ero sulla terrazza della Segreteria di Stato quando il cardinale Pericle Felici, dopo la fumata bianca, annunciò il nome del nuovo Papa: Karol Wojtyła. Monsignor Agostino Casaroli (divenuto cardinale l’anno dopo), che era lì con noi, commentò: «Che coraggio hanno avuto i cardinali, scegliendo un arcivescovo di un Paese oltre la “cortina di ferro”! Che coraggio!».
Circondammo tutti monsignor Casaroli, facendogli domande, mentre aspettavamo che il nuovo Papa si affacciasse al balcone della basilica Vaticana.
Ci rispose: è una personalità forte e affascinante per le tante sue doti, ma mai avevo pensato all’eventualità che il nuovo Papa potesse venire da oltre la “cortina di ferro”.
A 45 anni di distanza, il lungo pontificato di Giovanni Paolo II colpisce per la vastità e la grandiosità delle opere realizzate, per il grande numero di eventi e di iniziative, per il consenso ottenuto e per ciò che la sua guida spirituale e morale ha rappresentato per oltre un quarto di secolo.
Papa Wojtyła tuttavia ha stupito non solo per quello che ha fatto, ma anche per l’amore che lo animava e il desiderio che aveva di aiutare tutti nella ricerca di Dio e nel far crescere nel mondo il rispetto dei diritti umani, la fraternità e la solidarietà.
San Giovanni Paolo II è stato una personalità fuori dall’ordinario, un Papa che si è inserito nel solco della tradizione della Chiesa con un innegabile timbro di novità, ma anche di piena fedeltà alla dottrina che viene dagli apostoli.
Non possiamo non riconoscere che la Divina Provvidenza gli ha assegnato grandi compiti nella storia mondiale del suo tempo.
- Uomo di Dio
San Giovanni Paolo II è stato innanzi tutto un grande uomo di Dio, animato da una fede incrollabile.
La prima e fondamentale dimensione del suo pontificato è stata quella religiosa. Il movente dell’intero suo pontificato, il centro ispiratore dei suoi pensieri e di tutte le sue iniziative è stato di natura religiosa: tutti gli sforzi del Papa miravano ad avvicinare gli uomini a Dio e a fare rientrare Dio da protagonista in questo mondo. Voleva che in questo nostro mondo vi fosse ancora posto per Dio.
Il vibrante appello pronunciato nella sua prima celebrazione eucaristica in piazza San Pietro: «Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo», esprimeva bene la linea ispiratrice e il programma di tutto il suo pontificato. Quelle parole manifestavano l’ansia apostolica che lo avrebbe spinto sulle strade del mondo, incontro a popoli di ogni cultura e di ogni razza per annunciare a tutti che solo in Dio, che in Cristo si è fatto a noi vicino, l’umanità può trovare la vera salvezza.
Questa verità egli l’ha proclamata con fedeltà e con un coraggio che nemmeno le due pallottole sparategli contro il 13 maggio 1981 riuscirono a indebolire o a scalfire.
La grandezza del suo lungo pontificato sta soprattutto nell’avere risvegliato nel mondo il senso religioso. Nella società secolarizzata del suo tempo, egli ha aiutato i cristiani a liberarsi dai falsi sensi di inferiorità nei confronti della cultura laicista dominante, e a non avere timore ad essere e a dirsi cristiani. Instancabile fu il suo richiamo a ritornare a Dio, rivolto ad una società che in Occidente lo stava dimenticando e che oltre la “cortina di ferro” lo combatteva.
Ha fatto capire che non si possono limitare a questa terra gli orizzonti di noi, uomini e donne. Ha insegnato che la coscienza, «in cui l’uomo si trova solo con Dio e scopre una legge scritta nel cuore» (Gaudium et spes, 16), conferisce un’altissima dignità all’uomo e alla donna ed ha esortato a rinnovare la società facendole ritrovare la forza del messaggio di Cristo (Cfr. Insegnamenti 1986, i, p. 1379).
Giovanni Paolo II ha avuto fiducia nella forza delle istanze spirituali e morali ed è stato un testimone di eccezionale statura anche per la sua limpida coerenza: in lui non esisteva frattura fra ciò che pensava e ciò che diceva; fra ciò in cui credeva e ciò che egli era. In lui vi era piena unità di fede e di vita.
- Difensore dei diritti umani
Oltre che uomo di Dio, Giovanni Paolo II è stato un appassionato difensore dell’uomo, della dignità, dei diritti e della libertà di ogni persona umana. Fu anche questo un tema caratterizzante il suo insegnamento, che ha aiutato molte persone a scoprire il senso etico della vita. Alla radice di questo impegno per l’uomo si staglia una chiara visione della dignità di ogni persona umana, «unica e irrepetibile», come soleva dire. Ogni attentato contro la dignità di qualsiasi essere umano è un’offesa a Dio, nostro Creatore. I diritti umani erano da lui proclamati e difesi come diritti che Dio ha posto nella natura umana. Si schierò sempre in difesa del carattere inviolabile della vita umana, dal primo istante del concepimento fino al naturale tramonto.
L’uomo e la donna erano da lui visti con gli occhi di Dio e amati col cuore di Dio. La sua era un’antropologia cristocentrica: la creatura umana trova il senso della sua vita al di sopra di sé; lo trova in Dio, che in Cristo si è fatto uomo.
- Uomo di preghiera
Lavorando vicino a Giovanni Paolo II, molte erano le cose che colpivano (impressionavano la sua sicurezza, le sue certezze, la capacità di parlare alle folle... la capacità di veder più lontano degli altri), ma ciò che mi ha sempre stupito di più è stata la profonda intensità della sua preghiera. Non si può comprendere Papa Giovanni Paolo II se si prescinde dal suo rapporto con Dio. È stato un grande uomo di preghiera, animato da una forte spiritualità cristocentrica e mariana. Aveva in sé una tensione spirituale e mistica inconfondibile ed è dalla preghiera che fluivano la sua sicurezza, l’assoluta padronanza di sé e la sua serenità in ogni circostanza.
Colpiva come si abbandonava alla preghiera: si notava in lui un totale coinvolgimento, che lo assorbiva come se non avesse avuto problemi e impegni urgenti che lo chiamavano alla vita attiva. Il suo atteggiamento era raccolto e insieme spontaneamente naturale.
Dal modo con cui pregava si avvertiva come l’unione con Dio era per lui respiro dell’anima e umile ascolto della voce di Dio.
Commuovevano la facilità e la prontezza con le quali passava dal contatto umano con la gente al raccoglimento del colloquio intimo con Dio. Aveva una grande capacità di concentrazione. Quando era raccolto in preghiera, quello che accadeva attorno a lui sembrava non toccarlo e non riguardarlo, tanto si immergeva nell’incontro con Dio.
Durante la giornata, il passaggio da un’occupazione all’altra era sempre segnato da una breve preghiera.
Maturava ogni scelta importante nella preghiera. Prima di ogni decisione significativa Giovanni Paolo II vi pregava sopra a lungo, a volte per più giorni. Sembrava che trattasse con Dio i vari problemi.
Nelle scelte di un certo peso non decideva mai subito. Ai suoi interlocutori che gli chiedevano o proponevano qualcosa, rispondeva che desiderava riflettere prima di dare risposta. In realtà, guadagnava tempo per ascoltare qualche parere, ma soprattutto intendeva pregare per ottenere luce dall’alto prima di decidere.
Ricordo un caso, negli anni in cui ero sostituto della Segreteria di Stato, in cui mi sembrò che il Papa fosse già decisamente a favore di una determinata difficile scelta. Gli chiesi pertanto se si potesse procedere a darne comunicazione. La risposta fu: «Aspettiamo, voglio pregare ancora un po’ prima di decidere».
Nelle decisioni il suo primo interesse era di operare davanti a Dio secondo verità, giustizia ed equità, e non se esse fossero popolari o no. Non gli mancò mai il coraggio necessario.
Quando si stava studiando un problema e non si riusciva a trovare una soluzione giusta e adeguata, il Papa concludeva dicendo: «Dobbiamo pregare ancora, perché il Signore ci venga in aiuto». Si affidava alla preghiera per trovare luce sulla strada da seguire.
Punto forte della sua spiritualità è stata la devozione alla Madonna: la dimensione mariana, espressa nel motto “Totus tuus”, ha contrassegnato l’intera sua esistenza. Era un’eredità lasciatagli dalla mamma scomparsa prematuramente, che poi ha approfondito e sviluppato accompagnato dal padre nel cammino di maturazione spirituale. Karol Wojtyła nacque il 18 maggio 1920, alcuni minuti dopo le ore 17, mentre nella chiesa parrocchiale, vicinissima a casa sua, era in corso la funzione mariana del mese di maggio. Appena il piccolo Karol era venuto alla luce, la mamma, sentendo il canto delle litanie lauretane che giungeva dalla chiesa, disse: «Aprite le finestre, perché voglio che le prime voci ed i primi suoni che il mio bambino ascolta siano i canti della Madonna».
Nel periodo in cui andava a lavorare alla cava di pietra e poi alla fabbrica Solvay, Karol Wojtyła lesse il libro di san Luigi Maria Grignion de Montfort Trattato della vera devozione a Maria, che gli era stato dato da un laico, Jan Tyranowski. Questi aveva creato in parrocchia un gruppo di 15 giovani, fra i quali Karol Wojtyła, che si impegnavano a recitare ognuno una decina del rosario al giorno.
Non è senza significato che due settimane dopo la sua elezione alla sede di Pietro, nel pomeriggio della prima domenica per lui libera, sia andato al santuario della Mentorella per pregare la Madonna, ma anche per parlare della preghiera, affermando che considerava suo primo compito come Papa quello di pregare per la Chiesa e per il mondo e desiderava che la preghiera fosse «il primo annuncio del Papa« (Omelia al santuario della Mentorella, «L’Osservatore Romano», 30-31 ottobre 1978).
La messa era per lui la realtà più alta, più importante e più sacra. In un incontro con i sacerdoti nel 1995 disse: «la messa è in modo assoluto il centro della mia vita e di ogni mia giornata». «Celebrare ogni giorno la messa è per me un bisogno del cuore».
Il mondo intero ha seguito gli ultimi giorni di Papa Giovanni Paolo II. Col suo esempio ci ha insegnato che la vita è un dono che va vissuto fino alla fine con fiducia in Dio e accettando con serenità i disagi della malattia. Ci ha indicato come si percorre il cammino verso il mistero che ci attende, quando anche per ciascuno di noi si apriranno le porte dell’eternità. È stato questo il suo ultimo insegnamento: un insegnamento da Papa.
di Giovanni Battista Re
 Decano del Collegio cardinalizio
Decano del Collegio cardinalizio
NOTA:
Carlo Wojtyla,
 AMORE E RESPONSABILITA’.
AMORE E RESPONSABILITA’.
 Morale sessuale e vita interpersonale,
Morale sessuale e vita interpersonale,
 Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)
Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)fls
-
> GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- "Gesù, il re ribelle. Una storia ebraica". Giulio Busi racconta l’«ebreo» che fondò un Regno in antitesi con ogni regalità mondana (di Enzo Bianchi).13 ottobre 2023, di Federico La Sala
LONTANO E VICINO
"Gesù fu un re mistico, ribelle e sovversivo che non si piegò ai romani e a nessun potere"
 Giulio Busi racconta l’«ebreo» che fondò un Regno in antitesi con ogni regalità mondana
Giulio Busi racconta l’«ebreo» che fondò un Regno in antitesi con ogni regalità mondanadi ENZO BIANCHI (La Stampa - TuttoLibri, 07 Ottobre 2023) *
«È falso sino all’assurdo vedere in una “credenza” il segno distintivo del cristiano: soltanto la pratica cristiana, una vita come la visse colui che morì sulla croce, soltanto questo è cristiano... Ancora oggi una tale vita è possibile, per certi uomini è persino necessaria: l’autentico, originario cristianesimo sarà possibile in tutti i tempi... Non una credenza, bensì un fare, soprattutto un non-fare-molte-cose, un diverso essere». Queste lucide parole di Friedrich Nietzsche in L’anticristo, un pensatore non certo tenero nei confronti del cristianesimo, costituiranno sempre un buon punto di partenza per interrogarsi su cosa è essenziale alla fede cristiana, ovvero sulla singolarità del cristianesimo.
In effetti, il cristianesimo è una cosa estremamente semplice, è essenzialmente una persona: Gesù Cristo. Secondo la fede cristiana, se si vuole conoscere Dio è necessario guardare a Gesù, tenere fisso lo sguardo su di lui, perché Gesù è l’ultimo e definitivo racconto di Dio. Guai a chi rende il cristianesimo un «sistema religioso» difficile e riservato a pochi: il cristianesimo riguarda tutti gli uomini e le donne siano essi credenti o non credenti, cristiani o appartenenti ad altre religioni. Rinchiudere Gesù nel recinto spesso angusto dell’interpretazione confessionale e dottrinale cristiana della sua figura e della sua vicenda è fargli il torto più grande, quasi che l’incomprensione e il tradimento siano il destino di quest’uomo.
Per questo, il nuovo saggio di Giulio Busi "Gesù il re ribelle. Una storia ebraica"*, va accolto con ammirazione e salutato con estremo entusiasmo. Tra i principali intellettuali italiani e tra i più importanti studiosi di misticismo ebraico, Giulio Busi dal 1999 dirige l’Istituto di Giudaistica della Freie Universität di Berlino. Dopo aver pubblicato fondamentali saggi su personaggi come Pico della Mirandola, Lorenzo de’ Medici, Cristoforo Colombo e Giulio II, ora si accosta alla figura immensa di Gesù. Il titolo e il sottotitolo indicano i tre elementi portanti del libro: regalità, ribellione, ebraismo.
La prospettiva del libro è dichiaratamente ebraica. Pagina dopo pagina si percepisce a fior di pelle che quest’opera è frutto di quarant’anni di ricerca nell’ambito della lingua e della cultura ebraica. Busi applica a Gesù la sua vastissima conoscenza della mistica ebraica. Ed è questo l’apporto più inedito, significativo e originale della sua lettura ebraicamente mistica del Rabbi di Nazaret, ma un misticismo per nulla misticheggiante, al contrario è la mistica di un re ribelle, di un sovvertitore, di un eversivo. Una regalità ribelle che sfata l’immagine spesso docile e addomesticata che la tradizione cristiana ha consegnato di Gesù. Emerge in tutta la sua forza il Gesù «uomo dello scandalo, capace di ammaliare le folle e di suscitare un odio implacabile», che non evita la polemica, che sceglie l’invettiva e che dichiara apertamente di essere venuto non a portare pace ma la spada per separare. Sì, il Gesù ribelle che Busi fa emergere dai quattro Evangeli canonici - ai quali si attiene scrupolosamente ma rifiutandone l’antigiudaismo - è un ribelle che chiama i suoi seguaci e i suoi ascoltatori alla ribellione verso ogni forma di sopraffazione, ricchezza e soprattutto di potere ingiusto, sia esso politico come religioso. Ma «è la ribellione di un ebreo, orgoglioso della sua appartenenza». Per lui gli ebrei non sono mai «loro», ma sempre «noi».
La regalità vissuta e impersonata da Gesù e il Regno di Dio che annuncia sono alle antitesi della regalità mondana. Gesù è un viandante che passa da villaggio in villaggio, che cambia luogo improvvisamente e apparentemente senza ragione, è un maestro che insegna a persone senza cultura ed è tra queste che sceglie i suoi discepoli. La gente lo chiama Rabbi ma non è un Rabbi autorizzato da titoli di studio riconosciuti dell’élite religiosa. «La sua forza non è l’erudizione. Non è per studiare che ha abbandonato la casa, il lavoro, la famiglia. Se ne è andato, e ha scelto la vita del maestro itinerante, qualcuno dice vagabondo, per rispondere a una chiamata». Se le autorità religiose lo hanno rifiutato e condannato a morte per il suo tipo di ribellione, il cristianesimo ha trasformato la sua regalità senza potere in un regno solido che è durato due millenni grazie all’alleanza con imperi, regni, stati.
Grazie a una lettura intelligente e mai scontata dei racconti evangelici Giulio Busi ripercorre la vita del Nazzareno attraverso i passaggi decisivi, i momenti più significativi, le parole più intense e sconvolgenti. Emblematico dell’interpretazione dell’autore è l’accostamento di due episodi: l’immersione nel Giordano all’inizio della missione e l’incontro con l’adultera. Per quale ragione Gesù decide di ricevere da Giovanni il Battezzatore un battesimo per il perdono dei peccati? La tradizione di questo episodio è forte al punto che gli stessi evangelisti non possono sottrarsi ma il loro imbarazzo rimane evidente. Busi osserva come in principio vi sia l’acqua nella quale Gesù si immerge, entra nella corrente del fiume e lascia che il suo corpo ne venga avvolto completamente. Quando esce vede scendere su di lui una colomba lieve e leggera, mansueta ma anche enigmatica tuttavia è la forma che lo Spirito ha scelto per posarsi su di lui fino a sfiorarlo. Il cielo si apre sopra di lui come sopra il profeta Ezechiele e ode la voce. «Sei tu il mio Figlio, l’amato, in te ho posto la mia benevolenza». Il Dio fatto uomo non ha certo bisogno di conferme visibili e udibili, «eppure - osserva Busi - è lì, tra l’acqua del Giordano e la riva assolata, che avviene un passaggio decisivo. Nella vita di ogni mistico, e in questo non pensiamo che Gesù faccia eccezione, esiste una porta che separa “prima” e “dopo”. C’è insomma un’esperienza biografica iniziale, che segna la presa di coscienza dei propri poteri spirituali. Un simile cambiamento può concretizzarsi in una visione, una percezione uditiva, un trauma, o un’emozione debordante».
Se nel battesimo Gesù si è sottoposto a un rito di purificazione senza aver commesso peccato, allo stesso modo davanti alla donna sorpresa in adulterio rinuncia a giudicarla. Per Giulio Busi vi è una logica evangelica che lega l’immersione nel Giordano e il «neppure io ti condanno» annunciato all’adultera: «Gesù è il re che si ribella. Non si sottomette al potere. Non si piega ai romani, rifiuta i sacerdoti, allontana da sé la presunzione di chi è colto ma non pio. Ripudia i giudici, mescola tempo sacro e tempo profano. La prima ribellione, la più paradossale, la compie però contro se stesso». Lascio al lettore scoprire e gustare in cosa consista questa ribellione contro se stesso.
L’illuminazione del vero ricercatore che qui Busi mostra di avere, vale la lettura di un libro che non è solo erudito, ma è un libro di ricerca, di avventura, direi di autentica passione nei confronti del mistico ebreo Gesù. Questa l’illuminazione feconda: «Il progetto di Gesù si misura sulla natura misteriosa e contradditoria del Figlio dell’uomo. La sua è una regalità inaudita. Ed è questa nuova concezione del potere che egli impone, in maniera rivoluzionaria, ai suoi seguaci, chiamandoli a partecipare a un regno condiviso». Gesù è stato re al contrario, in un modo mai tentato prima e mai veramente realizzato dopo. Per questo diamo ancora la parola a Nietzsche: «In fondo è esistito un solo cristiano e questi è morto in croce».
*
- Giulio Busi, "Gesù, il re ribelle. Una storia ebraica" (Mondadori, Milano 2023)
-
>FILOLOGIA ("ECCE HOMO") E CRISTOLOGIA. Riflessioni sul rinnovamento teologico: "Non c’è riforma della Chiesa senza riforma della teologia". A COLLOQUIO CON PIERO CODA (A. Monda e R. Cetera))..29 luglio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA ("ECCE HOMO"), E CRISTOLOGIA (OLTRE L’ORIZZONTE DELL’ANDROCENTRISMO).
"Non c’è riforma della Chiesa senza riforma della teologia". Una intervista degna di attenzione da L’Osservatore Romano (del 27 luglio 2023): al centro una rinnovata e forte attenzione al rapporto e alla relazione (di "Adamo ed Eva" e) di "Maria e Giuseppe":
QUESTIONE ANTROPOLOGICA: "[...] Il tema della relazione uomo-donna è paradigmatico. Per dirla un po’ provocatoriamente, penso che oggi più che una “questione femminile” ci troviamo ad affrontare una “questione maschile”! Mi riferisco alla perdita d’identità dell’uomo maschio, che non riesce ad adeguarsi all’emancipazione irreversibile - e benedetta! - del femminile. Il maschio era abituato a idealizzare - e imprigionare - la donna: nei ruoli della madre, della sorella, della sposa o... dell’amante, e in tutti i casi, troppo spesso, della serva. E lui gestiva questi ruoli. Ma non si relazionava con la donna come amica. La straordinaria bellezza della categoria dell’amicizia, meravigliosamente evocata nel #Canticodeicantici, non rientrava nello schema dei rapporti tra i sessi. Oggi la donna finalmente si rifiuta d’essere ingabbiata dentro questo schema riduttivo e persino distorto, approntato dai soli maschi. E l’uomo non sa più che pesci prendere. -Occorre ritrovare e implementare la dimensione originaria della reciprocità. Che è più e altro dalla complementarietà. È uno stato di crisi, quello attuale, che influisce sull’opacità e indeterminatezza dell’identità sessuale. Recuperare la freschezza e gioia della reciprocità da ambedue i sessi, dunque, per recuperare la pienezza della persona nel vivere affetti, libertà e solidarietà.
 La nostra arretratezza nel leggere questo fenomeno viene erroneamente attribuita alla fissità anacronistica di una idealizzazione della “sacra famiglia”. Che in verità rappresenta piuttosto un modello che, liberato dalle incrostazioni devozionali che gli abbiamo ritagliato addosso, riluce come lo scrigno delle relazioni umane fondate sull’affettività, la libertà e solidarietà.
La nostra arretratezza nel leggere questo fenomeno viene erroneamente attribuita alla fissità anacronistica di una idealizzazione della “sacra famiglia”. Che in verità rappresenta piuttosto un modello che, liberato dalle incrostazioni devozionali che gli abbiamo ritagliato addosso, riluce come lo scrigno delle relazioni umane fondate sull’affettività, la libertà e solidarietà.
 Non scordiamo che Gesù non solo assume la sua umanità da Maria ma la matura anche dalla relazione con Giuseppe. Queste considerazioni valgono non solo per la famiglia, ma anche per le comunità di vita religiosa: che non sono meno in crisi delle famiglie. La famiglia di Nazareth è modello per tutti, chi è sposato e chi vive la verginità, entrambi nella logica dell’avvento del Regno. L’evanescenza del ruolo paterno che registriamo è oggi spesso penetrata anche tra i chierici, che non sanno più essere padri, essendo figli e fratelli.
Non scordiamo che Gesù non solo assume la sua umanità da Maria ma la matura anche dalla relazione con Giuseppe. Queste considerazioni valgono non solo per la famiglia, ma anche per le comunità di vita religiosa: che non sono meno in crisi delle famiglie. La famiglia di Nazareth è modello per tutti, chi è sposato e chi vive la verginità, entrambi nella logica dell’avvento del Regno. L’evanescenza del ruolo paterno che registriamo è oggi spesso penetrata anche tra i chierici, che non sanno più essere padri, essendo figli e fratelli.
 Uno dei meriti di Papa Francesco è quello di suggerire uno sguardo nuovo sulla presenza della figura di Giuseppe padre e di Maria madre nella nostra vita di discepoli. Ma c’è molto cammino da fare. [...]" ( cfr. "Non c’è riforma della Chiesa senza riforma della teologia". Riflessioni sul rinnovamento teologico. A colloquio con monsignor Piero Coda, segretario della Commissione teologica internazionale, di Andrea Monda e Roberto Cetera).
Uno dei meriti di Papa Francesco è quello di suggerire uno sguardo nuovo sulla presenza della figura di Giuseppe padre e di Maria madre nella nostra vita di discepoli. Ma c’è molto cammino da fare. [...]" ( cfr. "Non c’è riforma della Chiesa senza riforma della teologia". Riflessioni sul rinnovamento teologico. A colloquio con monsignor Piero Coda, segretario della Commissione teologica internazionale, di Andrea Monda e Roberto Cetera). -
> GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- BIOETICA. Utero in affitto sia reato universale: il 19 giugno in aula la proposta di legge (di Marina Casini - AgenSir).21 giugno 2023, di Federico La Sala
BIOETICA
Utero in affitto sia reato universale: il 19 giugno in aula la proposta di legge
di Marina Casini (AgenSir, 19 Giugno 2023)
- Arriva in aula il 19 giugno la proposta di legge che definisce l’utero in affitto (maternità surrogata) reato universale e che prevede la perseguibilità del cittadino italiano che all’estero ricorre a questa pratica. Sebbene la legge 40 del 2004 sanzioni giustamente questa pratica, la proposta - in linea con quanto richiesto nella scorsa legislatura da settanta associazioni facenti capo al Network “Ditelo sui tetti” - si è resa tuttavia necessaria per disincentivare l’espatrio di chi vuole aggirare l’ostacolo salvo poi rimpatriare a cose fatte chiedendo di essere riconosciuto genitore del bambino così ottenuto
Arriva in aula il 19 giugno la proposta di legge che definisce l’utero in affitto (maternità surrogata) reato universale e che prevede la perseguibilità del cittadino italiano che all’estero ricorre a questa pratica. Sebbene la legge 40 del 2004 sanzioni giustamente questa pratica, la proposta - in linea con quanto richiesto nella scorsa legislatura da settanta associazioni facenti capo al Network “Ditelo sui tetti” - si è resa tuttavia necessaria per disincentivare l’espatrio di chi vuole aggirare l’ostacolo salvo poi rimpatriare a cose fatte chiedendo di essere riconosciuto genitore del bambino così ottenuto.
 Che l’affitto di utero sia una pratica che altera le relazioni riducendo a cose donne e bambini è matura acquisizione raggiunta da molti:
Che l’affitto di utero sia una pratica che altera le relazioni riducendo a cose donne e bambini è matura acquisizione raggiunta da molti:una pratica legata ad una distorsione organizzata e pianificata della maternità, della paternità, della filiazione, inserite in una logica produttivistica, in una catena di montaggio aperta allo scarto (aborto volontario previsto dal contratto) di bambini eventualmente non rispondenti alle aspettative di salute o di troppo in caso di gravidanze gemellari.
E’ una pratica di sfruttamento mercantile (dove chi trae maggior vantaggio economico sono le cliniche, gli intermediari, i consulenti legali), di pretesi diritti inesistenti che mutilano i veri diritti; una pratica che deturpa la dimensione del dono caricaturandola di dolciastro altruismo - “gestazione solidale”, “gestazione per altri”, “gestazione di sostegno”, “in quella torsione linguistica così cara a diversi attuali filoni di pensiero, mossi dalla ricerca di consensi pubblici, che ne amplifichino benevolmente la crudezza dei messaggi” (Paola Ricci Sindoni) - ,
 e fa piacere che su un tema così antropologicamente forte si trovi sintonia anche con i più (apparentemente) lontani da una visione personalista ontologicamente fondata.
e fa piacere che su un tema così antropologicamente forte si trovi sintonia anche con i più (apparentemente) lontani da una visione personalista ontologicamente fondata.Vedremo come si svilupperà il dibattito parlamentare. La proposta è comunque supportata da autorevoli documenti giuridici. L’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vieta di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro, la maternità surrogata è condannata dal Parlamento Europeo (risoluzione del 17 dicembre 2015) perché “compromette la dignità della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce”, e secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 272/2017, confermata dalla n. 33/2021) “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. La Convenzione sui diritti del bambino (ratificata dall’Italia) in base al “principio del prevalente interesse del minore” riconosce per ogni bambino, nella misura del possibile, il diritto a conoscere i propri genitori, ad essere da loro allevato, a preservare la propria identità comprensiva delle relazioni familiari.
Va da sé che l’auspicio sia che la proposta diventi legge a tutti gli effetti e dunque parte dell’ordinamento giuridico italiano.
 La speranza, tuttavia, è che non sia un punto di arrivo, ma una tappa nel cammino di riflessione, che va portato a tutti i livelli, sul senso del figlio, tale dal concepimento, della maternità e della paternità.
La speranza, tuttavia, è che non sia un punto di arrivo, ma una tappa nel cammino di riflessione, che va portato a tutti i livelli, sul senso del figlio, tale dal concepimento, della maternità e della paternità.Non basta dire “no” all’utero in affitto ̶ comunque lo si voglia diversamente definire, maternità surrogata o gestazione per altri o altro ancora ̶ bisogna dire “sì” all’uguale e inerente dignità di ogni essere umano, quindi sin dal momento in cui ogni essere umano inizia ad esistere in quel “big bang” chiamato concepimento. Solo questo mette al riparo da abusi, discriminazioni, sfruttamenti e prepotenze di ogni tipo, e solo da qui possiamo gettare solide basi per un più alto livello di civiltà e costruire sempre più pienamente e autenticamente la fraternità e la pace.
-
> GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- Il «nesso dei misteri» e l’immaginazione: “Maria, il Roseto di Roma e la Menorah”. Un commento dei teologi Scarafoni e Rizzo).13 maggio 2023, di Federico La Sala
“Maria, il Roseto di Roma e la Menorah”
Un commento dei teologi Scarafoni e Rizzo
PAOLO SCARAFONI E FILOMENA RIZZO*
- [Foto] La statua della Madonna di Fatima
Maggio è il mese per eccellenza dedicato alla Madonna. La regina dei fiori è la rosa, il fiore più bello. Per questo motivo è stato associato a Maria, che è chiamata nelle litanie lauretane «rosa mistica». La preghiera devozionale e contemplativa dedicata a lei è il «rosario», che allude alla ghirlanda di rose che nel medioevo si poneva sul capo delle statue della Vergine. La recita delle «ave Maria» è una ghirlanda mistica offerta alla Madonna.
In Italia l’amore per le rose è testimoniato da tanti roseti incantevoli dal Nord al Sud dello Stivale. Basta consultare i vari siti dedicati ai roseti da visitare nel mese di maggio, periodo della fioritura. Ci sono gli «itinerari delle rose». Tanti i luoghi bellissimi indicati, come i Giardini Botanici di Villa Taranto a Pallanza, la Reggia della Venaria Reale a Torino, il roseto di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, il Giardino de Boboli in Toscana, il “Roseto Vacunae Rosae” a Rieti, “Le stanze in fiore di Canalicchio” a Catania. Il Roseto comunale di Roma, che ospita una collezione di rose botaniche antiche e moderne, circa 1200 specie provenienti da tutto il mondo, si distingue per la sua bellezza e per la sua storia particolare, che si può leggere anche sul sito del Comune di Roma.
«Unico al mondo per la sua spettacolare posizione, si adagia sulle pendici dell’Aventino, di fronte ai resti del Palatino, appena sopra il Circo Massimo. Fin dal III secolo a.c. il luogo in cui sorge il roseto era dedicato ai fiori. Tacito, negli Annales, parla di un tempio dedicato alla dea Flora, i cui festeggiamenti “floralia” si svolgevano in primavera nel Circo Massimo. Ricoperto di orti e vigne fino a tutto il XVI secolo, nel 1645 divenne l’Orto degli Ebrei con annesso il piccolo cimitero della Comunità. Dal 1934, anno del trasferimento del cimitero ebraico al Verano, l’area, destinata dal Piano Regolatore Generale di Roma a Parco, rimase incolta fino al 1950, quando divenne sede del nuovo roseto comunale. Come ringraziamento alla comunità ebraica che aveva permesso di ricreare il roseto in un luogo sacro, venne posta all’ingresso del giardino una stele in ricordo della precedente destinazione e i vialetti che dividono le aiuole, assunsero la forma della menorah, il candelabro a sette bracci, simbolo dell’Ebraismo».
In questi giorni abbiamo passeggiato per il roseto. Abbiamo supposto che alcuni padri del Concilio Vaticano II nei momenti di pausa e di discernimento avranno anche loro camminato tra i sentieri di rose che tracciano i bracci della menorah, e avranno dato via libera alla loro immaginazione riflettendo sul documento che stavano preparando per il dialogo con gli ebrei e che sarebbe diventato la dichiarazione Nostra aetate.
L’immaginazione è il luogo dove entrano in gioco la libertà divina e la libertà umana. Per la relazione con Dio trova spazio in modo particolare in alcuni loci theologici: la liturgia, la Parola, il comportamento o vivere etico, la pietà popolare. Il giardino delle rose di Roma pur essendo un luogo laico è per molti una luce gentile della pietà popolare.
Sicuramente ai padri conciliari sarà venuta alla mente e al cuore Maria ebrea, che porta in sé la Sapienza divina. «Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo... “agli uomini di quella stirpe appartengono l’adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo secondo la carne” (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine. Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani e ad ebrei, questo sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo».
Già i Padri della Chiesa avevano attribuito a Maria le proprietà della Sapienza divina riassunte nel simbolo del fiore della rosa: «pianta di rose in Gerico» (Sir 24, 14); «pianta di rose su un torrente» (Sir 39, 13); «fiore di rose nella stagione di primavera» (Sir 50, 8).
Il legame di Maria con il popolo d’Israele indica l’unità della salvezza. Il «nesso dei misteri» è colto nella persona di Maria, la figlia di Sion, la madre di Gesù Cristo.
Non è raro scorgere chi come noi va a recitare il rosario, in maniera discreta, in quel luogo incantevole. Immaginare per immaginare, ci piacerebbe assistere ad un concerto mattutino nel roseto di Roma, per il giubileo del 2025, che celebri l’aurora della fraternità. È un luogo laico che si presta all’immaginazione che muove i cuori.
* Teologi
FONTE: LA STAMPA, 13 MAGGIO 2023
-
> IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- CORDONE OMBELICALE E FILOLOGIA. «Sono» nasce da un «siamo», e sta scritto al centro delle nostre pance (di Annalisa Teggi).4 dicembre 2022, di Federico La Sala
PIANETA TERRA 2022.
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, ANALFABETISMO, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (FREUD, 1929):
COME NASCONO I BAMBINI? COSA "STA SCRITTO AL CENTRO DELLE NOSTRE PANCE" DI ESSERI UMANI?
***
- "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Nel momento stesso in cui sono cominciati i viaggi extra-terrestri, forse, è possibile cominciare anche a capire l’importanza del cordone ombelicale e preoccuparsi meglio e di più delle condizioni che rendono possibile la vita sul Pianeta Terra.
- TERRA-MADRE (DEMETRA ->ELEUSIS, una delle capitali europee della cultura 2023). Senza cordone ombelicale (il filo "tecnologico", il "pezzo di terra", che assicura condizioni di vita terrestre ad un essere umano) nessuno può avventurarsi fuori dalla Terra (non solo nell’aria o nell’acqua del #Pianeta , ma nemmeno e ancor di più nello spazio planetario o cosmico) e tornare a Casa.
***
CORDONE OMBELICALE
di Annalisa Teggi (L’ Osservatore Romano, 02 dicembre 2022
"Se dovessi scegliere la notizia dell’anno di questo 2022 che si avvia al termine, la tirerei fuori dalle pieghe più silenziose della realtà. Lo scorso maggio a Catania è stato trovato un neonato abbandonato in una cesta con il cordone ombelicale ancora attaccato. Proprio quest’ultimo dettaglio mi è rimasto impresso, quasi fosse un grido. Che grande vulnerabilità esposta in quel cordone, segno di una dipendenza totale. Guai a manifestare una cosa del genere, oggi. I nostri cordoni ombelicali li tagliamo spavaldamente, o piuttosto li nascondiamo con cura (anche noi stessi). Ostentiamo la fierezza di traguardi che ci siamo guadagnati da soli, con le nostre forze. Senza chiedere niente a nessuno - la medaglia da appuntarsi al petto. Ma sarà poi vero?
[...]
«Sono» nasce da un «siamo», e sta scritto al centro delle nostre pance. È un «siamo» che è durato nove mesi dentro il grembo e non sparisce quando siamo creature separate da nostra madre. Restiamo bisognosi di non recisi dal cuore del mondo.
In una lettera datata 8 gennaio 1944 J.R.R. Tolkien scrisse a suo figlio Christopher: «Ma Dio è anche (si fa per dire) dietro di noi, sostenendoci, nutrendoci (dato che siamo creature sue). Quel luminoso punto di potere dove il cordone della vita, il cordone ombelicale dello spirito termina, là è il nostro angelo, che guarda in due direzioni: a Dio dietro di noi, senza che noi possiamo vederlo, e a noi». Ce lo immaginiamo sempre presente, l’angelo custode. Ma un po’ staccato da noi. Magari su un’imprecisata nuvoletta sopra la nostra testa. Solo un genio profondamente intuitivo poteva regalarci quest’istantanea dell’angelo custode che sta a reggere il cordone ombelicale che ci lega fecondamente al Cielo. Verrebbe da attribuirgli tutta l’energia vivace che si vede nei corpi e nei volti di chi fa il tiro alla fune. Solo che non c’è nessuna gara per l’angelo, solo l’inesausto desiderio di non separarci dal vero bene.
E questo «cordone ombelicale dello spirito» non è il filo del burattino che viene manovrato, è una cascata di nutrimento che ci tiene in piedi, per essere davvero liberi. Liberi, perché legati come figli. " (L’Osservatore Romano, 02 dicembre 2022).
***
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") --- IL LIBRO DEL PROFETA DANIELE E IL "FIGLIO DELL’UOMO, NOSTRO FIGLIO" (di Luigino Bruni).26 giugno 2022, di Federico La Sala
Il mistero rivelato / 13.
Figlio dell’uomo, figlio nostro
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 25 giugno 2022)
- La grande novità della Bibbia nelle umili cose dell’economia sta nel superamento dell’economia, sta nel messaggio che delinea un compito umano che addita una condotta di vita più elevata
- Riccardo Bachi, L’economia politica della Bibbia, 1936
Dopo aver visto le quattro bestie, e poi l’Eterno, l’Antico-di-giorni, Daniele finalmente vide un uomo, uno "simile ad un figlio d’uomo". A dirci che dopo i tempi dei regni dei mostri la sua terra, la terra di tutti conoscerà finalmente un regno umano. Non capiamo l’arrivo di questo figlio d’uomo se non lo confrontiamo con le bestie della prima parte della visione di Daniele. La sua profezia storica è la speranza vera che un giorno, un indefinito ma reale e storico giorno, i regni bestiali dei mostri dai dieci corni e con i grossi denti di ferro termineranno e inizierà il regno dell’umanità, di persone non più bestie, di sovrani umani che faranno il bene delle donne e degli uomini. Finalmente: finalmente per Daniele, finalmente per noi, che da millenni guardiamo la Terra, le sue guerre e i suoi mostri a quattro teste, e ripetendo la stessa domanda di Daniele preghiamo la sua stessa preghiera: «Antico-di-giorni, Dio Eterno: basta ingiustizia, basta guerre, basta mostruosità: aiutaci a vivere da umani». Dovremmo anche sapere che la Terra non sarà mai come vorremmo che fosse, perché siamo noi, sono io, a non essere come vorremmo e dovremo essere. Ma nel recitare quella preghiera-profezia dobbiamo diventare ignoranti, e pregare come fossimo ancora con l’Adam nel primo giardino, e lì con lui, con Daniele, con i profeti e con i bambini chiedere, richiedere e chiedere ancora. E poi non darci pace finché quel piccolo pezzo di terra dove viviamo somigli un po’ di più alla Terra di domani del figlio dell’uomo. Il figlio dell’uomo è anche nostro figlio, sono tutti i figli e le figlie che ci chiedono di crescere in un mondo finalmente umano.
«Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino all’Antico-di-giorni e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto» (Daniele 7,13-14). Questi versetti del capitolo 7 di Daniele sono forse i più noti del suo Libro. Le interpretazioni, ebraiche e cristiane, canoniche e apocrife, sono legioni, e il flusso di nuove ipotesi non si è mai interrotto. Chiunque abbia solo sfogliato i vangeli ha incontrato almeno una volta l’espressione "Figlio dell’uomo", che Gesù usava molto per parlare di sé. E se il messianismo di Gesù è quello del Figlio dell’uomo, allora è anche e soprattutto faccenda umana. Perché il suo Regno dei cieli non riguarda il paradiso né l’altra vita: riguarda questa terra. Il Regno inaugurato dal Figlio dell’uomo era faccenda di uomini e donne, non di angeli e demoni. Era storia, profezia storica, terra, polvere. Riguardava la giustizia, gli orfani e le vedove, Lazzaro e il ricco epulone, i buoni samaritani e i buoni albergatori, le vittime e i carnefici, le tasse e i talenti, il vino e le croci. Riguarda quindi l’economia, la politica, il diritto, le armi, la pace e la guerra: «Il Regno di Dio è in mezzo a voi» (Lc 17,21).
Anche il figlio dell’uomo di Daniele è cosa di terra. Forse è un’immagine del Messia, dell’Immanuel di Isaia, del ritorno di Elia, magari del "veltro" dantesco (If 1,101). Ma sempre di un figlio d’uomo si tratta, quindi della vita sotto il sole. L’espressione non era nuova. Il profeta Ezechiele l’amava molto ("ben adam"). Non sappiamo se il capitolo 7 di Daniele venne prima o dopo delle tradizioni apocalittiche che diedero vita ai "Libri di Enoch", dove nel tomo II, il Libro delle Parabole, il figlio dell’uomo è una figura centrale. Il figlio dell’uomo di Enoch non ci aiuta però a capire il Figlio dell’uomo di Daniele. Il capitolo di Daniele fu scritto in aramaico: "ben adam" è la traduzione ebraica dell’espressione aramaica originale "bar nashà", che mette in luce soprattutto la fragilità dell’uomo insieme alla sua grandezza (Salmo 8). In Daniele, infatti, il figlio dell’uomo è un essere terrestre che sale verso la corte divina - "ecco venire con le nubi..." -, mentre in Enoch è essere divino o angelico. In Daniele il bar nashà è mondo, in Enoch è cielo. Forse il significato più vero di figlio dell’uomo è essere umano, un appartenente alla razza umana: ecce homo.
I libri di Enoch non sono entrati nel canone perché, come dissero gli antichi scribi del III secolo a.C., quei libri non "sporcavano le mani", non sporcavano le mani perché troppo celesti. Il libro di Daniele è invece nel canone perché sporca le mani, e le sporca perché le sue visioni parlano della terra, di polvere (Adam è soprattutto il terrestre, il plasmato con la polvere del suolo). Quindi di storia, perché solo una fede che ci porta dentro la nostra storia ci "sporca le mani" - e questa sporcizia buona ci fa più umani. Non meno importante e bella è la continuazione del racconto. Daniele, terminate le visioni delle bestie e del figlio dell’uomo, si trova in una situazione simile a quella nella quale si era venuto a trovare il re Nabucodònosor al termine dei suoi sogni e incubi (cap. 2). Infatti: «Io, Daniele, mi sentii agitato nell’animo, tanto le visioni della mia mente mi avevano turbato; mi accostai a uno dei vicini e gli domandai il vero significato di tutte queste cose» (17,15-16). Daniele era stato l’interprete-profeta che con la sua spiegazione del sogno misterioso del re lo aveva rasserenato. Ma ora che riceve lui stesso un sogno-visione, Daniele ha a sua volta bisogno di un angelo-interprete per placare il suo proprio turbamento. L’interprete ha bisogno di un interprete, il profeta ha bisogno di un altro profeta. Un brano che ci suggerisce molte cose decisive nella vita dei profeti.
Certamente il genere letterario onirico aveva le sue regole e i suoi canoni, che noi oggi non capiamo più; qualcosa comunque lo possiamo dire. Quando un profeta - la profezia è una dimensione presente in molte persone, dentro e fuori le religioni, in particolare ogni vocazione è profezia - deve decifrare i propri sogni, quando cioè non deve soltanto interpretare i sogni degli altri perché un giorno ha iniziato a sognare in proprio e vuole comprendere i suoi stessi sogni, la prima esperienza che fa è quella dell’insufficienza: quei doni e carismi che per anni lo avevano assistito nell’interpretazione dei sogni-incubi altrui, applicati a se stesso non funzionano. Il profeta sente una nuova povertà e avverte il bisogno di un interprete per capire il senso delle sue visioni. La profezia qui svela una sua natura intimamente relazionale. Il profeta ha il dono di lettura delle visioni degli altri, il suo talento si rivela dentro un rapporto, è un dialogo che poi diventa svelamento di misteri. Questa dimensione relazionale è talmente essenziale nell’umanesimo e nell’antropologia biblici che quando un profeta si ritrova egli stesso a sognare, per capire il senso e il messaggio di quei suoi sogni ha bisogno di un "angelo" che glieli spieghi. Come tutti i doni e i talenti anche quelli profetici si attivano solo all’interno di un rapporto, si aprono mentre a nostra volta li doniamo. "La fonte non è per me" (Bernardette), è regola aurea anche della profezia. E ci svela qualcosa di essenziale.
C’è una grande tentazione che prima o poi arriva nella vita di chi, per vocazione, ha ricevuto doni che ha usato con gratuità a vantaggio della comunità e di tutti. Questa tentazione in genere si insinua dopo i grandi successi che quei talenti-doni hanno generato. Un giorno si comincia così a pensare di usare il dono ricevuto non più a vantaggio degli altri ma a vantaggio di se stessi. Di fronte ai grandi risultati dei propri talenti applicati a servizio gratuito degli altri, si intrufola un pensiero che diventa dominante: "Perché non posso usare queste abilità-talenti anche per me? Perché non metterli a reddito, magari per un buon fine? Anch’io ho diritto a capire i miei sogni..." Se si cede a questa tentazione, termina la castità nei confronti dei propri doni, la castità da se stessi, quella davvero cruciale da custodire nel corso della vita, fino alla fine.
Daniele, di fronte a queste tentazioni naturali e forse necessarie, ci dice qualcosa di decisivo: "Anche tu hai diritto a decifrare i tuoi sogni, ma devi trovarti un angelo, non puoi usare il tuo carisma per te stesso". Perché i doni-carismi più grandi e preziosi ci vengono dati per il bene di tutti, sono beni comuni, e quando cerchiamo di privatizzarli si auto-distruggono. E poi quando volessimo in un altro giorno usarli di nuovo per interpretare i sogni degli altri, se il dono è stato privatizzato non funziona più - è così che molti profeti nati onesti si trasformano in falsi profeti per mancanza di castità da se stessi. Quando un interprete dei sogni degli altri un giorno sogna un proprio sogno grande e diverso, il primo segno che non sta diventando un falso profeta è la presenza di questa indigenza, è la consapevolezza di aver bisogno di un angelo-interprete. Questa povertà è la sua grande ricchezza. Un altro messaggio riguarda le comunità carismatiche: una comunità che ha ricevuto un carisma, quando deve interpretare i suoi propri sogni deve ricorrere ad un carisma diverso, non può utilizzare il proprio carisma per se stessa - è anche questo il valore della comunione tra i carismi.
Infine, c’è un dato curioso del testo: sembra che il turbamento e il dialogo di Daniele con l’interprete avvengano ancora durante il sogno, perché l’angelo-interprete che Daniele trova è uno "dei vicini" al trono. L’esegeta del sogno è dentro lo stesso sogno. Per molte visioni e sogni è possibile, e forse è bene, che l’esegeta sia fuori dal nostro sogno. L’angelo-interprete non deve essere della nostra comunità, della nostra religione e fede. A volte questa alterità è una necessaria distanza terapeutica per una buona esegesi. Ma in certi sogni diversi, l’interprete deve stare dentro il nostro stesso sogno. Qui l’angelo deve essere qualcuno che ci conosce intimamente perché è dentro la stessa esperienza, sta sognando con noi. Ci "legge dentro" con un’altra intelligenza, perché anche lui/lei è un personaggio della comune visione, è "uno dei vicini". Qualche volta non capiamo i messaggi della vita perché l’interprete è troppo vicino; altre volte, e sono quelle davvero cruciali, la rivelazione della visione si trova dentro casa ma noi la cerchiamo troppo lontano. E non passa il turbamento del cuore.
NOTA:
#ANTROPOLOGIA #TEOLOGIA E #ARTE: IL #NODODORO DELLA #TESSITURA DELLA #STORIA DELL’#UMANITA’: RIPRENDERE IL #FILO DEL RACCONTO DEI #PROFETI E DELLE #SIBILLE BRILLANTEMENTE ILLUSTRATO NELLA #CORNICE DEL TONDODONI.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- "Praedicate Evangelium". Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo.22 marzo 2022, di Federico La Sala
Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium”
sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo,
19.03.2022
Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede *
INDICE
- I Preambolo
- II Principi e Criteri per il servizio della Curia romana
- III Norme generali (artt. 1 - 43)
- IV Segreteria di Stato (artt. 44 - 52)
- V Dicasteri
- [...]
PREAMBOLO
1. Praedicate evangelium (cfr Mc 16,15; Mt 10,7-8): è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce «il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all’intera umanità nel mondo odierno»[1]. A questo essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l’ascolto della fede (cfr Rm 1,1-5; Gal 3,5). La Chiesa adempie il suo mandato soprattutto quando testimonia, in parole e opere, la misericordia che ella stessa gratuitamente ha ricevuto. Di ciò il nostro Signore e Maestro ci ha lasciato l’esempio quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli e ha detto che saremo beati se faremo anche noi così (cfr Gv 13,15-17). In questo modo «la comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo»[2]. Facendo così, il popolo di Dio adempie al comando del Signore, il quale chiedendo di annunciare il Vangelo, sollecitò a prendersi cura dei fratelli e delle sorelle più deboli, malati e sofferenti.
La conversione missionaria della Chiesa
2. La “conversione missionaria” della Chiesa[3] è destinata a rinnovare la Chiesa secondo l’immagine della missione d’amore propria di Cristo. I suoi discepoli e discepole sono quindi chiamati ad essere “luce del mondo” (Mt 5,14). Questo è il modo con cui la Chiesa riflette l’amore salvifico di Cristo che è la Luce del mondo (cfr Gv 8,12). Essa stessa diventa più radiosa quando porta agli uomini il dono soprannaturale della fede, «luce che orienta il nostro cammino nel tempo» e servendo il Vangelo perché questa luce «cresca per illuminare il presente fino a diventare stella che mostra gli orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui l’uomo è particolarmente bisognoso di luce»[4].
3. Nel contesto della missionarietà della Chiesa si pone anche la riforma della Curia romana. Fu così nei momenti in cui più urgente si avvertì l’anelito di riforma, come avvenuto nel XVI secolo, con la Costituzione apostolica Immensa aeterni Dei di Sisto V (1588) e nel XX secolo, con la Costituzione apostolica Sapienti Consilio di Pio X (1908). Celebrato il Concilio Vaticano II, Paolo VI, riferendosi esplicitamente ai desideri espressi dai Padri Conciliari[5], con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae (1967), dispose e realizzò una riforma della Curia. Successivamente, Giovanni Paolo II promulgò la Costituzione apostolica Pastor bonus (1988), al fine di promuovere sempre la comunione nell’intero organismo della Chiesa.
In continuità con queste due recenti riforme e con gratitudine per il servizio generoso e competente che nel corso del tempo tanti membri della Curia hanno offerto al Romano Pontefice e alla Chiesa universale, questa nuova Costituzione apostolica si propone di meglio armonizzare l’esercizio odierno del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, soprattutto in questa stagione, sta vivendo.
La Chiesa: mistero di comunione
4. Per la riforma della Curia romana è importante avere presente e valorizzare anche un altro aspetto del mistero della Chiesa: in essa la missione è talmente congiunta alla comunione da poter dire che scopo della missione è proprio quello «di far conoscere e di far vivere a tutti la «nuova» comunione che nel Figlio di Dio fatto uomo è entrata nella storia del mondo»[6].
Questa vita di comunione dona alla Chiesa il volto della sinodalità; una Chiesa, cioè, dell’ascolto reciproco «in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri, e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità (cfr Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli dice alle Chiese (cfr Ap 2,7)»[7]. Questa sinodalità della Chiesa, poi, la si intenderà come il «camminare insieme del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore»[8]. Si tratta della missione della Chiesa, di quella comunione che è per la missione ed è essa stessa missionaria.
Il rinnovamento della Chiesa e, in essa, anche della Curia romana, non può che rispecchiare questa fondamentale reciprocità perché la comunità dei credenti possa avvicinarsi il più possibile all’esperienza di comunione missionaria vissuta dagli Apostoli con il Signore durante la sua vita terrena (cfr Mc 3,14) e, dopo la Pentecoste, sotto l’azione dello Spirito Santo, dalla prima comunità di Gerusalemme (cfr At 2,42).
Il servizio del Primato e del Collegio dei Vescovi
5. Fra questi doni dati dallo Spirito per il servizio degli uomini, eccelle quello degli Apostoli, che il Signore scelse e costituì come “gruppo” stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro[9]. Agli stessi Apostoli affidò una missione che durerà sino alla fine dei secoli. Per questo essi ebbero cura di istituire dei successori[10], sicché come Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per volontà del Signore, un unico Collegio apostolico, così ancora oggi, nella Chiesa, società gerarchicamente organizzata[11], il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico corpo episcopale, al quale i Vescovi appartengono in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col capo del Collegio e con le sue membra, cioè con il Collegio stesso[12].
6. Insegna il Concilio Vaticano II: «L’unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con le Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi, sia della moltitudine dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari. Queste sono formate a immagine della Chiesa universale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica. Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano la Chiesa universale in un vincolo di pace, di amore e di unità»[13].
7. È importante sottolineare che grazie alla Divina Provvidenza nel corso del tempo sono state stabilite in diversi luoghi dagli Apostoli e dai loro successori varie Chiese, che si sono riunite in diversi gruppi, soprattutto le antiche Chiese patriarcali. L’emergere delle Conferenze episcopali nella Chiesa latina rappresenta una delle forme più recenti in cui la communio Episcoporum si è espressa al servizio della communio Ecclesiarum basata sulla communio fidelium. Pertanto, ferma restando la potestà propria del Vescovo, quale pastore della Chiesa particolare affidatagli, le Conferenze episcopali, incluse le loro Unioni regionali e continentali, insieme con le rispettive Strutture gerarchiche orientali sono attualmente uno dei modi più significativi di esprimere e servire la comunione ecclesiale nelle diverse regioni insieme al Romano Pontefice, garante dell’unità di fede e di comunione[14].
Il servizio della Curia romana
8. La Curia romana è al servizio del Papa, il quale, in quanto successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli[15]. In forza di tale legame l’opera della Curia romana è pure in rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi, e anche con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, e le Strutture gerarchiche orientali, che sono di grande utilità pastorale ed esprimono la comunione affettiva ed effettiva tra i Vescovi. La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno.
9. L’attenzione che la presente Costituzione apostolica dà alle Conferenze episcopali e in maniera corrispondente ed adeguata alle Strutture gerarchiche orientali, si muove nell’intento di valorizzarle nelle loro potenzialità[16], senza che esse fungano da interposizione fra il Romano Pontefice e i Vescovi, bensì siano al loro pieno servizio. Le competenze che vengono loro assegnate nelle presenti disposizioni sono volte ad esprimere la dimensione collegiale del ministero episcopale e, indirettamente, a rinsaldare la comunione ecclesiale[17], dando concretezza all’esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali per il bene dei fedeli delle rispettive nazioni o di un determinato territorio[18].
Ogni cristiano è un discepolo missionario
10. Il Papa, i Vescovi e gli altri ministri ordinati non sono gli unici evangelizzatori nella Chiesa. Essi «sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo»[19]. Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, è un discepolo-missionario «nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù»[20]. Non si può non tenerne conto nell’aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità. La loro presenza e partecipazione è, inoltre, imprescindibile, perché essi cooperano al bene di tutta la Chiesa[21] e, per la loro vita familiare, per la loro conoscenza delle realtà sociali e per la loro fede che li porta a scoprire i cammini di Dio nel mondo, possono apportare validi contributi, soprattutto quando si tratta della promozione della famiglia e del rispetto dei valori della vita e del creato, del Vangelo come fermento delle realtà temporali e del discernimento dei segni dei tempi.
11. La riforma della Curia romana sarà reale e possibile se germoglierà da una riforma interiore, con la quale facciamo nostro «il paradigma della spiritualità del Concilio», espressa dall’«antica storia del Buon Samaritano»[22], di quell’uomo, che devia dal suo cammino per farsi prossimo ad un uomo mezzo morto che non appartiene al suo popolo e che neppure conosce. Si tratta qui di una spiritualità che ha la propria fonte nell’amore di Dio che ci ha amato per primo, quando noi eravamo ancora poveri e peccatori, e che ci ricorda che il nostro dovere è servire come Cristo i fratelli, soprattutto i più bisognosi, e che il volto di Cristo si riconosce nel volto di ogni essere umano, specialmente dell’uomo e della donna che soffrono (cfr Mt 25,40).
12. Deve pertanto essere chiaro che «la riforma non è fine a se stessa, ma un mezzo per dare una forte testimonianza cristiana; per favorire una più efficace evangelizzazione; per promuovere un più fecondo spirito ecumenico; per incoraggiare un dialogo più costruttivo con tutti. La riforma, auspicata vivamente dalla maggioranza dei Cardinali nell’ambito delle Congregazioni generali prima del Conclave, dovrà perfezionare ancora di più l’identità della stessa Curia romana, ossia quella di coadiuvare il Successore di Pietro nell’esercizio del suo supremo Ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari. Esercizio col quale si rafforzano l’unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo. Certamente raggiungere una tale meta non è facile: richiede tempo, determinazione e soprattutto la collaborazione di tutti. Ma per realizzare questo dobbiamo innanzitutto
- [...]
Dato a Roma, presso San Pietro, nella Solennità di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria, il giorno 19 marzo 2022, decimo di Pontificato.
Francesco
- [...]
* Fonte: Vatican.va - Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede (ripresa parziale).
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA E DI SONNO DOGMATICO. La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo (di Giovanni Paolo II - 2001).25 febbraio 2022, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E QUESTIONE ANTROPOLOGICA: UT UNUM SINT... *
GIOVANNI PAOLO II
UDIENZA GENERALE
Mercoledì, 14 febbraio 2001
La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo *
1. Il disegno salvifico di Dio, “il mistero della sua volontà” (Ef 1,9) concernente ogni creatura, è espresso nella Lettera agli Efesini con un termine caratteristico: “ricapitolare” in Cristo tutte le cose, celesti e terrestri (cfr Ef 1,10). L’immagine potrebbe rimandare anche a quell’asta attorno alla quale si avvolgeva il rotolo di pergamena o di papiro del volumen, recante su di sé uno scritto: Cristo conferisce un senso unitario a tutte le sillabe, le parole, le opere della creazione e della storia.
A cogliere per primo e a sviluppare in modo mirabile questo tema della ‘ricapitolazione’ è sant’Ireneo vescovo di Lione, grande Padre della Chiesa del secondo secolo. Contro ogni frammentazione della storia della salvezza, contro ogni separazione tra Antica e Nuova Alleanza, contro ogni dispersione della rivelazione e dell’azione divina, Ireneo esalta l’unico Signore, Gesù Cristo, che nell’Incarnazione annoda in sé tutta la storia della salvezza, l’umanità e l’intera creazione: “Egli, da re eterno, tutto ricapitola in sé” (Adversus haereses III, 21,9).
2. Ascoltiamo un brano in cui questo Padre della Chiesa commenta le parole dell’Apostolo riguardanti appunto la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose. Nell’espressione “tutte le cose” - afferma Ireneo - è compreso l’uomo, toccato dal mistero dell’Incarnazione, allorché il Figlio di Dio “da invisibile divenne visibile, da incomprensibile comprensibile, da impassibile passibile, da Verbo divenne uomo. Egli ha ricapitolato tutto in se stesso, affinché come il Verbo di Dio ha il primato sugli esseri sopracelesti, spirituali e invisibili, allo stesso modo egli l’abbia sugli esseri visibili e corporei. Assumendo in sé questo primato e donandosi come capo alla Chiesa, egli attira tutto in sé” (Adversus haereses III, 16,6). Questo confluire di tutto l’essere in Cristo, centro del tempo e dello spazio, si compie progressivamente nella storia superando gli ostacoli, le resistenze del peccato e del Maligno.
3. Per illustrare questa tensione, Ireneo ricorre all’opposizione, già presentata da san Paolo, tra Cristo e Adamo (cfr Rm 5,12-21): Cristo è il nuovo Adamo, cioè il Primogenito dell’umanità fedele che accoglie con amore e obbedienza il disegno di redenzione che Dio ha tracciato come anima e meta della storia. Cristo deve, quindi, cancellare l’opera di devastazione, le orribili idolatrie, le violenze e ogni peccato che l’Adamo ribelle ha disseminato nella vicenda secolare dell’umanità e nell’orizzonte del creato. Con la sua piena obbedienza al Padre, Cristo apre l’era della pace con Dio e tra gli uomini, riconciliando in sé l’umanità dispersa (cfr Ef 2,16). Egli ‘ricapitola’ in sé Adamo, nel quale tutta l’umanità si riconosce, lo trasfigura in figlio di Dio, lo riporta alla comunione piena con il Padre. Proprio attraverso la sua fraternità con noi nella carne e nel sangue, nella vita e nella morte Cristo diviene ‘il capo’ dell’umanità salvata. Scrive ancora sant’Ireneo: “Cristo ha ricapitolato in se stesso tutto il sangue effuso da tutti i giusti e da tutti i profeti che sono esistiti dagli inizi” (Adversus haereses V, 14,1; cfr V, 14,2).
4. Bene e male sono, quindi, considerati alla luce dell’opera redentrice di Cristo. Essa, come fa intuire Paolo, coinvolge tutto il creato, nella varietà delle sue componenti (cfr Rm 8,18-30). La stessa natura infatti, come è sottoposta al non senso, al degrado e alla devastazione provocata dal peccato, così partecipa alla gioia della liberazione operata da Cristo nello Spirito Santo.
Si delinea, pertanto, l’attuazione piena del progetto originale del Creatore: quello di una creazione in cui Dio e uomo, uomo e donna, umanità e natura siano in armonia, in dialogo, in comunione. Questo progetto, sconvolto dal peccato, è ripreso in modo più mirabile da Cristo, che lo sta attuando misteriosamente ma efficacemente nella realtà presente, in attesa di portarlo a compimento. Gesù stesso ha dichiarato di essere il fulcro e il punto di convergenza di questo disegno di salvezza quando ha affermato: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32). E l’evangelista Giovanni presenta quest’opera proprio come una specie di ricapitolazione, un “riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,52).
5. Quest’opera giungerà a pienezza nel compimento della storia, allorché - è ancora Paolo a ricordarlo - “Dio sarà tutto in tutti” (1Cor 15,28).
L’ultima pagina dell’Apocalisse - che è stata proclamata in apertura del nostro incontro - dipinge a vivi colori questa meta. La Chiesa e lo Spirito attendono e invocano quel momento in cui Cristo “consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza... L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa (Dio) ha posto sotto i piedi” del suo Figlio (1Cor 15,24.26).
Al termine di questa battaglia - cantata in pagine mirabili dall’Apocalisse - Cristo compirà la ‘ricapitolazione’ e coloro che saranno uniti a lui formeranno la comunità dei redenti, che “non sarà più ferita dal peccato, dalle impurità, dall’amor proprio, che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica, nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile agli eletti, sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di reciproca comunione” (CCC, 1045).
La Chiesa, sposa innamorata dell’Agnello, con lo sguardofisso a quel giorno di luce, eleva l’invocazione ardente:“Maranathà” (1Cor 16,22), “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20).
* FONTE: VATICAN.VA, 14 FEBBRAIO 2001 (RIPRESA PARZIALE)
*
NOTA:
PER UNA RICAPITOLAZIONE ANTROPOLOGICAMENTE "INTERA" IN GESU’ ("ECCE HOMO"), NON ANDROLOGICAMENTE "DIMEZZATA" IN PAOLO ("ECCE VIR")!
- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- FILOLOGIA E DIRITTO: LEZIONE DI PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei : "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
- FILOLOGIA E RELIGIONE: LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
DUE SOLI IN TERRA E UNO SOLE IN CIELO. La Monarchia di Dante è una lezione di antropologia prima che di politica: il giardino dell’intera umanità (impero e chiesa) è uno solo - o l’aiuola della guerra o il paradiso terrestre
FLS
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- L’Anno speciale su San Giuseppe si è concluso l’8 dicembre scorso, ma "cosa rappresenta San Giuseppe per Lei?". Intervista del Papa (di A. Monda - A. Gisotti).13 gennaio 2022, di Federico La Sala
Francesco: i genitori che affrontano ogni sfida per i loro figli sono eroi
Intervista del Papa con i media vaticani sull’essere genitori al tempo del Covid e la testimonianza di San Giuseppe, esempio di forza e tenerezza per i padri di oggi
di Andrea Monda - Alessandro Gisotti *
L’Anno speciale su San Giuseppe si è concluso l’8 dicembre scorso, ma l’attenzione e l’amore di Papa Francesco per questo Santo non si sono conclusi e anzi si sviluppano ulteriormente con le catechesi che, dal 17 novembre scorso, sta incentrando sulla figura del Patrono della Chiesa universale. Da parte nostra, L’Osservatore Romano ha pubblicato una rubrica mensile, lungo tutto il 2021 e ripresa anche dal sito Vatican News, sulla Patris Corde dedicando ogni numero ad un capitolo della Lettera Apostolica su San Giuseppe.
 Questa rubrica che ha parlato di padri, ma anche di figli e di madri in dialogo ideale con lo Sposo di Maria, ha suscitato in noi il desiderio di poter confrontarci con il Papa proprio sul tema della paternità nelle sue più diverse sfaccettature, sfide e complessità.
Questa rubrica che ha parlato di padri, ma anche di figli e di madri in dialogo ideale con lo Sposo di Maria, ha suscitato in noi il desiderio di poter confrontarci con il Papa proprio sul tema della paternità nelle sue più diverse sfaccettature, sfide e complessità.
 Ne è scaturita questa intervista in cui Francesco risponde alle nostre domande mostrando tutto il suo amore per la famiglia, la sua prossimità per chi sperimenta la sofferenza e l’abbraccio della Chiesa ai padri e alle madri che oggi devono affrontare mille difficoltà per dare un futuro ai propri figli.
Ne è scaturita questa intervista in cui Francesco risponde alle nostre domande mostrando tutto il suo amore per la famiglia, la sua prossimità per chi sperimenta la sofferenza e l’abbraccio della Chiesa ai padri e alle madri che oggi devono affrontare mille difficoltà per dare un futuro ai propri figli.Santo Padre, Lei ha indetto un Anno speciale dedicato a San Giuseppe, ha scritto una lettera, la Patris Corde, e sta svolgendo un ciclo di catechesi tutte dedicate alla sua figura. Cosa rappresenta San Giuseppe per Lei?
Non ho mai nascosto la sintonia che sento nei confronti della figura di San Giuseppe. Credo che questo venga dalla mia infanzia, dalla mia formazione. Da sempre ho coltivato una devozione speciale nei confronti di San Giuseppe perché credo che la sua figura rappresenti, in maniera bella e speciale, che cosa dovrebbe essere la fede cristiana per ciascuno di noi. Giuseppe infatti è un uomo normale e la sua santità consiste proprio nell’essersi fatto santo attraverso le circostanze belle e brutte che ha dovuto vivere ed affrontare. Non possiamo però nemmeno nascondere il fatto che San Giuseppe lo ritroviamo nel Vangelo, soprattutto nei racconti di Matteo e di Luca, come un protagonista importante degli inizi della storia della salvezza. Infatti, gli eventi che hanno visto la nascita di Gesù sono stati eventi difficili, pieni di ostacoli, di problemi, di persecuzioni, di buio, e Dio per venire incontro a Suo Figlio che nasceva nel mondo gli mette accanto Maria e Giuseppe. Se Maria è colei che ha dato al mondo il Verbo fatto carne, Giuseppe è colui che lo ha difeso, che lo ha protetto, che lo ha nutrito, che lo ha fatto crescere. In lui potremmo dire c’è l’uomo dei tempi difficili, l’uomo concreto, l’uomo che sa prendersi la responsabilità. In questo senso in San Giuseppe si uniscono due caratteristiche. Da una parte la sua spiccata spiritualità che viene tradotta nel Vangelo attraverso le storie dei sogni; questi racconti testimoniano la capacità di Giuseppe nel saper ascoltare Dio che parla al suo cuore. Solo una persona che prega, che ha un’intensa vita spirituale, può avere anche la capacità di saper distinguere la voce di Dio in mezzo alle tante voci che ci abitano. Accanto a questa caratteristica poi ce n’è un’altra: Giuseppe è l’uomo concreto, cioè l’uomo che affronta i problemi con estrema praticità, e davanti alle difficoltà e agli ostacoli, egli non assume mai la posizione del vittimismo. Si mette invece sempre nella prospettiva di reagire, di corrispondere, di fidarsi di Dio e di trovare una soluzione in maniera creativa.
Questa rinnovata attenzione a San Giuseppe in questo momento di così grande prova assume un significato particolare?
Il tempo che stiamo vivendo è un tempo difficile segnato dalla pandemia del coronavirus. Molte persone soffrono, molte famiglie sono in difficoltà, tante persone sono assediate dall’angoscia della morte, di un futuro incerto. Ho pensato che proprio in un tempo così difficile avevamo bisogno di qualcuno che poteva incoraggiarci, aiutarci, ispirarci, per capire qual è il modo giusto per sapere affrontare questi momenti di buio. Giuseppe è un testimone luminoso in tempi bui. Ecco perché era giusto dare spazio a lui in questo tempo per poter ritrovare la strada.
Il suo ministero petrino è iniziato proprio il 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe...
Ho considerato sempre una delicatezza del cielo poter iniziare il mio ministero petrino il 19 marzo. Credo che in qualche modo San Giuseppe mi abbia voluto dire che avrebbe continuato ad aiutarmi, ad essermi accanto, e io avrei potuto continuare a pensare a lui come a un amico a cui rivolgermi, a cui affidarmi, a cui chiedere di intercedere e di pregare per me. Ma certamente questo rapporto che è dato della comunione dei Santi non è riservato solo a me, penso che potrà essere di aiuto per molti. Ecco perché l’anno dedicato a San Giuseppe spero abbia fatto riscoprire nel cuore di molti cristiani il valore profondo della comunione dei Santi che non è una comunione astratta ma è una comunione concreta che si esprime in una relazione concreta e ha delle conseguenze concrete.
Nella rubrica sulla Patris Corde, ospitata dal nostro giornale durante l’Anno speciale dedicato a San Giuseppe, abbiamo intrecciato la vita del Santo con quella dei padri, ma anche dei figli di oggi. Cosa i figli di oggi, cioè i padri di domani, possono ricevere dal dialogo con San Giuseppe?
Non si nasce padri ma certamente tutti nasciamo figli. Questa è la prima cosa che dobbiamo considerare, cioè ciascuno di noi al di là di quello che la vita gli ha riservato è innanzitutto un figlio, è stato affidato a qualcuno, proviene da una relazione importante che lo ha fatto crescere e che lo ha condizionato nel bene o nel male. Avere questa relazione, e riconoscerne la sua importanza nella propria vita, significa comprendere che un giorno, quando avremo la responsabilità della vita di qualcuno, cioè quando dovremo esercitare una paternità, porteremo con noi innanzitutto l’esperienza che abbiamo fatto personalmente. Ed è importante allora poter riflettere su questa esperienza personale per non ripetere gli stessi errori e per fare tesoro delle cose belle che abbiamo vissuto. Sono convinto che il rapporto di paternità che Giuseppe aveva con Gesù ha talmente tanto influenzato la sua vita fino al punto che la futura predicazione di Gesù è piena di immagini e riferimenti prese proprio dall’immaginario paterno. Gesù ad esempio dice che Dio è Padre, e non può lasciarci indifferenti questa affermazione specie pensando a quella che è stata la sua personale esperienza umana di paternità. Ciò sta a significare che Giuseppe ha fatto talmente tanto bene il padre fino al punto che Gesù trova nell’amore e nella paternità di quest’uomo il riferimento più bello da dare a Dio. Potremmo dire che i figli di oggi che diventeranno i padri di domani dovrebbero domandarsi quali padri hanno avuto e che padri vogliono diventare. Non devono lasciare che il ruolo paterno sia frutto del caso o semplicemente della conseguenza di un’esperienza fatta in passato, ma che consapevolmente possano decidere in che modo voler bene a qualcuno, in che modo prendersi la responsabilità di qualcuno.
Nell’ultimo capitolo di Patris Corde si parla di Giuseppe come padre nell’ombra. Un padre che sa essere presente ma lasciando libero il figlio di crescere. È possibile questo in una società che sembra premiare solo chi occupa spazi e visibilità?
Una delle caratteristiche più belle dell’amore, e non solo della paternità, è appunto la libertà. L’amore genera sempre libertà, l’amore non deve mai diventare prigione, possesso. Giuseppe ci mostra la capacità di aver cura di Gesù senza mai impossessarsene, senza mai volerlo manovrare senza mai volerlo distrarre da quella che è la sua missione. Credo che questo sia molto importante come verifica della nostra capacità di amare e anche della nostra capacità di saper fare un passo indietro. Un buon padre è tale quando sa togliersi al momento opportuno affinché il figlio possa emergere con la sua bellezza, con la sua unicità, con le sue scelte, con la sua vocazione. In questo senso in ogni relazione di bene bisogna rinunciare a voler imporre dall’alto un’immagine, un’aspettativa, una visibilità appunto, un riempire completamente e sempre la scena con un eccessivo protagonismo. La caratteristica tutta giuseppina di sapersi mettere da parte, l’umiltà che è la capacità anche di passare in seconda linea, è forse l’aspetto più decisivo dell’amore che Giuseppe mostra nei confronti di Gesù. In questo senso è un personaggio importante, oserei dire essenziale nella biografia di Gesù, proprio perché a un certo punto sa defilarsi dalla scena affinché Gesù possa splendere in tutta la sua vocazione, in tutta la sua missione. Ad immagine di Giuseppe noi dobbiamo domandarci se siamo in grado di saper fare un passo indietro, di permettere all’altro, e soprattutto a chi ci è affidato, di trovare in noi un riferimento ma mai un ostacolo.
Più volte Lei ha denunciato che la paternità oggi è in crisi. Cosa si può fare, cosa può fare la Chiesa, per ridare forza alla relazione padre-figlio, fondamentale per la società?
Quando pensiamo alla Chiesa la pensiamo sempre come Madre, e questa non è certamente una cosa sbagliata. Anche io in questi anni ho cercato di insistere molto su questa prospettiva perché il modo di esercitare la maternità della Chiesa è la misericordia, cioè è quell’amore che genera e rigenera alla vita. Il perdono, la riconciliazione, non sono forse un modo attraverso cui noi veniamo rimessi in piedi? Non è un modo attraverso cui noi riceviamo nuovamente la vita perché riceviamo un’altra possibilità? Non può esistere una Chiesa di Gesù Cristo se non attraverso la misericordia! Ma credo che dovremmo avere il coraggio di dire che la Chiesa non dovrebbe essere solo materna ma anche paterna. È chiamata cioè a esercitare un ministero paterno non paternalistico. E quando dico che la Chiesa deve recuperare questo aspetto paterno mi riferisco proprio alla capacità tutta paterna di mettere i figli in condizione di prendersi le proprie responsabilità, di esercitare la propria libertà, di fare delle scelte. Se da una parte la misericordia ci sana, ci guarisce, ci consola, ci incoraggia, dall’altra parte l’amore di Dio non si limita semplicemente a perdonare, a guarire, ma l’amore di Dio ci spinge a prendere delle decisioni, a prendere il largo.
A volte la paura, ancor più in questo tempo di pandemia, sembra paralizzare questo slancio...
Sì, questo periodo storico è un periodo segnato dall’incapacità di prendere delle decisioni grandi nella propria vita. I nostri giovani molto spesso hanno paura di decidere, di scegliere, di mettersi in gioco. Una Chiesa è tale non solo quando dice sì o di no, ma soprattutto quando incoraggia e rende possibile le grandi scelte. E ogni scelta ha sempre delle conseguenze e dei rischi, ma a volte per paura delle conseguenze e dei rischi rimaniamo paralizzati e non riusciamo a fare nulla e a scegliere nulla. Un vero padre non ti dice che andrà sempre tutto bene ma che se anche ti troverai nella situazione in cui le cose non andranno bene tu potrai affrontare e vivere con dignità anche quei momenti, anche quei fallimenti. Una persona matura la si riconosce non nelle vittorie ma nel modo con cui sa viver un fallimento. È proprio nell’esperienza della caduta e della debolezza che si riconosce il carattere di una persona.
Per Lei è molto importante la paternità spirituale. I sacerdoti come possono essere padri?
Dicevamo prima che la paternità non è una cosa scontata, non si nasce padri, al massimo lo si diventa. Ugualmente, un sacerdote non nasce già padre ma deve impararlo un po’ alla volta, a partire innanzitutto dal suo riconoscersi figlio di Dio ma poi anche figlio della Chiesa. E la Chiesa non è un concetto astratto è sempre il volto di qualcuno, una situazione concreta, qualcosa a cui noi possiamo dare un nome ben preciso. La nostra fede l’abbiamo ricevuta sempre attraverso la relazione con qualcuno. La fede cristiana non è qualcosa che può essere appresa dai libri o dai semplici ragionamenti, è sempre invece un passaggio esistenziale che passa attraverso le relazioni. Così la nostra esperienza di fede nasce sempre dalla testimonianza di qualcuno. Dobbiamo quindi domandarci in che modo viviamo la gratitudine nei confronti di queste persone, e soprattutto se conserviamo quella capacità critica di saper anche distinguere ciò che invece non di buono è potuto passare attraverso di loro. La vita spirituale non è diversa dalla vita umana. Se un buon padre, umanamente parlando, è tale perché aiuta il figlio a diventare se stesso, rendendo possibile la sua libertà e spingendolo alle grandi decisioni, ugualmente un buon padre spirituale è tale non quando si sostituisce alla coscienza delle persone che si affidano a lui, non quando risponde alle domande che queste persone si portano nel cuore, non quando spadroneggia sulla vita di chi gli è affidato, ma quando in maniera discreta e allo stesso tempo ferma riesce a indicare la strada, fornire chiavi di lettura diverse, aiutare nel discernimento.
Cosa è più urgente oggi per dare forza a questa dimensione spirituale della paternità?
La paternità spirituale molto spesso è un dono che nasce soprattutto dall’esperienza. Un padre spirituale può condividere non tanto le sue competenze teoriche, ma soprattutto la sua personale esperienza. Solo così può essere utile a un figlio. Si sente una grande urgenza, in questo momento storico, di relazioni significative che potremmo definire di paternità spirituale, ma - permettetemi di dire - anche di maternità spirituale, perché questo ruolo di accompagnamento non è una prerogativa maschile o soltanto dei sacerdoti. Ci sono tante brave religiose, tante consacrate, ma anche tanti laici e tante laiche che hanno un bagaglio di esperienza tale da poter condividere con altre persone. In questo senso il rapporto spirituale è una di quelle relazioni che dobbiamo riscoprire con più forza in questo momento storico senza mai confonderlo con altri percorsi di natura psicologica o terapeutica.
Tra le drammatiche conseguenze del Covid c’è anche la perdita di lavoro di tanti padri. Cosa si sente di dire a questi papà in difficoltà?
Sento molto vicino il dramma di quelle famiglie, di quei padri e di quelle madri che stanno vivendo una particolare difficoltà, aggravata soprattutto a causa della pandemia. Credo che non sia una sofferenza facile da affrontare quella di non riuscire a dare il pane ai propri figli, e di sentirsi addosso la responsabilità della vita degli altri. In questo senso la mia preghiera, la mia vicinanza ma anche tutto il sostegno della Chiesa è per queste persone, per questi ultimi. Ma penso anche a tanti padri, a tante madri, a tante famiglie che scappano dalle guerre, che sono respinte ai confini dell’Europa e non solo, e che vivono situazioni di dolore, di ingiustizia e che nessuno prende sul serio o ignora volutamente. Vorrei dire a questi padri, a queste madri, che per me sono degli eroi perché trovo in loro il coraggio di chi rischia la propria vita per amore dei propri figli, per amore della propria famiglia. Anche Maria e Giuseppe hanno sperimentato questo esilio, questa prova, dovendo scappare in un paese straniero a causa della violenza e del potere di Erode. Questa loro sofferenza li rende vicini proprio a questi fratelli che oggi soffrono le medesime prove. Questi padri si rivolgano con fiducia a San Giuseppe sapendo che come padre egli stesso ha sperimentato la stessa esperienza, la stessa ingiustizia. E a tutti loro e alle loro famiglie vorrei dire di non sentirsi soli! Il Papa si ricorda di loro sempre e per quanto possibile continuerà a dare loro voce e a non dimenticarli.
*Fonte: Vatican-News, 13 gennaio 2022
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA! - DEUS CHARITAS EST. La via per sviluppare "il senso della paternita e della maternita’ e rinascere!5 gennaio 2022, di Federico La Sala
#ANTROPOLOGIA #EPIFANIA E #MAGI_A.
Nessuno ha mai visto Dio;
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi.
"Deus CHARITAS est" (1 Gv. 4:8):
su questa via,
ogni #essereumano può #sviluppare
"il senso della paternità e della maternità"
(Teresa d’Avila insegna)! -
e rinascere,
diventare "bambino" (Gv. 3.7).
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- EPIFANIA2022: UDIENZA GENERALE (PAPA FRANCESCO, 5 GEN.).5 gennaio 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. EPIFANIA 2022. Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri....
PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE
Aula Paolo VI
Mercoledì, 5 gennaio 2022
Catechesi su San Giuseppe: 6. San Giuseppe, il padre putativo di Gesù *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi mediteremo su San Giuseppe come padre di Gesù. Gli Evangelisti Matteo e Luca lo presentano come padre putativo di Gesù e non come padre biologico. Matteo lo precisa, evitando la formula “generò”, usata nella genealogia per tutti gli antenati di Gesù; ma lo definisce «sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù detto il Cristo» (1,16). Mentre Luca lo afferma dicendo che era padre di Gesù «come si riteneva» (3,23), cioè appariva come padre.
Per comprendere la paternità putativa o legale di Giuseppe, occorre tener presente che anticamente in Oriente era molto frequente, più di quanto non sia ai nostri giorni, l’istituto dell’adozione. Si pensi al caso comune presso Israele del “levirato” così formulato nel Deuteronomio: «Quando uno dei fratelli morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, con un estraneo. Suo cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il primogenito che ella metterà al mondo, andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele» (25,5-6). In altre parole, il genitore di questo figlio è il cognato, ma il padre legale resta il defunto, che attribuisce al neonato tutti i diritti ereditari. Lo scopo di questa legge era duplice: assicurare la discendenza al defunto e la conservazione del patrimonio.
Come padre ufficiale di Gesù, Giuseppe esercita il diritto di imporre il nome al figlio, riconoscendolo giuridicamente. Giuridicamente è il padre, ma non generativamente, non l’ha generato.
Anticamente il nome era il compendio dell’identità di una persona. Cambiare il nome significava cambiare sé stessi, come nel caso di Abramo, il cui nome Dio cambia in “Abraham”, che significa “padre di molti”, «perché - dice il Libro della Genesi - sarà padre di una moltitudine di nazioni» (17,5). Così per Giacobbe, che viene chiamato “Israele”, che significa “colui che lotta con Dio”, perché ha lottato con Dio per obbligarlo a dargli la benedizione (cfr Gen 32,29; 35,10).
Ma soprattutto dare il nome a qualcuno o a qualcosa significava affermare la propria autorità su ciò che veniva denominato, come fece Adamo quando conferì un nome a tutti gli animali (cfr Gen 2,19-20).
Giuseppe sa già che per il figlio di Maria c’è un nome preparato da Dio - il nome a Gesù lo dà il vero padre di Gesù, Dio - il nome “Gesù”, che significa “Il Signore salva”, come gli spiega l’Angelo: «Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Questo particolare aspetto della figura di Giuseppe ci permette oggi di fare una riflessione sulla paternità e sulla maternità. E questo credo che sia molto importante: pensare alla paternità, oggi. Perché noi viviamo un’epoca di notoria orfanezza. È curioso: la nostra civiltà è un po’ orfana, e si sente, questa orfanezza. Ci aiuti la figura di San Giuseppe a capire come si risolve il senso di orfanezza che oggi ci fa tanto male.
Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri. «Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti» (Lett. ap. Patris corde). Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell’adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l’affetto familiare con chi ne è rimasto privo. Non bisogna avere paura di scegliere la via dell’adozione, di assumere il “rischio” dell’accoglienza. E oggi, anche, con l’orfanezza, c’è un certo egoismo.
 L’altro giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti ... Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e - come diceva uno un po’ umoristicamente - “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la verità.
L’altro giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti ... Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e - come diceva uno un po’ umoristicamente - “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la verità.
 Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore.
Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore.
 Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore. Tempo fa ho sentito la testimonianza di una persona, un dottore - importante il suo mestiere - non aveva figli e con la moglie hanno deciso di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne hanno offerto loro uno e hanno detto: “Ma, non sappiamo come andrà la salute di questo. Forse può avere qualche malattia”. E lui disse - lo aveva visto - disse: “Se lei mi avesse domandato questo prima di entrare, forse avrei detto di no. Ma l’ho visto: me lo porto”. Questa è la voglia di essere padre, di essere madre anche nell’adozione. Non abbiate paura di questo.
Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore. Tempo fa ho sentito la testimonianza di una persona, un dottore - importante il suo mestiere - non aveva figli e con la moglie hanno deciso di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne hanno offerto loro uno e hanno detto: “Ma, non sappiamo come andrà la salute di questo. Forse può avere qualche malattia”. E lui disse - lo aveva visto - disse: “Se lei mi avesse domandato questo prima di entrare, forse avrei detto di no. Ma l’ho visto: me lo porto”. Questa è la voglia di essere padre, di essere madre anche nell’adozione. Non abbiate paura di questo.Prego perché nessuno si senta privo di un legame di amore paterno. E coloro che sono ammalati di orfanezza vadano avanti senza questo sentimento così brutto. Possa San Giuseppe esercitare la sua protezione e il suo aiuto sugli orfani; e interceda per le coppie che desiderano avere un figlio. Per questo preghiamo insieme:
San Giuseppe,
 tu che hai amato Gesù con amore di padre,
tu che hai amato Gesù con amore di padre,
 sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia
sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia
 e desiderano un papà e una mamma.
e desiderano un papà e una mamma.
 Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli,
Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli,
 aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande.
aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande.
 Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame,
Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame,
 una persona che si prenda cura di lui o di lei;
una persona che si prenda cura di lui o di lei;
 e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita,
e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita,
 perché spalanchi il cuore all’amore.
perché spalanchi il cuore all’amore. Saluti [...]
Saluti [...]* Fonte: Vatican.va, 05.01.2022 (ripresa parziale).
NOTA:
ANTROPOLOGIA ED #EPIFANIA. "A un uomo e a una donna che non sviluppano il senso della paternità e della maternità manca qualcosa di fondamentale". Che cosa? "#Eccehomo. Come si diventa ciò che si è" (#Nietzsche): sapere #come nascono i bambini.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- «Il Natale con Ignazio di Loyola, lettore della “Vita Christi” di Ludolfo di Sassonia» (di Filippo Rizzi)30 dicembre 2021, di Federico La Sala
Spiritualità.
«Il Natale secondo sant’Ignazio»
Il gesuita Cattaneo: impariamo grazie agli Esercizi del santo basco a sperimentare lo stesso stupore dei pastori a Betlemme. Tra le fonti di questo percorso la Vita Christi di Ludolfo di Sassonia
di Filippo Rizzi (Avvenire, giovedì 30 dicembre 2021)
- Ignazio di Loyola riceve tra le braccia il Bambino Gesù. Dipinto di Tommaso Missiroli, secolo XVII - Pinacoteca Comunale di Faenza
Contemplare il mistero del Natale ponendo il proprio sguardo verso Betlemme e immaginando quasi noi stessi di fronte alla mangiatoia per metterci così al servizio e in “colloquio interiore” con Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù. È l’immagine suggestiva con cui Ignazio di Loyola (1491-1556) negli Esercizi Spirituali (paragrafi 111-117) esorta a riscoprire il senso della Natività. Si tratta di un invito, quello del santo basco, volto a sperimentare in un’autentica «composizione di luogo» la stessa meraviglia provata dai pastori di fronte alla visione della capanna dove nacque Gesù più di duemila anni fa.
Recentemente su questo argomento si è soffermato sulla rivista della Compagnia di Gesù La Civiltà Cattolica il gesuita Enrico Cattaneo, che ha affrontato il tema: Il Natale con Ignazio di Loyola, lettore della “Vita Christi”. Il saggio del religioso ignaziano, già docente di patrologia alla Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale (sezione San Luigi) di Napoli e al Pontificio Istituto Orientale di Roma, è stato pensato anche alla luce di un importante giubileo: i 500 anni dalla conversione di Ignazio dopo la ferita a Pamplona, avvenuta il 20 maggio 1521.
 L’Anno Ignaziano apertosi il 20 maggio scorso a Pamplona si chiuderà il 31 luglio prossimo a Roma, nella memoria liturgica dedicata al fondatore dei gesuiti.
L’Anno Ignaziano apertosi il 20 maggio scorso a Pamplona si chiuderà il 31 luglio prossimo a Roma, nella memoria liturgica dedicata al fondatore dei gesuiti.Cuore delle riflessione di padre Cattaneo non sono solo le fonti ignaziane sul Natale ma anche l’opera Vita Christi del grande scrittore ascetico il domenicano e poi certosino Ludolfo di Sassonia (1295-1377). «Molto di quello che Ignazio sperimentò negli Esercizi e nei suoi colloqui interiori con il Signore - dice ad Avvenire lo studioso - trova il suo debito negli scritti di Ludolfo».
 E annota: «Nella sua Autobiografia, Ignazio stesso spiega come sia arrivato a leggere i tre grossi volumi della Vita Christi di Ludolfo di Sassonia. Costretto a letto per una frattura alla gamba, si annoiava a stare senza far niente. Allora chiese dei libri da leggere, possibilmente libri di avventure cavalleresche (Ignazio era ancora un uomo di mondo), ma nella casa di suo fratello c’erano solo dei libri religiosi, una Vita di Cristo e delle Vite di santi. Egli li lesse più per ammazzare il tempo che per vero interesse, ma proprio da quella lettura venne la sua conversione». Un invito dunque quello suggerito dai due grandi scrittori ascetici Ignazio e Ludolfo a entrare nel mistero della Natività quasi con gli occhi di un bambino che scruta la “magia del presepe”. «La Vita Christi di Ludolfo di Sassonia è una specie di “Summa” di vita cristiana a partire dai Vangeli. In effetti gli Esercizi hanno come traccia i Vangeli, dalla Natività alla Risurrezione. Da Ludolfo Iñigo impara soprattutto quella che viene chiamata la “composizione di luogo”, cioè immaginare la scena che sto meditando - in questo caso viene da pensare al nostro Natale - in tutti i particolari, in modo da farmi partecipe dell’avvenimento».
E annota: «Nella sua Autobiografia, Ignazio stesso spiega come sia arrivato a leggere i tre grossi volumi della Vita Christi di Ludolfo di Sassonia. Costretto a letto per una frattura alla gamba, si annoiava a stare senza far niente. Allora chiese dei libri da leggere, possibilmente libri di avventure cavalleresche (Ignazio era ancora un uomo di mondo), ma nella casa di suo fratello c’erano solo dei libri religiosi, una Vita di Cristo e delle Vite di santi. Egli li lesse più per ammazzare il tempo che per vero interesse, ma proprio da quella lettura venne la sua conversione». Un invito dunque quello suggerito dai due grandi scrittori ascetici Ignazio e Ludolfo a entrare nel mistero della Natività quasi con gli occhi di un bambino che scruta la “magia del presepe”. «La Vita Christi di Ludolfo di Sassonia è una specie di “Summa” di vita cristiana a partire dai Vangeli. In effetti gli Esercizi hanno come traccia i Vangeli, dalla Natività alla Risurrezione. Da Ludolfo Iñigo impara soprattutto quella che viene chiamata la “composizione di luogo”, cioè immaginare la scena che sto meditando - in questo caso viene da pensare al nostro Natale - in tutti i particolari, in modo da farmi partecipe dell’avvenimento».Padre Cattaneo accenna a un altro aspetto: l’intimo significato del Natale che disvela già dentro di sé il mistero del «patibolo della Croce». Ma non solo che l’annuncio della nascita del Figlio dell’uomo è stato indirizzato prima di tutto ai poveri e ai semplici. «Ludolfo e di riflesso Ignazio vedono nella nascita di Gesù il Signore dei Signori, il Re dei re, i segni dell’umiltà di Dio, perché i pastori non avessero timore di accostarsi a Lui. Questo vale per tutti, anche per noi. È quanto continua a ripeterci papa Francesco con il suo magistero: non abbiate timore di avvicinarvi al Signore, che non vi caccerà via, perché è venuto a salvarvi. Basti pensare al canto degli angeli: “Gloria a Dio e pace gli uomini”. Forse dobbiamo anzitutto fare pace con Dio, che abbiamo messo sotto accusa in questo difficile momento anche a causa del Covid-19».
Contemplare il Natale con occhi diversi attraverso il “colloquio interiore”
Un altro suggerimento che arriva da questi testi è imparare a contemplare il Natale con occhi diversi. «Ludolfo, per esempio, esorta idealmente a entrare nella mangiatoia, a mettersi ai piedi del Bambino e a “pregare la Madonna che te lo porga e che ti permetta di prenderlo in braccio e baciarlo con rispetto...”».
 Un’altra esortazione infine, dopo la contemplazione, è quella di imparare a pregare. «Sant’Ignazio ha preso certamente da qui il suggerimento di terminare ogni Esercizio con un “colloquio”, ora con la Madonna, perché interceda presso il Figlio suo, ora con il Signore, stesso, perché interceda presso il Padre. Lo chiama “colloquio” perché deve essere “come un amico che parla con un amico”, “ora chiedendo qualche grazia, ora chiedendo perdono, ora comunicando le proprie cose e chiedendo consigli su di esse”. E per il Natale, la richiesta è quella “che rinasca in me la santità di una vita nuova”».
Un’altra esortazione infine, dopo la contemplazione, è quella di imparare a pregare. «Sant’Ignazio ha preso certamente da qui il suggerimento di terminare ogni Esercizio con un “colloquio”, ora con la Madonna, perché interceda presso il Figlio suo, ora con il Signore, stesso, perché interceda presso il Padre. Lo chiama “colloquio” perché deve essere “come un amico che parla con un amico”, “ora chiedendo qualche grazia, ora chiedendo perdono, ora comunicando le proprie cose e chiedendo consigli su di esse”. E per il Natale, la richiesta è quella “che rinasca in me la santità di una vita nuova”». -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ---- Udienza. La nuova preghiera del Papa a San Giuseppe per il 2022: proteggi chi fugge ("Avvenire").29 dicembre 2021, di Federico La Sala
Udienza. La nuova preghiera del Papa a San Giuseppe per il 2022: proteggi chi fugge
A conclusione dell’ultima udienza generale del 2021, Francesco dona ai fedeli una nuova preghiera allo sposo di Maria, al quale affida i perseguitati di oggi
di Redazione Internet (Avvenire, mercoledì 29 dicembre 2021)
- [Foto] La statuina di San Giuseppe nel presepe allestito in Aula Paolo VI - Vatican news
Al termine dell’ultima udienza del 2021, in Aula Paolo VI, papa Francesco dona ai fedeli di tutto il mondo una nuova preghiera a San Giuseppe, uomo giusto e coraggioso, come è stato descritto nella catechesi in cui ha rievocato la fuga dell Sacra Famiglia in Egitto per sfuggire alla persecuzione di Erode, per domandarne la protezione per la vita dei migranti, degli abbandonati e dei perseguitati del nostro tempo.
Ecco il testo:
“San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire tu che sei stato costretto a fuggire per salvare la vita alle persone più care, proteggi tutti coloro che fuggono a causa della guerra, dell’odio, della fame. Sostienili nelle loro difficoltà, rafforzali nella speranza e fa’ che incontrino accoglienza e solidarietà. Guida i loro passi e apri i cuori di coloro che possono aiutarli. Amen.”
Un testo breve in cui si condensano le parole della Patris Corde, la lettera con cui il Papa ha aperto, l’8 dicembre 2020, l’Anno dedicato a San Giuseppe, concluso, sempre l’8 dicembre scorso, durante la visita alla Comunità Cenacolo.
Con la preghiera di oggi, papa Francesco chiede che quella allo sposo di Maria non rimanga solo un’orazione personale ma che tutti i fedeli si rivolgano a lui in questo 2022 e mettano nelle sue mani speranze e difficoltà di “coloro che sono vittime di circostanze avverse e si sentono per questo scoraggiati e abbandonati”.
Da qui l’intenzione di preghiera rivolta ai pellegrini polacchi ma valida per tutti i fedeli del mondo, in vista del nuovo anno:
“Per l’intercessione di Maria Santissima Madre di Dio e di San Giuseppe suo sposo preghiamo che l’anno prossimo sia felice per noi e per tutti gli uomini, che cessi la pandemia e possiamo godere della pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle società e nel mondo”.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- ARTE E ANTROPOLOGIA. Quel padre nell’ombra. Il più bel dipinto su san Giuseppe rimasto per secoli ignoto (di Claudio Strinati - L’Osservatore Romano).6 dicembre 2021, di Federico La Sala
ARTE, RELIGIONE, E ANTROPOLOGIA. SAN GIUSEPPE, TERESA D’AVILA, E IL CARMELO TERESIANO...
#DIVINACOMMEDIA: #DUESOLI (#DANTE2021)! PER UNA MIGLIORE #LETTURA DELLA FIGURA DEL PADRE NELL’OMBRA #RICORDARSI DEL #RICONOSCIMENTO DI #SANGIUSEPPE PROPOSTO DA #TERESADAVILA E DI #COMENASCONOIBAMBINI
Quel padre nell’ombra
Il più bel dipinto su san Giuseppe rimasto per secoli ignoto
di Claudio Strinati (L’Osservatore Romano, 04 dicembre 2021)
Uomo probo e riservato, padre maturo, amorevole, sollecito. Questo è il san Giuseppe dipinto nella bellissima pala d’ altare della chiesa di Santa Maria Assunta nel piccolo remoto borgo di Serrone, oggi depositata presso il museo capitolare diocesano di Foligno. Un’ opera d’ arte tanto importante in un luogo così appartato! Un grande dipinto ad olio su tela, alto quasi tre metri per due, rimasto ignoto per secoli fino a che, una quarantina d’ anni fa, fu visto e studiato da un manipolo di esperti guidati da Bruno Toscano, uno dei maggiori storici dell’arte del nostro tempo.
Ne rimasero incantati ma si accorsero che non c’erano testimonianze o documenti antichi che parlassero dell’autore. E non c’erano firme sull’opera tranne una lettera G segnata sulla pialla dietro alla figura del tenero Bambino Gesù in piedi. Lettera che può far individuare l’autore in un artista misterioso e pressoché dimenticato, Giovanni Demostene Ensio, aristocratico pittore attivo in area romana per committenti provenzali tra fine Cinquecento e inizio Seicento, aggregato all’ Accademia di San Luca e noto solo per lusinghiere testimonianze documentarie.
Risultò, infatti, evidente, oltre alla meravigliosa bellezza, la mirabile composizione dei colori fatti di materiali preziosi di origine soprattutto minerale, di cui si sa che il maestro Giovanni Demostene Ensio fosse tra i pochissimi in quel tempo a utilizzare, confermando l’ ipotesi di Toscano che aveva immaginato un ignoto pittore di origine francese o fiamminga, operoso in Italia nei primi anni del diciassettesimo secolo.
 Il quadro rappresenta la bottega di san Giuseppe che non è qui un semplice artigiano ma un tecnico di primo livello che lavora il legno anche per l’edilizia. Il pittore descrive infatti con cura scientifica, veramente fiamminga, tutti gli strumenti di lavoro, le assi e i piani su cui il maestro ebanista sta lavorando, nonché la poderosa porta di ingresso al laboratorio fabbricata da Giuseppe stesso, appena aperta per far entrare la morbida luce del mattino. Questa rischiara il sorriso sul volto del Bambino Gesù che, sotto gli occhi seri, attenti e scrupolosi del padre sta legando un pezzetto del filo bianco proveniente dal gomitolo utilizzato dalla mamma nel cucito, per fabbricare un giocattolino a forma di croce, chiara premonizione della sua Passione futura. Con amorevole evangelica umiltà, il pittore rappresenta una miriade di cose sparse per il laboratorio, dai trucioli per terra, alla scatola di lavoro della Vergine agli zoccoli abbandonati al suolo. Tutto forgiato da quell’uomo saggio e avveduto. È lui che ha progettato, costruito e attrezzato il grande ambiente compresa la magnifica finestra bifora che si vede in fondo facendolo sembrare una cattedrale piuttosto che un laboratorio. Ed è lui che ha plasmato il clima familiare e morale che genera sia la composta quiete espressa dalla giovane moglie assorta nei suoi pensieri, sia la crescente consapevolezza del divino fanciullo colto nel momento magico della prima scoperta della famiglia intorno a noi e del mondo che si aprirà di fronte.
Il quadro rappresenta la bottega di san Giuseppe che non è qui un semplice artigiano ma un tecnico di primo livello che lavora il legno anche per l’edilizia. Il pittore descrive infatti con cura scientifica, veramente fiamminga, tutti gli strumenti di lavoro, le assi e i piani su cui il maestro ebanista sta lavorando, nonché la poderosa porta di ingresso al laboratorio fabbricata da Giuseppe stesso, appena aperta per far entrare la morbida luce del mattino. Questa rischiara il sorriso sul volto del Bambino Gesù che, sotto gli occhi seri, attenti e scrupolosi del padre sta legando un pezzetto del filo bianco proveniente dal gomitolo utilizzato dalla mamma nel cucito, per fabbricare un giocattolino a forma di croce, chiara premonizione della sua Passione futura. Con amorevole evangelica umiltà, il pittore rappresenta una miriade di cose sparse per il laboratorio, dai trucioli per terra, alla scatola di lavoro della Vergine agli zoccoli abbandonati al suolo. Tutto forgiato da quell’uomo saggio e avveduto. È lui che ha progettato, costruito e attrezzato il grande ambiente compresa la magnifica finestra bifora che si vede in fondo facendolo sembrare una cattedrale piuttosto che un laboratorio. Ed è lui che ha plasmato il clima familiare e morale che genera sia la composta quiete espressa dalla giovane moglie assorta nei suoi pensieri, sia la crescente consapevolezza del divino fanciullo colto nel momento magico della prima scoperta della famiglia intorno a noi e del mondo che si aprirà di fronte.Il volto di Giuseppe immerso nell’ombra è nitidamente percepibile. E in questo modo rifulge il padre putativo della tradizione che significa la funzione paterna svincolata dal fattore biologico primario che compete esclusivamente alla madre.
Quasi che il pittore volesse farci vedere, attraverso tale umanissima rappresentazione di san Giuseppe, come questo principio, insondabile e apparentemente discriminante, non valga solo per lui, ma valga in realtà per tutti gli esseri umani anche se i nostri figli non sono figli di Dio.
Ma il pittore ci dice che invece è proprio così. Tutti, maschi o femmine o quant’altro, siamo, in quanto embrioni, feti e persone, figli di Dio perché il corpo generato dalla madre funziona a seguito dell’esito della fecondazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo ma la vita in sé che possiamo chiamare l’ anima scaturisce da qualcos’ altro che possiamo chiamare il divino.
di Claudio Strinati
 Segretario Generale dell’ Accademia Nazionale di san Luca
Segretario Generale dell’ Accademia Nazionale di san Luca
NOTA:
ARTE, RELIGIONE,E ANTROPOLOGIA.
SAN GIUSEPPE, TERESA D’AVILA, E IL CARMELO TERESIANO... *
"[...] è bene ricordare che, il culto del santo nel Carmelo entra già dalle origini dell’Ordine. La devozione a san Giuseppe, a livello personale e locale, si viveva fin dalla venuta dei carmelitani in Europa, anche se la festa del santo Patriarca, a livello di Ordine, non appare sino alla seconda metà del XV secolo.
 Tale devozione nel Carmelo teresiano, va essenzialmente unita a santa Teresa. È uno dei legati più ricchi e caratteristici che la Santa lasciò ai suoi figli. Non si comprende il Carmelo teresiano senza san Giuseppe, senza l’esperienza giuseppina della Santa. Per la Santa Madre, i conventi che fonda, a immagine del primo (Avila 1562), sono ‘case’ di san Giuseppe. Per questo procura che la maggior parte di essi porti il nome e titolo di san Giuseppe.
Tale devozione nel Carmelo teresiano, va essenzialmente unita a santa Teresa. È uno dei legati più ricchi e caratteristici che la Santa lasciò ai suoi figli. Non si comprende il Carmelo teresiano senza san Giuseppe, senza l’esperienza giuseppina della Santa. Per la Santa Madre, i conventi che fonda, a immagine del primo (Avila 1562), sono ‘case’ di san Giuseppe. Per questo procura che la maggior parte di essi porti il nome e titolo di san Giuseppe.
 Dei diciassette, fondati dalla Santa, undici stanno sotto il titolo di san Giuseppe. Se non tutte le fondazioni della Santa Madre portano quel titolo, non ce n’è nessuna dove non ci sia un’immagine del Santo che presieda e protegga la comunità. È un’ulteriore manifestazione, più della sua devozione ed esperienza giuseppina, il diffondere nei conventi le immagini del santo, la maggior parte delle quali ancora si conserva.
Dei diciassette, fondati dalla Santa, undici stanno sotto il titolo di san Giuseppe. Se non tutte le fondazioni della Santa Madre portano quel titolo, non ce n’è nessuna dove non ci sia un’immagine del Santo che presieda e protegga la comunità. È un’ulteriore manifestazione, più della sua devozione ed esperienza giuseppina, il diffondere nei conventi le immagini del santo, la maggior parte delle quali ancora si conserva.
 È da notare, a questo riguardo, il dato che portava con sé in tutte le fondazioni, una statua di san Giuseppe, che riceveva il titolo di “Patrocinio di san Giuseppe” [...]" (Antonio Faita, "Un inedito di Giuseppe Sarno: san Giuseppe con Gesù Bambino presso la chiesa teresiana di Gallipoli", Fondazione Terra d’Otranto, 19.03.2020).
È da notare, a questo riguardo, il dato che portava con sé in tutte le fondazioni, una statua di san Giuseppe, che riceveva il titolo di “Patrocinio di san Giuseppe” [...]" (Antonio Faita, "Un inedito di Giuseppe Sarno: san Giuseppe con Gesù Bambino presso la chiesa teresiana di Gallipoli", Fondazione Terra d’Otranto, 19.03.2020).* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. “De Domo David. 49 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò, Fondazione Terra d’Otranto, 10.11.2019).
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- In parole e in opere: così si racconta Gesù. Il cardinal Ravasi ricostruisce la “biografia” di Cristo (di Alessandro Zaccuri).29 ottobre 2021, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA: IL MESSAGGIO EVANGELICO, "IL FIGLIO DELL’UOMO", E IL "DIO AMORE", IL "DEUS CHARITAS"... *
Il nuovo libro di Ravasi. In parole e in opere: così si racconta Gesù
Il cardinal Ravasi ricostruisce la “biografia” di Cristo in una traversata della Scrittura che fa dell’Incarnazione un principio storico e interpretativo
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, mercoledì 27 ottobre 2021)
- [Foto] Giotto, ’L’ingresso a Gerusalemme’ - Padova, Cappella degli Scrovegni
Nessuno meglio del cardinale Gianfranco Ravasi conosce la complessità con la quale è chiamato a confrontarsi chi voglia ripercorrere la vicenda di Gesù. È una tradizione ricchissima, che risale perlomeno alla Vita Iesu Christi data alle stampe nel 1474 dal certosino Ludolfo di Sassonia, precoce best seller di età umanistica del quale si contano 88 edizioni. Ma anche prima, anche nella lunga stagione del Medioevo la storia del Figlio dell’Uomo era stata raccontata più volte, attraverso le immagini della Biblia Pauperum diffusa ovunque in Europa, nelle cattedrali più sfarzose come nelle più remote pievi di campagna. Per non parlare del Novecento, che è l’epoca di Giovanni Papini e di François Mauriac, di Norman Mailer e di José Saramago. Il «pensoso palpito» del Cristo di Ungaretti si percepisce chiaramente anche nel tempo dell’inquietudine e della secolarizzazione, secondo una traiettoria che lo stesso Ravasi ripercorre con la consueta precisione all’inizio di questa sua Biografia di Gesù. Secondo i Vangeli (Cortina, pagine 256, euro 19,00, in libreria dal 28 ottobre). A dispetto dell’apparente semplicità, titolo e sottotitolo meritano di essere esaminati con attenzione, perché comporre una biografia di Gesù “secondo i Vangeli” significa anche addentrarsi in una “biografia dei Vangeli”.
Forte della sua autorità di biblista, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura segue appunto questa strada, che è quella di un’esegesi tanto ragionata quanto appassionata. Non per niente, la “vita di Gesù” che più di ogni altra somiglia a questa di Ravasi è l’estroso Volete andarvene anche voi? di Luigi Santucci, uno scrittore che dello stesso Ravasi è stato amico e perfino complice sul piano spirituale e intellettuale. In quel libro, anziché ricondurre l’esistenza terrena di Cristo a uno schema narrativo, Santucci trasceglieva alcuni brani o versetti salienti e li commentava con la sua sensibilità di narratore e credente. Il metodo di Ravasi è un altro, ma risponde alla medesima logica di aderenza al testo.
C’è una biografia dei Vangeli, dicevamo, che coincide con la scoperta e con la valorizzazione della loro dimensione storica. Ravasi, com’è noto, non ha mai considerato come dato dirimente l’antichità del singolo frammento, preferendo insistere sul principio di storicità interna che preside alla struttura del canone neotestamentario, a sua volta convalidato dalle attestazioni di ambito profano (su tutte, il celebre dispaccio di Plinio il Giovane all’imperatore Traiano e la controversa ma comunque sintomatica menzione da parte di Giuseppe Flavio). Radicati nella storia, i Vangeli non sono tuttavia resoconti storici in senso stretto, ricorda Ravasi. Fin dal principio nel racconto della vita di Gesù gli elementi di cronaca si mescolano con l’interpretazione da parte della comunità dei discepoli, che in questo modo si fa partecipe dell’Incarnazione: proprio perché si è fatto uomo, Cristo può essere fatto oggetto di racconto; proprio perché è Dio, non può essere raccontato se non nella consapevolezza del mistero.
A rigore, la biografia dei Vangeli comincia fuori dai Vangeli stessi. Ravasi indica come punto germinale la dichiarazione di fede che, nella Pasqua dell’anno 57, Paolo riproduce nella Prima lettera ai Corinzi: «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e fu sepolto. È risorto il terzo giorno secondo le Scritture e apparve a Cefa e quindi ai Dodici». La novità buona del kerygma si colloca qui, nell’indissolubilità tra Passione, Risurrezione e testimonianza proclamata dall’annuncio originario. Questo è anche il fuoco prospettico dell’intera Biografia di Gesù, nella quale Ravasi non si limita a passare in rassegna i quattro Vangeli, registrando le peculiarità di ciascuno dei Sinottici e argomentando la singolarità del testo di Giovanni.
L’aspetto più coinvolgente della sua Biografia di Gesù sta nell’individuazione dei grandi nuclei tematici che si ripresentando nelle sequenze narrative maggiori. Quelle riferite alla morte e Risurrezione, anzitutto, ma anche i racconti dell’infanzia, nei quali l’intonazione letteraria si fa più evidente, senza per questo inficiare la consistenza del fatto storico. Particolarmente convincente, fino a imporsi come l’aspetto più originale del libro, è la scelta di concentrarsi in modo specifico sulle due componenti essenziali del linguaggio di Gesù. La parola efficace delle parabole e il gesto eloquente dei miracoli sono indagati da Ravasi in capitoli carichi di spunti per la meditazione personale. «Le mani di Gesù - scrive tra l’altro l’autore - toccano ripetutamente carni malate, operano su persone sofferenti, s’intrecciano con le sue parole di speranza. Piaghe, organi paralizzati, corpi devastati o inerti sono ininterrottamente sotto l’azione di quelle mani».
Così come non comincia nei Vangeli, il racconto della vita di Gesù non si esaurisce in essi. A fianco del canone si situa infatti la lussureggiante biblioteca degli apocrifi, alla quale nel corso del tempo hanno attinto con larghezza artisti, poeti e narratori. Molte immagini alle quali siamo abituati e non poche figure fatte segno di devozione provengono da questa zona che Ravasi non manca di attraversare nelle ultime pagine del libro. Ancora una volta, si ritorna all’essenziale, ai giorni fatidici della condanna a morte e della Pasqua. Ripercorriamo così le peripezie di Pilato, che da personaggio storico diventa nella narrazione degli apocrifi esempio morale. E ci imbattiamo nella “correzione” più struggente, quella che nel Vangelo di Gamaliele rimedia al mancato incontro tra Gesù e la Madre. Episodio poi carissimo alla devozione popolare, a conferma di come la storia «di un Dio che si fa crocifiggere sul Golgota» (è la geniale sintesi di Borges) non smetta mai di essere raccontata.
* NOTARE BENE:
MESSAGGIO EVANGELICO E FIGLIO DELL’UOMO [nel senso di "Adamo" ed "Eva", di "Giuseppe" e "Maria"! - "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo [="Filius hominis" = "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου"] deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34=C.E.I.]).
LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO. Prima lettera ai Corinzi, 11, 1-3: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «aner, andròs - uomo»], e capo di Cristo è Dio" .
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- LA SCIENZA, LA FEDE, E LA NASCITA DEI FIGLI. "La scienza è neutra e solida, non sempre i suoi portavoce" (di Maurizio Patriciello).27 ottobre 2021, di Federico La Sala
Omosessuali e figli.
La scienza è neutra e solida, non sempre i suoi portavoce
di Maurizio Patriciello (Avvenire, mercoledì 27 ottobre 2021)
Lunedì scorso, Stefania si è laureata. Alla fine della festicciola, tra l’altro, ha ringraziato i genitori anche perché «mi hanno insegnato che tra scienza e fede non c’è contrasto», come qualcuno avrebbe voluto farle credere nei suoi anni di studio. Mi sembra un bel traguardo. Mente e cuore meritano di camminare insieme. Guai a separarli. «La via più breve tra due piazze della città non è la più corta ma la più bella», ha scritto martedì su questo giornale, Ferdinando Camon. Poche parole che aprono un abisso.
A Piero Angela siamo tutti debitori, ha fatto entrare, con semplicità, la scienza in casa nostra. Ci ha fatto capire che non c’è niente che non possa essere compreso anche dai bambini e dalle nonne, se solo abbiamo la pazienza e la capacità di spiegarglielo. Piero Angela, giornalista, divulgatore scientifico, uomo di cultura, mai è venuto meno alla severità del dato squisitamente scientifico. Per farlo, negli anni, ha invitato nei suoi programmi esperti di ogni tipo. Loro, dall’alto del loro sapere, si sforzavano di spiegare fenomeni complessi, non a tutti comprensibili, snocciolavano dati, numeri; lui, stimolava la riflessione con le stesse domande che avrebbero fatto gli operai, le casalinghe, i ragazzi che trovavano in quei programmi un ottimo aiuto per la scuola. Era difficile, anche per i suoi più acerrimi critici, trovare sbavature in quelle trasmissioni. Le registrazioni erano ben preparate e curate; lui, sempre elegante, pesava e misurava le parole, i gesti, gli esempi.
Mai e poi mai, Piero Angela, avrebbe permesso a chicchessia di dire che i pulcini nascono come nascono i gattini e i cangurini. La scienza è una cosa seria e va maneggiata con estrema serietà, su questo punto, Angela non ha mai ceduto. Gli anni passano per tutti e tutti, lentamente, ci avviciniamo a quella linea di demarcazione che chiamiamo morte. Interrogato a riguardo, il nostro, l’ha paragonata a una mitragliatrice. Man mano che si avanza nella vita ci avviciniamo a essa.
È triste pensare alla morte come a una sventagliata che ti spazza via. Preferisco riflettere sulle parole di Teresa di Lisieux che poco prima di lasciare questo mondo, sorridendo, disse: «Non sto andando incontro alla morte, ma allo Sposo». Non è questo, però, il punto su cui vorrei riflettere.
 Lunedì, ospite di Fabio Fazio, parlando dei fratelli e delle sorelle omosessuali, Angela ha detto tra l’altro: «Spesso viene vista l’omosessualità come un rapporto fisico, contronatura, in realtà le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso: attrazione, innamoramento, gelosia, vita di coppia, figli... Bisogna capirlo bene». Un discorso non propriamente scientifico e nemmeno razionale.
Lunedì, ospite di Fabio Fazio, parlando dei fratelli e delle sorelle omosessuali, Angela ha detto tra l’altro: «Spesso viene vista l’omosessualità come un rapporto fisico, contronatura, in realtà le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso: attrazione, innamoramento, gelosia, vita di coppia, figli... Bisogna capirlo bene». Un discorso non propriamente scientifico e nemmeno razionale.Un conto è parlare di affettività e vita di coppia, altra cosa è parlare di figli. Strano. Il severo divulgatore scientifico, ormai più che novantenne, ha affermato qualcosa che mai avrebbe permesso a nessuno di dire nei suoi studi.
 Dall’unione di due maschi o di due donne mai e poi mai nascerà un bambino. Non è questione di fede o di cultura ma di scienza. Non lo dice il prete o la religione, ma la realtà, l’esperienza, la medicina, la genetica... Lo dice la vita che si trasmette da miliardi di anni. La cosa, naturalmente, non è passata inosservata e in tanti hanno fatto le loro osservazioni.
Dall’unione di due maschi o di due donne mai e poi mai nascerà un bambino. Non è questione di fede o di cultura ma di scienza. Non lo dice il prete o la religione, ma la realtà, l’esperienza, la medicina, la genetica... Lo dice la vita che si trasmette da miliardi di anni. La cosa, naturalmente, non è passata inosservata e in tanti hanno fatto le loro osservazioni.E anche qui, come sempre senza acrimonie, e solo col desiderio di capire ci facciamo qualche domanda: come mai il severo uomo di cronaca e di scienza che tutti conosciamo ha ceduto in modo tanto grossolano a questa imprecisione? È stata una scivolata, facilmente perdonabile in un signore ultranovantenne o una miccia volutamente accesa proprio alla vigilia del nuovo approdo nell’aula del Senato del controverso ddl Zan? Non abbiamo risposta.
 Abbiamo capito, però, che questo è il pensiero di Piero Angela. Pensiero che fa a pugni con la scienza e con l’esperienza. Si conferma, quindi, se ancora ce ne fosse bisogno, che se la scienza è neutra, mai lo è lo scienziato e il cultore di scienza, che, come tutti i mortali, deve lottare, per non rimanere imbrigliato nelle sue convinzioni, nelle sue credenze, in una data filosofia di vita e nelle sue ideologie.
Abbiamo capito, però, che questo è il pensiero di Piero Angela. Pensiero che fa a pugni con la scienza e con l’esperienza. Si conferma, quindi, se ancora ce ne fosse bisogno, che se la scienza è neutra, mai lo è lo scienziato e il cultore di scienza, che, come tutti i mortali, deve lottare, per non rimanere imbrigliato nelle sue convinzioni, nelle sue credenze, in una data filosofia di vita e nelle sue ideologie. -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- ANTROPOLOGIA, ANDROLOGIA (GINECOLOGIA), E TEOLOGIA. Quale Dio? E il respiro divenne bambino (di Luigino Bruni).18 luglio 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. IL PROBLEMA DEL "DE DOMO DAVID" E DEL "COME NASCONO I BAMBINI", OGGI... *
- "Di quale Dio parliamo quando parliamo di Dio, e di quale Dio parlano quando parlano di Dio? La domanda è cruciale. Infatti non è per niente chiaro, non è sempre lo stesso, e sovente non è un Dio innocuo" (RanieroLaValle, "Se questo è un Dio", Ponte alle grazie).
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- "Veggiolo un’altra volta esser deriso; / veggio rinovellar l’aceto e ’l fiele, / e tra vivi ladroni esser anciso. /Veggio il nuovo Pilato sì crudele / che ciò nol sazia, ma sanza decreto /portar nel Tempio le cupìde vele"" (Dante Alighieri, Purgatorio XX, 88-93).
DE DOMO DAVID. Gesù "Venne a Nàzaret, dove era cresciuto (..) Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?»
La fedeltà e il riscatto /16.
E il respiro divenne bambino
di Luigino Bruni *
- Noi abbiamo bisogno di cambiare Dio per conservarlo, e perché lui conservi noi
- Paolo de Benedetti, Quale Dio?.
«Così Boaz prese in moglie Rut. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire: ella partorì un figlio. E le donne dicevano a Noemi: "Benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto di riscatto. Il suo nome sarà ricordato in Israele! Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di sette figli"» (Rut 4,13-15). Tornano in scena le donne di Betlemme, come coro in una tragedia greca. Il libro di Rut è molte cose, tutte belle, ma bellissime sono le donne. Prima di iniziarne il commento sapevo che Rut era un libro al femminile; non pensavo però lo fosse così intensamente. Una grande sorpresa, ma anche un modo per onorare le donne che in questo tempo di pandemia hanno sorretto, con la loro cura, il mondo. Le donne donano, ancora una volta, parole meravigliose a Noemi, e a noi. L’ambiente della benedizione è ancora la reciprocità: Rut mette al mondo un bambino, le donne dicono che quel bambino riscatterà Noemi, amata da Rut, che per lei vale come molti figli. Una danza d’amore stupenda, una circolazione di hesed, di agape e di philia. Reciprocità diretta e indiretta, autentica protagonista del libro.
In un libro tutto centrato attorno alla grande figura-istituzione del goèl, il riscattatore-redentore, alla fine scopriamo che il goèl non è solo Boaz: l’altro goèl è il bambino. Quel bambino riscatterà le due donne, e sarà il loro consolatore, il loro hiphil, colui che, letteralmente, "fa tornare il respiro", colui che "ridona il fiato", il rianimatore.
 È molto bella questa definizione del bambino di Rut come goèl e come rianimatore. Ogni giorno assistiamo nelle nostre famiglie all’arrivo di bambini che nascendo ridanno fiato a una madre, a un padre, a una nonna. Coppie stanche, famiglie sfiatate, ricominciano a respirare col bambino che nasce. Ogni bambino non porta con sé soltanto il fagotto di provvidenza, porta anche ossigeno per ricominciare a respirare, o per respirare tutti meglio. I bambini allungano la vita non solo perché fanno affacciare la nostra esistenza al di là di essa, ma perché estendono il nostro respirare, ci danno una gioia e una voglia di vivere che non avremo senza quel dono. I bambini forzano il nostro destino e ci donano giorni di vita extra, che decidiamo di vivere solo per poter rivedere un figlio o una nipote ancora domani. Ci insegnano a contare i nostri giorni con un’altra sapienza del cuore.
È molto bella questa definizione del bambino di Rut come goèl e come rianimatore. Ogni giorno assistiamo nelle nostre famiglie all’arrivo di bambini che nascendo ridanno fiato a una madre, a un padre, a una nonna. Coppie stanche, famiglie sfiatate, ricominciano a respirare col bambino che nasce. Ogni bambino non porta con sé soltanto il fagotto di provvidenza, porta anche ossigeno per ricominciare a respirare, o per respirare tutti meglio. I bambini allungano la vita non solo perché fanno affacciare la nostra esistenza al di là di essa, ma perché estendono il nostro respirare, ci danno una gioia e una voglia di vivere che non avremo senza quel dono. I bambini forzano il nostro destino e ci donano giorni di vita extra, che decidiamo di vivere solo per poter rivedere un figlio o una nipote ancora domani. Ci insegnano a contare i nostri giorni con un’altra sapienza del cuore.Il bambino di Rut è il riscattare di Noemi, è il suo secondo goèl. Boaz, il primo goèl, poteva riscattare solo il terreno e garantire una sussistenza materiale a Rut e a sua suocera; ma il libro ci ha continuamente detto che il vero riscatto di Rut e Noemi era un figlio. Questo riscatto non può essere garantito con atti giuridici e neanche con il matrimonio.
 È solo e soltanto dono. Perché ogni bambino è dono, e non c’è dono più puro e grande di un figlio. Ogni figlio è qualcosa di più di un fatto naturale e necessario. Siccome nella natura esiste anche la sterilità, per l’arrivo di un figlio la natura non basta. E anche se la nostra cultura ha perso il senso religioso della generatività, un bambino che arriva è la gioia più grande perché porta iscritta in sé questa dimensione essenziale di libertà e di dono. Se un giorno il senso religioso dovesse scomparire dalla faccia della terra, potrà sempre rinascere insieme a un bambino.
È solo e soltanto dono. Perché ogni bambino è dono, e non c’è dono più puro e grande di un figlio. Ogni figlio è qualcosa di più di un fatto naturale e necessario. Siccome nella natura esiste anche la sterilità, per l’arrivo di un figlio la natura non basta. E anche se la nostra cultura ha perso il senso religioso della generatività, un bambino che arriva è la gioia più grande perché porta iscritta in sé questa dimensione essenziale di libertà e di dono. Se un giorno il senso religioso dovesse scomparire dalla faccia della terra, potrà sempre rinascere insieme a un bambino.«Noemi prese il bambino, se lo pose nel seno e gli fece da nutrice. Le vicine gli cercavano un nome e dicevano: "È nato un figlio a Noemi!"» (4,16-17). Il padre, Boaz esce di scena subito dopo aver svolto il suo compito - il midrash Leqah lo fa morire il giorno dopo le nozze ("Le leggende degli ebrei", vol. VI). -Il nome e lo svezzamento del bambino diventano una faccenda interamente femminile, anche perché lo sono davvero. Il monopolio femminile dei primi anni di vita dei bambini e delle bambine è stata una delle leggi auree non scritte delle civiltà. Fino alla generazione dei miei genitori gli uomini erano ospiti temporanei e provvisori dell’educazione primaria dei loro bambini. Si affacciavano ogni tanto sull’uscio, poi si ritraevano subito per mancanza di tatto e di competenze. In quel mondo i bambini erano i tesori delle donne (mamme, nonne, zie, sorelle), tesori fugaci e passeggeri, spesso le uniche gioie in vite difficili e ingiuste.
È nato un figlio a Noemi: il figlio era nato a Rut, ma ieri più di oggi ogni figlio che nasce a una figlia è anche figlio della madre di lei. Pochi amori sono più grandi di quello di una nonna per un/a nipote, impossibile da comparare a quello dei genitori, e se fossimo capaci di calcolarlo non lo scopriremmo minore, solo diverso. Ce ne accorgiamo, per contrasto drammatico, quando entra in campo la sofferenza per un nipote: quella dei nonni è una sofferenza aumentata, quella per il nipote moltiplicata per quella dei suoi genitori, un prodotto che sfiora l’infinito.
 Inoltre, come unica volta nella Bibbia, il figlio viene attribuito a una donna e non a un uomo (per esempio: «A Set nacque un figlio, che chiamò Enos»: Gn 4,26). E Noemi non è più l’amara e la vuota, Dio l’ha riempita con un bambino. Lei diventa nutrice del bambino che a sua volta le darà respiro nella sua vecchiaia: ancora una faccenda di reciprocità. Le donne scelgono addirittura il nome per il bambino, anche qui unico caso nella Bibbia, perché non sono le vicine di casa né le donne del paese a scegliere il nome di un bambino. Qui invece le donne danno il nome al figlio di Rut-Noemi, forse per dirci qualcosa che le altre donne della Bibbia ci avrebbero detto se avessero potuto prendere più spesso la parola: un figlio non è un bene privato, è bene comune, è figlio di tutte, ed è l’intero villaggio a crescerlo. Nel presepe ci sono anche tutte queste donne di Betlemme, anche se non potevano saperlo.
Inoltre, come unica volta nella Bibbia, il figlio viene attribuito a una donna e non a un uomo (per esempio: «A Set nacque un figlio, che chiamò Enos»: Gn 4,26). E Noemi non è più l’amara e la vuota, Dio l’ha riempita con un bambino. Lei diventa nutrice del bambino che a sua volta le darà respiro nella sua vecchiaia: ancora una faccenda di reciprocità. Le donne scelgono addirittura il nome per il bambino, anche qui unico caso nella Bibbia, perché non sono le vicine di casa né le donne del paese a scegliere il nome di un bambino. Qui invece le donne danno il nome al figlio di Rut-Noemi, forse per dirci qualcosa che le altre donne della Bibbia ci avrebbero detto se avessero potuto prendere più spesso la parola: un figlio non è un bene privato, è bene comune, è figlio di tutte, ed è l’intero villaggio a crescerlo. Nel presepe ci sono anche tutte queste donne di Betlemme, anche se non potevano saperlo.«E lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Iesse, padre di Davide» (4,17). Ecco il nome che mancava al nostro mosaico, Davide, il nome più amato di tutti i nomi, che echeggia nell’aria fin dall’inizio della storia. E grazie a questo nome, che da solo racchiude tutta la Bibbia, capiamo un senso profondo del libro di Rut. La storia di Noemi, Rut e Boaz è il ponte che lega le storie della preistoria alla storia di Israele, Abramo e patriarchi con la monarchia, Davide con la tribù di Giuda e Gerusalemme. Quando Davide fa la sua comparsa nella storia di Israele (nel primo libro di Samuele), non viene menzionata la sua genealogia, arriva a Betlemme dal nulla. Il libro di Rut completa il filo d’oro della salvezza, spiega la trama della provvidenza. E così il libro di Rut riscatta la triste storia di Giuda, quell’incesto con Tamar, da cui nacque Peres, l’avo di Boaz, il nonno di Davide: «Questa è la discendenza di Peres: Peres generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Amminadàb, Amminadàb generò Nacson, Nacson generò Salmon, Salmon generò Boaz, Booz generò Obed, Obed generò Iesse e Iesse generò Davide» (4,18-22).
Tutto questo per dirci qualcosa di importante sulla logica della Bibbia, e della vita. Il tempo nella Bibbia si muove nelle due direzioni dell’asse. Per capire il senso pieno di un evento bisogna andare avanti e indietro nel tempo. Ciò che lo spiega non è solo quanto è accaduto prima, perché essenziale è anche quanto è accaduto dopo. Il matrimonio tra Boaz e Rut non illumina soltanto la persona e la storia di Davide (che verrà dopo), spiega anche la storia di Giuda e Tamar (avvenuta prima). Dà senso ai dolori e alle gioie che l’hanno preceduto e seguito.
 Gesù di Nazareth non spiega solo il senso della storia di Giuda, Tamar, Rut e Davide, ma Giuda, Rut e Davide spiegano Gesù: ci fanno capire che nella sua carne e nel suo messaggio c’erano anche l’incesto di Giuda e l’omicidio di Davide, insieme alla grazia e alla fedeltà di Rut. E quindi che l’umanità di Cristo è vera anche perché raccoglie i peccati e le virtù disseminate lungo la sua genealogia. Ma se è così, allora nel suo corpo risorto ci sono anche Giuda, Davide, Rut, Noemi e tutte le donne di Betlemme, riscattati da un altro goèl.
Gesù di Nazareth non spiega solo il senso della storia di Giuda, Tamar, Rut e Davide, ma Giuda, Rut e Davide spiegano Gesù: ci fanno capire che nella sua carne e nel suo messaggio c’erano anche l’incesto di Giuda e l’omicidio di Davide, insieme alla grazia e alla fedeltà di Rut. E quindi che l’umanità di Cristo è vera anche perché raccoglie i peccati e le virtù disseminate lungo la sua genealogia. Ma se è così, allora nel suo corpo risorto ci sono anche Giuda, Davide, Rut, Noemi e tutte le donne di Betlemme, riscattati da un altro goèl.
 Quando i primi cristiani fecero la coraggiosa e felicissima scelta di tenere legato l’Antico al Nuovo Testamento, allungarono, nei due sensi, l’asse dei goèl della storia della salvezza, la serie dei riscattatori e dei riscattati, moltiplicarono il dono del respiro dei bambini. Ma se guardiamo il mondo con occhi di Bibbia, ci accorgiamo che ogni volta che un bambino viene generato, con la sua storia spiegherà la storia dei suoi avi e illuminerà quella dei suoi discendenti. Quante volte la laurea di una nipote e la fedeltà di una nonna si spiegano e illuminano a vicenda? E qualche volta per capire veramente un grande dolore o una grande gioia bisogna aspettare i mille anni e oltre che separano i campi di orzo di Boaz dalla grotta di Maria. Nella lingua con cui sono scritte le frasi decisive della nostra vita il verbo è posto alla fine.
Quando i primi cristiani fecero la coraggiosa e felicissima scelta di tenere legato l’Antico al Nuovo Testamento, allungarono, nei due sensi, l’asse dei goèl della storia della salvezza, la serie dei riscattatori e dei riscattati, moltiplicarono il dono del respiro dei bambini. Ma se guardiamo il mondo con occhi di Bibbia, ci accorgiamo che ogni volta che un bambino viene generato, con la sua storia spiegherà la storia dei suoi avi e illuminerà quella dei suoi discendenti. Quante volte la laurea di una nipote e la fedeltà di una nonna si spiegano e illuminano a vicenda? E qualche volta per capire veramente un grande dolore o una grande gioia bisogna aspettare i mille anni e oltre che separano i campi di orzo di Boaz dalla grotta di Maria. Nella lingua con cui sono scritte le frasi decisive della nostra vita il verbo è posto alla fine.* Avvenire, sabato 17 luglio 2021 (ripresa parziale)
*Sul tema, nel sito, si cfr.:
- UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
COME NASCONO I BAMBINI: EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
FLS
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- HANNAH ARENDT, I DATI DELL’ISTAT SULLA NATALITA’, E IL MIRACOLO CHE SALVA IL MONDO (di Sergio Belardinelli).2 luglio 2021, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA. COME NASCONO I BAMBINI...*
- HANNAH ARENDT E IL PROBLEMA DELL’INIZIO, DELLA NASCITA: "Nella grande opera sulla Città di Dio Agostino enuncia, senza però darne spiegazione, ciò che avrebbe potuto divenire il sostegno ontologico di una filosofia della politica autenticamente romana o virgiliana. A suo dire, come sappiamo, Dio creò l’uomo come creatura temporale, homo temporalis; il tempo e l’uomo furono creati insieme, e tale temporalità era confermata dal fatto che ogni uomo deve la sua vita non semplicemente alla moltiplicazione della specie, ma alla nascita, l’ingresso di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo, fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo. Lo scopo della creazione dell’uomo fu di rendere possibile un inizio: «Acciocché vi fosse un inizio, fu creato l’uomo, prima del quale non ci fu nessuno», «Initium ... ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit» (Agostino, De civitate Dei, libro XII, cap. 21). La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita" (H. ARENDT, La vita della mente, Bologna 1987, p. 546).
È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo
Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità
di Sergio Belardinelli (il Foglio, 24 apr 2021)
L’Istat ci ha comunicato di recente che, complice anche il Covid, in Italia nel 2020 i morti sono stati 746 mila e i nuovi nati 404 mila. Un dato agghiacciante nel suo significato sociale e culturale che a me, come una sorta di riflesso condizionato, richiama alla mente uno dei brani filosofici più intensi che abbia mai letto: “Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane dalla sua normale, naturale rovina è in definitiva il fatto della natalità in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell’azione. È in altre parole la nascita di nuovi uomini, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’”.
Con queste parole Hannah Arendt conclude il capitolo di Vita Activa dedicato all’azione. Si tratta di un brano che cito e commento ormai da quarant’anni, nel quale viene messo a tema un nesso, quello tra la libertà e la natalità, tra la libertà e la vita, col quale, che io sappia, soltanto la Arendt ha avuto l’acutezza e il coraggio di cimentarsi e che, a prima vista, può apparire persino paradossale. La vita infatti, almeno immediatamente, sembra richiamare non tanto la libertà, quanto piuttosto il gigantesco, immutabile ripetersi dei cicli naturali, l’ambito di quelli che il grande biologo Adolf Portmann, autore peraltro assai caro alla Arendt, definirebbe i “rapporti preordinati” - il contrario, quindi, di ciò che in genere intendiamo allorché parliamo di libertà. Quanto poi alla vita specificamente umana, essa, è certo impastata di libertà, ma è anche qualcosa che, a diversi livelli, non dipende da noi, qualcosa di cui, nonostante le tecnologie della riproduzione, non possiamo avere il completo controllo: la riceviamo semplicemente; non scegliamo i nostri genitori, né il luogo dove venire al mondo; dobbiamo fare continuamente i conti con gli altri, con le nostre passioni, i nostri istinti, le nostre inclinazioni, con quel coacervo di natura, ragione, sentimenti, usi e costumi che vanno a costituire appunto il “gran mare” della vita. La vita insomma pone una serie di condizioni e condizionamenti alla libertà che possono renderla persino impossibile. Eppure, rompendo in un certo senso questa grande catena, è proprio la libertà che dà sapore e specificità alla vita umana; solo la libertà impedisce che il mondo si riduca spinozianamente a “sostanza”, a qualcosa di omogeneo, a qualcosa come un continuo fluire; solo la libertà è capace di introdurre nel mondo un elemento di novità, qualcosa di imprevisto.
Pensieri non nuovi, si potrebbe dire. Ma proprio qui si inserisce la fondamentale postilla arendtiana, preziosa per leggere in una chiave forse inusuale ma certo illuminante anche i dati Istat sulla natalità in Italia da cui siamo partiti: è la stessa vita umana, il nostro venire al mondo, la nascita unica e irripetibile di ciascuno di noi, a rappresentare la prima e più immediata forma di novità, il primo scompaginamento, se così si può dire, della routine della vita.
La facoltà dell’azione, dice la Arendt, “è ontologicamente radicata” nel “fatto della natalità”. In entrambe le dimensioni - la libertà e la natalità - ritroviamo non a caso una costitutiva “novità”, un costitutivo essere insieme agli altri (non si nasce, né si agisce da soli), qualcosa che implica l’accettazione della realtà nella quale siamo e insieme fiducia nel futuro. In questo senso ogni bambino che nasce è un segno di speranza nel mondo; è l’irruzione nel mondo di una “novità”, la cui memoria, è il caso di dire, ritroviamo da adulti nell’esercizio della nostra libertà, nella nostra capacità di incominciare qualcosa che senza di noi non incomincerebbe mai.
Novità, pluralità (gli uomini, non l’uomo abitano la terra, ripete spesso Hannah Arendt) e speranza: questo ci schiude direttamente e in modo straordinario il discorso arendtiano sulla libertà radicata nella natalità. Ma indirettamente, specialmente oggi, tale discorso ci schiude molto di più. Ci fa capire, ad esempio, quale tragedia, anche simbolica, si consuma nel momento in cui un paese come l’Italia registra in un anno un saldo passivo tra morti e nuovi nati di 342 mila unità. È un po’ come se il mondo e la nostra libertà perdessero la speranza, ossia ciò che dà loro sapore, ciò che è insieme accettazione della realtà nella quale viviamo e fiducia nel futuro.
È vero, tutto passa. La vita non è altro che un eterno dissolversi nel gigantesco circolo della natura dove, propriamente, non esiste inizio né fine e dove tutte le cose e gli eventi si svolgono in un’immutabile ripetizione: la mors immortalis di cui parlava Lucrezio. Ma la Arendt non accetta questa mestizia, poiché a suo avviso “la nascita e la morte di esseri umani non sono semplici eventi naturali”; avvengono in un mondo dove vivono altri uomini; un mondo che acquista significato grazie alle loro azioni e ai loro discorsi; un mondo che per questo è sempre aperto alla novità.
Con la creazione dell’uomo, dice la Arendt, “il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, e questo, naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo”. Di nuovo l’inizio, dunque, diciamo pure, la natalità.
È proprio perché, in quanto uomini, siamo initium, nuovi venuti, iniziatori, per virtù di nascita che secondo la Arendt, siamo indotti ad agire. La definizione che più si addice agli uomini non è quella di “mortali”, ma piuttosto quella di “coloro che nascono”. In questo modo, quasi per una sottile ironia della sorte, la categoria della natalità diventa fondamentale proprio nel pensiero di un’allieva (e anche qualcosa di più) di Martin Heidegger, l’inventore dell’essere per la morte. Non che la Arendt ovviamente trascuri che la morte rappresenta l’ineluttabile fine di ogni vita umana, solo che, a suo avviso, gli uomini, anche se debbono morire, non nascono per questo, bensì per incominciare. E siamo di nuovo al passo da cui siamo partiti: “Il miracolo che salva il mondo....”.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. --- "ESSERE E TEMPO" E FILOLOGIA. Note su "Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore".
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- E "«LA NOSTRA CARITAS», COME AMAVA DIRE SAN PAOLO VI". DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI MEMBRI DELLA "CARITAS" ITALIANA NEL 50° DI FONDAZIONE26 giugno 2021, di Federico La Sala
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI MEMBRI DELLA CARITAS ITALIANA NEL 50° DI FONDAZIONE *
- Aula Paolo VI
- Sabato, 26 giugno 2021
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti, tutti!
Ringrazio il Cardinale Bassetti e il Presidente della Caritas Italiana, Monsignor Redaelli, per le parole che mi hanno rivolto a nome di tutti. Grazie. Siete venuti dall’Italia intera, in rappresentanza delle 218 Caritas diocesane e di Caritas Italiana, e io sono contento di condividere con voi questo Giubileo, il vostro cinquantesimo anno di vita! Siete parte viva della Chiesa, siete «la nostra Caritas», come amava dire San Paolo VI, il Papa che l’ha voluta e impostata. Egli incoraggiò la Conferenza Episcopale Italiana a dotarsi di un organismo pastorale per promuovere la testimonianza della carità nello spirito del Concilio Vaticano II, perché la comunità cristiana fosse soggetto di carità. Confermo il vostro compito: nell’attuale cambiamento d’epoca le sfide e le difficoltà sono tante, sono sempre di più i volti dei poveri e le situazioni complesse sul territorio. Ma - diceva San Paolo VI - «le nostre Caritas si prodigano oltre le forze» (Angelus, 18 gennaio 1976). E questo è vero!
La ricorrenza dei 50 anni è una tappa di cui ringraziare il Signore per il cammino fatto e per rinnovare, con il suo aiuto, lo slancio e gli impegni. A questo proposito vorrei indicarvi tre vie, tre strade su cui proseguire il percorso.
La prima è la via degli ultimi. È da loro che si parte, dai più fragili e indifesi. Da loro. Se non si parte da loro, non si capisce nulla. E mi permetto una confidenza. L’altro giorno ho sentito, su questo, parole vissute dall’esperienza, dalla bocca di don Franco, qui presente. Lui non vuole che si dica “eminenza”, “cardinale Montenegro”: don Franco. E lui mi ha spiegato questo, la via degli ultimi, perché lui ha vissuto tutta la vita questo. In lui, ringrazio tanti uomini e donne che fanno la carità perché l’hanno vissuta così, hanno capito la via degli ultimi. La carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono e renderle protagoniste della propria vita. Molte scelte significative, in questi cinque decenni, hanno aiutato le Caritas e le Chiese locali a praticare questa misericordia: dall’obiezione di coscienza al sostegno al volontariato; dall’impegno nella cooperazione con il Sud del pianeta agli interventi in occasione di emergenze in Italia e nel mondo; dall’approccio globale al complesso fenomeno delle migrazioni, con proposte innovative come i corridoi umanitari, all’attivazione di strumenti capaci di avvicinare la realtà, come i Centri di ascolto, gli Osservatori delle povertà e delle risorse. È bello allargare i sentieri della carità, sempre tenendo fisso lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo. Allargare sì lo sguardo, ma partendo dagli occhi del povero che ho davanti. Lì si impara. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i poveri, di guardarli negli occhi, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla. È con i loro occhi che occorre guardare la realtà, perché guardando gli occhi dei poveri guardiamo la realtà in un modo differente da quello che viene nella nostra mentalità. La storia non si guarda dalla prospettiva dei vincenti, che la fanno apparire bella e perfetta, ma dalla prospettiva dei poveri, perché è la prospettiva di Gesù. Sono i poveri che mettono il dito nella piaga delle nostre contraddizioni e inquietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento. E quando il nostro cuore, la nostra coscienza, guardando il povero, i poveri, non si inquieta, fermatevi..., dovremmo fermarci: qualcosa non funziona.
Una seconda via irrinunciabile: la via del Vangelo. Mi riferisco allo stile da avere, che è uno solo, quello appunto del Vangelo. È lo stile dell’amore umile, concreto ma non appariscente, che si propone ma non si impone. È lo stile dell’amore gratuito, che non cerca ricompense. È lo stile della disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù che si è fatto nostro servo. È lo stile descritto da San Paolo, quando dice che la carità «tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,7). Mi colpisce la parola tutto. Tutto. È detta a noi, a cui piace fare delle distinzioni. Tutto. La carità è inclusiva, non si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno solo di quello spirituale. La salvezza di Gesù abbraccia l’uomo intero. Abbiamo bisogno di una carità dedicata allo sviluppo integrale della persona: una carità spirituale, materiale, intellettuale. È lo stile integrale che avete sperimentato in grandi calamità, anche attraverso i gemellaggi, bella esperienza di alleanza a tutto campo nella carità tra le Chiese in Italia, in Europa e nel mondo. Ma questo - lo sapete bene - non deve sorgere solo in occasione delle calamità: abbiamo bisogno che le Caritas e le comunità cristiane siano sempre in ricerca per servire tutto l’uomo, perché “l’uomo è la via della Chiesa”, secondo l’espressione sintetica di San Giovanni Paolo II (cfr Lett. enc. Redemptor hominis, 14).
La via del Vangelo ci indica che Gesù è presente in ogni povero. Ci fa bene ricordarlo per liberarci dalla tentazione, sempre ricorrente, dell’autoreferenzialità ecclesiastica ed essere una Chiesa della tenerezza e della vicinanza, dove i poveri sono beati, dove la missione è al centro, dove la gioia nasce dal servizio. Ricordiamo che lo stile di Dio è lo stile della prossimità, della compassione e della tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Ci sono due mappe evangeliche che aiutano a non smarrirci nel cammino: le Beatitudini (Mt 5,3-12) e Matteo 25 (vv. 31-46). Nelle Beatitudini la condizione dei poveri si riveste di speranza e la loro consolazione diventa realtà, mentre le parole del Giudizio finale - il protocollo sul quale saremo giudicati - ci fanno trovare Gesù presente nei poveri di ogni tempo. E dalle forti espressioni di giudizio del Signore ricaviamo anche l’invito alla parresia della denuncia. Essa non è mai polemica contro qualcuno, ma profezia per tutti: è proclamare la dignità umana quando è calpestata, è far udire il grido soffocato dei poveri, è dare voce a chi non ne ha.
E la terza via è la via della creatività. La ricca esperienza di questi cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ripetere; è la base su cui costruire per declinare in modo costante quella che San Giovanni Paolo II ha chiamato fantasia della carità (cfr Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50). Non lasciatevi scoraggiare di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri e di nuove povertà. Ce ne sono tante e crescono! Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza. Contro il virus del pessimismo, immunizzatevi condividendo la gioia di essere una grande famiglia. In questa atmosfera fraterna lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e anche poeta, suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo.
E ora - dopo questa predica di Quaresima! - vorrei dirvi grazie, grazie: grazie a voi, agli operatori, ai sacerdoti e ai volontari! Grazie anche perché in occasione della pandemia la rete Caritas ha intensificato la sua presenza e ha alleviato la solitudine, la sofferenza e i bisogni di molti. Sono decine di migliaia di volontari, tra cui tanti giovani, inclusi quelli impegnati nel servizio civile, che hanno offerto in questo tempo ascolto e risposte concrete a chi è nel disagio. Proprio ai giovani vorrei che si prestasse attenzione. Sono le vittime più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche i potenziali artefici di un cambiamento d’epoca. Sono loro i protagonisti dell’avvenire. Non sono l’avvenire, sono il presente, ma protagonisti dell’avvenire. Non è mai sprecato il tempo che si dedica ad essi, per tessere insieme, con amicizia, entusiasmo, pazienza, relazioni che superino le culture dell’indifferenza e dell’apparenza. Non bastano i “like” per vivere: c’è bisogno di fraternità, c’è bisogno di gioia vera. La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assaporare il gusto buono di ritrovare sé stessi dedicando il proprio tempo agli altri. Così facendo la Caritas stessa rimarrà giovane e creativa, manterrà uno sguardo semplice e diretto, che si rivolge senza paura verso l’Alto e verso l’altro, come fanno i bambini. Non dimenticare il modello dei bambini: verso l’Alto e verso l’altro.
Cari amici, ricordatevi, per favore, di queste tre vie e percorretele con gioia: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività. Vi saluto con una frase dell’Apostolo Paolo, che festeggeremo tra pochi giorni: «L’amore del Cristo ci possiede» (2 Cor 5,14). L’amore del Cristo ci possiede. Vi auguro di lasciarvi possedere da questa carità: sentitevi ogni giorno scelti per amore, sperimentate la carezza misericordiosa del Signore che si posa su di voi e portatela agli altri. Io vi accompagno con la preghiera e vi benedico; e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!
* Fonte: Vatican.va, 26.06.2021
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- Un Anno Speciale dedicato al "padre putativo" di Gesù: sette invocazioni attinte dagli interventi dei Papi sulla figura del patrono della Chiesa universale ("Avvenire").4 maggio 2021, di Federico La Sala
Nuove Litanie.
San Giuseppe ora diventa anche patrono di esuli, afflitti e poveri
Le Litanie in onore di san Giuseppe, approvate nel 1909, sono state integrate con sette invocazioni attinte dagli interventi dei Papi sulla figura del patrono della Chiesa universale
di Redazione Catholica (Avvenire, lunedì 3 maggio 2021)
- [Foto]San Giuseppe, Cattedrale di Santa Reparata a Nizza - Lamiot
Nel 150° anniversario della dichiarazione di san Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, papa Francesco ha reso nota la lettera apostolica Patris corde, con l’intento di «accrescere l’amore verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio»; e ha indetto un Anno speciale dedicato al padre putativo di Gesù, iniziato lo scorso 8 dicembre.
Alla luce di tutto ciò la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti ha inviato una lettera ai presidenti delle Conferenze episcopali informandoli che «è parso opportuno aggiornare le Litanie in onore di san Giuseppe, approvate nel 1909 dalla Sede Apostolica» e «integrandovi sette invocazioni attinte dagli interventi dei Papi che hanno riflettuto su aspetti della figura del Patrono della Chiesa universale».
Sono queste: «Custode del Redentore» (san Giovanni Paolo II, Redemptoris custos); «Servo di Cristo» (san Paolo VI, omelia del 19.3.1966, citata in Redemptoris custos n. 8 e Patris corde n. 1); «Ministro della salvezza» (san Giovanni Crisostomo, citato in Redemptoris custos, n. 8); «Sostegno nelle difficoltà» (Francesco, Patris corde, prologo); «Patrono degli esuli, degli afflitti, dei poveri» (Patris corde, n. 5).
«Sarà compito delle Conferenze dei vescovi disporre la traduzione delle Litanie nelle lingue di loro competenza e pubblicarle» si legge sempre nella lettera firmata dal segretario del dicastero, l’arcivescovo Arthur Roche, e dal sottosegretario, padre Corrado Maggioni. «Tali traduzioni non avranno bisogno di conferma della Sede Apostolica. Secondo il loro prudente giudizio, le Conferenze dei vescovi potranno anche introdurre, al luogo opportuno e conservando il genere letterario, altre invocazioni con le quali san Giuseppe è particolarmente onorato nei loro Paesi».
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- IL "TESTAMENTO" DI GIACOMO LEOPARDI, LE "SIBILLE" DI ANTONIO ROSMINI E LA "CHARITAS".30 aprile 2021, di Federico La Sala
IL "TESTAMENTO" DI GIACOMO LEOPARDI, LE "SIBILLE" DI ANTONIO ROSMINI E LA "CHARITAS".... *
- E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce (Gv. III, 19=C.E.I.]).
- "Il nulla che Rosmini chiede di riconoscere intimamente è il nulla grazie al quale si può ricevere tutto e da cui tutto si origina nella vita: non è il nulla davanti allo specchio del nulla, che si gode nel suo narcisismo inconsolabile; è, invece, il nulla davanti a Dio, allo specchio della fede cristiana.
 È dunque un nulla sorgivo, promettente, come la verginità di Maria di Nazareth che rende possibile addirittura l’incarnazione del Figlio di Dio" (A. Staglianò).
È dunque un nulla sorgivo, promettente, come la verginità di Maria di Nazareth che rende possibile addirittura l’incarnazione del Figlio di Dio" (A. Staglianò).
Idee.
Leopardi, Rosmini e la diversità del «nulla»
«Riconoscere intimamente il proprio nulla» è la quinta massima di perfezione cristiana secondo il filosofo. Un approccio all’idea di umiltà e di affidamento prolifico alla grazia di Dio creatore
di Antonio Staglianò (Avvenire, giovedì 29 aprile 2021)
La Quinta massima di perfezione cristiana del Rosmini invita il cristiano a «riconoscere intimamente il proprio nulla», penetrando sempre più e sempre meglio nella propria «infermità» e «nichilità». Lo deve fare, non in modo generico e sentimentale, ma con la massima lucidità e metodicità: «Il cristiano deve avere scritte nella mente le ragioni del suo nulla: prima quelle che provano il nulla di tutte le cose; poi quelle che umiliano specialmente l’uomo; in terzo luogo quelle che umiliano la sua persona». Un ’nulla’ affidato a Dio, un «nulla intimo», custodisce e diffonde la pace interiore. Costruisce anche l’umiltà che ci rende veri! Da qui nasce la fede testimoniale, quella che sa di vero abbandono e di compagnia a Dio il quale «resta in agonia (d’amore) fino alla fine dei tempi», come ha sostenuto B. Pascal. Famosa è la sua definizione dell’uomo quale «canna pensante ». Certo il pensiero renderebbe superiore l’uomo rispetto alla natura che lo sovrasta, eppure come ’canna’ è sbattuta dai venti e dalle intemperie e rischia di continuo di spezzarsi e sparire. La sproporzione dell’universo rispetto a questo piccolo anima-letto umano è grande. Tanto più oggi, nell’immagine scientifica della realtà guadagnata attraverso le scoperte di un universo in continua espansione, con milioni di soli e miliardi di stelle e altrettante galassie.
Sono «gli interminati spazi» che Leopardi non ha bisogno di fingersi (diversamente dai «sovrumani silenzi » e dalla «profondissima quiete» nella poesia Infinito, perché li conosce bene dopo la svolta copernicana e galileiana. Rosmini sostiene dell’uomo: «Siccome egli è un atomo in paragone dell’universo, così è un nulla in paragone di Dio». Sembra che, per adorare la grandezza di Dio, l’uomo debba di necessità giungere a riconoscere il proprio nulla: quanto più l’uomo è niente, nulla, tanto più è nella giusta disposizione per avere «un grandissimo zelo per la gloria di Dio, e del ben del prossimo, con un sentimento che gli dice di essere incapace di ogni bene, incapace di porre alcun rimedio ai mali del mondo». Si tratta di un duplice approfondimento d’essere una «nientità», un nulla: anzitutto quello del limite creaturale (cosa è davvero un atomo rispetto alla totalità?), ma, in particolare, quello della sua debole condizione esistenziale a causa del peccato originale, «quella colpa in cui è stato concepito, l’inclinazione al male che porta in sé». In paragone a Dio, essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, ogni creatura (anche l’uomo, che pure è creato a immagine e somiglianza di Dio) è nulla. Col linguaggio dei medievali, questo si spiega filosoficamente perché solo Dio ’è’ l’Essere, la creatura ’ha’ l’essere per partecipazione.
Emanuele Severino, denunciando la follia dell’Occidente, insiste su questa ovvietà del senso comune di tutti: le cose sono niente, perché vengono dal nulla e scadono nel nulla, perciò sono nulla. Egli vede, così, proprio in Leopardi, colui che ha portato alle estreme conseguenze la follia dell’Occidente, la fede nel divenire delle cose, che porta al tramonto di tutto, anche degli dei, di ogni divinità, anche del Dio cristiano. Tutto è nulla, niente è eterno, nemmeno Dio, e la religione è una dolce illusione che con le sue fantastiche dottrine sull’aldilà (il paradiso, la gioia in Dio, la grazia di Dio e il suo perdono) allevia la sofferenza angosciante dell’uomo posto dalla vita (anche dalla natura matrigna) di fronte al nulla, all’annientamento, attraverso la morte: «sola nel mondo eterna, in cui si volve ogni creata cosa, in te morte riposa nostra ignuda natura ». Così anche nello Zimbaldone giungeva alla stessa scoperta (proposta dal Rosmini nella sua quinta Massima): «E io percepiva e considerava intorno a me solo nulla e, io medesimo, solido nulla». Leopardi non soltanto sente («e io percepiva») ma riflette e conosce intellettualmente («e io considerava») il nulla di tutte le cose e anche di sé, di ogni uomo, di ogni vicenda umana, quasi ripetendo con le parole di Qoelet «vanità delle vanità, tutto è vanità». Le ’parole’ sono le stesse e anche i ’concetti’. Eppure si assiste a un miracolo di vita nel riconoscere rosminiano il proprio «intimo nulla».
In Leopardi, invece, c’è solo la coscienza infelice di una tristezza insuperabile e angosciante, da cui distrarsi con le dolci illusioni della religione (fantastica) per non disperare e morire di crepacuore. Da dove si origina questa differenza di decisione per la vita e per la morte? Per riconoscere il proprio nulla, bisogna prima (ma è un ’prima’ solo logico) conoscere «il proprio nulla», cioè «conoscersi allo specchio del nulla», giungere all’intimità più profonda di sé per accedere davvero alla propria «nichilità- nientità», e così sapere in verità cosa siamo stati dall’eterno in Dio - nell’atto del generarsi eterno di Dio in Dio, Figlio dal Padre - e cosa siamo adesso: nulla, cioè assoluta apertura a un richiamo di vita. È il «nulla eccitante » di cui parla Florenskij nella sua teologia ortodossa La colonna e il fondamento della verità. È il nulla da cui tutte le cose sono state create. ’Questo nulla’ ha un significato che l’avvicina più allo «zero dei matematici che contiene tutti i numeri in positivo e in negativo all’infinito» o al «vuoto degli astrofisici da cui l’universo in espansione con tutta la massa della sua materia si è originato per l’inflazione originaria » che non al «nulla dei filosofi greci e di Leopardi che ne condivide il linguaggio».
Il nulla che Rosmini chiede di riconoscere intimamente è il nulla grazie al quale si può ricevere tutto e da cui tutto si origina nella vita: non è il nulla davanti allo specchio del nulla, che si gode nel suo narcisismo inconsolabile; è, invece, il nulla davanti a Dio, allo specchio della fede cristiana.
 È dunque un nulla sorgivo, promettente, come la verginità di Maria di Nazareth che rende possibile addirittura l’incarnazione del Figlio di Dio.
È dunque un nulla sorgivo, promettente, come la verginità di Maria di Nazareth che rende possibile addirittura l’incarnazione del Figlio di Dio.
 Chi riconosce intimamente questo proprio nulla consegue l’umiltà vera, non quella ’pelosa’ di certi spirituali che puntano a mortificare i doni di Dio e i carismi, orientando a far sotterrare i talenti. È piuttosto l’umiltà di chi si vede dotato per aver ricevuto tutto da Dio e loda il suo Signore pe la sua magnificenza.
Chi riconosce intimamente questo proprio nulla consegue l’umiltà vera, non quella ’pelosa’ di certi spirituali che puntano a mortificare i doni di Dio e i carismi, orientando a far sotterrare i talenti. È piuttosto l’umiltà di chi si vede dotato per aver ricevuto tutto da Dio e loda il suo Signore pe la sua magnificenza.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- ICONOGRAFIA E INCARNAZIONE: IL TRITTICO DI MERODE.
In questo Granel di sabbia, il qual terra ha nome
 LA GINESTRA O IL FIORE DEL DESERTO. IL "TESTAMENTO" DI GIACOMO LEOPARDI
LA GINESTRA O IL FIORE DEL DESERTO. IL "TESTAMENTO" DI GIACOMO LEOPARDIDOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. -- ANTONIO ROSMINI, LE SIBILLE, E LA "CHARITAS".
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM".
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- DE DOMO DAVID. LA GENEALOGIA DI GESU’: L’ALBERO DI JESSE. Iconografia.21 aprile 2021, di Federico La Sala
Albero di Jesse *
L’albero di Jesse (o Iesse) è un motivo frequente nell’arte cristiana tra l’XI e il XV secolo: rappresenta una schematizzazione dell’albero genealogico di Gesù a partire da Jesse, padre del re Davide, il quale è di particolare importanza nelle tre religioni abramitiche, l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam.
- [Foto] Un pannello dell’Armadio degli Argenti raffigurante la Genealogia di Gesù.
Origine
Il tema iconografico trae spunto da un famoso annuncio messianico contenuto nel capitolo 11 del libro del profeta Isaia (11,1.10) [1] da cui ha origine il suo nome greco [2]. Gli artisti combinarono la frase con la genealogia di Gesù come appare nel vangelo secondo Matteo [3] o secondo il Vangelo di Luca (3, 23-38)[4], genealogie che tuttavia presentano vistose differenze.
La più antica rappresentazione conosciuta dell’albero di Jesse è datata 1086, e compare nel Codice Vissegradesi, vangelo dell’incoronazione di Vratislao II di Boemia[5].
Iconografia
Jesse viene solitamente rappresentato coricato, semi-coricato o nell’iconografia meno antica seduto[6][7]. Nell’arte romanica, solitamente, egli è rappresentato coricato all’aperto mentre in quella gotica appare più spesso dentro ad un letto riccamente adornato, come nelle vetrate della chiesa di Saint-Étienne a Beauvais che datano al 1520.
Spesso Jesse appare addormentato, la testa appoggiata su una mano. Questa posizione è, a volte, associata ad un sogno profetico concernente la discendenza del dormiente. Dal suo fianco o dal suo ventre o anche dal dorso[7] o più raramente dalla sua bocca, s’innalza un albero i cui rami sorreggono gli antenati di Gesù, in particolare Davide riconoscibile per la sua arpa, fino a Maria. Le vetrate della cattedrale di Chartres rappresentano, dal basso in alto Davide, Salomone, Roboamo, Abias ed infine Maria. Ogni artista, a seconda del testo che ha utilizzato, del proprio gusto e dello spazio che ha a disposizione, aggiunge altri personaggi dell’Antico Testamento, spesso i profeti che gli esegeti del Medioevo pensavano avessero annunciato la venuta di Cristo (sono quattordici sulle vetrate di Chartres). Alla sommità si trova Gesù, a volte in croce, a volte bambino, sulle ginocchia della madre.
Nel XIII secolo, l’albero si sviluppa verticalmente, ed è solo nel XV che comincia a ramificarsi lateralmente[6]. Ancora presente nell’iconografia cristiana del XV sec., il motivo declina nel XVI per scomparire con la Controriforma[6].
Esistono naturalmente anche altre forme di rappresentazione della genealogia di Gesù, che non utilizzano l’albero di Jesse, il più famoso è quello dipinto nelle lunette della Cappella Sistina da Michelangelo tratto dal Vangelo secondo Matteo[8].
I supporti
L’albero di Jesse è stato un motivo popolare in tutte le arti: si trovano esempi nei manoscritti miniati, le stampe, le vetrate, la scultura monumentale, gli affreschi, le tappezzerie o nei ricami[6].
Manoscritti
- Salterio di Scherenberg, Strasburgo, c. 1260
Il motivo appare in parecchie bibbie romane, ad esempio nella Bibbia di Lambeth, sotto forma di una B maiuscola decorata all’inizio del Libro di Isaia o del vangelo di Matteo. La bibbia di San Benigno, del XII secolo, una delle più antiche che ci sono pervenute, mostra Jesse e le sette colombe rappresentanti i sette doni dello Spirito Santo[9]. La bibbia dei Cappuccini (ultimo quarto del XII sec.) conservata nella Bibliothèque nationale de France ne è un altro esempio, l’albero di Jessi decora la L maiuscula del Liber generationis nel vangelo di Matteo[10].
Poiché il re Davide era considerato l’autore dei Salmi, i salteri erano sovente illustrati con un albero di Jesse, soprattutto i manoscritti inglesi, dove l’albero di Jesse s’arrotola attorno alla B maiuscola del testo latino Beatus Vir all’inizio del primo salmo. Uno dei primi esempi è il salterio di Huntingfield, della fine del XII secolo. La British Library possiede un bellissimo salterio del XIV sec., detto di Gorleston. In questi due esemplari Jesse è allungato ai piedi della lettera B. Si potrebbero citare ancora il salterio di Macclesfield (Fitzmuseum, Cambridge) ed il Salterio e le Ore del duca di Bedford [11].
Alcuni manoscritti consacrano una pagina intera al motivo, aggiungendovi personaggi, per esempio la sacerdotessa di Apollo Sibilla Cumana del salterio d’Ingeburg (inizio del XII sec.). Presso Colonia, in un lezionario di prima del 1164 si descrive un Jesse insolito, morto in una tomba o bara, da cui l’albero cresce[12].
Una prestigiosa rappresentazione dell’Albero di Jesse si trova nella cappella Roano (voluta dall’Arcivescovo Giovanni Roano), detta cappella del Crocifisso, sita all’interno del Duomo di Monreale in Sicilia.
Evoluzione
L’albero di Jesse, contaminato dalla popolarità del tema della parentela santa si modifica fino a diventare, a partire dal X secolo, il modello da cui deriveranno le successive rappresentazioni degli alberi genealogici[13] e in particolare per sintetizzare figurativamente la genealogia delle famiglie reali[14].
Per Tilde Giani Gallino l’albero di Jesse dell’abbazia di Saint-Denis rappresenta, dissimulato, un fallo di dimensioni sproporzionate. Questa rappresentazione è risultato dell’inconscia compensazione del suo ideatore, l’abate Sugerio, che - sfavorito dalla natura, causa imbecille corpusculum - proiettò, tramite quello che per lui era simbolo di forza e autorità, la sua «volontà di potenza».[15][16]
L’immagine dell’albero che nasce direttamente dal fianco di Jesse, affermatasi nei secoli XI-XII, ha una sconcertante analogia con la scena in cui si vede Brahmā seduto su un loto che esce dal ventre di Viṣṇu, secondo i testi sacri Veda. Nell’arte romanica i personaggi sono collocati direttamente sui rami e non nei calici dei fiori come avverrà dopo un paio di secoli, analogamente a quanto rappresentato nelle sculture buddhiste in Birmania, Cambogia, Cina ed altre parti dell’Estremo Oriente. Queste immagini si ritrovano a Worms, Issoudun (cappella dell’Ospedale), Rouen (cattedrale), Sens (cattedrale).[17]
* Fonte: Wikipedia (ripresa parziale, senza immagini e senza note).
-
>DE DOMO DAVID. LA GENEALOGIA DI GESU’: L’ALBERO DI JESSE--- In Spagna arcivescovo indagato per una frase. Caso che fa riflettere. Nota della Presidenza CEI sul Ddl Zan.29 aprile 2021, di Federico La Sala
Nota della Presidenza CEI sul Ddl Zan.
Troppi i dubbi: serve un dialogo aperto e non pregiudiziale *
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26 aprile, coerentemente a quanto già espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel quadro della visione cristiana della persona umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna.
In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative.
L’atteggiamento che è stato di Gesù Buon Pastore ci impegna a raggiungere ogni persona, in qualunque situazione esistenziale si trovi, in particolare chi sperimenta l’emarginazione culturale e sociale.
Il pensiero va in particolare ai nostri fratelli e sorelle, alle nostre figlie e ai nostri figli, che sappiamo esposti anche in questo tempo a discriminazioni e violenze.
Con Papa Francesco desideriamo ribadire che «ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza» (Amoris Laetitia, 250).
Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della donna, e riconosciamo anche di doverci lasciar guidare ancora dalla Sacra Scrittura, dalle Scienze umane e dalla vita concreta di ogni persona per discernere sempre meglio la volontà di Dio.
Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una società più giusta e solidale.
La Presidenza della CEI
28 Aprile 2021
* Fonte: Chiesa Cattolica Italiana
Omofobia.
In Spagna arcivescovo indagato per una frase. Caso che fa riflettere
Il rischio è di introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto "reato di opinione", anche chi afferma verità affermate dalla Chiesa cattolica da sempre
di Marcello Palmieri (Avvenire, mercoledì 10 giugno 2020)
- [Foto] Il Parlamento spagnolo - Ansa
La cosiddetta Legge Mancino, recepita negli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, punisce «con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
Non solo. Lo stesso testo normativo istituisce la pena della «reclusione da sei mesi a quattro anni» per «chi in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Sono ben precise e tassative - come d’altronde impone il diritto penale - le fattispecie punite, in quanto i concetti di discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi risultano pacificamente chiari alla stragrande maggioranza dei cittadini.
Lo stesso non può dirsi per le fattispecie che vorrebbero essere incluse in questa legge: locuzioni come "identità di genere" e "orientamento sessuale" - contenuti nei testi in discussione presso la commissione Giustizia della Camera - rimandano a concetti tutt’altro che definiti, sui quali anche la comunità scientifica non si è ancora pronunciata in modo univoco. E il rischio, qualora queste proposte diventassero legge, sarebbe quello di introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto "reato di opinione", per la cui commissione basterebbe riferire un pensiero personale.
Né più né meno di quanto successo nel 2014 all’arcivescovo di Malaga (Spagna), indagato penalmente per aver affermato che la sessualità è destinata alla procreazione, evidentemente impossibile all’interno di una coppia omosessuale: una situazione, insomma, che si porrebbe in evidente contrasto il diritto alla libertà di pensiero sancita dalla nostra Costituzione. Affermare questo, tuttavia, non significa voler negare una doverosa tutela a quelle persone che, per via delle loro tendenze omo, si trovassero oggetto di qualsiasi tipo di violenza.
Già ora, infatti, il nostro ordinamento punisce penalmente chi uccide una persona, oppure la percuote, la diffama, la riduce o la mantiene in schiavitù, la sequestra, la violenta, la minaccia, la obbliga a fare o non fare una cosa, oppure ancora la rende vittima di stalking. Anche in questo caso, si tratta fatti (odiosi e delittuosi) ben chiari. Non di (liberi) pensieri, per di più su concetti tutt’altro che condivisi.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- ANDARE OLTRE LA "TEORIA" DEL "TRITTICO DI MERODE" E DELLA "DOTTA IGNORANZA"!19 aprile 2021, di Federico La Sala
#MENSCHWERDUNG.
ripartendo dal #saperedinonsapere,
Niccolò Cusano
ricade nella #antropologia zoppa e cieca di #Aristotele
e propone nella #Docta Ignorantia (III, 5) del 1440
la visione (#teoria) del trittico di Merode (1427)
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- FILOLOGIA E STORIOGRAFIA. "L’invenzione di Gesù di Nazareth" e un "refuso" di lunga durata.6 aprile 2021, di Federico La Sala
#FILOLOGIA #Storiografia #critica.
Un #lapsus e un #refuso di #lungadurata: "Le Fonti. Le lettere di #PaolodiTarso [...] 1 Cor 11, 23-26 (sull’#eucarestia: Mc 14, 22-25/Mt 26, 26-29/Lc 22, 14-20) [...]" (Fernando Bermejo-Rubio, L’invenzione di Gesù di Nazareth, Torino 2021, p. 21)! #Eucaristia, eu-#carestia, e #latinorum. Uscire dal #letargo. O no?!
#CHARIDAD, #EUCARISTIA (EU-#CHARIS-TIA), #PoncioPilato (#PonzioPilato).La #invencion de #JesusdeNazaret. #Historia #ficción #historiografia (#FernandoBermejoRubio): https://www.amazon.it/invenci%C3%B3n-jes%C3%BAs-Nazaret-Fernando-Bermejo/dp/8432319201?asin=B07KSXYNPR&revisionId=e46a8f88&format=1&depth=1
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA E SPY STORY: IL "TESTIMONIUM FLAVIANUM". Giuseppe Flavio, ambiguo testimone del Cristo. Luciano Canfora smonta molti pregiudizi (di Franco Cardini).8 luglio 2021, di Federico La Sala
Il caso.
Giuseppe Flavio, ambiguo testimone del Cristo
Ci hanno provato in tanti a farne un cripto-cristiano, basandosi su alcuni passi dove sembra porgere la prova dell’esistenza storica di Gesù. Ma in un saggio Luciano Canfora smonta molti pregiudizi
di Franco Cardini (Avvenire, giovedì 8 luglio 2021)
- [Foto] Un ritratto dello scrittore ebreo Giuseppe Flavio, autore delle ’Antichità giudaiche’ - WikiCommons
Che ci sia sempre stato, e fin dall’antichità, qualcuno che ha dubitato dell’esistenza di Gesù come personaggio storico, è cosa nota. Del resto, è successo così anche per altri personaggi storici: per Napoleone, ad esempio, che ai bei tempi dell’ipercriticismo storiografico qualche bello spirito in vena di funambolismi comparativistici qualcuno volle far passare come un ’mito solare’.
Per Gesù, poi, le voci dovevano circolare con tanta insistenza che i Padri del Concilio di Nicea, nel 325, credettero bene di metter fine alle chiacchiere annoverandolo nel loro Synbolon (poi divenuto la preghiera del Credo) tra le verità oggetto di dogma. Si continua ancor oggi, peraltro, a discutere sulla storicità della figura del Cristo: argomento al quale è stato dedicato recentemente un tomo di ben 702 pagine, L’invenzione di Gesù di Nazareth, di Fernando Bermejo-Rubio (Bollati Boringhieri). E lo studioso spagnolo, esaminando nel primo capitolo del suo saggio il tema delle fonti storiche disponibili, dedica alcune dense pagine a un passo testuale da secoli considerato ’croce e delizia’ - ma soprattutto ’croce’, ed è il caso di dirlo... - dalla critica.
Si tratta del celebre Testimonium Flavianum, l’insieme di due brevi passi delle Antichità giudaiche (XVIII, 63-64, e XX, 200), nei quali lo storico Giuseppe - che si era denominato ’Flavio’ in omaggio al suo liberatore e patrono, l’imperatore Flavio Vespasiano -, scrivendo naturalmente in greco, accenna a Gesù e lo definisce ’il Cristo’. Personalità straordinaria e discussa, questo Giuseppe. Vissuto fra il 37 e il 103 circa d.C., di famiglia sacerdotale e di tendenze farisaiche, aveva partecipato alla rivolta giudaica del 66 ricoprendo anche funzioni militari importanti. Imprigionato nel 67 dall’imperatore Vespasiano, aveva ricevuto un generoso trattamento, era rimasto in Palestina con Tito, era stato testimone oculare della distruzione del Tempio di Gerusalemme e aveva seguito quindi a Roma il nuovo imperatore.
Giuseppe è (insieme con Filone d’Alessandria, di un paio di generazioni prima) uno dei massimi esempi di quegli ambienti ebraici che si convinsero dell’opportunità della collaborazione con l’impero romano restandone sudditi fedeli. È molto probabile che, nel lungo soggiorno romano coinciso con la seconda parte della sua esistenza, Giuseppe abbia avuto notizia dei nuovi fatti che laceravano sia la comunità degli ebrei restati in Palestina, sia quelli da tempo sparsi per l’impero - ed oltre - e in modo particolare presenti nel Caput Mundi. Il testo di quel passo della sua opera più ampia sembrerebbe una decisa dichiarazione filocristiana. Ma su questo punto è nata una violenta polemica: alcuni hanno accusato il Testimonium di essere un vero e proprio falso, altri vi hanno visto comunque delle infiltrazioni.
Nella secolare polemica sono entrati un po’ tutti: il cardinal Baronio, il dotto calvinista Isaac Casaubon, Edward Gibbon, ovviamente il Voltaire e via dicendo. La pietra dello scandalo non era tanto se davvero Giuseppe Flavio avesse mai nominato Gesù, quanto il fatto che fino dai suoi primi tempi l’intellighenzia cristiana si era impadronita di lui: da Giustino e Minucio Felice a metà del II secolo, fino a Eusebio e quindi, con decisione, a sant’Ambrogio e a san Girolamo, egli era divenuto non solo un testimone sicuro di Gesù ma un cristiano o filocristiano egli stesso.
È stato forse proprio Isaac Casaubon a gettare Luciano Canfora in caccia, sulle tracce di Giuseppe Flavio, della parziale o totale autenticità o meno del Testimonium Flavianum, della legittimità o meno della decisione con la quale gli autori cristiani procedettero al suo arruolamento nelle loro fila. Perché dalla filoromanità al filocristianesimo il passo di un ebreo ellenizzato del I secolo d.C. non è breve e potrebb’essere problematico. E la lettera del Testimonium è di per sé sottilmente ambigua: potrebbe esser letta come un’ovvia attestazione di fede, ma altresì come una tanto dura qualto sottile attestazione anticristiana.
Casuabon è abbastanza noto al grande pubblico in quanto egli e un paio di personaggi con il suo stesso cognome figurano nel Pendolo di Foucault di Umberto Eco, del 1988. Canfora ne aveva fatto il protagonista di uno studio attentissimo e coinvolgente del 2002, Convertire Casuabon (Adelphi, 2002), un vero e proprio ’thriller filologico’ fondato su un articolato tentativo gesuitico di conquistare al campo cattolico il dotto e implacabile erudito calvinista. Può darsi dunque che quel breve ma non brevissimo scritto che un ventennio fa valse a Canfora il ’Premio Capalbio’ sia la radice e l’antefatto di un suo libro recentissimo, La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato (Salerno, pagine 196, euro 18), che ha l’unico torto di essere stato riduttivamente inserito dall’Editore nella collana ’Piccoli Saggi’. Che un libro di quasi 200 pagine sia, quanto alla sua mole, già ’piccolo’, è discutibile ma accettabile; sul piano della sostanza, però, siamo al livello del Canfora migliore: come filologo rigoroso, come duttile storico capace di spaziare dall’antica Grecia al presente, come polemista lucido e talora perfido e infine - è giusto riconoscerglielo - come scrittore lucido e spesso divertente. Si è detto di lui ch’egli è capace di «trasformare la filologia in spy story e la storia della cultura in appassionante racconto».
Fedeli al suo spirito, ci guarderemo bene dall’assecondare l’odiosa e spregevole pigrizia di quei pessimi lettori di ’gialli’ che vanno subito a sbirciare nelle ultime pagine il nome dell’assassino. Del resto, in questo caso se lo facessero rimarrebbero delusi. Canfora è troppo buon professore per assecondare i vizi degli allievi: e il suo Epilogo - incentrato sulla corrispondenza fra Spinoza ed Heinrich/Henry Oldenburg, segretario della Royal Society di Londra e ’cristiano-apoca-littico’, è la perfetta conclusione filologica di una spy story: se non si è letto con attenzione il libro, si rischia di fraintenderne le conclusioni. Sine labore, nullum gaudium.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- IL "TESTIMONIUM FLAVIANUM". “La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato” di Luciano Canfora. Recensione (di Laura Bigoni).8 luglio 2021, di Federico La Sala
“La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato” di Luciano Canfora
- Recensione a: Luciano Canfora, La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato, Salerno Editrice, Roma 2021, pp. 200, 18 euro (scheda libro)
Scritto da Laura Bigoni *
Lezioni di metodo per il presente
Nel XVIII libro delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, autore ebreo di età romana imperiale (37-100 d.C. ca.), si fa menzione del processo a Gesù:
- «In quel tempo visse Gesù, uomo saggio, se pure lo si può chiamare uomo; poiché egli compì opere sorprendenti, e fu maestro di persone che accoglievano con piacere la verità. Egli conquistò molti Giudei e molti Greci. Egli era il Cristo. Quando Pilato udì che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che fin da principio lo avevano amato non cessarono di aderire a lui. Nel terzo giorno, apparve loro nuovamente vivo: perché i profeti di Dio avevano profetato queste e innumeri altre cose meravigliose su di lui. E fino ad oggi non è venuta meno la tribù di coloro che da lui sono detti Cristiani» (AJ, XVIII 63-64).
Queste parole, definite nel corso del tempo Testimonium Flavianum, hanno rappresentato il principale biglietto da visita del loro autore per accedere alla tradizione manoscritta occidentale, in massima parte come sappiamo dovuta a mani cristiane; esse costituiscono però anche un appassionante caso filologico, se non altro per la strana ambiguità che le contraddistingue, se le si pensa (così come ce le trasmettono i manoscritti) nella penna di un intellettuale ebreo. -Nella ristampa del 2018 dell’edizione UTET delle Antichità, a cura di Luigi Moraldi, da cui è tratta la traduzione sopra riportata, il passo è presentato addirittura in copertina al secondo volume, di per sé un riconoscimento della centralità di quelle poche righe all’interno dell’opera di Giuseppe Flavio.
 Si tratta però, prevedibilmente, di una centralità acquisita nel corso della tradizione e della sempre più grande fortuna che i padri della Chiesa costruirono attorno a Giuseppe Flavio e al suo Testimonium, decretandone di fatto la diffusione (e la copiatura). Proprio della storia di questa straordinaria fortuna ci fa dono Luciano Canfora nella breve ma densissima indagine dal titolo La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato, recentemente pubblicata per Salerno Editrice.
Il libro è organizzato in diciotto brevi capitoli, preceduti da un’introduzione e seguiti da un epilogo; ciascuno aggiunge un tassello al mosaico della tradizione testuale di Giuseppe Flavio, introducendone via via i protagonisti e i contesti. La struttura rende agevole a chi legge il viaggio tra i meandri di una tradizione testuale fatta di riconoscimenti, di attribuzioni pseudonime, di ritocchi più o meno tendenziosi, ma soprattutto, e fatalmente quando si tratta di testi cui si attribuisce valore religioso, di fazioni.
Si tratta però, prevedibilmente, di una centralità acquisita nel corso della tradizione e della sempre più grande fortuna che i padri della Chiesa costruirono attorno a Giuseppe Flavio e al suo Testimonium, decretandone di fatto la diffusione (e la copiatura). Proprio della storia di questa straordinaria fortuna ci fa dono Luciano Canfora nella breve ma densissima indagine dal titolo La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato, recentemente pubblicata per Salerno Editrice.
Il libro è organizzato in diciotto brevi capitoli, preceduti da un’introduzione e seguiti da un epilogo; ciascuno aggiunge un tassello al mosaico della tradizione testuale di Giuseppe Flavio, introducendone via via i protagonisti e i contesti. La struttura rende agevole a chi legge il viaggio tra i meandri di una tradizione testuale fatta di riconoscimenti, di attribuzioni pseudonime, di ritocchi più o meno tendenziosi, ma soprattutto, e fatalmente quando si tratta di testi cui si attribuisce valore religioso, di fazioni.
 La storia del testo di Giuseppe Flavio narrataci da Canfora diventa infatti ben presto simile a quella della traduzione greca delle Scritture di Israele detta dei Settanta, campo di battaglia per dispute di natura teologica e oggetto di ripetute canonizzazioni. Secondo la puntuale ricostruzione del libro, infatti, la sopravvivenza delle opere quasi complete dell’autore (ovvero Guerra giudaica, Antichità, Contro Apione e Autobiografia) nella tradizione manoscritta sembra ricollegabile ad una cosciente appropriazione culturale da parte dei pensatori cristiani, fin da Eusebio di Cesarea (260-337 ca.) e Girolamo (347-419 ca.).
La storia del testo di Giuseppe Flavio narrataci da Canfora diventa infatti ben presto simile a quella della traduzione greca delle Scritture di Israele detta dei Settanta, campo di battaglia per dispute di natura teologica e oggetto di ripetute canonizzazioni. Secondo la puntuale ricostruzione del libro, infatti, la sopravvivenza delle opere quasi complete dell’autore (ovvero Guerra giudaica, Antichità, Contro Apione e Autobiografia) nella tradizione manoscritta sembra ricollegabile ad una cosciente appropriazione culturale da parte dei pensatori cristiani, fin da Eusebio di Cesarea (260-337 ca.) e Girolamo (347-419 ca.).
 Nella temperie dei primi secoli del cristianesimo, apparve infatti vantaggioso che uno storico ebreo, che aveva assistito, dalla parte dei Romani, alla distruzione del Tempio a Gerusalemme, avesse anche solo menzionato Gesù e il suo processo, sebbene nel contesto di una serie di seditiones del tempo di Ponzio Pilato (cf. pp. 76ss.). Segno inequivocabile dell’avvenuta appropriazione è la migrazione del Testimonium all’altra grande opera di Giuseppe, la Guerra giudaica, che si trova in alcuni manoscritti, tra cui il Vossiano greco F 72, oggi conservato a Leiden, in cui il nostro testo è addirittura seguito da una scena di giudizio universale, che fa dunque della vicenda terrena di Gesù una tappa cruciale della storia della salvezza, secondo una visione strettamente cristiana; l’accoppiamento ha poi una vita propria nella tradizione successiva (cf. pp. 51s.).
Nella temperie dei primi secoli del cristianesimo, apparve infatti vantaggioso che uno storico ebreo, che aveva assistito, dalla parte dei Romani, alla distruzione del Tempio a Gerusalemme, avesse anche solo menzionato Gesù e il suo processo, sebbene nel contesto di una serie di seditiones del tempo di Ponzio Pilato (cf. pp. 76ss.). Segno inequivocabile dell’avvenuta appropriazione è la migrazione del Testimonium all’altra grande opera di Giuseppe, la Guerra giudaica, che si trova in alcuni manoscritti, tra cui il Vossiano greco F 72, oggi conservato a Leiden, in cui il nostro testo è addirittura seguito da una scena di giudizio universale, che fa dunque della vicenda terrena di Gesù una tappa cruciale della storia della salvezza, secondo una visione strettamente cristiana; l’accoppiamento ha poi una vita propria nella tradizione successiva (cf. pp. 51s.).
 Parallelamente alla fortuna negli ambienti dell’apologetica cristiana, nel mondo ebraico (come in quello pagano, in cui sempre cercò di inserirsi e di farsi leggere, senza successo) Giuseppe è stato ben presto ridotto al silenzio. Le vicende del testo sono alterne a seconda del contesto politico, ma per i cristiani il Testimonium sembra sempre un asso nella manica, come ad esempio nel periodo di crisi della Chiesa sotto Giuliano l’Apostata, in cui fu agevole forzare la dizione di un passo della Guerra guidaica (VI 250, 288-310) a significare una precisa volontà di Dio dietro la distruzione del Tempio, profetizzata ex post nei Vangeli (cf. pp. 155ss.).
Parallelamente alla fortuna negli ambienti dell’apologetica cristiana, nel mondo ebraico (come in quello pagano, in cui sempre cercò di inserirsi e di farsi leggere, senza successo) Giuseppe è stato ben presto ridotto al silenzio. Le vicende del testo sono alterne a seconda del contesto politico, ma per i cristiani il Testimonium sembra sempre un asso nella manica, come ad esempio nel periodo di crisi della Chiesa sotto Giuliano l’Apostata, in cui fu agevole forzare la dizione di un passo della Guerra guidaica (VI 250, 288-310) a significare una precisa volontà di Dio dietro la distruzione del Tempio, profetizzata ex post nei Vangeli (cf. pp. 155ss.).Soffermandosi sul Testimonium e tratteggiando uno status quaestionis, l’autore si chiede come mai non ci si sia mai dedicati troppo alla domanda, per lui al contrario centrale, relativa all’appropriazione culturale operata dai cristiani sul testo di Giuseppe Flavio. Verrebbe da chiedersi se non ci sia forse ancora un impalpabile velo di sostituzionismo latente in questo genere di studi, che scoraggi i tentativi di fare luce su stadi precristiani dei testi poi incardinati nella tradizione della Chiesa. Pur lasciando irrisolta l’aporia a proposito degli studi moderni, Canfora punta il dito sul dato, eclatante per la storia della tradizione, che l’opera in greco di Giuseppe sia giunta intera (a fronte del naufragio di gran parte della letteratura, storiografica e non, in greco classico e postclassico), mentre non è rimasta nessuna traccia delle stesure aramaiche (cf. pp. 35ss.).
 Importante è il riconoscimento e lo smascheramento del ruolo della progressiva cristianizzazione del Testimonium, che lo apparenta alla traduzione della Bibbia dei Settanta. Sul paragone l’autore si sofferma considerando un dato tanto ovvio quanto trascurato come l’appropriazione delle Scritture tradotte in greco dai giudei della diaspora ellenistica, che passano così nettamente nell’alveo della Chiesa da prendere il nome di ‘Antico Testamento’, che significa naturalmente un presupposto del Nuovo. Come Giuseppe Flavio perde terreno nella tradizione ebraica e di fatto ne scompare, lo stesso varrà per questa straordinaria impresa traduttoria del mondo antico.
Importante è il riconoscimento e lo smascheramento del ruolo della progressiva cristianizzazione del Testimonium, che lo apparenta alla traduzione della Bibbia dei Settanta. Sul paragone l’autore si sofferma considerando un dato tanto ovvio quanto trascurato come l’appropriazione delle Scritture tradotte in greco dai giudei della diaspora ellenistica, che passano così nettamente nell’alveo della Chiesa da prendere il nome di ‘Antico Testamento’, che significa naturalmente un presupposto del Nuovo. Come Giuseppe Flavio perde terreno nella tradizione ebraica e di fatto ne scompare, lo stesso varrà per questa straordinaria impresa traduttoria del mondo antico.Alla fine del capitolo IX è presentato con chiarezza il cruccio che fu di Ambrogio, ma anche di tutta la tradizione patristica, ovvero fino a quanto la Chiesa potesse permettersi di mostrare una continuità tra la tradizione cristiana e il mondo ebraico. In questo senso stabilire un canone diverso da quello ebraico, nella selezione dei libri sacri, nel loro ordine, nella denominazione e nel numero, fu un graduale ma vincente passo verso l’emancipazione della cristianità dalle sue pur irrinunciabili radici ebraiche[1].
 La comunanza di destini che lega due testi molto diversi come le Antichità (e a partire da esse, come si è visto, gli opera omnia di Giuseppe Flavio) e la traduzione della Bibbia è occasione per una riflessione sull’importanza della philologia sacra per il metodo storico-critico. Così si esprimeva Pasquali a proposito della eccessiva divisione del lavoro all’interno della filologia: «La colpa di questa ignoranza [della prefazione di Lachmann al Nuovo Testamento] è, credo, tutta della specializzazione. La metà del secolo XIX fu il tempo dei classicisti puri e dei latinisti puri: chi si occupava di Catullo, sdegnava di leggere e studiare il Nuovo Testamento. E d’altra parte i teologi, anche quelli protestanti, non avevano interesse per le quisquilie della storia dei testi. Tutto questo è una prova di più che nella filologia la specializzazione non può che nuocere»[2].
La comunanza di destini che lega due testi molto diversi come le Antichità (e a partire da esse, come si è visto, gli opera omnia di Giuseppe Flavio) e la traduzione della Bibbia è occasione per una riflessione sull’importanza della philologia sacra per il metodo storico-critico. Così si esprimeva Pasquali a proposito della eccessiva divisione del lavoro all’interno della filologia: «La colpa di questa ignoranza [della prefazione di Lachmann al Nuovo Testamento] è, credo, tutta della specializzazione. La metà del secolo XIX fu il tempo dei classicisti puri e dei latinisti puri: chi si occupava di Catullo, sdegnava di leggere e studiare il Nuovo Testamento. E d’altra parte i teologi, anche quelli protestanti, non avevano interesse per le quisquilie della storia dei testi. Tutto questo è una prova di più che nella filologia la specializzazione non può che nuocere»[2].
 Naturalmente, il testo di Giuseppe Flavio non è ritenuto sacro da alcuna confessione religiosa, ma si è visto come questo non impedisca alla sua storia testuale di presentare questioni simili a quelle tipiche dei testi religiosi, in quanto molto copiati e diffusi, proprio perché ritenuti oltremodo autorevoli. Un omaggio all’affinamento degli strumenti della philologia profana attraverso quella sacra sembra quindi doveroso (cf. pp. 87s.).
Naturalmente, il testo di Giuseppe Flavio non è ritenuto sacro da alcuna confessione religiosa, ma si è visto come questo non impedisca alla sua storia testuale di presentare questioni simili a quelle tipiche dei testi religiosi, in quanto molto copiati e diffusi, proprio perché ritenuti oltremodo autorevoli. Un omaggio all’affinamento degli strumenti della philologia profana attraverso quella sacra sembra quindi doveroso (cf. pp. 87s.).In questo libro, Canfora ha molti meriti: il primo è saper restituire gli ingranaggi di eventi molto lontani come se lontani non fossero, come se appartenessero a un presente senza tempo. Il merito di avvicinare le storie dei testi classici raccontandole per quello che sono, storie umane. E spogliandole così dell’aura di sacralità e intoccabilità che abbiamo progressivamente affibbiato all’antico. Nel suo narrare, assumono un ruolo centrale i recessi, il backstage che viene alla luce grazie alla minuzia filologica, col risultato di restituire un complesso vivo. Nei primi capitoli traccia un profilo dell’autore, sottolineando la tipicità e la concretezza della vita di un transfuga ebreo in epoca romana, il compromesso raggiunto con l’ellenismo e con la dominazione straniera, senza mai rinnegare la fede dei padri, ma tentando di inserirla nella (e legittimarla agli occhi della) cultura dominante. Come ci riferisce nel proemio, Giuseppe scrive «perché ritengo di essere debitore a tutti i Greci, perché - così mi pare - comprenderanno la nostra grande antichità e l’ordinamento politico degli Ebrei» (AJ, I 5). Nei capitoli successivi Canfora scava altrettanto scrupolosamente nelle ragioni dei rappresentanti delle fazioni pro e contra Giuseppe, restituendocene i tratti notevoli.
Un secondo merito è quello di aver sparso tra le pagine più di una lezione di filologia e di metodo, con un taglio divulgativo al punto giusto da essere comprensibile ai non addetti ai lavori, ma anche istruttivo, se non altro come memento, a chi addetto lo è eccome. Sfata, ad esempio, miti come quello del copista capriccioso che cambia il testo a suo (com)piacimento (pp. 42s.), e non lo fa per rendere meno appassionante la lettura di un saggio filologico, quanto per rinfrescare in chi legge l’attitudine al metodo storico-critico come valore inderogabile dello studio quotidiano; come ricorda, con felice espressione, a p. 49, «la via d’uscita è sempre la storia del testo».
In questo quadro credo debbano inserirsi anche le parole sferzanti riservate, spesso in nota ma non solo, ad alcune delle nuove imprese di studio comprensivo dell’antichità e dei suoi autori, in cui si ignora sistematicamente la discussione sei-settecentesca e in generale la storia della disciplina. Per esempio, l’affondo di p. 117 su studi contemporanei che, «purché espressi in inglese», possono dire quel che vogliono, dal momento che il nostro «è un ambito di studi nel quale non costa nulla fare passi indietro», o la desolante conclusione di p. 128: «Bilancio. Anche a seguito della feticistica devozione al monolinguismo anglico, si è andata via via smarrendo la conoscenza dei risultati cui era giunta la grande erudizione dei secoli XVI-XVII (quasi sempre in latino). Di conseguenza si riscrive goffamente e con qualche contributo peggiorativo ciò che era stato già da secoli prospettato e argomentato con ben altra finezza e disciplina critica». In effetti, quella di tornare a leggere la storia di una disciplina come la filologia, che funziona inevitabilmente per accumulazione, è nota importante, in un’epoca che sembra talora perdere l’attenzione per la storia[3]. Anche senza entrare in un discorso troppo generale e perciò troppo generico, occorre fare attenzione alla maniera in cui certe argomentazioni sono già state poste in passato; Canfora porta dunque alla luce del pubblico contemporaneo delle situazioni a loro modo paradigmatiche del mestiere della storia e della critica testuale, considerando uno spettro di fonti davvero ampio e riconoscendo il giusto credito a studiosi che sarebbero altrimenti dimenticati anche in opere di settore.
Oltre che illuminare sul metodo, Canfora ricorda a chi legge anche un dato cruciale della natura dei testi, ovvero la loro intrinseca mobilità (è forse questo che più di ogni altro cardine della filologia dovrebbe essere insegnato). L’autore riporta un breve ma significativo cenno ai tempi moderni, in cui sottolinea il valore costante e universale di questa caratteristica dei testi: «per chiarezza, è bene non dimenticare che una ‘citazione’ può nascere anche da un fraintendimento, o da una notizia di seconda mano, che - nel passaggio da una fonte all’altra - si gonfia e si complica, e magari [...] finisce in una ‘Enciclopedia’ (accade anche in tempi moderni)» (p. 51). Nel mutare continuo dei testi, anche una sola parola può bastare a cambiarne il volto, come nel caso del Testimonium, in cui è stato sufficiente sostituire un ‘era ritenuto’ con un ‘era’ nella frase cruciale «egli era il Cristo» (cf. p. 58). Non è certo la prima né l’ultima volta che un’unica parola è in grado di generare effetti così notevoli; si pensi al filioque dei primi concili cristiani, o al solum aggiunto da Lutero nella sua traduzione della Lettera ai Romani (3,28)[4].
Sebbene questo risulti quasi paradossale, vista la sua smisurata produzione scientifica, Canfora ricorda a chi si occupa di filologia il monito nietzschiano a proposito della lentezza di questa disciplina, per cui il/la filologo/a «non raggiunge nulla se non lo raggiunge lento»[5]. Proprio nel lento ascolto delle fonti e nell’attento vaglio di ciascuna di esse sta la straordinaria (e forse per alcuni inaspettata) apertura della filologia: una metodologia non dogmatica, che presta attenzione alla pluralità delle fonti e al loro intreccio: lo si vede nel libro, ad esempio nell’uso della tradizione araba (cui è dedicato il cap. VII), o di quella siriaca. Le interazioni sempre più strette con le discipline orientalistiche e con le tradizioni delle lingue semitiche spostano l’orizzonte di quello che siamo abituati a conoscere come il mondo classico, ampliandolo e riformandone il concetto stesso.
L’ultima e forse la più importante delle lezioni che si può trarre dalla conoscenza così approfondita di certe controversie sull’autorità dei testi, fitte di accuse e controaccuse dettate da opportunità di politica religiosa (o culturale in senso ampio), è quella di tentare un affrancamento dalla faziosità, una visione laica, inclusiva e basata sulla profondità storica quando si approcciano testi dalla tradizione così imponente. È insomma quella di provare a sostenere un campo di studi che sproni a lasciarsi questo tipo di controversie finalmente alle spalle.
[1] Cf. J. Mead, The Biblical Canon Lists from Early Christianity. Texts and Analysis, Oxford University Press, Oxford 2018.
[2] G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Le Lettere, Firenze 2015, p. 8.
[3] Recentissimo il volumetto di Adriano Prosperi dall’eloquente titolo Un tempo senza storia. La distruzione del passato (Einaudi, Torino 2021).
[4] Sul primo caso, si veda l’inquadramento di L. Perrone, Da Nicea (325) a Calcedonia (451). I primi quattro concili ecumenici: istituzioni, dottrine, processi di redazione, in G. Alberigo (ed.), Storia dei concili ecumenici, Queriniana, Brescia 1990, pp. 11-118; sul secondo, basti leggere la luterana Lettera del tradurre, nella versione italiana a cura di E. Bonfatti (Marsilio, Venezia 2001).
[5] F. Nietzsche, Aurora. Pensieri su pregiudizi morali, trad. it. F. Masini, in B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo, Feltrinelli, Milano 2006, p. 329.
- Laura Bigoni. Nasce a Bibbiena nel 1993. Dopo la laurea in Filologia greca a Bologna, dove è stata allieva del Collegio Superiore, è dottoranda in Storia delle Religioni all’Università di Strasburgo e si occupa principalmente di lessicografia greca e di tradizione e ricezione della Bibbia dei Settanta. Collabora al progetto “Historical and Theological Lexicon of the Septuagint” (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna). È appassionata di teatro, lingue antiche e moderne e yoga.
* FONTE: PANDORA RIVISTA
-
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- BASTA CON LA "EU-CARESTIA". USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA: IN MEMORIA DI DANTE ALIGHIERI (2021).1 aprile 2021, di Federico La Sala
#DANTE2021
- La #DivinaCommedia: "l’#amor che move il #sole e le altre #stelle"(Pd. XXXIII, 145), o la eterna #tragedia di un #Dio che «non ha risparmiato il proprio #Figlio, ma lo ha offerto per tutti noi» (San Paolo, Lett. ai Romani., 8.32)? *
STORIA DELL’ARTE E TEOLOGIA:
LA PRIMA “CENA” DI “CAINO” (DOPO AVER UCCISO IL PASTORE “ABELE”) E L’INIZIO DELLA “BUONA-CARESTIA”(“EU-CARESTIA”)!
NELL’OSSERVARE “L’Ultima Cena raffigurata sulla parete di fondo del refettorio dell’ex convento dei francescani di Veglie” (sec. XVI/XVII ca.) E NEL RIFLETTERE SUL FATTO CHE “è tra le più canoniche rappresentazioni del momento in cui Cristo istituì la santissima Eucarestia” (Riccardo Viganò, "Fondazione Terra d’Otranto"), c’è da interrogarsi bene e a fondo su chi (teologi ed artisti) abbia potuto concepire e dare forma con straodinaria chiarezza e potenza a questa “cena”(vedere la figura: “Portata centrale, saliere e frutti”) e, insieme, riflettere ancora e meglio sui tempi lunghi e sui tempi brevi della storia di questa interpretazione tragica del messaggio evangelico - a tutti i livelli, dal punto di vista filosofico, teologico, filologico, artistico, sociologico. O no?
NOTARE BENE E RICORDARE. Siamo a 700 anni dalla morte dell’autore della “COMMEDIA”, della “DIVINA COMMEDIA”, e della sua “MONARCHIA”!
SAPERE AUDE! (I. KANT). Sul tema, per svegliarsi dal famoso “sonno dogmatico”, mi sia lecito, si cfr. l’intervento di Armando Polito, “Ubi maior minor cessat”(Fondazione Terra d’Otranto, 24.02.2021) e, ancora, una mia ipotesi di ri-lettura della vita e dell’opera di Dante Alighieri.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- San Paolo "ai Romani": "Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!" (Lettera ai Romani, 8. 31-34).
- Papa Francesco ai "cari fratelli sacerdoti":
- "[...] La magnanimità di quell’uomo che manda il suo figlio pensando che sarà rispettato dai vignaioli, scatena tuttavia in essi una ferocia fuori da ogni misura: siamo di fronte al mistero dell’iniquità, che porta a uccidere il Giusto (cfr Mt 21,33-46).
- Tutto questo, cari fratelli sacerdoti, ci fa vedere che l’annuncio della Buona Notizia è legato misteriosamente alla persecuzione e alla Croce.
- Sant’Ignazio di Loyola, nella contemplazione della Natività - scusatemi questa pubblicità di famiglia -, in quella contemplazione della Natività esprime questa verità evangelica quando ci fa osservare e considerare quello che fanno San Giuseppe e la Madonna: «Per esempio, camminano e si danno da fare perché il Signore nasca in un’estrema povertà e, dopo aver tanto sofferto fame e sete, caldo e freddo, ingiurie e oltraggi, muoia in croce. E tutto questo per me. Poi - aggiunge Ignazio -, riflettendo, ricavare qualche frutto spirituale» (Esercizi spirituali, 116). La gioia della nascita del Signore, il dolore della Croce, la persecuzione.
- Che riflessione possiamo fare per trarre profitto per la nostra vita sacerdotale contemplando questa precoce presenza della Croce - dell’incomprensione, del rifiuto, della persecuzione - all’inizio e nel cuore stesso della predicazione evangelica? [...]"(OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO. Basilica di San Pietro. Giovedì Santo, 1 aprile 2021).
Con Wojtyla (2000), oltre. Guarire la nostra Terra. Verità e riconciliazione
FLS
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- MEMORIA DI SAN GIUSEPPE, UN "UOMO GIUSTO", E DI DANTE ALIGHIERI (25 MARZO 2021).19 marzo 2021, di Federico La Sala
LA “DIVINA COMMEDIA” E IL CUORE DEL “PADRE NOSTRO”, “L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE”...
- Una nota a margine dell’art. di di Fabrizio Cazzato, "Raffigurazioni di San Giuseppe a Tutino di Tricase", Fondazione Terra d’Otranto, 19.03.2021.
PLAUDENDO ALL’ECCEZIONALE LAVORO DELLA REDAZIONE DELLA FONDAZIONE “TERRA D’OTRANTO”, ANCHE ALLA LUCE DI QUESTO ULTIMO CONTRIBUTO, CREDO CHE OGGI (19 MARZO 2021), ALL’INTERNO DI UN ORIZZONTE STORICO SEGNATO DA UNA PANDEMIA PLANETARIA, SIA OPPORTUNO RIFLETTERE SUL FATTO CHE QUESTO ANNO (2021) è l’anno dedicato all’Anniversario della morte (1321) di Dante Alighieri e che a Lui è stata dedicato come giorno di memoria il 25 marzo, giorno di memoria liturgica anche dell’Annunciazione (vale a dire del concepimento del Bambino).
 Accogliendo la sollecitazione di questa importante connessione, forse, è meglio ripensare a “come nascono i bambini” (antropologicamente, filosoficamente e teologicamente), alla figura dell’uomo Gesù, all’”Ecce Homo”(«Ecco l’uomo», gr. «idou ho anthropos») di Ponzio Pilato, e, ancora, alla lezione di Dante.
Accogliendo la sollecitazione di questa importante connessione, forse, è meglio ripensare a “come nascono i bambini” (antropologicamente, filosoficamente e teologicamente), alla figura dell’uomo Gesù, all’”Ecce Homo”(«Ecco l’uomo», gr. «idou ho anthropos») di Ponzio Pilato, e, ancora, alla lezione di Dante.
 A mio parere, la sua lezione non è solo “poetico-letteraria”, ma è anche teologica e politica: la sua “Monarchia” con l’indicazione relativa ai “due soli” ha, infatti, il suo fondamento teologico e antropologico nell’amore (charitas) del “Cantico dei cantici” (cioè, di Salomone - non di Costantino: rileggere il c. XIV del “Paradiso”) e pone le condizioni per rileggere l’intera figura di san Giuseppe! Egli non è affatto un falegname che prepara la croce per inchiodarci su il bambino che gli è stato affidato, ma lo sposo di Maria, discendente della casa di Davide (“de domo David”: -https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-257181) che, come Salomone, ha saputo decidere e portare in salvo la madre vera e il bambino vero! O no?!
A mio parere, la sua lezione non è solo “poetico-letteraria”, ma è anche teologica e politica: la sua “Monarchia” con l’indicazione relativa ai “due soli” ha, infatti, il suo fondamento teologico e antropologico nell’amore (charitas) del “Cantico dei cantici” (cioè, di Salomone - non di Costantino: rileggere il c. XIV del “Paradiso”) e pone le condizioni per rileggere l’intera figura di san Giuseppe! Egli non è affatto un falegname che prepara la croce per inchiodarci su il bambino che gli è stato affidato, ma lo sposo di Maria, discendente della casa di Davide (“de domo David”: -https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-257181) che, come Salomone, ha saputo decidere e portare in salvo la madre vera e il bambino vero! O no?!-
>MEMORIA DI SAN GIUSEPPE, UN "UOMO GIUSTO", E DI DANTE ALIGHIERI (25 MARZO 2021). --- CANDOR LUCIS AETERNAE. NEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI, LA LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO.25 marzo 2021, di Federico La Sala
LETTERA APOSTOLICA
CANDOR LUCIS AETERNAE
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
NEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI *
Splendore della Luce eterna, il Verbo di Dio prese carne dalla Vergine Maria quando Ella rispose “eccomi” all’annuncio dell’Angelo (cfr Lc 1,38). Il giorno in cui la Liturgia celebra questo ineffabile Mistero è anche particolarmente significativo per la vicenda storica e letteraria del sommo poeta Dante Alighieri, profeta di speranza e testimone della sete di infinito insita nel cuore dell’uomo. In questa ricorrenza, pertanto, desidero unirmi anch’io al numeroso coro di quanti vogliono onorare la sua memoria nel VII Centenario della morte.
Il 25 marzo, infatti, a Firenze iniziava l’anno secondo il computo ab Incarnatione. Tale data, vicina all’equinozio di primavera e nella prospettiva pasquale, era associata sia alla creazione del mondo sia alla redenzione operata da Cristo sulla croce, inizio della nuova creazione. Essa, pertanto, nella luce del Verbo incarnato, invita a contemplare il disegno d’amore che è il cuore stesso e la fonte ispiratrice dell’opera più celebre del Poeta, la Divina Commedia, nella cui ultima cantica l’evento dell’Incarnazione viene ricordato da San Bernardo con questi celebri versi: «Nel ventre tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’etterna pace / così è germinato questo fiore» (Par. XXXIII, 7-9).*
Già nel Purgatorio Dante rappresentava, scolpita su una balza rocciosa, la scena dell’Annunciazione (X, 34-37.40-45).
Non può dunque mancare, in questa circostanza, la voce della Chiesa che si associa all’unanime commemorazione dell’uomo e del poeta Dante Alighieri. Molto meglio di tanti altri, egli ha saputo esprimere, con la bellezza della poesia, la profondità del mistero di Dio e dell’amore. Il suo poema, altissima espressione del genio umano, è frutto di un’ispirazione nuova e profonda, di cui il Poeta è consapevole quando ne parla come del «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra» (Par. XXV, 1-2).
Con questa Lettera Apostolica desidero unire la mia voce a quelle dei miei Predecessori che hanno onorato e celebrato il Poeta, particolarmente in occasione degli anniversari della nascita o della morte, così da proporlo nuovamente all’attenzione della Chiesa, all’universalità dei fedeli, agli studiosi di letteratura, ai teologi, agli artisti. Ricorderò brevemente questi interventi, focalizzando l’attenzione sui Pontefici dell’ultimo secolo e sui loro documenti di maggior rilievo. [...]
In questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, da situazioni che degradano l’umanità, da una mancanza di fiducia e di prospettive per il futuro, la figura di Dante, profeta di speranza e testimone del desiderio umano di felicità, può ancora donarci parole ed esempi che danno slancio al nostro cammino. Può aiutarci ad avanzare con serenità e coraggio nel pellegrinaggio della vita e della fede che tutti siamo chiamati a compiere, finché il nostro cuore non avrà trovato la vera pace e la vera gioia, finché non arriveremo alla meta ultima di tutta l’umanità, «l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Par. XXXIII, 145).
Dal Vaticano, 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore, dell’anno 2021, nono del mio pontificato.
Francesco
* PER IL TESTO INTEGRALE, CFR. -> VATICAN.VA.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- «Uniti da San Giuseppe», il custode del Redentore. Al via l’Anno della famiglia.16 marzo 2021, di Federico La Sala
L’iniziativa.
Il 19 marzo al via l’Anno della famiglia. «Uniti da San Giuseppe»
Sedici congregazioni religiose danno vita a un Comitato per iniziative comuni. Primo appuntamento un triduo online in preparazione alla festa del 19 marzo
di Enrico Lenzi (Avvenire, domenica 14 marzo 2021)
- Era il 19 marzo del 2016 quando il magistero papale sulla famiglia compiva un deciso passo in avanti. Pochi mesi prima, nell’ottobre 2015, il Papa aveva chiamato a Roma la Chiesa di ogni parte del mondo per riflettere in modo sinodale sulla “vocazione e la missione” del nucleo familiare. Da quell’assise, e da quel confronto, era scaturita l’esortazione apostolica Amoris laetitia che ora, cinque anni dopo, porta all’avvio di un anno speciale che Francesco ha intitolato proprio col nome del documento, come ha ricordato nel dopo Angelus di domenica: "Venerdì prossimo, 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, si aprirà l’anno della famiglia Amoris laetitia: un anno speciale per crescere nell’amore familiare. Invito a uno slancio pastorale rinnovato e creativo per mettere la famiglia al centro dell’attenzione della Chiesa e della società".
Sedici congregazioni tra maschili e femminili, diverse per storia, carisma, luogo di nascita e diffusione, ma unite dal riconoscere in san Giuseppe il proprio patrono o il santo ispiratore dell’azione della famiglia religiosa. È uno dei frutti del lavoro che già da qualche anno tre di queste famiglie religiose (i Giuseppini del Murialdo, gli Oblati di san Giuseppe e la Federazione italiana suore di san Giuseppe) stanno compiendo per diffondere non tanto la devozione, quanto la conoscenza dell’opera e del ruolo del Custode del Redentore.
Complice anche l’Anno di san Giuseppe indetto lo scorso 8 dicembre da papa Francesco, il nucleo iniziale di questa collaborazione ha deciso di invitare anche le altre famiglie religiose che pongono san Giuseppe all’interno del proprio carisma. Nasce così il Comitato San Giuseppe, che «in questo anno ha deciso di dare vita a un calendario di incontri e iniziative - spiega uno dei coordinatori, padre Luigi Testa, Oblato di san Giuseppe, congregazione nata ad Asti nel 1878 grazie a san Giuseppe Marello -, alla luce della Lettera apostolica «Patris corde» che papa Francesco ha diffuso proprio l’8 dicembre 2020 a 150 anni dalla proclamazione di san Giuseppe a patrono della Chiesa universale ».
E proprio da quel documento papale sono tratte le riflessioni che caratterizzeranno il triduo in preparazione alla memoria liturgica di san Giuseppe (19 marzo), che si svolgerà online sul canale YouTube denominato «Comitato San Giuseppe» il 16, 17 e 18 marzo prossimi alle 15.
 A quell’ora, infatti, sarà possibile seguire le riflessioni che tre religiosi e tre religiose, alternandosi, faranno prendendo ciascuno un aspetto della Patris corde.
A quell’ora, infatti, sarà possibile seguire le riflessioni che tre religiosi e tre religiose, alternandosi, faranno prendendo ciascuno un aspetto della Patris corde.
 Si inizia il 16 marzo con un collegamento dalla Basilica di san Giuseppe al Trionfale a Roma in cui si rifletterà sull’aspetto del «padre nella tenerezza» e in quello «nell’obbedienza».
Si inizia il 16 marzo con un collegamento dalla Basilica di san Giuseppe al Trionfale a Roma in cui si rifletterà sull’aspetto del «padre nella tenerezza» e in quello «nell’obbedienza».
 Il giorno successivo, dal Santuario San Giuseppe a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) si rifletterà sul Custode del Redentore come «padre nell’accoglienza » e «padre del coraggio creativo».
Il giorno successivo, dal Santuario San Giuseppe a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) si rifletterà sul Custode del Redentore come «padre nell’accoglienza » e «padre del coraggio creativo».
 Infine il 18, dal Santuario San Giuseppe ad Asti, si affronterà la figura come «padre lavoratore » e «padre nell’ombra».
Infine il 18, dal Santuario San Giuseppe ad Asti, si affronterà la figura come «padre lavoratore » e «padre nell’ombra».Ma il triduo «è l’appuntamento più ravvicinato del programma che stiamo elaborando insieme - spiega padre Testa -. Il 29 aprile abbiamo una iniziativa che coinvolgerà le scuole superiori. Si intitola “Nel laboratorio di Giuseppe. I giovani e il lavoro tra paura e speranza”, a cui è legato anche un concorso («Domani è un’altra impresa») che assegnerà alcune borse di studio». L’evento sarà in streaming e avrà come sede principale il Collegio Artigianelli di Torino dei Giuseppini del Murialdo e vi saranno collegamenti con Roma e Lucera.
 Già fissato anche l’evento che si lega alla conclusione dell’Anno di San Giuseppe: sarà a Roma dal 6 all’8 dicembre. «Stiamo studiando programma, relatori e modalità di realizzazione - aggiunge padre Testa -, ma intendiamo viverlo non come momento finale di un percorso, bensì come occasione per rilanciare l’attività di conoscenza e di studio anche teologico sulla figura di san Giuseppe». Insomma «ci domanderemo come continuare il percorso anche dopo il 2021».
Già fissato anche l’evento che si lega alla conclusione dell’Anno di San Giuseppe: sarà a Roma dal 6 all’8 dicembre. «Stiamo studiando programma, relatori e modalità di realizzazione - aggiunge padre Testa -, ma intendiamo viverlo non come momento finale di un percorso, bensì come occasione per rilanciare l’attività di conoscenza e di studio anche teologico sulla figura di san Giuseppe». Insomma «ci domanderemo come continuare il percorso anche dopo il 2021». -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- SALOMONE ("DE DOMO DAVID") E LA LEZIONE DI MICHELANGELO.La "Donna Sapienza fin dal principio" (di Marinella Perroni).3 marzo 2021, di Federico La Sala
Donna Sapienza
fin dal principio
di Marinella Perroni
 Biblista, Pontificio Ateneo S. Anselmo *
Biblista, Pontificio Ateneo S. Anselmo *Salomone lo conoscono più o meno tutti. Se non altro per quello stratagemma di voler far tagliare in due un bambino conteso tra due madri: una storia raccontata nel primo libro dei Re (3, 16-28).
 Forse, alcuni sanno anche che la saggezza del figlio di Davide e di Betsabea, l’adultera, è divenuta proverbiale perché il regno di Salomone ha assicurato a Israele non soltanto pace e stabilità, ma anche il contatto con le altre grandi culture del Vicino Oriente e, quindi, un tempo di grande vivacità culturale e di progresso civile. Per questo Israele ha attribuito al re Salomone tutta la riflessione sapienziale che sta alla base di alcuni libri della Bibbia, scritti in realtà in epoche diverse (dal secolo V al II prima di Cristo), che contengono sentenze, orientamenti e norme che hanno di mira una vita proficua e felice. Quasi nessuno però sa che quella sapienza che ha reso famoso Salomone è una raffigurazione che, accanto ad altre due figure, la Legge e il Messia, consente di capire perché, ma soprattutto come, Dio si fa presente nella storia del suo popolo. Ed è figura femminile.
Forse, alcuni sanno anche che la saggezza del figlio di Davide e di Betsabea, l’adultera, è divenuta proverbiale perché il regno di Salomone ha assicurato a Israele non soltanto pace e stabilità, ma anche il contatto con le altre grandi culture del Vicino Oriente e, quindi, un tempo di grande vivacità culturale e di progresso civile. Per questo Israele ha attribuito al re Salomone tutta la riflessione sapienziale che sta alla base di alcuni libri della Bibbia, scritti in realtà in epoche diverse (dal secolo V al II prima di Cristo), che contengono sentenze, orientamenti e norme che hanno di mira una vita proficua e felice. Quasi nessuno però sa che quella sapienza che ha reso famoso Salomone è una raffigurazione che, accanto ad altre due figure, la Legge e il Messia, consente di capire perché, ma soprattutto come, Dio si fa presente nella storia del suo popolo. Ed è figura femminile.Donna-Sapienza
Tra le tante cose degne di stupore emerse grazie al restauro della Cappella Sistina (1980-1994) una è, a mio avviso, tutt’altro che marginale. Nell’affresco della creazione, che occupa la volta, l’attenzione viene catturata dal vigore dell’Adamo e dalla grandiosa potenza espressiva con cui Michelangelo ha saputo rendere conto del rapporto di vicinanza e al contempo di distanza tra il creatore e la creatura fatta a sua immagine e somiglianza.
 Eppure, il restauro ha fatto riemergere un particolare per troppi secoli rimasto del tutto oscurato: tra i putti che circondano e sostengono Dio nel suo atto creativo domina una figura femminile che Dio vincola a sé in un abbraccio. Eva? Inevitabile che in molti lo sostengano, anche se, in realtà, alla creazione di Eva il pittore dedica un riquadro specifico nelle storie della Genesi che corredano la volta.
Eppure, il restauro ha fatto riemergere un particolare per troppi secoli rimasto del tutto oscurato: tra i putti che circondano e sostengono Dio nel suo atto creativo domina una figura femminile che Dio vincola a sé in un abbraccio. Eva? Inevitabile che in molti lo sostengano, anche se, in realtà, alla creazione di Eva il pittore dedica un riquadro specifico nelle storie della Genesi che corredano la volta.Se gli storici dell’arte propendono per l’identificazione con Eva, i biblisti azzardano invece un’altra ipotesi, tutt’altro che fantasiosa perché molto ben accreditata dagli scritti sapienziali della Bibbia. Leggiamo nel libro dei Proverbi: «Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. [...] Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull’abisso, [...] io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo» (Proverbi 8, 22-31).
 È la Sapienza stessa che si presenta come colei che presiede alla creazione, come la forza creativa che fa della creazione un’opera che - ce lo dice il racconto che apre il libro della Genesi - Dio considera una «cosa molto buona» (Genesi 1, 31). La reciprocità che Dio stabilisce con l’opera delle sue mani riflette, insomma, il rapporto ludico che intercorre tra Dio e la Sapienza. Il discorso sarebbe lungo: basti solo dire che, nonostante la struttura sociale di Israele fosse fortemente caratterizzata in senso patriarcale e nonostante ciò abbia spesso imposto alle donne anche pesanti restrizioni, nella letteratura biblica emergono invece, sia pure in modo carsico, attestazioni del ruolo decisivo giocato dalle donne nello sviluppo della storia di Dio con il suo popolo nonché riflessioni, spunti, allusioni che rivelano un immaginario religioso in cui la presenza femminile gioca un ruolo di primo piano. Al riguardo, gli scritti sapienziali sono una vera e propria miniera.
È la Sapienza stessa che si presenta come colei che presiede alla creazione, come la forza creativa che fa della creazione un’opera che - ce lo dice il racconto che apre il libro della Genesi - Dio considera una «cosa molto buona» (Genesi 1, 31). La reciprocità che Dio stabilisce con l’opera delle sue mani riflette, insomma, il rapporto ludico che intercorre tra Dio e la Sapienza. Il discorso sarebbe lungo: basti solo dire che, nonostante la struttura sociale di Israele fosse fortemente caratterizzata in senso patriarcale e nonostante ciò abbia spesso imposto alle donne anche pesanti restrizioni, nella letteratura biblica emergono invece, sia pure in modo carsico, attestazioni del ruolo decisivo giocato dalle donne nello sviluppo della storia di Dio con il suo popolo nonché riflessioni, spunti, allusioni che rivelano un immaginario religioso in cui la presenza femminile gioca un ruolo di primo piano. Al riguardo, gli scritti sapienziali sono una vera e propria miniera.Il termine italiano “sapienza”, come quello greco sofia, possono ingenerare un fraintendimento rispetto a quello ebraico hochmah, che ha una storia molto antica e rimanda a una qualità superiore che alcune persone hanno e altre no, l’aspirazione presente nelle radici più antiche della nostra cultura a saper orientare i nostri atteggiamenti di fondo nel mestiere di vivere. La sapienza non si insegna, ma questo non significa che la sapienza non si impari: il significato più arcaico di hakam è l’uomo abile, l’artigiano, in particolare, l’orefice, colui che conosce bene un mestiere.
La sapienza biblica tradizionale non ha quindi la pretesa di essere frutto di una rivelazione divina, per questo è stata definita una sapienza laica. E i libri sapienziali non contengono racconti mitici e nemmeno sono opere filosofiche o speculative, come quelle dei grandi pensatori greci. Sono un distillato di sapere pratico e di riflessioni sulla realtà vissuta, non vi si trovano discorsi edificanti e tanto meno devote esortazioni. La sapienza non trasmette neppure un facile moralismo religioso, ma piuttosto richiede, e in termini molto esigenti dal punto di vista umano, di saper riflettere e prendere posizione nei confronti di insegnamenti a volte perfino tra loro contraddittori. Per questo il valore della sapienza è inestimabile.
Un esempio eloquente
La divisione del libro dei Proverbi in sette sezioni potrebbe richiamare la dichiarazione che apre il c. 9 «La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne» e alludere così al fatto che, chi legge i proverbi e i discorsi di ammonimento contenuti nel libro, accoglie l’invito della sapienza a farsi ospitare nella sua casa.
 Molto ci sarebbe da dire su indubbi tratti di misoginia presenti nel testo, ma non bisogna neppure dimenticare che, più ancora che nel testo, l’androcentrismo è stata una delle dominanti della storia della sua interpretazione. Da qui la forte diffidenza nei confronti soprattutto di un brano come l’elogio della donna forte (31, 10-31) che appariva come una vera e propria esaltazione della moglie ideale che vive solo in funzione del suo uomo e dei suoi figli.
Molto ci sarebbe da dire su indubbi tratti di misoginia presenti nel testo, ma non bisogna neppure dimenticare che, più ancora che nel testo, l’androcentrismo è stata una delle dominanti della storia della sua interpretazione. Da qui la forte diffidenza nei confronti soprattutto di un brano come l’elogio della donna forte (31, 10-31) che appariva come una vera e propria esaltazione della moglie ideale che vive solo in funzione del suo uomo e dei suoi figli.
 Il capitolo è intitolato Parole di Lemuèl, re di Massa, «che egli apprese da sua madre» e si deve quindi supporre che si tratti di insegnamenti che la madre di un re trasmette a suo figlio. Non stupisce che per lungo tempo anche il ritratto della donna forte che suggella il libro sia stato interpretato come una raccolta di suggerimenti della madre al futuro re perché scelga una sposa appropriata.
Il capitolo è intitolato Parole di Lemuèl, re di Massa, «che egli apprese da sua madre» e si deve quindi supporre che si tratti di insegnamenti che la madre di un re trasmette a suo figlio. Non stupisce che per lungo tempo anche il ritratto della donna forte che suggella il libro sia stato interpretato come una raccolta di suggerimenti della madre al futuro re perché scelga una sposa appropriata.
 A ben guardare, però, il poemetto si chiude chiamando in causa direttamente una tra le “molte figlie” e questo lascia lecitamente supporre che, se la prima parte del discorso della madre è rivolta al futuro re, l’ultima parte è invece l’elogio di una figlia che «ha compiuto cose eccellenti», a cui bisogna essere «riconoscenti per il frutto delle sue mani» e di cui va tessuta lode pubblica «alle porte della città».
A ben guardare, però, il poemetto si chiude chiamando in causa direttamente una tra le “molte figlie” e questo lascia lecitamente supporre che, se la prima parte del discorso della madre è rivolta al futuro re, l’ultima parte è invece l’elogio di una figlia che «ha compiuto cose eccellenti», a cui bisogna essere «riconoscenti per il frutto delle sue mani» e di cui va tessuta lode pubblica «alle porte della città». Ben lungi dall’essere l’elogio di una futura nuora da parte di una suocera illustre, dunque, il brano contiene gli insegnamenti funzionali all’ideale di educazione del principe Lemuèl e di una principessa, di cui non si dice il nome, ma che viene interpellata direttamente.
Ben lungi dall’essere l’elogio di una futura nuora da parte di una suocera illustre, dunque, il brano contiene gli insegnamenti funzionali all’ideale di educazione del principe Lemuèl e di una principessa, di cui non si dice il nome, ma che viene interpellata direttamente.
 Studi archeologici e storico-sociali hanno poi messo in luce che, all’epoca, le donne erano proprietarie terriere ed erano attive in tutti gli ambiti menzionati nel nostro testo, dal commercio alla produzione e alla vendita dei tessuti di lusso, ben lontane cioè dall’ideale casalingo che ne faceva le regine del focolare. Per non dire, infine, che i tessuti preziosi delle sue vesti (v. 22), il lino e la porpora, sono gli stessi che arredano l’arca che guida il popolo nel deserto o che vestono i sacerdoti del Tempio e che oltre a lei (v. 25), in tutta la Bibbia solo Yahweh veste di forza (Salmo 93, 1).
Studi archeologici e storico-sociali hanno poi messo in luce che, all’epoca, le donne erano proprietarie terriere ed erano attive in tutti gli ambiti menzionati nel nostro testo, dal commercio alla produzione e alla vendita dei tessuti di lusso, ben lontane cioè dall’ideale casalingo che ne faceva le regine del focolare. Per non dire, infine, che i tessuti preziosi delle sue vesti (v. 22), il lino e la porpora, sono gli stessi che arredano l’arca che guida il popolo nel deserto o che vestono i sacerdoti del Tempio e che oltre a lei (v. 25), in tutta la Bibbia solo Yahweh veste di forza (Salmo 93, 1).Descritta dunque con tratti caratteristici dell’epoca, la donna forte con cui l’autore del libro dei Proverbi suggella il suo scritto, è Donna-Sapienza, la personificazione della Sapienza di Dio. A lei deve legarsi il re, come mostra la straordinaria preghiera per ottenere la sapienza che, non a caso, viene attribuita a Salomone (Sapienza 9, 1-18). Non è la casalinga, ma colei che, costruita la sua casa, «ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: “Chi è inesperto venga qui!”. A chi è privo di senno ella dice: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell’intelligenza” (Proverbi 9, 3-6).
I proverbi
- Una donna forte chi potrà trovarla?
 Ben superiore alle perle è il suo valore.
Ben superiore alle perle è il suo valore.
 In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto.
In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto.
 Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita.
Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita.
 Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.
Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.
 È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste.
È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste.
 Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia
Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia
 e dà ordini alle sue domestiche.
e dà ordini alle sue domestiche.
 Pensa a un campo e lo acquista
Pensa a un campo e lo acquista
 e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.
e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.
 Si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia.
Si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia.
 È soddisfatta, perché i suoi affari vanno bene;
È soddisfatta, perché i suoi affari vanno bene;
 neppure di notte si spegne la sua lampada.
neppure di notte si spegne la sua lampada.
 Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso.
Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso.
 Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero.
Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero.
 Non teme la neve per la sua famiglia,
Non teme la neve per la sua famiglia,
 perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito.
perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito.
 Si è procurata delle coperte, di lino e di porpora sono le sue vesti.
Si è procurata delle coperte, di lino e di porpora sono le sue vesti.
 Suo marito è stimato alle porte della città,
Suo marito è stimato alle porte della città,
 quando siede in giudizio con gli anziani del luogo.
quando siede in giudizio con gli anziani del luogo.
 Confeziona tuniche e le vende e fornisce cinture al mercante.
Confeziona tuniche e le vende e fornisce cinture al mercante.
 Forza e decoro sono il suo vestito
Forza e decoro sono il suo vestito
 e fiduciosa va incontro all’avvenire.
e fiduciosa va incontro all’avvenire.
 Apre la bocca con saggezza
Apre la bocca con saggezza
 e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà.
e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà.
 Sorveglia l’andamento della sua casa
Sorveglia l’andamento della sua casa
 e non mangia il pane della pigrizia.
e non mangia il pane della pigrizia.
 Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti,
Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti,
 suo marito ne tesse l’elogio:
suo marito ne tesse l’elogio:
 “Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,
“Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,
 ma tu le hai superate tutte!”.
ma tu le hai superate tutte!”.
 Illusorio è il fascino e fugace la bellezza,
Illusorio è il fascino e fugace la bellezza,
 ma la donna che teme Dio è da lodare.
ma la donna che teme Dio è da lodare.
 Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani
Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani
 e le sue opere la lodino alle porte della città.
e le sue opere la lodino alle porte della città.
Proverbi 31, 10-31
* Fonte: L’Osservatore Romano - 6 febbraio 2021 (ripresa parziale, senza immagini).
- Una donna forte chi potrà trovarla?
-
>IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA! --- "De Domo David" e un francobollo del Vaticano: tracce per una svolta antropologica.16 febbraio 2021, di Federico La SalaCRISTIANESIMO E CATTOLICESIMO-ROMANO: TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA.
 Per capire l’importanza storica e culturale di un fracobollo
Per capire l’importanza storica e culturale di un fracobollo
 (https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=30331),
(https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=30331),
 un brillante lavoro sulla figura di San Giuseppe: "De Domo David"
un brillante lavoro sulla figura di San Giuseppe: "De Domo David"
 (https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/)
(https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/)
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. AL DI LA’ DELLA VECCHIA ALLLEANZA: BASTA DISPARITA’.12 febbraio 2021, di Federico La Sala
La Consulta: "Il cognome del padre è retaggio patriarcale, basta disparità"
"Non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna"
- [Foto] Una coppia con la loro figlia © ANSA
di Redazione ANSA*
ROMA L’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre? Con questo dubbio, la Corte ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio. L’ordinanza n. 18 depositata oggi (relatore il vicepresidente Giuliano Amato) spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano.
L’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli "è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia", e di "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna". Lo sottolinea, riprendendo una sua pronuncia del 2006, la Consulta, nell’ordinanza con cui ha sollevato davanti a se’ stessa la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione ai figli del solo cognome paterno.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- PER ORIENTARSI, CON DANTE, RIMEDITARE LA LEZIONE DI PONZIO PILATO.9 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA! --- UN AMORE SEMPLICE (di Antonio Tarallo - "L’Osservatore Romano").23 gennaio 2021, di Federico La Sala
“DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE, MARIA, E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE... *
Lo sposalizio di Maria e Giuseppe
Un amore semplice
- [Foto] Raffaello, «Sposalizio della Vergine» (1504)
di Antonio Tarallo *
Si erge con magnifico splendore la pala del Raffaello, insigne maestro del Rinascimento: «Sposalizio della Vergine», olio su tavola firmato Raphael Vrbinas, datato mdiiii . Colpisce la maestria dei colori. Colpisce l’equilibrio perfetto delle forme. La scena del matrimonio di Maria e Giuseppe è posta in primo piano. Dietro di loro, al centro, un sacerdote. Tiene le mani di entrambi, custode delle nozze. Alla sinistra di Maria, le donne. A destra di Giuseppe, un gruppo di uomini. Nell’iconografia tradizionale, usualmente, proprio uno di questi uomini è colto nell’atto di spezzare un bastone. È un ramo secco destinato a non fiorire, a non portare frutto. Solo quello di Giuseppe, invece, fiorisce. Ma da dove proviene questa tradizione?
Secondo i vangeli apocrifi, Maria era cresciuta nel Tempio di Gerusalemme - conservando, quindi, la castità - e, quando giunta in età di matrimonio (secondo la tradizione ebraica) la troviamo promessa sposa di Giuseppe. Il Protovangelo di Giacomo ( ii secolo) ci fornisce alcune informazioni a riguardo. Giuseppe è discendente dalla famiglia di David e originario di Betlemme. Prima del matrimonio con Maria, si sposò con una donna con la quale ebbe sei figli. Rimase però, poi, vedovo. Ed è in questo contesto che si introduce la famosa tradizione del bastone fiorito di Giuseppe. Come? Andando ad approfondire il tema - grazie al lavoro che sta compiendo, da tempo, la Pontificia Accademia mariana internationale sul recupero di una vera ed autentica “storia di Maria”, su un sempre maggiore approfondimento della sua figura, scrostando le sovrastrutture che il tempo ha costruito sopra la Vergine - riusciamo a comprendere meglio questo “arcano” che si dipana tra tradizione e iconografia. Basterebbe pensare a tutte le immagini che raffigurano Giuseppe che tiene in mano un bastone fiorito. È, allora, assai interessante andare a scovare le parole che il vangelo apocrifo riserva a questo episodio: «Indossato il manto dai dodici sonagli, il sommo sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò a riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un angelo del Signore, dicendogli: “Zaccaria, Zaccaria! Esci e raduna tutti i vedovi del popolo. Ognuno porti un bastone: sarà la moglie di colui che il Signore designerà per mezzo di un segno”. Uscirono i banditori per tutta la regione della Giudea, echeggiò la tromba del Signore e tutti corsero. Gettata l’ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portando i bastoni. Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a pregare. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li restituì loro; ma in essi non v’era alcun segno. Giuseppe prese l’ultimo bastone: ed ecco che una colomba uscì dal suo bastone e volò sul capo di Giuseppe. Il sacerdote disse allora a Giuseppe: “Tu sei stato eletto a ricevere in custodia la vergine del Signore”». Fin qui, ciò che una errata tradizione ci dice. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su questo evento che ha segnato il piano di salvezza di Dio per l’umanità intera.
Il mese di Adar era il mese dei matrimoni. Un proverbio diceva: «Quando arriva Adar, Israele si riempie di gioia!». Troviamo una Maria quindicenne, allora. È una fanciulla che si avvicina all’età in cui le ragazze d’Israele erano solite contrarre matrimonio. Molto probabile che i genitori fossero già morti. Maria era, allora, nella casa di qualche parente della sua famiglia. Il capo di quella famiglia, come rappresentante del padre di Myriam, deve occuparsi del suo futuro. Viene concordato il matrimonio di Maria con Giuseppe. Sono poche le notizie che i Vangeli ci offrono sul “promesso sposo” di Maria. Del loro incontro, nulla sappiamo. È molto probabile che si conoscessero già prima del matrimonio. Il villaggio è piccolo: Nazaret, questo piccolo paese della Galilea.
Giuseppe era della stirpe reale di Davide e, in virtù del suo matrimonio con Maria, conferirà al figlio della Vergine - Figlio di Dio - il titolo legale di figlio di Davide. È l’adempimento delle profezie. Maria sa soltanto che il Signore l’ha voluta sposa di Giuseppe, un “uomo giusto”. Come immaginare, allora, il loro matrimonio? La tradizione giudaica antica ci viene in aiuto. Sappiamo bene che tutta la comunità del villaggio partecipava a questa gioia. Gran sfarzo di abiti. Frasi dell’Antico Testamento che riecheggiavano nella cerimonia: il Talmud, il libro principe di tutto. Gli anziani della città coprivano il loro capo con veli bianchi in segno di superiorità: sono gli anziani, gli uomini più rispettati della comunità. I bambini, in quel giorno così particolare, ricevevano dolci di miele e noci. E lo sposo faceva un regalo alla sposa, un regalo significativo.
«Il ragazzo e Maria si capivano senza parole, non c’era mai tra i due il minimo urto: sembrava che entrassero l’uno nell’altra, che costituissero un’unica persona, tanto era stretta la loro unione», così lo scrittore Pasquale Festa Campanile ci presenta i due coniugi nel suo romanzo Per amore, solo per amore (1983). E a noi, piace trovare in quella parola, «amore», l’infinito Amore di Dio per l’umanità, espresso proprio in un matrimonio, in una unione sponsale tra un giovane e una giovane. Così, semplicemente. Perché Dio è semplice nel suo Amore.
* Fonte: L’Osservatore Romano, 23 gennaio 2021
* Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Il Trittico di Mérode è un dipinto di Robert Campin, olio su tavola (129x64,50 cm) conservato nel Metropolitan Museum di New York, nella sezione The Cloisters, e databile al 1427. - Il trittico, formato tipico della produzione di Campin, poteva essere chiuso, ed era probabilmente destinato alla devozione privata. La scena centrale mostra l’Annunciazione, mentre gli scomparti laterali mostrano i due committenti inginocchiati e San Giuseppe al lavoro
- TEOLOGIA E BIOLOGIA: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio" (Dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
“DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE...
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FLS
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- Il caso. «Madri e padri? Irrinunciabili». Nella bozza del decreto della ministra Lamorgese si parlerà semplicemente di "genitori" (di Luciano Moia).15 gennaio 2021, di Federico La Sala
Il caso. «Madri e padri? Irrinunciabili». Anche sui documenti, parola di psicologo
Regalia: differenze anche nominali indispensabili per la costruzione dell’identità dei figli. Nella bozza del decreto della ministra Lamorgese si parlerà semplicemente di "genitori"
di Luciano Moia (Avvenire, venerdì 15 gennaio 2021)
Meglio scrivere "genitori" invece di madre e padre sulle carte d’identità o sui moduli scolastici dei ragazzi al di sotto dei 14 anni? Oppure "genitori 1 e 2"? Potrebbe apparire una differenza di poco conto, ma non è così. Sarà comunque indispensabile attendere il parere del garante della privacy e poi la decisione della Conferenza Stato-Regioni per capire la struttura del decreto del ministero dell’Interno destinato a cancellare, per la seconda volta in pochi anni, le parole padre e madre dalle carte d’identità elettroniche dei minori di 14 anni per far posto a un più generico "genitori".
Mercoledì le agenzie di stampa e le comunicazioni diffuse dopo il question time a cui il ministro Luciana Lamorgese ha risposto alla Camera, lasciavano intendere che le tradizionali denominazioni di madre e padre sarebbero state sacrificate sull’altare delle richieste europee e per rispettare le "criticità tecniche" segnalate dal garante della privacy. Di conseguenza sarebbe stata ripristinata l’anonima classificazione numerica dei genitori che già aveva fatto tanto discutere quando era stata introdotta nel 2015 dal governo Renzi.
Ma ieri la segreteria della ministra Lamorgese ha precisato che nella bozza del decreto non c’è al momento alcun riferimento numerico. Niente "genitore 1 e 2" ma semplicemente "genitori" o "tutori" nel caso di assenza dei primi. In un allegato del decreto si sottolinea anche le necessità di indicare nome e cognome dei genitori stessi. Ora, una madre e un padre biologici sono naturalmente genitori. Quindi il cambio lessicale non incide sull’identità e sui ruoli. Mentre nel caso delle famiglie arcobaleno maternità e paternità possono essere sia biologiche, sia "di intenzione".
Per questo motivo il garante della privacy ha sottolineato «forti criticità dal punto di vista della protezione dei dati e della tutela dei minori, nel caso in cui i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna».
Ma è proprio così? Esistono davvero criticità nel riferimento esplicito alla madre e al padre nel caso di famiglie in cui uno dei due partner della coppia non fondi il suo ruolo su un dato biologico? «La volontà di non riconoscere la peculiarità della funzione materna e paterna al punto da non nominarla, è una scelta che deve interrogare», osserva Camillo Regalia, docente di psicologia sociale alla Cattolica e direttore del Centro di ateneo studi e ricerche sulla famiglia. «Nominare la madre e il padre non deve far paura. Dal punto di vista della costruzione identitaria, sacrificare il riferimento personale per richiamarsi genericamente al concetto di genitori non è certo positivo».
A parere del docente non è questa la strada corretta per legittimare forme di genitorialità non biologica, quasi che, dove invece esiste una genitorialità evidente e chiara, si possa aprire una contrapposizione. Non dev’essere così, ma è evidente che ci sia anche una componente ideologica nel Regolamento europeo in materia di dati personali a cui il nostro quadro normativo deve adeguarsi, come spiegato dalla ministra Lamorgese, oscurando i nomi di madre e di padre.
«Quando si parla di famiglie arcobaleno occorre essere assolutamente rispettosi. In molte situazioni questi nuclei mostrano un impegno educativo lodevole anche se - sottolinea ancora Regalia - le difficoltà rimangono e non dobbiamo avere timore di parlarne. Il grande equivoco è quello di pensare che si possa parlare di funzioni genitorali indipendentemente dal fatto che i ruoli siano biologicamente determinati. Facciamo un esempio per chiarire meglio: una madre single può assolvere anche a una funzione paterna? Evidentemente sì, ma avrà maggiori difficoltà e farà più fatica. Lo stesso per una coppia omogenitoriale. Sono situazioni in cui si aggiungono dati problematici a una realtà, quella del ruolo genitoriale, che è già complesso di per sé».
Aspetti da affrontare senza toni da battaglia, ma guardando la realtà per quello che è, visto che il confronto esasperato sui problemi antropologici non ha altro effetto se non quello di rendere tutto confusivo e ideologico. «In ogni caso decidere di rinunciare ai nomi di padre e madre per lasciare solo "genitori" - conclude il direttore del Centro di ateneo della Cattolica - significa rinunciare alle differenze per privilegiare la vaghezza dell’indistinto. E questa non è certamente una scelta che aiuta a risolvere le situazioni. Se l’obiettivo è quello di costruire un’alleanza genitoriale forte per il bene del proprio figlio, è importante, in ogni situazione, non dimenticare le differenze neppure sul piano lessicale».
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- MEMORIA ANTROPOLOGICA: #DANTE2021 E LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI"28 dicembre 2020, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E MEMORIA ANTROPOLOGICA.
USCIRE DALL’ORIZZZONTE DELLA BIBLICA "CADUTA" ...
DANTE - 2021 E LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI": RISALIRE LA CORRENTE E RITROVARE I PROPRI "GENITORI". Al di là di Caino, la nuova Eva - Maria e Giuseppe, il nuovo Adamo , e Gesù è figlio dell’ amore [charitas] che move il Sole e le altre stelle (Pd. XXXIII, v. 145).
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- AVVENTO. Dispute teologiche intorno alla nascita (di Nadia Maria Filippini).23 dicembre 2020, di Federico La Sala
Dispute teologiche intorno alla nascita
AVVENTO. Il parto verginale di Maria. Tra esaltazione della maternità e rimozione. Per secoli il dibattito si è snodato intorno al modo in cui la ragazza di Nazareth ha «dato alla luce» Gesù. L’ostilità verso la materialità del corpo ha pesato sul vissuto femminile fino alla presa di parola del movimento delle donne
- [Foto] Antonio Veneziano, «Madonna del parto» (Pieve di San Lorenzo, Pontassieve)
di Nadia Maria Filippini (il manifesto, 23.12.2020)
Durante il periodo dell’Avvento, in vari luoghi dell’Occidente cristiano, tra Medioevo ed età moderna, si celebrava una festa particolare, successivamente scomparsa dal calendario liturgico: quella dell’attesa del parto di Maria, Expectatio partus Beatae Mariae Virginis. Il X Concilio di Toledo nel 656 l’aveva fissata nel giorno 18 dicembre, a pochi giorni dal Natale. Una vasta produzione artistica di statue e dipinti fissava questo momento dell’attesa, rappresentando Maria nella pienezza della sua gravidanza, spesso con in mano un libro (simbolo delle Sacre Scritture), o con la mano posata sul ventre, in una postura comune a tutte le donne incinte.
Ma in che modo la Madonna aveva messo al mondo Gesù? In che modo egli era uscito alla luce? Queste domande erano state al centro di un intenso dibattito teologico che si era snodato per secoli, ed avevano una rilevanza tutt’altro che secondaria, in quanto incrociavano frontalmente la questione della natura di Cristo: solo uomo (come sostenevano gli ariani) o solo Dio (come sostenevano i Nestestoriani)? Il Concilio di Efeso (431) aveva infine proclamato la sua duplice natura umana e divina, definendo di conseguenza Maria Theotòkos e Deipara (madre di Dio); il che rendeva ancor più complessa la questione del parto e della nascita: un inghippo esegetico intorno al quale continuarono ad arrovellarsi molti teologi, non senza dispute e conflitti.
IN QUANTO VERO UOMO egli avrebbe dovuto seguire le leggi della natura e venire al mondo attraverso le vie naturali, come sosteneva, ad esempio, Tertulliano. A far da ostacolo a questa ipotesi stavano però poderosi contenuti di natura sia culturale che religiosa. Innanzitutto il peso della religione ebraica che coniugava la punizione divina per il peccato originale proprio al parto, caricando l’evento di un’aurea che sanzionava con Eva tutte le sue discendenti. Vero è che la Vergine non era stata contaminata dal «seme immondo» della concupiscenza e in quanto Immacolata Concezione, cioè priva di peccato originale fin dal suo concepimento, era esonerata dalle sofferenze del travaglio; ma nei primi secoli della Chiesa, questa era solo un’ipotesi teologica controversa tra diverse correnti degli «immacolisti» e «macolisti»; non ancora una verità di fede, che verrà proclamata come dogma solo nel 1854.
 A creare problema era soprattutto una rappresentazione del parto carica di valenze negative che il Cristianesimo ereditava dal mondo antico. Il nascere nel sangue era visto dalla cultura classica e da quella ebraica come causa di impurità; al sangue impuro dei lochi era attribuito pure un potere malefico e corrosivo, analogo a quello mestruale, secondo un parere condiviso per secoli pure dalla medicina.
A creare problema era soprattutto una rappresentazione del parto carica di valenze negative che il Cristianesimo ereditava dal mondo antico. Il nascere nel sangue era visto dalla cultura classica e da quella ebraica come causa di impurità; al sangue impuro dei lochi era attribuito pure un potere malefico e corrosivo, analogo a quello mestruale, secondo un parere condiviso per secoli pure dalla medicina.AGLI DEI E AGLI EROI del mito classico erano attribuite infatti altre vie per la nascita, extra-ordinariae: ora dal fianco, come Asclepio o Dioniso, ora dalla testa, come Atena. Perfino il grande Giulio Cesare, secondo una falsa tradizione medioevale, era nato da taglio cesareo (da cui il nome). Questo sguardo disgustato sulla materialità della nascita si intrecciava, nei primi secoli del Cristianesimo, con il tema degli effetti della caduta del genere umano, di cui proprio le modalità del parto e della nascita (intra foeces et urinam) diventavano quasi simbolo, non solo nell’elaborazione degli gnostici o dei manichei, ma anche di molti teologi medioevali come Gregorio Magno e Lotario di Segni (papa Innocenzo III).
Come avrebbe potuto il figlio di Dio nascere nel sangue senza risultarne in qualche modo contaminato? Ed inoltre il suo stesso passaggio dalle vie naturali non comportava di per sé un’apertio vulvae, interrompendo la verginità di Maria, come appunto Tertulliano e altri sostenevano, ipotizzando una verginità della Madonna nel momento del concepimento, ma non durante o dopo il parto?
Sul parto della Madonna i Vangeli erano piuttosto vaghi: dicevano soltanto che mentre si trovava a Betlemme aveva «dato alla luce il suo figlio», avvolgendolo in fasce e ponendolo in una mangiatoria, perché non c’era posto per loro nell’albergo (Luca, 2,1). Solo due vangeli apocrifi, quello dello pseudo-Matteo e di Giacomo, rifacendosi al profeta Isaia, parlano esplicitamente del parto verginale di Maria, introducendo nel racconto la figura di una levatrice, Zelomi, chiamata da Giuseppe, che, arrivata troppo tardi quando il bambino era già nato, aveva avuto modo di verificare con la sua visita la verginità della Madonna, attestando l’evento miracoloso: Gesù «non aveva sofferto alcuna contaminazione di sangue»; la partoriente nessun dolore; essa, che aveva concepito vergine, aveva partorito vergine ed era rimasta tale.
FU PROPRIO questa versione dei vangeli apocrifi ad essere ripresa dalla Chiesa. Si ricorse a un’idea della verginità nel parto speculare a quella della fecondazione, che confermava l’evento della nascita di Cristo dal corpo della madre, ma modificava al contempo miracolosamente le leggi fisiologiche che normalmente lo regolano. Egli infatti «non era stato concepito dal piacere carnale, né era uscito alla luce attraverso i dolori» (come scriveva Gregorio di Nissa): era venuto al mondo lasciando intatto il sigillum; aveva attraversato il corpo della madre come un raggio di sole attraversa il vetro, con un’efficace immagine costantemente ripresa. In questo modo la nascita risultava assimilata con una specularità emblematica alla ri-nascita, all’uscita dal sepolcro che lasciava intatti i sigilli, come spiegava sant’Agostino nell’Enchiridion. Ne risultava rimarcata e arricchita di nuovi attributi anche la contrapposizione tra le due donne: Eva (origine e causa della morte) e Maria (origine e madre della vita).
Questa interpretazione divenne progressivamente maggioritaria a partire dal V secolo, sostenuta da autorevoli teologi come Efren Siro, il «poeta della Madonna», Zeno di Verona, Ambrogio, fino ad esser sancita da vari concili: quello di Calcedonia (451), di Costantinopoli II (553) e quello Lateranense (649). Maria venne dichiarata Aeiparthenos («sempre vergine») e questo appellativo fu inserito nella professione di fede del Concilio Lateranense IV (1215), ripreso poi anche da Paolo IV (1555) nella costituzione Cum quorundam, dove si riaffermava appunto che Maria era vergine «prima, durante e per sempre dopo il parto».
CI SI PUÒ CHIEDERE a questo punto quali conseguenze abbia avuto questa costruzione teologica sul piano del vissuto femminile, nella percezione del corpo, della gravidanza e del parto, per donne cristiane abituate a guardare alla figura della Madonna come modello assoluto. Non c’è dubbio che abbia introdotto elementi di profonda contraddizione nel vissuto della maternità, scindendone gli aspetti e attribuendovi significati e contenuti simbolici opposti. Se da un lato infatti, con il mistero dell’incarnazione, la nascita acquistava un rilievo speciale a livello simbolico; se la maternità risultava valorizzata sul piano spirituale e della relazione madre- figlio, con una rottura rispetto al mondo antico di cui è impossibile non cogliere la rilevanza; d’altro canto però il parto rimaneva confinato nel novero delle espressioni corporee indicibili e indegne della madre di Dio.
Questa svalorizzazione della maternità corporea era destinata ad accentuarsi ancor di più dopo il Concilio di Trento, quando le severe disposizioni controriformistiche in materia di raffigurazione delle immagini sacre portarono alla progressiva scomparsa di tutte quelle rappresentazioni artistiche che mettevano in mostra i segni della maternità corporea di Maria: le Madonne del parto andarono via via sparendo; nella rappresentazione della Natività la postura della Madonna puerpera fu abbandonata, a vantaggio di quella genuflessa, in adorazione del bambino (come più spesso si vede nei presepi) ed anche le mammelle di tante Madonne del latte rientrarono pudicamente nelle vesti.
QUESTA CANCELLAZIONE dei tratti corporei dal modello ideale di Madre e i contenuti teologici sottesi erano destinati a pesare non poco nell’autorappresentazione e nell’identità femminile, connotando l’esperienza materna di aspetti ambivalenti. Il tabù del parto, l’impurità della puerpera, che escludeva la madre perfino dal battesimo del figlio, non furono scalfiti dalla «rivoluzione cristiana», pesando, fino ad un passato molto prossimo, come un’ombra nera sul suo corpo fecondo.
In questo modo la forza, il coraggio e la capacità delle donne di mettere al mondo restavano avvolti in un alone di vergogna e impurità che solo in tempi recenti ha cominciato a esser rivisto, grazie al movimento delle donne.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- LE CONDIZIONI DI NASCITA DI OGNUNO DI NOI. Il presepio di Dio (di José Tolentino Mendonça).17 dicembre 2020, di Federico La Sala
LA TERRA, LA BUONA NOVELLA, E LA COSTITUZIONE - LA LEGGE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI... *
Pregare a occhi aperti
Il presepio di Dio
di José Tolentino Mendonça (Avvenire, giovedì 17 dicembre 2020)
Ci guadagneremmo molto a capire perché le letture bibliche del tempo di Avvento e del Natale insistono sulla dimensione visiva. Noi vediamo Dio stesso, il Dio trascendente, farsi prossimo, e il motivo della gioia è questo. Come dirà il prologo del Vangelo di Giovanni: «Noi abbiamo contemplato la sua gloria» (Gv 1,14). In effetti il Natale è l’anti-astrazione, è l’opposto delle vaghe generalizzazioni.
 Ognuno di noi, con le domande che sono le sue, con la serenità o il subbuglio che si porta dentro, con la situazione concreta di vita che sperimenta, è chiamato a vedere Dio. È sfidato a contemplarlo in quel Dio con noi, in quel nascituro in carne e ossa, in quel Figlio che ci è stato dato. In Gesù di Nazaret, Dio non viene in un modo indefinito: egli viene incontro a me, a te, a ogni essere umano, dandoci nella fede la possibilità di diventare figli di Dio (Gv 1,12).
Ognuno di noi, con le domande che sono le sue, con la serenità o il subbuglio che si porta dentro, con la situazione concreta di vita che sperimenta, è chiamato a vedere Dio. È sfidato a contemplarlo in quel Dio con noi, in quel nascituro in carne e ossa, in quel Figlio che ci è stato dato. In Gesù di Nazaret, Dio non viene in un modo indefinito: egli viene incontro a me, a te, a ogni essere umano, dandoci nella fede la possibilità di diventare figli di Dio (Gv 1,12).A donne e uomini fragili, imperfetti e tormentati come noi, Dio offre la possibilità di essere figli suoi. Di vivere, cioè, una vita che non sia unicamente l’espressione della nostra carne e del nostro sangue, ma che si riveli come conseguenza dell’impatto della vita divina. In questo senso, non siamo noi a fare il presepio perché Dio vi nasca: è Dio che prepara le condizioni di una nascita per ognuno di noi.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. "VA’, RIPARA LA MIA CASA"!!!
FLS
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- Papa Bergoglio inaugura il proprio Pontificato con un’omelia incentrata sul ruolo di custode del padre putativo di Gesù (di M. Muolo).9 dicembre 2020, di Federico La Sala
La statuina.
La devozione e l’affidamento di papa Francesco a san Giuseppe «dormiente»
Una devozione che risale alla giovinezza di Bergoglio e ci porta dritto al cuore della sua vocazione sacerdotale
di Mimmo Muolo *
- [Foto] San Giuseppe dormiente nella stanza di papa Francesco a Casa Santa Marta
Papa Francesco e san Giuseppe. Una devozione che risale alla giovinezza del Pontefice e ci porta dritto al cuore della sua vocazione sacerdotale. Come pure all’inizio del suo ministero petrino.
È infatti nella chiesa di San José di Buenos Aires che nel 1953 il diciassettenne Jorge Mario Bergoglio scopre la vocazione al sacerdozio. Ed è il 19 marzo 2013 - sei giorni dopo l’elezione a Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa universale - che egli inaugura il proprio Pontificato con un’omelia incentrata sul ruolo di custode del padre putativo di Gesù. Non stupisce dunque la decisione di dedicare al santo la Lettera apostolica di ieri e di proclamare l’anno "giuseppino" (con relative indulgenze plenarie). Si può anzi dire che questi due gesti del Pontefice costituiscano gli ultimi anelli (per il momento) di una catena di affetto e devozione che lega Jorge Mario Bergoglio al casto sposo della Vergine.
Francesco ha del resto raccontato più volte come a san Giuseppe sia solito affidare intenzioni di preghiera e speciali intercessioni per il suo ministero. Nel suo studio personale a Casa Santa Marta, ci sono infatti due statue che raffigurano il santo. Una in particolare gli è molto cara e lo accompagna da sempre, da quando viveva nel Collegio Maximo di San Miguel di cui era rettore. Si tratta di un’immagine insolita, per noi italiani ed europei, ma molto diffusa tra i fedeli sudamericani: una statua che raffigura san Giuseppe dormiente.
Ora, sappiamo dalla Scrittura quanto il sonno sia stato determinante nella vicenda terrena del falegname custode della Sacra Famiglia. E anche nella Lettera apostolica di ieri papa Francesco si sofferma sui sogni in cui Giuseppe dà ascolto all’Angelo per prendere in sposa Maria, per fuggire in Egitto onde sottrarre Gesù Bambino alla persecuzione di Erode e infine per fare ritorno a Nazaret, una volta morto il malvagio re.
Per questo il Papa ha l’abitudine di infilare sotto la statua del santo addormentato biglietti che contengono problemi, richieste di grazia, preghiere dei fedeli. È come se invitasse san Giuseppe a "dormirci su", e magari a mettere una buona parola davanti a Dio, per risolvere situazioni difficili e aiutare i bisognosi, rinnovando così il suo ruolo di padre misericordioso e tutto proteso verso coloro che ama.
Lo confidò egli stesso il 16 gennaio 2015 a Manila nell’incontro con le famiglie: «Io amo molto san Giuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia scrivania ho un’immagine di San Giuseppe mentre dorme e quando ho un problema o una difficoltà io scrivo un biglietto su un pezzo di carta e lo metto sotto la statua di San Giuseppe affinché lui possa sognarlo. (...) Ma come san Giuseppe, una volta ascoltata la voce di Dio, dobbiamo riscuoterci dal nostro sonno; dobbiamo alzarci e agire».
In definitiva, per papa Francesco lo sposo della Madonna è un santo davvero speciale, che protegge e aiuta perfino quando dorme.
Più volte nei suoi discorsi il Pontefice ha fatto riferimento alla figura del santo. In una delle omelie di Santa Marta, il 18 dicembre 2018, Francesco disse: «Giuseppe è l’uomo che sa accompagnare in silenzio» ed è «l’uomo dei sogni». Il 1° maggio scorso ha accolto a Santa Marta la statua di san Giuseppe lavoratore solitamente posizionata all’ingresso della sede nazionale delle Acli a Roma. Ma sicuramente, prima di ieri, l’espressione più compiuta della devozione giuseppina del Papa si trova nell’omelia di inizio pontificato.
«Giuseppe è "custode" - disse -, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge». L’eco di queste parole risuona ora nella Lettera apostolica "Patris corde".
 Leggi anche
Leggi anche- Il gesto.Il Papa indice l’Anno di San Giuseppe: "Il mondo ha bisogno di padri"
* Fonte: Avvenire, mercoledì 9 dicembre 2020
Sul terma, nel sito, si cfr.:
- LO STEMMA PAPALE - PAPA FRANCESCO (una stella a otto punte d’oro che simboleggia la Vergine Maria - un fiore di nardo d’oro che simboleggia San Giuseppe)
“DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE...
FLS
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- LA LEGGE E IL GRAN RIFIUTO DI PILATO. Se il miglior interprete dei diritti non è la Corte ma il papa (di Massimo Villone).24 ottobre 2020, di Federico La Sala
Se il miglior interprete dei diritti non è la Corte ma il papa
Diritti. La pronuncia dei giudici costituzionali è pericolosa, perché indebolisce il principio che la Corte è argine ultimo e necessario proprio contro legislatore
di Massimo Villone (il manifesto, 23.10.2020)
È davvero uno scherzo della storia leggere nello stesso giorno di Papa Francesco e della Corte costituzionale. Il Papa apre alle coppie gay, e chiede una legge sulle unioni civili. Non sembra dubbio che, senza toccare il sacramento del matrimonio, dalle sue parole derivi un riconoscimento con pienezza di diritti, inclusa la filiazione. Mentre la Corte quei diritti li amputa.
Il fatto. A una coppia di donne, unita civilmente, nasce in Italia un figlio a seguito di fecondazione eterologa all’estero. La registrazione allo stato civile viene rifiutata. Nel giudizio conseguente viene sollevata dal Tribunale di Venezia una questione di legittimità costituzionale della legge sulle unioni civili e del decreto sugli atti dello stato civile. Il diritto.
La Corte si orienta per l’inammissibilità delle questioni sollevate. Il riconoscimento dello status di genitore alla cd madre intenzionale “non risponde a un precetto costituzionale ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale”. E dunque il diritto non esiste.
Le secche parole del comunicato chiudono la strada anche a interpretazioni secundum Constitutionem.
Al momento abbiamo solo il comunicato, e vedremo poi in dettaglio le motivazioni. Intanto possiamo dire che la Corte sembra aver sviluppato una allergia per i temi eticamente sensibili, con eccezioni per la fecondazione assistita. Cappato insegna, e certo la Corte sa bene che il rinvio al legislatore può tradursi nell’inerzia del medesimo.
Dobbiamo poi cogliere che oggi la Corte va oltre.
Al rinvio al legislatore si aggiunge la contestuale negazione di un diritto costituzionalmente protetto. Sul tema la Corte ha già balbettato in passato. Nella sentenza 138/2010 lesse nel matrimonio di cui all’articolo 29 della Costituzione la disciplina del codice civile del 1942, che ovviamente conosceva soltanto la coppia formata da due persone di sesso diverso. Ben si poteva invece dare una lettura evolutiva, che tenesse conto del nuovo.
Un recupero parziale è venuto poi dalla sent. 170/2014, sul cosiddetto divorzio automatico o imposto nel caso di cambio di sesso di uno dei coniugi. La Corte ha rinviato al legislatore, dichiarando però la incostituzionalità e affermando il diritto a una piena tutela giuridica della coppia del medesimo sesso.
Quella pronuncia ha avuto poi riscontro nella tormentata legge sulle unioni civili. Ma la Corte tiene oggi a precisare che la coppia omosessuale, pur riconosciuta dalla legge nella forma dell’unione civile, non ha gli stessi diritti della coppia eterosessuale unita in matrimonio. La Costituzione non garantisce che li abbia.
Si faccia una ipotesi di scuola. Una legge che limitasse forzosamente il numero dei figli consentiti nel matrimonio sarebbe incostituzionale. Mentre una legge che ponesse lo stesso limite a una coppia omosessuale unita civilmente potrebbe non esserlo.
Che ne è del nucleo incomprimibile dei diritti, di cui tanto abbiamo letto nella giurisprudenza costituzionale? E della razionalità, intesa come tutela contro distinzioni discriminatorie? Il presidio costituzionale diventa evanescente. Forse la stessa legge sulle unioni civili sarebbe in principio reversibile, se “l’interprete del sentire della comunità nazionale”, e cioè il legislatore maggioritario, maturasse un umore avverso.
L’odierna pronuncia della Corte, magari al di là delle intenzioni, è pericolosa, perché indebolisce il principio che la Corte è argine ultimo e necessario proprio contro il legislatore. E che dunque l’area della political question sottratta al suo scrutinio deve essere il più possibile ristretta.
“Il sentire della collettività” è sempre il pericolo più grande per i diritti e per le libertà, che sono appunto un argine contro quel sentire tradotto in potere politico e legislativo. Bisogna essere estremamente cauti nell’affermare che questa o quella fattispecie sfugge alla protezione costituzionale.
Non è un paese felice quello in cui ci si sente garantiti da un capo religioso piuttosto che dal massimo organo di giustizia costituzionale.
Ma potremmo suggerire che Papa Francesco tenga per i giudici della Corte un seminario di formazione, dal momento che più e meglio di loro si mostra consapevole del senso vero della Costituzione.
#COSTITUZIONE ED #EVANGELO: #DUESOLI. #PapaFrancesco apre la strada a #Dante2021: pagare il tributo a #Cesare «è un #dovere»; ma la #CorteCostituzionale con poco #spirito di #Salomone (di fronte a #due cittadine, unite civilmente, con bambino) fa "per viltade il #granrifiuto".
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! ---- UNIONI CIVILI E "MATRIMONIO IGUALITARIO", NIENTE CONFUSIONE. Papa Francesco: «Non scherziamo con la verità» (di Lucia Capuzzi).23 ottobre 2020, di Federico La Sala
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!!
- «Matrimonio è un termine che ha una storia. Da sempre, nella storia dell’umanità e non solo della Chiesa, viene celebrato tra un uomo e una donna», afferma Francesco in Dio è un poeta, edito nel nostro Paese da Rizzoli. E aggiunge: «È una cosa che non si può cambiare. È la natura delle cose, è così. Chiamiamole unioni civili. Non scherziamo con la verità» (Cfr. Il punto. Coppie omosessuali, sì alla tutela civile ma niente confusione col matrimonio di Lucia Capuzzi, Avvenire, venerdì 23 ottobre 2020).
Il punto.
Coppie omosessuali, sì alla tutela civile ma niente confusione col matrimonio
Tante reazioni alle parole del Papa nel docufilm “Francesco”. Parla Fernández arcivescovo argentino: Sin da quando era cardinale arcivescovo di Buenos Aires, Bergoglio ha distinto i due piani
di Lucia Capuzzi (Avvenire, venerdì 23 ottobre 2020)
«Ciò che dobbiamo fare è una legge sulla convivenza civile, hanno diritto a una forma di tutela legale. L’ho già sostenuto». Al di là delle forzature mediatiche, l’opinione di Jorge Mario Bergoglio sulle coppie omosessuali non è cambiata negli ultimi dieci anni.
La frase riportata nel documentario di Evgeny Afineevsky ricalca quanto già espresso nel 2010 quando, come arcivescovo di Buenos Aires, si trovò ad affrontare l’infuocato dibattito sulle nozze gay, legge fortemente voluta dal governo dell’allora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ricordarlo non sono solo accreditate fonti giornalistiche di quell’epoca, tra cui il biografo ufficiale Sergio Rubín.
Ieri, in un messaggio su Facebook, monsignor Victor Manuel Fernández, arcivescovo di La Plata, teologo e profondo conoscitore del pensiero bergogliano, ricostruisce la vicenda, sottolineando come per papa Francesco, prima e dopo l’elezione al soglio pontificio, si devono distinguere due piani.
Da una parte c’è il «matrimonio», termine con un significato preciso, applicabile solo a un’unione stabile tra una donna e un uomo, aperta alla vita. «Questa unione è unica, perché implica la differenza tra l’uomo e la donna, uniti da un rapporto di reciprocità e arricchiti da questa differenza, naturalmente capace di generare vita», spiega monsignor Fernández. Qualunque altra unione simile richiede, dunque, una denominazione differente.
Unioni o convivenza civile, appunto. «Jorge Mario Bergoglio ha sempre riconosciuto, pur senza necessità di definirli matrimonio, l’esistenza di legami molto stretti fra persone dello stesso sesso, che vanno al di là del mero piano sessuale, ma sono alleanze intense e stabili. Le persone si conoscono a fondo, condividono lo stesso tetto per molto tempo, si prendono cura e si sacrificano l’uno per l’altro», afferma l’arcivescovo di La Plata. In caso di malattia grave o morte, uno dei due può desiderare i suoi beni all’altro o che sia quest’ultimo ad essere consultato invece di un familiare. «Tutto ciò può essere contemplato da una legge» sulle «unioni civili o normativa di convivenza civile, non matrimonio».
A tal proposito, monsignor Fernández conferma quanto già riportato dai media dieci anni fa. Ovvero che, durante il dibattito sul cosiddetto matrimonio igualitario in Argentina, il cardinal Bergoglio sostenne tale posizione durante un incontro ad hoc con l’episcopato: la maggioranza, però, si oppose. La questione era già emersa subito il conclave del 2013. Da allora, il successore di Pietro ha sempre mostrato sensibilità e attenzione pastorale nei confronti delle persone omosessuali. Certo, nel docu-film di Afineevsky, Francesco torna espressamente sulla questione delle unioni civili e ripropone, da Papa, quanto già affermato dieci anni fa. Nemmeno questo, però, è un inedito assoluto.
Nel libro che raccoglie le conversazioni con il sociologo Dominique Wolton, pubblicato in Francia nel 2017 e in Italia l’anno successivo, c’è già un accenno al riguardo. «Matrimonio è un termine che ha una storia. Da sempre, nella storia dell’umanità e non solo della Chiesa, viene celebrato tra un uomo e una donna», afferma Francesco in Dio è un poeta, edito nel nostro Paese da Rizzoli. E aggiunge: «È una cosa che non si può cambiare. È la natura delle cose, è così. Chiamiamole unioni civili. Non scherziamo con la verità» .
Il documentario Francesco, insignito ieri, nei giardini vaticani, del premio Kinéo, non contiene, dunque, verità sconvolgenti.
Del resto non era questo l’obiettivo dell’autore, ebreo non praticante di origini russe. Attraverso la raccolta di testimonianze e immagini, il regista cerca di narrare le ferite del mondo: le guerre, l’esodo infinito a cui sono costrette migliaia di persone, i muri vecchi e nuovi, fisici e mentali che separano gli uni dagli altri. Il racconto segue il Papa nei suoi viaggi, da Lampedusa a Manila, da Ciudad Juárez a Santiago.
 Il racconto su Francesco, spiega Afineevsky, però, piano piano, si è trasformato in un film «sull’umanità che commette errori, fatta di peccatori...». La chiave è contenuta in una frase di Oscar Wilde cara al Papa e riportata nel filmato: «Ogni santo ha un passato e ogni peccatore ha un futuro».
Il racconto su Francesco, spiega Afineevsky, però, piano piano, si è trasformato in un film «sull’umanità che commette errori, fatta di peccatori...». La chiave è contenuta in una frase di Oscar Wilde cara al Papa e riportata nel filmato: «Ogni santo ha un passato e ogni peccatore ha un futuro».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
A FREUD (Freiberg, 6 maggio 1856 - Londra, 23 settembre 1939), GLORIA ETERNA !!! IN DIFESA DELLA PSICOANALISI.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA : VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
> GESÙ "CRISTO", GESÙ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! - QUALE IL SUO "CARATTERE"?! L’Impronta. Segnavia della nostra storia (di Nunzio Galantino).2 ottobre 2020, di Federico La Sala
DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?! Quale il "carattere" (Charaktèr: gr. Χαρακτήρ) di Gesù?!
- "Come nella Bibbia (Ebr 1,3), dove Gesù è χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, è impronta - nel senso di piena ed esatta rappresentazione - della sostanza di Dio" ... ma di Dio Charitas (Amore) o Dio Caritas (Mammona)?!
Abitare le parole
Impronta.
SEGNAVIA DELLA NOSTRA STORIA
di Nunzio Galantino *
Per coprire il campo semantico della parola “impronta”, oltre al contributo che viene dalla derivazione etimologica, è opportuno porre attenzione al significato del termine χαρακτήρ che rende, in greco, la parola impronta e identificare gli attributi che, di volta in volta, l’accompagnano.
Sul piano etimologico, la parola impronta deriva dal latino imprĭmere (premere sopra, calcare). Χαρακτήρ - dal verbo χαράσσω (incidere, scolpire) - nella cultura greca è un nomen agentis: è cioè più di una traccia lasciata. È invece una persona che ritrae qualcuno o qualcosa. Come nella Bibbia (Ebr 1,3), dove Gesù è χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, è impronta - nel senso di piena ed esatta rappresentazione - della sostanza di Dio.
A proposito, poi, dell’impronta e degli attributi che l’accompagnano, si parla di impronta fisica lasciata da una parte del corpo o da uno strumento fisico, di impronta digitale cellulare e di impronta genetica. Sempre più spesso sentiamo, inoltre, rivolto a tutti l’invito a ridurre l’impronta ecologica; una sorta di indicatore che misura la quantità e la qualità del consumo delle risorse naturali prodotte dal pianeta Terra.
In senso generico, l’impronta è un segno tracciato con una pressione su una superficie. In senso figurato, la parola impronta indica una caratteristica che permette di identificare una persona o una sua produzione artistica, letteraria ecc. È vero che, almeno dal punto di vista fisico, non si può non lasciare un’impronta. Ma è anche vero che l’impronta non è solo il frutto inconsapevole di un gesto, di una presenza o di un passaggio.
 Il più delle volte, proprio perché espressione di una identità, l’impronta è frutto di una scelta consapevole, attraverso la quale io, di fatto, racconto la mia vita, le priorità che mi guidano e la qualità che scelgo di far ricadere in modo incisivo sulle mie relazioni.
Il più delle volte, proprio perché espressione di una identità, l’impronta è frutto di una scelta consapevole, attraverso la quale io, di fatto, racconto la mia vita, le priorità che mi guidano e la qualità che scelgo di far ricadere in modo incisivo sulle mie relazioni.E, proprio perché contengono pezzi di noi e della nostra interiorità, le impronte possono trasmettere un’immagine positiva di noi o comunicarne una negativa. Sono lì, come segnavia della nostra storia personale.
 Bisogna avere, di tanto in tanto, il coraggio di prenderle in mano e di fermarci per verificare cosa le impronte di cui disseminiamo la nostra presenza e le nostre relazioni stanno raccontando di noi.
Bisogna avere, di tanto in tanto, il coraggio di prenderle in mano e di fermarci per verificare cosa le impronte di cui disseminiamo la nostra presenza e le nostre relazioni stanno raccontando di noi.
 Uno sguardo attento e onesto sulle impronte ci permetterebbe di verificare se, quelle lasciate nel cuore e nella storia delle persone incontrate sul nostro cammino, sono impronte che generano e tramettono vita o piuttosto dolorose cicatrici.
Uno sguardo attento e onesto sulle impronte ci permetterebbe di verificare se, quelle lasciate nel cuore e nella storia delle persone incontrate sul nostro cammino, sono impronte che generano e tramettono vita o piuttosto dolorose cicatrici.La storia personale e quella relazionale in genere vive di impronte lasciate e di impronte subìte, attraverso uno sguardo, una parola, una carezza o un’emozione provocata. Ma essa è esposta anche a impronte che assomigliano molto di più a ferite. Quelle provocate da rifiuti, sguardi indifferenti o evidenti strumentalizzazioni. Se le prime hanno la capacità di ricomporre pezzi di vita andati in frantumi, le altre, più che impronte, sono cicatrici che rendono sempre più insopportabile la vita.
*Rubrica de Il Sole 24ore, 28/09/2020.
Sul tema, nel sito, si cfr. :
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA ? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA !!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- IL "FRATELLI TUTTI" DI FRANCESCO DI ASSISI E IL ’FRATELLI! (SENZA SORELLE) DELLA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO - OGGI, 2020.22 settembre 2020, di Federico La Sala
Caro Papa Francesco.
Finché è ancora in tempo, per favore cambi il titolo della nuova encliclica. *
Quel ’Fratelli’ (senza sorelle) non si può usare nel 2020.
Lei ci ha insegnato il peso delle parole.
Il titolo si mangerà il contenuto.
L’altro nome di Francesco è Chiara.
(Luigino Bruni - Twitter, 23 settembre 2020).
*
- Fratelli tutti è la terza enciclica di papa Francesco scritta nel suo ottavo anno di pontificato. Annunciata dalla Sala stampa vaticana il 5 settembre 2020[1], verrà firmata dal Papa il 3 ottobre 2020, in occasione della visita al santuario di Assisi e porterà la data del 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda san Francesco d’Assisi[2]. Il nucleo tematico è rappresentato dalla fraternità e dalla amicizia sociale, a partire da riflessioni circa la pandemia da COVID-19 del 2020. (Wikipedia - ripresa parziale.)
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- La Gloriosa. Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (di Michele G. Masciarelli).14 agosto 2020, di Federico La Sala
IL SI’ DELLA «MEDIAZIONE MATERNA» (e .. quello della «mediazione paterna»?) , LA GLORIFICAZIONE DI MARIA (e... di Giuseppe?), E IL "SOGGETTIVO ATTIVO DELL’ASSUNZIONE"?
- "[...] Con la sua Assunzione Maria anzitutto ci presenta il cristianesimo come religione del futuro assoluto [...]" (Michele Giulio Masciarelli, La Gloriosa. Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, L’Osservatore Romano).
La Gloriosa
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
di Michele Giulio Masciarelli *
Il rapporto di Maria con la Trinità è continuo; tutti gli aspetti della sua esistenza appartengono a quel mistero: l’ideazione della sua singolare vocazione, la sua concezione immacolata, la sua perpetua condizione verginale, la sua divina maternità, la sua compagnia materna data al Figlio in ogni passaggio della sua missione messianica, la sua maternità ecclesiale. È certamente vero che nessuna creatura ha avuto né avrà tanta relazione con la Trinità. Ciascuna delle tre divine Persone ha posto sull’esistenza di Maria, in modo proprio, l’impronta della sua somiglianza.
Il Padre, come è all’origine di tutta l’opera salvifica, è anche all’inizio dell’avventura di grazia vissuta da Maria come madre messianica: la grazia di Maria viene dal Padre e porta al Padre, che la glorifica chiamandola vicino al Figlio che siede alla sua destra. Maria è stata assunta: non si è auto-elevata in cielo; non è ascesa al cielo per forza propria. Occorre perciò indicare il soggetto attivo dell’Assunzione, per comprendere e spiegare, nella fede, tale privilegio mariano. Quel soggetto attivo è il Padre. È lui che ha chiamato e portato in cielo la madre del Figlio.
Maria, con l’Assunzione, rivive in modo inverso, la grazia e la gioia dell’incarnazione; lei, per così dire, esperimenta un nuovo rapporto con Gesù, quasi una restituzione dell’amore che egli le riserba accogliendola in Cielo: «Così com’ella l’ha accolto nell’ambito delle cose umane, allo stesso modo egli ora la fa entrare nella sua vita divina ed eterna. Entrambi gli atti sono in sé completi ed includono globalmente l’uomo, l’anima e il corpo. [...] È un ciclo anche quello tra la Madre e il Figlio, in quanto come una volta la Madre ha pronunciato un sì nei riguardi del Figlio e di tutto ciò che lo riguarda, allo stesso modo è il Figlio che oggi pronuncia un grande sì verso la Madre» (A. von Speyr, L’ancella del Signore. Maria, Milano, Jaca Book, 1986, p. 145).
La glorificazione di Maria con l’Assunzione al cielo è, con ogni evidenza, tema immediatamente mariano, ma fondamentalmente essa è tema teologico, nel senso che è una delle iniziative del Padre su Maria. La Vergine riceve la grazia dell’Assunzione, come aveva ricevuto quelle dell’Immacolata concezione, dell’annunciazione, della maternità divina. Tenendo conto questo grande aspetto del mistero cristiano (l’attività di Dio e la passività della creatura), è proprio il caso di dire che il cosiddetto “autogiudizio”, su cui tanto s’insiste in questi anni, non si dà nel senso più serio in cui si deve dire dell’ultimo giudizio di Gesù sui singoli uomini e sulla storia. Il giudizio ultimo è l’estremo atto salvifico che Gesù, quale fratello necessario, porrà come Redemptor hominis e come Salvator mundi. In quanto iniziativa del Padre, l’Assunzione conferma in modo chiaro che nel cristianesimo non esiste l’auto-redenzione e, perciò, neppure l’auto-giudizio e l’auto-glorificazione. Maria non si è auto-redenta (è il senso dell’Immacolata concezione); perciò non si è neppure auto-glorificata (è il senso dell’Assunzione). Gesù salva lei e i suoi tre popoli: il popolo di Adamo di cui è la figlia migliore; il popolo d’Israele, di cui è il “resto santo”; il popolo della Chiesa, di cui è il beato inizio.
Fede escatologica e mariana
C’è una dimensione mariana nella vittoria redentiva di Cristo ottenuta nell’evento passato della Pasqua, che determina l’intero futuro? e se c’è, dov’è? Maria, profetizzata come uno dei soggetti della lotta contro Satana (cfr. Gn 3, 15), quale nuova Eva partecipa a tale lotta con la presenza attiva sotto la Croce.
 I rapporti Adamo-Eva e Cristo-nuova Eva non possono non essere compresi nel contesto dell’evento staurologico: la Croce è il nuovo “albero della vita” sul quale (Cristo) e intorno al quale (Maria) ricomincia la storia della salvezza nel segno della fedeltà e dell’ubbidienza.
I rapporti Adamo-Eva e Cristo-nuova Eva non possono non essere compresi nel contesto dell’evento staurologico: la Croce è il nuovo “albero della vita” sul quale (Cristo) e intorno al quale (Maria) ricomincia la storia della salvezza nel segno della fedeltà e dell’ubbidienza.Maria, con il Sì della «mediazione materna», come san Giovanni Paolo II s’esprime nella terza parte della Redemptoris Mater, ha partecipato a escatologizzare la storia, prima permettendo l’ingresso in essa del Salvatore come causa escatologica, poi ha continuato la collaborazione all’opera messianica del Figlio, permanendo al fianco di lui fino all’apice della lotta messianica, ossia fin nel cuore del mistero dell’ora pasquale. La nostra fede escatologica è dunque anche mariana perché riguarda un futuro, la cui causa è stata posta in un passato (incarnazione e croce) nel quale Maria ha preso parte in modo attivo ed essenziale. Questo - non stupisca - esige anche che perfino la “teologia della storia” si connoti in modo mariano.
La partecipazione di Maria alla strutturazione della storia della salvezza, ossia alla sua escatologizzazione, è stata così profonda ed essenziale che la sua esistenza può essere considerata una «microstoria della salvezza» (S. De Fiores): essa ha infatti sintetizzato l’intero progetto di grazia che il Dio trinitario ha disegnato e realizzato per la famiglia umana. Nella sua esistenza si inverano, in modo essenziale e nuovo, i maggiori passaggi della storia di grazia: «Per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, riunisce per così dire e riverbera i massimi dati della fede» (Lumen gentium, n. 65). In particolare, nel suo mistero sfocia l’evento dei nostri primordi (è la “nuova Eva”); si concentra il mistero del primo Israele (è la “Figlia di Sion”); ha principio il mistero del secondo Israele (è la “Chiesa nascente”).
La connessione del mistero mariano col mysterium salutis è tale che l’esistenza della Vergine-Madre è segno di tutti i misteri cristiani: del mistero trinitario (per essere figlia eletta del Padre, madre santa del Figlio, sposa amorosa dello Spirito); del mistero dell’incarnazione (per la sua maternità divina); del mistero pasquale-pentecostale (per il suo essere stata “socia del Salvatore” sotto la croce e compagna degli apostoli nel cenacolo); del mistero della Chiesa (per essere sua madre e suo modello); del mistero della fine (per essere assunta nella gloria trinitaria ed essere glorificata come regina, divenendo in pienezza “La Gloriosa”).
La salvezza completa
Con la sua Assunzione Maria anzitutto ci presenta il cristianesimo come religione del futuro assoluto. Parla anche all’uomo contemporaneo, quasi ammonendolo, perché questi consuma la sua esistenza nel quotidiano e pone le sue scelte nella breve terra dell’oggi, senza pretendere che esse debbano scaturire da lontano (assenza della tradizione) o debbano portare lontano (assenza dell’apertura al futuro ultimo), restando così irretito nelle forre del presentismo.
D’altra parte, il presentismo non è il tempo buono per l’uomo del nostro “tempo debole”, né la storia, nel suo insieme, è adeguata risposta al radicalismo della tensione al futuro che è dentro il suo cuore: «L’istinto del cuore - afferma la Gaudium et spes - lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l’idea [...] di un annientamento definitivo della sua persona» (n. 18). Perciò dice bene il filosofo Michele Federico Sciacca, quando afferma, con amabile ironia: «Io con la storia mi accendo la pipa» (Come si vince a Waterloo, Milano 1965, p. 12).
Purtroppo, l’uomo contemporaneo sembra farsi bastare quanto entra nelle strette stive di una “nave“ che solca un mare senza orizzonti lunghi. Al cristianesimo ciò non basta: l’Assunzione di Maria ricorda quanto esso pensa sul destino ultimo dell’uomo, che è chiamato a realizzarsi in pienezza e per sempre. È questo il senso della “gloria”, parola che Hans Urs von Balthasar ha genialmente scelto per dire tutto il cristianesimo nella sua monumentale teologia.
È un fatto che molti uomini d’oggi, come denunciava Benedetto XVI, sono scivolati dentro l’anello nero e soffocante del nichilismo, che è filosofia debole, ma che ha certamente la forza di stringere al collo la «bambina speranza», di cui parlava Péguy, e di soffocarla. Dinanzi al labirinto nichilistico che smarrisce l’uomo di oggi disarcionandolo dalle “grandi narrazioni”, inchiodandolo al solo presente, convincendolo che gli possano bastare i futuri brevi, allevandolo soprattutto alla malsana idea di una vita senza “giudizio ultimo”, il cristianesimo, preoccupato, s’impegna ad aiutare l’uomo della post-modernità a uscirne per evitare che finisca nelle fauci della tigre cinica.
Maria è imitabile sempre, lo è anche la sua Assunzione. Ma che cosa significa, oggi, essere «assunti» a imitazione di Maria? È presto detto: significa elevare, in un vortice aspirante di grazia, le nostre persone, le nostre «opere» e i nostri «giorni», la nostra vita cristiana ed ecclesiale, la nostra missione, la nostra animazione evangelica delle realtà temporali.
Dinanzi a Maria assunta in cielo il grido dei pellegrini verso la Patria trinitaria dev’essere più acuto e più radicale: l’intero tuo spirito diventi nostro. Il cristianesimo, anche con l’ostensione dell’“icona della Gloriosa”, dinanzi a un uomo, quello contemporaneo, che ama raccontarsi come un essere senza radici e senza promesse, invita a non aver paura del futuro, ma a riassumerlo con fiducia e serietà, a interrogarlo con radicale rigore.
Sfida alla gioia
C’è una vena di tristezza che connota la nostra ora storica, ed è così profonda da non poter essere nascosta dal frastuono del suo vitalismo. L’epoca contemporanea, nonostante tutto, è triste. La sua è una tristezza che ne segna vistosamente il volto fino a contraddistinguerla. La nostra epoca, fra l’altro, sarà ricordata come un tempo che ha conosciuto la tentazione della disperazione. C’è stato nell’Occidente del Novecento, il terribile “secolo breve”, una venatura amara nella vita privata, nella vita sociale e politica, e perfino nella cultura: Baudelaire, Mallarmé, Camus, Gide, Bernanos, Pavese, Tomasi di Lampedusa sono solo alcuni nomi di quel filone nerastro della sua letteratura che tinge di tristezza il frontespizio del tempio della cultura contemporanea.
Senza dire delle correnti malinconiche, tristi, disperanti della filosofia contemporanea, che in tanta parte è filosofia nichilista o comunque della crisi della ragione e dei comuni valori. Tristissimo, poi, è lo scenario se guardiamo all’ambito socio-politico su scala planetaria: sono vistosi i segni di tristezza causati dalla fame e dalla guerra sul volto dei popoli, specie su quello dei cosiddetti “popoli ultimi”, e dal terrorismo che rattrista e getta nel panico tutti con i suoi progetti di violenza e di morte.
C’è oggi una «difficoltà a dir di sì», affermava anni fa Johann Baptist Metz. Si constata una marcata indisponibilità alla gioia e, ciononostante, le ostentazioni vitalistiche del nostro tempo, e nonostante le grandi vittorie che l’uomo d’oggi indubbiamente si è date in campo scientifico e tecnologico. Paradossalmente, tanta parte della tristezza patita dall’uomo di oggi dipende proprio da quelle presunte e improprie “vittorie”: basti il solo cenno al guasto ecologico per intenderci.
La Chiesa osserva ed è preoccupata. Essa sa che nel lungo elenco dei «prodotti» dell’Homo faber d’oggi non si trova la gioia. Si constata anche una tacita confessione di debolezza e d’impotenza da parte di una civiltà che pure mostra di poter tanto; basti pensare all’incapacità di questa a fronteggiare serenamente la morte, intorno a cui non sa fare altro che organizzare una specie di congiura del silenzio. Scriveva Paolo VI: «La società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Perché la gioia viene d’altronde. È spirituale» (Esort. ap. Gaudete in Domino [9.5.1975], i).
Ora, di fronte a questa profonda e vasta tristezza che permea dei suoi neri umori un’intera epoca, la Chiesa sente di dover reagire: presenta, anzitutto dinanzi ai suoi occhi, ma anche in faccia al mondo, un segno di speranza, ed è Maria Assunta (cfr. Lumen gentium, n. 68): «La solennità del 15 agosto celebra la gloriosa Assunzione di Maria al cielo: è, questa, la festa del suo destino di pienezza e di beatitudine, della glorificazione della sua anima immacolata e del suo corpo verginale, della sua perfetta configurazione a Cristo risorto; una festa che propone alla Chiesa e all’umanità l’immagine e il consolante documento dell’avverarsi della speranza finale: ché tale piena glorificazione è il destino di quanti Cristo ha fatto fratelli» (Paolo VI, Esort. ap. Marialis cultus, [2.2.1974], n. 6).
Nella vita della Chiesa
La presenza di Maria nella Chiesa non proviene solo dal passato (come se vi fosse solo ben ricordata), ma proviene anche dal futuro: l’attende nella gloria e realizza in essa una misteriosa presenza soprattutto come sua permanente madre. Maria, donna di futuro, è presente nella Chiesa da sempre, perché ne fa parte in modo costitutivo: senza di lei la Chiesa sarebbe una comunità religiosa senza prototipo e senza modello ispirativo, sarebbe un popolo pellegrino senza il segno di sicura speranza dinanzi ai suoi occhi, sarebbe una famiglia senza madre, ma non al modo di una famiglia restata senza madre (cosa che è possibile), ma al modo di una famiglia che non avrebbe avuto mai la madre (cosa che non riusciamo a concepire).
La Chiesa senza Maria dovrebbe spiegare diversamente le sue origini (è stata la Chiesa nascente), dovrebbe spiegare diversamente l’ingresso nel mondo del suo fondatore (Cristo è nato da donna: cfr. Gal 4, 4), dovrebbe spiegare diversamente la sua attuale unione con Cristo che rende salvifico il suo agire (è sacramento in Cristo, la cui sacramentalità è legata all’incarnazione del Verbo avvenuta nel seno della Vergine Madre).
Glorificazione regale
L’Assunzione non è l’ultimo mistero di Maria, che è già la sua glorificazione, ma ad essa segue un’altra forma di glorificazione, quella regale. Come si sa, Pio XII al termine dell’Anno mariano del 1954, dedicato al centenario alla definizione dommatica sull’Immacolata, l’11 ottobre pubblica l’enciclica Ad coeli reginam. In essa Papa Pacelli portava le motivazioni della nuova festa liturgica di Maria regina, fissandola a conclusione del mese di maggio, legandola perciò alla pietà popolare. Invece, nel riformato Calendario romano del 1969 la festa della regalità della Vergine viene spostata al 22 agosto, all’ottava dell’Assunta. In tal modo si fa una scelta teologica molto saggia e intelligente: infatti, è evidenziato il legame misterico che esiste fra Assunzione e glorificazione regale di Maria.
Questo legame è mostrato e reso esplicito dalla liturgia del 15 agosto, quando nell’antifona del Magnificat di quel giorno, così si canta: «Rallegratevi, perché Maria è salita nei cieli: / con Cristo regna per sempre». La “logica dei misteri” è evidente: il “salire in Cielo” e il “regnare in Cielo” si legano, come sono connessi l’ascendere di Gesù al Cielo e il suo regnare avendo ricevuto la glorificazione regale da parte del Padre. Con lucidità magisteriale Paolo VI afferma rispetto alla memoria mariana del 22 agosto: «La solennità dell’Assunzione ha un prolungamento festoso nella celebrazione della beata vergine Maria regina, che ricorre otto giorni dopo, nella quale si contempla colei che, assisa accanto al Re dei secoli, splende come Regina e intercede come Madre» (Esort. Ap. Marialis cultus, n. 6).
In questo testo pontificio non si afferma solo l’essenziale legame tra Assunzione e regalità di Maria, ma anche un ordine fra i due eventi della sua glorificazione. «Giustamente il testo sottintende che per la liturgia romana la solennità del 15 agosto costituisce, a rigor di termini, la celebrazione più piena della regalità di Maria: nella luce dell’Assunzione la festa del 22 agosto appare solo come un “prolungamento festoso” di essa come peculiare contemplazione di “colei che, assisa accanto al Re dei secoli, splende come Regina e intercede come Madre”» (D. M. Sartor, Le feste della Madonna. Note storiche e liturgiche per una celebrazione partecipata, Bologna, Dehoniane, 1987, p. 136).
Però, è anche vero che, in un’ottica teologica rigorosa, il culmine della glorificazione di Maria e, perfino il senso ultimo di essa, si ha nella sua glorificazione regale. È lì che lei diviene, in senso pienissimo, “La Gloriosa”.
* Fonte: L’Osservatore Romano, 13 agosto 2020
*
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA!!!
“DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE... Commenti a De Domo David. 49 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò
PER IL “futuro Simposio internazionale di studi su san Giuseppe, che si terrà tra due anni in Guatemala”. Alcuni “vecchi” appunti sul tema...
 “GIUSEPPE”, L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI “TRE” MONOTEISMI. Un importante studio di Massimo Campanini sul patriarca d’Israele e sul profeta del Corano. A quando la ri-considerazione e il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica dell’altro Giuseppe, quello ev-angelico?! Freud e Pirandello aspettano ancora.
“GIUSEPPE”, L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI “TRE” MONOTEISMI. Un importante studio di Massimo Campanini sul patriarca d’Israele e sul profeta del Corano. A quando la ri-considerazione e il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica dell’altro Giuseppe, quello ev-angelico?! Freud e Pirandello aspettano ancora.Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- LA QUESTIONE DEL BATTESIMO. Papa Francesco: non valido battesimo con formula ’noi battezziamo’. La Congregazione per la Dottrina della Fede interviene6 agosto 2020, di Federico La Sala
Papa Francesco: non valido battesimo con formula ’noi battezziamo’
La Congregazione per la Dottrina della Fede interviene per fermare la ’creatività’ di alcuni sacerdoti
di Redazione ANSA *
CITTA DEL VATICANO. La Congregazione per la Dottrina della Fede interviene dunque per fermare la ’creatività’ di alcuni sacerdoti che cambiano le formule dei riti dei sacramenti pensando di migliorarle. "Recentemente vi sono state celebrazioni del Sacramento del Battesimo amministrato con le parole: ’A nome del papà e della mamma, del padrino e della madrina, dei nonni, dei familiari, degli amici, a nome della comunità noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’. A quanto sembra, la deliberata modifica della formula sacramentale - riferisce la Congregazione per la Dottrina della Fede - è stata introdotta per sottolineare il valore comunitario del Battesimo, per esprimere la partecipazione della famiglia e dei presenti e per evitare l’idea della concentrazione di un potere sacrale nel sacerdote a discapito dei genitori e della comunità".
 Ma l’"io", che il sacerdote deve pronunciare ha un valore dottrinale ben preciso: "segno-presenza dell’azione stessa di Cristo". "Nel caso specifico del Sacramento del Battesimo, il ministro non solo non ha l’autorità di disporre a suo piacimento della formula sacramentale, per i motivi di natura cristologica ed ecclesiologica sopra esposti, ma non può nemmeno dichiarare di agire a nome dei genitori, dei padrini, dei familiari o degli amici, e nemmeno a nome della stessa assemblea radunata per la celebrazione", spiega la Congregazione per la Dottrina della Fede.
Ma l’"io", che il sacerdote deve pronunciare ha un valore dottrinale ben preciso: "segno-presenza dell’azione stessa di Cristo". "Nel caso specifico del Sacramento del Battesimo, il ministro non solo non ha l’autorità di disporre a suo piacimento della formula sacramentale, per i motivi di natura cristologica ed ecclesiologica sopra esposti, ma non può nemmeno dichiarare di agire a nome dei genitori, dei padrini, dei familiari o degli amici, e nemmeno a nome della stessa assemblea radunata per la celebrazione", spiega la Congregazione per la Dottrina della Fede.Ora si apre la questione dei battesimi celebrati con questo rito errato. Al quesito "Coloro per i quali è stato celebrato il Battesimo con la suddetta formula devono essere battezzati in forma assoluta?", la risposta del Vaticano è: "affermativamente". "Negativamente" è la risposta che si dà al quesito principale: "È valido il Battesimo conferito con la formula: ’Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’?".
In pratica i battesimi con la formula ’noi’ è come se non fossero mai stati fatti. Anche se comunque nel Catechismo della Chiesa Cattolica - secondo quanto spiegato da esperti in Vaticano - potrebbe trovarsi una via d’uscita per evitare il ’ripetersi’ del sacramento. Anche perché senza il Battesimo, a cascata non sono validi neanche gli altri sacramenti, dalla Cresima alla Comunione, dal Matrimonio alla Confessione. Nel Catechismo si stabilisce infatti che "Dio ha legato la salvezza al sacramento del Battesimo, tuttavia egli non è legato ai suoi sacramenti". Sempre nel Catechismo ci sono aperture per i non battezzati: "Ogni uomo che, pur ignorando il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la volontà di Dio come la conosce, può essere salvato". (ANSA).
-
> IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA --- I NONNI. Gioacchino e Anna. Volti di una storia umana abitata dall’amore eterno (di Matteo Liut).26 luglio 2020, di Federico La Sala
Gioacchino e Anna.
Volti di una storia umana abitata dall’amore eterno
di Matteo Liut (Avvenire, domenica 26 luglio 2020)
Il giorno in cui la Chiesa ricorda i nonni di Gesù, i genitori di Maria, è anche l’occasione per ricordare che ogni essere umano “è” una storia, è il frutto di un cammino, l’emergere di un senso condiviso, partecipato da chi l’ha preceduto e offerto a chi verrà. I santi Gioacchino e Anna, la cui storia è narrata nei Vangeli apocrifi, rappresentano l’intimità custodita nella vicenda del Dio che si fa uomo: Gesù ha una famiglia, segnata dalle stesse difficoltà delle altre famiglie, ma capace di aprirsi all’eterno.
Allo stesso tempo i due nonni santi sono il volto della maestosità del Vangelo: nel Risorto si riconciliano le generazioni e si realizza il Regno dell’amore che riguarda l’universo intero. La devozione per Gioacchino e Anna - celebrati nello stesso giorno dal 1584 - si è diffusa prima in Oriente; in Occidente ègiunta alla fine del primo millennio.
 Altri santi. Sant’Austindo, vescovo (XI sec.); San Giorgio Preca, sacerdote (1880-1962). Letture. 1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.
Altri santi. Sant’Austindo, vescovo (XI sec.); San Giorgio Preca, sacerdote (1880-1962). Letture. 1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.
 Ambrosiano. 1Sam 3,1-20; Sal 62 (63); Ef 3,1-12; Mt 4,18-22.
Ambrosiano. 1Sam 3,1-20; Sal 62 (63); Ef 3,1-12; Mt 4,18-22. -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- Amore e accoglienza al «Bar Giuseppe»: il film di Giulio Base girato tra Puglia e Basilicata (di Livio Costarella).31 maggio 2020, di Federico La Sala
SPETTACOLI
Amore e accoglienza al «Bar Giuseppe»: il film di Giulio Base girato tra Puglia e Basilicata
Domani su Rai Play, protagonisti Ivano Marescotti e Victoria Diop
di Livio Costarella (la Gazzetta del Mezzogiorno, 27 Maggio 2020)
Natività, famiglia, l’essere migranti. E l’eterna «novella» di Giuseppe e la sua sposa, tra il mistero del concepimento e il concetto di accoglienza. È di un’attualità inaspettata Bar Giuseppe, il film del regista Giulio Base presentato con successo lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma, con protagonista la strana coppia - ma «divina» - formata da un gigantesco Ivano Marescotti e una bravissima esordiente, Victoria Diop. Il film, girato in gran parte in Puglia, a Bitonto (con ciak anche nei territori tra Terlizzi, Palo del Colle e Canosa, fino a Lavello, in Basilicata), è il secondo che da domani, giovedì 28 maggio, sarà disponibile alla visione su RaiPlay, dopo Magari di Ginevra Elkann, lanciato la settimana scorsa. È una prima visione assoluta, in un momento in cui l’apertura delle sale cinematografiche è ancora un grosso punto interrogativo.
«Una grande opportunità per vedere un film che avrebbe avuto una normale distribuzione», ha detto ieri lo stesso regista torinese in una conferenza stampa svoltasi on line. Insieme a lui gli attori protagonisti Marescotti e Diop, oltre allo stato maggiore di One More Pictures e Rai Cinema, che insieme hanno prodotto il lungometraggio, sostenuto da Regione Puglia e Apulia Film Commission (rappresentata dalla presidente Simonetta Dellomonaco e dal direttore generale Antonio Parente).
«È una storia che mi ha commosso», ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano, intervenuto per salutare tutto lo staff insieme al sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, felice che la sua città sia stata «messa sottosopra», dal set di un film coraggioso e toccante.
Il Bar Giuseppe, nella trama del film, è gestito dal suo omonimo proprietario, insieme a una stazione di servizio, dislocata in una zona ai confini tra un mondo rurale - il paese in cui vivono i protagonisti, in un cast ricco di attori pugliesi -, e una strada provinciale, un limine simbolico in cui rombano i motori della modernità. Dopo essere rimasto vedovo, con due figli già adulti e diversi tra loro (interpretati da Nicola Nocella e Michele Morrone), Giuseppe assume come cameriera Bikira, una diciottenne giunta da poco dall’Africa. I due si innamorano creando grosso scandalo nel paese. E si sposano, nonostante il conflitto coi figli di lui.
In un film in cui la fotografia di Giuseppe Riccobene e le scenografie di Isabella Angelini s’intrecciano creando un suggestivo contrappunto di luci e ombre, tra albe e tramonti (nel cast anche Vito Mancini, Teodoso Barresi, Ira Fronten, Emmanuel Dabone, Selene Caramazza), Bar Giuseppe racconta sullo sfondo metaforico la parabola biblica di Giuseppe e Maria, interrogandosi sul mondo degli esiliati, sull’angoscia di non essere accolti, e sul sottile limite tra umanità e disumanità, con la strisciante e abietta visione maschilista e secolare della donna.
«Il lavoro nasce dall’incontro con un testo di Gianfranco Ravasi intitolato Giuseppe. Il Padre di Gesù - ha spiegato il regista -, che mi ha permesso di incontrare la figura di un uomo che non avevo mai approfondito. Mi ha colpito il fatto che nessuno l’avesse mai sentito parlare: non a caso i suoi silenzi, nella straordinaria maschera di Marescotti, contengono pensieri da decifrare. In lui contano più le mani che la bocca, più il lavoro che le parole. Simbolo di un’umanità che non strepita, che passa impercettibile e anonima in questo mondo, ma che spesso viene coinvolta in eventi imperscrutabili (e non parlo di miracoli) alla pietas umana».
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- ARTE, RELIGIONE,E ANTROPOLOGIA. SAN GIUSEPPE, TERESA D’AVILA, E IL CARMELO TERESIANO.21 maggio 2020, di Federico La Sala
ARTE, RELIGIONE,E ANTROPOLOGIA.
SAN GIUSEPPE, TERESA D’AVILA, E IL CARMELO TERESIANO... *
"[...] è bene ricordare che, il culto del santo nel Carmelo entra già dalle origini dell’Ordine. La devozione a san Giuseppe, a livello personale e locale, si viveva fin dalla venuta dei carmelitani in Europa, anche se la festa del santo Patriarca, a livello di Ordine, non appare sino alla seconda metà del XV secolo.
 Tale devozione nel Carmelo teresiano, va essenzialmente unita a santa Teresa. È uno dei legati più ricchi e caratteristici che la Santa lasciò ai suoi figli. Non si comprende il Carmelo teresiano senza san Giuseppe, senza l’esperienza giuseppina della Santa. Per la Santa Madre, i conventi che fonda, a immagine del primo (Avila 1562), sono ‘case’ di san Giuseppe. Per questo procura che la maggior parte di essi porti il nome e titolo di san Giuseppe.
Tale devozione nel Carmelo teresiano, va essenzialmente unita a santa Teresa. È uno dei legati più ricchi e caratteristici che la Santa lasciò ai suoi figli. Non si comprende il Carmelo teresiano senza san Giuseppe, senza l’esperienza giuseppina della Santa. Per la Santa Madre, i conventi che fonda, a immagine del primo (Avila 1562), sono ‘case’ di san Giuseppe. Per questo procura che la maggior parte di essi porti il nome e titolo di san Giuseppe.
 Dei diciassette, fondati dalla Santa, undici stanno sotto il titolo di san Giuseppe. Se non tutte le fondazioni della Santa Madre portano quel titolo, non ce n’è nessuna dove non ci sia un’immagine del Santo che presieda e protegga la comunità. È un’ulteriore manifestazione, più della sua devozione ed esperienza giuseppina, il diffondere nei conventi le immagini del santo, la maggior parte delle quali ancora si conserva.
Dei diciassette, fondati dalla Santa, undici stanno sotto il titolo di san Giuseppe. Se non tutte le fondazioni della Santa Madre portano quel titolo, non ce n’è nessuna dove non ci sia un’immagine del Santo che presieda e protegga la comunità. È un’ulteriore manifestazione, più della sua devozione ed esperienza giuseppina, il diffondere nei conventi le immagini del santo, la maggior parte delle quali ancora si conserva.
 È da notare, a questo riguardo, il dato che portava con sé in tutte le fondazioni, una statua di san Giuseppe, che riceveva il titolo di “Patrocinio di san Giuseppe” [...]" (Antonio Faita, "Un inedito di Giuseppe Sarno: san Giuseppe con Gesù Bambino presso la chiesa teresiana di Gallipoli", Fondazione Terra d’Otranto, 19.03.2020).
È da notare, a questo riguardo, il dato che portava con sé in tutte le fondazioni, una statua di san Giuseppe, che riceveva il titolo di “Patrocinio di san Giuseppe” [...]" (Antonio Faita, "Un inedito di Giuseppe Sarno: san Giuseppe con Gesù Bambino presso la chiesa teresiana di Gallipoli", Fondazione Terra d’Otranto, 19.03.2020).* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. “De Domo David. 49 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò, Fondazione Terra d’Otranto, 10.11.2019).
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- L’orfanezza che proviamo e la promessa che rincuora (di Marina Corradi).20 maggio 2020, di Federico La Sala
Santa Marta.
L’orfanezza che proviamo e la promessa che rincuora
di Marina Corradi (Avvenire, mercoledì 20 maggio 2020)
Nell’ultima Messa mattutina in diretta tv e social il Papa lascia il segno «Oggi nel mondo c’è un grande sentimento di orfanezza: tanti hanno tante cose, ma manca il Padre». È domenica mattina. Ascolti il Papa, per l’ultima volta nelle Messe da Santa Marta aperte al popolo della tv e dei social, e le sue parole ti sembrano una freccia che lascia il segno, cogliendo il bersaglio. Un bersaglio dolente e misconosciuto: qualcosa che riguarda il nostro modo di vivere, nel suo livello più profondo.
 Orfanezza, dice Francesco, e ti pare uno strano sostantivo (esistente però, dice il vocabolario); un’espressione che tuttavia centra con precisione un malessere carsico del nostro tempo. Orfanezza: il sentimento di non avere un Padre e dunque di non essere un figlio. Di non camminare in un disegno, ma dentro un caso cieco. Forse lo può capire meglio chi non è sempre vissuto nella fede: percepirsi soli, chissà perché venuti al mondo, e non veramente cari a nessuno.
Orfanezza, dice Francesco, e ti pare uno strano sostantivo (esistente però, dice il vocabolario); un’espressione che tuttavia centra con precisione un malessere carsico del nostro tempo. Orfanezza: il sentimento di non avere un Padre e dunque di non essere un figlio. Di non camminare in un disegno, ma dentro un caso cieco. Forse lo può capire meglio chi non è sempre vissuto nella fede: percepirsi soli, chissà perché venuti al mondo, e non veramente cari a nessuno.Chi ha ereditato in famiglia una fede di roccia stenta magari a immedesimarsi in questa assoluta solitudine, che però accomuna oggi un grande numero di uomini e donne. Quando le cronache raccontano di vandalismi gratuiti, di aggressioni ai deboli, di cattiverie senza ragione, ecco sembra di vedere sotto a questo male stupido, al male fatto per passare il tempo, quella vena sotterranea di cui parla Francesco: orfanezza. Sbandamento, noia, aggressività da figli di nessuno. Figli che nessun Padre, e forse nemmeno un padre in carne e ossa, aspetta a casa, la sera. «Soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può vivere in pace fra noi. Sempre le guerre, sia le piccole guerre sia le grandi guerre, sempre hanno una dimensione di orfanezza: manca il Padre, che faccia la pace», ha continuato Francesco.
E di nuovo la sensazione di sentire evocare l’origine, una radice antica della violenza tra gli uomini. Da quella immane dei conflitti mondiali e delle persecuzioni, a quella “piccola” di certe liti di condominio, apparentemente banali, e che però si trascinano anni e creano “piccoli” odi tenaci. Perché se non si è figli di un Padre, non si è nemmeno fratelli. Se non c’è un vincolo d’appartenenza e amore forte come asse portante di sé, tutto il resto è sospeso alla consistenza della persona. Che può essere leale e perfino stoica, oppure instabile e incerta, o concentrata solo sul proprio interesse. Ma manca un centro, su cui gravitare. (Ha scritto Kafka: «Anch’io, come chiunque altro, ho in me, fin dalla nascita, un centro di gravità, che neanche la più pazza educazione è riuscita a spostare. Ce l’ho ancora questo centro di gravità, ma, in un certo qual modo, non c’è più il corpo relativo»). «E una delle conseguenze del senso di orfanezza è l’insulto», aggiunge il Papa.
Pensi all’odio che tracima sul web nei messaggi degli haters, gli odiatori: che odiano gli immigrati, o gli ebrei, o i musulmani, o quelli che non la pensano come loro. Protetti dall’anonimato vomitano un odio che probabilmente nella vita quotidiana dissimulano. Una quantità di odio che spaventa. Ma anche quello, dice Francesco, è un male che attinge all’orfanezza, al non essere figli, né fratelli. All’essere soli - e, forse, smarriti in fondo nell’angoscia e nello spavento.
Come bambini nel buio. «Non vi lascerò orfani», è la promessa di Cristo nel Vangelo di Giovanni, che il Papa ci ricorda. Promessa e memoria da rinnovare ogni mattina. Non siamo orfani venuti al mondo per un caso fortuito, abbandonati alla Fortuna cieca dei pagani. Pensiamo a come una madre e un padre guardano, istintivamente, un figlio appena nato. Non sarà infinitamente più grande l’amore di Dio per ogni uomo? Ricordarlo, per sottrarci dai vapori di questa orfanezza che marca il nostro tempo. Pieno, per molti, di tante cose che una volta non c’erano; ma mancante, dolorosamente, di ciò che è più necessario.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --LA FIGURA DI PILATO, "UN PARALLELISMO", E IL TRAGUARDO DI DANTE (di R. Manescalchi).22 aprile 2020, di Federico La Sala
LA FIGURA DI PILATO E IL "PELLEGRINAGGIO" CHE PORTA DANTE A DIVENTARE UN ALTRO CRISTO, A RINASCERE E A RITROVARE L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE... *
Il gran rifiuto (Inf. III 59-60)
di Romano Manescalchi (Independent Scholar),
 Princeton.edu, 8 April 2014.
Princeton.edu, 8 April 2014. L’intervento di Lanza sul «gran rifiuto» riapre con grande determinazione la discussione riguardo il personaggio cui Dante si sarebbe riferito, discussione ultimamente sopita generalmente in favore di Celestino V.[1] In buona sostanza, ma in una sintesi necessariamente riduttiva, il Lanza evidenzia che l’atto di Celestino V non apparve riprovevole, se non a pochi estremisti, gli spirituali, che con Ubertino da Casale non ritennero valida l’abdicazione di Celestino, mentre generalmente apparve un atto di responsabilità, tanto che la Chiesa lo fece santo. Dante dagli spirituali rimarcò sempre le distanze;[2] ed aggiungerei che, per contro, Dante si trovò a lodare chi è capace di rinunciare ad un incarico per non sentirsi all’altezza, favorendo i meritevoli: «Molti rifiutan lo comune incarco» (Purg. vi 133); e a condannare quanti son sempre pronti a dire, irresponsabilmente, senza un minimo esame di coscienza «I’ mi sobarco» (ivi, 135).
Ma non intendo riassumere qui le sostanziose ragioni con le quali viene riproposta dal Lanza la candidatura di Ponzio Pilato e confutate le ragioni in favore di altri (Esaù, Celestino V soprattutto, Vieri de Cerchi, Giano della Bella, Giuliano l’Apostata, Romolo Augustolo ecc.), né ci sarebbe qui lo spazio per farlo. Qui vorrei solo aggiungere alcune mie considerazioni che vanno nella stessa direzione.
Innanzitutto una considerazione grammaticale e stilistica: «il gran rifiuto» può intendersi, su base grammaticale, in due modi: «quel gran rifiuto, che tutti conosciamo per averlo direttamente constatato», con «il» semplicemente indicativo; e la mente, in questo caso, va ad avvenimenti e personaggi recenti: Vieri di Cerchi, Giano della Bella, Celestino V ecc. Ma può intendersi anche «quel gran rifiuto di cui nessun altro è maggiore, il “gran rifiuto” per eccellenza, per definizione, per antonomasia»;[3] ed alla mente non può ricorrere se non Ponzio Pilato, con «il» che viene ad avere un valore superlativo, “antonomasico”. Ed ora il procedimento di Dante è questo: egli sostituisce i personaggi astratti del poema classico allegorico, semplici e unidimensionali personificazioni - vedi la Psicomachia di Prudenzio - con personaggi tratti dal mondo reale, indifferentemente della storia passata e del mito, o della cronaca dei suoi tempi. E la regola è questa: si sceglie il personaggio che meglio possa rappresentare quel peccato o vizio o virtù, che quel peccato o vizio o virtù lo rappresenti nel modo più eccellente, ne sia quasi la personificazione.
 E da questo punto di vista Ponzio Pilato non ha rivali nell’indicare chi non si vuol compromettere, chi si ritira da un suo specifico dovere per viltà. Appartiene alle viscere del nostro linguaggio, da cui continuamente riemerge, il dire: «Ti comporti come Ponzio Pilato. Sei un Ponzio Pilato», come si dice «Sei un Giuda», frasi quasi altrettanto comuni come l’altra parallela del «lavarsene le mani», che comunque è ancor più ricorrente nel comune quotidiano parlare e rafforza in pari grado, o forse di più, le nostre argomentazioni. Dante avrebbe potuto trarre il personaggio esemplare dell’ignavo anche dalla cronaca quotidiana, come fa in tanti altri casi, riempiendo tra l’altro l’inferno con i suoi concittadini. Poteva quindi benissimo ricorrere a Celestino V, come a Vieri dei Cerchi o altri. Ma nessuno di questi personaggi può insidiare minimamente la candidatura di Ponzio Pilato, senz’altro il personaggio più rispondente, più adatto, ad incarnare il prototipo dell’ignavo, come gli riconosce senza obiezione alcuna tutta la nostra cultura, a cominciare, come detto, dal quotidiano parlare.
E da questo punto di vista Ponzio Pilato non ha rivali nell’indicare chi non si vuol compromettere, chi si ritira da un suo specifico dovere per viltà. Appartiene alle viscere del nostro linguaggio, da cui continuamente riemerge, il dire: «Ti comporti come Ponzio Pilato. Sei un Ponzio Pilato», come si dice «Sei un Giuda», frasi quasi altrettanto comuni come l’altra parallela del «lavarsene le mani», che comunque è ancor più ricorrente nel comune quotidiano parlare e rafforza in pari grado, o forse di più, le nostre argomentazioni. Dante avrebbe potuto trarre il personaggio esemplare dell’ignavo anche dalla cronaca quotidiana, come fa in tanti altri casi, riempiendo tra l’altro l’inferno con i suoi concittadini. Poteva quindi benissimo ricorrere a Celestino V, come a Vieri dei Cerchi o altri. Ma nessuno di questi personaggi può insidiare minimamente la candidatura di Ponzio Pilato, senz’altro il personaggio più rispondente, più adatto, ad incarnare il prototipo dell’ignavo, come gli riconosce senza obiezione alcuna tutta la nostra cultura, a cominciare, come detto, dal quotidiano parlare.Vediamo ora il problema nell’economia della Commedia, nella cattedrale che anche è la Commedia, sintesi della storia universale dell’umanità in versione biblico-cristiana. Questa storia universale ha il suo punto centrale nella Redenzione della Croce, nella Crocifissione di Gesù. Non conosco racconto della storia della Crocifissione tante volte fatto dai pittori nelle cattedrali appunto, in cui manchino, accanto a Gesù, Pilato e Giuda. Ed ora Dante riconosce ed esalta i “meriti” di Giuda, dedicandogli a perpetua memoria - addirittura “eterna memoria” nel suo caso - un settore dell’inferno, la Giudecca, che appunto prende da lui il nome, dove anche grandeggia la sua statua vivente in una delle bocche di Lucifero (Inf. xxxiv vv. 61-63). Né è un settore qualunque quello a lui dedicato, bensì il più importante, dove è la reggia del sovrano infernale: diciamo che la Giudecca è la city della città infernale. Non penso proprio che Giuda si possa lamentare del trattamento che Dante gli ha riservato.
Ma lamentare si dovrebbe Pilato di cui non ci sarebbe nella Commedia, se gli togliamo di essere l’innominato di Inf. iii 59-60, niente altro che un fuggevole richiamo a Purg. xx 91 e solo per designare con il paragone con lui il sovrano di Francia Filippo IV. Davvero troppo poco. E se così fosse, dopo il tanto da lui fatto con il suo non far nulla, avrebbe ben motivo di rivoltarsi nella tomba contro un Dante tanto ingrato, dal momento che anche grazie a lui il poeta può fare questo pellegrinaggio[4] di redenzione che è la Commedia e guadagnarsi lui stesso il paradiso, grazie proprio a lui che in compenso del bene fatto (col non far nulla) come allo stesso poeta così a tutti i cristiani, dovrà subire pene eterne nell’inferno, pene che il poeta fiorentino non gli avrebbe nemmeno voluto determinare! E se non è troppo questo!
Dante darebbe a Pilato maggior rilievo a Mon. II xii 5-6: «Si ergo sub ordinario iudice Christus passus non fuisset, illa pena punitio non fuisset. Et iudex ordinarius esse non poterat nisi supra totum humanum genus iurisdictionem habens, cum totum humanum genus in carne illa Christi “portantis dolores nostros”, ut ait Propheta, puniretur. Et supra totum humanum genus Tiberius Cesar, cuius vicarius erat Pilatus, jurisdictionem non habuisset, nisi Romanum Imperium de iure fuisset. Hinc est quod Herodes, quamvis ignorans quid faceret, sicut et Cayphas cum verum dixit de celesti decreto, Christum Pilato remisit ad iudicandum... », dove il ruolo, comunque ragguardevole, avuto da Pilato è riconosciuto a chiare lettere, come anche a Mon. III xv 5 e ad Ep. V 28.
E dunque tanta importanza, quanto a mio avviso gli spetta, Dante dà a Pilato nella Monarchia, l’opera dantesca più vicina, per tematica e mole, alla Commedia, tanta in una lettera, comunque di molto peso come l’Ep. V indirizzata ai reggenti d’Italia, anche se di dimensioni indiscutibilmente minori; e non nominerebbe mai Pilato, direttamente, nella Commedia? A me pare molto, troppo, strano. Il personaggio è onnipresente nell’iconografia cristiana della Crocifissione e sarebbe assente nella Commedia, che è indiscutibilmente il massimo monumento laico della cristianità! È tanto inaccettabile quanto incomprensibile.
 Da qualche parte Pilato deve essere anche nella Commedia e se non qui, a Inf. iii 59-60, dove? Nella storia universale della Chiesa (e dell’umanità) - da intendere in chiave biblico-cristiana - il personaggio di Pilato ha un grande rilievo come gli riconosce tutta l’iconografia e, come anche detto, il linguaggio spicciolo quotidiano. Celestino V e gli altri in questa prospettiva sono irrilevanti. Nel quadro specifico poi della Crocifissione, l’elemento centrale di quella storia universale in versione cristiana ed elemento centrale della Commedia che quella storia universale ha per suo sfondo e, direi, addirittura per suo oggetto, Pilato è un elemento addirittura indispensabile come lo è Giuda. Da qualche parte Dante deve averlo messo e il luogo più giusto è senz’altro tra gli ignavi. E se è tra gli ignavi nessuno gli può togliere - sarebbe una vera usurpazione - il diritto di rappresentare la categoria, che riconosce in lui, per il consenso di tutte le genti (cristiane), il suo massimo rappresentante.
Da qualche parte Pilato deve essere anche nella Commedia e se non qui, a Inf. iii 59-60, dove? Nella storia universale della Chiesa (e dell’umanità) - da intendere in chiave biblico-cristiana - il personaggio di Pilato ha un grande rilievo come gli riconosce tutta l’iconografia e, come anche detto, il linguaggio spicciolo quotidiano. Celestino V e gli altri in questa prospettiva sono irrilevanti. Nel quadro specifico poi della Crocifissione, l’elemento centrale di quella storia universale in versione cristiana ed elemento centrale della Commedia che quella storia universale ha per suo sfondo e, direi, addirittura per suo oggetto, Pilato è un elemento addirittura indispensabile come lo è Giuda. Da qualche parte Dante deve averlo messo e il luogo più giusto è senz’altro tra gli ignavi. E se è tra gli ignavi nessuno gli può togliere - sarebbe una vera usurpazione - il diritto di rappresentare la categoria, che riconosce in lui, per il consenso di tutte le genti (cristiane), il suo massimo rappresentante.Ci sarebbe anche un parallelismo: l’episodio della Crocifissione inizia con Pilato che, pur riconoscendo Cristo innocente, non fa il suo dovere, piegato dalla pressione della folla. E con Pilato posto nell’Antinferno comincerebbe la “crocifissione” di Dante, che ad una “crocifissione” del proprio ego lo porta il suo “pellegrinaggio” al santuario del Paradiso.[5]
Non mi sfugge che Inf. iii 59 - «vidi e conobbi» - crea delle difficoltà. Osserverei che si deve distinguere tra il “riconoscere” del v. 58, immediatamente precedente ed il “conoscere” del v. 59, volendo certo il poeta distinguere «quelli riconosciuti direttamente e quello che gli fu fatto conoscere da Virgilio» (Lanza, op. cit., p. 85) . Prosegue il Lanza: «Se si vuole un chiaro esempio di conobbi in questo senso, si veda il v. 122 del canto iv (ibidem), ovvero «tra quai conobbi Ettòr ed Enea». Vedi anche «sopra “riconosce”, qui “conosce”, vede in faccia» D. Mattalia, ad locum.
[1] Cfr. A. Lanza, Uno specchietto per allodole non previsto da Dante: Celestino V (Inf. iii 59-60, SD, lxxviii, 2013, pp. 45-100.
[2] Vd.: «ma non fia da Casal né d’Acquasparta» (Par. xii 124).
[3] L’espressione «per antonomasia» viene usata anche dal Lanza, op. cit. p. 93, ma riferita a Pilato e non all’espressione «gran rifiuto».
[4] Uso il termine “pellegrinaggio” soprattutto in onore di Vincenzo Barelli, il quale ha dato l’avvio alla interpretazione moderna delle tre fiere come «le tre disposizion che il ciel non vuole», ed è oggi totalmente dimenticato, indegnamente dimenticato visto che la sua scrittura è di alto spessore; vd. L’allegoria della Divina Commedia di Dante Alighieri / esposta da Vincenzo Barelli, Firenze, Galileiana, 1864, p. 64.
[5] Per questo concetto di “crocifissione” dantesca si tenga presente: «Si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam» ( Matth. XVI 24); «Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt, cum vitiis et concupiscentiis» (Ad Galatas v 24); «Ego enim per legem, legi mortuus sum, ut Deo vivam; Christo confixus sum cruci. Vivo autem jam non ego; vivit vero in me Christus» (Ibidem ii 19-20). È questo il traguardo che Dante deve raggiungere con la Commedia.
* Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. CON MARX E FREUD. Una "ipotesi di rilettura. della DIVINA COMMEDIA"
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- In che lingua parlava Gesù? Oltre l’aramaico, conosceva anche l’ebraico e il greco? E in che lingua avvenne il processo davanti a Pilato?7 aprile 2020, di Federico La Sala
Pasqua. Aramaico, ebraico, greco, latino... in che lingua Gesù parlò con Pilato?
Oltre l’aramaico, conosceva anche l’ebraico e il greco? E in che lingua avvenne il processo davanti a Pilato? Le ipotesi degli studiosi e l’importanza degli idiomi per l’evangelizzazione
di Mimmo Muolo (Avvenire, martedì 7 aprile 2020).
In che lingua parlava Gesù? E i protagonisti dei grandi eventi che portarono alla sua morte in croce? La questione, da tempo al centro del dibattito tra gli studiosi, può essere assunta proprio nei giorni della Settimana Santa, come filo rosso per comprendere alcune dinamiche fondamentali dell’annuncio della Buona Novella dall’inizio fino a noi.
Le quattro lingue della Palestina
Va detto innanzitutto che al tempo in cui si svolsero gli eventi descritti nei Vangeli quattro erano le lingue parlate in Palestina. Quella ufficiale (ma anche la meno diffusa: usata solo da un ristretto numero di funzionari pubblico) era il latino. Quella religiosa era l’ebraico, parlata nelle sinagoghe, dove si leggevano i testi della Torah, e dai farisei che erano gli ebrei più osservanti. Quella della vita quotidiana era invece l’aramaico, che il popolo aveva adottato dopo il ritorno dall’esilio babilonese (VI sec. a.C.). E infine il greco della koiné, che era un po’ come l’inglese di oggi, parlata ovunque. Ebraico e aramaico erano lingue semitiche, imparentate tra loro come ad esempio l’italiano e il napoletano, dato che l’aramaico (nell’VIII secolo a.C. lingua delle comunicazioni internazionali nella Mesopotamia) era diventata una sorta di dialetto.
Gesù parlava solo l’aramaico?
Tra queste quattro lingue è ormai certo che quella usata da Gesù per la predicazione e per i colloqui con i discepoli fosse l’aramaico. Come ricorda Rinaldo Fabris, nel suo “Gesù il Nazareno” (Cittadella Editrice), sono almeno una ventina i passi dei Vangeli canonici (scritti in greco) in cui vengono citate parole o espressioni aramaiche. Per limitarci a quelle che riguardano la Settimana Santa: “Abba” (Padre), usato da Gesù nel Getsemani; “Eloi Eloi lemà sabachtani” (Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato) cioè le ultime parole di Cristo sulla croce secondo Marco e Matteo; il toponomastico Golgotha (“Luogo del cranio”) per indicare l’altura della crocifissione; e infine l’appellativo “rabbunì” (maestro mio) con cui Maria di Madgala chiama Gesù dopo la risurrezione. E a proposito di vittoria sulla morte, possiamo citare ancora il “talità qum”, (ragazza alzati) con cui Cristo riporta in vita la figlia di Giairo.
Del resto è naturale: cresciuto ed educato in una modesta famiglia della Galilea che abitava a Nazareth, villaggio di poche centinaia di abitanti, Egli certamente aveva come lingua materna l’aramaico occidentale che si parlava nella sua terra. Tra l’altro connotato da accento diverso da quello in uso a Gerusalemme, come attesta il “riconoscimento” di Pietro, nella notte dell’arresto di Gesù (Mt 26,73) proprio a motivo di come parlava.
L’aramaico, scelta di incarnazione
Questo fatto ci dice già una cosa importante. La concretezza dell’incarnazione vale per tutti gli aspetti della vita. Gesù si esprime in un idioma che tutti possono comprendere e poco importa se non è la lingua dei dotti. Anzi proprio questa vicinanza ai “piccoli”, al punto da parlare in “dialetto”, conferma se mai ce ne fosse bisogno la sua “rivoluzione” delle periferie, come direbbe papa Francesco. Il quale, parlando ai genitori dei bambini che stava battezzando nella Cappella Sistina il 7 gennaio 2018, raccomandò: “La trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto, la lingua intima delle coppie. Nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna”. E non è un caso che un grande santo e teologo come Tommaso d’Aquino abbia predicato il quaresimale del 1273 in dialetto napoletano.
Le ipotesi sull’ebraico e il greco
Ciò che resta ancora incerto è se Gesù sapesse parlare nelle altre lingue. Almeno l’ebraico e il greco. Quanto all’ebraico, bisogna registrare un simpatico siparietto durante la visita di papa Francesco in Medio Oriente nel 2014. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante un incontro ufficiale, disse al Pontefice: «Gesù ha vissuto qui, parlava ebraico». «Aramaico», lo corresse Francesco. Al che Netanyahu, immediatamente, precisò: «Parlava aramaico ma conosceva l’ebraico, perché leggeva le Scritture». Al di là dei cordiali sorrisi che chiusero l’episodio, viene da chiedersi: è proprio così?
 Secondo Fabris, “sulla base delle scarne informazioni del Vangeli non si è in grado di dare una risposta categorica alla domanda se Gesù sapesse leggere e scrivere”. E anche l’episodio riferito da san Luca, in cui nella sinagoga di Nazareth Egli prende e legge il rotolo del profeta Isaia, “non può essere addotto come prova che egli è in grado di leggere il testo ebraico della Bibbia”. Probabilmente infatti, argomenta lo studioso, quel racconto è il frutto di una rielaborazione dell’evangelista al quale interessa dire che Gesù è il Messia.
Secondo Fabris, “sulla base delle scarne informazioni del Vangeli non si è in grado di dare una risposta categorica alla domanda se Gesù sapesse leggere e scrivere”. E anche l’episodio riferito da san Luca, in cui nella sinagoga di Nazareth Egli prende e legge il rotolo del profeta Isaia, “non può essere addotto come prova che egli è in grado di leggere il testo ebraico della Bibbia”. Probabilmente infatti, argomenta lo studioso, quel racconto è il frutto di una rielaborazione dell’evangelista al quale interessa dire che Gesù è il Messia.Tuttavia questo punto non è pacifico fra gli esegeti. Stefano Tarocchi, biblista e preside emerito della Facoltà Teologica dell’Italia centrale, nota infatti che “diversi altri racconti dei Vangeli favoriscono la teoria secondo cui Gesù era in grado di servirsi anche dell’ebraico quando la situazione lo richiedeva”. Soprattutto le conversazioni e discussioni con capi religiosi ebrei. “Questi dialoghi di solito avvenivano in ebraico anche tra chi aveva come prima lingua l’aramaico. Per essere credibile come interlocutore, con molta probabilità Gesù usava l’ebraico quando era impegnato in discorsi teologici con i farisei, gli scribi e gli altri capi ebrei”.
Quanto al greco, alcuni esegeti hanno ipotizzato che Gesù potesse conoscerlo, dato che vicino a Nazaret c’erano Sepphoris, capitale della tetrarchia di Erode Antipa, e Tiberiade, centro commerciale di una certa importanza, dove i mercanti greci arrivavano facilmente. Ma Fabris esclude un’ipotesi del genere, così come la possibilità che egli abbia conversato o insegnato in greco.
In che lingua parlarono Pilato e Gesù durante il processo?
Più possibilista è invece Tarocchi, citando la conversazione con il centurione romano di Matteo 8,5-13. “Anche Pilato nel processo - afferma - avrebbe usato il greco, non il latino, come ha invece immaginato Mel Gibson in The Passion. Non è nemmeno ipotizzabile che un governatore romano abbia potuto conoscere ed usare l’aramaico”. Tuttavia il dialogo potrebbe essersi svolto con l’intermediazione di un interprete (anche se nei Vangeli non se ne fa menzione), perché quello a Gesù non era certamente l’unico processo che Pilato fece nella sua carriera e la registrazione di un particolare così scontato può essere stata considerata superflua.
L’importanza del greco per l’evangelizzazione
Il greco però sicuramente entra in scena - e pesantemente - dopo la risurrezione. Soprattutto grazie alle lettere di Paolo, che sono i documenti più antichi del Nuovo Testamento, tutto scritto nell’”inglese” dell’epoca.
A questo punto il cambio di priorità, e dunque di paradigma anche linguistico, appare evidente. Alla logica dell’incarnazione si affianca quella dell’universalità del messaggio evangelico, che essendo destinato a tutti gli uomini, ha bisogno di un veicolo comunicativo il più possibile conosciuto. Il greco, appunto, che diviene così la lingua della “fase due” dell’evangelizzazione, dopo il primo annuncio del Nazareno. A quel punto l’idioma originale parlato da da Gesù diventa secondario, quasi ininfluente.
 "Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio", esclameranno i presenti alla predicazione degli Apostoli, il giorno di Pentecoste. La voce di Cristo raggiunge ognuno nel suo linguaggio, secondo la doppia regola dell’incarnazione e dell’universalizzazione del messaggio della salvezza. E non è un caso che la Bibbia sia oggi il libro tradotto nel maggior numero di lingue al mondo.
"Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio", esclameranno i presenti alla predicazione degli Apostoli, il giorno di Pentecoste. La voce di Cristo raggiunge ognuno nel suo linguaggio, secondo la doppia regola dell’incarnazione e dell’universalizzazione del messaggio della salvezza. E non è un caso che la Bibbia sia oggi il libro tradotto nel maggior numero di lingue al mondo. -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- La dimensione messianica, il Salmo 2, e la categoria di "Figlio di Dio" (di Luigino Bruni)..4 aprile 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra /2.
La mano che abbassa il ponte
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 4 aprile 2020)
- C’è qualcosa di grandioso nel vivere nella speranza, ma allo stesso tempo c’è in esso qualcosa di profondamente irreale. Diminuisce il valore specifico dell’individuo, che non può mai realizzarsi pienamente, perché l’incompletezza segna le sue imprese
- Gershom Scholem, L’idea messianica nell’ebraismo
«Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano?». Con questa domanda inizia il Salmo 2. Una domanda tremenda che i profeti e i sapienti ripetono da millenni: perché nonostante la vocazione alla pace e al benessere iscritta nel cuore di ogni persona e delle comunità, gli uomini continuano a esercitarsi nell’arte della guerra, a seminare e coltivare discordia e inimicizia? Le civiltà restano vive finché non si stancano di ripetere questa domanda.
Siamo trasportati dal salmo dentro un ambiente di ribellione, in una congiura di popoli nei confronti di un re - «Spezziamo le catene, gettiamo via da noi il giogo» (2,2). Questo re non è un sovrano qualunque: «E i prìncipi congiurano insieme contro il Signore e il suo unto» (2). Il protagonista del salmo è il Messia, l’unto di YHWH, mistero e anelito di tutta la Bibbia. Il salmo dice che i popoli cospirano «invano», e che di queste congiure «ride Colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro» (4). È molto probabile che il Salmo 2 sia stato scritto dopo l’Esilio, quando la monarchia in Israele non c’era più e il popolo aveva sperimentato la distruzione, la sconfitta, la deportazione. Aveva sentito sulla propria pelle la forza tremenda delle trame di potere e di conquista dei popoli, e lì aveva capito che la verità del loro Dio non coincideva con la vittoria sui nemici. L’esilio fu infatti il grande tempo in cui gli ebrei impararono che un Dio sconfitto può restare un Dio vero.
Perché allora quell’«invano»? Nonostante l’esperienza della sconfitta e della violenza che prevale sulla pace, la Bibbia qui e altrove annuncia l’avvento di un Messia, e quindi di un tempo nuovo finalmente diverso, giusto e buono. Più la realtà si allontana dal tempo messianico, più occorre annunciarlo. Credere e affermare una verità quando la storia e il presente dicono tutt’altro: è questo il vero ruolo della grande spiritualità, che è sempre incarnata, che parla della nostra vita soprattutto nei tempi nei quali l’evidenza dice l’opposto delle sue parole. È negli esili che si fanno i sogni più grandi.
L’attesa del Messia è un’anima profonda dell’intera Bibbia. La troviamo nei profeti, nei libri storici, e ora nei salmi. È una forma concreta che assume in essa la speranza. Questa attesa ha tenuto vivo il futuro e lo ha custodito come giudizio sul presente e come possibilità di liberazione.
Se si perde la dimensione messianica della storia, la vita individuale e sociale accorcia il suo orizzonte, si schiaccia tutta sul presente, si spegne la gioia e si abbuia la libertà. Ci riempiamo di piccole attese perché abbiamo ucciso quella più grande. Il capitalismo ha racchiuso il Messia nella merce (come aveva capito Marx), e così lo ha cancellato. Il messianesimo biblico è l’anno giubilare della storia, quel tempo diverso che diventa criterio morale per giudicare le prassi di tutti gli altri tempi. Il Messia resta tale finché non è ancora venuto. È il sovrano del non-ancora, il suo tempo è l’ideale che misura il tempo reale, un ideale che è profezia della storia. C’è un rapporto profondo tra profezia e messianesimo: entrambi sono dentro e fuori la storia, reale e ideale, già e non ancora. E quando si perde questa tensione vitale e paradossale, il messianesimo si identifica in questo o in quel leader politico e la profezia diventa profezia di corte - sta anche qui il senso di quell’anima critica nei confronti della monarchia che è ben presente e operante nei libri storici della Bibbia.
Per usare le parole di Jacob Taubes, il messianesimo biblico ci ricorda che «il ponte levatoio si trova sull’altra sponda ed è dall’altra sponda che devono comunicarci che siamo liberi». Ci dice quindi che se esiste una dimensione fondamentale della libertà che è auto-liberazione, in altre sue dimensioni decisive la libertà è invece liberazione per mano di qualcuno che abbassa per noi il ponte levatoio. La Bibbia ha custodito nei secoli questa dimensione della libertà come liberazione, l’ha scritta come suo primo comandamento, e così ci ha protetti dall’auto-inganno frequentissimo di immaginare libertà senza avvertire più il bisogno di una voce diversa dalla nostra che ci chiama e ci salva. Sta qui uno dei sensi di quella che chiamiamo salvezza. Grazie a questa attesa tenace del Messia, nella Bibbia il futuro non diventò «un tempo omogeneo e vuoto: perché ogni secondo era la porta da cui poteva passare il Messia» (Walter Benjamin).
Un errore grave e frequente dei cristiani è allora pensare che l’attesa del Messia sia finita con la venuta di Cristo, dimenticando che egli deve venire ogni giorno e deve ritornare. La liturgia è il grande luogo dove ciò che è stato si incontra con ciò che è e che sarà: in ogni Sabato Santo preghiamo che il sepolcro torni ancora vuoto e ogni resurrezione accade oggi. Nella Bibbia ricordare è verbo al futuro.
Molto noto e forte è il versetto 7 del Salmo: «Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato"». Una frase splendida, molto amata anche nel Nuovo Testamento e nel cristianesimo, dove la categoria di "Figlio di Dio" è divenuta un pilastro teologico. In questo salmo (e altrove nella Bibbia ebraica) scopriamo, tra l’altro, che chiamare Dio con l’appellativo di Padre e concepire la condizione umana come figliolanza non è una invenzione del cristianesimo ma eredità biblica.
Ma è quell’oggi che ci conquista - «oggi ti ho generato». Qui non c’è solo, forse, un’antica traccia di un canto composto per la consacrazione di un nuovo re in Israele; in questo "oggi" ci possiamo leggere anche qualcosa di diverso e di più. C’è il paradigma di ogni vocazione spirituale, che è una figliolanza che si manifesta dentro un primo oggi che si ripete in tutti gli oggi dell’esistenza, perché una vocazione è viva solo nel presente, e in questo presente continuo si incontra l’eternità.
Ogni paternità e ogni maternità umana è poi una generazione declinata al presente. È ripetere per tutta la vita: «Oggi ti ho generato» - «Ma ora che sei morta, o madre, io so le volte che mi hai generato. In silenzio, non vista d’alcuno» (David Maria Turoldo). Ogni generazione è ri-generazione, e ciò che è vivo se non si rigenera degenera. La paternità-maternità ci dice, simbolicamente (quindi realmente), che siamo vivi e capaci di generare perché oggi siamo rigenerati. Il giorno che tutti smetteranno di generarci inizieremo a morire. Per la Bibbia il principio, l’origine di questa generazione-rigenerazione sempre attuale è Dio, che quindi diventa il garante di quella mutua generazione che scandisce il ritmo della vita. Fino alla fine, quando nell’ultimo oggi ci sorprenderemo di vedere scendere il ponte levatoio e passeremo, indenni, sopra i coccodrilli.
Dopo aver udito pronunciare la promessa del Messia-figlio, eccoci precipitati in un altro paesaggio ampio e profondo: «Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in possesso i confini della terra» (8). Questo «chiedimi» ricorda l’invito rivolto da Dio a Salomone nell’oggi della sua chiamata: «Chiedimi ciò che vuoi» (1 Re 3,4). Salomone chiese la cosa più bella («Un cuore che sa ascoltare»: 9). Non sappiamo invece cosa chiese quel re dell’antico salmo; sappiamo però la promessa ivi contenuta, che se è diventata salmo allora, è promessa universale: le genti e la terra sono anche nostra eredità e nostro possesso. Sono l’eredità e il possesso di chi prega i salmi, che oggi, mentre li canta si deve riscoprire erede di tutte le genti e possessore dell’intera terra. Nell’umanesimo biblico, però, tutta la terra è di YHWH, e gli uomini sono soltanto utilizzatori e amministratori (economi). E dunque ogni proprietà è seconda e ogni possesso è imperfetto. La promessa è vera perché è imperfetta, o perché la completezza sta nella sua incompletezza.
Ogni figlio è erede, e quindi i figli di Dio sono eredi di tutto il cielo e di tutta la terra. Lo abbiamo intuito, e ci siamo sentiti eredi. Ma ci siamo dimenticati dell’incompiutezza, siamo diventati padroni della terra, l’abbiamo profanata, siamo diventati, molte volte, mercenari.
Dentro la stessa tradizione e promessa, un giorno Gesù di Nazareth ci disse qualcos’altro di nuovo e di importante su questa speciale eredità: «Beati i miti, perché erediteranno la terra». La mitezza è anche il riconoscimento dell’incompiutezza e della provvisorietà dell’esistenza e dei nostri possessi. Il mite abita il mondo senza diventarne predatore, possiede senza concupiscenza, usa i beni con castità. Il mite è custode della terra e del fratello. È l’anti-Caino. Solo una custodia mite può amministrare l’eredità della terra e far sì che i figli siano eredi di un patrimonio non sperperato.
La mitezza è virtù delle mani - mansueto, cioè "abituato alla mano", docile alla mano del pastore, come sa fare l’agnello. La custodia mite non è stata quella della nostra generazione. Ma oggi ci siamo improvvisamente ritrovati dentro una inondazione di mitezza, in un oceano di mansuetudine. Questo tempo tremendo sta diventando il tempo dei miti. Quello di chi sa restare a casa, di chi sa stare, docile, sotto le mani di medici e infermieri. Stiamo vedendo molte mani abbassare ponti su sponde che prima sembravano irraggiungibili.
«E ora siate saggi, o sovrani; lasciatevi correggere, o giudici della terra; servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore» (Salmo 2,10-12). Le ultime parole del salmo ci donano una nuova beatitudine per questo tempo: «Beato chi in lui si rifugia».
-
> GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- Il nuovo «Padre Nostro» - con la formula: "Non abbandonarci alla tentazione" - arriva in Avvento, a partire dal 29 novembre (di Riccardo Maccioni).28 gennaio 2020, di Federico La Sala
TEOLOGIA ED ESTETICA. I volti della Grazia... *
La preghiera.
Il nuovo «Padre Nostro» arriva in Avvento
La preghiera con la formula: "Non abbandonarci alla tentazione" anziché "Non indurci in tentazione" sarà recitata durante le Messe a partire dal 29 novembre
di Riccardo Maccioni (Avvenire, martedì 28 gennaio 2020)
Per il “nuovo” Padre Nostro ci vuole ancora un po’ di pazienza. La traduzione rinnovata della più popolare delle preghiere, insegnata direttamente da Gesù, sarà inserita nel Messale che verrà consegnato subito dopo Pasqua, quest’anno il 12 aprile.
A rivelarlo è stato il teologo Bruno Forte arcivescovo di Chieti-Vasto parlando all’AdnKronos a margine del forum internazionale sul rapporto tra estetica e teologia in corso alla Pontificia Università Lateranense.
Come noto il Padre Nostro nella nuova versione prevede che l’invocazione “Non indurci in tentazione” lasci al posto alla più corretta formulazione “Non abbandonarci alla tentazione”. Versione, ha aggiunto monsignor Forte, che verrà recitata durante le Messe nella chiese italiane a partire dal 29 novembre, prima Domenica d’Avvento.
Leggi anche
Intervista.Arriva il «nuovo» Padre Nostro, ma per la Messa ci vorrà un po’
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?!
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- “Nuova versione Cei del Padre Nostro in uso dal 29 novembre". Intervista a monsignor Bruno Forte (di Federico Piana).28 gennaio 2020, di Federico La Sala
Bruno Forte: “Nuova versione Cei del Padre Nostro in uso dal 29 novembre"
L’arcivescovo di Chieti-Vasto e teologo annuncia le date dell’uscita del nuovo messale con la preghiera modificata e spiega le motivazioni che hanno spinto i vescovi italiani a cambiare il ‘non indurci in tentazione’: “Dio ci ama, non ci tende trappole per cadere nel peccato”
Federico Piana - Città del Vaticano *
E’ monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, presidente della Conferenza abruzzese-molisana e noto teologo, ad annunciare in anteprima che “il Messale con la nuova versione del Padre Nostro voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana uscirà qualche giorno dopo la prossima Pasqua”. Nella preghiera, l’invocazione a Dio ‘non indurci in tentazione’ è stata modificata con una traduzione ritenuta più appropriata: ‘non abbandonarci alla tentazione’. “L’uso liturgico sarà introdotto a partire dalle Messe del 29 novembre di quest’anno, prima domenica d’Avvento”.
Monsignor Forte, perché i vescovi italiani hanno deciso la modifica di una delle più antiche e conosciute preghiere cristiane?
R. - Per una fedeltà alle intenzioni espresse dalla preghiera di Gesù e all’originale greco. In realtà l’originale greco usa un verbo che significa letteralmente ‘portarci, condurci’. La traduzione latina ‘inducere’ poteva richiamare l’omologo greco. Però, in italiano ‘indurre’ vuol dire ‘spingere a..’ in sostanza, far sì che ciò avvenga. E risulta strano che si possa dire a Dio ‘non spingerci a cadere in tentazione’. Insomma, la traduzione con ‘non indurci in...’ non risultava fedele.
E allora i vescovi italiani hanno pensato di trovare una traduzione migliore...
R. - Un interrogativo che si sono posti anche episcopati di tutto il mondo. Ad esempio, in spagnolo, lingua più parlata dai cattolici nel pianeta, si dice ‘fa che noi non cadiamo nella tentazione’. In francese, dopo molti travagli, si è passati da una traduzione che era ‘non sottometterci alla tentazione’ alla formula attuale che è ‘non lasciarci entrare in tentazione’. Dunque, l’idea da esprimere è questa: il nostro Dio, che è un Dio buono e grande nell’amore, fa in modo che noi non cadiamo in tentazione. La mia personale proposta è stata che si traducesse in ‘fa che non cadiamo in tentazione’ però dato che nella bibbia Cei la traduzione scelta è stata ‘non abbandonarci alla tentazione’ alla fine i vescovi per rispettare la corrispondenza tra il testo biblico ufficiale e la liturgia hanno preferito quest’ultima versione.
Molti teologi e pastori hanno fatto notare che la vecchia espressione ‘non ci indurre in tentazione’ facesse riferimento alle prove che Dio permette nella nostra vita...
R. - Una cosa è la prova, in generale, ma il termine che si trova nella preghiera del Padre Nostro è lo stesso che viene usato nel Vangelo di Luca nel riferimento alle tentazioni di Gesù, che sono vere tentazioni. Allora, non si tratta semplicemente di una qualunque prova della vita ma di vere tentazioni. Qualcosa o qualcuno che ci induce a fare il male o ci vuole separare dalla comunione con Dio. Ecco perché l’espressione ‘tentazione’ è corretta ed il verbo che le corrisponde deve essere un verbo che faccia comprendere che il nostro è un Dio che ci soccorre, che ci aiuta a non cadere in tentazione. Non un Dio che in qualunque modo ci tende una trappola. Questa è un’idea assolutamente inaccettabile.
Questo cambiamento provocherà qualche problema ai fedeli abituati alla vecchia versione?
R. - Sostanzialmente, la modifica è molto limitata. Non credo che dovrebbero esserci grossi problemi. Dobbiamo aiutare le persone a capire che non si tratta di voler un cambiamento fine a se stesso ma di cambiare per pregare in maniera ancora più consapevole e vicina a quelle che sono state le intenzioni di Gesù.
* Fonte: Vatican News, 28.01.2020.
-
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! - L’ICONA UNIVERSALE DEL CATTOLICESIMO ROMANO: LA "SANTA FAMIGLIA DI GESù, MARIA E GIUSEPPE"-29 dicembre 2019, di Federico La Sala
ECUMENISMO E PROBLEMA DELL "UNO" ... *
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Contemplando con fede la casa di Nazareth ogni credente può scorgervi un modello
di Matteo Liut (Avvenire, domenica 29 dicembre 2019)
La vita nasce da una relazione che si apre all’infinito, perché ogni essere umano che viene al mondo è segno dell’amore sconfinato di Dio. La famiglia è scrigno prezioso che ha la responsabilità di dare forma a questa continua promessa di futuro.
Oggi il rito romano pone la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, icona universale di un’intimità domestica portatrice di un messaggio rivoluzionario: Dio abita in mezzo a noi. Contemplando la casa di Nazareth ogni credente non può non scorgervi un’ispirazione e un modello: i piccoli gesti di cura e attenzione vissuti tra quelle mura testimoniano lo stile dell’agire di Dio nella storia. Ecco perché per i cristiani farsi compagni di strada degli ultimi significa prima di tutto essere luce di speranza e di amore per le persone più vicine: tutti abbiamo bisogno di aprirci continuamente alla vita attraverso relazioni d’amore.
 Altri santi. San Davide, re (X sec. a.C.); san Tommaso Becket, martire (1118-1170).
Altri santi. San Davide, re (X sec. a.C.); san Tommaso Becket, martire (1118-1170).
 Letture. Sir 3,3-7.14-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
Letture. Sir 3,3-7.14-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
 Ambrosiano. Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14.
Ambrosiano. Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO".NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FLS
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- Il presepe del "lasciamo riposare mamma". Il Papa all’udienza generale: il presepe è Vangelo domestico18 dicembre 2019, di Federico La Sala
L’udienza. Il Papa: il presepe è Vangelo domestico
Francesco all’udienza generale: porta il Vangelo nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e nelle case di cura, nelle carceri, nelle piazze
di Redazione Internet (Avvenire, mercoledì 18 dicembre 2019)
- [Foto] L’udienza di Francesco stamani in Aula Paolo VI - Vatican Media
«Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio. Dio sempre è stato vicino al suo popolo, ma quando si è incarnato, è nato, è stato troppo vicino, molto vicino, vicinissimo: è riscoprire che Dio è reale, concreto, vivo e palpitante». Lo ha detto il Papa, che nella catechesi dell’udienza di oggi, sulla scorta della sua recente lettera apostolica e a una settimana dal Natale, ha ribadito che «il presepe infatti è come un Vangelo vivo»: «Porta il Vangelo nei posti dove si vive: nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e nelle case di cura, nelle carceri e nelle piazze. E lì dove viviamo ci ricorda una cosa essenziale: che Dio non è rimasto invisibile in cielo, ma è venuto sulla Terra, si è fatto uomo, un bambino».
«Dio non è un signore lontano o un giudice distaccato, ma è amore umile, disceso fino a noi», ha fatto notare il Papa: «Il Bambino nel presepe ci trasmette la sua tenerezza. Alcune statuine raffigurano il Bambinello con le braccia aperte, per dirci che Dio è venuto ad abbracciare la nostra umanità. Allora è bello stare davanti al presepe e lì confidare al Signore la vita, parlargli delle persone e delle situazioni che abbiamo a cuore, fare con lui il bilancio dell’anno che sta finendo, condividere le attese e le preoccupazioni».
Preparasi al Natale facendo il presepe
«In questi giorni, mentre si corre a fare i preparativi per la festa, possiamo chiederci: "Come mi sto preparando alla nascita del Festeggiato?"», ha esordito il Papa. «Un modo semplice ma efficace di prepararsi è fare il presepe. Anch’io quest’anno ho seguito questa via: sono andato a Greccio, dove san Francesco fece il primo presepe, con la gente del posto. E ho scritto una lettera per ricordare il significato di questa tradizione. Cosa significa il presepe nel tempo di Natale».
Leggi anche
- Lettera apostolica.Papa Francesco a Greccio: ecco il vero significato del presepe
- Abusi sui minori.Papa Francesco abolisce il segreto pontificio
Facendo il presepe «possiamo anche invitare la Sacra Famiglia a casa nostra, dove ci sono gioie e preoccupazioni, dove ogni giorno ci svegliamo, prendiamo cibo e siamo vicini alle persone più care» ha detto il Papa. «Accanto a Gesù vediamo la Madonna e san Giuseppe», l’immagine evocata da Francesco: «Possiamo immaginare i pensieri e i sentimenti che avevano mentre il Bambino nasceva nella povertà: gioia, ma anche sgomento».
 «La parola presepe letteralmente significa mangiatoia, mentre la città del presepe, Betlemme, significa casa del pane», ha ricordato il Papa: «Mangiatoia e casa del pane: il presepe che facciamo a casa, dove condividiamo cibo e affetti, ci ricorda che Gesù è il nutrimento essenziale, il pane della vita. È Lui che alimenta il nostro amore, è Lui che dona alle nostre famiglie la forza di andare avanti e di perdonarci».
«La parola presepe letteralmente significa mangiatoia, mentre la città del presepe, Betlemme, significa casa del pane», ha ricordato il Papa: «Mangiatoia e casa del pane: il presepe che facciamo a casa, dove condividiamo cibo e affetti, ci ricorda che Gesù è il nutrimento essenziale, il pane della vita. È Lui che alimenta il nostro amore, è Lui che dona alle nostre famiglie la forza di andare avanti e di perdonarci».Il presepe del "lasciamo riposare mamma"
«Il presepe è attuale, è l’attualità di ogni famiglia» ha aggiunto Francesco "a bracci". «Ieri mi hanno regalato un’immaginetta di un presepe speciale, piccolina - ha raccontato - e si chiamava "lasciamo riposare mamma". E c’era la Madonna addormentata e Giuseppe col bambinello lì, facendolo addormentare. Quanti di voi dovete dividere la notte tra marito e moglie per il bambino o la bambina che piange, piange, piange! Lasciate riposare mamma: la tenerezza di una famiglia, del matrimonio».
Francesco ha sottolineato infine che «il presepe ci ricorda che Gesù viene nella nostra vita concreta». «E questo è importante - ha aggiunto -: fare un piccolo presepe a casa,sempre, perché è il ricordo che Dio è venuto da noi, nato da noi, ci accompagna nella vita, è uomo come noi, si è fatto uomo come noi. Nella vita di tutti i giorni non siamo più soli. Egli abita con noi. Non cambia magicamente le cose ma, se lo accogliamo, ogni cosa può cambiare».
«Vi auguro allora - ha concluso il Papa - che fare il presepe sia l’occasione per invitare Gesù nella vita. Quando noi facciamo il presepe a casa è come aprire la porta e dire "Entra Gesù". È fare concreta questa vicinanza, questo invito a Gesù perché venga nella nostra vita. Perché se lui abita la nostra vita, essa rinasce. E se la vita rinasce è davvero Natale. Buon Natale a tutti».
«Grazie per gli auguri» ricevuti nei giorni scorsi
Al termine dell’udienza Francesco ha ringraziato «quanti in questi giorni, da tante parti del mondo, mi hanno inviato messaggi augurali per il 50/o di sacerdozio e per il compleanno. Grazie soprattutto per il dono della preghiera».
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- ADMIRABILE SIGNUM. "Il mirabile segno": Lettera apostolica di papa Francesco sul significato e il valore del presepe.1 dicembre 2019, di Federico La Sala
 LETTERA APOSTOLICA
LETTERA APOSTOLICA
 Admirabile signum
Admirabile signum
 DEL SANTO PADRE
DEL SANTO PADRE
 FRANCESCO
FRANCESCO
 SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE *
SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE *1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata.
2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe.
 Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.
 Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
 Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. -La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. -La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.
 Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».[3]
Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».[3]3. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. D’altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel silenzio.
 Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
 Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
 In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).4. Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere il senso che portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita. -Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi interrogativi Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della sofferenza (cfr Lc 1,79).
 Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.
Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.5. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano preannunciato i profeti, che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore.
 «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. -A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. -A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.6. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi.
 I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. -Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. -Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
 7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
 Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.
Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.8. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque.
 La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
 «La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. -Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.
«La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. -Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.9. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel presepe le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi in cammino verso Betlemme per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi regali hanno un significato allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù; l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa umanità che conoscerà la morte e la sepoltura.
 Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia.
Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia.
 I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.
I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.10. Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.
Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, settimo del pontificato.
FRANCESCO
 [1] Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468.
[1] Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468.
 [2] Cf. ibid., 85: FF, n. 469.
[2] Cf. ibid., 85: FF, n. 469.
 [3] Ibid., 86: FF, n. 470.
[3] Ibid., 86: FF, n. 470.
 [01938-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[01938-IT.01] [Testo originale: Italiano]
* Fonte: Lettera apostolica. Papa Francesco a Greccio: ecco il vero significato del presepe di Mimmo Muolo, Avvenire, 30.11.2019 (ripresa parziale).
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- BANGKOK (THAILANDIA). Tracce per una svolta antropolòogica e teologica.23 novembre 2019, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.... *
- THAILANDIA. "Ad accogliere il Papa tantissimi, al St. Louis Hospital di Bangkok. L’incontro è nel grande auditorium con da una parte il ritratto del re e della regina, dall’altro una immagine di Gesù con la Vergine Maria (cfr.: G. Cardinale, Papa in Thailandia: bambine costrette a prostituirsi, sfigurata dignità , Avvenire, giovedì 21 novembre 2019)
- Pianeta Terra. A che "gioco" si gioca? Tracce per una svolta antropologica: lezione di Dante: Due Soli, di Freud: Edipo, Pirandello: la notte di Natale, e ... del Vaticano: Tebe, la città della regina-madre Giocasta e del figlio-re Edipo!!!
Il viaggio.
Papa in Thailandia: bambine costrette a prostituirsi, sfigurata dignità
Francesco nell’omelia della messa allo Stadio nazionale di Bangkok tocca la piaga della prostituzione, anche minorile, legata al turismo sessuale, piaga particolarmente sentita in Thailandia
di Gianni Cardinale, inviato in Thailandia (Avvenire, giovedì 21 novembre 2019)
Questa mattina primo bagno di folla per Papa Francesco nella sua visita in Thailandia. Siamo al St. Louis Hospital di Bangkok, fiore all’occhiello della diocesi ed eccellenza nel campo sanitario del Paese. E’ stato fondato 120 anni fa e ad accogliere il Papa sono in tantissimi: medici, infermiere, impiegati, operai con i loro familiari, semplici fedeli. Tutti con la bandierina thai e della Santa Sede. Questo è l’ultimo dei tre appuntamenti della mattinata.
 L’incontro è nel grande auditorium con da una parte il ritratto del re e della regina, dall’altro una immagine di Gesù con la Vergine Maria.
L’incontro è nel grande auditorium con da una parte il ritratto del re e della regina, dall’altro una immagine di Gesù con la Vergine Maria.- [Foto] Bambini durante la visita di Papa Francesco al Saint Louis Hospital in Bangkok (Ansa)
"Tutti voi, membri di questa comunità sanitaria - dice Papa Bergoglio -, siete discepoli missionari quando, guardando un paziente, imparate a chiamarlo per nome". "I vostri sforzi e il lavoro delle tante istituzioni che rappresentate sono la testimonianza viva della cura e dell’attenzione che siamo chiamati a dimostrare per tutte le persone, in particolare per gli anziani, i giovani e i più vulnerabili", aggiunge. E poi ricorda come in questi 120 anni di vita del St. Louis "quante persone hanno ricevuto sollievo nel loro dolore, sono state consolate nelle loro oppressioni e accompagnate nella loro solitudine!”. Di qui il grazie “per il dono della vostra presenza nel corso di questi anni”, e la richiesta “di far sì che questo apostolato, e altri simili, siano sempre più segno ed emblema di una Chiesa in uscita che, volendo vivere la propria missione, trova il coraggio di portare l’amore risanante di Cristo a coloro che soffrono". La visita del Papa si chiude con un incontro privato con alcuni malati.
In precedenza il Papa ha già incontrato le autorità politiche del Paese e ha visitato la principale autorità buddista della Thailandia. Nel discorso rivolto ai rappresentanti del governo, al corpo diplomatico e ai leader politici al Government House ribadisce che “la crisi migratoria non può essere ignorata". "La stessa Tailandia, - sottolinea - nota per l’accoglienza che ha concesso ai migranti e ai rifugiati, si è trovata di fronte a questa crisi dovuta alla tragica fuga di rifugiati dai Paesi vicini” (QUI IL DISCORSO) . Di qui il rinnovato auspicio “che la comunità internazionale agisca con responsabilità e lungimiranza”, in modo da risolvere “i problemi che portano a questo tragico esodo” e a promuovere “una migrazione sicura, ordinata e regolata”.
Nel suo intervento Francesco rivolge anche un pensiero "quelle donne e a quei bambini del nostro tempo che sono particolarmente feriti, violentati ed esposti ad ogni forma di sfruttamento, schiavitù, violenza e abuso".
 Esprime la sua “riconoscenza al governo tailandese per i suoi sforzi volti ad estirpare questo flagello, come pure a tutte le persone e le organizzazioni che lavorano instancabilmente per sradicare questo male e offrire un percorso di dignità”.
Esprime la sua “riconoscenza al governo tailandese per i suoi sforzi volti ad estirpare questo flagello, come pure a tutte le persone e le organizzazioni che lavorano instancabilmente per sradicare questo male e offrire un percorso di dignità”.Auspica che nascano sempre più “artigiani dell’ospitalità”, uomini e donne che “si prendano cura dello sviluppo integrale di tutti i popoli, in seno a una famiglia umana che si impegni a vivere nella giustizia, nella solidarietà e nell’armonia fraterna". E invita a coniugare libertà Thai (vuol dire proprio questo) e solidarietà, afinché “le persone e le comunità possano avere accesso all’educazione, al lavoro degno, all’assistenza sanitaria, e in tal modo raggiungere i livelli minimi indispensabili di sostenibilità che rendano possibile uno sviluppo umano integrale".
Dopo l’incontro con il mondo diplomatico e della politica Papa visita il Patriarca Supremo dei Buddisti, Somdej Phra Maha Muneewong, nel Tempio Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram. Qui ribadisce che “il cammino interreligioso” può testimoniare "anche nel nostro mondo, tanto sollecitato a propagare e generare divisioni e esclusioni, che la cultura dell’incontro è possibile” (QUI IL DISCORSO COMPLETO). Perché “quando abbiamo l’opportunità di riconoscerci e di apprezzarci, anche nelle nostre differenze, offriamo al mondo una parola di speranza capace di incoraggiare e sostenere quanti si trovano sempre maggiormente danneggiati dalla divisione".
Il Pontefice rimarca "quanto sia importante che le religioni si manifestino sempre più quali fari di speranza, in quanto promotrici e garanti di fraternità". E ringrazia la Thailandia perché fin dall’arrivo del cristianesimo, circa quattro secoli e mezzo fa, "i cattolici, pur essendo un gruppo minoritario, hanno goduto della libertà nella pratica religiosa e per molti anni hanno vissuto in armonia con i loro fratelli e sorelle buddisti". Tra i doni offerti da Papa Francesco al patriarca buddista dell, vi è "il Documento sulla Fraternità umana di Abu Dhabi".
La mattinata di Papa Francesco in Thailandia si chiude quando in Italia comincia ad albeggiare. Il fuso orario segna sei ore di differenza. Nel pomeriggio di Bangkok si è svolta la visita di cortesia al re e la messa nello Stadio Nazionale.
Nell’omelia della messa, con 60mila fedeli che riempiono lo stadio, papa Francesco torna ad alludere al problema del turismo sessuale. Nell’omelia il Pontefice rivolge un pensiero particolare a "quei bambini, bambine e donne esposti alla prostituzione e alla tratta, sfigurati nella loro dignità più autentica". (QUI L’OMELIA)
E poi anche "a quei giovani schiavi della droga e del non-senso che finisce per oscurare il loro sguardo e bruciare i loro sogni; penso ai migranti spogliati delle loro case e delle loro famiglie". E poi ai tanti altri che "possono sentirsi dimenticati, orfani, abbandonati". E poi "ai pescatori sfruttati, ai mendicanti ignorati". Tutti questi, sottolinea il Papa, "fanno parte della nostra famiglia, sono nostre madri e nostri fratelli".
Da qui un duplice l’appello. Primo: a non privare "le nostre comunità dei loro volti, delle loro piaghe, dei loro sorrisi, delle loro vite". Secondo: non privare "le loro piaghe e le loro ferite dell’unzione misericordiosa dell’amore di Dio". -Infatti "l’evangelizzazione non è accumulare adesioni né apparire potenti, ma aprire porte per vivere e condividere l’abbraccio misericordioso e risanante di Dio Padre che ci rende famiglia".
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Pianeta Terra. A che gioco si gioca? Tracce per una svolta antropologica: lezione di Dante: Due Soli, di Freud: Edipo, Pirandello: la notte di Natale, e ... del Vaticano: Tebe, la città della regina-madre Giocasta e del figlio-re Edipo!!!
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- LA STELLA E IL NARDO. “DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”.11 novembre 2019, di Federico La Sala
“DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE.
 Un commento a De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò
Un commento a De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò
PROVANDO E RIPROVANDO. LA STELLA E IL NARDO... Ricordando quanto sia determinante e fondamentale, oggi, ripensare sul piano antropologico (andrologico e ginecologico) e teologico la figura della “sacra famiglia” e di san Giuseppe (si cfr. i commenti a "Ggimentu, gimmientu e ggimintare" di A. Polito, Fondazione Terra d’Otranto, 06.07.2018), e “come nascono i bambini”, non posso non PLAUDIRE alla realizzazione del “convegno e del libro per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò”, con tutti i suoi molteplici contributi!!!
SUL TEMA DELLA «GIUSEPPOLOGIA», MI SIA LECITO, si cfr.: GESU’ “CRISTO”, GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE (“CHARITAS”) DI GIUSEPPE E DI MARIA!!!
Federico La Sala
-
>GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- “DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”.15 novembre 2019, di Federico La Sala
"GIUSEPPE": "DE DOMO DAVID". Un convegno e un libro ... *
- Melchisedech, i tre anelli, e... la buona-notizia
- "GIUSEPPE", L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI "TRE" MONOTEISMI. Un importante studio di Massimo Campanini sul patriarca d’Israele e sul profeta del Corano. A quando la ri-considerazione e il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica dell’altro Giuseppe, quello ev-angelico?! Freud e Pirandello aspettano ancora
De Domo David e l’edizione di Nardò, dalla Congregazione degli Oblati di San Giuseppe
di padre Alberto Santiago (Fondazione "Terra d’Otranto", 12/11/2019)
Buona serata a voi tutti: saluto cordialmente mons. Filograna, vescovo di Nardò, il Rettore della Confraternita di San Giuseppe Patriarca monsignor Santantonio, le Autorità presenti, il Priore della Confraternita Mino De Benedittis, i sodali e tutti i convenuti.
Porto il saluto della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe fondata da san Giuseppe Marello nel 1870, e di tutto l’ambito giuseppino, che si compone anche della Congregazione di S.Giuseppe fondata da s.Leonardo Murialdo, e vari Istituti femminili, tutti informati ed entusiasti dell’iniziativa che si celebra nella diocesi di Nardò-Gallipoli.
Vengo inoltre come portavoce del Centro Studi del “Movimento Giuseppino” di Roma, che promuove l’interazione tra i devoti di san Giuseppe, per favorire e valorizzare la conoscenza della sua missione nel piano dell’Incarnazione, e animare la vita ecclesiale con la pratica delle virtù evangeliche tipiche di san Giuseppe.
Il sito del «Movimento Giuseppino» si propone di raccogliere e presentare con organicità di contenuti costantemente aggiornati, le informazioni riguardanti san Giuseppe in ogni suo aspetto, provenienti dai vari Centri nazionali e internazionali di studi. Il sito è aperto a ogni forma di confronto e collaborazione da parte di quanti volessero segnalare integrazioni, inesattezze e lacune, ma soprattutto ampliare l’orizzonte delle conoscenze. Sarà senz’altro disponibile a segnalare questa iniziativa di oggi nelle prossime settimane.
Vi trasmetto un fervido augurio poi da parte di p. Tarcisio Stramare, teologo e biblista, la cui opera di approfondimento negli studi teologici su san Giuseppe, e sui relativi documenti pontifici, ha diffuso la conoscenza e la devozione al Custode del Redentore. E’il titolo scelto da papa Giovanni Paolo II per riassumere il ruolo di san Giuseppe nel mistero dell’incarnazione, e risale però a un’antica concezione teologica che può aver ispirato lo scultore dell’angelo sull’altare maggiore di questa chiesa di Nardò: un angelo, appunto, “custode”, come una presenza che protegge dal male e da ogni pericolo. Quale miglior correlazione con la figura di san Giuseppe che porta in salvo il Figlio dalle insidie di Erode? La statua collocata nella parte più alta di questo bellissimo altare rispecchia l’atteggiamento di Giuseppe nei confronti di Gesù, chiamato ad assicurare la sua sopravvivenza e la sua crescita.
La giornata di oggi è punto di arrivo di un progetto, ideato per celebrare i quattrocento anni di vita della Confraternita di San Giuseppe Patriarca a Nardò, di ricerca e di approfondimento sul patrimonio artistico della chiesa, e sulle forme di devozione al santo.
Promosso con il patrocinio della Diocesi di Nardò-Gallipoli, della Fondazione Terra d’Otranto e della Confraternita, il libro che accompagna questo convegno richiama l’attenzione per il suo titolo, lungo come negli incunaboli di una volta: De domo David. La Confraternita di San Giuseppe Patriarca e la sua chiesa a Nardò. Studi e ricerche a quattro secoli dalla fondazione (1619-2019).
Ma sono soprattutto le prime parole a destare la curiosità del lettore: perché De domo David?
Questa espressione ricorre nella liturgia, e si legge nel vangelo di Luca ai versetti 26-27 del primo capitolo: “... missus est angelus Gabriel ... ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph de domo David ...” Possiamo ricordare anche la novena di Natale: “Ecce veniet Deus, et homo de domo David sedere in throno ...”.
Certamente da questi antecedenti deriva il motto della Confraternita di San Giuseppe Patriarca: De domo David, e quindi il titolo del libro, che si legge anche sulla convessa facciata della chiesa.
L’obiettivo di un libro ampiamente illustrato, come questo, è appunto che il lettore possa in qualche misura entrare in relazione con le opere, in modo che ogni immagine sia come uno specchio capace di coinvolgere lo spettatore. E che l’arte diventi una esperienza del mondo che modifica radicalmente chi la fa, ampliando la comprensione che il soggetto ha di sé e della realtà che lo circonda.
Concepito come libro di pregio, fuori commercio e con una tiratura di poche centinaia di copie, il volume curato da Marcello Gaballo e Stefania Colafranceschi è risultato un lavoro di altissima qualità sia per la strutturazione dei materiali, sia per la quantità di illustrazioni (quasi 800) in eccellente risoluzione.
Grazie alla collaborazione spontanea di studiosi in varie città d’Italia e delle diocesi del Salento, si è potuto realizzare un percorso ricco e qualificato, sorprendente per varietà di contributi; vi sono articoli di taglio dottrinale, storico e artistico, e molti contributi da Confraternite, Oratori, Associazioni legate a san Giuseppe. L’elaborato che ne è conseguito si rivela dunque molto rappresentativo.
Non potevamo immaginare questo lungo cammino attraverso il tempo - poiché gli articoli spaziano tra IV e XIX secolo -, come pure le conoscenze emerse sul patrimonio artistico di questa chiesa e i suoi significati.
Ringrazio tutti i collaboratori che hanno messo a frutto le loro competenze e lo spirito di ricerca, dando un apporto importante sul piano culturale nelle sue varie forme, ma anche considerevole per la conoscenza della figura di s. Giuseppe, solo apparentemente secondaria e silenziosa.
Esprimo l’apprezzamento inoltre per la disponibilità della Biblioteca Casanatense di Roma e il Museo Pitrè di Palermo, che hanno fornito materiale di particolare interesse; la Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo per le riproduzioni degli arazzi cinquecenteschi, la Pinacoteca di Brera, la Galleria Nazionale di Parma e tutti i numerosi prestatori delle immagini pubblicate.
Principalmente ringrazio la Confraternita, all’origine di questo ambizioso progetto, e la Fondazione Terra d’Otranto che l’ha sostenuto e realizzato.
Rivolgo i saluti più cordiali agli autori qui presenti: Giovanni Boraccesi -che ha preso in esame gli argenti pugliesi raffiguranti san Giuseppe-, Marino Caringella -che illustra esempi di iconografie giuseppine-, Stefano Cortese -che documenta le antiche pitture parietali nel Salento-, Giuseppe Fai -che tratta la devozione del santo nella sua città di Parabita-, Antonio Faita -che presenta le opere statuarie dei celebri Verzella-, Antonio Solmona -che pone in evidenza alcune iconografie presenti a Galatone- e Stefano Tanisi -che esamina i dipinti nelle diocesi di Otranto e Ugento-, unitamente agli altri collaboratori.
Altri autori, come da programma, esporranno personalmente i propri contributi.
Il lavoro compiuto in questa ricorrenza, che ha fatto scoprire a tutta l’Italia la storia e l’arte di questa chiesa e di questa confraternita, di questa diocesi e della Puglia, è importante per ideare e costruire nuovi traguardi; è augurabile che parte di questo libro sia condiviso nel futuro Simposio internazionale di studi su san Giuseppe, che si terrà tra due anni in Guatemala. E’ una mèta possibile, sulla base delle svariate testimonianze acquisite, e dell’esperienza maturata in itinere.
Le stesse intenzioni mi vengono riferite per una ulteriore presentazione di questo libro a Roma, nella prestigiosa sede dell’antichissima e prestigiosa Biblioteca Casanatense, che come vedrete ha contribuito a realizzarlo mettendo a disposizione centinaia di incisioni e miniature dei secoli XV - XVIII, omaggiando questa chiesa e questa Diocesi.
E centinaia sono anche le rare riproduzioni di canivet di Lo Cicero e santini di Damato, alcuni tra i più importanti collezionisti italiani, che hanno messo a disposizione per la prima volta tante preziosità, accrescendo il prestigio del lavoro editoriale che questa sera presentiamo.
Con questo auspicio invito a far tesoro delle oltre seicento pagine del volume, tutte a colori e in pregevole edizione, e a proiettarsi nel futuro prossimo, in unità di intenti con il mondo giuseppino, che ancora una volta ringrazia per la particolare attenzione che questo lembo d’Italia ha voluto dedicare al santo di cui porta il nome.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
FESTA DI SAN GIUSEPPE E DEL PAPA’ - NON DEL PAPA!!! BASTA CON LA "MALA EDUCACION" E CON LA "MALA FEDE"!!! RESTITUIRE A GIUSEPPE L’ANELLO DEL "PESCATORE" E GIUSEPPE A MARIA E ALLA SUA FAMIGLIA - UMANA E DIVINA!!! LA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE INVESTE L’ AVVENIRE DELL’INTERA UMANITA’, NON QUELLO DEI VESCOVI DELLA CHIESA "CATTOLICA"
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
Federico La Sala
-
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- IL PECCATO ORIGINALE E IL IL MITO DELLE ORIGINI. Che cosa c’era sul leggio di Maria? (di Rosita Copioli).21 ottobre 2019, di Federico La Sala
IL MITO DELLE ORIGINI FAVOLOSE E IL PECCATO ORIGINALE... *
Arte e sacro. Che cosa c’era sul leggio di Maria?
Nelle raffigurazioni dell’Annunciazione il libro su cui legge Maria compare tardi, dal IX secolo. Il filologo Michele Feo va a caccia delle tante ipotesi sul contenuto del volume
di Rosita Copioli (Avvenire, sabato 19 ottobre 2019)
- [Foto] Antonello da Messina, “Vergine Annunciata” (1475 circa), particolare
La storia della Madonna è un meraviglioso romanzo per immagini. Più misteriosa tra tutte l’Annunciazione perché è il mistero stesso di Maria. Ma anche la più rivoluzionaria nella storia dell’umanità, perché fonda il mondo dopo Adamo: il mondo da Gesù Cristo, origine del nostro tempo. E poi perché racchiude tutto il turbamento, anzi lo sconvolgimento, e insieme la concentrata tenerezza della Vergine prima che concepisca e nel suo stesso istante: l’anticipazione dell’aurora, prima che irrompa il giorno in lei, in ognuno di noi.
Le scarne parole di Luca e Matteo non sono prive di immagini potenti, anzi assolute: per Alberto Magno l’ombra non è l’oscurità - che non viene dalla somma luce - ma l’immagine specchiata dell’onnipotenza; tuttavia solo i Vangeli apocrifi ci mostrano le scene, gli oggetti, i simboli, che i pittori prediligono. In essi Maria è alla fonte, al pozzo con la brocca, poi in casa, intenta a filare scarlatto e porpora (colori della regalità) accanto a un vaso dove fiorisce il giglio di Gesù; più tardi ha con sé un libro aperto e talora lo legge.
Sono queste le raffigurazioni che si susseguono dovunque nei secoli, in molteplici varianti. Soprattutto impone infinite riflessioni la presenza del libro, che compare tardi, dal IX secolo, su un cofanetto d’avorio francese dall’aria regale. Perché quella ragazza umile e il libro, che fu strumento di distinzione, non solo per la sapienza, ma nelle classi sociali? E significava soprattutto autorevolezza, garanzia di verità? E cosa era scritto nel libro di Maria, oltre alle parole dei profeti, dei salmi, dei Vangeli, del Magnificat?
Si può rispondere che Maria stessa è un libro, contiene il passato e soprattutto il futuro: un libro profetico al massimo grado. Ma c’è quella commistione di realtà e di sentimenti, che colpisce nel profondo, e non si accontenta di spiegazioni teologiche. In Maria il mistero teologico è reale e carnale, attraversa la vita quotidiana, gli affetti delle madri nelle famiglie, tutte le forme reali e immaginarie, che le madri quotidiane e le divinità femminili hanno mostrato in ogni tempo e spazio.
Michele Feo, filologo e acutissimo investigatore dei testi, ne è stato così commosso e catturato, da inventariarne le immagini per uno studio colto e appassionato (Cosa leggeva la Madonna; Polistampa, pagine 304, euro 20,00). Ma non dobbiamo pensare che l’indagine di Feo si limiti a un excursus erudito che riguarda soltanto l’abbinamento con il libro. Si estende a ogni riflessione che tocca Maria, con una condivisione totale e sottile della femminilità e dei suoi valori più profondi.
Mentre segue nei secoli e nelle contestualizzazioni delle opere le Annunciazioni, decifrando e commentando le iscrizioni e le composizioni, Feo non dimentica mai l’origine. Chi è veramente Maria? Cosa accade nel momento in cui riceve l’annuncio traumatico dell’angelo che ha sconvolto lei fino a noi stessi? Perché l’Annunciazione non è un evento che si conclude, ma un progetto che ci riguarda inesorabilmente? Come sono diventati lontani nei secoli i sensi originari? Come tutto è diventato infinitamente indecifrabile, sebbene continuino a colpirci quegli atti e quei gesti e quelle mani della ragazza non ancora madre, che talora si specchiano nelle mani dell’angelo, o - come nella Vergine Annunciata palermitana di Antonello da Messina - emergono in assoluta eloquenza fuori dal quadro?
La ricchezza di questo libro sta anche nella presentazione di testi preziosi che accompagnano la figura dell’Annunciazione; non solo quelli sacri, o Dante, o Petrarca (di cui Feo è massimo studioso), che nel cammino dell’amore che nobilita attraverso la donna, compie la «rivoluzionaria e decisiva collocazione della Vergine a chiusura dei Rerum vulgarium fragmenta». Feo ci traduce molti testi straordinari: ora popolari, ora dei più sofisticati umanisti che intrecciano la Vergine con le divinità greco-latine, ora di mistici ottocenteschi, ora di teologi moderni. Il valore del libro sta anche nel sapiente dialogo che Feo intrattiene tra culture diverse.
Vorrei aggiungere una testimonianza, che ha origine da due antiche tradizioni romagnole. Esse hanno riscontri nei calendari popolari e nel Tempio malatestiano di Rimini, dove compaiono le due porte che le anime passano: nel segno del Capricorno abbandonano la carne attraverso la porta degli dèi e dell’immortalità; nel segno del Cancro si incarnano. Nell’Annunciazione (e incarnazione) del 25 marzo, nell’equinozio di primavera, Maria è seduta, intenta a filare il lino “marzuolo”. In questa immagine, che riprende il protovangelo di Giacomo, Maria è l’umile donna antica, attenta alla rocca, al fuso, al telaio. Ma rievoca anche archetipi: Elena che in Omero tesse una tappezzeria di porpora con le lotte di Greci e Troiani in cui lei è al centro; Cloto che fila lo stame della vita.
La vigilia di Natale, a Ravenna, in una filastrocca che inizia con l’invocazione «Levati, levati mio sole / con il raggio del Signore», tre angeli donano a Maria tre forcine o tre falci d’oro: lei le porge al Signore, e Lui con queste mette in moto la ruota del cosmo: è la nascita di Gesù e del tempo: il compimento dell’Annunciazione avviene nel solstizio d’inverno, sotto il segno del Capricorno. In sintonia con tradizioni immemoriali, raccolte da quelle platoniche, Maria tra primavera ed estate incarna, mentre nel cuore dell’inverno, con il “sole invitto” libera dalla carne, verso l’eternità.
*
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
Michele Feo, Mio nonno era un re , "Il grande vetro".
- Maria Montessori, Il peccato originale [e "i reattivi psichici"], a cura di Fulvio De Giorgi, Morcelliana, Brescia 2019.
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA...L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò i mosaici" dei "faraoni".
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! --- Sulla divinità di Gesù, il l Vaticano corregge Scalfari (di Riccardo Maccioni).10 ottobre 2019, di Federico La Sala
Sulla divinità di Gesù. il Vaticano corregge Scalfari
Nota della Sala Stampa vaticana: dal fondatore di Repubblica libera e personale interpretazione. La precisazione dopo le sconcertanti e irreali frasi attribuite al Papa sulla divinità di Gesù Cristo
di Riccardo Maccioni (Avvenire, mercoledì 9 ottobre 2019)
Qualcuno stamattina leggendo “La Repubblica” avrà fatto un balzo sulla sedia. Nel suo commento al Sinodo intitolato “Francesco e lo spirito dell’Amazzonia” il fondatore del quotidiano Eugenio Scalfari attribuisce infatti al Papa riflessioni e opinioni quanto meno sconcertanti.
 In particolare Scalfari scrive: «Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo».
In particolare Scalfari scrive: «Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo».E a conferma di quanto appena detto, il giornalista e filosofo, passa in rassegna, modificandola anche un po’, la Passione di Gesù, soffermandosi in particolare sul grido di Cristo in croce, tratto dal Vangelo di Marco che riprende il Salmo 22: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Un’invocazione che Scalfari riassume in “Signore mi hai abbandonato”. «Quando mi è capitato di discutere queste frasi - aggiunge Scalfari - papa Francesco mi disse: “Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio”». Davvero, quella di Scalfari, un’interpretazione troppo libera e palesemente irreale, al punto da meritarsi una “correzione”.
Arrivata con una nota del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: «Come già affermato in altre occasioni, le parole che il dottor Eugenio Scalfari attribuisce tra virgolette al Santo Padre durante i colloqui con lui avuti non possono essere considerate come un resoconto fedele di quanto effettivamente detto, ma rappresentano piuttosto una personale e libera interpretazione di ciò che ha ascoltato, come appare del tutto evidente da quanto scritto oggi in merito alla divinità di Gesù Cristo».
Del resto per capire che le espressioni attribuite al Pontefice non potevano essere reali sarebbe bastato recuperare le parole del Papa, ripetute in più occasioni. Poteva essere sufficiente anche solo riprendere pochi passaggi dell’udienza generale del 18 dicembre 2013: «Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente. La presenza di Dio in mezzo all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia così com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane».
Concetti ribaditi a Caserta il 28 luglio 2014: «L’Apostolo Giovanni è chiaro: “Colui che dice che il Verbo non è venuto nella carne, non è da Dio! È dal diavolo”. Non è nostro, è nemico! Perché c’era la prima eresia - diciamo la parola fra di noi - ed è stata questa, che l’Apostolo condanna: che il Verbo non sia venuto nella carne. No! L’incarnazione del Verbo è alla base: è Gesù Cristo! Dio e uomo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, vero Dio e vero uomo».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- Cosa significa Gesù per me (di Mohandas Karamchand Gandhi - 1941),3 ottobre 2019, di Federico La Sala
Cosa significa Gesù per me
di Mohandas Karamchand Gandhi *
Benché io abbia dedicato gran parte della mia vita allo studio della religione e alla discussione con i capi religiosi di tutte le fedi, riconosco molto bene di non poter non sembrare presuntuoso nel momento in cui mi accingo a scrivere di Gesù Cristo e a cercare di spiegare ciò che Lui significa per me. (...)
... Egli è stato sicuramente il più alto esempio di chi ha desiderato di dare tutto senza chiedere in cambio niente e senza interessarsi a quale sarebbe stato il credo che avrebbe professato il ricevente. Sono sicuro che se Lui in questo momento vivesse tra gli uomini, Egli benedirebbe le vite di molti di coloro che forse non hanno mai sentito il Suo nome, se soltanto le loro vite incarnassero le virtù delle quali Lui è stato l’esempio vivente sulla terra, la virtù di amare il prossimo come se stessi e del fare del bene e della carità tra i propri simili.
 Allora, cosa può significare per me Gesù? Per me Egli è stato uno dei più grandi maestri che l’umanità abbia mai conosciuto.
Allora, cosa può significare per me Gesù? Per me Egli è stato uno dei più grandi maestri che l’umanità abbia mai conosciuto.
 Secondo i Suoi credenti Egli è stato l’Unigenito Figlio di Dio. Ma il fatto che io accetti o meno questa convinzione può far sì che Gesù abbia maggiore o minore influenza nella mia vita? È forse che tutta la grandezza dei Suoi insegnamenti e della Sua dottrina devono essermi vietati? Non posso crederci.
Secondo i Suoi credenti Egli è stato l’Unigenito Figlio di Dio. Ma il fatto che io accetti o meno questa convinzione può far sì che Gesù abbia maggiore o minore influenza nella mia vita? È forse che tutta la grandezza dei Suoi insegnamenti e della Sua dottrina devono essermi vietati? Non posso crederci.Per me ciò implica una nascita spirituale. In altre parole, la mia interpretazione è che nella vita di Gesù vi è la chiave della Sua vicinanza a Dio e che Egli espresse, come nessun altro ha saputo fare, lo spirito e la volontà di Dio. È in questo senso che io Lo vedo e Lo riconosco come Figlio di Dio.
(...)
E poiché la vita di Gesù ha quel senso e quella trascendenza ai quali io ho alluso, credo che Egli appartenga non soltanto al cristianesimo ma al mondo intero, a tutte le razze e a tutti i popoli, poco importa sotto quale bandiera, nome o dottrina essi possano lavorare o professare una fede o adorare un dio ereditato dai propri avi.[1]
*
[1] Mohandas Karamchand Gandhi, Cosa significa Gesù per me, «Modern Review», ottobre 1941. Pubblicato in Mohandas Karamchand Gandhi, La forza della verità. Scritti etici e politici, Edizioni Sonda, Torino 1991, vol. I, pp. 458-460 .
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI. Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche.21 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! ---Andrej Rublëv e "La Trinità" (José Tolentino Mendonça). Note.17 giugno 2019, di Federico La Sala
LA TRINITA’ DI ADAMO ED EVA O LA TRINITA’ DI GIUSEPPE E MARIA?! Al di là della Trintà edipica....*
La Trinità
di José Tolentino Mendonça (Avvenire, domenica 16 giugno 2019)
Come si rappresenta il mistero? Noi ci accostiamo a esso a tastoni, consapevoli che i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre immagini vacillano e arrivano appena a intravvederne, poveramente, la realtà. Ma questo nostro tentativo di approssimazione costituisce comunque un importante patrimonio di fede.
Pensiamo ad Andrej Rublëv: siamo nella seconda metà del XV secolo quando egli crea quella che sarà la più celebre icona della Trinità. Il testo biblico soggiacente (Gen 18,1-15) è quello dell’ospitalità che Abramo offre ai tre personaggi celesti che lo visitano. Nella contemplazione di questa stupenda icona della Trinità, l’orante viene condotto al centro del mistero di Dio.
In effetti, ciò che vien lì focalizzato è il Dio unico, un solo Dio con la stessa natura divina in tre persone. I tratti fisionomici coincidono esattamente, come se fosse la medesima figura mostrata per tre volte, anche se in tre posizioni differenti.
I personaggi hanno lo stesso volto, lo stesso atteggiamento del corpo, le stesse ali. Inoltre, tutti hanno in mano uno scettro e posseggono un’aureola per indicare eguali dignità e regalità.
Ciascun personaggio, però, occupa una posizione differente nello spazio e sono diversi i gesti, i colori degli abiti e il gioco degli sguardi.
Il Padre, da cui proviene ogni benedizione, guarda all’umanità attraverso il Figlio. E il Figlio guarda a noi attraverso lo Spirito Santo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- PROVANDO E RIPROVANDO. LA STELLA E IL NARDO .... Ripartire dalle radici moderne, eu-angeliche e francescane -dal "presepe"!
"NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
>GESU’... MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- UNA CORRENTE DI GRAZIA. Santa Sede: nasce "Charis" per il Rinnovamento Carismatico Cattolico.7 giugno 2019, di Federico La Sala
Santa Sede: nasce Charis per il Rinnovamento Carismatico Cattolico
CHARIS in Vaticano. Il nostro sogno è fare comunione. Ce lo chiede il Papa
I responsabili del Rinnovamento Carismatico Cattolico si incontrano in Vaticano da oggi fino a sabato 8 giugno per pregare insieme in attesa dell’apertura ufficiale di Charis
di Emanuela Campanile (Vatican News, 06 giugno 2019)
Città del Vaticano Si sono dati appuntamento in Vaticano - Aula Paolo VI - e arrivano da tutto il mondo. Sono più di 550 e sono i responsabili del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Vogliono pregare insieme e mettersi all’ascolto dello Spirito Santo in attesa dell’inizio ufficiale di Charis previsto proprio domenica 9 giugno: solennità di Pentecoste. Voluto espressamente da Papa Francesco, Charis (Catholic Charismatic Renewal International Service) segna una nuova tappa per il Rinnovamento Carismatico Cattolico come corrente di grazia nel cuore della Chiesa.
Il Charis
Si tratta di un servizio di comunione tra tutte le realtà del Rinnovamento Carismatico Cattolico che, nel mondo, conta attualmente più di 120 milioni di cattolici che vivono l’esperienza del battesimo nello Spirito in gruppi di preghiera, comunità, scuole di evangelizzazione, reti di comunicazioni e ministeri vari. Quando nella solennità di Pentecoste prenderà ufficialmente il via, l’Iccrs e il Catholic Fraternity cesseranno di esistere.
Rinnovamento come corrente di grazia
"Il nostro sogno è fare ciò che il Papa ci ha chiesto", spiega nell’intervista Jean-Luc Moens, il professore belga nominato moderatore di Charis. "Lui parla del Rinnovamento carismatico come di una corrente di grazia nella Chiesa, riprendendo l’espressione dal cardinale Suenens, il quale voleva sottolineare che il Rinnovamento Carismatico non è un movimento, perché - prosegue il professore - in un movimento c’è un’appartenenza; le persone sono o dentro o fuori. Dunque, c’è una separazione.
 Una corrente di grazia è un’altra cosa. Il cardinale faceva il paragone con la corrente del Golfo nell’Atlantico che riscalda tutto l’oceano e poi sparisce. Allora, forse posso dire qualcosa di abbastanza strano, ma -
conclude - il nostro sogno è quello di sparire quando tutta la Chiesa avrà scoperto il battesimo nello Spirito Santo".
Una corrente di grazia è un’altra cosa. Il cardinale faceva il paragone con la corrente del Golfo nell’Atlantico che riscalda tutto l’oceano e poi sparisce. Allora, forse posso dire qualcosa di abbastanza strano, ma -
conclude - il nostro sogno è quello di sparire quando tutta la Chiesa avrà scoperto il battesimo nello Spirito Santo". -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- Dio, natura, umanità. Dialogo tra un vescovo e un giornalista (di Francesco D’Agostino).19 maggio 2019, di Federico La Sala
Lettera per amore.
Dialogo tra un vescovo e un giornalista: Dio, natura, umanità
di Francesco D’Agostino (Avvenire, sabato 18 maggio 2019)
Ammirevole la lettera che il vescovo Luigi Bettazzi, emerito di Ivrea, scrive a Corrado Augias, provocandolo, con amicizia, sul tema dei temi, quello di Dio e del nostro rapporto con Lui. Augias, diversamente da altri giornalisti e saggisti del suo spessore, non ha mai eluso il tema della religione, anzi lo ha affrontato più di una volta, anche in scritti di ampio respiro, senza però mai volersi compromettere personalmente e fino in fondo con questa tema.
Bettazzi non scrive ad Augias per metterne in discussione la spiritualità, ma per esortarlo a respingere la tentazione dell’ateismo e a considerarsi piuttosto agnostico: infatti, chi (come Augias) dà prova di credere nella libertà, nella bellezza, nella giustizia, crede fondamentalmente nel bene, anche se non vuole o comunque esita a chiamarlo ’Dio’. Agli agnostici, intesi nel senso che si è detto, conclude il vescovo, si può voler bene; mentre voler bene agli atei è davvero difficile.
La risposta di Augias nella rubrica che tiene su ’la Repubblica’ (pubblicata martedì scorso, 14 maggio 2019) è sobria e limpida: grato per l’attenzione che gli viene rivolta, egli ribadisce che il suo atteggiamento fondamentale è quello di prendere le distanze da tutti i dogmi, dai riti, dai catechismi, dai testi sacri e soprattutto da quell’immagine di Dio, come ’super-padre’, occulto e onnipotente governatore del creato, che le religioni inevitabilmente veicolano.
L’immagine di Dio è ormai uscita dagli scenari del nostro tempo, insiste Augias, ma non per questo ci mancano efficaci surrogati di questa immagine, surrogati tra i quali sembra che egli prediliga un’immagine vagamente spinoziana della natura, come epifania di Dio («Deus sive natura»). Il giornalista-scrittore riconosce che l’amore per la terra, per l’acqua, per l’aria non è un perfetto surrogato della religione, ma può comunque essere sufficiente per giustificare una spiritualità «matura e pacifica», rispettosa del prossimo e dell’ambiente e in fondo non molto diversa da quella percepita ed espressa da san Francesco di Assisi.
Il ’naturalismo’ di Augias non ci deve naturalmente meravigliare troppo: è perfettamente in sintonia con l’ecologismo dominante nella cultura contemporanea. Né ci deve meravigliare il riportare il naturalismo allo spirito francescano. Non è la prima volta che questo nesso viene istituito, anche se ha ben poco fondamento: l’amore di san Francesco per la natura è direttamente conseguente al suo amore per il creato e il creato, nello spirito francescano (e ovviamente non solo nello spirito francescano, ma in generale nella spiritualità cristiana), va amato proprio in quanto ’creato’, come portatore dell’immagine di Dio. Se togli Dio, o lo metti tra parentesi, del creato resta solo il paradigma materialistico e meccanicistico che pervade tanta parte della scienza contemporanea. La materia può anche essere ammirata, e una pari ammirazione possiamo nutrire nei confronti degli algoritmi che la strutturano; ma tra l’ammirazione e l’amore c’è una distanza su cui non dovremmo mai smettere di riflettere.
Il cuore della questione è che l’essenza della religione (e penso, in particolare, alla religione cristiana) non consiste nel costruire un’immagine di Dio come Ente supremo o come super-Padre e nel predicare la nostra doverosa sottomissione ai suoi comandi, bensì nel ricevere e nell’accogliere un Vangelo, una buona notizia, tanto semplice quanto sconvolgente: siamo creati e siamo amati da Dio senza alcun merito da parte nostra e questo amore, assolutamente immeritato, chiede di essere ricambiato.
La natura ci nutre, ci tiene in vita, ci affascina, ma non ci ama; dobbiamo rispettarla, prendercene cura, al limite anche venerarla, ma non dobbiamo illuderci: è la stessa natura, nel cui contesto veniamo al mondo, che ci condanna a morte. Solo l’amore è promessa di vita e solo l’amore gratuito di Dio è promessa di vita eterna. Augias ha ragione, quando afferma che oggi la domanda stessa se Dio esista per tanti «è», o sembra, «uscita di scena». Ciò però che non può uscire di scena è il bisogno di amore che ogni persona, anche la più violenta e arrogante, nutre nel segreto del cuore. Ateismo e agnosticismo sono nobili concetti teoretici, l’amore è un’esigenza vitale. Forse è proprio da qui che bisogna dare inizio alla nuova evangelizzazione, della quale da tanto tempo si parla.
SUL TEMA, BEL SITO, SI CFR.:
Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... Francesco D’Agostino (dall’Avvenire) vuole dare lezioni a Rosy Bindi e mostra solo tutto il livore di un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio con "Mammona"!!!
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’, IL FIGLIO DELL’AMORE DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! - O IL FIGLIO DELLA "DIADE"?! NEL REGNO DI EDIPO: "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE", L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO.8 maggio 2019, di Federico La Sala
NEL REGNO DI EDIPO: "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE", L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO... *
- APPELLO DI DONNE CRISTIANE CONTRO IL CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE ( Il paese delle donne on line - Rivista, 25.03.2019).
- "A me e a voi, suppongo, è chiaro che prima della famiglia, comunque intesa, c’è la diade formata da una donna e dalla creatura che lei ha concepito e portato al mondo" (Luisa Muraro, "Appello di una femminista alle donne cristiane che sono contro il Congresso mondiale delle famiglie", "www.libreriadelledonne.it", 29.03 2019)
Appello di una femminista alle donne cristiane che sono contro il Congresso mondiale delle famiglie
di Luisa Muraro (Libreria delle donne, 29 Marzo 2019) *
Care amiche, vorrei sottoscrivere il vostro Appello contro il Congresso delle famiglie a Verona. Sono d’accordo con quello che dite, in primo luogo che la famiglia non è un’entità naturale ma un’istituzione culturale, che quasi sempre mostra una forte impronta patriarcale.
A me e a voi, suppongo, è chiaro che prima della famiglia, comunque intesa, c’è la diade formata da una donna e dalla creatura che lei ha concepito e portato al mondo. È un rapporto molto speciale, che precede i dualismi tipici della cultura maschile: la donna che accetta di entrare nella relazione materna, alla sua creatura dà la vita e insegna a parlare, le due cose insieme. Ed è un “insieme” che si tende, come un ponte insostituibile, sopra l’abisso della schizofrenia umana.
Vorrei ma non posso sottoscrivere il vostro Appello perché, nella difesa delle nuove forme familiari, non c’è una critica di quelle che si costituiscono da coppie che, sfortunatamente o naturalmente sterili, invece di adottare, si fanno fare la creatura a pagamento.
Da donne cristiane, mi aspettavo una calorosa difesa dell’adozione e un’energica richiesta della sua estensione a persone e coppie finora escluse dalla legge. Ma, ancor più, essendo voi donne, mi aspettavo una difesa della relazione materna libera e responsabile così come oggi è diventata possibile. Invece, parlate solo di genitorialità, usate cioè una parola tipica del linguaggio neutro-maschile. E a voi che parlate del corpo femminile come luogo di spiritualità incarnata, chiedo: che famiglia è mai quella che nasce con il programma esplicito, messo nero su bianco, di cancellare la relazione materna che si sviluppa con la gestazione in un intimo scambio biologico e affettivo?
Voi, a differenza di tanti cattolici, leggete la Bibbia e sapete che la cosiddetta gravidanza per altri, ossia la donna che partorisce senza diventare madre, corrisponde pari pari ad antiche usanze del patriarcato, usanze che sembravano superate. Le ultime pagine del Contratto sessuale di Carole Pateman, parlano proprio di questo sostanziale arretramento. Detto alla buona, ci sono “nuove” famiglie che di nuovo hanno solo la tecnologia.
A proposito: che cosa pensano di tutto questo gli uomini vicini a voi, i vostri compagni di fede e d’impegno politico? Perché non compaiono nel vostro Appello? Mi è venuto un sospetto, di ritrovarmi davanti a quel noto comportamento maschile che è di nascondersi dietro a una o più donne quando si vuol far passare pubblicamente qualcosa che è contro le donne. Devo portare degli esempi? Ma, se questo non fosse vero, scusatemi.
* www.libreriadelledonne.it, 29 marzo 2019
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. COME NASCONO I BAMBINI? - E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!
Cultura e civiltà. L’ordine simbolico della madre.....
 NEL REGNO DI EDIPO. L’ordine simbolico di "mammasantissima"
NEL REGNO DI EDIPO. L’ordine simbolico di "mammasantissima""L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE": L’ALLEANZA CATTOLICO-"EDIPICA" DEL FIGLIO CON LA MADRE!!!
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
DOC.
APPELLO DI DONNE CRISTIANE CONTRO IL CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Le donne presenti all’incontro nazionale sul tema “I nostri corpi di donne, da luogo del dominio patriarcale a luogo di spiritualità incarnata” (Roma dal 22 al 24 marzo 2019 - Casa Internazionale delle donne), manifestano il profondo sconcerto per il sostegno che alcune Istituzioni politiche e religiose hanno dato al Congresso mondiale delle famiglie, che vuole riportarci su posizioni retrograte e omofobe.
Siamo donne che da molti anni hanno intrapreso un percorso per liberarsi dalle gabbie di un sistema religioso, sociale e politico, impregnato di patriarcato.
Quanto lavoro per uscire da un mondo di istituzioni, di segni, di linguaggi che continuamente riproducono una immagine stereotipata della donna “sposa e madre”, una disparità di poteri, di diritti, di autorevolezza.
Che tristezza adesso constatare che alcune Istituzioni pubbliche patrocinano un Congresso mondiale sulla famiglia impropriamente definita “naturale”.
C’è ben poco di naturale in questa istituzione sociale fondata sul matrimonio nata come forma di contratto sociale e religioso, in un determinato contesto storico.
La famiglia “naturale” non esiste, esiste una struttura familiare che ha dato molto alla società, ma che ora è in crisi e in cambiamento. Non serve uno sguardo nostalgico al passato, serve il coraggio di dire che possono esistere vari modelli di famiglia che sperimentano forme anche nuove di solidarietà, genitorialità basate sull’amore e il rispetto reciproci.
Denunciamo che gli slogan utilizzati e gli obiettivi proposti sono la quint’essenza del dominio patriarcale, responsabile della violenza sulle donne, di cui ci siamo liberate e di cui non vogliamo il ritorno.
Chiediamo quindi che le istituzioni pubbliche non finanzino e non diano il patrocinio a iniziative discriminatorie e intolleranti.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- "Il Vangelo. Pregare trasforma in ciò che si contempla" (Ermes Ronchi).16 marzo 2019, di Federico La Sala
«Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Ma come un vitello d’oro di Mammona ("caritas") o come il bambino, figlio dell’Amore ("charitas") di Giuseppe e Maria?! *
Il Vangelo.
Pregare trasforma in ciò che si contempla
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 14 marzo 2019)
 II Domenica di Quaresima
II Domenica di Quaresima
 Anno C
Anno C- In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. [...]
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, verso l’infinito, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti di luce.
 Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l’uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi.
Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l’uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi.
 Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull’abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza.
Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull’abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza.
 Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l’entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell’uomo.
Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l’entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell’uomo.
 Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un’altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar).
Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce.
Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un’altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar).
Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce.
 Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull’ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all’ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull’ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all’ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose. (Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1; Luca 9,28-36)
(Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1; Luca 9,28-36)
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- L’amore di Dio è quello del Padre “che è nei cieli” (Papa Francesco)21 febbraio 2019, di Federico La Sala
Catechesi sul “Padre nostro”: 7. Padre che sei nei cieli
di Papa Francesco *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’udienza di oggi si sviluppa in due posti. Prima ho fatto l’incontro con i fedeli di Benevento, che erano in San Pietro, e adesso con voi. E questo è dovuto alla delicatezza della Prefettura della Casa Pontificia che non voleva che voi prendeste freddo: ringraziamo loro, che hanno fatto questo. Grazie.
Proseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”. Il primo passo di ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un mistero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare Dio mio Padre incomincio il mistero. Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio» (n. 2779).
Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno; come noi, a nostra volta, non saremo mai genitori, o pastori, perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti. Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso o di manipolazione dell’altro. Per questo a volte le dichiarazioni di amore si tramutano in sentimenti di rabbia e di ostilità. Ma guarda, questi due si amavano tanto la settimana scorsa, oggi si odiano a morte: questo lo vediamo tutti i giorni! E’ per questo, perché tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone e alle volte escono e fanno del male.
Ecco perché, quando parliamo di Dio come “padre”, mentre pensiamo all’immagine dei nostri genitori, specialmente se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbiamo andare oltre. Perché l’amore di Dio è quello del Padre “che è nei cieli”, secondo l’espressione che ci invita ad usare Gesù: è l’amore totale che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore, - noi siamo mendicanti di amore, abbiamo bisogno di amore - cercano un luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti!
Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone. La mitologia dice che è figlio di Poros e di Penía, cioè della scaltrezza e della povertà, destinato a portare in sé stesso un po’ della fisionomia di questi genitori. Di qui possiamo pensare alla natura ambivalente dell’amore umano: capace di fiorire e di vivere prepotente in un’ora del giorno, e subito dopo appassire e morire; quello che afferra, gli sfugge sempre via (cfr Platone, Simposio, 203). C’è un’espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la congenita debolezza del nostro amore: «Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce» (6,4). Ecco che cos’è spesso il nostro amore: una promessa che si fatica a mantenere, un tentativo che presto inaridisce e svapora, un po’ come quando al mattino esce il sole e si porta via la rugiada della notte.
Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così debole e intermittente. Tutti ne abbiamo l’esperienza: abbiamo amato ma poi quell’amore è caduto o è diventato debole. Desiderosi di voler bene, ci siamo poi scontrati con i nostri limiti, con la povertà delle nostre forze: incapaci di mantenere una promessa che nei giorni di grazia ci sembrava facile da realizzare. In fondo anche l’apostolo Pietro ha avuto paura e ha dovuto fuggire. L’apostolo Pietro non è stato fedele all’amore di Gesù. Sempre c’è questa debolezza che ci fa cadere. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non trovare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita: l’amore.
Però, esiste un altro amore, quello del Padre “che è nei cieli”. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato - un’ipotesi storica -, c’è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L’amore di Dio è costante. Dice il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16).
 Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.
Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.Nella fame d’amore che tutti sentiamo, non cerchiamo qualcosa che non esiste: essa è invece l’invito a conoscere Dio che è padre. La conversione di Sant’Agostino, ad esempio, è transitata per questo crinale: il giovane e brillante retore cercava semplicemente tra le creature qualcosa che nessuna creatura gli poteva dare, finché un giorno ebbe il coraggio di alzare lo sguardo. E in quel giorno conobbe Dio. Dio che ama.
L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un’altra dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano. Basta dire “Padre nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene.
Pertanto, non temere! Nessuno di noi è solo. Se anche per sventura il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu fossi in rancore con lui, non ti è negata l’esperienza fondamentale della fede cristiana: quella di sapere che sei figlio amatissimo di Dio, e che non c’è niente nella vita che possa spegnere il suo amore appassionato per te.
*
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE -Aula Paolo VI
 Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale). -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! -- LA MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI, IL "MANIFESTO DELLA FEDE" DEL CARDINALE MULLER, E PAPA BERGOGLIO...10 febbraio 2019, di Federico La Sala
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. "VA’, RIPARA LA MIA CASA" *
Il caso.
Il cardinale Müller pubblica un "Manifesto della fede" senza citare il Papa
Il porporato spiega il documento come una risposta a quella che definisce la crescente confusione dottrinaria. Il testo diffuso per primo dal sito web Usa che diede risalto alle accuse di Viganò
di Mimmo Muolo (Avvenire, domenica 10 febbraio 2019)
- [Foto] Il cardinale Gerhard Ludwig Müller (Fotogramma)
Un elenco ragionato di alcune verità della fede cattolica, tratte dal Catechismo. Si presenta così il “Manifesto della fede” scritto dal cardinale Gerhard Ludwig Müller (fino al 2017 prefetto della Congregazione per la dottrina delle fede), diffuso sabato da un sito web Usa (che diede voce alle accuse rivolte al Pontefice da monsignor Carlo Maria Viganò) e nel quale diversi commentatori hanno voluto vedere (forse troppo frettolosamente?) un attacco a Francesco, mai citato. L’estensore del documento esordisce affermando che «dinanzi a una sempre più diffusa confusione nell’insegnamento della fede, molti vescovi, sacerdoti, religiosi e laici della Chiesa cattolica mi hanno invitato a dare pubblica testimonianza verso la Verità della rivelazione». Nei successivi cinque punti in cui è articolato il “Manifesto” (più un appello finale), vengono toccati altrettanti argomenti fondamentali: «Dio uno e trino, rivelato in Gesù Cristo; la Chiesa; l’ordine sacramentale; la legge morale; e la vita eterna».
«L’epitome della fede di tutti i cristiani risiede nella confessione della Santissima Trinità - scrive il cardinale -. La differenza delle tre persone nell’unità divina segna una differenza fondamentale rispetto alle altre religioni. Riconosciuto Gesù Cristo, i fantasmi scompaiono. Egli è vero Dio e vero uomo. Il Verbo fatto carne, il Figlio di Dio è l’unico Salvatore del mondo e l’unico mediatore tra Dio e gli uomini». Perciò «è con chiara determinazione che occorre affrontare la ricomparsa di antiche eresie che in Gesù Cristo vedevano solo una brava persona, un fratello e un amico, un profeta e un esempio di vita morale». Anche il Papa mette spesso in guardia dalla ricomparsa di antiche eresie (il pelagianesimo, ad esempio) e fin dall’inizio del Pontificato ha detto che una Chiesa senza la Croce corre il rischio di diventare una Ong.
A proposito della Chiesa, Müller ricorda che «Gesù Cristo ha fondato la Chiesa come segno visibile e strumento di salvezza, che sussiste nella Chiesa cattolica» e che «diede alla sua Chiesa, che “è nata dal cuore trafitto di Cristo morto sulla croce”, una struttura sacramentale che rimarrà fino al pieno compimento del Regno».
Quanto all’ordine sacramentale, «la Chiesa è in Gesù Cristo il sacramento universale della salvezza». Dunque, scrive il porporato, «non è un’associazione creata dall’uomo, la cui struttura può essere modificata dai suoi membri a proprio piacimento». Il riferimento è anche all’Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» e alle condizioni per riceverla in modo degno. Chi è in peccato grave deve prima accedere alla confessione. «Dalla logica interna del sacramento - afferma il prefetto emerito dell’ex Sant’Uffizio - si capisce che i divorziati risposati civilmente, il cui matrimonio sacramentale davanti a Dio è ancora valido, come anche tutti quei cristiani che non sono in piena comunione con la fede cattolica e pure tutti coloro che non sono debitamente disposti, non ricevano l’Eucaristia». Müller infine invita i pastori a ricordare anche le verità ultime della fede, la vita eterna e il giudizio dopo la morte con «la terribile possibilità che una persona, fino alla fine, resti in contraddizione con Dio: rifiutando definitivamente il Suo amore, essa “si dannerà immediatamente per sempre”». «Tacere su queste e altre verità di fede oppure insegnare il contrario è il peggiore inganno contro cui il Catechismo ammonisce vigorosamente», conclude il porporato.
Il «manifesto» del cardinale Müller.La carità è una e ha più forme
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, domenica 10 febbraio 2019)
Confusione e divisione nella Chiesa sono due termini ricorrenti nei media, che spesso travisano quanto accade nella vigna del Signore. Il testo diffuso sabato 9 febbraio a firma del cardinal Gerhard Müller mi sembra un contributo alla riflessione aperto a successivi approfondimenti per la fede dei credenti, eppure è stato presentato come un intervento, anzi un vero e proprio "manifesto della fede", contro il magistero del Papa e, dunque, contro l’unità della Chiesa. Un’operazione grave e greve.
Parafrasando il beato Antonio Rosmini potremmo dire che nel testo pubblicato ieri da alcuni siti internet di vari Paesi si cerca di declinare la carità intellettuale/dottrinale in conflitto con quella che lo stesso Rosmini denomina «carità pastorale», culmine delle tre forme di carità: temporale (per i bisogni immediati), intellettuale (per la sete di verità), pastorale (per il dono di sé incondizionato). Ora se il cardinale teologo esercita la seconda di queste forme in maniera autentica, non può in nessun modo contrapporsi alla forma suprema di carità, che il Vescovo di Roma esprime nell’oggi della storia. Ricordare la dottrina, purché non si intenda ritenere che il cristianesimo sia esclusivamente "dottrinale", è un servizio per tutta la Chiesa. Esercitare il servizio della carità pastorale è imprescindibile e necessario in un mondo in cui i gesti valgono più delle parole e i fatti più delle teorie.
 La Chiesa di oggi non ha alcun bisogno di divisioni e di contrapposizioni, ma di concordia e di unità: quella unità di cui il Papa è segno. Nonostante una minuscola, ma insistente, campagna di deliberato fraintendimento, le verità della Rivelazione che Müller richiama trovano serena espressione nel magistero dell’attuale pontefice, anche in materia "morale" e in particolare per quanto riguarda la logica sacramentale e il rapporto fra i sacramenti dell’eucaristia e del matrimonio.
La Chiesa di oggi non ha alcun bisogno di divisioni e di contrapposizioni, ma di concordia e di unità: quella unità di cui il Papa è segno. Nonostante una minuscola, ma insistente, campagna di deliberato fraintendimento, le verità della Rivelazione che Müller richiama trovano serena espressione nel magistero dell’attuale pontefice, anche in materia "morale" e in particolare per quanto riguarda la logica sacramentale e il rapporto fra i sacramenti dell’eucaristia e del matrimonio.
 A questo riguardo il cardinale scrive: «Dalla logica interna del sacramento si capisce che i divorziati risposati civilmente, il cui matrimonio sacramentale davanti a Dio è ancora valido, come anche tutti quei cristiani che non sono in piena comunione con la fede cattolica e pure tutti coloro che non sono debitamente disposti, non ricevano la santa Eucaristia fruttuosamente, perché in tal modo essa non li conduce alla salvezza. Metterlo in evidenza corrisponde a un’opera di misericordia spirituale». Né va dimenticato che, in un testo particolarmente significativo a tale riguardo, Müller aveva affermato: «Se il secondo legame fosse valido davanti a Dio, i rapporti matrimoniali dei due partner non costituirebbero nessun peccato grave, ma piuttosto una trasgressione contro l’ordine pubblico ecclesiastico, quindi un peccato lieve». E tutto ciò è in perfetta coincidenza con il dettato dell’Amoris laetitia.
A questo riguardo il cardinale scrive: «Dalla logica interna del sacramento si capisce che i divorziati risposati civilmente, il cui matrimonio sacramentale davanti a Dio è ancora valido, come anche tutti quei cristiani che non sono in piena comunione con la fede cattolica e pure tutti coloro che non sono debitamente disposti, non ricevano la santa Eucaristia fruttuosamente, perché in tal modo essa non li conduce alla salvezza. Metterlo in evidenza corrisponde a un’opera di misericordia spirituale». Né va dimenticato che, in un testo particolarmente significativo a tale riguardo, Müller aveva affermato: «Se il secondo legame fosse valido davanti a Dio, i rapporti matrimoniali dei due partner non costituirebbero nessun peccato grave, ma piuttosto una trasgressione contro l’ordine pubblico ecclesiastico, quindi un peccato lieve». E tutto ciò è in perfetta coincidenza con il dettato dell’Amoris laetitia.La confusione e la divisione sono l’arma diabolica utilizzata non da uomini di Chiesa, autenticamente in ricerca e animati dalle migliori intenzioni, ma da vecchi e nuovi media propensi al sensazionalismo, lobby laiciste e manipoli di ipercritici "interni" che sembrano non avere altro interesse che il discredito su quanto lo Spirito opera nell’attuale momento che la Chiesa cattolica vive. Ecco perché il nostro cuore e la nostra mente non sono affatto turbati da simili operazioni (Gv 14,1), in quanto radicati nella convinzione che la comunità ecclesiale non è, nemmeno in questi anni, guidata da un uomo, ma dallo Spirito, perché:
 «La Chiesa ha in sé del divino e dell’umano. Divino è il suo eterno disegno; divino il principal mezzo onde quel disegno viene eseguito, cioè l’assistenza del Redentore; divina finalmente la promessa che quel mezzo non mancherà mai, che non mancherà mai alla santa Chiesa e lume a conoscere la verità della fede, e grazia a praticarne la santità, e una suprema Providenza che tutto dispone in sulla terra in ordine a lei. Ma dopo ciò, oltre a quel mezzo principale, umani sono altri mezzi che entrano ad eseguire il disegno dell’Eterno: perciocché la Chiesa è una società composta di uomini, e, fino che sono in via, di uomini soggetti alle imperfezioni e miserie dell’umanità. Indi è che questa società, nella parte in cui ella è umana, ubbidisce nel suo sviluppamento e nei suoi progressi a quelle leggi comuni che presiedono all’andamento di tutte le altre umane società. E tuttavia queste leggi, a cui le umane società sono sommesse nel loro svolgersi, non si possono applicare interamente alla Chiesa, appunto perché questa non è una società al tutto umana, ma in parte divina» (Antonio Rosmini, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa). E in essa la verità si fa nella carità, ovvero nell’unità (cf Ef 4,15).
«La Chiesa ha in sé del divino e dell’umano. Divino è il suo eterno disegno; divino il principal mezzo onde quel disegno viene eseguito, cioè l’assistenza del Redentore; divina finalmente la promessa che quel mezzo non mancherà mai, che non mancherà mai alla santa Chiesa e lume a conoscere la verità della fede, e grazia a praticarne la santità, e una suprema Providenza che tutto dispone in sulla terra in ordine a lei. Ma dopo ciò, oltre a quel mezzo principale, umani sono altri mezzi che entrano ad eseguire il disegno dell’Eterno: perciocché la Chiesa è una società composta di uomini, e, fino che sono in via, di uomini soggetti alle imperfezioni e miserie dell’umanità. Indi è che questa società, nella parte in cui ella è umana, ubbidisce nel suo sviluppamento e nei suoi progressi a quelle leggi comuni che presiedono all’andamento di tutte le altre umane società. E tuttavia queste leggi, a cui le umane società sono sommesse nel loro svolgersi, non si possono applicare interamente alla Chiesa, appunto perché questa non è una società al tutto umana, ma in parte divina» (Antonio Rosmini, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa). E in essa la verità si fa nella carità, ovvero nell’unità (cf Ef 4,15).Professore ordinario di Teologia fondamentale
Sul tema, nel sito, si cfr.:
*
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?!
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. "VA’, RIPARA LA MIA CASA"!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- "Battesimo del Signore". Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio (di E. Ronchi).).10 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il cielo si apre
Siamo tutti figli di Dio nel Figlio
di Ermes Ronchi ( Avvenire, giovedì 10 gennaio 2019)
- Battesimo del Signore - Anno C
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il Battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l’unica che suona in mezzo all’anima. E parla parole di vita. «Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere l’uomo nell’oceano dell’Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato.
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro.
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da tutto.
“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l’idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante.
 (Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22).
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
- GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- LA VERA STORIA DEL PRESEPIO. Il ritorno al proprio Io bambino.31 dicembre 2018, di Federico La Sala
LA VERA STORIA DEL PRESEPIO .... *
“[...] Che cos’è esattamente il presepio? Come nasce? Perché ci sono quei personaggi? Che senso ha farlo oggi? Sono tante le domande che s’affollano in questo libro del classicista Maurizio Bettini, Il presepio (Einaudi, pp. 189, € 19). Il suo non è solo un libro di studio, ma anche un libro di memoria. Meglio: un’autobiografia in forma di studio e di racconto. Tutto comincia con una dichiarazione ad apertura di volume: “Non saprei dire da quanti anni ho smesso di fare il presepio. Venti, trenta, anzi molto di più”. Perché interrogarsi oggi su questo “oggetto” tanto da scrivere un libro dotto e complesso? La risposta non viene subito. Prima bisognerà intraprendere un cammino, per quanto una definizione l’autore la dà subito: il presepio è “una finzione fragile, per questo incantevole”.
[...] Corro alla fine, là dove c’è la risposta ai tanti perché di questo viaggio nella storia e nell’antropologia del presepio. De te fabula narratur. Perché mi occupo del presepio?, si chiede l’autore. Perché ho un patto di fedeltà nei confronti di me stesso. Non quello con la religione in cui sono stato allevato, il Cristianesimo - Bettini ha scritto vari libri per manifestare la “superiorità” del politeismo sul monoteismo. La fedeltà a se stessi è quella all’infanzia, alla propria infanzia. Il presepio, non è solo l’infanzia della Divinità, che ha dominato la nostra storia occidentale per due millenni, ma proprio l’infanzia di Maurizio Bettini, e il presepio è il ritorno al proprio Io bambino...”
* Cfr. Marco Belpoliti, “La vera storia del presepio”, “Doppiozero”, 24.12.2018 (https://www.doppiozero.com/materiali/la-vera-storia-del-presepio).
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- IL RE DELL’UNIVERSO. Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve (di Ermes Ronchi).22 novembre 2018, di Federico La Sala
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA.
IL "PADRE NOSTRO" E IL "CRISTO RE": IL REGNO DI DIO-MAMMONA ("CARITAS") O DI DIO-AMORE ("CHARITAS")!? *
"LE VIE DELLA VERITÀ. [...] per la verifica rinascimentale, analizzare la letteratura dei cristiani offesi, a partire dal Contra hypocritas di Poggio Bracciolini fino all’Isola dei papòmani nel Gargantua di Rabelais. In una lettera del 2 luglio 1497 Savonarola esortò un monaco «all’animosa libertà» contro le parole abbiette, ossia agli ordini ipocriti, pur indorate dalla potestà papale, detta suprema o delle Chiavi. Chi passava dalla collera etica contro la menzogna delle parole [...] alla satira beffarda, si soffermava soprattutto sull’evoluzione del titolo papale di servo dei servi di Dio, per dimostrare che avesse preso senso di signore dei signori, «dominus dominantium»: si legga l’Eremita di Antonio de’ Ferraris detto il Galateo. Anzi era pensiero di Michelangelo che servo dei servi si diviene in croce e perciò quel titolo compete solo a Cristo (Rime, n. 298). Per parte mia sono convinto dell’ironia di Raffaello quando nelle Stanze Vaticane figura Pietro scalzo e i papi Giulio II e Leone X nella pompa della gloria" (cfr. Romeo De Maio, Rinascimento senza toga, Alfredo Guida Editore, Napoli, 1999, p. 18).
Il Vangelo
Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 22 novembre 2018)
Gesù Cristo Re dell’Universo
- Anno B
- In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all’altro; Pilato e il potere inesorabile dell’impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna.
Con Gesù invece arriva un’aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare. Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo?
Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re?
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma?
Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei manipolato?
E cerca di portare Pilato su di un’altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io sono dell’altro. Che è differente, è ad un’altra latitudine del cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un’anima di violenza e di guerra, perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce morte. Il mio mondo è quello dell’amore e del servizio che producono vita. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l’essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande è colui che serve.
Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più violento, il più armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero.
La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto dell’uomo, che è un amore diventato visibile.
 Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos’è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è.
Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos’è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è.
 Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell’uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere.
Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell’uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere.Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui come stella del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino.
(Letture: Deuteronomio 7,13-14; Salmo 92; Apocalisse 1,5-8; Giovanni 18,33-37)
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!
- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- E IL "PADRE NOSTRO" CHI E’?! Un "lamento della pace" (Erasmo da Rotterdam, 1517)..19 novembre 2018, di Federico La Sala
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA ...
iL "PADRE NOSTRO"?! Alcune pagine dalla "Querela pacis" (1517)
di Erasmo *
Pochi anni fa, quando il mondo era travolto a prendere le armi da non so quale peste esiziale, alcuni araldi del Vangelo, frati Minori e Predicatori, dal sacro pulpito davano fiato ai corni di guerra e ancor piú infervoravano chi già propendeva per quella follia. In Inghilterra aizzavano contro i Francesi, in Francia animavano contro gli Inglesi, ovunque spronavano alla guerra. Alla pace non incitava nessuno tranne uno o due, a cui costò quasi la vita l’aver soltanto pronunciato il mio nome.
 Prelati consacrati scorrazzavano un po’ dovunque dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivano con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, ora i monarchi ad affrettare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per conto loro. Eppure questa patente pazzia noi l’avvolgemmo in splendidi titoli.
Prelati consacrati scorrazzavano un po’ dovunque dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivano con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, ora i monarchi ad affrettare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per conto loro. Eppure questa patente pazzia noi l’avvolgemmo in splendidi titoli.
 A tal fine sono da noi distorte con somma impudenza - dovrei dire con sacrilegio - le leggi dei padri, gli scritti di uomini santi, le parole della Sacra Scrittura. Le cose sono giunte a tal punto che risulta sciocco e sacrilego pronunciarsi contro la guerra ed elogiare l’unica cosa elogiata dalla bocca di Cristo. Appare poco sollecito del bene del popolo e tiepido sostenitore del sovrano chi consiglia il massimo dei benefici e scoraggia dalla massima delle pestilenze.
A tal fine sono da noi distorte con somma impudenza - dovrei dire con sacrilegio - le leggi dei padri, gli scritti di uomini santi, le parole della Sacra Scrittura. Le cose sono giunte a tal punto che risulta sciocco e sacrilego pronunciarsi contro la guerra ed elogiare l’unica cosa elogiata dalla bocca di Cristo. Appare poco sollecito del bene del popolo e tiepido sostenitore del sovrano chi consiglia il massimo dei benefici e scoraggia dalla massima delle pestilenze.Ormai i sacerdoti seguono perfino le armate, i vescovi le comandano, abbandonando le loro chiese per occuparsi degli affari di Bellona. Ormai la guerra produce addirittura sacerdoti, prelati, cardinali ai quali il titolo di legato al campo sembra onorifico e degno dei successori degli Apostoli. Per cui non fa meraviglia se hanno spirito marziale coloro che Marte ha generato. Per rendere poi il male insanabile, coprono un tale sacrilegio col sacro nome della religione. Sugli stendardi sventola la croce.
 Armigeri spietati e ingaggiati per poche monete a compiere macelli spaventosi innalzano l’insegna della croce, e simboleggia la guerra il solo simbolo che dalla guerra poteva dissuadere.
Armigeri spietati e ingaggiati per poche monete a compiere macelli spaventosi innalzano l’insegna della croce, e simboleggia la guerra il solo simbolo che dalla guerra poteva dissuadere.
 Che hai a che fare con la croce, scellerato armigero? I tuoi sentimenti, i tuoi misfatti convenivano ai draghi, alle tigri, ai lupi. -Quel simbolo appartiene a Colui che non combattendo ma morendo colse la vittoria, salvò e non distrusse; da lí soprattutto potevi imparare quali sono i tuoi nemici, se appena sei cristiano, e con quale tattica devi vincere.
Che hai a che fare con la croce, scellerato armigero? I tuoi sentimenti, i tuoi misfatti convenivano ai draghi, alle tigri, ai lupi. -Quel simbolo appartiene a Colui che non combattendo ma morendo colse la vittoria, salvò e non distrusse; da lí soprattutto potevi imparare quali sono i tuoi nemici, se appena sei cristiano, e con quale tattica devi vincere.
 Tu innalzi l’insegna della salvezza mentre corri alla perdizione del fratello, e fai perire con la croce chi dalla croce fu salvato?
Tu innalzi l’insegna della salvezza mentre corri alla perdizione del fratello, e fai perire con la croce chi dalla croce fu salvato? Ma che! Dai sacri e adorabili misteri trascinati anch’essi per gli accampamenti, da queste somme raffigurazioni della concordia cristiana si corre alla mischia, si avventa il ferro spietato nelle viscere del fratello e sotto gli occhi di Cristo si dà spettacolo della piú scellerata delle azioni, la piú gradita ai cuori empi: se pure Cristo si degni di essere là. Colmo poi dell’assurdo, in entrambe le armate, in entrambi gli schieramenti brilla il segno della croce, in entrambe si celebra il sacrificio. -Quale mostruosità è questa? La croce in conflitto con la croce, Cristo in guerra con Cristo. È un simbolo fatto per atterrire i nemici della cristianità: perché adesso combattono quello che adorano? Uomini degni non di quest’unica croce, ma della croce patibolare.
Ma che! Dai sacri e adorabili misteri trascinati anch’essi per gli accampamenti, da queste somme raffigurazioni della concordia cristiana si corre alla mischia, si avventa il ferro spietato nelle viscere del fratello e sotto gli occhi di Cristo si dà spettacolo della piú scellerata delle azioni, la piú gradita ai cuori empi: se pure Cristo si degni di essere là. Colmo poi dell’assurdo, in entrambe le armate, in entrambi gli schieramenti brilla il segno della croce, in entrambe si celebra il sacrificio. -Quale mostruosità è questa? La croce in conflitto con la croce, Cristo in guerra con Cristo. È un simbolo fatto per atterrire i nemici della cristianità: perché adesso combattono quello che adorano? Uomini degni non di quest’unica croce, ma della croce patibolare.Ditemi, come il soldato può recitare il “Padre nostro” durante queste messe? Bocca insensibile, osi invocare il Padre mentre miri alla gola del tuo fratello? “Sia santificato il tuo nome”: come si potrebbe sfregiare il nome di Dio piú che con queste vostre risse? “Venga il tuo regno”: cosí preghi tu che su tanto sangue erigi la tua tirannide? “Sia fatta la tua volontà, come in cielo, cosí anche in terra”: Egli vuole la pace, tu prepari la guerra.
 “Il pane quotidiano” chiedi al Padre comune mentre abbruci le messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui?
“Il pane quotidiano” chiedi al Padre comune mentre abbruci le messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui?
 Infine come puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il massimo male al fratello?
Infine come puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il massimo male al fratello?*
Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 51-55.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018. Note18 agosto 2018, di Federico La Sala
SACRA FAMIGLIA E CARTE TRUCCATE. GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA...
- Preghiera dei bambini (1870): “Cristo lo voglio io per Padre/ la Madonna la voglio per Madre/ S. Giuseppe lo voglio per fratello,/ I Santi tutti li voglio per parenti / Affinché mi scampino da tutti i cimenti” (http://www.fondazioneterradotranto.it/2018/07/06/ggimentu-gimmientu-e-ggimintare/#comment-96032)
- Dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16).
PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018 *
 Dio, nostro Padre,
Dio, nostro Padre,
 Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
 Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
 Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
 Rendici pazienti e gentili,
Rendici pazienti e gentili,
 Amorevoli e generosi,
Amorevoli e generosi,
 Accoglienti con i bisognosi.
Accoglienti con i bisognosi.
 Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
 Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
 Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
 [facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
 persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
 Aumenta la nostra fede,
Aumenta la nostra fede,
 Rendi forte la nostra speranza,
Rendi forte la nostra speranza,
 Conservaci nel tuo amore,
Conservaci nel tuo amore,
 Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
 Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore,
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, Amen
Amen Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
 San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
 Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
 San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.*Fonte: https://www.worldmeeting2018.ie/WMOF/media/downloads/prayerA4-IT.pdf
* L’Incontro mondiale. «Famiglia, sfida globale». Ecco il senso dell’incontro di Dublino. L’arcivescovo Martin, primate della Chiesa d’Irlanda: Amoris Laetitia, messaggio di misericordia nella complessità. Uno spazio dedicato anche al soloroso tema degli abusi (di Luciano Moia, Avvenire, venerdì 17 agosto 2018: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/famiglia-sfida-globale-ecco-il-senso-di-dublino).
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- Dio si “costruisce una casa” in mezzo agli uomini (di Matteo Liut).8 settembre 2018, di Federico La Sala
Natività della Vergine Maria.
Dio si “costruisce una casa” in mezzo agli uomini
di Matteo Liut (Avvenire, sabato 8 settembre 2018)
Siamo creature chiamate a generare Dio nel mondo, una “missione” vissuta fin dall’inizio della propria esistenza da Maria, che è stata un ponte tra il Creatore e le creature. La festa di oggi, che celebra la natività della Vergine Maria, è legata indissolubilmente a quella del Natale: nella lettura dei Padri, infatti, con la nascita di Maria Dio si “costruisce una casa” in mezzo agli uomini, una dimora che poi lui stesso abiterà nell’Incarnazione.
La ricorrenza odierna è nata in Oriente ed è stata introdotta anche in Occidente da papa Sergio I nel VII secolo. Oggi questa festa è un invito a curare la nostra vita e la nostra interiorità perché è qui che s’incontra Dio. Una lezione “mistica” che i cristiani non devono mai dimenticare se non vogliono ridurre la fede a semplici “buone pratiche”.
Altri santi. Santi Adriano e Natalia, sposi e martiri (IV sec.); san Federico Ozanam, laico (1813-1853).
 Letture. Mi 5,1-4; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23.
Letture. Mi 5,1-4; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23.
 Ambrosiano. Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23 / Gv 20,1-8.
Ambrosiano. Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23 / Gv 20,1-8.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- Gesù ha una famiglia, segnata dalle stesse difficoltà delle altre famiglie, ma capace di aprirsi all’eterno Matteo Liut).26 luglio 2018, di Federico La Sala
IL SANTO DEL GIORNO: GIOACCHINO E ANNA
Gioacchino e Anna.
I volti dell’umanità che sa aprirsi all’eterno
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 26 luglio 2018)
Non è solo il giorno in cui la Chiesa ricorda i nonni di Gesù, i genitori di Maria, ma l’occasione per ricordare che ogni essere umano "è" una storia, è il frutto di un cammino, l’emergere di un senso condiviso, partecipato da chi l’ha preceduto e offerto a chi verrà. I santi Gioacchino e Anna, la cui storia è narrata nei Vangeli apocrifi, rappresentano l’intimità custodita nella vicenda del Dio che si fa uomo: Gesù ha una famiglia, segnata dalle stesse difficoltà delle altre famiglie, ma capace di aprirsi all’eterno. Allo stesso tempo i due nonni santi sono il volto della maestosità dell’annuncio cristiano: nel Risorto si riconciliano le generazioni e si realizza il vero Regno dell’amore che riguarda l’universo intero.
 La devozione per Gioacchino e Anna - celebrati nello stesso giorno solo dal 1584 - si è diffusa prima in Oriente per giungere in Occidente alla fine del primo millennio.
La devozione per Gioacchino e Anna - celebrati nello stesso giorno solo dal 1584 - si è diffusa prima in Oriente per giungere in Occidente alla fine del primo millennio. Altri santi. Sant’Austindo, vescovo (XI sec.); San Giorgio Preca, sacerdote (1880-1962).
Altri santi. Sant’Austindo, vescovo (XI sec.); San Giorgio Preca, sacerdote (1880-1962).
 Letture. Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9.
Letture. Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9.
 Ambrosiano. Gdc 2,18-3,6; Sal 105; Lc 9,51-56.
Ambrosiano. Gdc 2,18-3,6; Sal 105; Lc 9,51-56.
IL SANTO DEL GIORNO: GIOACCHINO E ANNA
Gioacchino e Anna.
Mamma e papà di Maria modello per i genitori
di Matteo Liut (Avvenire, mercoledì 26 luglio 2017)
L’annuncio della nascita di Maria fu per i suoi genitori, Gioacchino e Anna, come la prima goccia che nell’arsura anticipa la pioggia benefica. E quella pioggia è diventata, anche grazie a loro, la speranza di una vita nuova per l’intera umanità. Oggi la Chiesa ricorda così i nonni di Gesù: avanti con gli anni ricevettero dal Cielo il dono di una figlia, aprendosi con saggezza e umiltà a quella novità. "Maria", ovvero "amata da Dio", è il nome che scelsero, un nome nel quale oggi milioni di fedeli si riconoscono e trovano rifugio.
 L’esempio di Gioacchino (il cui nome significa "Dio solleva") e Anna (nome che vuol dire "grazia"), invece, è da sempre indicato come un modello per tutti i genitori, chiamati a guardare ai loro figli come degli autentici doni gratuiti di Dio. -La memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna è stata unificata nel 1584.
L’esempio di Gioacchino (il cui nome significa "Dio solleva") e Anna (nome che vuol dire "grazia"), invece, è da sempre indicato come un modello per tutti i genitori, chiamati a guardare ai loro figli come degli autentici doni gratuiti di Dio. -La memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna è stata unificata nel 1584. Altri santi. Sant’Austindo, vescovo (XI sec.); San Giorgio Preca, sacerdote (1880-1962). Letture. Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9. Ambrosiano. Gdc 2,18-3,6; Sal 105; Lc 9,51-56.
Altri santi. Sant’Austindo, vescovo (XI sec.); San Giorgio Preca, sacerdote (1880-1962). Letture. Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9. Ambrosiano. Gdc 2,18-3,6; Sal 105; Lc 9,51-56.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FILOMENA: "Colei che è amata"... Una spia linguistica dalla revisione del "martirologio romano"!!!
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- Antropologia, cristologia, pedagogia. Una preghiera per "bambini".12 luglio 2018, di Federico La Sala
Jesus. Chi era costui? Antropologia filologia archeologia filosofia teologia cristologia pedagogia ...
- Dopo il "VICISTI, GALILAEE" di Keplero a GALILEO, l’Accademia del Cimento, e l’Unità d’Italia, una preghiera per "bambini" del 1870... *
IL "CIMENTO" DELL’ACCADEMIA GALILEIANA E LA "PIETRA” DEI FILOSOFI: "PROVANDO E RIPROVANDO"!
A riorganizzare le idee, a sollecitare ulteriori riflessioni e approfondimenti sugli importanti e vitali "rapporti tra cemento, cimento e cimentare" ("Ggimentu, gimmientu e ggimintare"), e a non cadere nel delirio di onnipotenza della preghiera nient’affatto evangelica e nient’affatto infantile, troppo “infantile” (“Cristo lo voglio io per Padre/ la Madonna la voglio per Madre/ S. Giuseppe lo voglio per fratello,/ I Santi tutti li voglio per parenti / Affinché mi scampino da tutti i cimenti” - vale a dire, i serpenti-parenti), tenendo conto delle precisazioni del prof. Polito e delle mie "vecchie" note relative al suo articolo "Serpente? Presente",
RICORDO
che il motto della ACCADEMIA DEL CIMENTO ("Accademia dell’esperimento"), nel solco del "Saggiatore" di Galileo Galilei, è
"PROVANDO E RIPROVANDO".
Solo su questa strada, valendosi "del proprio intelletto senza la guida di un altro", con l’uso della propria "bilancetta", è possibile trovare all’interno dalla caverna la "pietra da costruzione" ("lapis philosophorum") e al contempo l’uscita dallo Stato di minorità (Kant).
*
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- L’ORIZZONTE DELLA CIVILTÀ E I DRAMMI CON CUI CONVIVIAMO (di Paolo Farinella, prete).15 giugno 2018, di Federico La Sala
LA STORIA DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.... *
L’ORIZZONTE DELLA CIVILTÀ E I DRAMMI CON CUI CONVIVIAMO
di don Paolo Farinella (la Repubblica, 10 giugno 2018)
«Tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza. Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo (anche) le altre parti soffrono. Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo». Queste parole sono scolpite nell’atrio del Palazzo dell’Onu.
 Parole antiche, di Poeta e di Mistico, Saādi di Shiraz, Iran 1203 - 1291. Nove secoli fa un persiano musulmano esprimeva un pensiero che è ebraico e cristiano. Nella Bibbia, « Adamo » non è nome proprio di persona, ma nome collettivo e significa « Umanità - Genere Umano » , senza aggettivi perché non è occidentale, orientale, del nord o del sud, ma solo universale. L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di « civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.
Parole antiche, di Poeta e di Mistico, Saādi di Shiraz, Iran 1203 - 1291. Nove secoli fa un persiano musulmano esprimeva un pensiero che è ebraico e cristiano. Nella Bibbia, « Adamo » non è nome proprio di persona, ma nome collettivo e significa « Umanità - Genere Umano » , senza aggettivi perché non è occidentale, orientale, del nord o del sud, ma solo universale. L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di « civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.Due giorni fa, di mattina presto, un’amica mi ha inviato due video ripresi nei pressi della Regione Liguria dove dormivano persone per terra, « figlie di Adamo » , carne e sangue « della sua essenza » . Mi sono chiesto se la nostra civiltà non stia regredendo verso la preistoria, verso il nulla.
 Come insegna il secolo XX, secolo di orrori, la barbarie porta all’abisso e inghiotte la Storia in un buco nero senza ritorno. Guardando le immagini di umanità crocifissa nella miseria dell’opulenza attorno al Grattacielo della Regione Liguria, ho pensato istintivamente alle parole del pastore protestante tedesco, Martin Möller, pronunciate nel 1946 in un sermone liturgico: « Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».
Come insegna il secolo XX, secolo di orrori, la barbarie porta all’abisso e inghiotte la Storia in un buco nero senza ritorno. Guardando le immagini di umanità crocifissa nella miseria dell’opulenza attorno al Grattacielo della Regione Liguria, ho pensato istintivamente alle parole del pastore protestante tedesco, Martin Möller, pronunciate nel 1946 in un sermone liturgico: « Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».A Genova sarà restaurata la Lanterna, simbolo della città, faro di luce nel buio e segnale per rotte sicure; a Genova si perseguitano i poveri, i senza dimora, gli sbandati, figli di una società impazzita che crede di potersi chiudere in sé, erigendo muri e fili spinati, mentre si difendono Istituzioni ed Europa. Chi costruisce muri distrugge l’Europa e il proprio Paese, chi perseguita il povero si attira la collera di Dio che è «il Dio degli umili, il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati» (Gdt 14,11).
 La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz. Se oggi, cittadini, uomini e donne, politici e amministratori, vescovi e preti, politici e governanti, sindaci e assessori, credenti e non credenti, docenti e studenti, non si riconoscono laicamente nelle parole che vengono dal lontano Medio Evo, noi abbiamo messo mano alla scure per recidere l’albero su cui siamo seduti.
La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz. Se oggi, cittadini, uomini e donne, politici e amministratori, vescovi e preti, politici e governanti, sindaci e assessori, credenti e non credenti, docenti e studenti, non si riconoscono laicamente nelle parole che vengono dal lontano Medio Evo, noi abbiamo messo mano alla scure per recidere l’albero su cui siamo seduti.
*
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- San Paolo: "Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. [...] Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. [...] Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. (1 Cor., 12-27)
- FORZA "CRISTO RE"! San Paolo: "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16).
"È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi" (Emilio Gentile)
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. "Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka).
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! -21 maggio 2018, di Federico La Sala
PAPA FRANCESCO
MEDITAZIONE MATTUTINA NELLA CAPPELLA DELLA
DOMUS SANCTAE MARTHAE
La Chiesa è donna e madre
Lunedì, 21 maggio 2018
(da: L’Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLVIII, n.114, 22/05/2018)
A Santa Marta, il 21 maggio, Papa Francesco ha celebrato per la prima volta la messa nella memoria della beata Vergine Maria madre della Chiesa: da quest’anno infatti la ricorrenza nel calendario romano generale si celebra il lunedì dopo Pentecoste, come disposto dal Pontefice con il decreto Ecclesia mater della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti (11 febbraio 2018), proprio per «favorire la crescita del senso materno della Chiesa nei pastori, nei religiosi e nei fedeli, come anche della genuina pietà mariana».
«Nel Vangeli ogni volta che si parla di Maria si parla della “madre di Gesù”» ha fatto subito notare Francesco nell’omelia, riferendosi al passo evangelico di Giovanni (19,25-34). E se «anche nell’Annunciazione non si dice la parola “madre”, il contesto è di maternità: la madre di Gesù» ha affermato il Papa, sottolineando che «questo atteggiamento di madre accompagna il suo operato durante tutta la vita di Gesù: è madre». Tanto che, ha proseguito, «alla fine Gesù la dà come madre ai suoi, nella persona di Giovanni: “Io me ne vado, ma questa è vostra madre”». Ecco, dunque, «la maternalità di Maria».
«Le parole della Madonna sono parole di madre» ha spiegato il Papa. E lo sono «tutte: dopo quelle, all’inizio, di disponibilità alla volontà di Dio e di lode a Dio nel Magnificat, tutte le parole della Madonna sono parole di madre». Lei è sempre «con il Figlio, anche negli atteggiamenti: accompagna il Figlio, segue il Figlio». E ancora «prima, a Nazareth, lo fa crescere, lo alleva, lo educa, ma poi lo segue: “La tua madre è lì”». Maria «è madre dall’inizio, dal momento in cui appare nei Vangeli, da quel momento dell’Annunciazione fino alla fine, lei è madre». Di lei «non si dice “la signora” o “la vedova di Giuseppe”» - e in realtà «potevano dirlo» - ma sempre Maria «è madre».
«I padri della Chiesa hanno capito bene questo - ha affermato il Pontefice - e hanno capito anche che la maternalità di Maria non finisce in lei; va oltre». Sempre i padri «dicono che Maria è madre, la Chiesa è madre e la tua anima è madre: c’è del femminile nella Chiesa, che è maternale». Perciò, ha spiegato Francesco, «la Chiesa è femminile perché è “chiesa”, “sposa”: è femminile ed è madre, dà alla luce». È, dunque «sposa e madre», ma «i padri vanno oltre e dicono: “Anche la tua anima è sposa di Cristo e madre”».
«In questo atteggiamento che viene da Maria che è madre della Chiesa - ha fatto presente il Papa - possiamo capire questa dimensione femminile della Chiesa: quando non c’è, la Chiesa perde la vera identità e diventa un’associazione di beneficienza o una squadra di calcio o qualsiasi cosa, ma non la Chiesa».
«La Chiesa è “donna” - ha rilanciato Francesco - e quando noi pensiamo al ruolo della donna nella Chiesa dobbiamo risalire fino a questa fonte: Maria, madre». E «la Chiesa è “donna” perché è madre, perché è capace di “partorire figli”: la sua anima è femminile perché è madre, è capace di partorire atteggiamenti di fecondità».
«La maternità di Maria è una cosa grande» ha insistito il Pontefice. Dio infatti «ha voluto nascere da donna per insegnarci questa strada». Di più, «Dio si è innamorato del suo popolo come uno sposo con la sposa: questo si dice nell’antico Testamento. Ed è «un mistero grande». Come conseguenza, ha proseguito Francesco, «noi possiamo pensare» che «se la Chiesa è madre, le donne dovranno avere funzioni nella Chiesa: sì, è vero, dovranno avere funzioni, tante funzioni che fanno, grazie a Dio sono di più le funzioni che le donne hanno nella Chiesa».
Ma «questo non è la cosa più significativa» ha messo in guardia il Papa, perché «l’importante è che la Chiesa sia donna, che abbia questo atteggiamento di sposa e di madre». Con la consapevolezza che «quando dimentichiamo questo, è una Chiesa maschile senza questa dimensione, e tristemente diventa una Chiesa di zitelli, che vivono in questo isolamento, incapaci di amore, incapaci di fecondità». Dunque, ha affermato il Pontefice, «senza la donna la Chiesa non va avanti, perché lei è donna, e questo atteggiamento di donna le viene da Maria, perché Gesù ha voluto così».
Francesco, a questo proposito, ha anche voluto indicare «il gesto, direi l’atteggiamento, che distingue maggiormente la Chiesa come donna, la virtù che la distingue di più come donna». E ha suggerito di riconoscerlo nel «gesto di Maria alla nascita di Gesù: “Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia”». Un’immagine in cui si riscontra «proprio la tenerezza di ogni mamma con suo figlio: curarlo con tenerezza, perché non si ferisca, perché stia ben coperto ». E «la tenerezza» perciò è anche «l’atteggiamento della Chiesa che si sente donna e si sente madre».
«San Paolo - l’abbiamo ascoltato ieri, anche nel breviario l’abbiamo pregato - ci ricorda le virtù dello Spirito e ci parla della mitezza, dell’umiltà, di queste virtù cosiddette “passive”» ha affermato il Papa, facendo notare che invece «sono le virtù forti, le virtù delle mamme». Ecco che, ha aggiunto, «una Chiesa che è madre va sulla strada della tenerezza; sa il linguaggio di tanta saggezza delle carezze, del silenzio, dello sguardo che sa di compassione, che sa di silenzio». E «anche un’anima, una persona che vive questa appartenenza alla Chiesa, sapendo che anche è madre deve andare sulla stessa strada: una persona mite, tenera, sorridente, piena di amore».
«Maria, madre; la Chiesa, madre; la nostra anima, madre» ha ripetuto Francesco, invitando a pensare «a questa ricchezza grande della Chiesa e nostra; e lasciamo che lo Spirito Santo ci fecondi, a noi e alla Chiesa, per diventare noi anche madri degli altri, con atteggiamenti di tenerezza, di mitezza, di umiltà. Sicuri che questa è la strada di Maria». E, in conclusione, il Papa ha fatto notare anche come sia «curioso il linguaggio di Maria nei Vangeli: quando parla al Figlio, è per dirgli delle cose di cui hanno bisogno gli altri; e quando parla agli altri, è per dire loro: “fate tutto quello che lui vi dirà”».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"TEBE": IN VATICANO NON C’E’ SOLO LA "SFINGE" - C’E’ LA "PESTE"!!! Caro Benedetto XVI ... DIFENDIAMO LA FAMIGLIA!? MA QUALE FAMIGLIA - QUELLA DI GESU’ (Maria - e Giuseppe!!!) O QUELLA DI EDIPO (Laio e Giocasta)?!
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
LA COMPETENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DEL VATICANO E’ "PREISTORICA" E "MAMMONICA". Il "romanzo familiare" edipico della chiesa e della cultura cattolico-romana è finito
Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") - GIOACCHINO DA FIORE, HENRI DE LUBAC, E LA TEOLOGIA DEL DIO "MAMMONA".10 marzo 2018, di Federico La Sala
- STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO: HENRI DE LUBAC E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO: HENRI DE LUBAC E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
 L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
IL DIO MAMMONA (“CARITAS”), IL DENARO, E “IL GATTO CON GLI STIVALI”. LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI ... *
PURGATORIO DE L’INFERNO, 10. “Questo è il gatto con gli stivali” *
- Mentre con il figlio osserva un libro illustrato, il poeta sollecita con amore e affetto a guardare le immagini con attenzione e spirito critico, dietro a ogni cosa in esso rappresentata, e a ogni manifestazione della vita, si nasconde l’onnipotenza del ’dio’ denaro.
Questo è il gatto con gli stivali, questa è la pace di Barcellona
fra Carlo V e Clemente VII, è la locomotiva, è il pesco
fiorito, è il cavalluccio marino: ma se volti pagina, Alessandro,
ci vedi il denaro:
questi sono i satelliti di Giove, questa è l’autostrada
del Sole, è la lavagna quadrettata, è il primo volume dei Poetae
Latini Aevi Carolini, sono le scarpe, sono le bugie, è la scuola di Atene, è il burro,
è una cartolina che mi è arrivata oggi dalla Finlandia, è il muscolo massetere,
è il parto: ma se volti foglio, Alessandro, ci vedi
il denaro:
e questo è il denaro,
e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri
con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette
di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie:
ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente
Edoardo Sanguineti
* SI CFR. : KARL MARX E WALTER BENJAMIN - “PURGATORIO DE L’INFERNO”: IL DIO MAMMONA (“CARITAS”), IL DENARO, E “IL GATTO CON GLI STIVALI”. LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=519#forum3139212
- STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto...
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! -- Australia, migliaia di bambini abusati da sacerdoti e insegnanti cattolici.16 dicembre 2017, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE...
Australia, migliaia di bambini abusati da sacerdoti e insegnanti cattolici
Minori. Conclusa l’inchiesta della Royal commission.
Il premier Turnbull: «Tragedia nazionale»*
«Decine di migliaia di bambini sono stati abusati sessualmente in molte istituzioni australiane, non sapremo mai il vero numero. Non si tratta di poche mele marce, le principali istituzioni della società hanno seriamente fallito». È la terribile conclusione a cui è giunta la Royal commission, istituita nel 2013 dal governo laburista di Julia Gillard per fare luce sugli abusi sessuali in Australia, dopo un’inchiesta quinquennale, articolata in 8.013 sessioni private e 57 udienze pubbliche, durante la quale sono state raccolte le testimonianze di oltre 8000 vittime, con più di 1200 testimoni ascoltati in 440 giorni. «La più alta forma di inchiesta pubblica australiana», la definisce la Bbc.
In 17 volumi che ha aggiunto 189 raccomandazioni alle 220 che erano già state rese pubbliche e che saranno ora esaminate dai legislatori, la relazione invita la Chiesa cattolica a rivedere le sue regole sul celibato. Perché secondo il rapporto la maggior parte degli abusi sono stati commessi - tra il 1950 e il 2015 - da ministri religiosi e insegnanti scolastici delle istituzioni cristiane: 4.400 abusi verificati solo nella chiesa cattolica, 1.115 denunce raccolte da quella anglicana, 1000 presunti molestatori nascosti dalla chiesa dei Testimoni di Geova.
Ma «non è un problema del passato», ha avvisato il presidente della commissione McClellan, perché dai sistemi di protezione dell’infanzia alla giustizia civile e la polizia, «molte istituzioni hanno tradito i nostri bambini». Il premier australiano, Malcolm Turnbull, ringraziando «i membri della commissione e coloro che hanno avuto il coraggio di raccontare le loro storie», ha parlato di «tragedia nazionale».
Mentre Denis Hart, l’arcivescovo di Melbourne, ha dichiarato di aver preso «molto seriamente» i risultati dell’inchiesta, ha ribadito le «scuse incondizionate per questa sofferenza e il nostro impegno a garantire giustizia per le persone colpite», ma ha respinto la raccomandazione della commissione di rendere obbligatorie le denunce di molestie raccolte durante le confessioni religiose: «Voglio osservare la legge della terra - ha detto - ma la pena per ogni sacerdote che spezza il sigillo della confessione è la scomunica». Il Papa tace.
*il manifesto, 16.12.2017
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VERITA’ E RICONCILIAZIONE. PAPA RATZINGER A SYDNEY, PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’: "IL RE E’ NUDO"!!! NON SOLO DEVE CHIEDERE PERDONO ALL’AUSTRALIA E ALL’ITALIA E AL "PADRE NOSTRO", MA CAMBIARE STILE DI VITA!!! Gesù, che non era schizofrenico, non si travestiva da imperatore.
"AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
-
> A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana". -- Biotestamento. Il testamento biologico è legge. Cosa sono le “dat”? Come decidere sul fine vita.15 dicembre 2017, di Federico La Sala
Il testamento biologico è legge
Cei contraria, medici cattolici divisi
L’associazione confessionale: non la applicheremo. Ma la sezione di Milano è favorevole
di M. D. B. (Corriere della Sera, 15.12.2017)
ROMA Mancano circa 10 minuti a mezzogiorno quando il tabellone si illumina di puntini verdi e dall’aula si alza un lungo applauso. «È la legge di Luca», piange dal palco Maria Cristina Coscioni, mamma del malato di Sla che aprì la campagna per il testamento biologico. Il Senato ha detto sì senza modificarlo al testo passato ad aprile alla Camera: 180 no, 6 astenuti, 71 contrari. Risultato di una coalizione atipica: Pd, Mdp e M5S. L’Italia trova a fine legislatura le norme sul fine vita, uguali per strutture pubbliche e religiose. Ed è qui che i cattolici perdono compattezza. Il direttore dell’ufficio Cei per la Pastorale della Salute, don Massimo Angelelli, pone l’altolà: «Non ci riconosciamo nella legge. Tutela i medici sollevandoli da responsabilità e le strutture pubbliche. E carica la scelta sui malati senza pensare ai sofferenti».
Uno dei punti più controversi è su idratazione e nutrizione artificiale, considerate trattamenti. La Cei distingue: «Se un paziente dovesse chiedere di interromperle negli ospedali cattolici non si procederà.
A favore i medici cattolici di Milano: «La mediazione trovata in Parlamento risponde in più parti al nostro documento». Ma il presidente dell’associazione nazionale Filippo Boscia prende le distanze: «Sono una minoranza. È incrinato il principio dell’indisponibilità della vita laicamente inteso». Il senatore Maurizio Sacconi: «Avremo casi Charlie Gard», il bimbo senza cervello cui è stato negato il proseguimento delle cure di sostegno.
«È una pagina di bella politica che spero possa segnare la storia dei diritti di questo Paese», si emoziona Emilia Grazia De Biasi che con la strategica mossa di dimettersi da relatrice in Commissione sanità del Senato ha tirato fuori le Dat da una caterva di emendamenti ostruzionistici. C’è un’altra donna fra i protagonisti, Donata Lenzi, pd, relatrice alla Camera. Le nomina al megafono Marco Cappato, leader dell’Associazione Coscioni, riunita ieri in piazza, in prima fila Mina Welby e Filomena Gallo. «Un passo avanti per la dignità della persona», scrive su Twitter il presidente del consiglio Paolo Gentiloni. Come lui i ministri Martina e Fedeli.
Una legge che prova ad allinearci agli altri Paesi
di Gilberto Corbellini (Il Sole-24 Ore, 15.12.2017)
Una volta tanto, anche se con qualche decennio di ritardo, proviamo ad allinearci con i Paesi più civili nel riconoscere, con una legge, che quando arriviamo alla fine della vita non possiamo perdere il diritto umano più fondamentale di ogni altro, quello all’autodeterminazione.
 La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e il consenso informato, approvata ieri, cancella un’anomalia etica e legale, ovvero che mentre un cittadino italiano maggiorenne e cosciente può rifiutare un trattamento medico (come prevede l’art. 32 comma 2 della Costituzione), incluse alimentazione e idratazione artificiali, se questa stessa persona perde coscienza non dispone più di tale diritto. Ovvero decidono parenti e medici.
La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e il consenso informato, approvata ieri, cancella un’anomalia etica e legale, ovvero che mentre un cittadino italiano maggiorenne e cosciente può rifiutare un trattamento medico (come prevede l’art. 32 comma 2 della Costituzione), incluse alimentazione e idratazione artificiali, se questa stessa persona perde coscienza non dispone più di tale diritto. Ovvero decidono parenti e medici.
 Le disposizioni anticipate di trattamento sono una continuazione del consenso informato, che finalmente è riconosciuto dalla legge come presupposto necessario per procedere a qualunque trattamento medico, ed entrano in gioco quando mancano le condizioni psicologiche per decidere (la coscienza per capire le informazioni e dare il consenso). È tutto qui ed è molto facile da capire.
Le disposizioni anticipate di trattamento sono una continuazione del consenso informato, che finalmente è riconosciuto dalla legge come presupposto necessario per procedere a qualunque trattamento medico, ed entrano in gioco quando mancano le condizioni psicologiche per decidere (la coscienza per capire le informazioni e dare il consenso). È tutto qui ed è molto facile da capire.Le direttive anticipate non sono un obbligo e quindi chi vuole continuare ad affidarsi a parenti e medici può farlo, ma si è almeno capito che una volta che sono state redatte devono essere rispettate da tutti, a iniziare dai medici, e che anche alimentazione e idratazione artificiale sono trattamenti medici (a predisporli peraltro non può essere che un medico). Un argomento che accade di ascoltare, è che le persone possono cambiare idea. Ma le disposizioni si possono cambiare in qualunque momento ed è auspicabile si costruiscano anche in Italia spazi informatici dove ognuno può aggiornare direttamente le proprie. E credere che una persona che non è più cosciente possa cambiare idea è ridicolo.
È giusto ricordare oggi Piergiorgio Welby, Giovanni Nuvoli, Eluana Englaro e Walter Pilulu, perché senza il loro coraggio e la loro determinazione, il tema non avrebbe raggiunto i livelli di consapevolezza culturale e politica che hanno portato a una legge, che però non è la migliore possibile sul fine vita. Questa legge non avrebbe risposto alle domande di dj Fabo e c’è ancora un tratto di strada da percorrere per diventare davvero civili.
 Domande e risposte
Domande e risposte
 Cosa c’è da sapere sul Biotestamento
Cosa c’è da sapere sul Biotestamento
 Come decidere sul fine vita
Come decidere sul fine vita
 Dalle disposizioni anticipate di trattamento alla libertà di scelta delle cure
Dalle disposizioni anticipate di trattamento alla libertà di scelta delle cure
 I doveri dei sanitari e il ruolo del fiduciario
I doveri dei sanitari e il ruolo del fiduciariodi Caterina Pasolini (la Repubblica, 15.12.2017)
ROMA Cosa sono le “dat”?
 Sono le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero le nostre volontà in materia di assistenza sanitaria in previsione di una futura incapacità a decidere o comunicare. La legge prevede che ogni maggiorenne indichi le preferenze sanitarie e possa nominare un fiduciario che parli e lo rappresenti col medico quando non potrà o non vorrà farlo. Le dat sono inserite nella legge che parla di consenso informato alle cure, di rifiuto all’accanimento terapeutico
Sono le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero le nostre volontà in materia di assistenza sanitaria in previsione di una futura incapacità a decidere o comunicare. La legge prevede che ogni maggiorenne indichi le preferenze sanitarie e possa nominare un fiduciario che parli e lo rappresenti col medico quando non potrà o non vorrà farlo. Le dat sono inserite nella legge che parla di consenso informato alle cure, di rifiuto all’accanimento terapeuticoCosa tutela la legge?
 La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e soprattutto alla autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato e proseguito senza il consenso libero e informato del malato. In caso di impossibilità a comunicare, la sua scelta medica verrà rappresentata dalle dat e difesa dal suo fiduciario.
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e soprattutto alla autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato e proseguito senza il consenso libero e informato del malato. In caso di impossibilità a comunicare, la sua scelta medica verrà rappresentata dalle dat e difesa dal suo fiduciario.Cosa si può accettare o rifiutare?
 Quando si è lucidi e coscienti si è liberi di scegliere o rifiutare cure o accertamenti. Così nelle dat la persona può accettare di sottoporsi in futuro a qualsiasi cura, chiedere di essere assistita a oltranza oppure rifiutare qualsiasi accertamento o terapia. Può entrare nel dettaglio: non voglio essere rianimato, intubato, voglio antidolorifici, oppiacei, rianimazione meccanica. Voglio o non voglio che siano iniziati trattamenti anche se il loro risultato fosse uno stato di demenza, uno stato di incoscienza senza possibilità di recupero. Oppure restare sul vago: non voglio essere rianimato.
Quando si è lucidi e coscienti si è liberi di scegliere o rifiutare cure o accertamenti. Così nelle dat la persona può accettare di sottoporsi in futuro a qualsiasi cura, chiedere di essere assistita a oltranza oppure rifiutare qualsiasi accertamento o terapia. Può entrare nel dettaglio: non voglio essere rianimato, intubato, voglio antidolorifici, oppiacei, rianimazione meccanica. Voglio o non voglio che siano iniziati trattamenti anche se il loro risultato fosse uno stato di demenza, uno stato di incoscienza senza possibilità di recupero. Oppure restare sul vago: non voglio essere rianimato.Idratazione e nutrizione si possono rifiutare?
 Sì. Sono considerate somministrazioni su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivo medici, come il sondino nella pancia, e quindi terapie alle quali si può decidere di rinunciare.
Sì. Sono considerate somministrazioni su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivo medici, come il sondino nella pancia, e quindi terapie alle quali si può decidere di rinunciare.Si può cambiare idea, revocare le scelte?
 La revoca è sempre possibile in ogni momento, e come l’accettazione o il rifiuto delle cure, va annotata nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
La revoca è sempre possibile in ogni momento, e come l’accettazione o il rifiuto delle cure, va annotata nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.Il medico è obbligato ad ubbidire al malato?
 Nessun medico può violare la volontà dei malati, ma al medico è riconosciuto il diritto di obiettare le scelte del paziente e rifiutarsi di eseguirle.
Nessun medico può violare la volontà dei malati, ma al medico è riconosciuto il diritto di obiettare le scelte del paziente e rifiutarsi di eseguirle.Quindi chi ha l’ultima parola?
 Il paziente. Se il dottore si rifiuta per motivi personali di seguire le sue indicazioni, la struttura ospedaliera ha il dovere di trovare un sostituto che garantisca il rispetto delle volontà del malato.
Il paziente. Se il dottore si rifiuta per motivi personali di seguire le sue indicazioni, la struttura ospedaliera ha il dovere di trovare un sostituto che garantisca il rispetto delle volontà del malato.Da quando si possono fare le dat?
Da subito, le disposizioni sono immediatamente valide. In futuro verrà istituito un registro nazionale e nei prossimi mesi si potranno inserire all’interno del fascicolo medico elettronico presente in numerose regioni. Così il medico, quando si arriva in ospedale, sa subito, anche se incoscienti, se vogliamo essere rianimati o meno. Evitando cosi il ripetersi di drammatici casi come quello tristemente famoso di Eluana Englaro.
Le Dat vanno scritte a mano?
 Si possono scrivere a mano, a macchina o sul computer,
Si possono scrivere a mano, a macchina o sul computer,Si può videoregistrare?
 Sì, si può anche videoregistrare.
Sì, si può anche videoregistrare.Devono essere firmate?
 Sì, devono essere sempre firmate a mano.
Sì, devono essere sempre firmate a mano.Davanti a chi vanno firmate?
 In comune o davanti al notaio
In comune o davanti al notaioA chi vanno consegnate?
 Nei comuni dove ci sono i registri, sono più di 170 già ora, oppure al notaio. Andrebbero consegnate anche al fiduciario che si è scelti.
Nei comuni dove ci sono i registri, sono più di 170 già ora, oppure al notaio. Andrebbero consegnate anche al fiduciario che si è scelti.I compiti del fiduciario?
 Deve rappresentare le nostre volontà quando non saremo in grado di esprimerci e, nel caso di nuove invenzioni e cure, valutare se siano coerenti col nostro pensiero.
Deve rappresentare le nostre volontà quando non saremo in grado di esprimerci e, nel caso di nuove invenzioni e cure, valutare se siano coerenti col nostro pensiero.Tutti possono fare il fiduciario?
 Sì, purché maggiorenni. Non ci sono limitazioni. E una scelta personale.
Sì, purché maggiorenni. Non ci sono limitazioni. E una scelta personale.Valgono i testamenti fatti prima della legge nei comuni o consegnati ai notai?
 Si, valgono, non c’è bisogno di rifarli.
Si, valgono, non c’è bisogno di rifarli.Si può chiedere l’eutanasia?
 Suicidio assistito ed eutanasia nel nostro Paese sono vietati, quindi non si possono chiedere.
Suicidio assistito ed eutanasia nel nostro Paese sono vietati, quindi non si possono chiedere.Si può chiedere la sedazione profonda?
 Sì, è prevista per i malati in fase terminale ai quali altre terapie antidolorifiche risultano inefficaci. È garantita dalla legge sulle cure palliative
Sì, è prevista per i malati in fase terminale ai quali altre terapie antidolorifiche risultano inefficaci. È garantita dalla legge sulle cure palliativeCosa è previsto per i minorenni?
 I minorenni non possono fare il biotestamento come le persone considerate incapaci. In questo caso il consenso informato è espresso dai genitori, dal tutore o dall’amministratore e sentito il ragazzo.
I minorenni non possono fare il biotestamento come le persone considerate incapaci. In questo caso il consenso informato è espresso dai genitori, dal tutore o dall’amministratore e sentito il ragazzo.Cos’è il consenso informato?
 Ogni paziente ha diritto a conoscere le proprie condizioni di salute, ad essere informato su diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti.
Ogni paziente ha diritto a conoscere le proprie condizioni di salute, ad essere informato su diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti.
 Il malato può nominare un fiduciario se non vuole ricevere informazioni sulla sua salute e per esprimere il consenso o il rifiuto al suo posto.
Il malato può nominare un fiduciario se non vuole ricevere informazioni sulla sua salute e per esprimere il consenso o il rifiuto al suo posto. -
> GESU’. MA CHI ERA COSTUI?! -- Dubbi sul Padre Nostro. "Non ci indurre in tentazione", il vero significato. Note.14 settembre 2017, di Federico La Sala
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E
DUEMILA ANNI DI "LATINORUM" CATTOLICO-ROMANO... *
A)
Dubbi sul Padre Nostro
Alcuni lettori ci scrivono.
"Non ci indurre in tentazione", il vero significato
Risponde il teologo Giuseppe Pulcinelli (Avvenire, 13.09.2017)
- La frase del Padre nostro «non ci indurre in tentazione» (Mt 6,13) crea problemi: come va tradotta e interpretata? UN ABBONATO
Nell’originale greco c’è il verbo eisenenkes che significa “immettere”, “introdurre”. Ma si vuol forse dire che Dio spinge l’uomo verso il male (la tentazione) e quindi gli si chiede di non farlo?
In realtà, alla luce di altri passi della Scrittura (cfr. Gc 1,13: «Dio non tenta nessuno»), si può e si deve dare un’altra spiegazione. Il verbo greco probabilmente traduce - in modo approssimativo - un originale semitico che va compreso in base a testi come il Salmo 140 (141),4: «Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i peccatori».
Il senso dell’invocazione è dunque: «Non ci lasciare entrare e soccombere nella tentazione». Speriamo che presto venga adottata anche nella liturgia la versione ufficiale della Cei (2008), che ha corretto con «non abbandonarci alla tentazione».
B)
Chiedi al teologo
Non abbandonarci «alla» o «nella» tentazione?
di Luigi Lorenzetti (Famiglia Cristiana, 02/06/2017)
- SERGIO - Nella nuova traduzione del Padre nostro la frase «non abbandonarci alla tentazione» potrebbe far pensare che essere tentati è già un peccato. Non era meglio la preposizione «nella»?
Nella nuova traduzione della Bibbia Cei (2008) la dizione «Non c’indurre in tentazione», è cambiata in «Non abbandonarci alla tentazione». La tentazione mette la libertà-responsabilità della persona di fronte a un bivio: il bene e il male. Ad esempio, aiutare il prossimo o lasciarlo perdere? Per scegliere il bene, è necessario l’aiuto di Dio che, d’altra parte, non lo impone a nessuno. Da qui la consapevolezza d’averne bisogno e di chiederlo fiduciosi nella preghiera.
Il significato della nuova dizione è tutto nell’invocazione «Non abbandonarci» alla (traduzione ufficiale) o (il che è lo stesso) nella tentazione. Nell’una come nell’altra versione, è chiara la distinzione tra «essere tentati» e «consentire ». È consolante pensare e credere che Dio è sempre presente alla (o nella) tentazione, così da vincerla, anzi, trasformarla in conferma nella scelta del bene.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Dio è amore ("charitas") e il cristianesimo non è un cattolicismo!!!
IL "PADRE NOSTRO" NON E’ QUELLO DI PAPA BENEDETTO XVI. IL "DIO" DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI NON CI INDUCE IN TENTAZIONE!!!
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- San Giuseppe, tra il culto e i paradossi (di Arnaldo Casali).19 marzo 2017, di Federico La Sala
San Giuseppe, tra il culto e i paradossi
di Arnaldo Casali *
- GIOTTO CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI PARTICOLARE DELLA NASCITA DI GESU’ E ANNUNCIO AI PASTORI
 Particolare della nascita di Gesù e annuncio ai pastori, Giotto, Cappella degli Scrovegni (Padova)
Particolare della nascita di Gesù e annuncio ai pastori, Giotto, Cappella degli Scrovegni (Padova)
Ogni 19 marzo la Festa del papà rende omaggio al papà meno padre della storia della paternità.
È solo uno dei tanti paradossi sviluppati nel corso del Medioevo dalla Chiesa cattolica. Che al culto di San Giuseppe, peraltro, ci arriva lentamente e quasi con fatica.
Il padre-non padre di Gesù è in effetti una figura difficile, imbarazzante; e anche sfuggente. Perché di lui i Vangeli parlano pochissimo: tutto ciò che sappiamo è che faceva il falegname e che discendeva dalla famiglia di Davide, cosa che renderebbe Gesù stesso un erede del Re di Israele. Se non fosse che in realtà Giuseppe, padre di Gesù, non lo è affatto.
Almeno secondo due dei quattro evangelisti: Luca e Matteo - gli unici a interessarsi delle origini di Cristo - raccontano la sua nascita in modo completamente diverso ma una delle pochissime cose su cui concordano è il fatto che sia stato concepito senza rapporti sessuali.
Un dato squisitamente teologico che serve a dimostrare che niente è impossibile a Dio e non ha alcuna valenza morale (la verginità non era un valore nella cultura ebraica) e non è nemmeno connesso alla divinità di Cristo: non a caso il Vangelo che insiste di più su Gesù come “verbo divino” è quello di Giovanni, che non fa alcun cenno al suo concepimento verginale.
Sarà invece la cultura pagana in cui il cristianesimo si innesterà in occidente a recepire Cristo, su modello della mitologia greca, come una sorta di uomo-Dio figlio di una donna “inseminata” dal divino.
Il concepimento di Gesù raccontato nei Vangeli ha, tuttavia, una qualche base storica: se gli stessi farisei durante uno scontro con Cristo sottolineano che “noi non siamo nati da prostituzione” (Giovanni 8,41) evidentemente qualche tipo di pettegolezzo, sul fatto che Gesù fosse un figlio illegittimo, circolava già durante la sua vita, e i racconti di Matteo e Luca potrebbero essere serviti proprio a dissipare le malelingue.
D’altra parte la discendenza di Gesù da Davide ha una valenza squisitamente letteraria: Matteo, fortemente influenzato dal giudaismo, è interessato a dimostrare che Cristo è il Messia atteso dagli ebrei e non è certo preoccupato di una ricostruzione storicamente attendibile né tanto meno di una coerenza di natura biologica.
Per il resto, Giuseppe è completamente assente nella vita adulta di Cristo (per questo se ne deduce che sia morto quando era ancora adolescente) e, spodestato di ogni autorità paterna, si è dovuto accontentare sin dai primi secoli del cristianesimo del ruolo di “custode” di Gesù.
- Dono Doni (attribuito), accettazione della divina maternità, Chiesa di Sant’Andrea, Spello (Pg)
 Dono Doni (attribuzione), accettazione della divina maternità, Chiesa di Sant’Andrea, Spello (Perugia)
Dono Doni (attribuzione), accettazione della divina maternità, Chiesa di Sant’Andrea, Spello (Perugia)
I Vangeli apocrifi - scritti all’alba del Medioevo - lo hanno trasformato poi in un vecchietto che vince una sorta di bando (viene sottoposto ad una prova insieme ad altri pretendenti e ha la meglio perché il suo bastone fiorisce miracolosamente) per aggiudicarsi la custodia della giovanissima Maria che, arrivata alla pubertà, non può più continuare a vivere nel tempio dove è stata allevata.
C’è bisogno di aggiungere che nella religione ebraica non esistono bambine consacrate a Dio e allevate nel tempio e che il racconto (ripreso anche da Fabrizio De André nell’album La Buona Novella) è inventato di sana pianta e privo di qualsiasi attendibilità storica?
Gli apocrifi, peraltro, si premurano di sottolineare che al momento del matrimonio Giuseppe avrebbe avuto oltre novant’anni di età. Più un bisnonno che un marito, quindi, per la giovane Maria. Una precisazione che mira a mettere la Sacra Famiglia al riparo da qualsiasi tentazione sessuale.
D’altra parte se il Vangelo non parla mai di una castità perpetua della coppia e al contrario dà per scontato che dopo la nascita di Gesù i due abbiano avuto normali rapporti sessuali (Marco e Matteo citano quattro fratelli di Gesù - Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda - e diverse sorelle di cui non vengono fatti i nomi) già i padri della Chiesa cercano in ogni modo di dimostrare che Giuseppe non ha mai “profanato” la Vergine Maria, divenuta dopo il concepimento di Gesù un vero e proprio santuario di Dio intoccabile.
Così, da finto padre, Giuseppe diventa anche marito fasullo. Secondo la dottrina cattolica, infatti, il matrimonio non consumato non è valido e può essere annullato.
- Tondo Doni, particolare, Michelangelo Buonarroti, Galleria degli Uffizi, Firenze
 Tondo Doni, particolare, Michelangelo Buonarroti, Galleria degli Uffizi, Firenze
Tondo Doni, particolare, Michelangelo Buonarroti, Galleria degli Uffizi, Firenze
La Sacra Famiglia, dunque - presunto modello della famiglia cristiana - diventa una comunità piuttosto anomala basata su un matrimonio di facciata e un figlio illegittimo.
Figlio che peraltro, essendo (sempre secondo i Vangeli apocrifi) perfettamente sapiente e consapevole della propria divinità sin dalla nascita, non ha assolutamente nulla da imparare dai propri genitori e non può quindi essere in alcun modo educato, ma solo rispettosamente venerato.
Quando arriva al Medioevo, dunque, Giuseppe non è più né un vero padre né un vero marito: è il “custode” di Gesù e il “castissimo sposo” di Maria.
La sua principale virtù è quella di resistere alle tentazioni sessuali, il grande merito quello di aver salvato la moglie dalla pubblica infamia “coprendo” col suo nome la nascita irregolare di Gesù.
In compenso viene sempre più apprezzato come lavoratore; ché il lavoro, almeno quello, non era solo di facciata e Giuseppe il falegname l’ha fatto davvero.
Non a caso a rinverdire il suo culto - così sbiadito ai primordi del cristianesimo - ci pensano i promotori dell’ora et labora, e cioè i monaci benedettini. Sono proprio loro, infatti, i primi a celebrare la memoria di San Giuseppe nel 1030.
- Il falò di Sermoneta (Latina) per la festa di San Giuseppe
 Il falò di Sermoneta (Latina) per la festa di San Giuseppe
Il falò di Sermoneta (Latina) per la festa di San Giuseppe
La data del 19 marzo, ovviamente, è puramente convenzionale, visto che di solito i santi vengono celebrati nel giorno della morte e della morte di Giuseppe non si sa assolutamente nulla. Convenzionale ma non casuale: come il giorno di Natale e quello di San Valentino anche la festa di San Giuseppe ha radici antichissime: si colloca infatti alla vigilia dell’equinozio di primavera e veniva solennizzata con baccanali e riti dionisiaci volti alla propiziazione della fertilità e alla purificazione agraria.
Rituali di cui è rimasta traccia nella tradizione - ancora oggi diffusa in molte regioni italiane - dei falò con cui si bruciano i residui del raccolto dell’anno precedente come auspicio di una buona stagione.
Il culto di san Giuseppe, intanto, con il tempo si va sempre più allargando: dal 1324 la festa viene recepita anche dai Servi di Maria (ordine mendicante fondato a Firenze nel 1233) mentre i francescani la adottano nel 1399.
Ci vorrà ancora qualche decennio, però, prima che la ricorrenza venga istituzionalizzata e celebrata da tutti i cristiani; nel calendario romano, infatti, ci entrerà solo nel XV secolo, e sarà estesa formalmente a tutta la Chiesa solo nel 1621 da Gregorio XV, mentre bisognerà aspettare addirittura il 1870 perché Pio IX dichiari San Giuseppe “Patrono della Chiesa universale” riscattandolo definitivamente da quel ruolo ombra cui gli apocrifi lo avevano relegato.
- Gerrit van Honthorst detto Gherardo delle Notti, Sacra Famiglia nella bottega di carpenteria di S. Giuseppe, 1610 circa
 Gerrit van Honthorst detto Gherardo delle Notti,Sacra Famiglia nella bottega di carpenteria di S. Giuseppe, Ermitage, San Pietrogurgo
Gerrit van Honthorst detto Gherardo delle Notti,Sacra Famiglia nella bottega di carpenteria di S. Giuseppe, Ermitage, San Pietrogurgo
La sua resta comunque una festa primaverile strettamente legata al lavoro della terra, dunque festa del lavoro e dei lavoratori.
Niente ha invece a che fare, nel Medioevo, con la festa del papà; associazione che avverrà più tardi e non in tutto il mondo: ancora oggi, infatti, nei Paesi anglosassoni la festa del papà viene celebrata la terza domenica di giugno e senza alcun carattere religioso.
In compenso in Italia il padre di Gesù, costretto a far nascere suo figlio in una stalla e poi a fuggire all’estero, da profugo, per metterlo in salvo, viene onorato anche come protettore dei poveri.
Di qui l’usanza presente in alcune regioni di organizzare il 19 marzo il “Banchetto di San Giuseppe”. Ed è per questo che un elemento importante legato alla festa è il pane, che ricorre spesso soprattutto nel contesto siciliano, deposto sugli altari.
I falò e le tavole imbandite si ritrovano anche nel Salento, dove la festa è celebrata all’insegna degli elementi fondamentali del pellegrinaggio e dell’ospitalità, mentre a Roma nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro, la confraternita dei falegnami organizzava solenni festeggiamenti e banchetti a base di frittelle e bignè.
Esemplare è poi il dolce napoletano, che prende il nome di zeppola di San Giuseppe seguendo una tradizione secondo cui, dopo la fuga in Egitto con Maria e Gesù, Giuseppe dovette vendere frittelle per poter mantenere la famiglia. In Toscana e in Umbria è diffuso come dolce tipico la frittella di riso, preparata con riso cotto nel latte e aromatizzato con spezie e liquori e poi fritta.
Nell’Italia del nord, invece, dolce tipico della festività è la raviola: un piccolo involucro di pasta frolla o pasta di ciambella richiuso sopra una cucchiaiata di marmellata, crema o altro ripieno, poi cotta al forno o fritta. Alla salute di Giuseppe.
Arnaldo Casali
* FESTIVAL DEL MEDIOEVO (RIPRESA PARZIALE - SENZA IMMAGINI).
- GIOTTO CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI PARTICOLARE DELLA NASCITA DI GESU’ E ANNUNCIO AI PASTORI
-
> A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana" --- Mina Welby: "Licio Gelli in Chiesa, Piergiorgio no. I funerali dovrebbero averli tutti. Intervenga il Papa".18 dicembre 2015, di Federico La Sala
Mina Welby: "Licio Gelli in Chiesa, Piergiorgio no. I funerali dovrebbero averli tutti. Intervenga il Papa"
di Redazione (L’Huffington Post, 17/12/2015)
"Tutti dovrebbero avere i funerali, tutti quelli che dovessero volerli". Così come è stato per Vittorio Casamonica, anche Licio Gelli avrà funerali cattolici, a Pistoia, nella chiesa della Misericordia. Nonostante Gelli sia massone e per questo scomunicato.
Secondo la dichiarazione sulla massoneria a firma del prefetto Joseph Cardinal Ratzinger, rimane "immutato il giudizio negativo della chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della chiesa e perciò l’iscrizione a esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla santa comunione".
"Ma i massoni che conosco io cercano il bene della cittadinanza", replica Mina Welby, la moglie di Piergiorgio, morto nel dicembre del 2006 dopo una grave e lunga malattia. Il cardinale Ruini gli negò i funerali.
"Su mio marito ci fu un giudizio politico, in quanto radicale, il Vaticano non ama i radicali". Piergiorgio "non voleva il suicidio", lui chiese l’eutanasia: "voleva una legge - dice ancora all’agenzia dire - che comprendesse varie scelte che l’uomo può fare alla fine della propria vita, compresa l’eutanasia. Per lui era una morte dignitosa".
Secondo Mina Welby "Tutti quelli che lo volessero dovrebbero avere i funerali. Com’è stato per Vittorio Casamonica, per Gelli e doveva essere così per Piergiorgio. Avere un funerale o meno deve essere una scelta della persona. Io personalmente vorrei arrivare ad una legge per l’eutanasia, al punto di non avere il funerale. I cittadini mi accompagneranno in altra maniera".
Per Piergiorgio "i funerali non erano importanti, me lo disse poco prima di morire. Mi prese da parte e mi disse ’per me non sono importanti, ma per mamma fallo’. Lui era un credente agnostico, ha ricevuto tutti i sacramenti, noi ci siamo anche sposati in chiesa. Ora spero che il papa dirà qualcosa su questo, siamo nel giubileo della misericordia. Lo aspetto".
Chissà cosa direbbe oggi Piergiorgio sapendo dei funerali di Casamonica e di Gelli: "si farebbe una risata. Ricordo che quando era in vita, durante la conferenza episcopale uscì un documento in cui si parlava di Piergiorgio anche se non venne mai nominato - racconta Mina - si parlava di lui come del male, di satana".
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ---- Le ultime diciotto ore di Gesù. Ultima inchiesta su Gesù: Augias racconta la fine di Cristo7 settembre 2015, di Federico La Sala
Ultima inchiesta su Gesù
Tra fiction e saggio, Augias racconta la fine di Cristo
Si susseguono personaggi storici e da romanzo molto vicini alla realtà
È un uomo contro le istituzioni religiose che assegna il primato alla spiritualità
di Vito Mancuso (la Repubblica, 07.09.2015)
L’anno cruciale per la storiografia su Gesù fu il 1906, quando il sogno di scriverne la biografia perfetta cadde in frantumi a seguito dell’opera di Albert Schweitzer intitolata “Storia della ricerca sulla vita” di Gesù. Schweitzer vi mostrava come la ricerca storica su Gesù, iniziata con gli scritti di Reimarus pubblicati da Lessing nel 1778, si dovesse ritenere conclusa con un sostanziale fallimento in quanto i singoli autori avevano interpretato Gesù ognuno secondo i propri ideali giungendo a un inaccettabile soggettivismo.
Conclusione inevitabile a causa della natura delle fonti neotestamentarie, orientate a presentare il messaggio salvifico di Gesù e ben poco la sua storia reale. Da allora gli studi sul Gesù storico non si sono certo interrotti, anzi fioriscono con un ritmo tale che rende quasi impossibile seguirli. La sostanza però non muta: Meier, Sanders, Vermes, Neusner, Fabris, Barbaglio, Pesce, Ratzinger e moltissimi altri presentano ognuno un Gesù diverso, sicché leggendo le loro opere si incontra Gesù filtrato dalla loro teologia. La situazione non è quindi molto diversa da come la descriveva Rudolf Bultmann nel 1926: «Ciò che è stato scritto da circa un secolo e mezzo sulla vita di Gesù, sulla sua personalità e sulla sua evoluzione interiore ecc., è frutto di fantasia e materiale da romanzo ».
Consapevole di questo status quaestionis , Corrado Augias propone nel suo nuovo libro sulle ultime ore di Gesù in uscita da Einaudi un lavoro che per buona parte è esattamente “frutto di fantasia e materiale da romanzo”. La differenza è che lo è in modo esplicito e tecnicamente avvertito perché dichiara che «qualunque storia è almeno in parte una bugia - o un sogno».
Tale dosaggio di saggistica e di narrativa consente all’autore di presentare i personaggi storici arricchiti di personalità e al contempo di creare personaggi da romanzo molti vicini alla realtà. Sfilano così Myriam la madre e Joseph il padre di Gesù, anzi una delle trovate più interessanti riguarda proprio quest’ultimo, riscattato dalla figura piuttosto grigia di “san Giuseppe” e presentato come un single che ha lasciato la moglie e i figli, sempre inquieto per le origini non chiare di quel suo primo figlio da lui tanto amato, e che ora vive solo sulle alture di Gerusalemme: anche lui entrerà in scena nelle ultime ore del figlio. Miryam dal canto suo confessa di non riuscire a pensare a suo marito “senza rimorso”: «se solo avessimo trovato il modo, il coraggio, di parlarci davvero». Riguardo invece alle voci sulla risurrezione del figlio: «Non so se devo crederlo vivo, io non l’ho visto, se fosse vero e non è venuto a vedermi, sapendo quanto dolore ho ingoiato, vuol dire che ha cose più importanti da fare»; tuttavia non perde che la fiducia che “un giorno verrà”.
Ma chi sono per Augias i responsabili della morte di Gesù giocatasi in quel pugno di ore? Non il potere romano in quanto tale, perché Ponzio Pilato non fu all’origine della sua cattura e tutto sommato avrebbe voluto salvarlo. Neppure lo è il popolo ebraico in quanto tale, perché la frase del Vangelo di Matteo che parla di “tutto il popolo” (e che è all’origine dello stereotipo del popolo deicida) è giustamente mostrata da Augias nella sua falsità. I responsabili per Augias sono piuttosto i capi religiosi ebrei, Caifa e Anna, esponenti dell’aristocrazia religiosa ed economica, profondamente seccati dalla predicazione rivoluzionaria di Gesù: «un mestatore uscito dalla feccia del popolo che sobilla schiavi e prostitute». Augias inventa anche un intrigo di corte dovuto a un consigliere di Pilato legato da un rapporto masochista con una prostituta, Fillide.
Nella storiografia su Gesù, nelle bugie e nei sogni che ogni interprete vi proietta, appare l’anima occidentale alle prese con gli eterni problemi dell’origine e del senso, del dolore e del morire, della vita presente e della vita futura.
Chi è dunque Gesù per Augias? Non è certo il Figlio di Dio redentore dell’uomo, piuttosto «un uomo pio, di forte fede, tendenzialmente mite anche se, in alcune occasioni, ha ceduto a scatti d’ira o gridato frasi minacciose», quindi anche “aspro, difficile”, e tale da essere classificato come “un agitatore”. Nel colloquio con Lucilio, lo scrittore alter ego di Augias, Gesù spiega la sua missione in termini di “alternativa possibile”, di «vita libera dagli istinti, dal desiderio di possesso», e dice di rifiutare «una fede chiusa nell’ambito di una famiglia», «che si limiti ai riti della sinagoga, alla ripetizione meccanica dei versetti, all’obbedienza formale della Legge con il cuore vuoto ».
Insomma un Gesù in linea con la profezia biblica e la migliore filosofia morale, capace di analizzare con lucidità le contraddizioni della religione: «Le strutture religiose diventano spesso uguali alle istituzioni politiche, creano gerarchie, poteri, interessi, circola denaro, si mercanteggiano favori, si parla e si scrive troppo». Un Gesù che, contro l’obbedienza all’istituzione, assegna il primato alla spiritualità. «Dice di aver voluto rendere gli uomini liberi, dai riti dalle forme, dai sacerdoti; libero ognuno con la sua coscienza davanti a Dio».
Poco coerente però con questa intenzione di fondo è l’interpretazione di Giuda Iscariota fornita da Augias che, ispirandosi al Vangelo di Giuda, testo gnostico recentemente scoperto, lo presenta come il discepolo prediletto che consegna Gesù perché è il maestro stesso a chiederlo: ma così si pone la coscienza di Giuda libera davanti a Dio? Gesù al contrario la inchioderebbe alla più terribile tragedia. Altri particolari del lavoro di Augias non convincono, come la presentazione della spiritualità essena come mite e pacifica mentre gli esseni avevano una regola della guerra e mostravano aspra intolleranza verso le posizioni altrui.
Ma, come ho detto, raccontare Gesù significa esporre la propria visione del mondo: quindi attraverso il suo nuovo libro si incontra la grande simpatia di Augias per il mondo classico; la sua simpatia per la figura storica dell’ebreo Gesù; la sua tendenziale distanza dall’ebraismo istituzionale, e soprattutto la sua inequivocabile antipatia per il cristianesimo nato dalla predicazione di san Paolo. Non penso sia un caso che Augias lasci l’ultima parola alle sprezzanti osservazioni di Tacito sui cristiani.
Quanto alla figura di Gesù, rimangono valide le parole di Schweitzer a conclusione del suo capolavoro: «Egli viene verso di noi come uno sconosciuto senza nome... Si rivelerà a coloro che gli obbediscono, si rivelerà nella pace, nell’azione, nelle lotte e nelle sofferenze che costoro vivranno in comunione con lui. Ed essi sperimenteranno chi egli è, come si conosce un segreto ineffabile».
*
 IL LIBRO E I FESTIVAL
IL LIBRO E I FESTIVAL
 Le ultime diciotto ore di Gesù (Einaudi, pagg. 252, euro 20)
Le ultime diciotto ore di Gesù (Einaudi, pagg. 252, euro 20)
 Corrado Augias lo presenterà venerdì 11 alle 21.15 al Festival di Mantova; il 12 a Camogli (ore 18.30)e il 16 a Pordenonelegge (ore 21)
Corrado Augias lo presenterà venerdì 11 alle 21.15 al Festival di Mantova; il 12 a Camogli (ore 18.30)e il 16 a Pordenonelegge (ore 21) -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- "Je suis Charlie". Il ministro della Giustizia, Christiane Taubira e il "pugno" di Papa Francesco.16 gennaio 2015, di Federico La Sala
Papa Francesco: ’Se uno mi offende la madre gli do un pugno’
Francesco sui fatti di Parigi: "Non si offendono le fedi"
di Tullio Giannotti *
MANILA. "Non si offende la religione degli altri", parola di Francesco. Il Papa si esprime nel giorno in cui il fronte unico "Je suis Charlie" mostra le prime crepe, e lo fa senza mezzi termini: sì alla libertà d’espressione ma senza "provocare, insultare, ridicolizzare la fede degli altri".
Diametralmente opposta a Papa Francesco, la Francia si inorgoglisce per essere il Paese "di Voltaire e dell’irriverenza" - come rivendica il ministro della Giustizia, Christiane Taubira - e non accetta confini alla libertà d’espressione: "possiamo disegnare tutto, incluso il Profeta".
Francois Hollande, dopo le giornate terribili in cui ha reso onore alle salme di poliziotti, ha abbracciato i familiari di giornalisti trucidati in redazione, ha abbracciato i musulmani in un incontro all’Istituto del mondo arabo, diretto ora dall’ex ministro della Cultura, Jack Lang. Voi, ha detto ai musulmani, "siete le prime vittime del fanatismo, del fondamentalismo e dell’intolleranza".
Per Papa Bergoglio, "la libertà di religione e la libertà di espressione sono tutti e due diritti umani fondamentali".
 Durante il viaggio verso Manila, il pontefice ha risposto alle domande dei giornalisti, e con un inviato francese si è lungamente soffermato sui dolorosi fatti di questi giorni, sempre premettendo che "non si uccide in nome di Dio" e che "i kamikaze danno la propria vita ma non la danno bene". "Ognuno - ha detto - ha il diritto di praticare la propria religione, senza offendere, liberamente". "Non si può offendere o fare la guerra - ha proseguito - uccidere in nome della religione, cioè in nome di Dio". E qui il mea culpa, il ricordo "della nostra storia", delle "grandi guerre di religione" fino alla "notte di San Bartolomeo".
Durante il viaggio verso Manila, il pontefice ha risposto alle domande dei giornalisti, e con un inviato francese si è lungamente soffermato sui dolorosi fatti di questi giorni, sempre premettendo che "non si uccide in nome di Dio" e che "i kamikaze danno la propria vita ma non la danno bene". "Ognuno - ha detto - ha il diritto di praticare la propria religione, senza offendere, liberamente". "Non si può offendere o fare la guerra - ha proseguito - uccidere in nome della religione, cioè in nome di Dio". E qui il mea culpa, il ricordo "della nostra storia", delle "grandi guerre di religione" fino alla "notte di San Bartolomeo".Poi il tema del sangue di questi giorni, dell’irruzione terroristica in una redazione di vignettisti: "ognuno ha non solo la libertà o il diritto ma anche l’obbligo di dire quello che pensa se ritiene che aiuti il bene comune".
 Infine, il "pugno": quello che il suo "caro amico" "dottor Gasbarri", l’organizzatore dei viaggi papali che era al suo fianco, può "aspettarsi" da lui se "dice una parolaccia contro la mia mamma": "perché non si può provocare, insultare, ridicolizzare la fede degli altri".
Infine, il "pugno": quello che il suo "caro amico" "dottor Gasbarri", l’organizzatore dei viaggi papali che era al suo fianco, può "aspettarsi" da lui se "dice una parolaccia contro la mia mamma": "perché non si può provocare, insultare, ridicolizzare la fede degli altri".Il discorso del Papa è destinato a lasciare una traccia e a suscitare polemiche in Francia, dove di limiti alla libertà d’espressione, semmai, ci sono soltanto quelli in cui è caduto l’umorista Dieudonné: antisemitismo, apologia di terrorismo o negazionismo.
La guardasigilli Taubira ha scandito bene le parole, era emozionata ma determinata nel suo intervento per l’estremo saluto a uno dei vignettisti uccisi dai fratelli Kouachi il 7 gennaio: "nel paese di Voltaire e dell’irriverenza abbiamo il diritto di ironizzare su tutte le religioni. Possiamo disegnare tutto, incluso il Profeta. Fra l’omaggio commosso a Tignous da parte della "superstite" Coco e un "Bella ciao" da brividi cantato dall’umorista Christophe Aleveque, la Taubira ha ricordato i principi del paese dei Lumi: "non ci sono tabù", i disegnatori uccisi "vegliavano sulla democrazia, per evitare che sonnecchiasse".
Hollande ha teso la mano ai musulmani, contro i quali dal 7 gennaio si sono intensificate le azioni violente: "il fondamentalismo islamico - ha detto il presidente - si nutre di tutte le contraddizioni, delle povertà, dei conflitti non risolti da troppo tempo, e sono i musulmani ad esserne le prime vittime". Ribadendo l’imperativo di "evitare le confusioni" fra estremisti violenti e musulmani moderati, il presidente ha sottolineato il "dovere di solidarietà nei confronti del mondo arabo", a partire dal caso della Siria, dove "è la forza che ha avuto la meglio a furia di non affrontare quella questione". "Il mondo arabo è in piena mutazione, anche se non tutte le sue ’primavere’ hanno prosperato - ha detto ancora il presidente - questi cambiamenti richiedono tempo".
-
> GESU’...IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! --- La libertà di figlio e lo Spirito Santo. Papa Francesco a Santa marta (di Andrea Tornielli)10 gennaio 2015, di Federico La Sala
«Mille corsi di spiritualità o di yoga non ti danno la libertà di figlio che dona lo Spirito»
Il Papa nell’omelia di Santa Marta: chi cerca solidità nel dettato della legge è sicuro come un uomo o una donna nella cella di un carcere, è una sicurezza senza libertà
di Andrea Tornielli (La Stampa, 9/01/2015)
Città del Vaticano. Si possono fare «mille corsi di catechesi, mille corsi di spiritualità, mille corsi di yoga, zen», ma tutto questo non potrà mai dare la libertà di figlio: solo lo Spirito Santo «muove il tuo cuore per dire "Padre"». Lo ha detto questa mattina Francesco nell’omelia della messa celebrata a Santa Marta, come riporta Radio Vaticana. Il Papa ha ripreso l’episodio del Vangelo di Marco nel quale i discepoli si spaventano nel vedere Gesù camminare verso di loro sull’acqua ,che termina con una considerazione sul perché di quello spavento: gli apostoli non avevano capito il miracolo dei pani perché «il loro cuore era indurito».
Un cuore, ha osservato Papa Bergoglio, può essere «di pietra» per tanti motivi, osserva il Papa, ad esempio per «esperienze dolorose», come capita ai discepoli di Emmaus, timorosi di illudersi «un’altra volta»; o a Tommaso, che rifiuta di credere alla resurrezione di Gesù. «Un altro motivo che indurisce il cuore - spiega Francesco - è la chiusura in se stesso».
«Fare un mondo in se stesso, chiuso. In se stesso, nella sua comunità o nella sua parrocchia, ma sempre chiusura. E la chiusura può girare intorno a tante cose: ma pensiamo all’orgoglio, alla sufficienza, pensare che io sono meglio degli altri, anche alla vanità, no? Ci sono l’uomo e la donna-specchio, che sono chiusi in se stessi per guardare se stessi continuamente... Questi narcisisti religiosi, no? Ma, hanno il cuore duro, perché sono chiusi, non sono aperti. E cercano di difendersi con questi muri che fanno intorno a sé».
Il Papa ha quindi parlato di chi si barrica dietro la legge, aggrappandosi alla «lettera» di ciò che i comandamenti stabiliscono. Qui a indurire il cuore è un problema di «insicurezza». E chi cerca solidità nel dettato della legge è sicuro - dice il Papa con una punta di ironia - come «un uomo o una donna nella cella di un carcere dietro la grata: è una sicurezza senza libertà». Cioè l’opposto di ciò «che è venuto a portarci Gesù», la libertà.
«Il cuore, quando si indurisce, non è libero e se non è libero è perché non ama: così finiva Giovanni apostolo nella prima Lettura. L’amore perfetto scaccia il timore: nell’amore non c’è timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore. Non è libero. Sempre ha il timore che succeda qualcosa di doloroso, di triste, che mi faccia andare male nella vita o rischiare la salvezza eterna... Ma tante immaginazioni, perché non ama. Chi non ama non è libero. E il loro cuore era indurito, perché ancora non avevano imparato ad amare».
Francesco ha detto che «chi ci insegna ad amare» e «chi ci libera da questa durezza» è «soltanto lo Spirito Santo». «Tu puoi fare mille corsi di catechesi, mille corsi di spiritualità, mille corsi di yoga, zen e tutte queste cose. Ma tutto questo non sarà mai capace di darti la libertà di figlio. Soltanto è lo Spirito Santo che muove il tuo cuore per dire "Padre". Soltanto lo Spirito Santo è capace di scacciare, di rompere questa durezza del cuore e fare un cuore... morbido?... Non so, non mi piace la parola... "Docile". Docile al Signore. Docile alla libertà dell’amore».
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- Senza Maria, un cristiano è orfano (di Papa Francesco)29 giugno 2014, di Federico La Sala
Il Papa ai giovani: senza Maria, un cristiano è orfano
- Un cristiano senza devozione per Maria, madre di Cristo, è “orfano”. Lo ha detto il Papa ai giovani della diocesi di Roma, impegnati nel cammino di discernimento vocazionale, incontrati ieri sera presso la Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, assieme al cardinale Agostino Vallini. L’appuntamento, alla vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo, è una tradizione inaugurata da Benedetto XVI. Il servizio di Giada Aquilino:
Il cristiano ha bisogno di “due Madri”: la Madonna e la Chiesa. Parlando a braccio ai giovani della diocesi di Roma impegnati nel cammino di discernimento vocazionale, Papa Francesco ha ricordato come la Madonna sia “tanto importante nella nostra vita”. È lei, ha detto, che “ci accompagna nella scelta definitiva, la scelta vocazionale”, avendo accompagnato Suo Figlio nel proprio cammino vocazionale “che è stato tanto duro, tanto doloroso”. Insomma: “ci accompagna sempre”:
“Un cristiano senza la Madonna è orfano. Un cristiano senza Chiesa è anche un orfano. Un cristiano ha bisogno di queste due donne, due donne Madri, due donne Vergini: la Chiesa e la Madonna”.
Lo ha definito un test di “vocazione cristiana giusta”, il Pontefice, quello di domandarsi come vada il “rapporto con queste due Madri”, la Madre Chiesa e la Madre Maria:
“Questo non è un pensiero ‘di pietà’... No, è teologia pura. Questa è teologia. Come va il mio rapporto con la Chiesa, con la mia Madre Chiesa, con la Santa Madre Chiesa gerarchica? E come va il mio rapporto con la Madonna, che è la mia mamma, mia madre”?
Quindi una riflessione sul cammino di discernimento. “Per ognuno di noi - ha assicurato il Santo Padre - il Signore ha la sua vocazione, quel posto dove Lui vuol che noi facciamo la vita”. Va cercato, trovato e poi portato avanti. Una scelta a cui va dato un “senso del definitivo”, di fronte alla “cultura del provvisorio” che stiamo vivendo:
“Abbiamo paura del definitivo, no? E per scegliere una vocazione, una vocazione qualsiasi sia, anche quelle vocazioni “di stato”, il matrimonio, la vita consacrata, il sacerdozio, si deve scegliere con una prospettiva del definitivo. Va contro questo la cultura del provvisorio. E’ una parte della cultura che a noi tocca vivere in questo tempo, ma dobbiamo viverla, ma vincerla”.
D’altra parte, ha concluso salutando i ragazzi, colui che “ha più sicura la sua strada definitiva è il Papa”.
 (Tratto dall’archivio della Radio Vaticana)
(Tratto dall’archivio della Radio Vaticana) -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ---- STRANE NASCITE. Secondo un antico detto, l’apparenza inganna (di Piero Stefani)22 dicembre 2013, di Federico La Sala
Strane nascite
di Piero Stefani (22.12.2013) *
Matteo e Luca nei loro «vangeli dell’infanzia» (i soli che parlano dell’evento) descrivono la nascita di Gesù come un parto verginale. Tra tutti gli aspetti narrativi collegati all’immaginario natalizio, questo è, senza dubbio, quello meno tenuto presente. La ragione è semplice: il tema della verginità feconda emerge in primo piano nelle feste mariane, mentre a Natale il centro è occupato da Gesù. Tutte le altre, anche le più prossime, sono figure di contorno. Di presepi ce ne sono stati tanti e di molti tipi, ma nessuno tra essi evoca una scena di parto. Il bambinello viene messo tra la paglia dall’esterno, come se venisse da fuori. Nella storia dell’iconografia molti sono i ritratti di Maria che allatta ma nessuno di essi - salvo smentite - è collocato in un presepe. Nella stalla la madre è presentata la prima tra gli adoranti. Vale a dire, è caratterizzata da un atteggiamento che ogni fedele può assumere in proprio. Tra i gesti paraliturgici della notte di Natale vi è quello di baciare un neonato che «scende dalle stelle» isolandolo dai suoi genitori.
Secondo un antico detto, l’apparenza inganna. Si è fatta molta fatica per cercare di comprendere la difficile frase secondo la quale Giuseppe, una volta scoperta la gravidanza della sua promessa sposa, «poiché era uomo giusto» non volle accusarla pubblicamente e pensò perciò di ripudiarla in segreto (Mt 1,19). Che senso di giustizia vi è mai in ciò? Una risposta sta proprio nel rifiuto di Giuseppe di prendere quanto appare per quel che è. Quando non si sa decifrare un avvenimento, la persona giusta, in luogo di condannare, sospende il giudizio: «non giudicate per non esser giudicati» (Mt 7,1).
In base a un modello biblico, il vangelo di Matteo inizia con una genealogia (Mt 1,1-17). Essa riguarda «Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo». Nella genealogia compaiono anche quattro donne - Tamar (Gen 38), Rachab (Gs 2), Rut (Rt 3-4) e la moglie di Uria (Betsabea, 2Sam 11,1-12,24) - le cui maternità furono contraddistinte da tratti «irregolari». Tuttavia, nonostante le apparenze, queste nascite furono tutte conformi alla giustizia di Dio; esse anticipano quanto sarebbe avvenuto in Maria e interagiscono con l’anomalia di una genealogia che termina in Giuseppe che pur non è presentato come padre naturale di Gesù.
Tra i quattro casi il più fruttuoso, in riferimento a Giuseppe, è quello relativo a Tamar e a Giuda (il capostipite della tribù a cui appartenne lo sposo di Maria). Giuda, dopo aver violato la legge che lo obbligava a far sposare un suo figlio con la propria nuora rimasta vedova, ha rapporti sessuali con Tamar, da lui non riconosciuta perché travestitasi da prostituta. Quando la nuora rimane incinta il suocero esige l’applicazione della pena capitale prevista per le adultere. Tamar gli fornisce però le prove inconfutabili della sua paternità; allora il suocero esclama: «Lei è più giusta di me» (Gen 38,26). Sotto la maschera di un rapporto sessuale con una prostituta si annida un’opera di giustizia. Giuda giudicò secondo le apparenze, non così il giusto suo discendente Giuseppe.
Se ci si limitasse alle apparenze cosa mai sarebbe il Natale? La nascita di un povero bimbo di duemila anni fa venuto al mondo in una stalla. La fede non nega che sia così, ma nel contempo ci fa pure andar oltre. Anche tenendo conto di tutte le differenze del caso, qualcosa di simile vale pure per i rapporti interumani.
Nel mondo dominato dalle immagini e quindi dall’apparire, il giusto Giuseppe ci invita, da un lato, a non giudicare in base a quanto appare in superficie e, dall’altro, ad essere aperti a credere che persino quella che ai nostri occhi sembra una colpa può essere un luogo dove opera Dio.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. --- "TU NON CI INDUCI IN TENTAZIONE". Il "Padre nostro" nella versione di Giovanni Vannucci (di Antonio Gentili)5 novembre 2013, di Federico La Sala
[Il "Padre nostro", nella versione di] Giovanni Vannucci*:
Il tentativo forse più riuscito è quello di padre Giovanni Vannucci (1913-1984), il quale era solito dire che «nella Chiesa cattolica il più grande martire è il Padre nostro», a motivo della trascuratezza con cui viene recitato e... vissuto. Padre Giovanni, dell’ordine dei Servi di Maria, fu valente esegeta, e in spirito sinceramente ecumenico visse e operò nell’eremo della Stinche (Firenze).
Egli faceva notare che nell’ebraico ci sono due lingue: quella delle comunicazioni ordinarie e quella sacra che, diceva, «va riscoperta pazientemente, tenacemente, attentamente, ma soprattutto nel silenzio e nell’ascesa del nostro essere. Ora, la lingua sacra ebraica conosce soltanto due tempi: lo stato di perfezione e lo stato di imperfezione».
Questo, secondo padre Vannucci, si applica anche al Padre nostro, le cui espressioni non indicano un puro desiderio condizionato alla fallibile volontà dell’uomo, ma contengono un’affermazione di fede nella quale si riflettono gli immutabili disegni divini.
Tenendo conto di questo, dovremmo tradurre - precisa padre Vannucci - non "sia santificato il tuo nome", ma santo è il tuo nome; non "venga il tuo regno", ma il tuo regno viene; non "sia fatta la tua volontà...", ma la tua volontà si compie nella terra come nel cielo; non "dacci oggi il nostro pane quotidiano", ma tu doni a noi il pane di oggi e di domani ("quotidiano" traduce un termine che ha il doppio significato di pane terreno e pane celeste). E ancora: tu perdoni i nostri debiti nell’istante in cui li perdoniamo ai nostri debitori; tu non ci induci in tentazione, ma nella tentazione tu ci liberi dal male.
Anche per padre Vannucci, come per santa Teresa d’Avila, questa fu una vera e propria scoperta. «Dovete scusarmi, ma prima d’ora non me ne ero accorto», furono le parole pronunciate sommessamente, e con un accenno di sorriso che chiedeva comprensione, alcuni mesi prima della morte.
Secondo padre Giovanni Vannucci, questa versione nel nostro idioma della preghiera di Gesù, così diversa da quella che solitamente siamo abituati a recitare, era più fedele all’autentico senso originario della lingua parlata da Cristo ed era coerente con altre parole di lui riportate nei racconti evangelici: «Padre nostro che sei nei cieli, / santo è il Tuo Nome, / il Tuo Regno viene, / la Tua volontà si compie / nella terra come nel cielo. / Tu doni a noi il pane di oggi / e di domani. / Tu perdoni i nostri debiti / nell’istante in cui / li perdoniamo ai nostri debitori. / Tu non ci induci in tentazione, / ma nella tentazione / tu ci liberi dal male».
* Cfr.: Antonio Gentili, Il Vangelo in una sola preghiera (Jesus, n. 8, 1999 - http://www.stpauls.it/jesus00/0899je/0899je70.htm)
-
> GESU’ "CRISTO" --- IL "PADRE NOSTRO". DUEMILA ANNI E PIU’ DI BESTEMMIE! “Padre Nostro”: ci sono voluti 50 anni perché il Vaticano non bestemmiasse più Dio (di Henri Tincq)1 novembre 2013, di Federico La Sala
LA PREGHIERA AL "PADRE NOSTRO" E IL "NON CI INDURRE IN TENTAZIONE". MA CHI E’ IL "PADRE NOSTRO": DIO ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?!
- Nella "Lettera di Giacomo", così sta scritto: "Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio; perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce (...) Non andate fuori strada, fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall’alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c’è variazione né ombra di cambiamento" (vv. 13-16).
- NONOSTANTE TUTTA LA CHIAREZZA LOGICA ED EVANGELICA DELL’APOSTOLO GIACOMO SULLA TENTAZIONE, LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA ANCORA OGGI CONTINUA A INSEGNARE E A CHIEDERE AL "PADRE NOSTRO" DI "NON CI INDURRE IN TENTAZIONE"!!!
 NON C’E’ DA MERAVIGLIARSI: BENEDETTO XVI HA APPENA SCRITTO CHE DIO E’ "MAMMONA" ("CARITAS"): "DEUS CARITAS EST" (2006)... E PAPA FRANCESCO HA SUBITO SOTTOSCRITTO (SENZA PENSARCI DUE VOLTE) LA "LUMEN FIDEI" GIA’ PREPARATA DAL SUO COLLEGA EMERITO... SUL TEMA, SI VEDANO NEL SITO LE NOTE IN QUESTI DUE TITOLI SEGUENTI:
NON C’E’ DA MERAVIGLIARSI: BENEDETTO XVI HA APPENA SCRITTO CHE DIO E’ "MAMMONA" ("CARITAS"): "DEUS CARITAS EST" (2006)... E PAPA FRANCESCO HA SUBITO SOTTOSCRITTO (SENZA PENSARCI DUE VOLTE) LA "LUMEN FIDEI" GIA’ PREPARATA DAL SUO COLLEGA EMERITO... SUL TEMA, SI VEDANO NEL SITO LE NOTE IN QUESTI DUE TITOLI SEGUENTI:
“Padre Nostro”: ci sono voluti 50 anni perché il Vaticano non bestemmiasse più Dio
di Henri Tincq
in “www.slate.fr” del 30 ottobre 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
Rivoluzione nelle fila cattoliche. Ad una scadenza ancora incerta - 2014? 2015? - i fedeli francofoni non reciteranno più la loro preghiera quotidiana favorita, il Padre Nostro, secondo la formulazione in uso da subito dopo il Concilio Vaticano II, quasi cinquanta anni fa (1966). La sesta “domanda” di questa celebre preghiera in forma di suppliche successive fatte a Dio - “Et ne nous soumets pas à la tentation” (non sottoporci alla tentazione) - sarà soppressa e sostituita da “Et ne nous laisse pas entrer en tentation” (non lasciarci entrare in tentazione). Non si tratta di un dettaglio o di una disputa bizantina. È l’epilogo di una battaglia di esperti che dura da mezzo secolo.
La Chiesa pensa di avere l’eternità davanti a sé. Le sono stati necessari 17 anni di lavoro e la collaborazione di 70 traduttori - esegeti, biblisti, innografi - per giungere a questo risultato. 17 anni, è il tempo che è stato necessario per la nuova traduzione integrale della Bibbia liturgica, che, per la Francia, sarà adottata l’8 novembre dai vescovi e che sarà in vendita nelle librerie a partire dal 22 novembre.
Quegli eminenti traduttori sono partiti dai testi originali in aramaico, in greco, in ebraico, e non più dalle traduzioni già esistenti. Ed è questo aggiornamento radicale che ha permesso a questi studiosi, con l’accordo del Vaticano, di giungere alla redazione di un nuovo Padre Nostro, più soddisfacente e più corretto teologicamente.
Il Padre Nostro è la preghiera di base di tutti i cristiani, indipendentemente dalla loro confessione, cattolica, protestante, ortodossa o anglicana. Essa è tanto più sacra in quanto, secondo i vangeli di Luca e di Matteo, è stata insegnata direttamente da Cristo stesso. “Signore, insegnaci a pregare”, gli chiedevano gli apostoli. La risposta di Gesù si trova nelle parole del Padre Nostro, preziosamente riprodotte - “Padre Nostro che sei nei cieli...” - che risalgono così a due millenni fa. Ritrascritta dal greco al latino, è stata poi tradotta nelle lingue parlate del mondo intero.
Questa preghiera, la più comune dei cristiani, può essere recitata o cantata in qualsiasi momento della giornata. Non è codificata come la preghiera dell’islam (cinque volte al giorno e ad ore fisse). Compare in ogni celebrazione della messa dopo la preghiera eucaristica. È anche recitata in tutte le assemblee ecumeniche. È il segno di una volontà di riconciliazione e di unità di tutte le confessioni cristiane, nate dallo stesso vangelo, ma separate dalle loro istituzioni.
Ma perché cambiare oggi un simile monumento della spiritualità cristiana, sul punto preciso della tentazione? Un punto centrale nell’antropologia cristiana. Secondo i vangeli, Cristo ha trascorso quaranta giorni nel deserto ed è stato tentato da Satana: tentazione dell’orgoglio, del potere, del possesso (Matteo 4,11). Gesù stesso ha detto ai suoi apostoli nel giardino del Getzemani, la sera della sua passione, proprio prima del suo processo e della sua morte in croce: “Pregate per non entrare in tentazione”.
Precisamente, cinquant’anni fa, un errore di traduzione è stato commesso a partire dal verbo greco eisphérô che significa letteralmente “portar dentro”, “far entrare”.Questo verbo avrebbe dovuto essere tradotto con: “Ne nous induis pas en tentation” (non indurci in tentazione) o con “Ne nous fais pas entrer en tentation” (non farci entrare in tentazione). I traduttori del 1966 hanno preferito la formula “Ne nous soumets pas à la tentation” (non sottoporci alla tentazione).
Formula contestata. Controsenso, se non addirittura bestemmia, si protesta in seguito. Come è possibile che Dio, che nell’immaginario cristiano è “infinitamente buono”, possa “sottoporre” l’uomo alla tentazione del peccato e del male? È insostenibile.
Tale forma equivoca è stata tuttavia letta dal pulpito in tutte le chiese del mondo francofono, pregata pubblicamente o intimamente da milioni e milioni di cristiani, inducendo, in menti non competenti, l’idea di una sorta di perversità di Dio, che chiede ai suoi sudditi di supplicarlo per sfuggire al male che lui stesso susciterebbe!
Oggi si torna quindi ad una formulazione più corretta: “Et ne nous laisse pas entrer en tentation” (non lasciarci entrare in tentazione). Così il ruolo di Dio è compreso meglio, riabilitato. Dio non può tentare l’uomo. La tentazione è opera del diavolo. È Dio, invece, che può impedire all’uomo di soccombere alla tentazione.
Ora occorre che i protestanti, gli ortodossi, gli anglicani si allineino su questa nuova formulazione cattolica. Nel 1966, i teologi cattolici, protestanti, ortodossi si erano alleati per riflettere su una traduzione veramente ecumenica (con gli stessi termini) del Padre Nostro, che non esisteva prima della rivoluzione del Concilio Vaticano II. Avevano proposto un testo comune alle loro Chiese, che lo avevano adottato. Senza dubbio oggi si metteranno nuovamente d’accordo per ratificare la nuova preghiera nei termini già definiti dai cattolici. Anche solo per smentire coloro che si lamentano dello stato di avvicinamento ecumenico che avrebbe perso vigore e si preoccupano del risveglio di riflessi comunitari.
-
> GESU’ "CRISTO" --- IL "PADRE NOSTRO". DUEMILA ANNI E PIU’ DI BESTEMMIE! --- «Non dire: Mi sono sviato per colpa del Signore, perché Egli non fa ciò che detesta»1 novembre 2013, di Federico La Sala
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DI GIACOMO, DA *
[...] Agapan è il verso dell’amore gratuito, oblativo e fedele capace di porre l’amato al di sopra di tutto, anche di se stessi e di ogni proprio interesse. È la prima indicazione dello shema’ Israel: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze» (Dt 6,4-5; Mt 22,34-40).
1,13-15: Riprendendo una riflessione del Siracide (Sir 15,11-17: «Non dire: Mi sono sviato per colpa del Signore, perché Egli non fa ciò che detesta»), Giacomo ribadisce che la tentazione non viene da Dio, che detesta il male e non spinge nessuno al male. Essa viene piuttosto dal cuore dell’uomo, da cui si producono pensieri desideri e azioni cattive, che contaminano l’uomo (Mt 15,15-20).
Si descrive poi la genesi del peccato a partire dal cuore: la concupiscenza (epithymia), desiderio smodato e possessivo, che pretende l’afferrare immediato dell’oggetto del proprio godimento, trascina (exelkomenos) e seduce (deleazomenos), portando a concepire (syllabousa) il peccato già nell’intimo del cuore, sino a partorirlo (tiktei amartian). Una volta portato a compimento (apotelestheisa), il peccato procura la morte (apokyei thanaton). La seduzione da parte della concupiscenza è descritta al pari del fascino perverso della donna sfacciata, della maritata in veste di prostituta che compare nei Proverbi (Pr 7,6-27): essa si fa strada con dolce lusinga, sino a far cadere in trappola. Analoga descrizione quasi psicologica del generarsi del peccato dal desiderio la si trova nei Salmi: «Ecco, l’empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna» (Sal 7,15).
Il processo verso il peccato, sotto il pungolo lusinghiero della tentazione è descritto in Gen 3: la donna fa spazio nel suo cuore alla parola del tentatore che fa concepire al suo cuore il desiderio, sino alla consumazione dell’atto trasgressivo, che tende a propagarsi, procurando divisione e morte. Giacomo descrive in modo paradossale un processo generativo interno al cuore, pari a quello che accade nel grembo di una donna, il quale, tuttavia, anziché produrre vita genera morte.
Non si tratta qui con buona probabilità della morte in senso escatologico, quale pena eterna dei dannati; si tratta piuttosto di una situazione esistenziale e spirituale ormai incapace di produrre frutti di opere buone. Più avanti, nella terza parte, l’apostolo riprende la riflessione sui desideri smodati del soggetto che procurano guerre e divisioni, diventando peccati sociali, generatori di una cultura di morte (4,1-2).
b) 1,16-17: Il secondo passo, descrive un movimento contrapposto al primo: l’uomo, cogliendo la sua fragilità apre il suo cuore verso l’alto, implorando il dono buono e perfetto (pasa dosis agathe kai pan dorema teleion) della Sapienza, che proviene dal Padre della luce. Questi è descritto ancora nei suoi tratti essenziali di chi non ha alterazione (parallaghe), né ombra di mutazione (tropes aposkiasma), tratti che rafforzano l’idea già sopra espressa di una generosità tutta luminosa, senza ombre né pentimento [...]
*
http://www.diocesilucca.it/documenti/sussidio_lettera_giacomo.pdf
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- “Sdemonizzare” Dio! Una “tentazione” teologicamente corretta (di Stéphanie Le Bars - "Le Monde")17 ottobre 2013, di Federico La Sala
Una “tentazione” teologicamente corretta
di Stéphanie Le Bars
in “Le Monde” del 17 ottobre 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
Ci sono voluti cinquant’anni alla Chiesa cattolica e ai suoi esegeti per, in un certo senso, “sdemonizzare” Dio. Dal 22 novembre prossimo, una nuova traduzione [in francese] del Padre Nostro ridarà al Dio cristiano il posto che gli spetta. E i milioni di cattolici francofoni che recitavano, pur senza saperlo, un testo erroneo, torneranno sulla retta via.
Quindi, alla sesta richiesta di tale preghiera basilare per i cristiani, non bisognerà supplicare “ne nous soumets pas à la tentation” (non sottoporci alla tentazione), ma “ne nous laisse pas entrer en tentation” (non lasciare che entriamo in tentazione). Una formula certo meno felice dal punto di vista della fluidità lessicale, ma teologicamente più corretta, secondo i numerosi specialisti che hanno studiato da decenni questa frase controversa.
La traduzione del 1966, basata su un compromesso ecumenico tra cattolici, protestanti riformati e ortodossi, era stata considerata “blasfema” da alcuni teologi fin dalla fine degli anni ’60 e rifiutata dalle correnti più tradizionaliste. La formulazione faceva infatti pensare che Dio stesso incitasse i fedeli a soccombere alla tentazione. “Quella traduzione presuppone una certa responsabilità di Dio nella tentazione che porta al peccato, al male. Ma in tutto il Nuovo Testamento, non si dice che Dio tenta la creatura umana”, ricordava nel 2011 Mons. Hervé Giraud, vescovo di Soissons e autore di un testo che riassume gli annessi e i connessi di questo tema spinoso. “Normalmente è il diavolo che si incarica di questa operazione”, insisteva.
Fin dal 1969, l’abate Jean Carmignace sottolineava nella sua tesi “Ricerche sul Padre Nostro”, le difficoltà di interpretazione sollevate dal passaggio dall’ebraico al greco e dal greco al francese. Il religioso proponeva ai fedeli una formula meno compromettente: “Fais que nous n’entrons pas dans la tentation”(Fa’ che non entriamo in tentazione). Nel corso degli anni, alcuni, tra i protestanti, hanno preferito l’espressione “ne nous laisse pas entrer en tentation” (non lasciarci entrare in tentazione), un’espressione adottata nel 2000 dalla Bibbia di Gerusalemme.
Altri hanno proposto “ne nous induis pas en tentation” (non indurci in tentazione) o anche “ne nous introduis pas en tentation” (non introdurci in tentazione), opzioni tutte giudicate inadatte. I più anziani ricordano la formula anteriore al Vaticano II (1962-1965), in cui si dava rigorosamente del “voi” a Dio: “Ne nous laissez pas succomber à la tentation” (Non lasciateci soccombere alla tentazione).
La modifica apportata ora alla preghiera che, secondo la tradizione, sarebbe stata trasmessa da Gesù stesso agli apostoli, è il risultato di un lungo lavoro iniziato diciassette anni fa da decine di traduttori. È la parte più visibile, quella di cui il grande pubblico si accorge, di un impegno molto più vasto che mira a proporre una nuova versione della Bibbia per la liturgia francofona. Si annunciano ad esempio cambiamenti nel testo delle Beatitudini.
Verosimilmente ci vorranno anni prima che le chiese risuonino del frutto di questo lavoro, convalidato in luglio dal Vaticano. In Francia, questa versione sarà presentata ai vescovi nella loro assemblea plenaria di inizio novembre a Lourdes. Poi la “Bibbia ufficiale di 2.928 pagine” sarà venduta al “prezzo di lancio di 59.90 euro”, secondo la rivista Famille chrétienne, che annunciava questo “evento importante per la Chiesa” fin dal 5 settembre.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- "Io ritengo che Gesù venga da Dio perché le cose che dice sono davvero di origine divina, cioè sono davvero il meglio, il più divino che ho trovato nella mia storia" (Gianni Vattimo).3 luglio 2013, di Federico La Sala
Vattimo: «Quelle sue parole sono di origine divina»
di Gianni Vattimo (Avvenire, 03 luglio 2013)
- Nel volume «Interrogazioni sul cristianesimo. Cosa possiamo ancora attenderci dal Vangelo?» il filosofo GIanni Vattimo e il teologo Pierangelo Sequeri, si confrontano con il contraddittorio atteggiamento del nostro tempo verso la religione e, in particolare, con il ruolo del messaggio cristiano e della Chiesa nella società postmoderna. "Io ritengo che Gesù venga da Dio perché le cose che dice sono davvero di origine divina, cioè sono davvero il meglio, il più divino che ho trovato nella mia storia. Quello che mi impressiona è la perfezione del suo messaggio, prima e più che i suoi miracoli".
Io ritengo che Gesù venga da Dio perché le cose che dice sono davvero di origine divina, cioè sono davvero il meglio, il più divino che ho trovato nella mia storia. Quello che mi impressiona è la perfezione del suo messaggio, prima e più che i suoi miracoli. Non mi faccio impressionare, ad esempio, dalla risurrezione di Lazzaro, perché tutto dipenderebbe dalla fede che presto agli scritti che me ne parlano: infatti, chi mi parla della risurrezione di Lazzaro? È difficile pensare all’esistenza di altri documenti antichi, oltre ai Vangeli, in cui si parli di uno che ha risuscitato un tale di nome Lazzaro...
Credo che Schleiermacher non si esprimesse in termini molto diversi (anche se più attenuati dei miei) quando scriveva che Gesù Cristo è l’uomo che ha realizzato il più possibile la vicinanza e il senso di dipendenza da Dio: Gesù sarebbe l’esempio più grande, sotto questo profilo, e noi ci salveremmo in quanto in contatto storico-sacramentale con lui (mediante i Vangeli, il culto) come massimo eroe della coscienza religiosa dell’umanità.
Io non seguirei per intero il percorso di Schleiermacher, ma nemmeno mi interessa granché stabilire se Gesù sia di natura divina o di natura umana, se in lui vi siano due nature e una persona, o tutte le altre questioni in cui si avviluppa la teologia di oggi. (...)
Io credo nella divinità di Gesù Cristo soprattutto per ciò che lui mi ha detto; anzi, posso persino ammettere che egli sia resuscitato sulla base del fatto che tutte le altre cose che mi dice sono così attraenti che non posso non credergli. Insomma, è come se, avendolo visto, mi sia innamorato di lui e sia quindi divenuto capace di dargli ascolto. Del resto è proprio san Paolo ad affermare che la fede è sempre fides ex auditu. Non è quindi inverosimile pensare alla propria fede come all’essere presi da un messaggio affascinante - per dirla con un aggettivo certamente inadeguato - insomma capace di prenderti. (...)
Se qualcuno mi chiedesse perché preferisco Gesù Cristo a Buddha, risponderei: «Perché sono stato educato nel cristianesimo». E se mi si obiettasse che questo è un limite, risponderei che non posso certo cavarmi gli occhi per vedere meglio. Io ho una tradizione e vivo al suo interno: anzi, per proseguire con l’esempio della preferenza a Cristo anziché a Buddha, direi che il buddhismo ancora non l’ho giudicato perché non è una religione positivamente dogmatica, e che piuttosto solo nel cristianesimo trovo le ragioni per interessarmi anche al buddhismo e ad altre tradizioni.
Sono quindi convinto, in primo luogo, che la mia fedeltà al Vangelo è anche (o soprattutto, chi lo sa?) fedeltà a una tradizione umanistico- culturale- politica che è la tradizione europea; non riesco a separare nettamente queste due realtà, quasi esistesse un cristianesimo esterno all’Occidente e ad esso invece non profondamente avviluppato.
Sono poi convinto che la verità dell’Occidente è il cristianesimo, e, viceversa, che la verità del cristianesimo è oggi l’Occidente (non necessariamente in senso per così dire eterno, ma considerando che il «cristianesimo » è anche la «cristianità », al cui interno peraltro il fermento cristiano opera criticamente, rimettendo in discussione assetti stabiliti, invitando all’ascolto di altre tradizioni religiose, ecc.).
In definitiva io non ho scelto di stare nella tradizione cristiana: vi sono dentro, prendendo atto dell’esistenza di una quantità di cose che ho pensato come separate da questa tradizione mentre in realtà ad essa mi riconducono. Di ciò prendo atto anche criticamente, ovvero senza alcun esclusivismo o integralismo, quasi che ora si dovesse smettere di leggere tutti gli autori contemporanei e fermarsi solo al Vangelo o a certi contenuti dell’insegnamento della Chiesa.
Piuttosto, io rimango nella tradizione cristiana perché ritengo che anche Voltaire si trovava al suo interno, e, con lui, tutta la democrazia moderna. Semmai contrappongo talvolta un brano di questa tradizione - che a me sembra dotato di qualche autenticità - ad altri che magari trovo più autoritari, dogmatici; in ogni caso, è sempre all’interno di questa tradizione che mi muovo. Per me essere cristiano è come accettare la mia finitezza, peraltro descritta dalla Sacra Scrittura.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- IL FIGLIO DI GIUSEPPE E MARIA NON IL FIGLIO DI ADANO ED EVA! Il battesimo (di Giuseppe Dossetti).11 gennaio 2013, di Federico La Sala
Il battesimo
di G.Dossetti (dalla Omelia del sabato di Pasqua - 1970)
“Una sola cosa diciamo: un ulteriore commento lo faremo in un atto di potenza, tra pochi istanti, con la celebrazione del rito del battesimo che è rito di potenza, con il quale nel nome del Signore, in Cristo risorto, per la potenza dello Spirito, la comunità della Chiesa che siamo tutti noi genera alla vita divina un nuovo figlio.
Battezzeremo adesso un piccolo con la nuova acqua battesimale fecondata dalla potenza dello Spirito del Signore risorto. E’ questa, per eccellenza, l’ora messianica, nella quale viene compiuta veramente la nuova creazione. Come l’antica creazione, come il primo mondo uscito all’inizio dalle mani di Dio e violato poi dal peccato, aveva un capo e delle membra, Adamo e i suoi discendenti, così il nuovo mondo, la nuova creazione scaturita da questa notte pasquale, ha un nuovo capo e nuove membra: il capo, il Cristo risorto; le membra, i figli rigenerati dall’acqua del battesimo fecondata dalla potenza del suo Spirito effuso attraverso la sua passione e la sua risurrezione.
E noi ci dobbiamo sempre più abituare - ed ecco il commento nel rito di potenza che compiremo adesso - a vedere questa notte pasquale non solo come la notte in cui Cristo è risorto, ma la notte in cui viene al mondo un uomo nuovo, un uomo diverso da quello che viene generato secondo la carne e il sangue.
Il bimbo che fra poco battezzeremo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, generato dai suoi genitori è carne e soffio vitale, ma generato dall’acqua scaturita dal costato di Cristo, nella potenza del battesimo della sua morte e della sua risurrezione, è carne e Spirito Santo. Il suo destino umano sarebbe la morte, il destino divino che viene suggellato su di lui dal risorto presente tra noi e tra noi operante è la vita e la vita divina.
Ecco allora quello che non noi, ma il Signore presente tra di noi opererà tra poco.”
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ----- La fabbrica del bene tra carità e diritti (di Adriano Sofri)7 gennaio 2013, di Federico La Sala
La fabbrica del bene tra carità e diritti
di Adriano Sofri (la Repubblica, 7 gennaio 2013)
La crisi moltiplica i circoli viziosi, fino a quando non si trovi il modo di spezzarli. In uno, l’impoverimento rende sempre più preziose le attività solidali (“di mutuo soccorso”, ha scritto Gad Lerner) cui però mancano sempre più le risorse materiali e umane. Nessuno saprebbe tenere un vero conto di come una società di tagli e grattaevinci vada avanti attraverso la solidarietà, famigliare prima di tutto, e poi di vicini, volontari, associazioni. Quanto ai conti internazionali più autorevoli sulla filantropia, paiono anch’essi azzardati, misurando denaro e comportamenti, entità di donazioni, tempo dedicato alla buona volontà, cura dello straniero. Un’accreditata classifica sulla beneficenza è redatta dalla britannica Charities Aid Foundation.
Alla vigilia di Natale veniva citata con enfasi la caduta dell’Italia dal 29° posto del 2010 al 104° del 2011. Una degradazione troppo forte, anche considerando l’incidenza della solidarietà col terremoto in Abruzzo. Ora il consuntivo del 2012 ha riportato l’Italia al 57° posto. A parte lo sconcerto per gli alti e bassi, teniamo un posto assai mediocre fra i paesi “avanzati”. Si annuncia dunque come una novità importante per l’Italia la formazione alla “filantropia strategica”, “beneficenza scientifica”.
Si è tentati di sorridere dell’annessione della carità a scienza e strategia, o sentirci odore d’affari, come si irrideva alle brave dame (“pour faire une bonne dame patronnesse, il faut être bonne, mais sans faiblesse...”).
La carità, spiegano gli esperti, è altra cosa dalla filantropia: se non fraintendo, è la famosa differenza fra dare un pesce all’affamato, o insegnargli a pescare. Di più: il passaggio della filantropia dalla spontaneità alla scienza vuole insegnare ai sazi a insegnare a pescare. Ci si potrà vedere un passo verso il superamento del divario enorme fra l’Italia - e l’Europa in genere - e gli Stati Uniti, dove la combinazione fra individuo e comunità produce un ingente investimento nella beneficenza in senso lato. Le donazioni restano una vocazione eminentemente americana e, ai nostri occhi, mirabolante. Nel novembre del 2011 i signori Dorothy e Robert King hanno donato 150 milioni di dollari all’università di Stanford, di cui lui è ex alunno, per un programma destinato ad alleviare la povertà nei paesi in via di sviluppo.
Nell’ottobre 2012 il finanziere John Paulson (hedge fund ecc.) ha donato 100 milioni di dollari all’organizzazione no-profit che cura la manutenzione del Central Park. Decine di personaggi fra i più ricchi del mondo - ma tutti americani - hanno aderito all’impegno promosso da Bill Gates e Warren Buffett a devolvere almeno il 50 per cento della propria ricchezza a scopi di filantropia. Compreso il giovane Zuckerberg, che intanto ha dato 100 milioni alle scuole di Newark da cui proviene.
La vecchia Europa “socialista” può contrapporre una propria idea di “redistribuzione” della ricchezza sociale alla “restituzione” cui si ispira la filantropia americana, affidandosi la prima all’equità del governo, la seconda alla benevolenza dei privati. I risultati però non ci danno ragione, in particolare nella pratica delle successioni ereditarie. Una differenza più particolare riguarda l’Italia, o la Spagna. La nostra carità ha un’impronta più cattolica e castigata, controriformata. La beneficenza è stata essenzialmente affare della Chiesa, cui lo Stato la delegava volentieri, per convenienza e per servilismo. Diversa è anche la gratificazione del riconoscimento pubblico.
Da noi la discrezione, così spesso ipocrita, sta a metà fra modestia evangelica (non sappia la tua mano destra, fa’ il bene e scordalo ecc.) e vergogna di essere ricchi; e la vergogna oscilla anche lei fra l’altruismo e l’imbarazzo sull’origine della ricchezza. Alla discrezione di precetto lo Stato aderisce con entusiasmo, astenendosi dal tassare solo una piccola percentuale della ricchezza devoluta in beneficenza dai singoli. C’è il luogo comune del differente trattamento fiscale della beneficenza. Ne leggo una smentita drastica nel libro di Francesco Antinucci, “Cosa pensano gli americani” (Laterza 2012): “Consiglio la lettura dell’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate, sulle Erogazioni liberali... Ci sono differenze tra Italia e Stati Uniti, ma sostanzialmente i due trattamenti si equivalgono.
Anzi, in alcuni casi, quello italiano è addirittura più vantaggioso per il donatore. Per esempio,l’importantissima classe di donazioni alle università e agli enti di ricerca scientifica, in Italia è deducibile dal reddito senza alcuna limitazione, mentre negli Stati Uniti è soggetta alla soglia del 50 per cento del reddito. Invece, in Italia, le persone fisiche possono detrarre soltanto fino al 10 per cento del reddito, le imprese senza alcuna limitazione. In America, resta il 50 per cento del reddito per tutti, persone fisiche e imprese”.
La differenza è rilevante, dal momento che, come informa lo stesso Antinucci, le donazioni personali negli Stati Uniti coprono l’88 per cento del totale. Abbastanza incongruamente, l’Europa applica le norme più disparate, dal 25 per cento di deduzione in Spagna al 100 in Austria. Del resto, benché la facilitazione fiscale incida, non è la causa principale dell’impulso alla donazione, che è piuttosto culturale e, in senso lato, religioso.
Ezio Mauro sottolineava qui nello scorso novembre la distinzione della democrazia dei diritti “dalla ‘democrazia compassionevole’ e anche dalla ‘Big society’ che sostituiscono la benevolenza individuale e dei gruppi sociali all’organizzazione dello Stato sociale, la carità ai diritti. La beneficenza non ha bisogno della democrazia ma in democrazia, la solidarietà sociale ha bisogno di qualcosa di più della beneficenza: i diritti”. Il rischio è che la crisi tagli diritti e carità. Fece allora scalpore in Spagna il gesto di Amancio Ortega Gaona, fondatore e presidente del più grande gruppo tessile, Inditex, produttore fra altri del marchio Zara, terzo uomo più ricco del mondo per la classifica di Bloomberg, nella quale ha spodestato Warren Buffett, quello che vorrebbe pagare più tasse della sua segretaria. Il signor Ortega, leggendariamente alieno da interviste e comparse pubbliche, ha regalato alla Caritas spagnola 20 milioni di euro. La cifra era imponente, ma non ha impedito a molti commentatori di calcolare che corrispondeva allo 0,05 per cento del suo patrimonio, e che un comune cittadino spagnolo con un patrimonio di 10 mila euro, in proporzione avrebbe dato in beneficenza 5 euro. Le monete hanno sempre due facce.
O tre, con quella politica. La “filantropia strategica”, quella attenta all’efficacia delle risorse investite, quella in cui uomini e donne di formidabile successo trasferiscono talento e passione facendone il proprio impegno primario, da Bill Gates in giù, può ottenere risultati magnifici, in particolare nell’istruzione e negli scambi col mondo povero. Possono imparare e insegnare a pescare. Ma resta il vecchio dilemma. Resta quello che ha fame, qui e ora, e bisogna dargli un pesce. (Teniamo la parabola, anche se il problema sta diventando per ricchi e poveri la scomparsa dei pesci). Bisogna che ci siano delle mense con un pasto caldo, delle stanze con una branda e una coperta.
Non è solo un urgente problema sociale, ma diventa un problema politico, esemplificato vistosamente da quel genere di beneficenza selettiva - razzista, per dirla intera - su cui Alba Dorata in Grecia e filiali altrove lucrano il proprio seguito popolare. La parola d’ordine: “I Greci prima di tutto”, o “Gli Italiani”, o “I Padani”, e così via (che vuol dire: “I Greci e basta”, “i Padani e basta”...) fa una presa molto più forte e torbida quando si rivolge agli impoveriti. C’è dunque anche una carità, o una filantropia, che baratta un piccolo bene con un grande male, e rende odiosa se stessa. Chi abbia frequentato i luoghi in cui la carità si esercita all’ingrosso, sa in quale terribile tentazione di iniquità siano indotti i suoi benevoli attori. E poche forme di potere sono rischiose quanto quella di chi ha in mano un pane superfluo davanti alla fila degli affamati.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- Berlino, lite sul sesso di Dio. Qual è il «sesso di Dio» spiegato ai bambini? Il ministro per la Famiglia tedesco, Kristina Schröder: «Dio diventi neutro: basta con il maschile».22 dicembre 2012, di Federico La Sala
 «Dio diventi neutro: basta con il maschile»
«Dio diventi neutro: basta con il maschile»
 Berlino, lite sul sesso di Dio
Berlino, lite sul sesso di Dio
 La ministra: «Sia neutro»
La ministra: «Sia neutro» di Paolo Lepri (Corriere, 22.12.2012)
di Paolo Lepri (Corriere, 22.12.2012)-*** «Dio deve diventare neutro: basta indicarlo con il maschile». Il ministro per la Famiglia tedesco, Kristina Schröder, cristiano-democratica, nota per le battaglie contro il femminismo, in un’intervista ha detto di trovarsi in imbarazzo con la sua piccola Lotte, un anno e mezzo, parlando di Dio.
BERLINO - Qual è il «sesso di Dio» spiegato ai bambini? Non si tratta di un dibattito teologico-grammaticale che potrebbe escludere quel 16 per cento della popolazione mondiale che secondo un recente studio del «Pew Forum on Religion and Public Life» si professa non credente.
È qualcosa di più, e riguarda tutti coloro che hanno figli piccoli, perché il problema del «genere» nell’educazione infantile è ormai all’ordine del giorno in molti Paesi europei. Lo dimostra la proposta del governo francese di inserire nel libretto di famiglia la dizione «genitore 1» e «genitore 2» al posto del padre e della madre, e il riaffacciarsi in Svezia del pronome neutro per sostituire il «lui» e il «lei» nell’asilo.
In Germania, è stato il ministro per la Famiglia, Kristina Schröder, cristiano-democratica, nota per le sue battaglie contro il «femminismo storico», a fare discutere tutti. In questo caso, si è iniziato a parlare di religione, ma il vero scontro è sulla figura dell’uomo e della donna nell’immaginario dei bambini.
In un’intervista al settimanale Die Zeit, Kristina Schröder ha detto di trovarsi in imbarazzo con la sua Lotte (un anno e mezzo) parlando di Dio al maschile, come avviene nella lingua tedesca, e ha aggiunto che sarebbe meglio usare l’articolo «das», con cui si precedono i nomi di genere neutro. «Ciascuno - ha detto - dovrebbe decidere per conto proprio». Una riflessione, questa, che è stata accompagnata da critiche al «sessismo» delle fiabe e della letteratura per bambini in cui «raramente si trovano figure positive di donne».
Le parole della Schröder sono state accolte con una raffica di proteste. Christine Haderthauer, ministro per gli Affari sociali della Baviera, le ha definite una «sciocchezza intellettualistica». Un altro esponente cristiano-sociale, il parlamentare Stefan Müller, ha osservato che «Dio appare a noi come il Padre di Cristo e così dovrebbe rimanere». Secondo un eminente teologo cattolico, padre Wilhelm Imkamp, l’idea di rendere neutro il Padreterno è «stupida, insolente e testimonianza di opportunismo».
L’unico a gettare acqua sul fuoco è stato Klaus-Peter Willsch, parlamentare della Cdu nell’Assia (il Land dove Kristina Schröder sarà capolista nelle elezioni del prossimo autunno), suggerendo che «per chi cerca una figura di genere neutro, c’è Gesù Bambino». Alla parola Christkind, infatti, si accompagna «das». «Per chi crede in Dio l’articolo è indifferente», ha risposto il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert, durante il consueto briefing del governo.
Secondo un collaboratore di Kristina Schröder, Benedetto XVI «ha scritto che Dio non è né uomo né donna» e quindi «i critici del ministro non dovrebbero essere più "papali" del Papa». E lei, la diretta interessata? Ha ricordato alla Bild che si stava riferendo ad una bambina e non ai tanti adulti «inciampati» sulle sue parole. Ma non è detto che tutto finisca qui.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- "L’infanzia di Gesù" secondo Ratzinger - Benedetto XVI.11 ottobre 2012, di Federico La Sala
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. ---- E IL "PADRE NOSTRO". Dio ci induce in tentazione? (di Hervé Giraud - "temoignage chretien").18 giugno 2011, di Federico La Sala
Premessa (fls):
"Signore, insegnaci a pregare" (Lc., 11.1)
Dio è Amore - Deus charitas est
PRIMA LETTERA DI GIOVANNI (1 Gv.: 4, 1-16).
Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. ... Dio è Amore
Charissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint: quoniam multi pseudoprophetæ exierunt in mundum.... Deus charitas est
O AMORE,
SPIRITO SANTO
 PADRE NOSTRO,
PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI,
CHE SEI NEI CIELI,
 SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,
 VENGA IL TUO REGNO,
VENGA IL TUO REGNO,
 SIA FATTA LA TUA VOLONTA’
SIA FATTA LA TUA VOLONTA’
 COME IN CIELO COSI’ IN TERRA.
COME IN CIELO COSI’ IN TERRA. TU CI DAI OGGI IL NOSTRO PANE PIU’ SOSTANZIOSO,
TU CI DAI OGGI IL NOSTRO PANE PIU’ SOSTANZIOSO,
 E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
 COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI.
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI.
 TU NON CI INDUCI IN TENTAZIONE
TU NON CI INDUCI IN TENTAZIONE
 MA CI LIBERI DAL MALE.
MA CI LIBERI DAL MALE.
 COSI E’: COSI SIA.
COSI E’: COSI SIA.
 AMEN.
AMEN.
Dio ci induce in tentazione?di Hervé Giraud
 in “www.temoignagechretien.fr” del 17 giugno 2011
in “www.temoignagechretien.fr” del 17 giugno 2011
 (traduzione: www.finesettimana.org)
(traduzione: www.finesettimana.org)Nel Padre Nostro, ogni parola ha la sua importanza. Mentre la Conferenza episcopale francese lavora ad una nuova traduzione liturgica francofona della Bibbia, Mons. Giraud, vescovo di Soissons, ha voluto offrire ai lettori del suo blog - e ai cattolici in generale - la sua visione di una frase particolarmente importante del vangelo di Matteo: “Non indurci in tentazione”. Se questa frase sarà cambiata, bisognerà abituarsi a dire questa preghiera in modo diverso. Se no, la riflessione proposta pubblicamente dal vescovo permette, a suo avviso, di comprendere meglio il rapporto dei cattolici con la tentazione. Questo dibattito c’è stato del resto anche tra gli anglosassoni che stanno mettendo a punto il loro nuovo messale e dovrebbero utilizzarlo a partire dall’Avvento 2011.
«La nuova versione del Padre Nostro è apparsa nella liturgia cattolica in Francia con la messa della Veglia pasquale del 1966. Una richiesta poneva problema sia dal punto di vista teologico che da quello esegetico o filosofico: “Ne nous laissez pas succomber à la tentation” (non lasciarci soccombere alla tentazione) era diventato “Ne nous soumets pas à la tentation” (non sottoporci alla tentazione). Attualmente, nessuno è soddisfatto della traduzione ecumenica della sesta richiesta del Padre Nostro. In effetti, questa traduzione presuppone una certa responsabilità di Dio nella tentazione che ha condotto al peccato, al male.
La parola peirasmos potrebbe certo essere tradotta con “prova” e non con “tentazione”. Ma “non sottoporci alla prova” sembra chiedere a Dio di farci rifuggire dalla condizione umana normale, segnata dalla prova.
La traduzione letterale del testo greco di Matteo 6,13 dovrebbe essere “Ne nous induis pas en tentation” (non indurci in tentazione) o “Ne nous fais pas entrer en (dans la) tentation”, “Ne nous introduis pas en tentation” (non farci entrare, non introdurci nella tentazione). Il verbo eisphérô significa etimologicamente “portare dentro”, “far entrare”. La tentazione è vista come un luogo nel quale Dio ci introdurrebbe. Ma Dio potrebbe “introdurci” in tentazione? Questo verbo esprime un movimento locale verso un luogo dove si penetra. Fa pensare a Gesù, quando è condotto dallo Spirito nel deserto per esservi tentato (Mt 4,11), o anche nel Getsemani: “Priez pour ne pas entrer en tentation” (pregate per non entrare in tentazione) (Mt 26,41). Ora, in tutto il Nuovo Testamento, non è mai detto che Dio tenti la sua creatura umana. La formula sembra supporre che Dio possa tentare l’uomo, mentre è il diavolo che si incarica normalmente di questa operazione. Dio non è l’autore della tentazione.
Sono state studiate diverse traduzioni. “Ne nous soumets pas à la tentation” (non sottoporci alla tentazione): questa traduzione evoca l’immagine di un Dio che fa subire la tentazione e che sarebbe come l’autore della tentazione. “Fais que nous n’entrions pas en (dans la) tentation” (fa che non entriamo in tentazione): questa traduzione cerca di scagionare Dio dall’essere l’autore della tentazione. “Ne nous fais pas entrer dans la tentation” (non farci entrare in tentazione): certo, “entrare in tentazione” non significa necessariamente soccombervi, ma significa entrare in quella situazione critica in cui Satana (il Male) comincia a raggiungerci e in cui noi rischiamo, a causa della nostra debolezza, di lasciarci vincere. Tuttavia rischia di designare ancora una certa responsabilità di Dio nella tentazione.
“Ne nous laisse pas entrer en tentation” (non lasciarci entrare in tentazione); questa traduzione sarebbe la migliore anche perché si avvicinerebbe ad una fonte letteraria aramaica. In francese “lasciar fare” vuol dire “non impedire”. “Non lasciar fare” ha il senso positivo di “impedire”. Dio può permettere che noi entriamo nella tentazione e darci la forza di poterne “uscire”.
Dio non ci tenta, ma ci mette talvolta alla prova permettendo a Satana (il Male) di tentarci per purificarci. Con questa traduzione, noi supplichiamo Dio “Non permettere neppure che entriamo in tentazione”. Noi gli chiediamo di intervenire in nostro favore per allontanare dalla nostra strada un pericolo temuto, quello di rischiare di essere separati da Lui e dal suo Popolo.
La traduzione liturgica della Bibbia potrebbe quindi scegliere di proporre “E ne nous laisse pas entrer en tentation” sulla base di Matteo 26,41. Già la Bibbia di Segond del 1964 riprendeva l’espressione “Ne nous laisse pas entrer en tentation”, come farà la Bibbia di Gerusalemme del 2000. La sua introduzione nel Padre Nostro della messa e nell’uso corrente attende un accordo dei vescovi, di tutte le Chiese e le Comunità ecclesiali francofone, perché è importante che i cristiani continuino a dire insieme la preghiera che il Signore ha insegnato.»
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. ---- E IL "PADRE NOSTRO". “Credo nello Spirito Santo” (di di Guy-Marie Riobé - vescovo di Orléans, membro dell’Union fondata da Charles de Foucauld).19 giugno 2011, di Federico La Sala
Lo Spirito, secondo Monsignor Riobé
di Guy-Marie Riobé
in “www.baptises.fr” del 10 e 12 giugno 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
“Credo nello Spirito Santo”: con questo titolo, in una serie intitolata “Une brassée de confessions de foi”, per iniziativa di Henri Fesquet, “Le Monde” del 10 luglio 1978 ha pubblicato questo testo di Monsignor Guy-Marie Riobé, vescovo di Orléans (membro dell’Union fondata da Charles de Foucauld). Otto giorni prima della sua morte.
Quando potremo allora, liberati dalle nostre formule esangui e dalle nostre astrazioni, confessare la nostra fede nello Spirito Santo con una parola capace di andare da cuore a cuore, come una fiamma ne chiama un’altra?
Credere nello Spirito, è credere nella vita, è credere che ogni vita avrà in Lui, definitivamente, vittoriosamente, l’ultima parola su tutte le fatalità di disgregazione, di immobilismo e di morte.
Credere nello Spirito, è credere nella storia come storia di salvezza, storia di liberazione dell’uomo, di tutti gli uomini. Credo allo Spirito Santo non come ad una porta aperta per evadere, ma come alla sola speranza che possa, in definitiva, animare la storia degli uomini.
Credo nello Spirito che anima oggi le grandi spinte di liberazione che tendono verso una universalità umana concreta, diversa, capace quindi di comunione fatta attraverso l’uguale dignità e il libero incontro dell’uomo e della donna, delle etnie, delle culture.
Credo nello Spirito che vibra nelle grida del Terzo Mondo come un appello alla condivisione dei beni della terra, al rispetto dei popoli a lungo disprezzati, al dialogo delle civiltà riconosciute nelle loro differenze e nella loro originalità.
Ogni uomo è mio fratello perché siamo tutti figli di uno stesso amore. Ogni uomo è sacro per me perché ogni uomo è figlio di Dio. E Credo nello Spirito che nello stesso tempo fa crescere nei nostri paesi, in maniera talvolta selvaggia, sconcertante, una grande sete di senso.
È fuori dalle nostre Chiese, lo so, che molti uomini cercano quel Dio d’amore che solo lo Spirito può farci conoscere ed amare. Mi dispiace, ma li capisco. Tutte le istituzioni, tutti i segni, anche i più sacri, si degradano se non accettano ad ogni primavera di cambiar pelle, a qualsiasi costo, anche a costo di accettare lacerazioni e sofferenze. Le nostre comunità, come tutte le istituzioni, non sfuggono al tempo e alla sua usura.
La Chiesa, in diversi momenti della sua storia, ha avuto paura dello Spirito, ha smesso di essere mistica e creatrice per diventare giuridica e moralizzatrice. Allora le burrasche dello Spirito hanno soffiato alla sua periferia e a volte contro di lei in una grande esigenza di vita creatrice, di giustizia e di bellezza. “Ci sono atei che grondano parola di Dio”, diceva Péguy, ed è tuttora vero.
Credo che Dio ci accompagni tutti nella nostra avventura umana e che solo la sua presenza sia eterna, e non le strutture, le parole, le immagini che, a poco a poco, nel corso dei secoli, abbiamo adottato per dire a noi stessi la sua presenza tra noi. La nostra Chiesa non ha nulla da temere dalle critiche che le vengono da altri, se sa ascoltarle come un appello di Dio.
Essa non può sprangare le porte per disporre più sicuramente di se stessa. Essa riceve ad ogni istante da Dio per essere continuamente inviata, immersa nel mondo, povera, modesta, fraterna, messaggera di gioia, prestando la sua voce ai poveri, agli uomini che vengono torturati o uccisi, a tutti coloro che ci gridano silenziosamente il Vangelo. È questa per la Chiesa, e per ogni cristiano, la necessità, talvolta l’urgenza, di discernere e di fondare la ragione dei propri atteggiamenti, delle proprie reazioni davanti a tutti i grandi movimenti della storia. Discernere senza spegnere o contristare il libero sgorgare dello Spirito e della vita che suscita.
Così potremo ritrovare l’attualità di quei grandi risvegli umani, venuti dal cuore dell’uomo comedelle pentecoste successive. È Dio che, attraverso tutta quella corrente che chiamiamo profetica, difende la sua opera, impedisce che sia mutilata o paralizzata. In questo, e negli aspetti più quotidiani della vita, c’è un vero dono dello Spirito in tanti veri viventi che non cessano di reinventare l’amore e la gioia profonda di essere. Scaturisce a volte alla superficie della storia, come un Dom Helder Camara, ad esempio. La Chiesa deve di nuovo lasciare che la parola di Dio fecondi la storia.
...
In queste contingenze necessarie, la mia fede cerca sempre al di là. Mi auguro che tra cristiani, di nuovo divisi, possiamo essere capaci di celebrare insieme, nella fede più pura, il nostro amore per Gesù Cristo che superi le nostre dispute di un tempo.
Mi auguro che tra credenti, alla ricerca del nostro unico Dio d’amore, sia possibile riunirci qualche volta, anche se nel silenzio delle nostre preghiere differenti, nell’unità dello stesso e solo Spirito che ci fa gridare Abba, Padre.
Mi auguro che tra uomini possiamo mettere in comune tutte le nostre forze d’amore perché i giovani di domani conoscano la fine dell’ingiustizia e dell’odio
Così sono in comunione con la speranza di tutti coloro che sono convinti che una terra di rispetto, di giustizia, di uguaglianza e di amicizia è possibile.
Mi sento solidale con coloro che ne hanno fatto la lotta della loro vita.
E mi rallegro per il fatto che attualmente molti giovani si siano prefissi il compito di ricostruire questa terra.
Abbiamo tutti appuntamento con questo amore sconosciuto che non possiamo o non osiamo nominare per paura di rinchiuderlo nei limiti del nostro tempo. A età diverse della propria vita, ciascuno lo accoglie e lo dice a modo suo. In momenti diversi del risveglio spirituale dell’uomo, ogni civiltà lo riceve e lo esprime nella propria cultura.
Perché è proprio l’umanità intera che ha appuntamento con Dio: alla sua nascita? In certi momenti della storia? All’apogeo della sua evoluzione? Che importa, è il segreto di Dio, non il mio, ma credo che lui è e sarà presente, in maniera inattesa, agli appuntamenti della storia umana, come è e sarà presente agli appuntamenti di ciascuna delle nostre storie personali. Mi basta ritrovare in questa speranza una gran parte del Vangelo.
È a questo punto che mi ricordo di Gesù di Nazareth. Lo ritrovo oggi nel cuore di tutto questo popolo di cercatori di Dio. Sì, credo che Gesù è vivo, sorgente dello Spirito, che è una persona presente, che può essere amico degli uomini, e che questa amicizia può essere lo scopo di tutta una vita. Essere cristiani, dopo tutto, non è accettare di ricevere se stessi continuamente da Cristo, come ci si riceve da ogni sguardo d’amore? Tutti i giorni, mi sembra di incontrare Cristo per la prima volta.
Mi basta credere che, tornando al Padre dopo la resurrezione, Cristo ci ha reso liberi attraverso il dono del suo Spirito e che ha aperto alla nostra responsabilità, fino a che Egli venga e perché venga, il cantiere della storia. In questa scia di libertà creatrice, non avremo mai finito di camminare da responsabili davanti a Dio, di imparare a vivere e a morire.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. ---- RIMETTERE A NOI I NOSTRI DEBITI. Ma che cosa voleva dire esattamente Gesù (di Adriano Prosperi - Debiti, giustizia, colpa: le vere parole di Gesù)25 novembre 2011, di Federico La Sala
Debiti, giustizia, colpa le vere parole di Gesù
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 25 novembre 2011)
Chiedersi che cosa fosse Gesù di Nazareth non per noi ma per i suoi contemporanei: questo è ciò che distingue il libro di Mauro Pesce - Da Gesù al cristianesimo (Morcelliana) - dalla immensa foresta di libri su Gesù che cresce ogni giorno. E la via che l’autorevole storico del Cristianesimo dell’Università di Bologna ci propone è quella di una ricerca filologica e storica sui significati delle parole di Gesù in quei due primi secoli dell’era volgare in cui furono la fede di una setta ebraica: il che non può che risvegliare la curiosità di coloro che hanno incontrato quelle stesse parole trasformate in istituzioni e pratiche sociali nelle epoche successive delle società cristiane.
Vediamone almeno un esempio. Tutti sanno, o credono di sapere, che cosa significhi "rimettere un debito". Specialmente di questi tempi, in cui alle tante forme storiche, morali e materiali, giuridiche e religiose del debito si è aggiunta quella che va sotto il nome di "debito sovrano". Ma se oggi sono gli economisti a tenere il campo, non si può certo dimenticare che per millenni il loro posto è stato occupato da teologi, moralisti, predicatori, tutti impegnati a interpretare e tradurre nella vita quotidiana la frase del "Padre nostro" dove a Dio Padre si chiede di "rimettere a noi i nostri debiti, come anche noi abbiamo rimesso ai nostri debitori"(Matteo, 6,12). Da quella frase doveva dipartirsi il lunghissimo percorso che ha istituzionalizzato nelle società cristiane la divisione tra peccato morale e colpa giuridica e ha lungamente elaborato i significati del rito della confessione.
Ma che cosa voleva dire esattamente Gesù di Nazareth? Per rispondere, osserva Pesce, bisogna partire dal dato di fatto che Gesù era un ebreo e non un "cristiano" e dunque comunicava coi suoi ascoltatori nel contesto della lingua e della tradizione ebraica. Se vogliamo intendere il significato letterale delle sue parole bisogna dunque mettere tra parentesi tutto ciò che ne è nato da quando sono state tradotte dall’aramaico nel greco dei Vangeli e poi in tutte le lingue del mondo. Si pensi anche solo ai sacramenti del battesimo e della confessione, al loro potere di "rimettere" i peccati. Tutto questo non c’era ancora nell’orizzonte ebraico di Gesù. Qui il bisogno di cancellare o riparare le colpe aveva ricevuto la forma del giubileo.
Come lo descrive il capitolo 25 del Levitico, giubileo significava riconciliazione e ricomposizione dell’intera società, liberazione dai debiti, ritorno di ognuno nella propria famiglia e nei propri beni, sospensione delle preoccupazioni ordinarie - nutrirsi, vestirsi e così via. Lo si doveva annunciare nel "giorno dell’espiazione" perché la rigenerazione richiedeva un rito di perdono delle colpe involontarie e di risarcimento del male fatto. Come nota Pesce, il nesso tra espiazione e remissione è documentato nei manoscritti del Mar Morto: il che ci introduce nell’orizzonte mentale del giudaismo dei tempi di Gesù, quando col profeta Isaia conversione umana e perdono divino si erano da tempo legati all’idea di una restaurata giustizia e di una prospettiva di speranza escatologica.
La remissione generale del "Pater noster" si comprende dunque come passaggio di purificazione ed espiazione legato all’annunzio dell’imminente avvento del Regno di Dio: un Dio padre del suo popolo, simile a quei sovrani dell’Oriente antico che all’inizio del loro regno concedevano ai sudditi l’amnistia e sospendevano la legge ordinaria per restaurare una superiore giustizia.
-
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ---- LA PAROLA DI DIO E LA PIRATERIA RATZINGERIANA. Gesù di Nazaret: Giallo sul nuovo libro del papa (di Piergiorgio Odifreddi)11 marzo 2011, di Federico La Sala
 LA PAROLA DI DIO, IL COPYRIGHT, E LA PIRATERIA RATZINGERIANA. LA "LUCE DEL MONDO" SONO IO! CHE SUCCESSO, QUANTI SOLDI CON I DIRITTI DI AUTORE!!!
LA PAROLA DI DIO, IL COPYRIGHT, E LA PIRATERIA RATZINGERIANA. LA "LUCE DEL MONDO" SONO IO! CHE SUCCESSO, QUANTI SOLDI CON I DIRITTI DI AUTORE!!!
 DIRITTI D’AUTORE E LETTERA DI EMBARGO. Gesù di Nazaret, Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. Giallo sul nuovo libro del papa. Una nota di Piergiorgio Odifreddi
DIRITTI D’AUTORE E LETTERA DI EMBARGO. Gesù di Nazaret, Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. Giallo sul nuovo libro del papa. Una nota di Piergiorgio Odifreddi
 (...) sono andato in libreria a comprare il libro del papa. Il libraio mi ha riconosciuto, e mi ha mostrato una sedicente “Lettera di embargo” che la RCS Libri aveva mandato nei giorni scorsi a tutti i librai. Poichè la cosa ha dell’inusuale (...) la riproduco qui, nonostante fosse ovviamente da tenere “segreta” (...)
(...) sono andato in libreria a comprare il libro del papa. Il libraio mi ha riconosciuto, e mi ha mostrato una sedicente “Lettera di embargo” che la RCS Libri aveva mandato nei giorni scorsi a tutti i librai. Poichè la cosa ha dell’inusuale (...) la riproduco qui, nonostante fosse ovviamente da tenere “segreta” (...)
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ---- VATICANO E INSULTO FUNEBRE. Quell’attacco postumo a Saramago (di/da Corrado Augias - risponde a Antonio Cammelli).22 giugno 2010, di Federico La Sala
Quell’attacco postumo a Saramago
risponde Corrado Augias (la Repubblica, 22.06.2010)
Caro Augias,
anche se viene sempre meno la voglia di scandalizzarsi, non posso fare a meno di provare vergogna per il tremendo attacco che l’Osservatore Romano ha dedicato a José Saramago dopo la morte. Un intervento pieno di livore. Un tempo la Chiesa sapeva distinguere tra peccato e peccatore affidava a Dio "misericordioso" anche l’anima di coloro che considerava irrecuperabili peccatori. La Chiesa di oggi, al centro di scandali di ogni genere, ha perso la tradizionale prudenza ed è diventata una protagonista attiva del penoso dibattito dei nostri giorni che consiste, sempre, nella demonizzazione dell’avversario, senza preoccuparsi per nulla, in particolare con Saramago, del fatto che, il pericoloso avversario, è passato a miglior (o peggior) vita, non avendo, perciò, possibilità di replica.
 Antonio Cammelli
Antonio Cammelli
 Firenze cammelli.a@tiscali.it
Firenze cammelli.a@tiscali.itHa molto colpito l’attacco post mortem ad uno scrittore premio Nobel che ha onorato l’arte sua, quali che fossero le sue idee in materia religiosa. Anche in altre materie, peraltro. Per esempio sulla politica dello Stato d’Israele, da lui condannata senza mezzi termini suscitando anche in questo caso aspre reazioni. Capisco il nervosismo di un paese in questo momento in forti difficoltà.
Ma l’organo ufficiale della Chiesa cattolica, che si vuole ispirata direttamente dal Cielo, avrebbe potuto argomentare con più misericordia verso un morto. Saramago vedeva nella diffusione del Male nel mondo una delle prove dell’inesistenza di Dio. Quanto meno del Dio della teologia cattolica. E’ un problema antico, più volte affrontato anche da grandi spiriti, mai risolto. Credo irrisolvibile.
Francesco Leporino (gransole@gransole.net) mi ricorda che: « L’uomo Saramago ha detto: "La bontà è una delle forme più alte di intelligenza!". Strappare al Cristianesimo il monopolio della bontà e iscriverlo in un pensiero illuminista, farne una categoria dell’intelligenza (e non del timor di dio) è stata una verità semplice e rivoluzionaria».
Francesco de Goyzueta da Napoli (fdegoyzueta@ extratel.it) scrive: « Saramago, grande voce civile che si è appena spenta, ha detto: "Dev’essere duro vivere quando il potere politico e quello imprenditoriale si riuniscono. Non invidio la sorte degli italiani, però alla fine è nella volontà degli elettori mantenere questo stato di cose o cambiarlo". Veemente dunque, ma anche rispettoso della democrazia».
Fulvio Bossino scrive: « Complimenti al Vaticano, tramite il suo organo di stampa introduce contro Saramago un nuovo genere letterario: dopo l’elogio funebre abbiamo finalmente l’insulto funebre».
Andrea Sillioni (Bolsena) è secco: «Fa rabbrividire una Chiesa che teme ancora, nel duemila, l’intellettualità atea e materialista».
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ---- Le domande che i ragazzi rivolgono a Gesù (di Vito Mancuso).12 gennaio 2010, di Federico La Sala
Le domande che i ragazzi rivolgono a Gesù
di Vito Mancuso (la Repubblica, 12 gennaio 2010)
Il Sermig di Torino, movimento cattolico fondato da Ernesto Olivero, ha sottoposto un esteso questionario a migliaia di giovani sulla figura di Gesù. Alla domanda numero 7, che chiedeva «Cosa diresti a Gesù se potessi parlare con lui oggi?», le principali risposte dei giovani furono le seguenti: Perché si deve morire? Che senso ha la mia vita? Perché esiste il male? Perché muoiono tanti giovani? Cosa mi aspetta dopo la morte? Perché mi hai creato?
Queste domande dei giovani a Gesù (ipotetiche quanto alla possibilità di raggiungere il destinatario, ma assolutamente reali quanto a valore esistenziale) mostrano un intenso bisogno di significato, si potrebbe dire di filosofia. Più che a Gesù quale singolo personaggio storico, le interpellanze dei giovani si rivolgono al Cristo, al Figlio di Dio in quanto Dio, a Dio, all’Assoluto. Sono tre infatti le questioni capitali: 1) chi sono io e perché sono qui; 2) perché questo mondo è colmo di ingiustizia; 3) che cosa ne sarà di me dopo la morte.
Oggi la teologia e la predicazione della Chiesa sono concentrate sul Gesù storico, sulla sua esistenza, la sua predicazione, il suo messaggio, la sua morte e la sua risurrezione. I corsi biblici organizzati dalle parrocchie non si contano più. Ma queste domande mostrano chiaramente che l’interesse degli uomini d’oggi non è per una storia lontana, destinata ogni anno a divenire sempre più lontana, ma per il senso di questa vita qui e ora.
Gesù non interessa come singolo personaggio storico a cui accadono delle cose speciali (emblematico che nessuno tra i giovani gli avrebbe chiesto lumi sul suo concepimento verginale, sulla veridicità dei suoi miracoli, sui responsabili della sua morte, sulla realtà della sua risurrezione) ma interessa come il maestro a cui chiedere spiegazioni su questa vita e sui suoi conti che faticano a tornare. Una risposta di un ragazzo di quindici anni metteva addirittura in crisi il sacrificio espiatorio di Gesù, o meglio la teologia tradizionale che interpreta Gesù quale «vittima immolata per la nostra redenzione» (come viene definito da alcune parole del canone della Messa).
Che cosa appare allora da queste domande dei giovani? Appare quello che già Hegel vedeva come il limite della coscienza cristiana tradizionale, cioè l’essere una «coscienza infelice». Da questi giovani emerge chiaramente un disorientamento sulla loro identità di uomini, segno dell’inefficacia delle risposte tradizionali della fede ascoltate nelle lezioni di catechismo. A differenza di quanto avveniva al tempo di sant’Agostino e di san Tommaso d’Aquino, dalla fede cristiana di oggi non emerge più una veritiera e affidabile visione del mondo. Da qui il senso diffuso di infelicità, da qui il disagio rispetto al proprio essere al mondo. I credenti adulti suppliscono questa incertezza teoretica con il ricorso al principio di autorità (è così perché è stato sempre insegnato che è così), ma con i giovani questo principio (se purtroppo o se per fortuna, non lo so) non funziona.
C’è un detto medievale che dice: «Vengo non so da dove; sono non so chi; muoio non so quando; vado non so dove; mi stupisco di essere lieto». Il filosofo Karl Jaspers, che lo cita all’inizio del libro La fede filosofica di fronte alla rivelazione, dice che per questa unione di ignoranza e di gioia tale detto non può essere cristiano. E poi aggiunge un affondo terribile, affermando che, al contrario, la coscienza cristiana ha sì le risposte a tutte le questioni perché sa da dove viene, perché sa chi è, perché sa che morirà quando lo deciderà Dio (non prima e non dopo), perché sa dove andrà, ma, sapendo tutto ciò, non è per nulla lieta, per nulla serena, ma è immersa nella macerazione e in una continua tensione con il mondo con cui non riesce a riconciliarsi. A mio avviso ha ragione: la coscienza cristiana troppo spesso appare come una coscienza infelice, a tratti risulta persino aggressiva, soprattutto in coloro che coltivano sopra ogni cosa l’adesione alla dottrina stabilita dalle gerarchie ecclesiastiche e che coniugano il verbo "credere" sempre accanto a "obbedire e combattere".
Da dove nascono invece quell’essere lieti in profondità, quella gioia inestirpabile verso la vita, quella quiete dello spirito e della mente, che sono il contrassegno di una autentica esperienza spirituale e che sole possono dare risposte convincenti alle inquietudini dei giovani? Nascono dal sapere di essere a casa in questo mondo di Dio, dal senso di intima comunione con l’essere e con la natura che portò Francesco d’Assisi a scrivere il "Cantico delle creature", e dalla certezza che l’incarnazione di Dio non riguarda solo un giorno lontano di tanti anni fa ma è la dinamica che si avvera ogni giorno, in tutti gli uomini che amano il bene e la giustizia. Gesù è l’uomo che cessa di fare di se stesso il centro del mondo e si pone al servizio di una realtà più importante di sé. Anche la Chiesa deve cessare di fare di se stessa il centro del mondo e si deve porre al servizio di qualcosa di più grande di sé, del bene comune e di ogni singolo individuo di questa nostra società, credente o non credente, bianco o nero, etero o omosessuale.
-
> GESU’ ---- ’’Quest’anno Gesu’ Bambino restera’ senza regali: i Magi non arriveranno perche’ sono stati respinti alla frontiera insieme agli altri immigrati" (Cattedrale di Agrigento - Arcivescovo Francesco Montenegro).6 gennaio 2010, di Federico La Sala
 Niente Re Magi in presepe
Niente Re Magi in presepe
 Cattedrale Agrigento: ’Respinti alla frontiera’
Cattedrale Agrigento: ’Respinti alla frontiera’Palermo, 5 gen. - (Adnkronos) - Un cartello posto dal direttore della Caritas diocesana Valerio Landri, avverte: ’’Quest’anno Gesu’ Bambino restera’ senza regali: i Magi non arriveranno perche’ sono stati respinti alla frontiera insieme agli altri immigrati". L’obiettivo della provocatoria iniziativa è far riflettere sul tema dell’immigrazione ed è stata concordata con l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Francesco Montenegro.
Palermo, 5 gen. - (Adnkronos) - Niente Re Magi nel presepe allestito nella Cattedrale di Agrigento. Un cartello posto dal direttore della Caritas diocesana Valerio Landri, avverte: ’’Quest’anno Gesu’ Bambino restera’ senza regali: i Magi non arriveranno perche’ sono stati respinti alla frontiera insieme agli altri immigrati".
L’obiettivo della provocatoria iniziativa e’ far riflettere sul tema dell’immigrazione ed e’ stata concordata con l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Francesco Montenegro. ’’Una legge in tema di immigrazione e’ necessaria - spiega Landri - ma bisogna anche comprendere che si tratta di gente disperata. Forse se Gesu’ Bambino volesse venire da noi oggi, sarebbe respinto alla frontiera, come accade a tanti nostri poveri fratelli’’.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! --- IN NUOVA ZELANDA, FUORI DA UNA CHIESA ANGLICANA. Il cartellone è stato affisso per «provocare riflessione e dibattito sulle vere origini del Natale» (di Giacomo Galeazzi).19 dicembre 2009, di Federico La Sala
SCANDALO IN NUOVA ZELANDA PER L’IMMAGINE AFFISSA FUORI DA UNA CHIESA ANGLICANA
E se accade con l’Islam?
Cartellone blasfemo scatena la polemica. E se fosse accaduto con l’Islam?
di GIACOMO GALEAZZI (La Stampa,19/12/2009)
Polemica in Nuova Zelanda per un cartellone pubblicitario raffigurante San Giuseppe e la Vergine Maria a letto, appeso fuori da una chiesa anglicana a St. Matthew’s-in-the-city. L’immagine, fatta affiggere dal vicario della chiesa, è accompagnata dalla scritta: «Povero Giuseppe, Dio è difficile da seguire». «Per la nostra tradizione natalizia bimillenaria, Maria è rimasta vergine e Gesù è il figlio di Dio, non di Giuseppe - ha affermato, indignato, Lyndsday Freer, portavoce della comunità cristiana neozelandese - Questo poster è inappropriato e irrispettoso». Secondo un giornale locale, l’immagine sembra suggerire che i due «abbiano appena avuto un rapporto sessuale». Poche ore dopo essere stato affisso, il cartellone è stato deturpato. Qualcuno ha coperto entrambi i volti dei santi e la scritta con della vernice marrone.L’arcidiacono Glynn Cardy, vicario della chiesa di St Matthwès, ha spiegato che il cartellone è stato affisso per «provocare riflessione e dibattito sulle vere origini del Natale». «Il cristianesimo progressista si distingue non soltanto per una visione univoca - ha continuato Cardy - ma anche per instaurare un dialogo con chi la pensa diversamente». E se fosse accaduto con l’Islam?
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. --- DIO E’ AMORE: COME IN CIELO, COSI’ IN TERRA. !!! E PER LA LEGGE DI "DIO" E DI TUTTI GLI ESSERI, MARIA E’ LA MADRE E GIUSEPPE E’ IL PADRE DI GESU’!!!20 dicembre 2009, di Federico La Sala
CARO GALEAZZI *
***MA CHE C’ENTRA L’ISLAM!!! ***
 QUI LA "PROVOCAZIONE" E’ INTERNA AL MONDO CRISTIANO ED E’ UNA SOLLECITAZIONE A MEGLIO PENSARE L’ALLEANZA TRA DIO E GLI ESSERI UMANI. *** NON PER NULLA L’ALLEANZA E’ DETTA ANCHE "ALLEANZA DI FUOCO" - COME DI FUOCO ERANO LE LINGUE CHE DISCESERO SUGLI APOSTOLI. ***
QUI LA "PROVOCAZIONE" E’ INTERNA AL MONDO CRISTIANO ED E’ UNA SOLLECITAZIONE A MEGLIO PENSARE L’ALLEANZA TRA DIO E GLI ESSERI UMANI. *** NON PER NULLA L’ALLEANZA E’ DETTA ANCHE "ALLEANZA DI FUOCO" - COME DI FUOCO ERANO LE LINGUE CHE DISCESERO SUGLI APOSTOLI. ***
 L’EVANGELISTA GIOVANNI SOLLECITA A NON CREDERE A OGNI SPIRITO E DICE CHIARO E TONDO CHE IL VERO DIO E’ AMORE (1 Gv., 4.8: Deus charitas est - e non come scrive Benedetto XVI: Deus caritas est)!!! *** Non con confondiamo il figlio-"tesoro" ("caritas") di "mammasantissima" e di "mammona" ("caritas"), con il Figlio della Grazia ("Charis") e dell’Amore ("Charitas", "Agàpe") di Maria e Giuseppe!!! ***
L’EVANGELISTA GIOVANNI SOLLECITA A NON CREDERE A OGNI SPIRITO E DICE CHIARO E TONDO CHE IL VERO DIO E’ AMORE (1 Gv., 4.8: Deus charitas est - e non come scrive Benedetto XVI: Deus caritas est)!!! *** Non con confondiamo il figlio-"tesoro" ("caritas") di "mammasantissima" e di "mammona" ("caritas"), con il Figlio della Grazia ("Charis") e dell’Amore ("Charitas", "Agàpe") di Maria e Giuseppe!!! ***
 NON TRUCCHIAMO LE CARTE - E L’AMORE EVANGELICO!!! *** O, siamo ancora tanto ’piccoli’, da credere alla "verità" del Cardinale Dario Castrillon Hoyos:
NON TRUCCHIAMO LE CARTE - E L’AMORE EVANGELICO!!! *** O, siamo ancora tanto ’piccoli’, da credere alla "verità" del Cardinale Dario Castrillon Hoyos:
 "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)*** e della tradizione cattolico-romana ( anglicana, e tutte le altre)?!! siamo nel terzo millennio dopo la nascita di Cristo - non prima di Cristo, al tempo dei Faraoni!!!
"Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)*** e della tradizione cattolico-romana ( anglicana, e tutte le altre)?!! siamo nel terzo millennio dopo la nascita di Cristo - non prima di Cristo, al tempo dei Faraoni!!!
 Il messaggio evangelico è il messaggio eu-angelico (una buona-notizia) - non una cattiva-notizia che manda tutto in gelo (van-gelo)!!!
Il messaggio evangelico è il messaggio eu-angelico (una buona-notizia) - non una cattiva-notizia che manda tutto in gelo (van-gelo)!!!
 BUON NATALE, BUON NATALE ... PACEM IN TERRIS!!! M. cordiali saluti ... Federico La Sala (19.12.2009 dopo la nascita di Gesù Cristo)
BUON NATALE, BUON NATALE ... PACEM IN TERRIS!!! M. cordiali saluti ... Federico La Sala (19.12.2009 dopo la nascita di Gesù Cristo)
 scritto da FEDERICO LA SALA 19/12/2009 20:45
scritto da FEDERICO LA SALA 19/12/2009 20:45-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. --- DIO E’ AMORE ("Charitas"): COME IN CIELO, COSI’ IN TERRA!!! --- "Natale non è un favola per bambini" (Benedetto XVI durante l’Angelus).20 dicembre 2009, di Federico La Sala
 IL MONITO DEL PONTEFICE
IL MONITO DEL PONTEFICE
 Benedetto XVI durante l’Angelus:
Benedetto XVI durante l’Angelus:
 "Natale non è un favola per bambini"
"Natale non è un favola per bambini" «E’ la risposta di Dio al dramma
«E’ la risposta di Dio al dramma
 dell’umanità in cerca della pace»
dell’umanità in cerca della pace»CITTA’ DEL VATICANO «Oggi, come ai tempi di Gesù, il Natale non è una favola per bambini, ma la risposta di Dio al dramma dell’umanità in cerca della vera pace». Lo ha affermato Benedetto XVI all’Angelus sottolineando la storicità del racconto del Vangelo di Luca che narra come mai Gesù nacque a Betlemme: «Giuseppe, lo sposo di Maria, essendo della "casa di Davide", dovette recarsi in quella cittadina per il censimento, e proprio in quei giorni Maria diede alla luce Gesù». «Mille anni prima di Cristo - ha ricordato rivolto ai circa 40 mila presenti in piazza San Pietro - Betlemme aveva dato i natali al grande re Davide, che le Scritture concordano nel presentare come antenato del Messia».
Il Papa ha poi citato la profezia di Michea che accenna proprio ad una misteriosa nascita: «Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele». «C’è dunque - ha osservato - un disegno divino che comprende e spiega i tempi e i luoghi della venuta del Figlio di Dio nel mondo».
Michea su Gesù Bambino: dice poi che «Egli stesso sarà la pace!». «A noi - ha spiegato Ratzinger - spetta aprire, spalancare le porte per accoglierlo. Impariamo da Maria e Giuseppe: mettiamoci con fede al servizio del disegno di Dio. È un disegno di pace, come annuncia ancora il profeta parlando del Messia che si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perchè egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra». «Anche se non lo comprendiamo pienamente - ha conmcluso il Pontefice - affidiamoci alla sua sapienza e bontà. Cerchiamo prima di tutto il Regno di Dio, e la Provvidenza ci aiuterà. Buon Natale a tutti!».
* La Stampa, 20/12/2009 (13:7)
-
-
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! ---- PREGHIERA PER GLI EBREI - E PER GIUSEPPE - DI GIOVANNI XXIII (di Orazio La Rocca).28 dicembre 2008, di Federico La Sala
 GIOVANNI XIII
GIOVANNI XIII
 PREGO PER GLI EBREI
PREGO PER GLI EBREIdi Orazio La Rocca *
CITTA DEL VATICANO - «Perdonaci, Signore, per non aver capito la bellezza del Tuo popolo eletto... perdonaci, perché nel corso dei secoli non sapevamo quello che stavamo facendo contro gli ebrei...». è un Papa anziano, molto malato, costretto a letto perché colpito da un male incurabile, che scrive queste parole pochi giorni prima di morire. è Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli, il papa Buono per antonomasia, il padre del Concilio Vaticano II e del successivo rinnovamento ecclesiale, che Giovanni Paolo II beatificherà nel 2000 sotto i riflettori di tutto il mondo, facendone una delle più importanti icone del grande Giubileo del 2000.
Quasi nessuno, però, finora ha mai saputo che il futuro beato Giovanni XXIII nel chiuso della sua stanza nel Palazzo apostolico, in Vaticano, verso la fine del mese di maggio 1963 - morirà dopo una lunga agonia la sera del successivo 3 giugno all’ età di 82 anni - dedica le sue ultime energie al popolo ebraico sotto forma di preghiera composta quasi di getto su un foglio bianco, davanti al Crocifisso al cospetto del quale ogni notte si era sempre raccolto in preghiera prima di dormire. è una chiara e appassionata richiesta di perdono per le "colpe" commesse dai cristiani nel corso dei secoli con i loro atteggiamenti antisemiti, che papa Roncalli intitola, significativamente, "Preghiera per gli ebrei". Un gesto fatto quasi di istinto, sincero, scritto con grande passione e dettato da un forte desiderio di "pulizia interiore" per le colpe antiebraiche dei cristiani, che anticipa di molti anni le due storiche tappe di avvicinamento al popolo ebraico compiute da Giovanni Paolo II, la visita alla Sinagoga di Roma del 1986 e la richiesta di perdono per le colpe e le omissioni dei cristiani verso gli ebrei nell’ ambito dei mea culpa del Giubileo del 2000. E che spiega, in qualche modo, anche la nascita del testo conciliare Nostra Aetate, approvato nel 1965, con cui la Chiesa cattolica si aprì al dialogo interreligioso e cancellò l’ anacronistica accusa di deicidio con cui per circa duemila anni erano stati apostrofati tutti gli ebrei.
La Preghiera agli ebrei è un documento finora sostanzialmente inedito in Italia. Era stato pubblicato solo in parte nel 1965, due anni dopo la scomparsa di Giovanni XXIII, su un giornale olandese e brevemente accennato nello stesso anno su un periodico italiano, sembra per iniziativa di un giovane monsignore statunitense che aveva preso parte al Concilio come esperto ed era molto amico dell’ allora pontefice. Lo stesso prelato che ne aveva parlato successivamente nel corso di un incontro interconfessionale, negli Stati Uniti d’ America. Da allora, però, se ne erano perse le tracce.
Il testo giovanneo - una quindicina di righe appena - dopo circa 45 anni di sostanziale e inspiegabile oblio domani pomeriggio (alle 16,30) sarà letto integralmente in pubblico per la prima volta al monastero di Santa Cecilia, in Trastevere, a Roma, nell’ ambito del recital Roncalli legge Roncalli interpretato da un discendente di Giovanni XXIII, l’ attore Guido Roncalli che - accompagnato dal violoncellista Michele Chiapperino - presenterà una serie di documenti editi e inediti di papa Roncalli, relativi sia al suo pontificato che agli anni passati nelle nunziature apostoliche in Turchia e in Francia. Il recital è stato presentato con successo una decina di giorni fa in Vaticano alla presenza del cardinale-governatore Giovanni Lajolo. Ma senza la lettura della preghiera ebraica che domani costituirà, inevitabilmente, il momento clou dell’ incontro, che - preannuncia Guido Roncalli - «avrà un carattere e una impostazione ancora più ecumenica». Nella lettera la parola "perdono" viene evocata più volte.
Nel dirsi certo che Cristo è morto e risorto non solo per i cristiani, ma per tutti gli uomini, anche per gli ebrei, Giovanni XXIII chiede al Signore «di perdonarci perché per molti e molti secoli i nostri occhi erano così ciechi che non erano più capaci di vedere ancora la bellezza del Tuo popolo eletto, né di riconoscere nel volto (di tutti gli ebrei - ndr) i tratti dei nostri fratelli privilegiati...». Una espressione, quest’ ultima, che rievoca in maniera impressionante un’ altra famosa frase, quella con cui Giovanni Paolo II nel 1986 nella Sinagoga di Roma salutò gli ebrei chiamandoli «nostri fratelli maggiori».
«Perdonaci, Signore», si legge ancora nella preghiera di papa Roncalli: perdonaci per le tante "ingiustizie" subite dagli ebrei nel corso dei secoli passati e per le "colpe" commesse dai cristiani nei loro confronti. Colpe, mancanze e ingiustizie che il papa Buono accomuna, con "rammarico", al primo delitto raccontato nel primo libro della Bibbia, la Genesi, dove si parla dell’ assassinio di Abele per mano di Caino. La chiusura del testo è contrassegnata anche da un forte impatto teologico perché Giovanni XXIII si spinge a prendere quasi "in prestito" le parole con cui Gesù sul Golgota dall’ alto della croce, prima di spirare, invocò il Padre per perdonare quelli che lo stavano uccidendo. Signore, "perdonaci", conclude infatti papa Roncalli, «perché i cristiani non sapevano cosa facevano» contro gli ebrei.
«Se da un lato la recita fatta in Vaticano mi ha dato un onore immenso perché ospite del successore di Giovanni XXIII, il recital di domani - commenta Guido Roncalli - sento che sarà particolarmente calzante per la rievocazione di un pontefice sensibile al dialogo interreligioso e all’ ecumenismo, e che in punto di morte si è sentito in dovere di scrivere parole bellissime e profonde per chiedere perdono agli ebrei, come una sorta di testamento».
 ORAZIO LA ROCCA
ORAZIO LA ROCCA* la Repubblica - 20 dicembre 2008
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ---- L’infanzia di Gesù nel vangelo di Matteo. Un testo di Giuseppe Barbaglio.22 dicembre 2008, di Federico La Sala
TUTTO NATALE
Un testo di Giuseppe Barbaglio
Mi sembra di leggere tra le righe di questa sbobinatura la ricerca insonne di Giuseppe di capire e di tenere il più possibile distinti i confini tra storia e fede. Non perché i due filoni si depotenzino, ma anzi perché fioriscano più significati e pensieri. Per questo lui parla di "credenza". Vorrei anche ricordare che il primo libro che mi ha dedicato diceva: "L’annuncio diventa carne e abita in noi". Fino all’ultimo Giuseppe mi ha ripetuto la domanda: qual è l’annuncio di gioia da dare al mondo di oggi, alle persone discriminate?
Carla Busato Barbaglio
L’infanzia di Gesù nel vangelo di Matteo
Gesù è l’uomo che nasce dalla terra, a Nazaret, in Galilea. L’origine di questo uomo fa volgere i nostri occhi verso il cielo perché lui esprime il mondo di Dio, lo incarna, è l’epifania della benevolenza e della filantropia di Dio. Questo uomo singolo e singolare, frutto della nostra terra, è la parola di Dio, incarna la vicinanza di Dio all’uomo.
Soltanto i vangeli di Matteo e di Luca riservano i primi due capitoli alla narrazione della nascita e dell’infanzia di Gesù. Essi nascono come espressione plastica, narrativa della fede dei primi credenti in Gesù figlio di Dio. Sono due racconti molto diversi, espressione degli ambienti culturali e religiosi a cui Matteo e Luca appartenevano.
Il vangelo dell’infanzia di Matteo, che comincia con la genealogia, centra l’attenzione su Giuseppe. A lui parlano gli angeli in sogno, è lui l’anello centrale che collega Gesù alla stirpe di Davide. Perché Giuseppe ha questa importanza? I circoli cristiani a cui partecipa Matteo credono nel concepimento verginale di Gesù, ma hanno il problema di come inserire Gesù nella storia ebraica, nella storia delle promesse di Dio fatte ad Abramo (In te saranno benedette tutte le nazioni) e a Davide (Io susciterò sul tuo trono uno che regnerà in eterno).
Come si fa a collocare questo figlio in una genealogia dove i fili sono tenuti dai maschi, dai padri, se Gesù non è figlio di Giuseppe? Matteo risponde, attraverso il suo racconto, che "Gesù è il figlio di Dio ma è anche il figlio legale di Giuseppe". In questo modo collega Gesù alle promesse fatte da Dio a Abramo e a Davide. All’inizio della genealogia Matteo scrive: "Libro dell’origine di Gesù Cristo, figlio di Abramo, figlio di Davide": Gesù è l’erede delle promesse. Alla fine della genealogia, conclude: "Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria dalla quale fu generato Gesù detto il Cristo". C’è uno scarto. Il racconto dell’infanzia serve a sanare questo scarto. Tutta la narrazione, i simboli, i luoghi, i personaggi vogliono confermare questa origine e collegare la vita di Gesù alla storia ebraica.
Intervengono allora gli angeli: "Giuseppe non pensare che Maria sia infedele, è la potenza di Dio che ha generato in lei il bambino, tu però sei quello che deve prendere Maria in casa, devi dare il nome al figlio e cioè lo devi inserire nella genealogia". Da una parte si afferma l’interesse alla paternità di Giuseppe, dall’altra che è il figlio di Dio. La credenza nel concepimento verginale di Gesù, ai tempi dei primi cristiani, era un modo per dire che lui era il figlio di Dio, era un’espressione di fede sull’identità di Gesù. La sua origine risale misteriosamente a Dio, è lui l’attore che sta dietro alle quinte.
La nascita avviene a Betlemme, dettaglio importante perché era la città di Davide, che conferma la discendenza davidica. Betlemme è il luogo dell’anagrafe di Dio, mentre secondo l’anagrafe umana e giudaica Gesù è il nazareno, nato a Nazaret.
I magi che vengono dall’oriente sono l’immagine dei pagani che vengono da lontano, una immagine che prefigura la missione al mondo pagano.
La fuga in Egitto, dettata in sogno a Giuseppe, e il successivo ritorno a Nazaret, rappresenta la storia del popolo ebraico, che Gesù rivive profeticamente.
Tutta la vita di Gesù incarna la storia nuova del popolo. I racconti dell’infanzia sono espressione di questa credenza in Gesù, figlio di Dio e erede delle promesse abramitiche e davidiche.
(il testo è tratto da un intervento tenuto da Giuseppe Barbaglio nella sede di Oreundici di via Ottaviano a Roma, alcuni anni fa)
 Articolo tratto da:
Articolo tratto da:
 FORUM (121) Koinonia
FORUM (121) Koinonia http://www.koinonia-online.it
http://www.koinonia-online.it
 Convento S.Domenico - Piazza S.Domenico, 1 - Pistoia - Tel. 0573/22046
Convento S.Domenico - Piazza S.Domenico, 1 - Pistoia - Tel. 0573/22046 -
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! ---- La Vergine col bambino un’icona contro le eresie. Ma l’immagine fu ereditata dalla dea egizia Iside.20 novembre 2008, di Maria Paola Falqui
 Un simbolo sfruttato dalla Chiesa dopo il Concilio di Efeso e nell’offensiva anti Lutero
Un simbolo sfruttato dalla Chiesa dopo il Concilio di Efeso e nell’offensiva anti Lutero La Vergine col bambino un’icona contro le eresie
La Vergine col bambino un’icona contro le eresie
 Ma l’immagine fu ereditata dalla dea egizia Iside
Ma l’immagine fu ereditata dalla dea egizia Iside di Francesca Bonazzoli (Corriere della Sera, 20.11.2008)
di Francesca Bonazzoli (Corriere della Sera, 20.11.2008)Ancor prima dell’epoca cristiana, l’immagine della «Madre col Bambino» veniva già usata da molte culture con un significato religioso: nell’area mediterranea, per esempio, rappresentava la dea Iside con in grembo il figlio Horus e fu proprio questa iconografia egizia a passare in quella cristiana occidentale attraverso la mediazione dell’Oriente bizantino.
In particolare, dopo il 431, le gerarchie ecclesiastiche cristiane promossero l’immagine della Madonna col Bambino per dare forza alla condanna, votata dal Concilio di Efeso, dell’eresia nestoriana secondo la quale la Vergine non poteva essere chiamata «madre di Dio», ma solo madre di Gesù poiché non aveva generato un Dio, bensì solo il corpo in cui Dio aveva poi preso dimora.
Da quel momento fino al Medioevo nelle chiese cristiane si assiste a una proliferazione delle immagini della Madonna col Bambino (spesso accompagnate dall’iscrizione «Maria Mater Dei» e «Sancta Dei Genitrix») raggruppabili in diverse varianti: la Madonna del latte (dove la Vergine allatta il figlio) è una delle prime iconografie conosciute, fin dalla catacomba di Priscilla del III secolo; la Madonna orante col Bambino (genuflessa e con le mani giunte mentre adora il figlio poggiato su un lembo del proprio manto); la Madonna leggente col Bambino (con in mano il libro della Sapienza); la Madonna del roseto (seduta in un giardino di rose simbolo della verginità della madre di Dio) particolarmente amata nel Nord Europa; la Madonna col bambino in trono (dove Maria personifica la Chiesa), di derivazione bizantina e i cui più antichi esempi in Occidente si trovano nei mosaici di Ravenna.
L’immagine registra poi un secondo grande momento di successo che coincide ancora una volta con un’eresia: quella protestante. A cavallo fra XV e XVI secolo, l’impiego della Madonna col Bambino viene nuovamente incentivato da parte della Chiesa cattolica per fini propagandistici e, dopo la condanna di Lutero, per confutare la dottrina protestante che ridimensionava il culto della Vergine assieme a quello dei santi. In quest’epoca furono soprattutto due i pittori che portarono il soggetto alla gloria: Raffaello e Giovanni Bellini. Il primo perché, noto ammiratore e amante di donne, seppe dare alle sue Madonne grazia e bellezza idealizzate, di una perfezione che incantava e trascendeva qualsiasi modello umano; il secondo perché, sincero credente, nei volti delle sue Vergini dall’aria dolce e domestica ritraeva quello della moglie amata di un amore casto e cristiano.
Nel Rinascimento il culto mariano si era ormai molto diffuso e via via che la devozione popolare si era fatta più appassionata, anche l’iconografia della Madonna col Bambino aveva perso la primitiva ieratica monumentalità per acquisire un tono più tenero. La rigidezza, eredità orientale nella rappresentazione della Madre in posizione frontale con il bambino eretto, vestito e benedicente, aveva lasciato già nel XIV secolo il posto a due nuove varianti dove madre e figlio venivano messi in un rapporto di affettuosità attraverso un gioco di sguardi o di mani: la Madonna dell’Umiltà (in particolare nel-l’Italia settentrionale) e la Mater amabilis, il tipo di rappresentazione più amata fra tutta l’iconografia mariana. È soprattutto per quest’ultima immagine intima e domestica che si sviluppano leggere varianti attraverso l’inserimento di oggetti simbolici. Fra i più frequentati figurano la mela, frutto dell’albero del Bene e del Male: tenuta in mano dal Bambino allude alla redenzione dal peccato originale.
L’uva è simbolo del vino eucaristico e quindi del sangue del Cristo redentore (anche nella variante della brocca che contiene il vino). Analogamente, le spighe sono il pane eucaristico e dunque il corpo di Cristo. La ciliegia, frutto del Paradiso, è simbolo del Cielo; la melagrana, che già nel mondo pagano era attributo di Proserpina, dea che presiedeva alla germinazione, allude alla Resurrezione. La noce, invece, era un complesso simbolismo sviluppato da sant’Agostino, dove il mallo stava per la carne di Cristo, il guscio di legno alludeva alla croce e il gheriglio alla natura divina del Cristo.
E infine l’uccello che, nella pittura cristiana, mantiene il simbolismo che già aveva in quella pagana, ovvero rappresenta l’anima umana che vola via alla morte del corpo. Spesso è un cardellino perché il suo piumaggio colorato lo rendeva particolarmente attraente agli occhi dei bambini e anche perché, secondo una leggenda, la macchia rossa sul capo sarebbe stata un residuo del sangue di Cristo con cui il cardellino si macchiò volando sopra la testa incoronata di spine di Gesù mentre questi saliva al Calvario.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! ---- I testimoni di Gesù, le origini del cristianesimo (di Corrado Augias)2 settembre 2008, di Federico La Sala
I testimoni di Gesù, le origini del cristianesimo
di Corrado Augias *
Gesù non ha mai detto di voler fondare una religione, una Chiesa, che portassero il suo nome; mai ha detto di dover morire per sanare con il suo sangue il peccato di Adamo ed Eva, per ristabilire cioè l’alleanza fra Dio e gli uomini; non ha mai detto di essere nato da una vergine che lo aveva concepito per intervento di un dio; mai ha detto di essere unica e indistinta sostanza con suo padre, Dio in persona, e con una vaga entità immateriale denominata Spirito.
Gesù non ha mai dato al battesimo un particolare valore; non ha istituito alcuna gerarchia ecclesiastica finché fu in vita; mai ha parlato di precetti, norme, cariche, vestimenti, ordini di successione, liturgie, formule; mai ha pensato di creare una sterminata falange di santi. Non è stato lui a chiedere che alcuni testi, i vangeli, riferissero i suoi discorsi e le sue azioni, né ha mai scritto personalmente alcunché, salvo poche parole vergate col dito nella polvere. Gesù era un ebreo, e lo è rimasto sempre; sia quando, in Matteo 5,17, ha detto: «Non pensiate che io sia venuto ad abolire la Legge o i profeti; non sono venuto per abolire ma per dare compimento»; sia quando, sul punto ormai di spirare, ha ripetuto l’attacco straziante del Salmo 22: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».
Davanti a queste incontestabili verità sorge con forza la domanda, la curiosità di sapere: ma allora com’è nato il cristianesimo? Chi e quando ne ha stabilito norme e procedure, riti e dogmi? Gesù non ha mai pensato di rendere obbligatori un comportamento o una verità certificati per decreto. Ha esortato, ha pregato, ha dato l’esempio. Soprattutto, nulla era più lontano da lui di una congerie di leggi, un’organizzazione monarchica, uno Stato sovrano dotato di territorio, moneta, esercito, polizia e giurisdizione, sia pure ridotti - ma solo dopo aspre lotte - a dimensioni simboliche. Torna di nuovo la domanda: ma allora chi ha elaborato tutto questo? perché? quando?
La vicenda del cristianesimo, ricostruita nel suo effettivo svolgimento secondo le leggi della ricerca storica e non della teologia, rappresenta una complessa avventura umana ricca di drammi, di contrasti, di correnti d’opinione che si sono scontrate sui piani più diversi: la dialettica, l’invenzione ingegnosa, la ricostruzione ipotetica di eventi sconosciuti a costo di affrontare i più inverosimili paradossi; l’amore per gli uomini, certo, nella convinzione di fare il loro bene, ma anche gli interessi politici, gli arbitrii e gli inganni; non di rado l’opposizione al mutamento spinta fino allo spargimento di sangue.
In breve: se si esaminano i fatti con la sola ottica della storia, nulla distingue la lenta e contrastata nascita di questa religione da quella di un qualsiasi altro movimento in grado di smuovere coscienze e interessi, di coinvolgere la società nel suo insieme e le singole persone che nella e della società vivono. Sigmund Freud ha scritto nel suo L’avvenire di un’illusione: «Dove sono coinvolte questioni religiose, gli uomini si rendono colpevoli di ogni sorta di disonestà e di illecito intellettuale». Forse l’espressione è eccessiva, nel senso che non sempre e non per tutti è stato così. E, se di disonestà si può parlare, si è spesso trattato di una «disonestà» particolare, concepita cioè per offrire agli esseri umani una consolazione che la vita raramente concede. Di sicuro, però, è vero il reciproco della frase di Freud e cioè che la ricerca storico-scientifica, condotta con criteri rigorosi, obbedendo solo alla propria deontologia, esclude ogni «disonestà», il suo fine essendo di arrivare a risultati certi.
Momentaneamente certi, aggiungo. Certi, cioè, fino a quando altre ricerche, altre scoperte, altri documenti falsificheranno quei risultati per proporne di nuovi. La differenza fra la storia (e qualunque altra attività scientifica) e la teologia è infatti soprattutto in questo: la scienza tende a un instancabile avvicinamento a verità perfettibili, la teologia tende a considerare immutabile la sua verità perfino quando le scoperte della scienza la rendono palesemente inverosimile. La ricerca scientifica e la fede religiosa, il perfezionamento di conferme verificabili e la fiducia in verità assolute si muovono su piani distinti.
Per ognuna delle due ci sono spazio e legittimità nella coscienza e nei sentimenti degli individui, assai meno nel campo delle attività razionali e pubbliche. La verità della politica e della convivenza, fatta di mediazioni e di incontri, è diversa dalla verità della fede, fatta di dogmi immutabili. Il filosofo Rousseau era arrivato a dire: «Il cristiano non può essere un buon cittadino. Se lo è, lo è di fatto, ma non di principio, perché la patria del cristiano non è di questo mondo». Vedremo quanto sia vero tale giudizio e quanto il principio abbia pesato nel momento in cui il cristianesimo lentamente si allontanò dal giudaismo originario per diventare una religione a sé.
Il professor Remo Cacitti insegna Letteratura cristiana antica e Storia del cristianesimo antico alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, materie su cui ha grande competenza. Nel dialogo raccolto in questo libro, egli ricostruisce le vicende che hanno caratterizzato la nascita del cristianesimo secondo i risultati della più attendibile e aggiornata ricerca. Nulla che non sia storicamente verificabile entra nel suo racconto. Non mancheranno quindi al lettore le sorprese, come non sono mancate a me, mentre lo ascoltavo raccogliendo le sue parole. Una narrazione basata su documenti è cosa molto diversa da una costruzione teologica, che per suscitare la fede deve trasformare i fatti, filtrarli attraverso categorie sottratte al controllo della ragione.
Quando e come comincia la nuova fede chiamata cristianesimo? È una domanda alla quale si risponde malvolentieri sia perché non è facile sia perché la materia è controversa, per taluni aspetti imbarazzante, basata su fonti aleatorie. Si può allora provare a formulare la questione in modo diverso: quando si conclude la fase che possiamo considerare originaria, aurorale, di questa religione? Ma soprattutto, per cominciare, a quale metodo si affidano gli storici per cercare di ricostruire con fedeltà le varie fasi degli avvenimenti?
Per la dottrina esiste una data ufficiale di nascita della Chiesa: la Pentecoste. Cinquanta giorni dopo la morte di Gesù, lo Spirito santo si manifestò prima come un vento, poi in forma di fiammelle che si posarono sul capo di ciascuno dei discepoli riuniti in assemblea. Riattualizzando l’originale significato ebraico della ricorrenza (legata alle primizie del raccolto e alla rivelazione di Dio su monte Sinai), la Pentecoste cristiana viene vista come la nuova legge donata da Dio ai suoi fedeli.
Questo nella dottrina. Nella realtà storica le origini della nuova religione sono molto più movimentate e incerte. Le due sole frasi che potrebbero far pensare all’intenzione di Gesù di fondare una sua Chiesa sono o male interpretate («Tu sei Pietro e su questa pietra...») o aggiunte in un secondo tempo al testo originario («Andate e predicate a tutte le genti...»). Per la cerchia dei seguaci la realtà della sua morte - di quella morte - dovette rappresentare uno shock tremendo. L’uomo, il profeta, se si vuole il messia tanto atteso, nel quale avevano riposto ogni speranza, al cui messaggio avevano creduto con pienezza di cuore, era finito su un patibolo ignominioso. Di colpo, tutti coloro che avevano creduto in lui erano diventati complici di un criminale giustiziato. La sventura si era abbattuta su di loro e, nello stesso tempo, il regno dei cieli, da lui annunciato come imminente, tardava ad arrivare. La loro risorsa, la loro salvezza fu rifugiarsi nelle antiche scritture della Bibbia, dov’era detto che i giusti secondo Dio sarebbero stati salvati.
A questa consolazione si aggiunse la notizia che la sua tomba era stata trovata vuota: la salma martoriata era scomparsa. Gesù doveva, dunque, essere risorto a nuova vita. I vangeli affermano con assoluta certezza due cose: che Gesù era realmente morto sulla croce; che molte persone lo videro dopo la resurrezione. Videro, cioè, un essere capace di passare attraverso una porta chiusa, di materializzarsi all’improvviso davanti ai suoi seguaci proprio come fanno gli spiriti, ma anche di mangiare del pesce e di far toccare le sue piaghe come un vero essere umano. Secondo gli storici tali apparizioni non sono vere prove di un ritorno dalla morte, sono invece testimonianze molto convincenti della fede che i suoi discepoli avevano in lui. L’annuncio del risorto cominciò a diffondersi in un territorio sempre più vasto a mano a mano che coloro che avevano creduto in lui presero a viaggiare, utilizzando a fini religiosi la fitta rete di comunicazioni che l’Impero romano aveva creato a scopi militari e di commercio.
Tutte le indagini storiche e archeologiche dimostrano che la nuova religione si sviluppò in luoghi diversi e con modalità differenti a seconda di come il racconto delle parole e delle azioni di Gesù veniva riferito passando di bocca in bocca. Come sostengono gli storici, e conferma con convinzione il professor Cacitti, all’inizio non ci fu un solo cristianesimo, ma diversi cristianesimi che avevano rilevanti diversità l’uno dall’altro, erano più o meno radicali, più o meno vicini all’originaria matrice ebraica. Alcune di queste differenze saranno dottrinalmente composte nel corso dei secoli, di altre continua a esserci traccia anche oggi nelle diverse confessioni che si dicono cristiane.
Corrado Augias
* Fonte: la Repubblica, 30 agosto 2008
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana".18 ottobre 2007, di Moebius93
Ciao a tutti,
Invece di farsi delle seghe mentali, non sarebbe meglio approfondire lo studio di storici, fortemente contrastato dallle religioni monoteiste, sicuramente interessate? E’ mai esistito cristo, dove e quando? www.Yeshua.it; www.luigicascioli.it; Piergiorgio Odifreddi; Ecc. ecc. Sono mai esistite, all’epoca, città quali Nazaret, Betlemme,Betania, Cafarnao??? ( Sembra di No) Per fortuna Internet non può essere messa all’indice dal signor natzinger!!! Sembra che "eminentissimi teologi" (???) dopo aver accettato un confronto con gli storici, se la siano poi data a gambe levate adducendo la scusa di " non essere adeguatamente preparati" (!!!) Da quest’ultimi non comprerei un’auto usata.... figuriamoci cristi, croci e fedi varie!!!
I soliti venditori di fumo... Sicuramente passerò inosservato e mi sarà dato del terrorista-laicista... ARICIAO
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?!18 ottobre 2007, di Biasi
Come credente non sono obbligato a fare una ricerca storica dettagliata sulla figura di Gesù per amarlo e seguirlo, così come quelli che hanno fatto seriamente uno studio a riguardo. La fede in Cristo non è solo adesione alle sue idee, come possono essere state interpretate dai suoi primi discepoli, ma adesione alla persona stessa di Gesù, nato da una Vergine, Maria, a Betlemme e crocifisso sotto Ponzio Pilato. È lui che ci interessa, e a lui guardiamo e ascoltiamo.
Così come Lei, abitando in una casa, non è tenuto a verificare continuamente la solidità delle fondamenta del fabbricato.
Se per Lei il Vangelo è solamente un intreccio di leggende, per molti (oltre due miliardi di persone, 1/3 della popolazione mondiale) è la Parola di Dio ! Un pò più di rispetto non guasterebbe.
Come vede non è passato innosservato...
Saluti cordiali.
biagio allevato
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?!22 ottobre 2007, di ballevuoi vedere che anche duemila anni fa nascevano bambini in provetta ! Altrimenti Maria non poteva essere vergine prima, figuriamoci "dopo" . Welby ha dato una lezione di dignità a tutti, e in sua memoria, considerato il torto subito, ho lasciato scritto che in caso di morte il sottoscritto non avrà funerali religiosi. I cristiani non sono due miliardi, ma meno di uno, e se si considera che per cristiani quelli intendono chi è stato battezzato, forze sarà il caso di rivedere anche quell’uno. saluti balle
-
-
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana".4 agosto 2007, di Federico La Sala
Lettera a Bruno Zanin, una vittima della pedofilia clericale
di Fausto Marinetti *
Caro Bruno Zanin,
grazie per il coraggio di riconoscere di essere un uomo. Non hai paura di te. E neppure "al figlio dell’uomo" fai paura, perché lui, ama ogni figlio d’uomo, qualunque cosa abbia fatto.
Tu non ti riempi la bocca di belle parole come facciamo "noi", uomini di chiesa. Sei quello che sei: "Sì, sì, no, no". Fai parte di quella stirpe, che il Cristo cercava allora come oggi: i pubblicani e le meretrici. E lui ha il coraggio di metterli in prima fila, scandalizzando gli osservanti della legge, i benpensanti, compresi coloro che dicono di "amare la chiesa, perché amano Cristo" (attenzione alla cripto-ipocrisia!). Quelli che antepongono la diplomazia al vangelo, quelli che predicano bene e razzolano male, quelli che impongono agli altri dei pesi che loro non muovono con un dito.
Il tuo coraggio ha dato frutto: altre vittime si sono fatte avanti a raccontare il loro trauma. E’ la riprova della mia ipotesi: se tutte le diocesi mettessero a disposizione un telefono verde, quante altre vittime verrebbero alla luce? Quello che noi vediamo è solo il top dell’iceberg... la "sporcizia" è sotto sotto, ma basta stuzzicarla e viene a galla.
Alcuni hanno rivelato nomi eccellenti, ma sono ancora in "coma emotivo", impigliati nella ragnatela della paura, del tradimento, dell’orrore che li paralizza.
Confessano di non aver neppure la forza di denunciare. Non ne vogliono sapere di andare in tribunale, sarebbe rivivere il Calvario, che stanno tentando di cancellare dalla loro carne. E poi ci sono monsignori intoccabili, una sorta di casta, perché, a volte, si servono delle "opere buone" per coprire i loro delitti. Il brutto è che non sono capaci di gettare la maschera come, invece, fai tu. Ma se è gente che fa professione di fede e di carità; se è gente votata al vangelo, come fa a servire Dio e stuprare i suoi figli? E si fanno chiamare "padri"...
Vedi? Io vengo dal di dentro e conosco certi meccanismi o strategie clericali. Credo che uno dei fattori ai quali imputare questa contraddizione, sia la "troppa verità", che li porta all’arroganza della verità (quella che in passato ha fatto le "sante" crociate, bruciato streghe, condannato Galilei, collaborato con la "conquista" e con la shoà, ecc.). Quanta saggezza nelle parole di Paolo: "Chi sta in piedi non si esalti troppo, perché anche lui può cadere...".
Oh se tutti i Fisichella avessero un po’ di spazio dentro di sé (oltre che per la teologia e il catechismo) per accogliere le vittime! Forse è per la troppa verità di cui sono sazi; forse è per la troppa dottrina, che hanno bisogno di nascondersi dietro agli "operai del bene", che, per fortuna, ci sono ancora tra le loro fila, e spesso tollerati quando non ostacolati, contrariati, ecc.? Tu sai che io sono stato dieci anni con uno perseguitato da loro: Don Zeno, il quale non gliele mandava a dire e, con il suo esempio ha criticato e messo in evidenza certa cultura cattolica che non ha niente a che fare con il vangelo. Non si tratta di virgole, ma di vedere la dignità umana secondo gli occhi e il cuore di Dio. Ti faccio qualche esempio:
1 - La cultura clericale non ha sempre trattato il figlio della ragazza-madre come "figlio del peccato"? E lui ironizzava: "Mai sentito dire che il diavolo abbia fatto dei figli!". Quando veniva accolta in comunità una gestante, ci insegnava che era come un ostensorio della vita e, quindi, dovevamo rispettarla, onorarla e anche venerarla come si venera l’eucarestia.
2 - Nel 1943 all’ombra del Santuario di Pompei trova un istituto con la scritta "Casa dei figli dei carcerati". E lui va in bestia: "Questi bambini non sono i figli dei carcerati, ma i gioielli di Dio Padre, carne battezzata, senza macchia d’origine" (27.2.1943). E quando la comunità verrà sciolta dal braccio secolare, con il beneplacito della S. Sede, circa 700 "figli" sono strappati alle madri e riportati negli istituti, scoppiando dal dolore, dirà: "C’è da meravigliarsi che il clero abbia accettato collegi e orfanotrofi? Un flagello! A Pompei hanno fatto perfino la Casa dei figli dei carcerati. Una scritta a caratteri cubitali. Tu, prete, hai il coraggio di chiamare così coloro, che Dio ha scelto, perché rifiutati dagli uomini? Disprezzati dal mondo è un conto, ma anche dalla Chiesa non è troppo? É lecito commettere di questi guai? Siamo come il sacerdote e il levita della parabola del samaritano. Il Calvario è la storia di Dio nell’umanità e Cristo continua a dire alla Chiesa: Donna, ecco tuo figlio. E alle vittime: Figli, ecco vostra madre".
3- Di fronte a un’Italia alla fame, nel dopoguerra, scrive a Pio XII: "In rerum natura non si sono mai visti i babbi e le mamme benestanti e i figli poveri, affamati, ignudi, senza casa. Si è visto e si vede spesso l’inverso. Noi ecclesiastici, padri per divina elezione, di fronte ai figli siamo quindi contro natura, in peccato, dal quale hanno diritto di difendersi. Vuol cambiare rotta? Io ci sto e chissà quanti ci stanno..." (25.5.1953).
Ma Fisichella crede proprio che basta mascherarsi con le opere buone di madre Teresa per cancellare le migliaia di vittime della pedofilia clericale? Altro che insistere nel dire che si tratta di "casi isolati", di responsabilità personale di alcuni preti che "non dovevano diventare preti"! E quella dei vescovi che li hanno smistati qua e là? E la copertura...
La tua confessione "coram populo" ci invita tutti a gettare la maschera, a riconoscerci semplicemente uomini, a non ritenerci migliori degli altri, perché il nostro vanto è proprio quello di essere della stessa pasta di Adamo, creature fragili e perfettibili. Chi non ha bisogno di farsi perdonare qualche cosa? Perché i prelati non dovrebbero ammetterlo? Per salvare l’immagine? Che cosa è questa benedetta immagine se non, appunto, un’immagine?
Fisichella ha perso un’occasione unica durante la trasmissione di Annozero? Se invece di arrampicarsi sui vetri per difendere a tutti i costi la chiesa, (Cristo non ha bisogno di crociati, vecchi o nuovi), si fosse inginocchiato davanti alla donna stuprata per anni da don Contini, che cosa sarebbe successo? Un’occasione d’oro mancata. Mancanza di coraggio o di fede?
Certo, meglio la diplomazia, l’arte di non perdere la faccia, "l’istituzione va salvata ad ogni costo"! Ma Cristo, altro che faccia...!, non ha perso tutto quanto quando è andato ad "abitare" sul Calvario? Se è vero che vi sta a cuore l’istituzione, perché non prevenire tanto male, tanta aberrazione coltivata nei seminari, tanta cultura sessuofobica, che non vi fa vedere la corporeità, i figli, le donne, ecc. con gli occhi di Dio?
Perché non si ha questo santo coraggio? Perché siamo diventati ecclesio-latri, abbiamo messo la chiesa al posto di Dio? Ma dove esiste nel vangelo il "culto" alla chiesa, al papa, ai principi della Chiesa?
E quanti disastri continua a fare l’idolatria del prete? Cosa non si fa per fargli credere di essere "altro" dal popolo, un diverso, un eletto, un predestinato? Non si è forse elaborata una "dottrina" per metterlo sul piedestallo di Dio stesso?
La teologia distingue tra il sacerdozio di "uomini speciali" e il "sacerdozio comune dei fedeli". Al sacerdote sono affidati poteri essenziali per la salvezza: celebrare l’eucarestia e perdonare in nome di Dio. Il concilio di Trento dichiara: "Se uno dice che nel Nuovo Testamento non c’è traccia visibile del sacerdozio e del potere di consacrare il corpo e il sangue di Cristo e di rimettere i peccati, sia anatema" (n°. 961). Il celibato obbligatorio rinforza la mistica del prete, che lo pone al di sopra dei laici. Quando viene ordinato si unisce a Cristo in tale maniera che è sostanzialmente diverso dagli altri (catechismo, 1581), perché "possiede l’autorità di agire con il potere e nella persona di Cristo stesso" (1548). Viene messo sul pulpito, accanto a Dio, di cui gode onori e privilegi. Il curato d’Ars dice: "Che cosa è un prete? Un uomo che sta al posto di Dio, investito di tutti i suoi poteri. Quando perdona non dice "Dio ti perdoni", ma "Io ti perdono". Se incontrassi un prete e un angelo, prima saluterei il prete poi l’angelo. Questi è amico di Dio, il prete sta al suo posto". S. Teresa baciava dove passava un prete. "Il sacerdote agisce in persona Christi e questo culmina quando consacra il pane e il vino" (Giovanni Paolo II, giovedì santo 2004). La divisione tra preti e laici è di origine divina (can. 207). Ma l’aureola anzitempo gioca brutti scherzi: ti illude di essere costituito in grazia, immune dal peccato, specie da quello banale e volgare del sesso, che spetta ai comuni mortali. Il passaggio dal potere al privilegio, dall’elite alla casta è breve. E così va a finire che il clericalismo distorce, distrugge, avvelena la missione della Chiesa. Se non è la causa di molti problemi, certo li causa per conservare privilegi, potere, prestigio, immagine. Quindi non è ammessa nessuna debolezza, lo scandalo va soppresso, le vittime messe a tacere. Corruzione e abuso inevitabili (cf "Sex, priests & secret codes, R. Sipe, T. Doyle, P. Wall, Los Angeles, 2006).
Se si fa credere al prete di essere "come Dio", è chiaro che questo influisce e condiziona la sua psiche al punto di considerarsi al di sopra della legge umana e inconsciamente si permette delle libertà, che non sono concesse ai comuni mortali.
Non ce n’è abbastanza per riflettere e decidere di cambiare rotta?
* Il dialogo, Sabato, 04 agosto 2007
*Ringraziamo Fausto Marinetti per averci inviato questa sua lettera a Bruno Zanin, una vittima della pedofilia clericale che ha raccontato la sua storia in un libro che fa tremare: "Nessuno dovrà saperlo" dove con raro coraggio ammette, come conseguenza, di essere diventato omosessuale, non pedofilo. Per lui, come per tanti altre vittime della pedofilia dei preti, nessuno muove un dito, neppure le scuse come avviene in America dove le vittime hanno diritto alle pubbliche scuse del vescovo, possono "raccontare" in chiesa il "fattaccio" o scriverlo sul giornale della diocesi. Possono anche giungere ad erigere nella piazza di Davenport, davanti alla casa del vescovo, una macina da mulino con le parole di Cristo: "Chi scandalizza un bambino sarebbe meglio per lui mettersi una macina da mulino al collo e buttarsi nel mare".
Verrà il giorno in cui in piazza S. Pietro, al posto della fontana, si metterà una gigantesca macina da mulino a perpetua memoria delle vittime dei preti?
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana".10 luglio 2007, di Federico La Sala
 Nuovo documento della Congregazione per la dottrina della fede
Nuovo documento della Congregazione per la dottrina della fede
 Ribadita la Dominus Iesus
Ribadita la Dominus IesusNuovi ostacoli sulla via dell’ecumenismo
Riportiamo di seguito le notizie dell’agenzia SIR del 10-7-2007 sul nuovo documento della Congregazione per la dottrina della fede dal titolo : "Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa" che affronta questioni legate all’ecumenismo. L’attuale documento si muove nel solco della Dominus Iesus che tanta polemica suscitò nel 2000 all’atto della sua promulgazione e che di fatto può considerarsi come il primo atto di Papa Ratzinger quando era ancora Cardinale. Nulla di nuovo dunque, se non la constatazione che il cammino ecumenico si fa sempre più difficile ed impervio. Il nuovo documento può essere letto al seguente link:
10/07/2007 12:00
SANTA SEDE: DOCUMENTO, “FUGARE VISIONI INACCETTABILI” PER “PROSEGUIRE IL DIALOGO ECUMENICO”
“Un chiaro richiamo alla dottrina cattolica sulla Chiesa”, che “oltre a fugare visioni inaccettabili, tuttora diffuse nello stesso ambito cattolico, offre preziosi indicazioni anche per il proseguimento del dialogo ecumenico, che resta sempre una delle priorità della Chiesa cattolica”. E’ il nuovo documento della Congregazione della dottrina della fede, “Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa”, diffuso oggi dalla sala stampa vaticana. Il testo - 16 pagine, articolate in cinque quesiti a domanda e risposta - intende “richiamare il significato autentico di alcuni interventi dl Magistero in materia di ecclesiologia perché la sana ricerca teologia non venga intaccata da errori e da ambiguità”, in modo da rispondere ad “interpretazioni errate”, “deviazioni e inesattezze”. Punto di partenza, la costituzione dogmatica Lumen Gentium ed i decreti conciliari sull’ecumenismo (Unitatis Redintegratio) e sulle Chiese orientali (Orientalium Ecclesiarum), e gli “approfondimenti e orientamenti per la prassi” offerti da Paolo VI nell’Ecclesiam Suam e da Giovanni Paolo II nell’Ut Unum Sint. Non mancano “puntualizzazioni e richiami” più recenti della stessa Congregazione per la Dottrina della Fede, come quelli contenuti nella Dominus Iesus.
10/07/2007 12:00
SANTA SEDE: DOCUMENTO, “IL CONCILIO NON HA CAMBIATO LA PRECEDENTE DOTTRINA DELLA CHIESA”
“Il Concilio ecumenico Vaticano II né ha voluto cambiare né di fatto ha cambiato” la precedente dottrina sulla Chiesa, “ma ha voluto solo svilupparla, approfondirla ed esporla più ampiamente”. A ribadirlo è il nuovo documento della Congregazione per la dottrina della fede, “Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa”, diffuso oggi dalla sala stampa vaticana. Nel primo quesito, citando le parole di Paolo VI nel suo discorso di promulgazione della Lumen gentium, la Congregazione pontificia fa notare che “c’è continuità tra la dottrina esposta dal Concilio e quella richiamata nei successivi interventi magisteriali”: anche la Dominus Iesus “ha solo ripreso i testi conciliari e i documenti post-conciliari, senza aggiungere o togliere nulla”. Nonostante ciò, la dottrina del Concilio, denuncia il dicastero vaticano, “è stata oggetto, e continua ad esserlo, di interpretazioni fuorvianti e in discontinuità con la dottrina cattolica tradizionale sulla natura della Chiesa”, concentrandosi “su singole parole di facile richiamo” e “favorendo letture unilaterali e parziali della stesa dottrina conciliare”. “L’idea di popolo di Dio, la collegialità dei vescovi come rivalutazione del ministero dei vescovi insieme con il primato del Papa, la rivalutazione delle Chiese particolari all’interno della Chiesa universale, l’apertura ecumenica del concetto di Chiesa e l’apertura alle altre religioni”: queste le acquisizioni centrali dell’ecclesiologia conciliare, così come viene delineata nella Lumen gentium. Su tutto, puntualizza la Congregazione per la dottrina della fede, si staglia però “la questione dello statuto specifico della Chiesa cattolica, che si esprime nella formula secondo cui la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, di cui parla il Credo, ‘subsistit in Ecclesia catholica’ (sussiste nella Chiesa cattolica, ndr.).
---------------------------------------
10/07/2007 12:01
SANTA SEDE: DOCUMENTO, “DIVISIONE TRA I CRISTIANI OSTACOLO ALLA PIENA REALIZZAZIONE DELLA CHIESA”
“L’universalità propria della Chiesa, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, a causa della divisione dei cristiani, trova un ostacolo per la sua piena realizzazione nella storia”. E’ una delle affermazioni centrali del nuovo documento della Congregazione per la dottrina della fede, diffuso oggi dalla sala stampa vaticana. Il secondo e il terzo quesito, in particolare, si soffermano sull’”unica Chiesa di Cristo, una santa, cattolica e apostolica”, come recita la Lumen gentium. “Secondo la dottrina cattolica - spiega il testo - mentre si può rettamente affermare che la Chiesa di Cristo è presente e operante nelle Chiese e nelle comunità ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica grazie agli elementi di santificazione e di verità che sono presenti in esse, la parola ‘sussiste’, invece, può essere attribuita esclusivamente alla sola Chiesa cattolica, poiché si riferisce appunto alla nota dell’unità professata nei simboli della fede”. La “preoccupazione” di fondo del documento, dunque, è “salvaguardare l’unità e l’unicità della Chiesa, che verrebbe meno se si ammettesse che vi possano essere più sussistenze della Chiesa fondata da Cristo”. Per i padri conciliari, precisa la Congregazione per la dottrina della fede, “l’identificazione della Chiesa di Cristo con la Chiesa cattolica non è da intendersi come se al di fuori della Chiesa cattolica ci fosse un ‘vuoto ecclesiale’”: al contrario, con l’espressione “subsistit in”, il Concilio ha voluto affermare “da un lato, che la Chiesa di Cristo, malgrado le divisioni dei Cristiani, continua ad esistere pienamente soltanto nella Chiesa cattolica, e, dall’altro, l’esistenza di numerosi elementi di santificazione e di verità al di fuori della sua compagine, ovvero nelle Chiese e comunità ecclesiali che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica”: di qui il carattere “a prima vista paradossale” dell’ecumenismo cattolico, in camino verso “l’unità con tutti i cristiani”. “Il Concilio ha voluto insegnare che la Chiesa di Gesù Cristo come soggetto concreto in questo mondo può essere incontrata nella Chiesa cattolica”, si legge ancora nel testo, in cui il quarto e quinto quesito sono dedicati al rapporto con le Chiese orientali separate, chiamate “Chiese sorelle delle Chiese particolari cattoliche” perché “restano unite alla Chiesa cattolica per mezzo della successione apostolica e della valida eucaristia”, e con le comunità ecclesiale nate dalla Riforma, con le quali “la ferita è molto più profonda”.
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana".18 luglio 2007, di Federico La Sala
IDEE
Il filosofo Spaemann mette in guardia da chi accusa le religioni di fomentare l’odio e il terrore: all’origine dei tre monoteismi vi è una divinità che si rivolge all’uomo attraverso il «logos». La ragione, dunque, appartiene al credente in quanto relazione con l’altro. Chi rifiuta questa dimensione dialogica apre la strada alla conflittualità
Ma Dio non è violenza
«Troppo spesso ancora nel mondo musulmano vince la via sanguinaria. Anche l’islam deve intraprendere la strada del dialogo comune»
di Robert Spaemann (Avvenire, 18.07.2007)
Non è un caso che il discorso di Regensburg abbia aperto un controverso dialogo con l’Islam. Senza il colpo di avvertimento costituito dalla citazione di un imperatore bizantino, più di trenta famosi professori islamici forse non avrebbero mai pensato di accettare l’invito al dialogo, di prenderlo sul serio, di rispondere gentilmente e di cominciare subito ad avanzare delle critiche invece dei soliti scambi di cortesie. Che altri musulmani abbiano reagito con un atto di violenza sanguinaria conferma che la questione del rapporto fra fede e violenza resta per l’Islam un problema aperto. Il Papa ha facilitato l’apertura di un dialogo serio ammettendo senza infingimenti apologetici che anche la cristianità ha avuto questo problema per tanto tempo e che spera che l’Islam compia lo stesso processo di apprendimento che ha compiuto la Chiesa. Oggetto di tale dialogo sarà verificare se il Corano favorisca un tale processo allo stesso modo del Nuovo Testamento. Metterlo inizialmente in dubbio fa parte di un onesto inizio di dialogo.
Ci si potrebbe chiedere perché bisogna discuterne e forse scontrarsi. Se i musulmani avessero un altro Dio rispetto ai cristiani un tale scontro sarebbe privo di senso. I cristiani potrebbero solo ribadire che non credono all’esistenza di quel Dio. In effetti tanti cristiani ritengono che Allah sia un altro Dio rispetto a quello dei cristiani. Se fosse così non avrebbe alcun senso scontrarsi rispettosamente su come si debba pensare e parlare correttamente di Dio. Ma in conformità col suo grande predecessore medievale Gregorio VII e col Concilio Vaticano II, Benedetto XVI parte dal presupposto che gli ebrei, i cristiani e i musulmani pregano lo stesso Dio uno e unico.
La lezione magistrale di Regensburg parla soprattutto della differenza che nel mondo di oggi salta agli occhi. Essa riguarda il tema «Dio e violenza». Ricollegandosi alle riflessioni di un imperatore bizantino, il Papa collega questo all’altro tema: «Dio e ragio ne». La ragione è quello step beyond ourselves la cui possibilità la modernità nega. Ho cercato, riferendomi a Nietzsche, di mostrare che questa possibilità dipende dall’esistenza di Dio e proprio di un Dio che nella sua essenza è luce. La ragione dunque non è uno strumento di sopravvivenza dell’homo sapiens, ma partecipazione alla luce divina e un vedere il mondo in questa «luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo» (Gv 1,9). Questa luce, come dice Platone, fa vedere il bene come il koinon, «ciò che è comune a tutti» (cfr. Platone, Fedone). Non a caso Eraclito parla a questo riguardo del logos, e logos significa anche «parola».
Soltanto attraverso la parola, soltanto attraverso la lingua, attraverso il parlare con gli altri, noi ragioniamo. La violenza però è l’esatto contrario del parlare con gli altri. Lo scopo del discorso è l’intesa tramite la comune sottomissione al criterio del vero, lo scopo della violenza è la sottomissione dell’altro alla volontà di colui che si dimostra fisicamente più forte. Michel Foucault, che nega l’intelligibilità del mondo, deve di conseguenza minimizzare la differenza tra dialogo e violenza. Siccome non esiste un qualcosa che sia verità, anche nel dialogo può trattarsi solo di misurare le forze nella lotta per il potere. Così già pensavano d’altronde i sofisti con i quali si scontrò Socrate. Soltanto quando si dà verità come koinon si dà un’alternativa alla violenza. Il criterio della forza fisica non ha nulla a che fare con quello della verità. E la vittoria nello scontro violento solo per caso può anche essere la vittoria del migliore. C’è la forza legittima dello Stato, la cui ragione risiede nell’impedire la violenza tra gli individui, c’è la forza legittima del potere statale per la difesa contro la violenza di un’ingiusta aggressione. Ma lo scatenarsi della violenza, la trasformazione del dialogo in violenza è semp re il fallimento della ragione, e la probabilità che una situazione violenta possa essere migliorata con la violenza è scarsa.
Ma è soprattutto la violenza nel nome di Dio che è condannata inequivocabilmente da Benedetto XVI. Dio come Signore della storia agisce attraverso tutto ciò che succede e anche la violenza dei violenti alla fine dovrà servire al Suo scopo. Ma lo serve solo come tutto ciò che è malvagio. La Sua volontà è fatta sempre e dappertutto. Non deve chiedere il permesso. Ma non dappertutto sulla terra succede come in cielo, e cioè attraverso il conformarsi della volontà degli angeli e degli uomini alla volontà di Dio. Mefistofele, nel Faust di Goethe, confessa di essere parte «di quella Forza che sempre vuole il male e sempre il bene crea». Noi preghiamo affinché la volontà di Dio non sia fatta sulla terra così, ma «come in cielo», e questo significa anche: non tramite la violenza. Anche il popolo di Israele, a questo riguardo, ha compiuto un processo di apprendimento che si conclude soltanto con Gesù. E nonostante questa conclusione, la cristianità nel Medioevo ha creduto ancora di dover punire con pene temporali fino alla condanna a morte almeno l’apostasia e l’eresia: un punto di vista che vige ancora oggi nei Paesi islamici.
Ma non si può costringere a rimanere nella luce con i mezzi delle tenebre. Laddove dei cristiani vengono perseguitati in quanto cristiani, essi, seguendo il loro Signore, rinunciano a restituire la violenza. Dove dei cristiani, d’altronde, difendono legittimamente la civitas terrena in qualità di cittadini di essa, sanno che il processo della violenza, nei suoi esiti, è indifferente alla giustizia e all’ingiustizia. Non si presenteranno dunque in nome di Dio e in nome del bene per punire i cattivi e terranno l’odio che avvelena l’anima fuori dallo scontro. Dove vige la violenza, la ragione tace e l’unica forma della sua perdurante presenza può essere soltanto quel rispetto dei nemici che anticipa già la riconciliazione.
Non sempre possiamo decidere se avere o no nemici. A volte può essere giusto smitizzare l’idea del nemico, a volte no. Dobbiamo verificare l’idea che abbiamo del nemico confrontandola con la realtà. Ma ciò che invece possiamo decidere è di chiedere la forza di amare i nemici. Tale forza trasforma lo status della violenza che si oppone a Dio ed è il suo modo supremo con cui la luce può illuminare le tenebre, la luce della ragione e dell’amore, il cui massimo testimone è nel nostro tempo Papa Benedetto XVI.
IL DIBATTITO
Dopo Ratisbona, quale dialogo tra le fedi?
Il richiamo alla ragione che Benedetto XVI ha fatto nel discorso di Ratisbona ha suscitato un dibattito molteplice e anche incomprensioni forzate, sebbene il discorso del Papa fosse incentrato sulla necessità di un dialogo che abbia come riferimento il criterio della verità. Su questo ora prendono la parola cinque intellettuali nel volume «Dio salvi la ragione», edito da Cantagalli, che, oltre al testo di Benedetto XVI, presenta gli interventi di Wael Farouq, André Glucksmann, Sari Nusseibeh, Robert Spaemann e Joseph H.H. Weiler. Dal volume, pubblichiamo alcuni stralci del saggio del filosofo Robert Spaemann (nella foto), incentrati sulla questione del presunto rapporto fra religione e violenza.
-
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana".10 luglio 2007, di Federico La Sala
VATICANO: CHIESA CATTOLICA UNICA VOLUTA DA CRISTO
(di Elisa Pinna) *
Cristo ha "costituito sulla terra un’unica Chiesa", che si identifica"pienamente" solo nella Chiesa cattolica: è quanto ribadisce un documento pubblicato oggi dalla Congregazione vaticana per la Dottrina della Fede, che però riconosce alle altre confessioni cristiane, e in particolare agli ortodossi,"numerosi elementi di santificazione e verità".
La nuova nota dottrinale, firmata dal Prefetto del Dicastero vaticano per la fede, lo statunitense William Levada, ed approvata da Benedetto XVI lo scorso 29 giugno, è un testo agile, con stile didascalico, di una quindicina di pagine, diviso in tre parti: una prefazione, una sezione dialogica con cinque risposte ad altrettanti quesiti, e un articolo di commento. Il titolo è "Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina della Chiesa". Scopo dichiarato del libriccino è quello di sgombrare l’orizzonte teologico dalle tante confusioni e interpretazioni "infondate" che si sono accumulate negli anni attorno al documento conciliare ’Lumen Gentium’ (1963) e in particolare su un passaggio in cui i padri conciliari affermano che ’la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica’. In tale pronunciamento, alcuni studiosi cattolici - tra cui é citato esplicitamente il brasiliano Leonardo Boff - hanno visto la possibilità che la Chiesa di Cristo "sussista", con pari pienezza, anche in altre chiese cristiane, oltre che in quella romana. Si tratta - puntualizza il documento della Congregazione per la Fede - di "interpretazioni infondate", "inaccetttabili", che hanno "frainteso" l’insegnamento dottrinale del Concilio Vaticano II. La parole ’sussiste’ - afferma il testo - "può essere attribuita alla sola Chiesa cattolica", che presenta "perenne continuità storica" e "la permanenza di tutti gli elementi istituiti da Cristo". Nonostante questo dato di principio, il documento apre la porta dell’ecumenismo: benché le altre chiese cristiane abbiano alcune "carenze" (in particolare il fatto di non riconoscere il primato del Papa su tutti gli altri vescovi), esse "non sono affatto spoglie di significato e di peso" nel "mistero della salvezza". "Infatti - si afferma in uno dei passaggi chiave - lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse come strumento di salvezza, il cui valore deriva dalla stessa pienezza della grazia e della verità, che è stata affidata alla Chiesa cattolica". Inoltre - puntualizza la nota in un’altra frase di rilievo ecumenico - "sarà sempre necessario sottolineare che il Primato del successore di Pietro, Vescovo di Roma, non deve essere inteso in modo estraneo o concorrente nei confronti dei vescovi delle chiese particolari".
La nota del Vaticano ribadisce, sulla scia dello spirito conciliare, che il titolo di "Chiese particolari" spetta alle diverse comunità nazionali ortodosse, accomunate alla Chiesa cattolica dal riconoscimento del sacerdozio e dell’eucarestia. Viceversa le comunità protestanti, nate dalla riforma luterana del sedicesimo secolo, non possono essere considerate, dalla dottrina cattolica, "chiese in senso proprio", in quanto non contemplano il sacerdozio e non conservano più in modo sostanziale il sacramento dell’Eucarestia. Nessun accenno, nel documento, all’ebraismo e all’Islam. Del resto sarebbe stato fuori luogo perché si tratta di un testo tutto interno alla dottrina cristiana e alla riflessione teologica innescata dal Concilio vaticano II.
* ANSA» 2007-07-10 16:28
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana".6 giugno 2007, di Federico La Sala
Deporre i poveri dalla croce: cristologia della liberazione
di ADISTA *
Importante iniziativa di Adista che ha tradotto e messo a disposizione gratuitamente il libro "Deporre i poveri dalla croce: cristologia della liberazione" edito dalla Commissione Teologica Internazionale della ASETT, Associazione Ecumenica dei Teologi/ghe del Terzo Mondo, in risposta alla notificazione vaticana sulle opere di Jon Sobrino.
Care lettrici, cari lettori,
segnaliamo un’importante novità sul nostro sito. Si può leggere finalmente anche in italiano, scaricandolo gratuitamente dalla home page di www.adista.it, il libro digitale "Bajar de la cruz a los pobres: cristología de la liberación" ("Deporre i poveri dalla croce: cristologia della liberazione") della Commissione Teologica Internazionale della ASETT, Associazione Ecumenica dei Teologi/ghe del Terzo Mondo.
La traduzione italiana, curata da Adista, dell’originale spagnolo (che, insieme alla traduzione in inglese, è disponibile agli indirizzi www.eatwot.org/TheologicalCommission e http://www.servicioskoinonia.org/LibrosDigitales) è presentata dal teologo Carlo Molari e presenta due contributi in più: di Aloysius Pieris e dello stesso Molari (è possibile leggere l’originale )
Il libro della Asett è la risposta di circa 40 teologi della liberazione alla Notificazione vaticana sulle opere di Jon Sobrino (autore dell’epilogo del libro), ma non solo: è una difesa, appassionata e potente, della cristologia della liberazione, quella che Leonardo Boff, nel prologo, definisce "una teologia militante che lotta per ’far scendere dalla croce i poveri’".
È questa voce potente quella che è oggi offerta anche al pubblico italiano, attraverso un nuovo metodo che l’Asett ha voluto sperimentare: quello di un libro digitale, libero e gratuito, che, scrive José María Vigil, coordinatore della Commissione Teologica Internazionale della Asett/Eatwot, "può essere regalato e inviato da chiunque per posta elettronica e che potrà anche essere stampato su carta mediante il procedimento della "stampa digitale", un metodo che permette di stampare su carta quantità minime di esemplari (5, 10, 20...), a un prezzo praticamente uguale a quello di un libro normale".
Per scaricare il libro, clicca qui
* IL DIALOGO, Mercoledì, 06 giugno 2007
-
> GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!! A memoria eterna di PIERGIORGIO WELBY e della sua lezione di sovranità umana, civile, e "christiana".2 maggio 2007, di Federico La Sala
 E’ ancora polemica dopo le parole pronunciate ieri dal palco di San Giovanni
E’ ancora polemica dopo le parole pronunciate ieri dal palco di San Giovanni
 Il quotidiano parla di "guerra strisciante, di nuova stagione della tensione"
Il quotidiano parla di "guerra strisciante, di nuova stagione della tensione" Concertone, il Vaticano all’attacco
Concertone, il Vaticano all’attacco
 L’Osservatore: "E’ terrorismo"
L’Osservatore: "E’ terrorismo"Rivera: "Sovrano è il popolo non gli organizzatori del concerto" *
ROMA - L’Osservatore romano giudica "vili attacchi" quelli pronunciati dal palco durante il Concertone di ieri a Roma e paragona le parole di Andrea Rivera, uno dei conduttori, ad un gesto di "terrorismo". Dal palco di San Giovanni Rivera, aveva attaccato il Papa "che non crede nell’evoluzionismo". "La chiesa non si è mai evoluta. Non sopporto che il Vaticano abbia rifiutato i funerali di Welby. Invece non è stato così per Pinochet, per Franco e per uno della banda della Magliana" aveva scandito dal microfono.
E oggi, dopo le critiche al conduttore espresse dai sindacati e dal direttore di Raitre, scende in campo anche il quotidiano della Santa Sede che equipara le parole di Rivera ad un atto "terroristico": "E’ terrorismo alimentare furori ciechi e irrazionali contro chi parla sempre in nome dell’amore. E’ vile e terroristico lanciare sassi questa volta addirittura contro il Papa, sentendosi coperti dalle grida di approvazione di una folla facilmente eccitabile".
Al concerto dei sindacati, denuncia l’Osservatore, si è tenuto "un piccolo comizio, dando vita ad un confuso e approssimativo discorso sull’evoluzionismo e sui temi della vita e della morte. Tutto questo di fronte a circa 400.000 persone e ad un più numeroso pubblico televisivo". Ed anche se, "i sindacati ed altri partecipanti alla manifestazione si sono dissociati dalle parole del conduttore, resta il fatto - rileva il quotidiano vaticano - che questo personaggio da qualcuno è stato scelto. E chi l’ha scelto non ha tenuto conto del momento che stiamo vivendo".
"Sono di queste ore - ricorda il quotidiano vaticano - gli attacchi e le minacce, pesanti, rivolte al Presidente della Cei, l’arcivescovo Angelo Bagnasco, a cui è arrivata l’apprezzata solidarietà del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sono di queste ore anche gli slogan nei cortei inneggianti ai terroristi, i messaggi che appaiono su internet, provenienti da br in carcere, un’offensiva che cerca di trovare terreno fertile nell’odio anticlericale".
"Qualcuno vuole aprire una guerra strisciante, una nuova stagione della tensione, dalla quale trae ispirazione chi cerca motivi per tornare ad impugnare le armi, per rivitalizzare organizzazioni che hanno perso su tutti i fronti, primo fra tutti quello della storia. Anacronismi. Come quella presenza sul palco a san Giovanni. Un residuato in mezzo a tanti giovani".
Ma Rivera non arretra di un millimetro. "Per me è sovrano il popolo e non gli autori del concerto - dice dai microfoni di ’Radio Capital’ - Voglio dare voce alla gente comune che non può mai dire in tv quel che pensa". Ipocrita è stata poi definito il riferimento ai funerali negati a Welby dalla Chiesa. "Non è forse vero che a Welby sono stati negati i funerali concessi invece a Pinochet? Chi è allora - ha concluso Rivera - l’ipocrita?".
* la Repubblica, 2 maggio 2007
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!3 aprile 2007, di Federico La Sala
Welby, salviamo il dottor Riccio
di Furio Colombo *
Ci sono molte ragioni - umane e civili - per non dimenticare il caso di Piergiorgio Welby, la sua sofferenza, la sua residua ma forte voce che non ha smesso richiedere agli esseri umani che gli stavano intorno di intervenire e di porre fine, per dovere morale e secondo la legge, al suo disumano dolore.
Qualcuno lo ha fatto. Lo ha fatto l’appello ostinato dei radicali, di Marco Cappato, a cui in molti ci siamo uniti, medici, giuristi, politici, cittadini di tutta Italia.
Uno di loro, uno di noi, il medico anestesista Mario Riccio, lo ha fatto.
Seguendo scrupolosamente il poco che le norme italiane indicano e consentono per rispettare la dignità e la volontà di una persona che non può più soffrire, il Dottor Riccio ha fermato la macchina-tortura che stava comunque portando Welby alla morte, però più lenta, più indecorosa, capace solo di alimentare un dolore sempre più grande.
Ora - nonostante la richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Roma, il Tribunale della stessa città annuncia di voler processare il medico e lo accusa di omicidio di persona consenziente, cioè di reato gravissimo. Non diremo che la decisione annunciata - se presa - avrà un fondamento teologico e non giuridico, per il rispetto sempre dovuto alla Magistratura.
Diremo che è tempo per tutte le persone guidate da un senso di umanità e solidarietà di essere presenti, attive e impegnate a sostenere due cause: la dignità del malato Welby, che aveva chiesto a lungo e invano - come in un film dell’orrore - che si ponesse fine alla sua sofferenza.
E l’atto di umanità da medico e da cittadino, compiuto a nome di tutti noi, dal medico Riccio, in base alla sua conoscenza, competenza e coscienza.
Chi di noi ha provato gratitudine - e anche riscatto per la propria incapacità di accorrere in aiuto - quando il Dottor Riccio è intervenuto, adesso ha l’impegno di essergli accanto e sostenerlo.
È giusto scrivere queste cose sul giornale di quella sinistra che della solidarietà, del soccorso, della dignità, del rispetto della persona e dei suoi diritti fondamentali ha sempre fatto la sua bandiera.
Propongo al nostro giornale di aprire una sottoscrizione: un fondo di difesa per sostenere al livello più alto le ragioni umane morali e civili che hanno guidato il Dottor Riccio nella sua decisione e nel suo intervento che ha posto fine al dolore.
In un mondo impegnato - anche con le sue migliori risorse tecnologiche - a creare dolore, occorre difendere Riccio ma anche il simbolo alto di ciò che ha fatto. Contribuisco a questo appello con 1000 euro. Ma anche un solo euro sarà contributo di testimonianza dovuta. È una buona, nobile, umanissima causa in cui nessuno deve tacere.
* l’Unità, Pubblicato il: 03.04.07, Modificato il: 03.04.07 alle ore 10.27
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!7 aprile 2007, di michelangelo
Un granello si sabbia in memoria di Piergiorgio Welby E se la sabbia del deserto fosse la Verità? Chi può asserire di conoscere l’architettura di un granello di sabbia in tutta la sua macrocosmica grandezza ed in tutta la sua microscopica infinitesimale dimensione? E se così fosse, avrebbe scoperto la natura della sua essenza e del suo divenire? E se la mente fosse il deserto di sabbia? La coscienza vigile, attenta, pensante, decisionale, serena o turbata, sana o malata, lucida o offuscata, razionale o irrazionale, libera o condizionata, quanta parte occuperebbe nel deserto della mente? Io dico: lo spazio di un granello di sabbia per l’uomo “comune” e per il genio, il poeta, l’artista, lo scienziato, il santo tanta sabbia quanta ne può essere contenuta in un pugno.
Ed ecco come una parte della verità sta in tutte le ragioni così come la ragione contiene sempre una parte della verità, sia del laico che del religioso. Ma quanta? Prendi un pugno sabbia dal deserto: questa è la porzione di verità che ti offre la tua mente cosciente e la chiesa del tuo tempo. Il “farsi suicidare” da una condizione alterata della mente cosciente non sarà mai la decisione di un libero arbitrio padrone assoluto del Regno della Mente, ove risiedono tulle le più sublimi ed inimmaginabili virtualità. Laddove l’Individualità dell’Io più profondo, si ricongiunge con la matrice che l’ha emanato e ad essa identificandosi ne acquisisce, in potenza, attributi e divinità. E la vita terrena di Piergiorgio programmata per sua libera scelta nella notte dei tempi ed intensamente vissuta in un attimo della sua eternità, anche se interrotta per le ragioni di un pugno di sabbia, nulla toglie ma molto aggiunge alla sua ricchezza spirituale d al suo cammino evolutivo nel ritorno al Padre attraverso quella scala di valori di cui tanta ne ha percorsa nella sua breve vita di quanto l’umanità nella maggioranza ne percorre in un secolo. E questo è l’autentico patrimonio di Piergiorgio. Per il resto: delitto o non delitto, che l’ UOMO rifletta!
***************
Un altro granello di sabbia per Piergiorgio Welby Caro Piergiorgio, anche io ho provato commozione per la tua sensibilità e per l’amore che hai nutrito per la vita e per tutti. Generalmente chi nutre tanto amore per gli altri ne ha un po’ meno per se stesso. Rispetto la tua volontà anche se rimango della convinzione che il tuo “Spirito” - la mente profonda - è rimasto ad osservare senza intervenire, con la “Sua autorità”, alla premeditata decisione. Certo non te ne sei andato in silenzio. A meno che, e ora ne sono convinto, l’abbia fatto di proposito per attirare l’attenzione del mondo scientifico, perchè all’uomo non serve l’accanimento ma la scoperta del farmaco, la prevenzione e la guarigione. Una provocazione? No! Una accusa precisa al “progresso”.
Si spacca l’atomo, si va sulla luna, si configurano e si organizzano miliardi e miliardi di informazioni in un piccolo monitor , che tutto lo scibile umano si chiami internet, si investono miliardi e miliardi per il benessere, per lo sport, la tecnologia.......e non si dirotta la maggior parte di tutte queste risorse per debellare la fame, le guerre e le malattie. Mille, centomila scienziati dovrebbero essere rinchiusi in un bunker per uscire solo quando avrebbero risolto i problemi che affliggono l’uomo. E che nessuno mi dica che è impossibile. Niente è impossibile all’uomo, se lo vuole. E’ per questo che Cristo andò sulla croce, che il martire si fa Santo, che tu riscatti tutti i Piergiorgio che giacciono non in attesa che la legge li uccida, ma che l’UOMO LI GUARISCA.
***************
Una bara bianca per Piergiorgio. A Loredana che mi ha inviato la canzone di Simone Cristicchi. Grazie del commento e del testo della canzone. Rispetto la tua riflessione su welby ed è molto poetica la canzone. Ma l’autore è sano e pieno di vita e... di successo, mentre Piergiorgio era solo tra tante ombre oscure, immerso e perduto nei suoi pensieri. Anche lui ha scritto dei bellissimi versi poetici, toccanti e pieni di amore per la vita e per il mondo intero. E quando Piergiorgio scriveva era pieno di vitalità, di voglia di vivere, e anche con la sua sofferenza "correva" incontro alla vita. Ne sono convinto. Uno Spirito elevato che sa di poter dare tanto, non decide di negare agli altri e a se stesso le perle della sua stessa saggezza. Tutto quanto, invece, girava attorno a lui, amici, familiari, medici, politici era un elogio alla morte, un’attesa, un atmosfera lugubre e pregna di energia negativa. Nessuna esortazione alla vita, ma uno squallido movimento mediatico e politico. La camera della morte allestita da tempo. E il Gesto non s’è fatto attendere. Un boia laureato per l’occasione e pochi intimi corvi neri furono le ultime immagini che i begl’occhi di Piergiorgio furono costretti a vedere mentre gli porgevano la cicuta. Nessuno dei presenti avrà pianto. Le lacrime sono venute da chi non l’ha conosciuto.
*****************
Io ho pianto. Ho pianto mentre scrivevo quest’ultima provocazione, perché sono emotivo e perché so di non essere compreso, questo poi credo che sia un mio karma. Io non sarei mai capace di pensare di dire: ti amo, ti amo da morire ma ti tolgo la vita per il tuo bene, per non farti soffrire e perché tu me lo chiedi. Qualcuno “grande più di tutti noi”ebbe a gridare nella sofferenza della croce: “Padre mio perché mi ha abbandonato”. E che vuol dire? Che l’aveva con Dio, che lo lasciava morire invece di salvarlo? Che non voleva morire dopo che era venuto sulla terra e programmata la sua vita ed in particolari la sua morte? Ed ancora ai suoi carnefici: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno” E che vuol dire? Che la morte che stavano per dargli era tanto grave da non riconoscersi il diritto del perdono e invitava il Padre a farlo. Non c’è perdono umano per chi si arroga il diritto di togliere la via di un uomo per nessun motivo. Ed io non smetterò di scrivere provocazioni su provocazioni che hanno un unico obiettivo: Che l’Uomo rifletta!
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!8 aprile 2007, di michelangelo
Un granello di sabbia di “K” ai lettori di la voce di Fiore “Chi sa di essere fratello dal fondo dell’anima, costui sentirà il soffio del buon vento ciò che altri non potranno. Allora si leverà e, andando, potrà ben vedere come si scala una montagna coi denti. Dopo, potrà dirne al mondo ogni meraviglia e sarà ascoltato”.
Buona Pasqua da Michelangelo
-
-
-
A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY : SONDAGGI TRUCCATI !23 gennaio 2007, di Biasi
I sondaggi "truccati" del Corriere
Sondaggi sul Corriere online “truccati”? Sembrerebbe proprio di sì a giudicare da questa esperienza. Alla fine di dicembre ho seguito con attenzione il sondaggio proposto che riguardava l’uomo dell’anno, dove Benedetto XVI era saldamente in testa. Senonché all’improvviso si nota una clamorosa rimonta di Piergiorgio Welby, piuttosto sospetta. Decido così di monitorare attentamente il sondaggio, e cosa accade? Tra la sera del 31 dicembre e la mattina del 1 gennaio, nell’unica notte in cui si può essere sicuri che la gente pensi ad altro, le preferenze per Welby raddoppiano, da 30mila a 60mila. Impossibile. A meno che.... A meno che si usino dei trucchetti: il primo possibile, e più semplice, è quello di eliminare i “cookies” dal proprio browser ogni volta che si vota. In questo modo si può votare tutte le volte che si vuole. Ma oggi molti sistemi si difendono da questo trucco e riconoscono l’indirizzo IP del computer; ecco perciò che ci sono in circolazione dei programmi in grado di moltiplicare gli indirizzi IP da cui far partire i voti. Un sistema più complesso, ma per chi è esperto è un giochetto da ragazzi, ed è anche più veloce.
Il sondaggio del Corriere è dunque stato evidentemente falsato da chi voleva intenzionalmente screditare il Papa, usando allo stesso tempo in modo strumentale la figura del defunto Welby per creare un consenso pubblico attorno all’eutanasia.
Scritto da: Bruno Mardegan il 9-1-2007 su il timone.org
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA".22 gennaio 2007, di Federico La Sala
Per il cardinale Martini la Chiesa doveva ascoltare Welby
di Anna Tarquini *
«Bisogna rispettare la volontà dei malati. E a situazioni come quelle di Welby la Chiesa dovrà dare più attenta considerazione anche pastorale». Per il cardinale Martini la Chiesa ha sbagliato. Doveva ascoltare Welby, e non negargli il funerale. Alla vigilia degli ottant’anni, malato di Parkinson, l’ex cardinale di Milano in un coraggiosissimo articolo pubblicato ieri dal Sole 24 ore, domanda nuove leggi chiare per consentire al malato di scegliere come morire e al medico di limitare la terapia. E cita il catechismo che sul tema è chiaro: non vuole accanimento terapeutico. Dice Martini: «Situazioni come quelle di Piergiorgio Welby saranno sempre più frequenti... La crescente capacità terapeutica della medicina che consente di protrarre la vita... richiede un supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona».
E ancora: «Bisogna distinguere tra eutanasia e accanimento considerando la prima un gesto per abbreviare la vita e il secondo la rinuncia all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate». Dice Martini che c’è «l’esigenza di elaborare una normativa», «che non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete, anche dal punto di vista giuridico,salvo eccezioni ben definite, di valutare se le cure che gli vengono proposte, in tali casi di eccezionale gravità, sono effettivamente proporzionate», che «bisogna anche proteggere il medico da eventuali accuse senza che questo implichi la legalizzazione dell’eutanasia».
Per molti sono parole che sbrogliano una matassa. Così Bersani: «Vorrei che l’Italia si fermasse un attimo e leggesse le sue parole». Le ha lette Ignazio Marino, presidente della commissione sanità in Senato (intervista a fianco). Ma non tutti sono pronti a leggere quelle parole. Come la senatrice Binetti ad esempio, che dell’intervento di Martini, ha preferito dare spazio ad alcune parole oscurandone altre. Così per lei diventa «chiara la condanna dell’eutanasia e non c’è nessun riferimento al testamento biologico, mentre chiede di garantire a tutti la buona sanità». O Castagnetti che parla di «un intervento che apre una riflessione, non all’eutanasia».
L’intervento di Martini arriva a un mese dalla morte di Welby, ma anche a pochi giorni da altri due casi che in Europa hanno fatto scandalo. Parliamo della richiesta di eutanasia fatta dalla ex moglie del regista Ingmar Bergman (eutanasia negata in un Paese, la Svezia, dove in alcuni casi è consentita dalla legge) e di quella invece accettata e portata a termine da Madeleine, la musa di Jaques Brel, che in Spagna ha ottenuto di morire prima che la sclerosi la immobilizzasse in un letto. Sono due casi che ricordiamo perché proprio ieri, in contemporanea, mentre sul Sole 24 ore il cardinale Martini apriva alla volontà del malato di scegliere o rifiutare la cura, il quotidiano dei vescovi, l’Avvenire, metteva sotto accusa gli episodi tacciandoli di spettacolarizzazione. «Come inscenare un finto plebiscito» era il titolo dell’editoriale. «Da Welby a Madeleine la modernizzazione soffia simmetrica e come coordinata. Mediaticamente trascinati, attraverso i buoni sentimenti e la pietà e anche gli equivoci, verso quella dittatura della maggioranza che Toqueville definiva la tendenza a non pensare più».
* l’Unità, Pubblicato il: 22.01.07, Modificato il: 22.01.07 alle ore 14.00
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!31 dicembre 2006, di Federico La Sala
La profezia di Welby
di Enzo Mazzi *
La critica verso il rifiuto opposto a Welby dalle gerarchie ecclesiastiche fino a negargli i funerali religiosi sta montando anche nella Chiesa cattolica, anzi direi proprio in questa. È stato sfigurato di fronte al mondo il volto della «sposa di Cristo», madre accogliente. E Dio stesso ha subito una penosa violenza direi quasi blasfema. È stato ingabbiato dall’intransigenza del Vicariato di Roma in una immagine quanto meno dimezzata e quindi falsata, come il Dio dell’onnipotenza, unico padrone della vita e della morte, giudice inflessibile banditore di una legge impietosa ed escludente. Mentre è stato oscurato il Dio che nasce in una stalla, soffre e muore nella maledizione, espulso dalla città, con le braccia aperte quasi in un abbraccio universale di tutti i maledetti. Hanno ragione Padellaro e Colombo a chiamare in causa l’assenza di Cristo, del Cristo della croce, se ho ben capito il senso profondo dei loro editoriali del 27 dicembre.
La vicenda di Welby è profetica: dice l’impotenza delle cattedre religiose di fronte ai drammi delle persone in carne ed ossa. Ma parla anche a tutti noi, incapaci finora di costruire una convivenza sociale accogliente verso il dramma di Piergiorgio, che è il dramma condiviso da molti nelle stesse sue condizioni. Dice che è distorto il nostro rapporto con la natura, con la vita e con Dio stesso. La profezia di Welby ha fatto affiorare una questione fondamentale anche per la nostra epoca, sepolta nel profondo, annegata nelle parti oscure della nostra coscienza. Un po’ come è accaduto duemila anni fa con la profezia di Gesù, quando morente emette il grido pieno di angoscia e di mistero, soffocato dagli spasmi della crocifissione: «Dio mio perché mi hai abbandonato». Quel grido è risuonato nella storia facendo ogni volta riemergere il bisogno e la ricerca di un Dio «diverso» da tutte le codificazioni dogmatiche isterilite e divenute inutili anzi dannose, violente e distruttive. Forse la riflessione su un Dio «altro» va rivolta anche alla ricerca di un concetto «altro» di natura. Abbiamo bisogno di guardare la natura con occhi nuovi. Ci può esser di aiuto avvicinare l’esperienza di Pierre Teilard de Chardin, gesuita, teologo con propensione al misticismo, grande scienziato, geologo e paleontologo. Gli fu proibito dall’autorità ecclesiastica di pubblicare gli scritti teologici e dopo la morte furono condannate le opere pubblicate postume. La sua intuizione di fondo sembra essere il «muoversi verso», cioè la trasformazione finalizzata. Attraverso la sua indagine di rigore scientifico sulla evoluzione biologica giunge alla convinzione che la Biosfera tende alla coscienza, cioè si evolve verso la Noosfera, parola difficile che significa in sostanza «mondo della coscienza». Ma ciò avviene non perché già all’inizio c’è un ordine precostituito. La natura non è data una volta per tutte. L’evoluzione non segue una linea ben individuabile, si muove anche a tentoni, a strappi e a impennate inspiegabili. L’ordine è nel futuro, non nel passato: va costruito. L’Universo si dipana nella libertà e nell’autonomia nutrite di relazioni. E sono precisamente questi valori di trasformazione che costituiscono il compito umano di «costruire la Terra - costruire la natura». Dio è lì, nella trasformazione, non nella fissità. Nello stesso periodo, anni 50, sosteneva cose simili Ernst Block, marxista antidogmatico ed eretico, autore del Principio-speranza: «Il nerbo del retto concetto della storia è e rimane il novum. Quando si è sperimentata una volta la realtà come storia non è più possibile il ritorno alla fede astorica di ciò che sussiste e rimane in eterno».
E siamo al dunque finale. Oltre a guarire la percezione della natura, abbiamo bisogno contestualmente di guarire anche la nostra malata percezione del rapporto fra vita e morte. Noi percepiamo la morte come separata dalla vita, anzi contrapposta alla vita. In particolare il cristianesimo ci ha abituati fin da piccoli a considerare la morte come punizione per il peccato: «a causa di un solo uomo (Adamo) il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte e la morte si è estesa a tutti perché tutti hanno peccato» (Lettera di Paolo ai Romani). La Chiesa indefettibile assicura la vittoria definitiva sul nemico assoluto che sarebbe la morte, dando la vita eterna a chi si affida al suo abbraccio. Con la secolarizzazione, la funzione di esorcizzare la morte è assolta da altre grandi costruzioni sociali fra cui non ultima una certa concezione assolutista della scienza medica. E non è forse una tale assolutizzazione della vita e una tale separazione fra vita e morte che rende tanto aggressivo l’«ordine» mondiale in cui viviamo? Mentre portiamo avanti ogni giorno l’impegno politico e sociale per la giustizia e la pace, contro la violenza e la guerra, al tempo stesso il nostro pacifismo ci deve portare oltre la dimensione socio-politica della lotta. E questo vale anche per l’impegno intraecclesiale che non può limitarsi a rincorrere con la critica scelte inopportune o errate delle gerarchie. Bisogna andare finalmente alle radici. Welby ci sia di esempio: ha fatto una scelta di grande valore simbolico e profetico, ha desacralizzato un concetto ossificato e ormai inadeguato di natura, del vivere e del morire, e ha riaperto la ricerca sul senso della esistenza, sulla natura e su Dio.
* l’Unità, Pubblicato il: 31.12.06, Modificato il: 31.12.06 alle ore 9.49
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!30 maggio 2007, di michelangelo
Molte, moltissime sono le riflessioni che ci accomunano, certamente il dialogo, se ci sarà e lo spero, ci farà condividere molti granelli di sabbia. La profezia di Welby è il raggio di sole di Quasimodo: un messaggio ri-velato di speranza. Invio mie riflessioni su Piergiorgio Welby e su "...è subito mattino." ************************************** Ognuno sta solo sul cuor della terra Trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera. Il Poeta affida un messaggio di verità al tempo affinché lo perpetui nel mondo. Egli è l’Iniziato che offre all’umanità un granello di sabbia - “un raggio di sole - del deserto della verità. Ma la verità se svelata - “ad ognuno che sta solo sul cuor della terra” - verrebbe fraintesa, manipolata, snaturata -“ed è subito sera”-. Allora il messaggio viaggia celato sulle ali del tempo fino a quando un Maestro in una delle infinite stazioni lo ferma lo Svela e ri-Velandolo lo restituisce al tempo. I contenitori sono tanti e di diversa natura ma tutti esoterici. E la verità viene sintetizzata, criptata, contrapposta e rovesciata, ridotta ad un segno, una figura, una frase, una parola, un “quadrato magico” un numero, un simbolo. Quasimodo ha scelto lo specchio, l’immagine speculare, l’opposto di quel che appare, il divenire di quel che era, quello che è e quel che sarà, il serpente che si morde la coda, l’uroborus. Il messaggio di verità e di speranza - Trafitto da un raggio di sole - protetto, e sigillato tra l’immagine della solitudine e quella della terra, svelato si leggerà come “ la quiete dopo la tempesta” o “mi illumino d’immenso”, ed io direi:
Nessuno sta solo sul cuor della terra Illuminati da un raggio di sole: ed è subito mattino. ********************************* Un granello si sabbia in memoria di Piergiorgio Welby
E se la sabbia del deserto fosse la verità? La coscienza vigile, attenta, pensante, decisionale, serena o turbata, sana o malata, lucida o offuscata, razionale o irrazionale, libera o condizionata, quanta parte occuperebbe nel deserto della mente? Io dico: lo spazio di un granello di sabbia per l’uomo comune e per il genio, il poeta, l’artista, lo scienziato, il santo tanta sabbia quanta ne può essere contenuta in un pugno. Ed ecco come una parte della verità sta in tutte le ragioni così come la ragione contiene sempre una parte della verità, sia del laico che del religioso. Ma quanta? Prendi un pugno sabbia dal deserto: questa è la porzione di verità che ti offre la tua mente cosciente. Il “farsi suicidare” da una condizione alterata della mente cosciente non sarà mai la decisione di un libero arbitrio padrone assoluto del Regno della Mente, laddove l’Individualità dell’Io più profondo, si ricongiunge con la matrice che l’ha emanato e ad essa identificandosi ne acquisisce, in potenza, attributi e divinità. E la vita terrena di Piergiorgio programmata per sua libera scelta nella notte dei tempi ed intensamente vissuta in un attimo della sua eternità, anche se interrotta per le ragioni di un pugno di sabbia, nulla toglie ma molto aggiunge alla sua ricchezza spirituale d al suo cammino evolutivo nel ritorno al Padre attraverso quella scala di valori di cui tanta ne ha percorsa nella sua breve vita di quanto l’umanità nella maggioranza ne percorre in un secolo. E questo è l’autentico patrimonio di Piergiorgio. Per il resto: delitto o non delitto, che l’ UOMO rifletta!
**********************************************
Un altro granello di sabbia per Piergiorgio Welby
Caro Piergiorgio, anche io ho provato commozione per la tua sensibilità e per l’amore che hai nutrito per la vita e per tutti. Generalmente chi nutre tanto amore per gli altri ne ha un po’ meno per se stesso. Rispetto la tua volontà anche se rimango della convinzione che il tuo “Spirito” - la mente profonda - è rimasto ad osservare senza intervenire, con la “Sua autorità”, alla premeditata decisione. Certo non te ne sei andato in silenzio. A meno che, e ora ne sono convinto, l’abbia fatto di proposito per attirare l’attenzione del mondo scientifico, perchè all’uomo non serve l’accanimento ma la scoperta del farmaco, la prevenzione e la guarigione. Una provocazione? No! Una accusa precisa al “progresso”.
Si spacca l’atomo, si va sulla luna, si configurano e si organizzano miliardi e miliardi di informazioni in un piccolo monitor , che tutto lo scibile umano si chiami internet, si investono miliardi e miliardi per il benessere, per lo sport, la tecnologia.......e non si dirotta la maggior parte di tutte queste risorse per debellare la fame, le guerre e le malattie. Mille, centomila scienziati dovrebbero essere rinchiusi in un bunker per uscire solo quando avrebbero risolto i problemi che affliggono l’uomo. E che nessuno mi dica che è impossibile. Niente è impossibile all’uomo, se lo vuole. E’ per questo che Cristo andò sulla croce, che il martire si fa Santo, che tu riscatti tutti i Piergiorgio che giacciono non in attesa che la legge li uccida, ma che l’UOMO LI GUARISCA.
************************************
Una bara bianca per Piergiorgio.
A Loredana che mi ha inviato la canzone di Simone Cristicchi. Grazie del commento e del testo della canzone. Rispetto la tua riflessione su welby ed è molto poetica la canzone. Ma l’autore è sano e pieno di vita e... di successo, mentre Piergiorgio era solo tra tante ombre oscure, immerso e perduto nei suoi pensieri. Anche lui ha scritto dei bellissimi versi poetici, toccanti e pieni di amore per la vita e per il mondo intero. E quando Piergiorgio scriveva era pieno di vitalità, di voglia di vivere, e anche con la sua sofferenza "correva" incontro alla vita. Ne sono convinto. Uno Spirito elevato che sa di poter dare tanto, non decide di negare agli altri e a se stesso le perle della sua stessa saggezza. Tutto quanto, invece, girava attorno a lui, amici, familiari, medici, politici era un elogio alla morte, un’attesa, un atmosfera lugubre e pregna di energia negativa. Nessuna esortazione alla vita, ma uno squallido movimento mediatico e politico. La camera della morte allestita da tempo. E il Gesto non s’è fatto attendere. Un boia laureato per l’occasione e pochi intimi corvi neri furono le ultime immagini che i begl’occhi di Piergiorgio furono costretti a vedere mentre gli porgevano la cicuta. Nessuno dei presenti avrà pianto. Le lacrime sono venute da chi non l’ha conosciuto.
******************************************
Io ho pianto.
Ho pianto mentre scrivevo quest’ultima provocazione, perché sono emotivo e perché so di non essere compreso, questo poi credo che sia un mio karma. Io non sarei mai capace di pensare di dire: ti amo, ti amo da morire ma ti tolgo la vita per il tuo bene, per non farti soffrire e perché tu me lo chiedi. Qualcuno “grande più di tutti noi”ebbe a gridare nella sofferenza della croce: “Padre mio perché mi ha abbandonato”. E che vuol dire? Che l’aveva con Dio, che lo lasciava morire invece di salvarlo? Che non voleva morire dopo che era venuto sulla terra e programmata la sua vita ed in particolari la sua morte? Ed ancora ai suoi carnefici: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno” E che vuol dire? Che la morte che stavano per dargli era tanto grave da non riconoscersi il diritto del perdono e invitava il Padre a farlo. Non c’è perdono umano per chi si arroga il diritto di togliere la via di un uomo per nessun motivo. Ed io non smetterò di scrivere provocazioni su provocazioni che hanno un unico obiettivo: Che l’Uomo rifletta!
Grazie per l’attenzione Michelangelo
http://michelangelok.spaces.live.com
-
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!30 dicembre 2006, di Federico La Sala
QUEL PRETE DISOBBEDIENTE NEL NOME DI WELBY
di Augusto Cavadi
Ringraziamo l’amico Augusto Cavadi per averci inviato questo suo articolo pubblicato sul quotidiano "Repubblica - Palermo" del 28.12.06 *
Il mio Natale, come quello di numerosi cittadini non solo ‘laici’ (com’è prevedibile) ma anche credenti, è stato turbato dalla notizia che il Vicariato di Roma avesse deciso di negare a Piergiorgio Welby i funerali religiosi. Sapere che questa amarezza fosse espressa un po’ in tutta Italia da giornalisti cattolici come Ettore Masina (che, in una lettera-circolare pervenuta anche nella mia casella, si chiedeva: “I commi dei giuristi prevalgono sull’insegnamento del Cristo? Dice la Lettera di San Giacomo nel Nuovo Testamento: ‘religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro padre è soccorrere gli orfani e le vedove nel momento delle loro afflizioni...’. Parola di Dio, ma non a Roma”), anzi persino da un vescovo non proprio progressista come Sandro Maggiolini (“Ho letto che negli ultimi 20 minuti Giorgio, che era cattolico e tale si professava, ha chiesto perdono a Dio. Anche soltanto il dubbio di questo dovrebbe indurre a dare esequie cattoliche! ”), mi era di qualche conforto. Ma Masina scriveva da Roma, Maggiolini da Como: e dalle nostre parti?
Con questi interrogativi ho partecipato alla celebrazione eucaristica natalizia di don Cosimo Scordato, docente di ecclesiologia sistematica alla Facoltà teologica di Palermo e rettore della chiesa di S. Francesco Saverio all’Albergheria. Egli ha esordito invitando i fedeli a chiedere perdono per i propri peccati, ma - ha aggiunto - anche per quelli di tutti i cristiani. E, per evitare equivoci, ha specificato: “Non so cosa ne pensiate voi, ma sento il dovere di dirvi che non ho condiviso la decisione dei responsabili della diocesi romana di negare i funerali in parrocchia a Piergiorgio Welby. Mi è sembrato che un tale gesto abbia ferito profondamente la memoria di un uomo che ha lottato coraggiosamente contro il dolore, la fedeltà eroica della moglie che gli è stata accanto così affettuosamente ed anche la sensibilità religiosa della madre ultraottantenne. Se la cerimonia liturgica fosse stata chiesta a me - ha concluso don Cosimo dal pulpito - avre! i, con dispiacere ma senza esitazione, disatteso il divieto dei superiori. Le norme della chiesa, come di ogni organizzazione istituzionale, sono importanti: ma nessuna di esse può contraddire il dettato evangelico della fraternità e della solidarietà. Anche per noi preti - come per qualsiasi altro - vale l’obbligo di seguire prima di tutto la coscienza e solo subordinatamente le disposizioni disciplinari”.
Da quel momento confesso di non aver seguito attentamente il resto della messa perché la mente ha iniziato, un po’ capricciosamente, a girovagare. E’ andata indietro agli “Atti degli apostoli” (quel libro della Bibbia dove si dice che “bisogna obbedire prima a Dio, poi agli uomini”); è passata per il medioevo (quando un grande santo come Tommaso d’Aquino, nonostante il divieto ecclesiastico, persevera nel farsi tradurre e nel leggere Aristotele producendo capolavori teologici memorabili) sino ad arrivare a don Lorenzo Milani (e al suo slogan a favore dell’obiezione di coscienza militare: “L’obbedienza non è più una virtù”). Ha rivisto le tragedie provocate durante il nazismo da una mentalità acriticamente legalistica che porta a farsi complici dei più efferati delitti di Stato sino a tanti episodi quotidiani in cui, nelle strutture civili come in quelle ecclesiastiche, debolezza di carattere e voglia di carriera inducono a subire umiliazioni,! ingiustizie, molestie. E’ difficile che qualcuno denunzi casi di vero e proprio mobbing in ufficio, in banca, all’università, in ospedale: quando poi non si tratta neppure di danni subiti personalmente, ma perpetrati sulla pelle degli altri, scatta una ferrea cortina di omertà. Non è un caso che, a proposito proprio di questo episodio di interruzione della spina, l’opinione prevalente fosse che su certe questioni bisogna arrangiarsi da sé senza fare troppa pubblicità.
E così, vagando qui e là, tra storia e cronaca, la mente birichina si è fermata solo davanti ad una domanda un po’ bizzarra suggeritami dalla predica del prete di Ballarò: non è che in questo momento Welby è accolto in cielo con banda e striscioni, quale testimone sempre più raro dell’invito di Gesù Cristo a che il nostro parlare sia “sì, sì, no, no”, dal momento che tutto il resto è chiacchiera maligna?
Augusto Cavadi
Il DIALOGO, Venerdì, 29 dicembre 2006
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!5 maggio 2007, di Federico La Sala
INTERVISTA Ha ragione il Papa: solo eros e agape rendono possibile la conoscenza, anzi fanno dell’altro una persona. Parla il filosofo Marion
Senza amore non si pensa
«Da Galileo in poi, gli affetti appaiono secondari in filosofia rispetto alla ragione. Invece non sono soltanto passioni dell’animo, bensì costituenti originari dell’ego»
Da Parigi Daniele Zappalà (Avvenire, 05.05.2007)
«
L’amore è molto più che una passione o un affetto. In un certo senso, è molto più di una conoscenza. È ciò che rende possibile la stessa conoscenza». Lo sostiene è il filosofo francese Jean-Luc Marion, successore di Emmanuel Lévinas alla Sorbona e di Paul Ricoeur all’Università di Chicago. Il Fenomeno Erotico, appena tradotto in Italia per Cantagalli (pp. 288, euro 18,50), ha già suscitato forti reazioni in Francia.
Professore, lei denuncia l’indifferenza della filosofia moderna verso l’amore. Come la spiega?
«Dall’epoca di Galileo in poi, gli affetti appaiono secondari in filosofia rispetto al pensiero teoretico, la cui analisi si basa sulla conoscenza e la rappresentazione. Soprattutto, si comincia a parlare di odio, amore e dei diversi affetti solo sulla base di un ego già costituito. L’amore, in altri termini, è visto come una passione dell’animo e non come un costituente originario dell’ego. Ciò che cerco di mostrare, invece, è che l’amore e l’odio precedono lo stesso ego e giungono in vista della sua costituzione».
Può farci qualche esempio?
«L’ego si esprime, per così dire, sotto forma di figure o stadi amorosi. Innanzitutto, la situazione di voler essere amati. Poi, voler amare a condizione di essere amati. In seguito, prendere la decisione di amare senza essere amati».
Il pensiero contemporaneo è attraversato dal tema dell’angoscia verso la complessità delle relazioni sociali. Esistono oggi maggiori ostacoli al desiderio di amare?
«Questa cosiddetta angoscia, soprattutto rispetto alle relazioni sociali, diventa comprensibile a mio avviso come una manifestazione dell’amore. L’angoscia non esisterebbe se il nostro rapporto col mondo fosse esclusivamente d’interesse, di conoscenza e di rappresentazione. Questo rapporto col mondo è in realtà fin dall’inizio permeato dall’amore, erotizzato in senso lato. Ciò è vero, del resto, anche per la stessa attività filosofica. Fin dall’origine, la filosofia è amor e della saggezza e non saggezza. Prima della conoscenza, esiste l’amore della conoscenza».
Comunemente, l’amore è immaginato come una pura emozione slegata da solidi appigli razionali. Che ne pensa?
«In un certo senso, l’amore è una forma di conoscenza. È solo amandola o odiandola che posso avere davvero accesso a una persona. La pura emozione, il puro piacere, il puro odio diventano significativi all’interno di questo processo di accesso all’altro o a se stessi. A mio avviso, è decisivo comprendere che esiste sempre un itinerario fra due soggetti, un itinerario che obbedisce a una propria logica».
Una logica che include il dono...
«Questo legame fra amore e dono appare in una situazione: quando l’individuo comprende chiaramente che è impossibile amare solo a condizione che l’altro ami. Una forma, o se vogliamo uno stadio, molto comune di amore consiste nell’esser pronti ad amare a condizione che l’altro ci ami. Ma questa reciprocità in realtà rende impossibile l’amore, riducendolo come a una forma di contratto. Un contratto, soprattutto, che non può essere rispettato. Se per amare attendo che l’altro mi ami, dovrò attendere molto a lungo e, in ogni caso, amerò molto poco. Per amare, occorre in realtà far sempre il primo passo. Se l’amore è visto come uno scambio e non come un dono, esso non supererà mai un certo stadio di maturazione e rischierà sempre di precipitare».
Amare significa anche veder emergere l’altro come persona?
«Direi che l’altro diventa persona all’interno di un processo d’amore. Nella vita di tutti i giorni, in genere non incontriamo gli altri in qualità di persone, ma in una funzione sociale che altri potrebbero ricoprire al loro posto. Siamo una persona se amiamo o siamo amati. In caso contrario, rischiamo di restare esseri umani in un senso più spersonalizzato». Internet e le comunicazioni a distanza creano talora l’impressione di forme di passione interpersonale, di «amore», senza mediazione del volto. Ciò è davvero possibile? «Solo il linguaggio, compreso quello del volto, può creare una situazione di amore. Una relazione sessuale senza la parola non è erotica. Mentre una relazione non sessuale con la parola può spesso divenire erotica in senso lato. Anche il volto parla, è essenzialmente una parola o un principio di parola».
In che senso l’amore umano può divenire trascendente?
«L’amore fra esseri umani è trascendente perché trascende l’individualità di chi ama in direzione di chi è amato. Da un punto di vista cristiano, i comandamenti dell’amore verso Dio e verso il prossimo corrispondono a un unico imperativo. Per questo, le regole dell’amore di Dio e dell’amore dell’altro possono essere confrontate».
Che impressione le ha lasciato la prima enciclica di Papa Benedetto XVI dedicata all’amore?
«Trovo molto positivo che l’insegnamento del Magistero si concentri sul centro della rivelazione cristiana. È strano, in proposito, che quest’enciclica sia apparsa a qualcuno come un’originalità. Trovo che la distinzione fra eros e agape sia molto utile, soprattutto per ritrovare l’origine comune e l’unità dell’amore. Tale distinzione non dovrebbe invece mai lasciar pensare che esistono due tipi di amore e credo si tratti di uno dei punti più forti dell’enciclica. Trovo perfettamente giusto e come un’innovazione il fatto di ricordare questa verità della filosofia e, credo, anche della teologia spirituale. L’amore ha una propria razionalità, unica ed universale. Una razionalità che non esige la ricerca della reciprocità».
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!29 maggio 2007, di Federico La Sala
RIFLESSIONE
Nel libro «Gesù di Nazaret» di Benedetto XVI la proposta di una rinnovata amicizia fra ebrei e cristiani in nome dell’unico Dio
L’unica alleanza
Il dialogo a distanza con il rabbino americano Jacob Neusner, che si pone sinceramente la domanda sulla divinità di Cristo
di Elio Guerriero (Avvenire, 29.05.2007)
Le molte religioni e l’unica alleanza, l’uomo alla ricerca del sacro e la rivelazione di Dio, le vie molteplici delle religioni e Dio che si rivela al Sinai, anzi scende dal cielo per porre la sua tenda tra gli uomini. Sto parlando dell’introduzione a Gesù di Nazaret di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI che la critica ha finora passato sotto silenzio. In essa il Papa accenna alla via delle religioni che in Mesopotamia, in Egitto o nel mondo indoeuropeo hanno aiutato l’uomo a scoprire la sua dignità, sono state all’origine della formazione della società, della costruzione della polis.
All’apice di questo percorso, Dio si manifesta ad Abramo. Cominciava, allora, il tempo della Rivelazione. Come scrive Julien Ries: «Alla lunga ricerca dell’uomo, Dio risponde con la sua manifestazione». Da questo momento, ha inizio il cammino della promessa che, come la stella dei Magi, sostiene il viaggio delle generazioni: «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te... un profeta pari a me, a lui darete ascolto» (18,5). Il Nuovo Testamento, di conseguenza, si apre con l’annuncio che l’antica promessa si è avverata, che sul Nuovo Sinai, la Montagna delle beatitudini, siede ora il nuovo Mosè, che insegna non come un rabbi che arriva all’incarico dopo lunga preparazione, ma come l’inviato di Dio. Più di Mosè che vide Dio solo di spalle, egli può parlare del Padre, perché « Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio Unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1,18).
Questo permette al Papa di affermare che non solo vi è concordia tra Antico e Nuovo Testamento, ma che l’alleanza stretta al Sinai e quella proclamata da Gesù sul monte delle beatitudini è unica. Gesù è venuto per portare a compimento, a pienezza l’alleanza. Così hanno insegnato quei personaggi umili e grandi (il Magnificat) che hanno adempiuto la Legge e segnato il passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento. Il Papa pensa anzitutto alla Vergine Maria, ma poi anche a Giuseppe, Zaccaria ed Elisabetta, a Simeone ed Anna e agli apostoli tutti. Pii israeliti, essi non smisero di osservare la Legge e conservarono il cuore puro, che li predispose alla chiamata di Colui che è più grande. Per questo sono immagine tipo di tutti i discepoli di Gesù.
Si inserisce a questo punto il dialogo, che ha suscitato scalpore, tra il Papa e il rabbino ortodosso americano Jacob Neusner. Autore di un volume dal titolo Disputa immaginaria tra un rabbino e Gesù, Neusner pone due importanti quesiti nella sua opera. Egli immagina di essere contemporaneo di Gesù e di recarsi, piacevolmente sorpreso dalla fama che precede il giovane Rabbi della Galilea, a sentire il discorso della Montagna. Non trova, tuttavia, alcunché di nuovo nella Torah di Gesù. Tutto gli era già noto dall’Antico Testamento e dalle tradizioni rabbiniche fissate nella Mishnah e nel Talmud. E’ inevitabile, allora, la domanda: perché è venuto Gesù, quale è il senso della sua Torah rispetto a quella di Mosè? Risponde il Papa: «Israele non esiste semplicemente per se stesso, per vivere nelle "eterne" disposizioni della Legge, esiste per diventare la luce dei popoli». Con il passare dei secoli era divenuto sempre più evidente che il Dio di Israele era Dio di tutti i popoli e di tutti gli uomini. Gesù è venuto per annunciare l’eudochìa di Dio, il suo beneplacito verso gli uomini tutti. Del resto una delle immagini più care alla tradizione cristiana è quella dei Magi, venuti a Gerusalemme per adorare il re dei Giudei (Mt 2,2). «Alla luce messianica della stella di Davide, cercano in Israele colui che sarà il re delle nazioni» (Catechismo della Chiesa Cattolica n. 528) Ricordato nell’epifania, una delle grandi feste cristiane, l’episodio manifesta il senso della venuta di Gesù: la realizzazione della promessa fatta ad Abramo per la quale la grande massa delle genti entra nella famiglia dei patriarchi e ottiene la dignità israelitica.
L’altra domanda sollevata da Neusner riguarda la divinità di Gesù. Egli legge con interesse l’episodio del giovane ricco e come il Maestro di Nazaret guarda a lui con simpatia. Ma perché il Maestro non si accontenta del suo rispetto della Legge, perché gli chiede di vendere tutto e seguirlo? Non si pone, così, allo stesso livello di Dio? San Giovanni e il Concilio di Nicea che hanno proclamato la divinità di Gesù non si sono sbagliati. Gesù chiede veramente di essere riconosciuto come Dio. Per questo il rabbino americano si allontana, mentre: «Con tanta cortesia e gentilezza, egli mi saluta con un cenno del capo e va via, per la sua strada. Senza "se" o "ma"...; proprio da amici». Al distacco, tuttavia, segue un ultimo gesto di comunione, che è particolarmente significativo per il rapporto fra ebrei e cristiani: alla sera nella sinagoga: «Noi offriamo la nostra preghiera serale al Dio vivente. E in alcuni villaggi lungo la valle, così fecero Gesù e i suoi discepoli e tutto l’eterno Israele».
La pubblicazione di Gesù di Nazaret di Benedetto XVI è stata affidata a un editore laico, forse un segnale rivolto agli uomini di cultura perché si rendano conto della portata del dialogo ebreo-cristiano. L’invito, tuttavia, è rivolto soprattutto agli ebrei. Come dicono il Papa e Neusner qui non si tratta affatto di un dibattito per stabilire la superiorità di una religione sull’altra ma di ritrovarsi nella discendenza di Abramo e di Mosè, per coltivare l’amicizia e la fraternità nel riconoscimento dell’unico Dio.
-
> A MEMORIA ETERNA DI PIERGIORGIO WELBY E DELLA SUA LEZIONE DI SOVRANITA’ UMANA , CIVILE, E "CRISTIANA". MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON LA "MASCHERA" DEL "DIO" DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA !!!30 giugno 2007, di Federico La Sala
Benedetto XVI agli ortodossi: insieme verso la piena unità
«Nella professione di Pietro possiamo sentirci ed essere una cosa sola Il nostro dialogo esprime la volontà di realizzare la preghiera di Cristo “ut unum sint”»
Da Roma Salvatore Mazza (Avvenire, 30.06.2007)
È nella professione di Pietro che, come cristiani, «possiamo sentirci ed essere tutti una cosa sola». Ciò «malgrado le divisioni che nel corso dei secoli hanno lacerato l’unità della Chiesa, con conseguenze che perdurano tuttora». Come già giovedì sera, nella Messa celebrata nella basilica di San Paolo fuori la Mura per lanciare l’Anno Paolino, a duemila anni dalla nascita dell’Apostolo delle genti, Benedetto XVI ha messo ieri l’accento, nella celebrazione per la solennità dei Santi Pietro e Paolo, sulla ricerca della «piena comunione», sempre presente, ha detto, nella volontà del Patriarca ecumenico di Costantinopoli e del Vescovo di Roma.
Parole tanto più solenni, quelle di Papa Ratzinger, in quanto pronunciate di fronte ai rappresentati del Patriarcato, giunti a Roma nel quadro dell’ormai consolidata tradizione dello scambio di delegazioni ufficiali tra Roma e Costantinopoli in occasione delle rispettive festività principali, il 29 giugno, appunto, e il 30 novembre, festa di Sant’Andrea.
Dopo l’omelia, con quale Benedetto XVI ha proposto una riflessione sul significato della confessione di Pietro - «momento decisivo del cammino dei discepoli con Gesù» - s’è svolta la cerimonia dell’imposizione del Pallio a quarantasei arcivescovi metropoliti di tutto il mondo, espressione dell’universalità della Chiesa. Tra loro gli italiani Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza episcopale italiana, Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, e Calogero La Piana, arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. La celebrazione s’è quindi conclusa con la preghiera del Papa al sepolcro di San Pietro, accompagnato dal canto dell’assemblea Tu es Petrus.
Sul tema ecumenico Benedetto XVI è poi tornato al momento dell’Angelus, ricordando l’indizione dell’Anno giubilare dedicato a san Paolo - dal 2008 al 2009 - e auspicando che tale evento possa «rinnovare il nostro entusiasmo missionario», rendendo più intense le relazioni con i fratelli dell’Oriente. Soprattutto ha però rinnovato l’impegno ad agire per «la causa dell’unità di tutti i discepoli di Cristo», per la piena comunione tra l’Oriente e l’Occidente cristiani: «I nostri incontri, le visite reciproche, i dialoghi in corso non sono dunque dei semplici gesti di cortesia, o tentativi per giungere a compromessi - ha spiegato - ma il segno di una comune volontà di fare il possibile perché quanto prima possiamo giungere a quella piena comunione implorata da Cristo nella sua preghiera al Padre dopo l’Ultima Cena: Ut unum sint».
Obiettivo ribadito ancora poco più tardi, ricevendo nel Palazzo Apostolico la delegazione del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, che era composta dall’arcivescovo greco ortodosso di Francia Emmanuel, dal metropolita di Sassima Gennadios e dal diacono Andreas del Fanar, coi quali s’è poi trattenuto a pranzo.
Nel suo breve discorso, Benedetto XVI ha ricordato con commozione la «calorosa accoglienza» ricevuta al Fanar, sede del Patriarcato a Istanbul, per la festa di sant’Andrea, nel corso della sua visita apostolica in Turchia lo scorso novembre, e l’«indimenticabile» incontro con il Patriarca Bartolomeo I. «L’abbraccio di pace scambiato tra di noi durante la Divina Liturgia - ha affermato - resta un sigillo e un impegno per la nostra vita di Pastori nella Chiesa, giacché siamo tutti persuasi che l’amore reciproco è condizione previa per giungere a quella piena unità nella fede e nella vita ecclesiale verso la quale siamo con fiducia incamminati». Questo, del resto, è l’obiettivo delle «nostre comuni iniziative», e cioè «a intensificare i sentimenti e i rapporti di carità fra le nostre Chiese e fra i singoli fedeli, in modo da superare quei pregiudizi e quelle incomprensioni che derivano da secoli di separazione per affrontare, nella verità ma con spirito fraterno, le difficoltà che impediscono ancora di accostarci alla stessa mensa eucaristica».
Ribadito, in questo procedere verso l’unità, il ruolo «indispensabile» della preghiera, Papa Ratzinger ha poi espresso la propria gioia per il fatto «che il dialogo teologico abbia ripreso il suo corso con rinnovato spirito e vigore», in riferimento all’incontro che nel prossimo autunno vedrà la Commissione Mista alle prese con lo studio delle questioni della collegialità e dell’autorità nella Chiesa: «Noi tutti vogliamo accompagnarne i lavori con perseverante preghiera... sono particolarmente lieto di sapere che il Patriarcato ecumenico e lo stesso Patriarca Bartolomeo I seguono con analoghi sentimenti l’attività di questa Commissione».
Nel ringraziare infine la delegazione ortodossa per la visita, e rinnovata l’espressione di affetto e stima per Bartolomeo I, Benedetto XVI ha ricordato come per la ricerca della piena unità «è necessario il coinvolgimento, sotto forme differenti, dell’intero corpo delle nostre Chiese». Sottolineando, in proposito, l’importanza dei contatti personali e culturali fra i giovani studenti e la necessità di una «formazione catechetica delle nuove generazioni, perché abbiano piena coscienza della propria identità ecclesiale e dei legami di comunione esistenti con gli altri fratelli in Cristo, senza dimenticare i problemi e gli ostacoli che tuttora impediscono la piena comunione tra noi».
-
>MA GESU’ "CRISTO" CHI ERA ?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’ AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! --- Giuseppe ha infatti vissuto alla luce del mistero dell’Incarnazione... «Essere padre è servire la vita e la crescita». Il testo integrale di Benedetto XVI in Africa18 marzo 2009, di Federico La Sala
Il testo integrale del discorso *
 IL PAPA IN AFRICA
IL PAPA IN AFRICA«Essere padre è servire la vita e la crescita» *
 Cari Fratelli Cardinali e Vescovi,
Cari Fratelli Cardinali e Vescovi,
 cari Sacerdoti e Diaconi,
cari Sacerdoti e Diaconi,
 cari fratelli e sorelle consacrati,
cari fratelli e sorelle consacrati,
 cari amici membri delle altre Confessioni cristiane,
cari amici membri delle altre Confessioni cristiane,
 cari fratelli e sorelle!
cari fratelli e sorelle!Abbiamo la gioia di ritrovarci insieme per rendere grazie a Dio in questa basilica dedicata a Maria Regina degli Apostoli di Mvolyé, che è stata costruita sul luogo dove venne edificata la prima chiesa ad opera dei missionari spiritani, venuti a portare la Buona Novella in Camerun. Come l’ardore apostolico di questi uomini che racchiudevano nei loro cuori l’intero vostro Paese, questo luogo porta in se stesso simbolicamente ogni piccola parte della vostra terra. E’ perciò in una grande vicinanza spirituale con tutte le comunità cristiane nelle quali esercitate il vostro servizio, cari fratelli e sorelle, che rivolgiamo questa sera la nostra lode al Padre della luce.
Alla presenza dei rappresentanti delle altre Confessioni cristiane, a cui indirizzo il mio rispettoso e fraterno saluto, vi propongo di contemplare i tratti caratteristici di san Giuseppe attraverso le parole della Sacra Scrittura che ci offre questa liturgia vespertina.Alla folla e ai suoi discepoli, Gesù dichiara: “Uno solo è il Padre vostro” (Mt 23,9). In effetti, non vi è altra paternità che quella di Dio Padre, l’unico Creatore “del mondo visibile ed invisibile”. E’ stato dato però all’uomo, creato ad immagine di Dio, di partecipare all’unica paternità di Dio (cfr Ef 3,15). San Giuseppe manifesta ciò in maniera sorprendente, lui che è padre senza aver esercitato una paternità carnale. Non è il padre biologico di Gesù, del quale Dio solo è il Padre, e tuttavia egli esercita una paternità piena e intera. Essere padre è innanzitutto essere servitore della vita e della crescita. San Giuseppe ha dato prova, in questo senso, di una grande dedizione. Per Cristo ha conosciuto la persecuzione, l’esilio e la povertà che ne deriva. Ha dovuto stabilirsi in luogo diverso dal suo villaggio. La sua sola ricompensa fu quella di essere con Cristo. Questa disponibilità spiega le parole di san Paolo: “Servite il Signore che è Cristo!” (Col 3,24).
Si tratta di non essere un servitore mediocre, ma di essere un servitore “fedele e saggio”. L’abbinamento dei due aggettivi non è casuale: esso suggerisce che l’intelligenza senza la fedeltà e la fedeltà senza la saggezza sono qualità insufficienti. L’una sprovvista dell’altra non permette di assumere pienamente la responsabilità che Dio ci affida.
Cari fratelli sacerdoti, questa paternità voi dovete viverla nel vostro ministero quotidiano. In effetti, la Costituzione conciliare Lumen gentium sottolinea: i sacerdoti “abbiano poi cura, come padri in Cristo, dei fedeli che hanno spiritualmente generato col battesimo e l’insegnamento” (n. 28). Come allora non tornare continuamente alla radice del nostro sacerdozio, il Signore Gesù Cristo? La relazione con la sua persona è costitutiva di ciò che noi vogliamo vivere, la relazione con lui che ci chiama suoi amici, perché tutto quello che egli ha appreso dal Padre ce l’ha fatto conoscere (cfr Gv 15,15). Vivendo questa amicizia profonda con Cristo, troverete la vera libertà e la gioia del vostro cuore. Il sacerdozio ministeriale comporta un legame profondo con Cristo che ci è donato nell’Eucaristia. Che la celebrazione dell’Eucaristia sia veramente il centro della vostra vita sacerdotale, allora essa sarà anche il centro della vostra missione ecclesiale. In effetti, per tutta la nostra vita, il Cristo ci chiama a partecipare alla sua missione, a essere testimoni, affinché la sua Parola possa essere annunciata a tutti.
Celebrando questo sacramento a nome e nella persona del Signore, non è la persona del prete che deve essere posta in primo piano: egli è un servitore, un umile strumento che rimanda a Cristo, poiché Cristo stesso si offre in sacrificio per la salvezza del mondo. “Chi governa sia come colui che serve” (Lc 22,26), dice Gesù. Ed Origene scriveva: “Giuseppe capiva che Gesù gli era superiore pur essendo sottomesso a lui in tutto e, conoscendo la superiorità del suo inferiore, Giuseppe gli comandava con timore e misura. Che ciascuno rifletta su questo: spesso un uomo di minor valore è posto al di sopra di gente migliore di lui e a volte succede che l’inferiore ha più valore di colui che sembra comandargli. Quando chi ha ricevuto una dignità comprende questo non si gonfierà di orgoglio a motivo del suo rango più elevato, ma saprà che il suo inferiore può essere migliore di lui, così come Gesù è stato sottomesso a Giuseppe” (Omelia su san Luca XX,5, S.C. p. 287).
Cari fratelli nel sacerdozio, il vostro ministero pastorale richiede molte rinunce, ma è anche sorgente di gioia. In relazione confidente con i vostri Vescovi, fraternamente uniti a tutto il presbiterio, e sostenuti dalla porzione del Popolo di Dio che vi è affidata, voi saprete rispondere con fedeltà alla chiamata che il Signore vi ha fatto un giorno, come egli ha chiamato Giuseppe a vegliare su Maria e sul Bambino Gesù! Possiate rimanere fedeli, cari sacerdoti, alle promesse che avete fatto a Dio davanti al vostro Vescovo e davanti all’assemblea. Il Successore di Pietro vi ringrazia per il vostro generoso impegno al servizio della Chiesa e vi incoraggia a non lasciarvi turbare dalle difficoltà del cammino! Ai giovani che si preparano ad unirsi a voi, come a coloro che si pongono ancora delle domande, vorrei ridire questa sera la gioia che si ha nel donarsi totalmente per il servizio di Dio e della Chiesa. Abbiate il coraggio di offrire un “sì” generoso a Cristo!
Invito anche voi, fratelli e sorelle che vi siete impegnati nella vita consacrata o nei movimenti ecclesiali, a rivolgere lo sguardo a san Giuseppe. Quando Maria riceve la visita dell’angelo all’Annunciazione è già promessa sposa di Giuseppe. Indirizzandosi personalmente a Maria, il Signore unisce quindi già intimamente Giuseppe al mistero dell’Incarnazione. Questi ha accettato di legarsi a questa storia che Dio aveva iniziato a scrivere nel seno della sua sposa. Egli ha quindi accolto in casa sua Maria. Ha accolto il mistero che era in lei ed il mistero che era lei stessa. Egli l’ha amata con quel grande rispetto che è il sigillo dell’amore autentico. San Giuseppe ci insegna che si può amare senza possedere. Contemplandolo, ogni uomo e ogni donna può, con la grazia di Dio, essere portato alla guarigione delle sue ferite affettive a condizione di entrare nel progetto che Dio ha già iniziato a realizzare negli esseri che stanno vicini a Lui, così come Giuseppe è entrato nell’opera della redenzione attraverso la figura di Maria e grazie a ciò che Dio aveva già fatto in lei. Possiate, cari fratelli e sorelle impegnati nei movimenti ecclesiali, essere attenti a coloro che vi circondano e manifestare il volto amorevole di Dio alle persone più umili, soprattutto mediante l’esercizio delle opere di misericordia, l’educazione umana e cristiana dei giovani, il servizio della promozione della donna ed in tanti altri modi!
Il contributo spirituale portato dalle persone consacrate è anch’esso assai significativo ed indispensabile per la vita della Chiesa. Questa chiamata a seguire Cristo è un dono per l’intero Popolo di Dio. In adesione alla vostra vocazione, imitando Cristo casto, povero ed obbediente, totalmente consacrato alla gloria del Padre suo e all’amore dei suoi fratelli e sorelle, voi avete per missione di testimoniare, davanti al nostro mondo che ne ha molto bisogno, il primato di Dio e dei beni futuri (cfr Vita consecrata, n.85). Con la vostra fedeltà senza riserve nei vostri impegni voi siete nella Chiesa un germe di vita che cresce al servizio del Regno di Dio. In ogni momento, ma in modo particolare quando la fedeltà è provata, san Giuseppe vi ricorda il senso e il valore dei vostri impegni.
La vita consacrata è una imitazione radicale di Cristo. E’ quindi necessario che il vostro stile di vita esprima con precisione ciò che vi fa vivere e che la vostra attività non nasconda la vostra profonda identità. Non abbiate paura di vivere pienamente l’offerta di voi stessi che avete fatta a Dio e di darne testimonianza con autenticità attorno a voi. Un esempio vi stimola particolarmente a ricercare questa santità di vita, quello del Padre Simon Mpeke, chiamato Baba Simon. Voi sapete come “il missionario dai piedi nudi” ha speso tutte le forze del suo essere in una umiltà disinteressata, avendo a cuore di aiutare le anime, senza risparmiarsi le preoccupazioni e la pena del servizio materiale dei suoi fratelli.Cari fratelli e sorelle, la nostra meditazione sull’itinerario umano e spirituale di san Giuseppe, ci invita a cogliere la misura di tutta la ricchezza della sua vocazione e del modello che egli resta per tutti quelli e quelle che hanno voluto votare la loro esistenza a Cristo, nel sacerdozio come nella vita consacrata o in diverse forme di impegno del laicato.
Giuseppe ha infatti vissuto alla luce del mistero dell’Incarnazione. Non solo con una prossimità fisica, ma anche con l’attenzione del cuore. Giuseppe ci svela il segreto di una umanità che vive alla presenza del mistero, aperta ad esso attraverso i dettagli più concreti dell’esistenza. In lui non c’è separazione tra fede e azione. La sua fede orienta in maniera decisiva le sue azioni. Paradossalmente è agendo, assumendo quindi le sue responsabilità, che egli si mette da parte per lasciare a Dio la libertà di realizzare la sua opera, senza frapporvi ostacolo. Giuseppe è un “uomo giusto” (Mt 1,19) perché la sua esistenza è “aggiustata” sulla parola di Dio.
La vita di san Giuseppe, trascorsa nell’obbedienza alla Parola, è un segno eloquente per tutti i discepoli di Gesù che aspirano all’unità della Chiesa. Il suo esempio ci sollecita a comprendere che è abbandonandosi pienamente alla volontà di Dio che l’uomo diventa un operatore efficace del disegno di Dio, il quale desidera riunire gli uomini in una sola famiglia, una sola assemblea, una sola ‘ecclesia’. Cari amici membri delle altre Confessioni cristiane, questa ricerca dell’unità dei discepoli di Cristo è per noi una grande sfida. Essa ci porta anzitutto a convertirci alla persona di Cristo, a lasciarci sempre più attirare da Lui. E’ in Lui che siamo chiamati a riconoscerci fratelli, figli d’uno stesso Padre. In questo anno consacrato all’Apostolo Paolo, il grande annunciatore di Gesù Cristo, l’Apostolo delle Nazioni, rivolgiamoci insieme a lui per ascoltare e apprendere “la fede e la verità” nelle quali sono radicate le ragioni dell’unità tra i discepoli di Cristo.
Terminando, rivolgiamoci alla sposa di san Giuseppe, la Vergine Maria, “Regina degli Apostoli”, perché questo è il titolo con il quale ella è invocata come patrona del Camerun. A lei affido la consacrazione di ciascuno e di ciascuna di voi, il vostro desiderio di rispondere più fedelmente alla chiamata che vi è stata fatta e alla missione che vi è stata affidata. Invoco infine la sua intercessione per il vostro bel Paese. Amen.
-
-
-
-