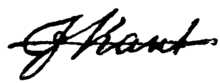
IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
sabato 16 dicembre 2006.COME ALL’INTERNO, COSI’ ALL’ESTERNO: "VERE DUO IN CARNE UNA". NOTE SUL PROGRAMMA DI KANT
di Federico La Sala *
- Kant elaborò esplicitamente tutto l’apparato di concetti, di principi, di argomentazioni della sua filosofia, per giustificare la validità della conoscenza nel caso di un soggetto attivo e recettivo insieme, cioè in vista di un punto di partenza precisamente dualistico, e non unitario (V. Mathieu, Introduzione all’Opus Postumum di Kant, Zanichelli, Bologna, 1963).
___
Pur condividendo l’opinione sulla rivalutazione del corpo, che è divenuta ormai obiettivo «comune [...] a molte aree della cultura del nostro tempo, anche fortemente divergenti tra loro», sulla corporeità intesa come un valore evidente in sé «nella globalità della persona umana», e, inoltre, pur giudicando pregevole e degno di considerazione l’intento di “ritornare alle radici» di questa moderna rivalutazione, ritengo che il tentativo fatto da Casini (1) - senza togliere nessun merito al lavoro, ed è bene ricordare che lo stesso vale per molta letteratura sull’argomento - abbia mancato proprio le radici e, senza di esse, la stessa possibilità di attuare un più ricco e articolato confronto coi pensatori prescelti: Schopenhauer, Feuerbach e Nietzsche.
Impedito da un’ottica storiografica parziale e riduttiva, [Casini] è rimasto in superficie - «nella crisi dell’idealismo tedesco e nelle filosofie che da esso sono scaturite»(2); e gli stessi Schopenhauer, Feuerbach e Nietzsche sono stati confinati tra i «pensatori che, in contrapposizione all’idealismo, hanno messo in rilievo la dimensione corporea dell’uomo»(3). A mio avviso, il luogo delle radici è più in basso; e credo che, una volta conquistato, possa aiutarci a comprendere meglio non solo il contributo di Schopenhauer, Feuerbach e Nietzsche, ma soprattutto la relazione di quei due poli (4) (coscienza e organismo, anima e corpo), che di fatto ci costituiscono e caratterizzano e che - come lo stesso Casini riconosce - «è compito irrinunciabile della riflessione filosofica» pensare fino in fondo «senza di volta in volta emarginare ora l’uno ora l’altro»(5).
Come si sa, del corpo (e, più in generale, della natura) la nostra cultura ha dato sempre (cum grano salis!) un’interpretazione negativa e servile. Succube della grande instaurazione platonica che aveva preteso di avere sciolto l’enigma e di aver trovato nell’anima l’essenza dell’uomo (6), e, con l’anima, l’accesso alla «pianura della verità», essa ha continuamente concepito e ridotto il corpo a una bestia (si ricordino i cavalli della biga platonica...) - strumento animato(... e la concezione aristotelica dello schiavo) o automa (Cartesio) - e, come tale, lo ha trattato, continuamente aggiogato al carro della ragione. E sull’animale della sua classica definizione di uomo non ha mai smesso di mettere una bella croce.
Di «che lagrime grondi e di che sangue» questa visione - profondamente schizogena e, tuttavia, eccellente strumento di domesticazione e di dominio - solo da due secoli si è cominciato a capire. E lo sforzo per lacerare la ragnatela entro cui l’intelligibile ha avvolto e costretto il sensibile, e restituire così al corpo le ragioni che ha e che la Ragione nega, è tuttora in corso.
La storia della metafisica non è stata e non è uno scherzo. Tra le maglie d’acciaio della sua gabbia intere generazioni di uomini hanno patito - letteralmente - le pene dell’inferno, e tutti, infine, hanno dovuto piegarsi alla forza della Ragione come alla ragione della Forza. Chi si è semplicemente opposto o, meglio, ha scoperto il trucco e mostrato le catene sotto i suoi splendidi fiori - Rousseau fu il primo maestro del sospetto (7) - raramente è riuscito a sopravvivere all’ostracismo, al carcere o al rogo. Il Vero, il Bene e il Bello della Ragione hanno finito sempre per vincere e soggiogare il Vero, il Bello e il Bene del corpo, e, pur se nella stessa casa, l’una ha sempre rimosso - rimosso l’animale (8) - e tenuto fuori scena l’altro.
Paradossalmente la fine possibile di questa Storia è cominciata proprio quando la ragione si apprestava a celebrare il suo trionfo e a indossare le vesti di Dea. Non dopo Hegel. Con Rousseau prima, e con Kant poi. Quando Kant - sull’onda dell’effetto copernicano e, nonostante tutto, fiero difensore della sua come della nostra umile terrestrità - ha unito in un saldissimo matrimonio (anche se - per ridotta immaginazione (9) - ancora ’patriarcale’) i due produttori dell’umana conoscenza (10) e, implicitamente, ha stabilito le premesse per un pieno riconoscimento dei due (coscienza sensibile e coscienza intelligibile - io intuisco, io penso) all’interno della stessa casa-soggetto (un vere duo in carne una a cui solo ora stiamo faticosamente pervenendo), e, così facendo, è giunto a mostrare chiaramente che le pretese della Ragione pura erano ingiustificate e che la metafisica non era una scienza né tanto meno la regina delle scienze, allora si è aperto l’orizzonte e si è avviata, insieme con tutto il resto, la stessa riscoperta del corpo (e di tutto ciò che ad esso è legato, compresa la decisiva questione della differenza sessuale, già richiamata da Feuerbach (11) e, attualmente, posta all’ordine del giorno dal movimento delle donne).
Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre costante... «si danno due tronchi dell’umana conoscenza» (12) - due poli: Kant imposta bene il problema fin dall’inizio. E se pure fallisce nello sforzo di codificare correttamente la relazione di bipolarità nel cuore stesso del soggetto trascendentale (offrendo cosi opportunità alla svolta idealistica e, al contempo, contributi alla restaurazione di quanto aveva demolito), egli è incrollabile e non torna mai indietro. Con tutti i limiti, difende fermissimamente sia la distinzione sia la complementarità tra le due facoltà (sensibilità e intelletto) e, unitariamente, la connessa concezione positiva della natura (13). E, cosa molto significativa, non smette mai di riflettere sulla duplicità dell’Io: «non si vuole intendere con ciò - scrive Kant nei Progressi della Metafisica - una doppia personalità, perché solo l’io, l’io penso e intuisco, è la persona» (14).
Nella consapevolezza - evidentemente - che il punto dolente del suo lavoro stava proprio nel modo in cui aveva strutturato la relazione delle due facoltà nell’unità trascendentale dell’appercezione e, in particolare, che ancora una volta - contrariamente alla sua stessa convinzione («nessuna delle due facoltà è da anteporre all’altra» (15)) - aveva concesso diritti in più all’intelletto rispetto ai sensi (alla coscienza intelligibile rispetto alla coscienza sensibile, all’io penso rispetto all’io intuisco), egli cerca di trovare la sua strada per rendere paritario il rapporto e, cosi, più dinamica la stessa funzione trascendentale(16).
Contro chi fraintende il suo pensiero e lo vorrebbe trascinare per altre vie (nel 1794 Fichte pubblica Sul concetto della dottrina della scienza e la Fondazione dell’intera dottrina della scienza, e, nel 1800, Schelling il Sistema dell’idealismo trascendentale), il vecchio Kant - è bene ricordarlo - resiste e lavora instancabilmente (nel 1795 appare Per la pace perpetua, nel 1797 la Metafisica dei costumi, nel 1798 l’Antropologia pragmatica, e, nel 1800, per sua volontà e a cura del suo allievo e amico G.B. Jasche, la Logica). E sempre movendosi all’interno dell’orizzonte della Critica della Ragion Pura - oltre al resto, ai fini della presente nota, si tenga presente l’importante «confutazione dell’idealismo» (1787), il costante rifiuto di attribuire all’uomo («un essere che è dipendente, e rispetto alla sua esistenza, e rispetto alla sua intuizione») l’intuizione intellettuale, e, infine, la radicale presa di distanza dalla Dottrina della Scienza di Fichte (17) (del 7.8.1799) - egli sviluppa nuove riflessioni che ampliano e precisano il senso della sua rivoluzione copernicana, e che se non si tengono presenti, non solo non si dà a Kant ciò che è di Kant, ma si rischia - come è accaduto - di non capire molta parte di tutta la ricerca posteriore, e, cosi, di non poter sciogliere quel nodo che non è solo suo: i due in uno.
Nella Logica, in particolare, riprendendo la distinzione (già avanzata nella Critica della Ragion Pura) tra una filosofia intesa scolasticamente e una filosofia intesa cosmicamente, egli chiarisce che la filosofia nel senso cosmico va intesa in senso cosmopolitico (18); e, ancora, precisa che le tre celebri domande (già formulate sempre nella Critica della Ragion Pura (19): «1. Che cosa posso sapere?, 2. Che cosa devo fare?, 3. Che cosa mi è dato sperare?») non sono affatto sufficienti a delimitare il campo della filosofia in questo nuovo significato e, con ciò, ad esaurire gli interessi fondamentali del cittadino del mondo, o, in senso più proprio, del pianeta Terra.
Per Kant, ora, le tre domande non bastano più: ad esse va unita - e unisce - una quarta e più fondamentale domanda: 4. “Che cosa è l’uomo?”. E, dopo aver rifatto l’elenco, aggiunge: «In fondo, si potrebbe ricondurre tutto all’antropologia, perché le prime tre domande [a cui rispondono, rispettivamente, la metafisica, la morale, la religione, fls] fanno riferimento all’ultima»(20). L’affermazione è «d’importanza non esagerabile»(21). Esprime l’intenzione di voler riprendere e ripensare le questioni dal punto da cui aveva iniziato, da quel soggetto intorno a cui ha messo a rotare l’oggetto. Non è affatto una cosa da poco.
Probabilmente, reso più attento dalla messa a fuoco cosmopolitica (del 1784 è L’idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico) della sua posizione e dalla consapevolezza - già espressa sempre nella Critica della Ragion Pura - che la nostra Terra «è un’isola» (22) e, ancora, che «sulla [Terra, fls], essendo sferica, gli uomini non possono disperdersi all’infinito, ma devono da ultimo rassegnarsi a incontrarsi e a coesistere» (23), oltre che dai continui fraintendimenti del suo lavoro, egli avverte tutta la necessità di reimpostare - in modo più chiaro di quanto abbia fatto e senza cedimenti né materialistici né idealistici - tutte e tre le questioni (metafisica, morale, religione), e, per questo, reinterrogarsi sul soggetto in modo più diretto e determinato: l’uomo, «l’ente sensibile che conosce se stesso» (24).
L’indicazione di Kant non è affatto trascurabile, né sottovalutabile: è carica di teoria, come di futuro. È un’intenzione e un invito a ricominciare da capo, senza tornare al di qua o andare al di là dell’orizzonte critico, e senza abbandonare il corpo e la Terra. Contro la torsione idealistica del suo stesso pensiero e analogamente - ripetiamo - contro ogni riduzione materialistica, Kant guarda di fatto verso quella terza via che la nostra tradizione non ha mai veramente (fallito il tentativo aristotelico) preso in considerazione («Socrate: Cos’è dunque l’uomo? [...] Socr.: Qui c’è una cosa da cui nessuno può dissentire. Alcibiade: Quale? Socr.: Che l’uomo sia almeno una delle tre cose. Alc.: Quali? Socr.: O anima, o corpo, o ambedue insieme, come un tutto unico»(25)) ma che proprio l’impostazione critica del problema della conoscenza lascia intravedere e porta alla luce, in modo nuovo.
Dai «due tronchi dell’umana conoscenza» al «fatto [Factum] indubitabile»(26) che siamo due in uno e all’apertura all’antropologia, come al sapere a cui possono essere ricondotte sia la metafisica sia la morale e la religione, il passo è inevitabile. E Kant lo fa. Per determinare meglio, e senza equivoci, il senso della sua rivoluzione copernicana, bisogna, ripensare quel soggetto che noi siamo, e, quindi, rimettere in campo il rapporto tra quei due Io (io penso, io intuisco) che caratterizzano l’unità dell’essere umano e, con ciò, lo stesso rapporto con l’esperienza.
Ancor prima di Hegel, l’indicazione è già data e la strada già aperta: il segreto della metafisica, il segreto della morale, «il segreto della teologia è l’antropologia»(27). Nonostante i suoi sbandamenti e le sue contraddizioni, il «cinese» di Koenigsberg non confuse mai i «cento talleri immaginari e i cento talleri reali»(28) e rimase sempre fedele alla terra(29); e questo, chi ha camminato nella direzione da lui indicata, bene o male, già sapeva. Per noi, è meglio tenerne conto.
Senza dare o togliere niente a nessuno, anche Kant aveva capito - e prima di tutti gli altri - che «nella coscienza [...] arriviamo a fantasticare di un io contrapposto a tutto il resto, al non-io», che bisognava «smettere di sentirsi come questo fantastico ego!», che bisognava «scoprire gli errori dell’ego» e, finalmente, cominciare a pensare e a «sentire ih modo cosmico!»(30): copernicano, ma sempre terrestre. E se alla fine pone la classica questione, non possiamo e non dobbiamo né equivocare, né sottovalutare.
Non è Socrate o Platone che parla o scrive: è Kant! E, quindi, la sua domanda «che cosa è l’uomo?», o, come dirà Nietzsche, «chi siamo noi in realtà?»(31), deve essere intesa nei suoi termini: come sono possibili quegli esseri che sono due in uno?, come è possibile il soggetto?, come è possibile l’uomo?
Dopo Schopenhauer, dopo Feuerbach, dopo Marx, come dopo Nietzsche e Freud, oggi, forse, siamo finalmente più preparati e pronti per rispondere. Riusciremo a portare a compimento la rivoluzione copernicana(32) e ad abitare la Terra serenamente?
* Riprendo qui, un capitolo di un mio lavoro (cfr. Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore, Prefazione di Fulvio Papi, Roma-Salerno, Edizioni Ripostes, 1996, pp. 112-119), in onore e in memoria di Elvio Fachinelli (e della sua ricerca culminata - nell’anno della morte - con La mente estatica, Milano, Adelphi, 1989). Mi auguro che esso possa essere utile a meglio comprendere e apprezzare l’importanza teoretica e la portata antropologica della sua opera di psicoanalista e di filosofo.
 (1)L. Casini, La riscoperta del corpo. Schopenhauer. Feuerbach. Nietzsche, Roma, Edizioni Studium, 1990, p. 16.
(1)L. Casini, La riscoperta del corpo. Schopenhauer. Feuerbach. Nietzsche, Roma, Edizioni Studium, 1990, p. 16.
 (2)Op. cit.. p. 15.
(2)Op. cit.. p. 15.
 (3)Ibidem, p. 16.
(3)Ibidem, p. 16.
 (4)“[...] due poli. Se da un lato la coscienza e lo spirito umano vengono considerati sempre più nei loro condizionamenti corporei e istintuali, d’altro canto il corpo non è più considerato oggetto di un soggetto, ma come soggetto esso stesso, sorgente di intenzionalità e di valore, realtà non meramente fisica, ma tessuto di emotività e vitalità che si estendono fino al centro coscienziale dell’uomo» (op. cit., p. 15).
(4)“[...] due poli. Se da un lato la coscienza e lo spirito umano vengono considerati sempre più nei loro condizionamenti corporei e istintuali, d’altro canto il corpo non è più considerato oggetto di un soggetto, ma come soggetto esso stesso, sorgente di intenzionalità e di valore, realtà non meramente fisica, ma tessuto di emotività e vitalità che si estendono fino al centro coscienziale dell’uomo» (op. cit., p. 15).
 (5)Ibidem, pp. 20-21.
(5)Ibidem, pp. 20-21.
 (6)«L’anima è l’uomo» (Platone, Alcibiade primo, 130 c).
(6)«L’anima è l’uomo» (Platone, Alcibiade primo, 130 c).
 (7)«Lo spirito ha le sue esigenze come le ha il corpo. Queste ultime costituiscono le basi della società, le prime ne sono l’ornamento. Mentre il governo e le leggi provvedono alla sicurezza e al benessere degli uomini riuniti in società, le scienze, le lettere e le arti, con minor dispotismo e forse con maggiore autorità, stendono ghirlande di fiorì sulle ferree catene di cui gli uomini sono gravati, soffocano in loro il sentimento di quella libertà originaria per la quale parevano essere nati, fanno loro amare la schiavitù cui sono soggetti, formando quelli che si chiamano i popoli civili» (J.J. Rousseau, Discorso sulle Scienze e le Arti).
(7)«Lo spirito ha le sue esigenze come le ha il corpo. Queste ultime costituiscono le basi della società, le prime ne sono l’ornamento. Mentre il governo e le leggi provvedono alla sicurezza e al benessere degli uomini riuniti in società, le scienze, le lettere e le arti, con minor dispotismo e forse con maggiore autorità, stendono ghirlande di fiorì sulle ferree catene di cui gli uomini sono gravati, soffocano in loro il sentimento di quella libertà originaria per la quale parevano essere nati, fanno loro amare la schiavitù cui sono soggetti, formando quelli che si chiamano i popoli civili» (J.J. Rousseau, Discorso sulle Scienze e le Arti).
 (8) Cfr. G. Galilei, Il Saggiatore, cap. 48.
(8) Cfr. G. Galilei, Il Saggiatore, cap. 48.
 (9) Sull’intricata questione, si cfr. almeno M. Heidegger, Kant e il problema della Metafisica, Bari. Laterza, 1981, pp. 113-174, e si ricordi che Kant resta, in ultima analisi, ancorato alla convinzione che la sensibilità «in sé è plebe, perché non pensa» (Antropologia, pf. 8: «Apologia della sensibilità»).
(9) Sull’intricata questione, si cfr. almeno M. Heidegger, Kant e il problema della Metafisica, Bari. Laterza, 1981, pp. 113-174, e si ricordi che Kant resta, in ultima analisi, ancorato alla convinzione che la sensibilità «in sé è plebe, perché non pensa» (Antropologia, pf. 8: «Apologia della sensibilità»).
 (10) «Queste due facoltà o capacità non possono scambiarsi le loro funzioni. L’intelletto non può intuire nulla, né i sensi nulla pensare. La conoscenza non può scaturire se non dalla loro unione. Ma non perciò si devono confondere le loro parti; ché, anzi, si ha grande ragione di separarle accuratamente e di tenerle distinte» (I. Kant, Critica della Ragion pura, Bari, Laterza. 1966, I, p. 94).
(10) «Queste due facoltà o capacità non possono scambiarsi le loro funzioni. L’intelletto non può intuire nulla, né i sensi nulla pensare. La conoscenza non può scaturire se non dalla loro unione. Ma non perciò si devono confondere le loro parti; ché, anzi, si ha grande ragione di separarle accuratamente e di tenerle distinte» (I. Kant, Critica della Ragion pura, Bari, Laterza. 1966, I, p. 94).
 (11) Su questo, cfr. L. Casini, La riscoperta del corpo..., cit., p. 149.
(11) Su questo, cfr. L. Casini, La riscoperta del corpo..., cit., p. 149.
 (12) Kant, op. cit.. p. 61.
(12) Kant, op. cit.. p. 61.
 (13) A riguardo molto hanno insistito, e a ragione, G. Della Volpe prima (cfr. Logica come scienza storica, Roma, Editore Riuniti, 1969, p. 18) e poi L. Colletti (cfr. Il marxismo e Hegel, Bari. Laterza, 1969. pp. 45 ss.).
(13) A riguardo molto hanno insistito, e a ragione, G. Della Volpe prima (cfr. Logica come scienza storica, Roma, Editore Riuniti, 1969, p. 18) e poi L. Colletti (cfr. Il marxismo e Hegel, Bari. Laterza, 1969. pp. 45 ss.).
 (14) Cfr. L Kant, I progressi della Metafisica. Napoli. Bibliopolis, 1977, p. 77.
(14) Cfr. L Kant, I progressi della Metafisica. Napoli. Bibliopolis, 1977, p. 77.
 (15) Cfr. I. Kant, Critica della Ragion Pura, cit., p. 94.
(15) Cfr. I. Kant, Critica della Ragion Pura, cit., p. 94.
 (16) Su questo, cfr. anche P. Manganaro, Introduzione a: I. Kant, I progressi..., cit., pp. 42-43.
(16) Su questo, cfr. anche P. Manganaro, Introduzione a: I. Kant, I progressi..., cit., pp. 42-43.
 (17) Per la dichiarazione di Kant sulla «Dottrina della scienza» di Fichte (7.8.1799), cfr. C. Cesa, Fichte e il primo Idealismo, Firenze, Sansoni, 1975, pp. 88-90.
(17) Per la dichiarazione di Kant sulla «Dottrina della scienza» di Fichte (7.8.1799), cfr. C. Cesa, Fichte e il primo Idealismo, Firenze, Sansoni, 1975, pp. 88-90.
 (18) Cfr. I. Kant, Logica, a cura di L. Amoroso, Bari, Laterza. 1984, p. 18.
(18) Cfr. I. Kant, Logica, a cura di L. Amoroso, Bari, Laterza. 1984, p. 18.
 (19) Cfr. I. Kant, Critica della Ragion Pura, cit., II, p. 612.
(19) Cfr. I. Kant, Critica della Ragion Pura, cit., II, p. 612.
 (20) Cfr. I. Kant, Logica, cit., p. 19.
(20) Cfr. I. Kant, Logica, cit., p. 19.
 (21) Op. cit., p. XIV. Su questo, cfr. anche M. Heidegger, op. cit., pp. 178 ss.
(21) Op. cit., p. XIV. Su questo, cfr. anche M. Heidegger, op. cit., pp. 178 ss.
 (22) Cfr. I. Kant, Critica della Ragion Pura, cit., I, p. 243.
(22) Cfr. I. Kant, Critica della Ragion Pura, cit., I, p. 243.
 (23) Cfr. I. Kant, Per la pace perpetua. A riguardo, cfr. anche N. Bobbio, Kant e la Rivoluzione Francese, in «Nuova Antologia», luglio-settembre 1990, pp. 53-60.
(23) Cfr. I. Kant, Per la pace perpetua. A riguardo, cfr. anche N. Bobbio, Kant e la Rivoluzione Francese, in «Nuova Antologia», luglio-settembre 1990, pp. 53-60.
 (24) Per questi problemi, cfr. P. Manganaro, op. cit., p. 43. e l’Introduzione di V. Mathieu a: I. Kant, Opus Postumum, Bologna, Zanichelli, 1963, pp. 3-57.
(24) Per questi problemi, cfr. P. Manganaro, op. cit., p. 43. e l’Introduzione di V. Mathieu a: I. Kant, Opus Postumum, Bologna, Zanichelli, 1963, pp. 3-57.
 (25) Cfr. Platone, Alcibiade primo, 130 a.
(25) Cfr. Platone, Alcibiade primo, 130 a.
 (26) Cfr. I. Kant, I progressi..., cit., p. 77.
(26) Cfr. I. Kant, I progressi..., cit., p. 77.
 (27) Cfr. L. Feuerbach, Tesi provvisorie per una riforma della Filosofia, in: L. Feuerbach,Principi della Filosofia dell’avvenire, Torino, Einaudi. 1971, p. 49.
(27) Cfr. L. Feuerbach, Tesi provvisorie per una riforma della Filosofia, in: L. Feuerbach,Principi della Filosofia dell’avvenire, Torino, Einaudi. 1971, p. 49.
 (28) Op. cit., p. 106.
(28) Op. cit., p. 106.
 (29) F. Nietzsche, Opere, VI, 1. p. 6.
(29) F. Nietzsche, Opere, VI, 1. p. 6.
 (30) F. Nietzsche, Opere, V. 2. pp. 280-281.
(30) F. Nietzsche, Opere, V. 2. pp. 280-281.
 (31) F. Nietzsche, Opere, VI. 3, p. 213.
(31) F. Nietzsche, Opere, VI. 3, p. 213.
 (32) A riguardo si tenga presente l’indicazione di Th. W. Adorno sulla necessità di «una seconda rivoluzione copernicana », e, in particolare, si cfr. A. Sohn-Rethel, Lavoro intellettuale e lavoro manuale. Per la teoria della sintesi sociale, Milano, Feltrinelli. 1977, pp. 68-70. Sul tema, inoltre, cfr. l’importante inedito di E. Husserl, Rovesciamento della dottrina copernicana nell’interpretazione della corrente visione del mondo, in «aut aut», 245, settembre-ottobre 1991,
pp. 3-18; Guido D. Neri, Terra e cielo in un manoscritto del 1934, op, cit., pp. 19-44; e F. La Sala, Per una nuova cultura all’altezza del Pianeta Azzurro, in «La Crìtica Sociologica». 93, 1990, pp. 111-115.
(32) A riguardo si tenga presente l’indicazione di Th. W. Adorno sulla necessità di «una seconda rivoluzione copernicana », e, in particolare, si cfr. A. Sohn-Rethel, Lavoro intellettuale e lavoro manuale. Per la teoria della sintesi sociale, Milano, Feltrinelli. 1977, pp. 68-70. Sul tema, inoltre, cfr. l’importante inedito di E. Husserl, Rovesciamento della dottrina copernicana nell’interpretazione della corrente visione del mondo, in «aut aut», 245, settembre-ottobre 1991,
pp. 3-18; Guido D. Neri, Terra e cielo in un manoscritto del 1934, op, cit., pp. 19-44; e F. La Sala, Per una nuova cultura all’altezza del Pianeta Azzurro, in «La Crìtica Sociologica». 93, 1990, pp. 111-115.
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. Sul tema generale, nel sito, cfr.:
- UNA DOMANDA SUL TEMA DEL "FIGLIO DELL’UOMO" ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]: "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- "ESSERE E TEMPO": IL TEMA DELLA "CURA" (* Favola di Igino, astronomo del I sec. a.C.- I sec. d.C., ripresa da K. Burdach, "Faust und die Sorge", e già utilizzata da Herder e Goethe):
- In una favola antica troviamo la seguente autointerpretazione dell’Esserci come "Cura".
- La “Cura”, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso;
pensierosa ne raccolse un po’ e incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a stabilire che cosa abbia
fatto, interviene Giove.
 La “Cura” lo prega di infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsente volentieri.
La “Cura” lo prega di infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsente volentieri.
 Ma quando la “Cura” pretese imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle fosse
imposto il proprio.
Ma quando la “Cura” pretese imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle fosse
imposto il proprio.
 Mentre la “Cura” e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che
era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché aveva dato ad esso una parte del proprio corpo.
Mentre la “Cura” e Giove disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che
era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché aveva dato ad esso una parte del proprio corpo.
 I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò ai contendenti la seguente giusta decisione:
I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò ai contendenti la seguente giusta decisione:
 “Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito; tu, Terra, che hai dato
il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fin che
esso vive lo possieda la “Cura”.
Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami homo poiché è fatto di humus (Terra).
“Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito; tu, Terra, che hai dato
il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fin che
esso vive lo possieda la “Cura”.
Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami homo poiché è fatto di humus (Terra).
 (M. Heidegger, "Essere e Tempo", [1927], pf. 42).
(M. Heidegger, "Essere e Tempo", [1927], pf. 42).
- BAMBINE E COMPLESSO DI EDIPO "(...)Come si compie lo sviluppo corrispondente nella bambina? Il nostro materiale diventa qui - incomprensibilmente - molto più oscuro e lacunoso. Anche il sesso femminile sviluppa un complesso edipico, un Super-Io e un’epoca di latenza. Gli si può attribuire anche un’organizzazione fallica e un complesso di evirazione? La risposta è affermativa, ma la situazione non può essere identica a quella del maschio.
 La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)
La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)
 Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).
Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).
 UOMINI E DONNE. SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. AL DI LA’ DELL’ "EDIPO".
UOMINI E DONNE. SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. AL DI LA’ DELL’ "EDIPO".
 IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO di Sigmund Freud (1931).
IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO di Sigmund Freud (1931).
FLS
FREUD_KANT_E_I_SOGNI_DELLA_TEOLOGIA_POLITICA_ATEA_E_DEVOTA
Forum
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". --- ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI E LINGUAGGIO: L’ INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (S. FREUD, 1899) E IL VINCOLO DEI NOMI (W. STEKEL, 1911).19 giugno 2024, di Federico La Sala
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (S. FREUD, 1899) E DEI NOMI (W. STEKEL, 1911): PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, LINGUAGGIO, E REALTA’.
NEL PROPORRE LA TRADUZIONE DELL’ARTICOLO DI WILHELM STEKEL (Vienna 1868 - Londra 1940), "Il vincolo dei nomi" ("Il passo psicoanalitico", 16 giugno 2024 ), #Michele #Lualdi premette una breve nota di chiarimenti storiografici di contestualizzazione per meglio far comprendere sia il lavoro di Stekel sia i rapporti dello stesso Stekel con il lavoro di Freud e degli altri psicoanalisti: l’articolo, proposto per la rivista "Zentralblatt für Psychoanalyse", nata nel 1910 e diretta da Freud, fu pubblicato invece sulla "Zeitschrift für Psychotherapie und Medizinische Psychologie" nel 1911.
MEMORIA. Detto che si tratta di "[...] un breve articolo sul rapporto tra nome (e cognome) di una persona da un lato e sintomi, abitudini, scelte di vita e d’amore dall’altro", Lualdi richiama e ricita da un suo precedente lavoro la interessante testimonianza di Stekel, proprio sul tema della pubblicazione dell’articolo: «“Freud indirizzò il suo primo veto contro di me; concerneva un saggio intitolato Il vincolo del nome”... prevedeva che i lettori avrebbero riso di me e conformemente al nostro accordo esercitò la sua prima opposizione. Allora io pubblicai l’articolo in un’altra rivista psicologica. Non vi furono né scherni né derisioni; al contrario, giunsero conferme da parte di molti ardenti freudiani.” (Lualdi, 2015, 245-56).» (op. cit.).
L’OMBELICO DEL "NOME": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, LINGUISTICA, E TEOLOGICO-POLITICA. A cercare di illuminare le ragioni dell’uno (Freud) e dell’altro (Stekel) e di riprendere la riflessione teorica sul "vincolo dei nomi", forse, è opportuno ricollocare la questione all’interno del problema di memoria culturale e antropologica di lunga durata (cfr. #DanteAlighieri, "De Vulgari eloquentia"), che affonda le sue radici nel "biblico" dare il nome alle cose (#Genesi, 2.19) da parte di #Dio e da parte di #Adamo il nome agli animali (#androcentrismo prima della nascita di #Eva e dopo la "cacciata" di entrambi dall’#Eden) , e nella tradizione filosofica greca, nel "#Cratilo" del "so-cratico" e demiurgico #Platone.
L’OMBELICO DEL SOGNO: IL MONDO NON E’ IL MAPPAMONDO. Se si ripensa e si accoglie la scelta di epistemologia critica propria e già di Freud (1899), che «ogni sogno ha un ombelico attraverso il quale è congiunto all’ignoto» ("Interpretazione dei sogni"), riconoscendo ovviamente a Stekel tutto il valore della sua ricerca, oggi, forse, è meglio pensare che i nomi delle persone (i #bambini), come la "rappresentazione" dei #sogni "sognati" (e delle #idee "pensate"), hanno il loro ombelico e, che è opportuno ri-considerare antropologicamente la "nostra semenza" (#Dante, Inf. XXVI, 118 ), come la #semenza altrui (e quella degli stessi sogni e delle stesse idee di ogni essere umano).
NOTA:
- RICERCASCIENTIFICA E STORIOGRAFIA DELLA PSICOANALISI: UNA QUESTIONE DI NOMINAZIONE. Considerato che "Freud - come ricorda Michele Lualdi - tracciava un trait d’union tra lui e il maestro francese", J.-M. #Charcot (1825-1893), alla luce di quanto viene raccontato nello stesso "necrologio" (Sigmund Freud, 1893), il "fatto" getta grande luce sulla sua formazione e, in particolare, sul problema della #interpretazione dei sogni-nomi e, ancora, sui confini critici ("kantiani") entro cui si è sempre mosso, pur tra le infinite difficoltà, nel lavoro di "costruzioni nell’analisi" (1937), e lo colloca, al di là delle varie "pasticcerie" di scuola interessate (filosofiche, psicologiche, ecc.), all’interno della "rivoluzione copernicana" di Immanuel #Kant.
- J.-M. Charcot: «L’esattezza scientifica non ha niente a che fare col pregiudizio che porta alcuni tipi di menti a guardare con sfavore qualunque osservazione che abbia dei caratteri inusuali; lo scetticismo merita, in questo caso, lo stesso disprezzo dell’ingenua credulità.» (Jean-Martin Charcot).
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- "I sei lati del mondo. Linguaggio ed esperienza" di Giorgio R. Cardona. «Assenza, più acuta presenza» (di Corrado Bologna - Insula Europea).7 gennaio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: "SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784). RIPRENDERE IL FILO DELLA RISCOPERTA DEL CORPO: IL RICORDO DELLA LEZIONE DI GIORGIO CARDONA. Un contributo (straordinario) di Corrado Bologna alla conoscenza del suo percorso di ricerca:
- Giorgio R. Cardona: «Assenza, più acuta presenza»
«Nessuno è indispensabile», diceva Giorgio Raimondo Cardona. Lo diceva spesso, con la saggezza socratica e la serena ironia che si moltiplicava nel bel viso coronato dai capelli ricci, occhi luccicanti e bocca sorridente fra barba e baffi color carota, da filosofo antico. Aveva ragione lui, come al solito: nessuno è indispensabile. Me ne rendo conto sempre più pensando che #oggi, 7 gennaio 2023, avrebbe compiuto 80 anni, e che invece partì per sempre a 45 anni, la feroce vigilia di ferragosto del 1988. [...]
 Giorgio Cardona non era solo un grande linguista: era anzitutto un grande antropologo.[...]
Giorgio Cardona non era solo un grande linguista: era anzitutto un grande antropologo.[...]Una tra le idee forti e originali più limpidamente approfondite nei due libri dai titoli parlanti e allegorici apparsi nel 1985, anno di grande fecondità per Giorgio (La foresta di piume. Manuale di etnoscienza; I sei lati del mondo. Linguaggio ed esperienza), è che tra il piano della formulazione linguistica di determinati saperi e quello della loro strutturazione conoscitiva non c’è coincidenza. Insomma, il linguaggio non “è” il pensiero, né il pensiero “sta dentro” il linguaggio. Componenti emozionali, conoscitive, immagini, suoni, percezioni sensoriali, intervengono a coordinare e formare la complessa procedura gnoseologica. Come il fonema rappresenta la cellula-base del linguaggio vocale, e il grafema della sua forma scritta, così, ipotizzava Giorgio, esisterà un noema, unità minima del pensiero, irriducibile alla mera componente linguistica.[...]
 Ne I sei lati del mondo, domandandosi se sia il linguaggio che influisce sulle nostre visioni del mondo, o se invece sia la realtà a imprimere il suo segno sui nostri modi di esprimerci, Giorgio mise in luce il “modello corporeo” con cui l’uomo organizza lo spazio: non solo “alto” e “basso”, ma anche “destra” e “sinistra”, e “davanti” e “dietro”. Cesare Segre, in Notizie dalla crisi (1993), richiamandosi anche alle ricerche di Th. Luckmann e di Harald Weinrich sul «corpo umano come struttura fondamentale della condizione umana», salutava con piena adesione le pagine dei Sei lati del mondo sul nesso «fra l’orientamento del corpo nello spazio e le preposizioni» e sulla «specularità fra l’uomo e il mondo», dell’«antropomorfizzazione del mondo e delle cose». Giorgio, per aprire il suo capitolo, si era richiamato a Leonardo nel Codice Trivulziano: «Ogni omo sempre si trova nel mezzo del mondo e sotto il mezzo del suo emisperio e sopra il centro d’esso mondo»: la postura eretta dell’Homo sapiens era già l’Homo copernicanus che sfora con la testa oltre le nuvole, pronto a misurare anche l’immisurabile.
Ne I sei lati del mondo, domandandosi se sia il linguaggio che influisce sulle nostre visioni del mondo, o se invece sia la realtà a imprimere il suo segno sui nostri modi di esprimerci, Giorgio mise in luce il “modello corporeo” con cui l’uomo organizza lo spazio: non solo “alto” e “basso”, ma anche “destra” e “sinistra”, e “davanti” e “dietro”. Cesare Segre, in Notizie dalla crisi (1993), richiamandosi anche alle ricerche di Th. Luckmann e di Harald Weinrich sul «corpo umano come struttura fondamentale della condizione umana», salutava con piena adesione le pagine dei Sei lati del mondo sul nesso «fra l’orientamento del corpo nello spazio e le preposizioni» e sulla «specularità fra l’uomo e il mondo», dell’«antropomorfizzazione del mondo e delle cose». Giorgio, per aprire il suo capitolo, si era richiamato a Leonardo nel Codice Trivulziano: «Ogni omo sempre si trova nel mezzo del mondo e sotto il mezzo del suo emisperio e sopra il centro d’esso mondo»: la postura eretta dell’Homo sapiens era già l’Homo copernicanus che sfora con la testa oltre le nuvole, pronto a misurare anche l’immisurabile.
 La finezza e la forza limpida dell’argomentazione di Giorgio Cardona muovendo da un luogo comune vi riconosceva un sottofondo, uno spazio disposto all’ermeneutica, nell’interstizio fra lingua e pensiero, e lì lavorava, scavava, scopriva filoni auriferi: «Il detto greco di tutte le cose è misura l’uomo’ (pánton tôn prámmaton métron ho ánthropos) viene citato per solito per ricordarci il senso della relatività posseduto dai Greci. Non c’è dubbio che l’interpretazione che vede in questo detto una tranquilla e coraggiosa professione di fede laica può essere giusta. Ma forse raramente o mai si pensa che il detto vada preso innanzitutto alla lettera. L’uomo è effettivamente la misura di tutte le cose, nel senso corrente in cui oggi si dice “a misura d’uomo”, e questa logica sottostante traspare da innumerevoli indizi; le misure delle cose sono corporee (pêkhus cubito’), il linguaggio è visto come un corpo articolato e perfino il tempo è analizzato a volte su un riferimento corporeo». Questo significava, per lui, abitare nel linguaggio. (Insula Europea, 06 GENNAIO 2023 ).
La finezza e la forza limpida dell’argomentazione di Giorgio Cardona muovendo da un luogo comune vi riconosceva un sottofondo, uno spazio disposto all’ermeneutica, nell’interstizio fra lingua e pensiero, e lì lavorava, scavava, scopriva filoni auriferi: «Il detto greco di tutte le cose è misura l’uomo’ (pánton tôn prámmaton métron ho ánthropos) viene citato per solito per ricordarci il senso della relatività posseduto dai Greci. Non c’è dubbio che l’interpretazione che vede in questo detto una tranquilla e coraggiosa professione di fede laica può essere giusta. Ma forse raramente o mai si pensa che il detto vada preso innanzitutto alla lettera. L’uomo è effettivamente la misura di tutte le cose, nel senso corrente in cui oggi si dice “a misura d’uomo”, e questa logica sottostante traspare da innumerevoli indizi; le misure delle cose sono corporee (pêkhus cubito’), il linguaggio è visto come un corpo articolato e perfino il tempo è analizzato a volte su un riferimento corporeo». Questo significava, per lui, abitare nel linguaggio. (Insula Europea, 06 GENNAIO 2023 ).***
Giorgio Raimondo Cardona, I sei lati del mondo. Linguaggio ed esperienza, Roma-Bari, Laterza, 1985
Dalle pp. 1-4 (Introduzione), 7-17 (Modelli e conoscenza):
I sei lati del mondo è una espressione persiana e poi turca usata per cogliere in un colpo solo l’insieme di tutte le localizzazioni spaziali raggiungibili. Molte parole sarebbero necessarie per spiegare quello che è invece del tutto intuitivo: l’orientamento umano individua quattro quadranti dello spazio; e questa prima suddivisione, che già potrebbe bastare a esaurire lo spazio tridimensionale, è completata dall’opposizione alto-basso.
Queste sei direzioni, i sei lati del mondo, sono riassunte in un modello tangibile, la tenda dei nomadi, che le sbarra ognuna con un piano - le quattro pareti, il tetto, il piano del suolo - creando quindi per l’uomo un riparo delimitato e circoscritto rispetto alla dimensione dello spazio. L’abitazione delimita, raccoglie, e proprio perché essa è la proiezione, il guscio, il carapace che l’animale uomo secerne per coprirsi e per ripararsi dalla centrifugità dello spazio, essa riceve nelle sue parti la proiezione del corpo che l’ha generata.
Questo è un modello percettivo e conoscitivo; per poter diventare efficiente e usabile esso ha però bisogno di sposarsi a un corrsipondente modello segnico, che permetta di comunicarlo. Una cultura fa uso di molti di questi modelli, psicologici prima che linguistici, ed è convinzione difendibile che la lingua e l’uso linguistico ce ne mostrino molte delle linee di forza, o almeno dei punti nodali.
Non troveremo nella lingua un fedele ricalco di tutto ciò che la comunità pensa; non tutto deve essere esplicitato perché molto di ciò che vive nella comunità vi vive allo stato latente. Non sono forse innumerevoli le "verità" culturali che tutti conosciamo e che quindi troveremmo sciocco o bizzarro enunciare con parole? Che le cose cadano dall’alto, che l’acqua disseti, che il fuoco riscaldi, dobbiamo forse dircelo? Tanto peggio per l’osservatore esterno che nei suoi nastri magnetici, ascoltati e riascoltati, non troverà traccia di quanto tutti invece sanno e danno per certo. [...]
Eppure molte tracce di quel che pensiamo e comunemente sappiamo filtrano in quel che diciamo, si depositano, si sedimentano in momenti e occasioni diverse. Per noi che le usiamo le parole sono ciottoli tutti uguali, e tali devono sembrarci; ma se ci soffermiamo ad osservarli, ciascuno ci mostra la sua storia, la sua composizione, le sostanze che vi sono dentro fossilizzate. [...]
Questo è un libro sulla visione linguistica del mondo: la tesi di fondo prevede innanzitutto che si possa parlare di una tale visione, che qualcosa del genere si dia; e, in secondo luogo, che gli elementi attraverso cui essa si costituisce siano attinti da un magazzino universale e rispondano ovunque, in misura variabile, ad analoghe restrizioni biologiche e culturali.
Proprio nella perpetua, mutevole dialettica tra la variazione e la diversità dei modi culturali e le costrizioni che ad essi oppone l’immutabile condizione umana sta uno dei principali motivi di interesse e di fascino per l’osservatore, antropologo o linguista. [...]
Capitolo primo. Modelli e conoscenza
1.1. Un ordine necessario
A tutto ciò che conosciamo, percepiamo, ideiamo, dobbiamo necessariamente dare un ordine. La nostra mente deve far posto a nozioni delle più varie provenienze: informazioni sul mondo biologico, diagrammi delle relazioni sociali, dati dell’esperienza personale vissuta; è un patrimonio di molti milioni di dati quello che si accumula nella nostra memoria nel corso di una vita. [...]
Ma questo materiale deve, per poter essere utile, venire in qualche modo inventariato, catalogato; e data la sua eterogeneità (nozioni quadro con valore sistematico e operativo coesistono con fotogrammi isolati, con brandelli di eventi) non potrà essere ordinato in modo univoco, senza residui; ci sarà invece un continuo processo di riordinamento: i dati volta per volta non più utili vengono cancellati completamente o messi - per così dire - in un cassetto, riposti in scaffali fuori mano; altri vengono raggruppati sotto una stessa intestazione, ridotti a fattore comune; vengono stabiliti sempre nuovi collegamenti, rapporti causali, regole predittive. Una notevole elasticità del sistema permette che gli incastri, le cerniere, i passaggi non debbano essere di un’assoluta precisione, ma consentano un certo gioco di adattamento.
L’approssimazione, l’indeterminatezza, il flou dei contorni - di per sé negativi e indesiderabili in un sistema formale - sono la condizione essenziale per permetterci di ricordare, di associare un fatto all’altro, di riconoscere una forma, una configurazione, anche appena intravista; con altrettanta se non maggiore indeterminatezza ci si offre il mondo degli stimoli e delle percezioni esterne.
1.2. La codificazione linguistica
In tutti questi processi mentali, vitali per la nostra stessa sopravvivenza come individui e come gruppo sociale, la lingua ha un posto eminente. Gran parte di queste informazioni può infatti - anche se non necessariamente - essere codificata nelle forme che ci offre la lingua. [...]
1.3. Altri sistemi semiotici
[...] molto spesso quello a cui facciamo riferimento non è la lingua in senso proprio bensì un sistema semiotico in generale, cioè una costruzione funzionale di cui la lingua non è che uno dei tipi possibili [...].
[...] La lingua ha come materia la voce - o, nella sua versione scritta, la carta, l’inchiostro o simili - ma altri sistemi si servono di stimoli visivi (forma, colori), di gesti, di suoni. [...]
Non c’è dubbio che le relazioni interpersonali all’interno di una comunità costituiscano un sistema: ci sono ruoli, rapporti privilegiati, regole di scambio, di reciprocazione, di evitazione e così via; ma tali sistemi, interiorizzati dai membri della comunità, devono, per trovare espressione percepibile, essere codificati in altri sistemi ancora, dalla forma e colore dei vestiti alle scenografie di una festa.
Si prenda la rappresentazione visiva: anche all’interno di una stessa scelta di modalità troviamo gradi diversi di semiologizzazione da cultura a cultura; la tradizione occidentale ha notevolmente privilegiato - dal livello popolare a quello più colto - il ricorso a segni con referente concreto, riconoscibile (figure, oggetti), altre tradizioni hanno dato invece molta importanza a forme geometriche, rapporti di spazi e linee, colori;
una pittura come quella tibetana, fortemente semiologica e decifrabile solo in riferimento all’universo significativo delle credenze e conoscenze religiose e cosmologiche pur gremita com’è di figure riconoscibili (demoni, divinità, oggetti), fa largo uso di elementi astratti, quali il colore usato in maniera simbolica e non naturalistica, la dimensione e la posizione relativa delle figure nello spazio, le forme geometriche (i vari mandala). E siamo già, si badi, di fronte a una forma artistica che si potrebbe a buon diritto definire classica, cioè al massimo dell’elaborazione colta e consapevole. Ciò significa che la forma espressiva scelta da queste altre culture non è immediatamente traducibile nelle forme della lingua.
Le arti figurative occidentali sono invece fortemente linguistiche; tra le forme espressive verbali e quelle figurative esiste per noi da sempre uno stretto parallelismo; l’ideologia dell’"ut pictura poësis" da un lato; all’altro la pictura dà corpo a personaggi e temi sanciti dalla letteratura.
I vari elementi che si compongono possono esser messi in corrispondenza con segni della lingua. Naturalmente anche al colore o ad alre forme astratte si può dare un nome, ma questo nominare è meno immediatamente a portata di mano.
L’espressione "ut pictura poësis" è di Orazio; ma nella tradizione il primo a paragonare poesia e pittura fu Simonide di Ceo. "Simonide - scrive Plutarco nel de gloria Atheniensium 3 - definiva la pittura una poesia silenziosa e la poesia una pittura parlante; giacché le azioni che i pittori dipingono nell’atto del loro compiersi, le parole le descrivono dopo il loro esser state compiute".
Sia questa osservazione che l’invenzione della mnemotecnica si iscrivono in una netta intelligenza del posto centrale che ha la visione fra le facoltà umane, intelligenza che Simonide [V sec. a.C.] sembra essere stato uno dei primi a raggiungere, almeno esplicitamente, in Occidente.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- Neurobiologia dell’esperienza interpersonale. "La mente relazionale" : il libro di D. J. Siegel (di Elisa Ginanneschi )13 novembre 2022, di Federico La Sala
La mente relazionale: Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, terza edizione
di Elisa Ginanneschi (Cultura Emotiva, 15 Novembre 2021)
- [Foto] Copertina e scheda del libro di Daniel J. Siegel
La terza edizione de La mente relazionale, edita Raffaello Cortina, rivista e ampliata per accogliere i principali progressi in campo neurobiologico, definisce due ambiti principali di informazione: a un primo livello viene proposta una nuova visione interdisciplinare delle conoscenze assodate; a un livello successivo, all’interno della stessa cornice teorica, vengono tratte implicazioni concettuali, formulate nuove ipotesi e affrontate nuove tematiche, per esempio l’esperienza di appartenenza e lo sviluppo dell’identità. Corredato da una bibliografia ricchissima di oltre mille voci, questo testo, scritto da un magistrale Daniel Siegel, si presenta come un manuale atto a coinvolgere neurobiologia e campo relazionale, scandito da esempi tratti dalla pratica clinica e dalla vita quotidiana.
Il libro si propone di mostrare come il tentativo di costruire relazioni più profonde, con gli altri e con la propria esperienza interiore, promuova l’integrazione sia di processi interni che interpersonali: percorso che è alla base del benessere psicologico e della resilienza.
- In altre parole, le connessioni umane plasmerebbero lo sviluppo delle connessioni nervose che danno origine alla mente: relazioni interpersonali e collegamenti neurali danno insieme origine a quest’unica entità che è molto più della somma delle sue parti.
La mente però è anche un flusso di informazioni che rappresenta sotto forma di pattern di eccitazione neuronale, corrispondenti ai simboli mentali. Si pensa che ognuna di queste forme di rappresentazioni comporti il coinvolgimento di circuiti cerebrali diversi; i vari sistemi possono lavorare indipendentemente, oppure interagire in maniera simultanea: quando pensiamo a un avvenimento del nostro passato, per esempio, possiamo evocare rappresentazioni complesse che comprendono sensazioni, percezioni, idee e simboli linguistici.
I rapporti interpersonali possono facilitare o inibire questa tendenza a integrare le rappresentazioni delle nostre diverse esperienze, e le relazioni che caratterizzano i nostri primi anni di vita possono avere un ruolo fondamentale nel plasmare le strutture di base che ci permettono di avere una visione coerente del mondo:
- le esperienze interpersonali influenzerebbero direttamente, in quest’ottica, le modalità con cui ricostruiamo mentalmente la realtà. Lo sviluppo delle strutture e delle funzioni cerebrali dipende infatti dalle modalità con cui le esperienze, specialmente quelle interpersonali, influenzano i programmi di maturazione geneticamente determinati del sistema nervoso.
L’approccio del testo si presenta come piuttosto innovativo: esso considera infatti i processi mentali, corporei e relazionali come fenomeni che coinvolgono pattern di flussi di energia e di informazioni, che consentono di riunire in maniera efficace i dati della scienza con la natura soggettiva della vita umana.
Il libro si apre partendo da una digressione anatomica delle strutture cerebrali, al fine di creare un quadro iniziale di conoscenze comuni che sono alla base di quelle che l’Autore, Daniel J. Siegel, definisce “triangolo dell’esperienza umana”, composto da mente, relazioni e cervello incorporato o incarnato, ovvero il meccanismo dei nostri flussi di energia e di informazioni.
Segue poi un capitolo dedicato agli stati della mente, definiti come organizzazione di processi mentali differenti, che in un dato momento consentono il collegamento fra attività cerebrali diverse.
Nel terzo capitolo, trattante la memoria e la narrazione, vengono riassunte le conoscenze inerenti le diverse forme mnestiche, le quali ci aiutano a comprendere come le esperienze dell’infanzia giochino un ruolo importante nel determinare sia ciò che ricordiamo che le modalità con cui revochiamo gli eventi passati e costruiamo il racconto della nostra vita.
Si passa poi alla trattazione della tematica dell’attaccamento nei bambini e degli adulti, al tema delle emozioni - ingredienti fondamentali delle esperienze di attaccamento sicuro - come aspetto cardine sia nell’evoluzione dell’identità e delle funzioni mentali del bambino che nelle relazioni interpersonali dell’età adulta.
Il processo di attribuzione dei significati e le relazioni interpersonali sembrano infatti essere mediate dalle stesse reti neurali responsabili dei processi emozionali, indi per cui le emozioni possono essere viste come processi integrativi che collegano i mondi interni e interpersonali della mente umana.
Da qui si passa poi all’analisi dei meccanismi coinvolti nella creazione delle rappresentazioni - o simboli mentali - delle esperienze e la costruzione della realtà. In tal senso, le nostre esperienze interne, mediate da emozioni, stati della mente e relazioni interpersonali, contribuiscono a plasmare i modi in cui questi processi rappresentazionali si sviluppano.
L’operazione di costruzione, spesso inconsapevole, di categorie e concetti, può tradursi infatti in simboli linguistici, i quali svolgono la funzione di rappresentazioni di conoscenze sul nostro mondo costruito socialmente e che vengono poi frequentemente condivise con gli altri.
Le rappresentazioni possono quindi agire da filtro della nostra esperienza, plasmando le proprie convinzioni sulla realtà e persino influenzando la percezione del reale.
Il capitolo 7 è invece incentrato sul processo di regolazione - o autoregolazione - e coerenza: tramite la regolazione emotiva è reso possibile l’emergere di stati integrati, che sono alla base di un funzionamento coerente. Essa si sviluppa inizialmente nell’ambito di esperienze interpersonali infantili, che conducono all’acquisizione di capacità auto-organizzative.
Il capitolo 8 esplora invece la natura delle connessioni fra le menti, in particolare il legame fra connessioni interpersonali e mente relazionale. La regolazione personale è infatti collegata all’interazione del Sé con altre persone. Questo ci aiuta a comprendere come le relazioni interpersonali possano continuare a promuovere il benessere emotivo durante tutta la nostra vita e come giungiamo a conoscere “noi stessi”.
Il capitolo successivo è dedicato all’integrazione interiore e relazionale: la mente realizza un senso di coerenza collegando gli stati della mente nel tempo, che forniscono un senso di continuità al Sé. Varie forme di disfunzione mentale possono in tal senso essere considerate il risultato di compromissioni dell’integrazione, che generano un senso di caos o di rigidità.
L’ultimo capitolo si sofferma infine sui MOI (Me + Noi) e sull’integrazione dell’identità. Attraverso l’analisi dell’importanza dell’esperienza di appartenenza e del suo rapporto col senso di identità, vengono presi in esame l’integrazione fra processi interiori e relazionali alla base del senso di identità e approfondite le implicazioni corrispondenti per il benessere personale, interpersonale, pubblico e planetario.
Il testo, seppur molto ampio e trattante tematiche complesse alla base della neurobiologia relazionale, è in realtà corredato da un lessico piuttosto semplice, che lo rende scorrevole e comprensibile.
L’idea alla base dei vari temi trattati ed esposti nel libro, poi riassunta nel titolo, è la seguente: le esperienze sociali possono plasmare direttamente la nostra architettura mentale, ponendosi dunque come passaggio fondamentale nella formazione della nostra mente, della nostra capacità di regolazione emotiva e perfino nella costruzione della nostra identità.
- Tale processo interattivo ci forgia e ci influenza per tutta la vita.
Perciò, per affrontare adeguatamente alcune delle sfide che ci si presentano e che si inseriscono nella nostra epoca contemporanea, potrebbe rivelarsi indispensabile trovare un modo di coltivare un senso integrato della nostra identità, che possa estendersi e divenire comunicativa con gli altri, con la comunità intesa in senso ampio e con la Terra tutta.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". - Platone, Alcibiade e la cura di sé (di Michel Foucault)20 dicembre 2021, di Federico La Sala
Alcibiade e la cura di sé
di Michel Foucault
Il principio che bisogna «occuparsi di se stessi» ha ricevuto la sua prima elaborazione filosofica nell’Alcibiade di Platone.
Come sappiamo, i commentatori esitano sulla data da proporre per questo dialogo. Alcuni elementi spingono a vedervi un testo della giovinezza di Platone: il genere di personaggi che vi partecipano, il tipo di interrogazione e la lentezza del dialogo, molti dei temi affrontati. Ma altri elementi invece richiamerebbero a una datazione più tarda: e in particolare la conclusione molto «metafisica» del dialogo, a proposito della contemplazione di sé nell’essenza divina. Lasciamo da parte questo dibattito, che non è di mia competenza.
E manteniamo solo la soluzione suggerita dai neoplatonici. È interessante per il senso che la tradizione antica attribuiva a questo dialogo e per l’importanza che dava al tema della «cura di sé». Albino, un autore del II secolo, diceva che ogni uomo «naturalmente dotato» e «giunto all’età di filosofare», se voleva tenersi al riparo dalle agitazioni politiche e praticare la virtù, doveva cominciare con lo studio dell’Alcibiade; e ciò al fine di «rivolgersi verso se stesso» e di determinare quale deve essere «l’oggetto delle sue cure». Più tardi, Proclo diceva che questo testo doveva essere considerato come «arkhe apases philosophias», principio e cominciamento di tutta la filosofia. Olimpiodoro, paragonando l’insieme del pensiero platonico a un recinto sacro, faceva dell’Alcibiade i «propilei» del tempio, il cui aduton sarebbe stato il Parmenide.
Non ho intenzione di studiare nel dettaglio questo testo. Vorrei semplicemente delineare alcuni tratti principali della nozione di epimeleia heautou che ne costituisce il fulcro.
1) Come la questione viene condotta nel dialogo?
Viene condotta dal progetto di Alcibiade di intraprendere la sua vita pubblica; più precisamente, «di prendere la parola di fronte al popolo», di prevalere su Pericle e diventare onnipotente nella città.
Nel momento in cui Socrate avvicina Alcibiade e lo invita alla cura di sé, quest’ultimo si trova in un punto di passaggio. Punto di passaggio tradizionale per ogni giovane aristocratico ateniese. Ma questo passaggio, Alcibiade vuole effettuarlo in una maniera molto particolare: non vuole accontentarsi dei privilegi che gli danno la sua nascita, la sua fortuna, il suo status; lo dice esplicitamente: non vuole «passare la sua vita» ad approfittare di tutto ciò. Vuole prevalere sugli altri all’interno della città; e vuole anche prevalere, esternamente, sui re di Sparta e sul sovrano persiano; questi ultimi per lui non sono semplicemente i nemici della sua patria, ma i suoi rivali personali.
Ora, Alcibiade si trova in [un] punto di passaggio anche dal punto di vista erotico: durante la sua adolescenza era desiderabile e aveva numerosi pretendenti; ma è giunto all’età in cui gli spunta la barba e in cui gli amanti si separano da lui. Quando era ancora nello splendore della sua bellezza aveva respinto tutti quelli che lo corteggiavano, non volendo loro «cedere» e cercando di rimanere «il più forte» (l’ambivalenza tra il vocabolario politico e il vocabolario erotico, che è costante in greco, qui è essenziale). Ma ecco che Socrate si presenta e che, senza interessarsi al corpo di Alcibiade, riesce laddove tutti gli altri hanno fallito; mostrerà ad Alcibiade di essere più forte di lui; lo porterà a «cedere», ma in tutt’altro senso.
La questione della cura di sé apparirà nel punto di intersezione tra una particolare ambizione politica nel giovane uomo (un’ambizione personale) e un particolare tipo di amore nel maestro (un amore filosofico).
2) Perché Alcibiade deve prendersi cura di sé?
Socrate interroga Alcibiade sui mezzi della sua ambizione. Sa forse cosa significa ben governare? Sa forse che cos’è il «giusto»? O la «concordia» nella città? Egli ignora tutto ciò, e si scopre incapace di rispondere (tutte queste interrogazioni sono familiari nei primi dialoghi platonici). Ma c’è anche un’altra argomentazione, che completa la prima. Che Alcibiade si confronti con quelli che saranno i suoi rivali al di fuori della città. I re di Sparta ricevono un’educazione molto accurata, che insegna loro le virtù indispensabili. Quanto al futuro re di Persia, egli viene affidato, fin dall’età di quattordici anni, a quattro pedagoghi, che gli insegnano: uno la saggezza, l’altro la giustizia, il terzo la temperanza, il quarto il coraggio. Ora lui, Alcibiade, che educazione ha ricevuto? È stato affidato a un vecchio schiavo ignorante, e il suo tutore, Pericle, non è stato nemmeno capace di educare convenientemente i propri figli.
Per prevalere sui suoi rivali, Alcibiade dovrebbe quindi acquisire una techne, un saper-fare; vi si dovrebbe applicare - epimeleisthai. Ma, come abbiamo visto: egli non sa nemmeno a cosa dovrebbe applicarsi, perché ignora cosa sia la giustizia, la concordia, il buongoverno. Alcibiade si trova dunque nel più grande imbarazzo. Si dispera. Ma interviene Socrate, e gli dice questa cosa importante: se tu avessi cinquant’anni, la situazione sarebbe grave, allora sarebbe troppo tardi per «occuparti di te stesso».
È questa la prima occorrenza dell’espressione nel dialogo. E vediamo che il principio di doversi prendere cura di sé è legato molto direttamente a un difetto della pedagogia, così come a un momento favorevole della vita, a quel momento di passaggio di cui si parlava poco fa; dopo sarebbe troppo tardi.
3) In cosa consiste questa cura di sé?
Tutta la seconda parte del dialogo è dedicata a rispondere a questa domanda. O piuttosto, ai due problemi che la questione pone: 1) che cos’è questo «sé» di cui ci si deve occupare; 2) in cosa consiste l’attività dell’«occuparsene»?
Passerò velocemente sulla lunga discussione che permette di rispondere alla prima domanda. Il sé di cui ci si deve occupare, non sono evidentemente le cose che possiamo possedere, come i nostri beni, i nostri vestiti, i nostri attrezzi; e forse non è nemmeno il nostro corpo, di cui si occupano il medico o il ginnasiarca (vediamo che qui si tratta di distinguere correttamente quella che Socrate vuole indicare come la vera cura di sé dalle forme a cui era abitualmente associata: l’attività economica, la pratica medica). Ciò di cui dobbiamo occuparci è il principio che si serve dei nostri beni, dei nostri attrezzi, del nostro corpo: e cioè l’anima.
Quanto alla maniera di occuparsene, tutto il finale del dialogo è dedicato alla sua definizione. E lo fa attraverso un ragionamento che merita di essere sottolineato. Per sapere in che modo occuparsi della propria anima, bisogna conoscerla. Ora, affinché essa possa conoscersi, bisogna che possa guardarsi in uno specchio che sia della sua stessa natura, cioè nell’elemento divino. Ed è in questa contemplazione che l’anima potrà, occupandosi di se stessa, ritrovare i princìpi e le essenze che possono fondare un’azione giusta e fornire le regole di un’azione politica.
Ci sono molte ragioni per cui questo passaggio merita di essere sottolineato. Innanzitutto perché manifesta molto chiaramente i colori di un platonismo tardo. Ma anche per un’altra ragione, che vorrei soprattutto osservare: il fatto che la cura di sé in qualche modo si trova interamente assorbita e riassorbita nella conoscenza di sé. Conoscere se stessi è condizione necessaria e sufficiente per occuparsi di sé. Durante tutto il dialogo, il principio della cura di sé, che era il tema principale della discussione, ha gravitato attorno al precetto delfico di conoscere se stessi. A più riprese, in maniera diretta o indiretta, lo gnothi seauton era stato menzionato accanto alla epimele [seauto]. Ma come vediamo bene: alla fine del dialogo è il «conosci te stesso» a occupare tutto lo spazio aperto dal principio che ci si dovrebbe prendere cura di sé.
Mi sono soffermato un po’ su questo testo, mentre la maggior parte dei documenti che studierò in seguito sono molto più tardi, perché mi sembra faccia apparire chiaramente molti dei problemi fondamentali che in seguito ritroveremo nella storia della cura di sé: le soluzioni apportate saranno spesso diverse da quelle fornite nell’Alcibiade, ma i problemi rimarranno:
 Problema del rapporto tra cura di sé e attività politica. Socrate chiedeva ad Alcibiade di occuparsi di se stesso nella misura in cui pretendeva di occuparsi degli altri e dirigerli. In seguito la questione si presenterà più spesso, e in particolare sotto l’Impero, in forma di alternativa: non è meglio allontanarsi dall’attività politica per prendersi cura di sé?
Problema del rapporto tra cura di sé e attività politica. Socrate chiedeva ad Alcibiade di occuparsi di se stesso nella misura in cui pretendeva di occuparsi degli altri e dirigerli. In seguito la questione si presenterà più spesso, e in particolare sotto l’Impero, in forma di alternativa: non è meglio allontanarsi dall’attività politica per prendersi cura di sé? Problema del rapporto tra cura di sé e pedagogia. Occuparsi di se stessi, nell’intenzione di Socrate, si presenta come un dovere per il giovane uomo che ha avuto una formazione insufficiente. In seguito, occuparsi di se stessi apparirà piuttosto come un dovere da adulto - un dovere da perseguire per tutta la vita.
Problema del rapporto tra cura di sé e pedagogia. Occuparsi di se stessi, nell’intenzione di Socrate, si presenta come un dovere per il giovane uomo che ha avuto una formazione insufficiente. In seguito, occuparsi di se stessi apparirà piuttosto come un dovere da adulto - un dovere da perseguire per tutta la vita. Problema del rapporto tra cura di sé e conoscenza di sé. Abbiamo visto il privilegio accordato dal Socrate di Platone allo gnothi seauton, e questo privilegio sarà uno dei tratti caratteristici di tutti i movimenti platonici. Senza che il principio di conoscere se stessi sia mai stato respinto, pare proprio che la cura di sé nella filosofia ellenistica e greco-romana abbia assunto una certa autonomia, forse anche un certo privilegio in rapporto alla conoscenza di sé: in ogni caso, capita spesso che l’accento filosofico sia posto sulla cura di sé - la conoscenza di sé non essendo altro che uno strumento, che un metodo per prendersi cura di sé come si deve.
Problema del rapporto tra cura di sé e conoscenza di sé. Abbiamo visto il privilegio accordato dal Socrate di Platone allo gnothi seauton, e questo privilegio sarà uno dei tratti caratteristici di tutti i movimenti platonici. Senza che il principio di conoscere se stessi sia mai stato respinto, pare proprio che la cura di sé nella filosofia ellenistica e greco-romana abbia assunto una certa autonomia, forse anche un certo privilegio in rapporto alla conoscenza di sé: in ogni caso, capita spesso che l’accento filosofico sia posto sulla cura di sé - la conoscenza di sé non essendo altro che uno strumento, che un metodo per prendersi cura di sé come si deve.* Fonte: Michel Foucault, Dir vero su se stessi, Orthotes 2020
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA" -- ALLE ORIGINI DELLA PSICOANALISI: USCIRE DALLA CLAUSTROFILIA. Note a margine del poema "quattro" di Italo Testa.9 settembre 2021, di Federico La Sala
POESIA E ANTROPOLOGIA. CAMBIAMENTO "CLIMATICO": IL PUNTO DI SVOLTA...
Note a margine del poema ("quattro") di Italo Testa:
- "Quattro in una stanza. Tre estati. Due extraterrestri. Un poema continuo. Se un giorno, un’invasione dallo spazio, due corpi caduti nel tempo, quattro occhi a vegliare nel buio. Inizia la vita bigemina .... " - un progetto parallelo di Italo Testa, nella collana Croma K delle edizioni Oèdipus." (Italo Testa, "quattro", Le parole e le cose, cit.).
CI SONO TUTTI GLI ELEMENTI. Riaffioramenti di antiche vie di ricerca antropologica e psicoanalitica. Nel lontano gennaio del 1898, il giorno QUATTRO, Sigmund Freud così scriveva al suo amico, il dr. Wilhelm Fliess: «Ho cominciato a considerare con attenzione il concetto di bisessualità e considero la tua idea in proposito come la più significativa per il mio lavoro, dopo quella di "difesa"». Il programma di Kant è messo all’ordine del giorno? O no?! Boh..... Federico La Sala
- P. S. - FILOSOFIA PSICOANALISI E RELATIVITÀ.
Riprendere il filo dal "quattro" di Italo Testa, ripartendo dalla lettera di Freud a Fliess del "quattro" gennaio del 1898, con il richiamo al programma di Kant, vuol essere un’indicazione di lavoro di "filosofia a venire" (J.-L. Nancy), al di là dei "Quattro" di Heidegger (cfr. "In cammino verso il Linguaggio": il commento a "Una sera d’inverno" di Georg Trakl), accogliendo il contributo di Elvio Fachinelli, una sollecitazione a ri-pensare il "nexologico" rapporto tra soggetto-oggetto, tra realtà-realtà (esterna) e realtà psichica, e venir fuori con Freud dall’orizzonte dialettico hegeliano e lacaniano!
Qualche giorno fa, sul filo di una ri-segnalazione di un libro dello psicoanalista Christopher Bollas, ("Se il sole esplode. L’enigma della schizofrenia", 2016), non a caso, parlavo di una OTTIMA SEGNALAZIONE che sollecita non solo a leggere e rileggere le opere del brillantissimo Christofer Bollas, ma anche a ricordare uno dei primi psicoanalisti, appunto Fachinelli, che ha messo a fuoco il nodo della "coppia freudiana" (cf. Pietro Barbetta, "Prenderli al volo prima che precipitino, 22 Ottobre 2016") e su cui (a mio parere) ancora c’è da riflettere (FACHINELLI E FREUD NELLA NAVE DI GALILEI : LA CONVERSAZIONE CONOSCITIVA...). O no?! Federico La Sala
- P. S. 2 - ALLE ORIGINI DELLA PSICOANALISI.
PSICHIATRIA, ARCHEOLOGIA DELLE SCIENZEUMANE, E CREATIVITÀ! Prima di scrivere RELATIVITÀ, nella nota precedente, avevo scritto ARCHEOLOGIA ma, volendo e dovendo dare giusto rilievo alla portata rivoluzionaria del "primo principio della dinamica" e ricordare la relatività di Galilei, ho sostituito l’uno con l’altro. Ora, un ricordo-commento ’veloce’ di un’amica ha favorito la sovrapposizione del titolo dell’opera di Michel Foucault ("Le parole e le cose. Archeologia delle scienze umane") per dire del titolo dell’opera di John L. Austin ("Come fare cose con le parole") e ha "riportato" il "racconto" al punto da dove il filo è partito: il legame tra il "quattro", il progetto di Italo Testa, la rivista elettronica "Le parole e le cose", ove il testo è apparso, e il quattro gennaio 1898, il giorno dell’invio della lettera di Sigmund Freud a Wilhelm Fliess: all’origine stessa della psicoanalisi. Che dire? Due passi avanti e uno indietro, per saltare meglio... “quattro”! Federico La Sala
- P. S. 3.: POESIA, ALCHIMIA E PSICOANALISI: "CINQUE"! PER FESTEGGIARE NON SOLO "QUATTRO" MA ANCHE "LE PAROLE E LE COSE"...
ARCHEOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE. SICCOME ITALO TESTA ha "rotto le acque" e, finalmente, in "quattro" e "quattro" (otto, la "gravidanza" è partita intorno al 2013), ha portato alla luce il suo poema (Oèdipus, 2021) e ha osato mettere il dito nella piaga, che non è solo una piaga, ma anche una "finestra" su un altro mondo ( per chi è incredulo, Caravaggio "in-segna"),
PER FESTEGGIARE al meglio l’evento (che coincide anche con i DIECI ANNI di "Le Parole e Le Cose"!) e sottolineare il "sorprendente" valore della sua ricerca poetica e antropologica, mi sia lecito,
CONSIGLIO di riconsiderare, alla luce del tempo pandemico presente che ha indotto e prodotto un gigantesco ed epocale lockdown (un confinamento esteso e prolungato, come di una "analisi interminabile"), i «rituali» nella «Wunderkammer» psicoanalitica (cfr. l’ intervista: "Sanguineti incontra Sigmund Freud" del 1974, in "Le interviste impossibili. Ottantadue incontri d’autore messi in onda da radio Rai", Donzelli 2006), e
INVITO a riandare (ancora e di nuovo) non solo "alle origini della psicoanalisi" (e alle discussioni tra Freud e Fliess: in particolare, al "quattro" gennaio 1898), ma anche a riprendere le indicazioni di sul tema ("La Freccia Ferma", 1979; "Claustrofilia", 1983) e cercare di venir fuori dall’orizzonte della città di Edipo.
Dalla città di Dite?! Sì!
In “quattro”, dal labirinto claustrofilico uscire si può.
DANTE 2021! Dante e Virgilio ce l’hanno fatta (Inf. XXXIV, 90) e hanno visto Lucifero a gambe all’aria! Federico La Sala
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- ITINERARI CRITICI: «PERFORMANCE STUDIES». «Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista». Un libro di Ilenia Caleo (di Giovanna Ferrara)7 settembre 2021, di Federico La Sala
Per pensare il vivente il «metodo» è l’amore
ITINERARI CRITICI. «Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista», di Ilenia Caleo per Bulzoni. Dagli studi postcoloniali alla filosofia poststrutturalista, dalle rinnovate riflessioni sul teatro ai femminismi plurali, fuori dai comuni steccati disciplinari
di Giovanna Ferrara (il manifesto, 04.09.2021)
- «Kiss» di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo a Santarcangelo (2019) foto di Sara Lorusso
Quello che è stato scritto è un continente di domande ed esperienze, nel rifiuto dei recinti. Di un andare nel mondo implacabile e ostinato. È la storia unica di intensità diverse (arte e filosofia, teatro e femminismi) che nell’attivismo politico hanno interagito liberandosi della menzogna burocratica delle settorialità di interesse. Il volume di Ilenia Caleo, Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista (Bulzoni editore, pp. 228, euro 20) abita lo spiano di una verità incarnata: tutto è politico e il politico è continua intersezione. La contiguità come metodo, e gli affetti come strada, sono il responso oracolare di questo lavoro, che abbatte tutto quello che interrompe la molteplicità dell’orizzonte: dal margine si vede meglio. Che non può esserci separazione se si intende confezionare uno stare nella vita libero e germogliativo, rispettoso della sua inevitabile irriducibilità.
NON È UN CASO che lo smontaggio degli steccati cominci a partire dalla riflessione sul corpo, massacrato dalla dualità soffocante in cui lo ha respinto chi lo oppone al pensiero. Che idiozia è stato ignorare che il concetto nasce anche da quello che sento quando tocco o quando vengo toccato, dallo spazio che abito a quello che subisco. «Pensare è sempre pensare per concetti, oppure per funzioni, oppure per sensazioni», ci avvertiva Deleuze, dialogando naturalmente con il rifiuto marxista del tranello messianico e di quello accumulativo, entrambi orchestrati per togliere «valore» all’immanenza della vita. Ma di questi avvertimenti la produzione teorica insorgente, il lavoro nelle accademie, quello più ampiamente cognitivo, ne ha tenuto conto?
I «PERFORMANCE STUDIES», di cui Caleo dà conto in maniera ragionata e ampia, superano questa domanda, cosi come fanno i femminismi afroamericani e lesbici, così come le pratiche attoriali che pensano mentre si danno, così come le occupazioni politiche che non sono di nessun mestiere ma di tutti. In questo la performance come centro di pensiero (del corpo, del movimento) ci abitua all’idea che qualsiasi lingua è una lingua straniera, che la conoscenza è esplorazione di altri, che il sapere «immobile» non è altro che il soprammobile sul comò di un passato mummificato.
Grande e soddisfacente è la lettura di un testo quando sa aprire i battenti e fa circolare correnti. Dagli studi postcoloniali alla filosofia poststrutturalista, dalle rinnovate riflessioni sul teatro ai femminismi plurali, ci sentiamo di essere dentro il crocevia dei diversi piani del vivente, lì dove solo si può trovare la leva da agire per avere un mondo nuovo, senza confini concettuali, senza recinzioni da identità fisse. Sembra che scorrendo le pagine l’intuizione della «intersezione» si faccia esistenziale, pratica continua di liberazione. Ogni pagina un vestito in meno, una struttura in meno, una oppressione in meno.
I generi non esistono come agenti isolanti dagli altri tratti che ci riguardano; i diritti non sono mai da pensarsi come scatole chiuse. Sono membrane aperte ad accogliere il non ancora arrivato così come ce la raccontava Rodotà, il giurista stellare che non dava alcuna dignità all’inattaccabile fossato che hanno scavato per dividere la legge dalla non legge, rifiutando la mobilità intrinsecamente permeabile della giustizia.
Viste così le occupazioni smettono di essere anomalie da correggere, le fluidità di genere novità eccentriche, le arti non sono riserve indiane, noi smettiamo di essere un noi pieno di fibrosi che producono impossibilità all’espansione. Tutto questo c’è, ad esempio, nel disorientamento innestato dallo spettacolo di Xavier Le Roy, descritto da Ilenia Caleo come evidenza della sua tesi che l’arte non oggettivizza un pensiero, ma lo «pensa». In quella performance smette di esistere il sopra e il sotto, non c’è lato: il disorientamento fa splendere una nuova riterritorializzazione che non ha niente di automatico e a cui nessuno può dettare regole.
ALLA MANIERA di certi architetti che rifiutano di vivere il passato come feticcio e la teoria come mondo altro, Caleo ci fa stare di continuo sulle soglie di un futuro impellente. E prosegue cambiando sempre il passo, come quando dalla sua prismatica esperienza di esistente (ricercatrice, artista, performer e militante) passa alla trattazione storiografica di come sono state rielaborate le esclusioni del femminile dai dispostivi maggioritari del sapere. Una cartografia dei femminismi, completa di cadute e resurrezioni. Un libro affettivo, infine. Che ragiona su quel manuale di felicità che ci ha regalato Spinoza. E che per questo abbatte anche quella divisione tra pubblico e privato che troppo spesso è stato il burrone dove andavano a finire i nostri sogni. Un libro sull’amore, amore-metodo, amore-soggetto, amore-oggetto. Amore ovunque.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- ALL’ORIGINE DELLA PSICOANALISI: ARCHEOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE E CAMBIAMENTO "CLIMATICO". Un poema continuo - "quattro": un progetto parallelo di Italo Testa. Note a margine.6 settembre 2021, di Federico La Sala
POESIA E ANTROPOLOGIA. CAMBIAMENTO “CLIMATICO”. IL PUNTO DI SVOLTA...
- “Quattro in una stanza. Tre estati. Due extraterrestri. Un poema continuo. Se un giorno, un’invasione dallo spazio, due corpi caduti nel tempo, quattro occhi a vegliare nel buio. Inizia la vita bigemina .... ” - un progetto parallelo di Italo Testa, nella collana Croma K delle edizioni Oèdipus.” (Italo Testa, "quattro", Le parole e le cose, 3 settembre 2021).
CI SONO TUTTI GLI ELEMENTI. Riaffioramenti di antiche vie di ricerca antropologica e psicoanalitica . Nel lontano gennaio del 1898, il giorno QUATTRO, Sigmund Freud così scriveva al suo amico, il dr. Wilhelm Fliess: «Ho cominciato a considerare con attenzione il concetto di bisessualità e considero la tua idea in proposito come la più significativa per il mio lavoro, dopo quella di “difesa”». Il programma di Kant è messo all’ordine del giorno? O no?! Boh.....
P. S. IN CAMMINO VERSO IL LINGUAGGIO.
FILOSOFIA, PSICOANALISI, E RELATIVITÀ. Riprendere il filo dal “quattro” di Italo Testa, ripartendo dalla lettera di Freud a Fliess del “quattro” gennaio del 1898, con il richiamo al programma di Kant, vuol essere un’indicazione di lavoro di “filosofia a venire” (J.-L. Nancy), al di là dei “Quattro” di Heidegger (cfr. “In cammino verso il Linguaggio”: il commento a “Una sera d’inverno” di Georg Trakl), accogliendo il contributo di Elvio Fachinelli, una sollecitazione a ri-pensare il “nexologico” rapporto tra soggetto-oggetto, tra realtà-realtà (esterna) e realtà psichica, e venir fuori con Freud dall’orizzonte dialettico hegeliano e lacaniano!
Qualche giorno fa, sul filo di una ri-segnalazione di un libro dello psicoanalista Christopher Bollas, (“Se il sole esplode. L’enigma della schizofrenia”, 2016), non a caso, parlavo di una OTTIMA SEGNALAZIONE che sollecita non solo a leggere e rileggere le opere del brillantissimo Christofer Bollas, ma anche a ricordare uno dei primi psicoanalisti, appunto Fachinelli, che ha messo a fuoco il nodo della “coppia freudiana” (cf. Pietro Barbetta, ”Prenderli al volo prima che precipitino”) e su cui (a mio parere) ancora c’è da riflettere (FACHINELLI E FREUD NELLA NAVE DI GALILEI: LA CONVERSAZIONE CONOSCITIVA...). O no?!
P. S. 2 - ALLE ORIGINI DELLA PSICOANALISI. Non c’è che dire: ripartire da "quattro"!
PSICHIATRIA, ARCHEOLOGIA DELLE SCIENZEUMANE, E CREATIVITÀ! Prima di scrivere RELATIVITÀ, nella nota precedente, avevo scritto ARCHEOLOGIA ma, volendo e dovendo dare giusto rilievo alla portata rivoluzionaria del "primo principio della dinamica" e ricordare la relatività di Galilei, ho sostituito l’uno con l’altro. Ora, un ricordo-commento ’veloce’ di un’amica ha favorito la sovrapposizione del titolo dell’opera di Michel Foucault ("Le parole e le cose. Archeologia delle scienze umane") per dire del titolo dell’opera di John L. Austin ("Come fare cose con le parole") e ha "riportato" il "racconto" al punto da dove il filo è partito: il legame tra il "quattro", il progetto di Italo Testa, la rivista elettronica "Le parole e le cose", ove il testo è apparso, e il quattro gennaio 1898, il giorno dell’invio della lettera di Sigmund Freud a Wilhelm Fliess: all’origine stessa della psicoanalisi. Che dire? Due passi avanti e uno indietro, per saltare meglio... “quattro”!
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. NECESSITÀ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA" --- LA RISCOPERTA DEL CORPO: JEAN-LUC NANCY, O DELLA PRESENZA (di Chiara Cappelletto).2 settembre 2021, di Federico La Sala
LA RISCOPERTA DEL CORPO E LA NECESSITÀ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA" .... *
- (KANT, FEUERBACH, E) NIETZSCHE: "Ben prima che le teorie dell’embodiment andassero per la maggiore[1] e autorevoli neuroscienziati stabilissero che Cartesio aveva avuto torto[2], Nancy ricordava che era stato Nietzsche a introdurre il corpo nella filosofia contemporanea, e che l’idea dell’ego sum da cui seguirà l’“ideologia psichica” esiste solo perché, prima, anima e corpo coesistono e si sentono" (Chiara Cappelletto, "Jean-Luc Nancy, o della presenza", Le parole e le cose, 1 Settembre 2021).
JEAN-LUC NANCY, O DELLA PRESENZA
di Chiara Cappelletto (Le parole e le cose, 1 Settembre 2021)
Il primo libro di Jean-Luc Nancy che ho incontrato era tradotto in inglese e collocato accanto a manuali di auto-aiuto nello scaffale di teologia di una libreria di New York nel 1999: The Birth of Presence. Scriveva nell’introduzione che forse è vero che i francesi sono filologi sciatti, ma “you sometimes have to take books out of libraries, and sentences out of books”. Lo presi, divertita. Ero una studentessa di filosofia alla Statale di Milano e non avevo la minima idea di chi fosse quell’autore, ma dopo anni di filosofia italiana paludata, ex-cattedra, e piuttosto ombelicale, fu per me, come sarebbe stato per molti, l’incontro con un pensiero che non aveva alcuna voglia di essere “debole” o “meta”. Capii poi che non poteva esserci modo migliore di scoprirlo che leggendolo in lingua straniera in un paese straniero.
Avrei conosciuto Nancy nel 2001, a Venezia, in occasione di una sua lezione sul cristianesimo all’Istituto Gramsci Veneto preceduta da una conferenza su La filosofia a venire a “Fondamenta”, il festival ideato da Daniele Del Giudice. Ben prima che le teorie dell’embodiment andassero per la maggiore[1] e autorevoli neuroscienziati stabilissero che Cartesio aveva avuto torto[2], Nancy ricordava che era stato Nietzsche a introdurre il corpo nella filosofia contemporanea, e che l’idea dell’ego sum da cui seguirà l’“ideologia psichica” esiste solo perché, prima, anima e corpo coesistono e si sentono. Voleva, dichiaratamente, salvare Cartesio dal peccato di dualismo, e per farlo ricordava la sua corrispondenza epistolare con Elisabetta di Boemia in cui abbondano tossi e raffreddori, e sottolineava la potenza teoretica della vita ordinaria da cui impariamo come siamo estranei a noi stessi e capaci di essere noi stessi solo in virtù di una tale inappropiabilità.
Non erano mere questioni di merito, né si trattava di mediare l’evidenza dell’esperienza diretta con l’autorevole impersonalità del discorso astratto, o di trasformare il vissuto della sua malattia in oggetto teorico. Tanto meno si trattava di scrivere una biografia filosofica. Al contrario, non avremmo letto del trapianto e del cancro in Corpus o ne L’intruso, libri tanto espliciti quanto pudichi, se prima Nancy non avesse scelto di concentrarsi sulla tensione tra corpo vivo, soggetto e mondo. Ne andava per lui della possibilità per la filosofia di rappresentare la relazione dell’uomo con se stesso e con gli altri, insieme alla sua vulnerabilità, e di farlo senza diventare un discorso ancillare della scienza e della tecnica, al più capace di critica ma certo non di indirizzo. In questo Nancy era un filosofo del Novecento che ha ben visto come quella possibilità fosse chiaramente finita, e ha detto e spiegato questa fine, convinto che i nostri post- e trans- umanismi siano fughe dal compito storico del pensiero fondante dell’Occidente. Era anche, soprattutto, un filosofo libero e amico, che sarebbe rimasto indifferente a quel che preme oggi agli instancabili professionisti del mestiere.
In una delle nostre prime conversazioni, quando scoprii che fare filosofia significava parlare con gioia e non poco divertimento di cose ultime e serissime per le quali la concentrazione era assoluta, mi raccontò che del suo nome lo disturbava molto la “u” di Jean-Luc, per la boccuccia che bisogna fare pronunciando una vocale così stretta. Mi è spesso tornato in mente quel momento, come una prova dell’autoironia divertita e divertente di un uomo quanto mai grande. E caro. Grande, gioioso, gentile e capace di stupore l’ho conosciuto negli anni in cui i postumi della malattia lo accompagnavano; molte cose gli erano e gli sarebbero state difficili, ma mai essere all’ascolto, restare in contatto.
Così l’ho ritrovato pochi mesi fa al convegno Thinking in Pandemic Times cui partecipava con una lectio magistralis dal titolo Etre soufflé. Era un po’ provato, disse, forse ammalato. Ragionava con calma e cura del fatto che di filosofia a venire non ce ne sarebbe davvero stata, perché “là, on change le stock génétique de notre civilisation,” affermando ancora una volta, fino alla fine, l’evidenza che corpo e pensiero, vita e teoria, sono insieme inassimilabili e in relazione.
Forse cogliendo in noi una smorfia di sconforto, provò a rassicurarci: “Aujourd’hui, il n’y a pas besoin de catastrophisme. Toutes les philosophies, les représentations respirent l’odeur acre de la bougie qu’on vient d’éteindre.” Ci salutammo, rimandando più lunghe conversazioni a quando sarebbe stato meglio. Non ci saranno. Rimangono, per tutti, i suoi libri, e rileggendoli mi accorgo ancora una volta di quanto grande sia il nostro debito nei suoi confronti. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo conserva il ricordo vivo dei molti modi in cui sapeva essere e restare presente.
Note
[1] A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher (a cura di), The Oxford Handbook of 4E cognition. Oxford University Press, Oxford 2018.
 [2] A. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, tr. it., Adelphi 1995.
[2] A. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, tr. it., Adelphi 1995.
*
NOTA A MARGINE:
CON J.-L. NANCY, OLTRE: SAPERE AUDE! (KANT - FOUCAULT, 1784/1984):
- "Ben prima che le teorie dell’embodiment andassero per la maggiore[1] e autorevoli neuroscienziati stabilissero che Cartesio aveva avuto torto[2], Nancy ricordava che era stato Nietzsche a introdurre il corpo nella filosofia contemporanea, e che l’idea dell’ego sum da cui seguirà l’“ideologia psichica” esiste solo perché, prima, anima e corpo coesistono e si sentono" (Chiara Cappelletto, cit., sopra).
Nel saggio "ETICA DEL CORRISPONDERE" (1997), J.-L. NANCY così scrive : "[...] L’uomo kantiano, di cui tutti siamo eredi, è, nel suo essere, responsabile di se stesso come di un fine infinito. [...] Il filo rosso che unisce, in questa prospettiva, tanti nomi così diversi è intrecciato con due elementi diversi: da una parte, prevale il motivo della responsabilità, dell’essere o dell’esistenza che vengono definiti mediante la responsabilità e, dall’altra, si ritrova il motivo della filosofia o del pensiero come responsabilità e come responsabilità «assoluta». L’intreccio di questi due motivi merita attenzione e permette di affinare l’analisi di Nietzsche [...]" (MicroMega, 25 agosto 2021) )..
Un capitolo - mi sia lecito - di un mio lavoro (cfr. Federico La Sala, "Della Terra, il brillante colore", Prefazione di Fulvio Papi, Roma-Salerno/Milano, 1996/2013, pp. 112-119), legato a un percorso di "riscoperta del corpo", così è intitolato: "IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITÀ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITÀ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
"CHE COSA È L’UOMO?": RIPRENDERE LA QUARTA DOMANDA DI KANT E PASSARE DALL’ORIZZONTE "ANDROLOGICO" (PLATONICO-HEGELIANO) A QUELLO ANTROPOLOGICO, NON È QUESTO IL PROBLEMA, OGGI?! O NO?
Federico La Sala
- (KANT, FEUERBACH, E) NIETZSCHE: "Ben prima che le teorie dell’embodiment andassero per la maggiore[1] e autorevoli neuroscienziati stabilissero che Cartesio aveva avuto torto[2], Nancy ricordava che era stato Nietzsche a introdurre il corpo nella filosofia contemporanea, e che l’idea dell’ego sum da cui seguirà l’“ideologia psichica” esiste solo perché, prima, anima e corpo coesistono e si sentono" (Chiara Cappelletto, "Jean-Luc Nancy, o della presenza", Le parole e le cose, 1 Settembre 2021).
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". ---SAPERE AUDE!: "DOCTA IGNORANTIA", "COINCIDENTIA OPPOSITORUM", E "MENSCHWERDUNG".19 aprile 2021, di Federico La Sala
#MENSCHWERDUNG.
ripartendo dal #saperedinonsapere,
Niccolò Cusano
ricade nella #antropologia zoppa e cieca di #Aristotele
e propone nella #Docta Ignorantia (III, 5) del 1440
la visione (#teoria) del trittico di Merode (1427)
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". --- «Che cosa è l’uomo?». È nostra la libertà più grande (di Luigino Bruni).7 giugno 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra /11.
È nostra la libertà più grande
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 6 giugno 2020)
- Chi sa se il deserto che lasceremo, un giorno, non avrà questa voce, questo lamento umano del vento, infinitamente ripetuto: mah-’enòsh? Che cos’è un uomo? Che cosa fu l’uomo? Che cosa è stato essere uomo?
- Guido Ceronetti, Il libro dei salmi.
«I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio» (Salmo 19,2-5). I cieli narrano. La Bibbia è tutta parola, è tutta narrazione; è custode della parola di Dio detta in parole umane. È gelosa sentinella di racconti straordinari e diversi, dove le parole sono state capaci di dire l’indicibile, farci sognare Dio fino a quasi vederlo.
La Bibbia ha amato e venerato la parola, al punto di rischiare di farla diventare un idolo, violando il divieto d’immagine e di idolatria contenuto tra le sue pagine. Uno dei dispositivi teologici e poetici che le ha consentito di non diventare l’idolo più grande e perfetto è la presenza in essa di linguaggi di Dio non verbali. Della gloria di Elohim parlano, infatti, anche i cieli, il firmamento, il sole, la notte. Non siamo solo noi umani a parlare di Dio, non siamo i soli affidatari e trasmettitori di messaggi divini. La Bibbia ci dice che ci sono meravigliosi racconti di Dio scritti senza parole umane. Dio ci parla con la bocca e con le parole dei profeti, ci ha scritto lettere d’amore con lo stilo dello scrittore sacro, ha composto canti stupendi con la poesia e la cetra di Davide. La Bibbia però sa che il linguaggio umano non è l’unica lingua usata nei colloqui tra Elohim e noi - -«Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce». Narrazioni più antiche di quelle umane, che hanno risuonato attraverso l’universo prima che vi arrivasse l’uomo, e che continuano oggi a risuonare nelle galassie infinite; a dirci che quelle narrazioni sono anche per noi, ma non sono soltanto per noi: non siamo l’unico senso della creazione. I loro racconti gli astri non li scrivono soltanto per noi. Qui l’umiltà e la grandezza dell’Adam si incontrano e si armonizzano.
Ma nel momento in cui la Bibbia testimonia le narrazioni delle stelle e le riconosce come linguaggio di Dio, anche quel linguaggio non-verbale diventa parola di uomo che narra la non-parola di Dio. E il Salmo diventa un incontro di narrazioni: i cieli narrano all’uomo la gloria senza usare parole umane, e le parole umane, nel narrare queste narrazioni non-verbali, tramutano in parola ciò che parola non è. Stupendo. Allora quando leggiamo la sua parola più folle - «la parola si è fatta carne» - in quella parola dobbiamo includere anche le non-parole del sole, delle stelle, del cosmo - il verbo nella Bibbia sono tutte le parole della terra e tutte le "parole" del cielo.
Forse i primi racconti scritti dagli uomini sono stati tentativi di narrare i racconti della natura scritti senza parole. Come il bambino impara a parlare ripetendo le parole della madre, noi abbiamo imparato a parlare ripetendo le "parole" dei racconti delle stelle. Molti popoli antichi erano così affascinati da questo linguaggio cosmico da chiamare dèi il sole e le stelle. La Bibbia, invece, pone il suo Dio al di sopra degli altissimi astri. Gli astri non sono Dio, ma sue creature - i cieli narrano la gloria di Dio. Non sono portatori di un messaggio proprio, ma significanti di altri significati, anch’essi "parole" pronunciate. Sta qui la differenza tra questo Salmo e i canti cosmici che ritroviamo nella letteratura babilonese o egiziana. Il sole non è Dio, ma è ospite di Dio: «Là pose la tenda per il sole, uno sposo che esce dall’alcova, un prode contento di slanciarsi per la sua via» (19,5-6). È il suo atleta migliore, che corre ogni giorno da oriente a occidente, andando incontro alla notte per passarle il suo messaggio, per dirle, ogni mattina, parole teofore: «Parte dal lontano dei cieli, all’altro estremo termina il suo arco» (19,7). C’è tutta la Bibbia nel Cantico di Frate sole.
Non abbiamo ancora ripreso fiato per questa visione cosmica del verbo, detta con una poesia che qui cogliamo in uno dei suoi momenti sorgivi all’aurora delle civiltà, ed ecco che il Salmo ci sorprende con un secondo colpo di scena: «La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima» (19,8). Come mai questo salto dalla sinfonia cosmica alla Torah, dal cielo alla Legge? Un salto talmente inatteso che non pochi esegeti hanno ipotizzato che i salmi all’origine del Salmo 19 fossero in realtà (almeno) due, fusi poi insieme da un redattore finale.
In realtà, l’unità del Salmo ce la svela la Bibbia stessa. Per l’uomo biblico il firmamento e la Torah sono entrambi capolavori di YHWH. Quando quell’antico salmista alzava gli occhi verso l’alto era incantato dall’armonia e dalla bellezza del cielo; ma poi provava lo stesso incanto quando guardava la terra e vi trovava la Torah. L’ordine cosmico è garantito da leggi intrinseche impresse dal Creatore nel creato, e l’ordine morale nasce dall’obbedire alle leggi e ai precetti della Torah. Lo scopo è lo stesso, l’identica provvidenza: «I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore;... sono più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante» (19, 9-11).
 Il salmista provava la stessa "gioia del cuore" quando vedeva, in ogni aurora, risorgere il sole e quando leggeva "onora il padre e la madre"; restava tramortito dal firmamento e dal "non uccidere". Perché sapeva che le stelle e la Torah erano dono per lui, erano solo e tutta gratuità. Senza questa doppia bellezza non entriamo nell’umanesimo biblico, non comprendiamo il suo più grande profitto: «Per chi li osserva è grande il profitto» (19,12).
Il salmista provava la stessa "gioia del cuore" quando vedeva, in ogni aurora, risorgere il sole e quando leggeva "onora il padre e la madre"; restava tramortito dal firmamento e dal "non uccidere". Perché sapeva che le stelle e la Torah erano dono per lui, erano solo e tutta gratuità. Senza questa doppia bellezza non entriamo nell’umanesimo biblico, non comprendiamo il suo più grande profitto: «Per chi li osserva è grande il profitto» (19,12).
 «Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me»: solo con il Salmo 19 davanti agli occhi si coglie il senso dell’ultima pagina della Critica della ragion pratica di Kant, una pagina tra le più bibliche di tutta la filosofia.
«Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me»: solo con il Salmo 19 davanti agli occhi si coglie il senso dell’ultima pagina della Critica della ragion pratica di Kant, una pagina tra le più bibliche di tutta la filosofia.Quell’antico poeta sapeva poi un’altra cosa: «Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati inconsapevoli. Anche dall’orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere» (19,13-14). Sopra il sole, gli astri obbediscono, docili e mansueti, alle leggi che YHWH ha scritto per loro; trasmettono il loro messaggio, non trasgrediscono, non peccano. Sotto il sole no, perché sulla terra l’Adam è stato creato con una libertà morale unica che lo rende il grande mistero dell’universo. Solo l’uomo e la donna possono decidere di non seguire le leggi d’amore pensate per loro da Dio. E in questo sono superiori al sole e alle stelle. Sta qui il grande mistero dell’uomo biblico: l’immagine di Dio lo rende libero al punto di poter negare le leggi pensate per la sua felicità (le nostre infelicità più importanti sono quelle che scegliamo sapendo che sono infelicità). Siamo più liberi del sole, e quindi meno ubbidienti. E torna il nostro destino tremendo e stupendo custodito dal Salmo 8: «Che cosa è l’uomo? Eppure...».
Tra i peccati umani troviamo qui sottolineati quelli fatti per inavvertenza e quelli inconsapevoli. Anche se il Novecento ci ha mostrato un inconscio non innocente, la categoria dei peccati inconsci è distante dalla nostra sensibilità moderna, molto centrata sulle intenzioni.
 La Bibbia non è un’etica, anche se nei suoi libri ci sono molte etiche. L’umanesimo biblico non può essere inquadrato in una o l’altra delle teorie etiche moderne (responsabilità, intenzioni, virtù...), ma è certamente più interessato di noi alle conseguenze degli atti. Perché ciò che più gli interessava era l’equilibrio del corpo sociale e la cura dell’Alleanza con Dio. Se allora qualcuno commetteva un peccato e provocava un danno, era a questo squilibrio nei rapporti sociali che la Bibbia soprattutto guardava.
La Bibbia non è un’etica, anche se nei suoi libri ci sono molte etiche. L’umanesimo biblico non può essere inquadrato in una o l’altra delle teorie etiche moderne (responsabilità, intenzioni, virtù...), ma è certamente più interessato di noi alle conseguenze degli atti. Perché ciò che più gli interessava era l’equilibrio del corpo sociale e la cura dell’Alleanza con Dio. Se allora qualcuno commetteva un peccato e provocava un danno, era a questo squilibrio nei rapporti sociali che la Bibbia soprattutto guardava.
 Il Decalogo inizia con il ricordo della liberazione dall’Egitto: non con un principio etico astratto, ma con un fatto. La dimensione storica della fede biblica si manifesta anche nel grande valore che attribuisce ai comportamenti, alle azioni, ai fatti, alle parole. Basti pensare, per un esempio, al vecchio Isacco che dona per errore/inganno la sua benedizione a Giacobbe; quando si accorge del suo errore non può più revocare quella benedizione sbagliata, perché quelle parole avevano generato la realtà mentre la dicevano, e avevano operato indipendentemente dalle condizioni soggettive di Isacco e dei suoi parenti (Gen 27).
Il Decalogo inizia con il ricordo della liberazione dall’Egitto: non con un principio etico astratto, ma con un fatto. La dimensione storica della fede biblica si manifesta anche nel grande valore che attribuisce ai comportamenti, alle azioni, ai fatti, alle parole. Basti pensare, per un esempio, al vecchio Isacco che dona per errore/inganno la sua benedizione a Giacobbe; quando si accorge del suo errore non può più revocare quella benedizione sbagliata, perché quelle parole avevano generato la realtà mentre la dicevano, e avevano operato indipendentemente dalle condizioni soggettive di Isacco e dei suoi parenti (Gen 27).
 I peccati sono fatti che agiscono e cambiano il mondo, con una vita propria distinta dalle intenzioni che li hanno generati. Se oggi ti dico una parola brutta e domani ti chiedo scusa, quelle scuse potranno agire sul futuro, ma non potranno cancellare la realtà di dolore che quella parola ha generato nel cuore dell’altro in quelle ore trascorse tra il peccato e il pentimento. Nella Bibbia poi la parola è talmente seria che produce effetti da sé medesima, anche quando non ne siamo coscienti, anche in quelle "ore" che passano e noi non chiediamo scusa perché non siamo consapevoli dei danni che stiamo procurando - i danni inconsci possono essere maggiori proprio perché non arrivano mai il pentimento né le scuse.
I peccati sono fatti che agiscono e cambiano il mondo, con una vita propria distinta dalle intenzioni che li hanno generati. Se oggi ti dico una parola brutta e domani ti chiedo scusa, quelle scuse potranno agire sul futuro, ma non potranno cancellare la realtà di dolore che quella parola ha generato nel cuore dell’altro in quelle ore trascorse tra il peccato e il pentimento. Nella Bibbia poi la parola è talmente seria che produce effetti da sé medesima, anche quando non ne siamo coscienti, anche in quelle "ore" che passano e noi non chiediamo scusa perché non siamo consapevoli dei danni che stiamo procurando - i danni inconsci possono essere maggiori proprio perché non arrivano mai il pentimento né le scuse.Chiedere allora a Dio (e alla comunità) di essere assolti per i peccati inconsci nasceva dalla consapevolezza che i danni che procuriamo sono maggiori delle nostre cattive intenzioni. L’uomo biblico lo sapeva, e ristabiliva l’equilibrio. Noi ne abbiamo perso coscienza, non chiediamo perdono a nessuno, ci copriamo dietro la buona fede, e accresciamo gli squilibri. Il Salmo 15 aveva lodato la sincerità. Il Salmo 19 ci dice che la sincerità qualche volta non basta. Perché nella vita c’è anche il valore delle conseguenze di azioni sbagliate compiute in buona fede. La Bibbia è un continuo e prezioso esercizio di auto-sovversione, che è la cura più efficace contro ogni ideologia. Incluse le molte piccole ideologie del nostro secolo nate sulla morte delle grandi ideologie del secolo scorso.
Il Salmo 19 ci ha rapiti al settimo cielo e poi ci ha riportato sulla terra, alle nostre inavvertenze e colpe inconsce, per dirci qualcosa di importante che non dovremmo più dimenticare: un rapporto sanato ha lo stesso valore di una galassia.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT --- LA CRITICA DELLA RAGION PURA E "LE DISTESE INTERIORI DEL COSMO". "Siamo Mito"(di Moreno Montanari).27 maggio 2020, di Federico La Sala
"CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT) E DEL "MONOMITO" (JAMES JOYCE). UN OMAGGIO A JOSEPH CAMPBELL
LA METAFORA NEL MITO E NELLA RELIGIONE E I PROLEGOMENI AD OGNI FUTURA METAFISICA CHE SI PRESENTERA’ COME SCIENZA.... *
- IL MITO E IL CORPO. [...] I vecchi dèi sono morti o stanno morendo e dappertutto la gente è alla ricerca di qualcosa di nuovo e si chiede: “Quale sarà la nuova mitologia, la mitologia di questa Terra unificata come un unico essere armonioso?”(Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo, i Nottetempo, Milano 2020, p. 23)
- LA COSMOLOGIA E L’IMMAGINAZIONE MITICA. Un’esperienza sorprendente, per me come certo per molti altri spettatori, è stata offerta dalla trasmissione televisiva del viaggio della navicella spaziale Apollo nel momento precedente lo sbarco di Armstrong sulla Luna. Quando dal Centro di controllo di Houston chiesero: «E ora chi è il navigatore?» la risposta che venne dallo spazio fu «Newton!».
 Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».
Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».
 Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).
Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).
Siamo mito
di Moreno Montanari (Doppiozero, 20 marzo 2020).
“Come fuori, così dentro” si potrebbe riassumere così, parafrasando la celebre massima alchemica, la tesi dell’ultimo libro di Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, Nottetempo, 2020. Si tratta di una raccolta di saggi che amplificano delle conferenze tenute tra il 1981 e il 1984 nello sforzo, consueto per Campbell, di illuminare la transculturalità, ossia gli elementi costanti, nonostante le variabili etnico-culturali, dei miti. Al cuore di ogni narrazione mitologica, che Campbell ha il merito indiscusso di mostrare ancora viva negli aspetti più comuni delle nostre culture, ci sono temi che Adolf Bastian (1826-1905) chiamava “idee elementari” e Carl Gustav Jung (1875-1961) “archetipi” ; si tratta di cristallizzazioni di risposte millenarie che la fantasia e l’immaginazione delle diverse civiltà umane hanno elaborato per affrontare questioni esistenziali che le hanno profondamente interrogate. Naturalmente queste forme archetipiche variano a seconda delle idee etniche che una determinata cultura esprime, ma esiste tra di loro una dialettica che Campbell riassume così : “l’idea elementare è radicata nella psiche ; l’idea etnica attraverso cui si manifesta è radicata nella geografia, nella storia e nella società” (p. 145) ; si accede al punto di vista del mito quando “nelle forme di un ambiente traspare la trascendenza” (p. 28).
Il suo lavoro più celebre sull’universalità del mito è sicuramente quello relativo a L’eroe dai mille volti (1949, tr. it. Lindau, Torino, 2012) figura che, nelle più disparate e diversificate espressioni culturali, lontanissime tra loro nello spazio e nel tempo, passa comunque sempre attraverso i seguenti snodi esistenziali : una nascita misteriosa, una relazione complicata con il padre, ad un certo momento della sua vita sente l’esigenza di ritirarsi dalla società e, in questa condizione, apprende una lezione, o elabora un sapere, che orienterà diversamente la sua vita, poi ritorna alla società per mettere al suo servizio la lezione che ha appreso, molte volte (ma non necessariamente) grazie ad un’arma che solo lui può usare.
In questo libro, invece, l’attenzione si rivolge alle diverse cosmologie e ai miti soteriologici elaborati nel corso dei millenni dalle differenti culture che si sono susseguite, e affiancate, nel nostro pianeta, comprese le attuali, e si organizza intorno alla felice intuizione kantiana che spazio e tempo siano categorie interiori della psiche che vengono applicate alla realtà esterna. Citando Novalis Campbell scrive : “La sede dell’anima è laddove il mondo esterno e il mondo interno s’incontrano”, e aggiunge, “è questo il paese delle meraviglie del mito” (p. 43).
 Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.
Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.
 Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:
Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:- “Le figurazioni mitiche sono metaforiche (...) in due sensi contemporaneamente : in quanto portatrici di connotazioni psicologiche e, allo stesso tempo, metafisiche. Attraverso questa doppia messa a fuoco, le caratteristiche psicologicamente interessanti di ogni ordine sociale locale, di ogni ambiente o di ogni ipotetica storia, possono venire trasformate attraverso il mito in trasparenze rivelatrici di trascendenza.
- Immanuel Kant ci ha fornito una formula straordinariamente semplice per interpretare queste due connotazioni. Compare nei Prologomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza ai paragrafi 57-58. Ci viene offerta una proporzione a quattro termini (a sta a b come c sta a x) che punta non tanto a porre un’imperfetta somiglianza tra due cose, ma definire un’identità perfetta di due rapporti tra cose del tutto dissimili (...). Non “a in qualche modo assomiglia a b”, ma il rapporto tra a e b è perfettamente identico a quello tra c e x, dove x rappresenta una quantità che non è soltanto sconosciuta, ma assolutamente inconoscibile, metafisica” (p. 80).
Mi sembra un esempio realmente illuminante per comprendere il senso di ogni comparazione e di ogni ermeneutica simbolica. Lo ha spiegato bene Jung : il simbolo, centrale in ogni mito, non rimanda a una realtà significata, è esso stesso realtà operante, costituisce la specifica capacità umana di “orientare la coscienza verso ulteriori possibilità di senso”, poiché non è mai del tutto riconducibile ad un significato univoco e definitivo ; per questo non può essere ridotto alla semiotica perché la sua funzione è piuttosto psicagogica, vale cioè per gli effetti che produce nella psiche, per le energie, le immagini, le interpretazioni, i processi psichici che sa evocare, promuovere, mettere in gioco (C. G. Jung, Tipi psicologici, 1921 ; tr. it. Bollati Boringhieri, 1977 e sgg, p. 527). Ecco perché il ricorso a Kant, a quell’x che resta inconoscibile e che apre alla metafisica, a ciò che trascende ogni possibilità di possesso e de-finizione del senso ultimo, appare particolarmente pertinente.
I rapporti che vengono suggestivamente indagati da Campbell, dicevamo, sono quelli che comparano lo spazio interiore e quello esteriore, secondo la celebre analogia tra macrocosmo e microcosmo :
- “la profondità e la sublime maestà della mitologia soppressa può essere apprezzata al meglio attraverso due movimenti a orologeria apparentemente irrelati ; l’uno è il più grande orologio dello spazio esteriore, l’altro appartiene allo spazio interiore. Sono rispettivamente la precessione astronomica degli equinozi e il battito fisiologico del cuore umano” (p. 54).
Attraverso un nutrito numero di calcoli e dati ricavati dagli studi di astronomia, i calendari ideati dalle diverse culture a partire dagli antichi babilonesi, le fonti bibliche, le arcaiche Upanisad induiste e i più remoti testi taoisti, Campbell giunge ad analizzare suggestivi - per un certo tipo di lettore - consonanze tra i cicli biologici del sistema solare (macrocosmo) e quelli dell’individuo (microcosmo). Ma non mi sembra questo il punto cruciale dei suoi sforzi, che consiste piuttosto nel promuovere una diversa prospettiva sul mondo e sulla vita, non più incentrata sulle nostre idee etniche, sui limiti delle nostre culture, ma aperta al riconoscimento di un’unica realtà “il cui centro è ovunque”, della quale dovremmo finalmente farci carico in maniera universale (si pensi agli assurdi sforzi dei singoli stati, in questi difficili giorni, di arginare il coronavirus secondo strategie nazionali, anziché comprenderne la portata globale che richiederebbe interventi condivisi, in tutti i sensi, su scala mondiale e non, addirittura, regionale - per non parlare delle differenti valutazioni a seconda delle fasce di età).
Dopo aver preso in esame i miti cosmologici e soteriologici delle diverse religioni delle nostre principali culture, Campbell giunge a questa conclusione :
- “Il primo passo per partecipare al destino dell’umanità, che non è quello di questo o di quel popolo, ma quello dell’intera popolazione del globo, è riconoscere che ogni immagine locale di un dio non è che una delle molte migliaia, dei milioni, forse anche miliardi di simbolizzazioni limitate di un mistero al di là della vista e del pensiero” (p. 63).
Il pensiero mitologico, quando non viene letteralizzato, promuove dunque un’apertura alla transculturalità, alla trascendenza di ogni appartenenza storico-culturale e si propone, in maniera apparentemente contro intuitiva, come strumento di laicità. Qui incontra l’arte, per la sua capacità di trasformare la coscienza e la visione abitudinarie della realtà in favore di un punto di vista nel quale, “la mente viene fermata e innalzata al di sopra del desiderio e dell’odio” ; sono parole di Joyce che Campbell fa sue e che trova affini all’esperienza ascetica che dovette compiere il Buddha prima di raggiungere l’illuminazione : vincere i tre demoni del desiderio (Kāma), della paura della morte (Māra) e l’identificazione con i vincoli sociali (Dharma), per accedere a una condizione che li sappia trascendere (pp. 201-201).
Un percorso e un’opportunità che, in chiave individuativa, sono poste al centro del lavoro di Giovanna Morelli nel suo Poetica dell’incarnazione. Prospettive mitobiografiche nell’analisi filosofica (Mimesis, 2020). In questo libro - uscito per la collana di Mimesis “Philo-pratiche filosofiche” curata da Claudia Baracchi - l’arte appare lo sfondo dal quale può emergere una rappresentazione mitobiografica della vita di ciascuno di noi, ossia, secondo la lezione di Ernst Bernhard, il modo di riconoscere come ogni singola esistenza si apra, o meglio si riconosca, in alcuni mitologemi (singoli aspetti di un mito) che si prestano a leggerne alcune gesta. Lo sguardo mitobiografico con il quale Morelli invita a osservare la vita, a partire dal racconto della propria, permette di “scoprire e amare l’universale attraverso il particolare, preservando entrambe le dimensioni”, di “narrare la propria vita secondo il disegno di senso che la illumina, la magnifica, la collega a figure universali e pertanto la rende epica, emblematica” (p. 127).
L’arte che indaga l’analista filosofo è dunque quella incarnata, ossia, consapevole che la vita di ciascuno di noi accede al simbolico grazie e attraverso quelle che James Hillman chiamava “metafore radicali” offerte dall’inconscio collettivo, ossia le strutture percettive, gli archetipi, che organizzano l’esperienza umana come già da sempre sovrapersonale.
Lo specifico di ogni vicenda biografica non viene meno se riconosce nel suo sviluppo echi, modalità e variazioni di temi ricorrenti nella storia dell’umanità - di cui la psiche mantiene una traccia in forma, appunto, archetipica - ma procede al contrario verso la sua individuazione, la possibilità di autenticare in modo esclusivo la propria esistenza, “se comunica con se stessa alle più diverse latitudini spazio-temporali, attraverso le tante narrazioni-quadro che si sono avvicendate nella storia” (pp. 38-39).
L’arte è qui poiesis, anzi, mitopoiesi e la vita, vista dall’osservatorio privilegiato della stanza d’analisi, ne costituisce il principale teatro (Giovanna Morelli è anche regista d’opera e critica teatrale), lo spazio in cui s’incontrano e si scontrano le nostre maschere sociali e i nostri doppi impresentabili, ma anche dove si facilita una più profonda espressione di sé che, in una vicenda personale, sa scorgere tracce di qualcosa di universale - il che, osserva Jung, è già di per sé terapeutico :
- “Il mito ha bisogno d’una nuova veste in ogni nuova era, se non vuol perdere la sua virtù terapeutica. (...) gli archetipi inconoscibili sono vivi (...) cambiano nome e veste in una successione infinita, e proprio attraverso questi mutamenti esprimono la loro imperscrutabile essenza” (C. G. Jung, Aion, Ricerche sul simbolismo del Sé, Bollati Boringhieri, Torino, p. 170, cit. in G. Morelli, op.cit., p. 45).
Un’operazione che, in modo diverso, sia Campbell che Morelli, ci invitano a fare per riconoscere nei miti la via maestra alla coltivazione di quella trascendenza che non rimanda a mondi altri e paralleli ma anima l’immanenza, qui ed ora, da sempre.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COME ALL’INTERNO, COSI’ ALL’ESTERNO: "VERE DUO IN CARNE UNA". NOTE SUL PROGRAMMA DI KANT
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaDAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". --- Pandemia. La filosofia e il dolore degli altri (di Alessandro Dal Lago).15 aprile 2020, di Federico La Sala
L’ADDIO A KANT, LA RIMOZIONE DELL’OMBELICO, E LA "FILOSOFIA" DEL "DOLORE DEGLI ALTRI" ... *
- "In diversi luoghi della sua immane produzione, Shakespeare fa pronunciare ai suoi celebri personaggi parole scettiche nei confronti della filosofia [...] non respingeva la filosofia in generale, ma quella cattiva, che - mi si perdoni l’espressione triviale - contempla il proprio ombelico, invece di proiettare chiarezza sul cielo e sulla terra, sulle passioni, sul destino e sul potere [...] Georg Simmel ha notato una volta quanto poco del dolore degli uomini sia entrato nella loro filosofia. " (Alessandro Dal Lago, "La filosofia e il dolore degli altri", 10.04.2020).
Pandemia
La filosofia e il dolore degli altri
di Alessandro Dal Lago ("Aut Aut", 10 aprile 2020)
In diversi luoghi della sua immane produzione, Shakespeare fa pronunciare ai suoi celebri personaggi parole scettiche nei confronti della filosofia: così Amleto (“Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne immagini la tua filosofia”) e Romeo (“Alla forca la filosofia! Se non può darmi Giulietta, farmi prendere una città, annullare la sentenza di un principe, non mi serve e non conta”). È quasi superfluo aggiungere che il più filosofico dei drammaturghi di ogni tempo (in buona compagnia con Dante, Calderón de la Barca ecc.) non respingeva la filosofia in generale, ma quella cattiva, che - mi si perdoni l’espressione triviale - contempla il proprio ombelico, invece di proiettare chiarezza sul cielo e sulla terra, sulle passioni, sul destino e sul potere.
Tutto ciò mi è venuto in mente scorrendo una raccolta online di riflessioni “filosofiche” di alcuni pensatori contemporanei sulla pandemia del Covid-19: La sopa de Wuhan. Piensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias (“La zuppa di Wuhan ecc.”).[1] Si tratta di un’operazione furbetta grazie a cui sono tradotti in castigliano e proposti un po’ alla rinfusa autori notissimi o alla moda (iek, Agamben, Nancy, Butler, Harvey, Badiou, Preciado) e altri di lingua spagnola e meno noti da noi, ma che il curatore, un certo Pablo Amadeo, ha ritenuto utili alla comprensione dell’impatto globale del virus sul nostro mondo. Complessivamente, ne ho tratto un’impressione desolante. Va bene che si tratta di interventi per lo più ad hoc, occasionali e sbrigativi, pubblicati tra fine febbraio e fine marzo 2020. È vero che qua e là si trovano anche idee interessanti. Ma se questo è il livello della filosofia contemporanea, non possiamo che essere d’accordo con lo sfortunato Romeo.
A parte gli interventi di Agamben, discutibili quanto si vuole, ma almeno coerenti, il brevissimo testo di Nancy, una garbata e non troppo amichevole risposta all’“amico” Giorgio Agamben, e i testi di Judith Butler e David Harvey, che dicono cose sensate, anche se condizionate dalla campagna per le presidenziali Usa, quasi tutti gli altri si segnalano per banalità o stramberie. Il platonico Badiou vuole una politica che si affidi ai sapienti, come se già i politici non si facessero guidare dalle molteplici e rissose tribù scientifiche. López Petit vede in corso una guerra tra la vita oscura (forse le moltitudini?) e quella algoritmica imposta dal Capitale. Altri, a onta della globalità del virus da tutti proclamata, non vanno al di là dell’orticello di casa propria, come via Mascarella per il bolognese Franco Berardi detto Bifo.
 Quanto a Markus Gabriel, seguace germanico del “nuovo realismo”, ha in mente una soluzione “realistica”, che illustro con le sue parole:
Quanto a Markus Gabriel, seguace germanico del “nuovo realismo”, ha in mente una soluzione “realistica”, che illustro con le sue parole:- Viviamo e continueremo a vivere sulla terra: siamo e continueremo a essere mortali e fragili. Convertiamoci pertanto in cittadini del mondo, in cosmopoliti di una pandemia metafisica. Qualsiasi altro atteggiamento ci sterminerà e nessun virologo ci potrà salvare.
Anche Paul B. Preciado, dopo considerazioni condivisibili sul confinamento, la paura e così via, si tuffa nell’irrealtà, proponendo che anche noi, come il maledetto virus, accettiamo di mutare (benché nei due casi il mutamento non sia proprio lo stesso).
- [...] mantenerci vivi come pianeta, davanti al virus, ma anche davanti a quello che potrà succedere, significa avviare forme strutturali di cooperazione planetaria. Come il virus muta, così, se vogliamo sottrarci alla sottomissione, dobbiamo mutare anche noi.
Come cosmopolitismo e/o cooperazione strutturale planetaria siano possibili in un mondo che sembra andare trionfalmente in direzione contraria (Trump, Bolsonaro, Orbán, neo-nazionalismi, dissoluzione potenziale di aggregazione di stati come l’Ue, emergere di nuovi poteri a dir poco voraci, per esempio la Cina) non ci viene spiegato. Ma, si sa, questo è compito di ontologie regionali come l’analisi politica o le relazioni internazionali. Quando invece qualcuno si spinge verso una valutazione empirica del presente conquista di colpo la palma dell’insensatezza. Come il leninista lacaniano Slavoj iek che vede “il comunismo germogliare dal virus” e assegna a Trump il merito di aver compreso che nell’epoca del Covid-19 è necessario un reddito minimo di base. Farei leggere a chiunque il testo del geniale psicoanalista-filosofo-tuttologo sloveno per illustrare il famoso motto di Wittgenstein “Ciò di cui non si può parlare si deve [o dovrebbe] tacere”.
***
La mia impressione desolante nasce soprattutto da quello di cui nessuno parla nella Sopa de Wuhan, e che invece mi sembra decisivo in una riflessione sulla pandemia: la sofferenza, il dolore delle decine migliaia di morti, dei loro parenti e dei loro amici, la solitudine di esseri, soprattutto anziani, che lasciano la vita intubati e con la testa chiusa in uno scafandro da cui hanno potuto inalare un po’ di ossigeno prima della fine.
 Qui non vale l’obiezione, che ho pescato in un testo del libro in questione, secondo la quale noi ci commuoviamo solo per le vittime di questa pandemia “dei ricchi”, che ha colpito cioè solo i paesi sviluppati. A parte il fatto che ne sono vittime anche i poveri, solo Dio sa se e quando la pandemia colpirà l’Africa, in cui si concentra gran parte della povertà del pianeta. Il fatto è, comunque, che il pensiero occidentale sembra per lo più incapace di comprendere la povertà, la desolazione, il dolore in cui vive una quota rilevante di umanità - come chiamarla: i nostri simili, i nostri fratelli, il Mitmensch globale?
Qui non vale l’obiezione, che ho pescato in un testo del libro in questione, secondo la quale noi ci commuoviamo solo per le vittime di questa pandemia “dei ricchi”, che ha colpito cioè solo i paesi sviluppati. A parte il fatto che ne sono vittime anche i poveri, solo Dio sa se e quando la pandemia colpirà l’Africa, in cui si concentra gran parte della povertà del pianeta. Il fatto è, comunque, che il pensiero occidentale sembra per lo più incapace di comprendere la povertà, la desolazione, il dolore in cui vive una quota rilevante di umanità - come chiamarla: i nostri simili, i nostri fratelli, il Mitmensch globale?
 E non parlo di empatia, perché dubito che noi umani siamo capaci di provare vera empatia per chi non ricade sotto il nostro sguardo miope. Parlo di comprensione, di vicinanza concettuale, di condivisione se non altro teoretica di un destino comune. Altro che cooperazione strutturale planetaria. Un po’ di compassione, avrebbero detto Karl Kraus e Rosa Luxemburg. Esempio di questa incapacità è un libretto[2] in cui il già citato iek, turbato dall’erompere di nazionalismi e sciovinismi, propone di militarizzare i migranti, non si capisce se rinchiudendoli in qualche neo-lager oppure gettandoli a mare (nella versione Salvini) o chiudendo i porti e lasciandoli alla deriva per il loro bene (versione del governo in carica mentre scrivo).[3]
E non parlo di empatia, perché dubito che noi umani siamo capaci di provare vera empatia per chi non ricade sotto il nostro sguardo miope. Parlo di comprensione, di vicinanza concettuale, di condivisione se non altro teoretica di un destino comune. Altro che cooperazione strutturale planetaria. Un po’ di compassione, avrebbero detto Karl Kraus e Rosa Luxemburg. Esempio di questa incapacità è un libretto[2] in cui il già citato iek, turbato dall’erompere di nazionalismi e sciovinismi, propone di militarizzare i migranti, non si capisce se rinchiudendoli in qualche neo-lager oppure gettandoli a mare (nella versione Salvini) o chiudendo i porti e lasciandoli alla deriva per il loro bene (versione del governo in carica mentre scrivo).[3]Georg Simmel ha notato una volta quanto poco del dolore degli uomini sia entrato nella loro filosofia. Il libretto da cui ho preso le mosse è una dimostrazione evidente del suo acume. In questi giorni, tante voci si levano per denunciare le misure profilattiche che ci costringono a qualcosa di simile agli arresti domiciliari (nel nostro caso di occidentali, abbastanza confortevoli). Ho letto invece pochi interventi filosofici originali, a più di 35 anni dalla morte di Foucault, sugli effetti della pandemia e delle restrizioni della libertà sui marginali, i deboli, i carcerati, gli invisibili, i vecchi abbandonati, gli homeless e tutte le minoranze che il virus e la prossima crisi economica trasformeranno probabilmente in maggioranze.
(10 aprile 2020)
[1] ^ Si può scaricare il testo all’indirizzo https://www.elextremosur.com/nota/23685-sopa-de-wuhan-el-libro-completo-y-gratis-para-leer-sobre-el-coronavirus.
[2] ^ S. iek, La nuova lotta di classe, Ponte alle Grazie, Firenze 2016. Leggere per credere.
[3] ^ Mi riferisco a un decreto dell’inizio di aprile del 2020 con cui il governo italiano, con il placido assenso di quasi tutte le forze politiche, chiude i porti alle navi delle Ong e alle navi da crociera.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
"NUOVO REALISMO", IN FILOSOFIA. DATO L’ADDIO A KANT, MAURIZIO FERRARIS SI PROPONE COME IL SUPERFILOSOFO DELLA CONOSCENZA (QUELLA SENZA PIU’ FACOLTA’ DI GIUDIZIO).
GUARDIAMO IL NOSTRO OMBELICO: DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA": CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
Federico La Sala
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA" --- ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA: L’«ECCE HOMO» DI PONZIO PILATO E LA DIGNITA’ DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE.6 aprile 2020, di Federico La Sala
L’ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE.
Da Giovanni Pico della Mirandola* a Herbert Marcuse** e ... ***
CARO ARMANDO, PER IMPARARE "a vivere meglio senza lasciarci condizionare dalla paura della morte, cioè dalla religione, qualunque essa sia", CREDO CHE SIA NECESSARIO riconsiderare il problema di "come nascono i bambini" (a tutti i livelli) ! Hai ragione : "Non possiamo permetterci, con le Sibille, Maria Vergine, Cristo come dio, Maometto ed altre favolette l’illusione di un altro Messia"! Ci siamo addormentati nella tradizione cattolico-costantiniana e illuministica acritica (contro Kant), e abbiamo finito per "concepire" noi stessi e noi stesse secondo la bio-logia e l’andro-logia “unidimensionale” dell’omuncolo !
L’«ECCE HOMO» di Ponzio Pilato, al contrario!, ci dice proprio questo - la fine delle "favolette" e di ogni "illusione di un altro Messia". Il discorso è di diritto e di fatto, romanamente universale, vale a dire, antropologico (non limitato all’« omuncolo » di qualche "uomo supremo" o “superuomo” !) :
- PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo » (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei : "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
SE SIAMO ANCORA CAPACI DI LEGGERE, COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA LEZIONE DI PONZIO PILATO ?! Non è una lezione critica contro i "sovranisti" laici e religiosi di ieri e di oggi ?!
Che vogliamo fare ? Continuare a riportare noi stessi e noi stesse davanti a Pilato e ripetere da scemi e da sceme la stessa scena, riascoltare il suo "Ecce Homo" e non capire una "H" (acca) ?!
* Discorso sulla dignità dell’uomo.
P.S. - RICORDANDO ... GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA.
***
Federico La Sala ("Fondazione Terra d’Otranto", 01/03/2020).
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". --- CORPOREITA’ E REALTA’ VIRTUALE. Se iI dolce veleno della tecnologia ci fa dimenticare che siamo corpo (di Raul Gabriel).16 ottobre 2019, di Federico La Sala
Frontiere.
Se iI dolce veleno della tecnologia ci fa dimenticare che siamo corpo
L’illusione della smaterializzazione è un sintomo mortale, l’evidenza di una progressiva sconfitta del senso del cammino che è vita
di Raul Gabriel (Avvenire, giovedì 10 ottobre 2019)
- [Foto] Realtà virtuale (Eddie Kopp/Unsplash)
Nello sviluppo delle tecnologie vi è un processo inevitabile di cui credo sia necessario avere piena coscienza. L’esempio perfetto viene dalla possibilità abbastanza recente di un corpo umano perfettamente riprodotto in 3D in grado di sostituire i corpi in carne e ossa per lo studio dell’anatomia umana, disponibile su un tavolo operatorio di dissezione virtuale. Realtà già attiva in Italia in alcuni distretti ospedalieri e scientifici avanzati, rappresenta solo l’inizio di cosa può significare la virtualizzazione e le sue possibili applicazioni.
Poter effettuare indagini ed esperienze senza avere a che fare con gli effetti più sgradevoli di tutto ciò che ci tiene in vita è certamente un grande passo avanti. Per qualche motivo la tecnologia sembra avallare e incoraggiare la tendenza comune a tutta la società moderna. Sanitizzare e rendere asettico tutto ciò con cui abbiamo a che fare, dai comportamenti, con l’avvento della relazione digitale, agli edifici, tutti sempre più simili a cattedrali purificate da ogni elemento che ricordi lontanamente l’uomo.
Un passaggio simile è quello delle armi. Dalla lotta diretta e il confronto fisico, con mazze, spade, lance, alla possibilità di polverizzare insediamenti e vite umane con l’utilizzo dei droni. Dall’esperienza diretta degli effetti della violenza esercitata alla distanza rarefatta di un sangue remoto, senza odore né colore e quindi in apparenza privo di umanità.
La contemporaneità è tale da promuovere un mestiere abbastanza infame come quello del cecchino a una dimensione epica da templare, dal momento che ha creato la possibilità di essere cecchini a migliaia di chilometri di distanza, pilotando strumenti di distruzione come i droni da un ambiente con tutti i comfort, aria condizionata e sedie confortevoli dove magari tra un cubalibre e un manhattan si annientano vite umane e compounds che per l’operatore di turno non sono altro se non "pixel" in "ultrahd" su uno schermo militare.
Non voglio essere in alcun modo catalogato tra i tanti che elaborano prefiche e invettive furiose e scandalizzate quanto ipocrite in nome di fedi o credi vari guidati unicamente dal senso di inadeguatezza. Qualcuno potrebbe obiettare che la realtà è ormai dimostrato essere questione di dimensione, che le immaginette di gente che cammina, svolge la sua vita quotidiana, con tutte le sue complesse mediocrità è meno realtà di un video realtime ad alta definizione.
Proprio qui come si è detto per altre questioni, l’umanità si divide in due. Qui si apre un varco insanabile tra chi annulla la dignità umana in nome di allucinazioni ideologiche e chi rispetta la carne come regalo ineguagliabile della provvidenza. Sembra essere una divergenza irrisolvibile quella tra tecnologia e esistenza corporale. Eppure la cronaca e la vita di tutti i giorni ci parlano inequivocabilmente di quanto siamo destinati al legame col nostro sangue, i nostri ormoni, i nostri corpi. La realtà è che qualunque sia la tecnologia di cui saremo dotati, il nostro rapporto col corpo è ineludibile.
La tecnologia stessa nasce dal fatto che siamo corpo. Non può trasformarsi in uno strumento che lo nega perché sarebbe una negazione ontologica, impossibile. Allora? Il fatto è che tendiamo a semplificare e ad abituarci a idee precostituite a cui amiamo adeguarci. La perdita di corporeità è come un veleno dal sapore dolce. Dal momento che la corporeità comporta una serie di effetti collaterali non sempre "presentabili" tendiamo a immaginare una vita senza corporeità, e la cosa spesso peggiora con la vecchiaia.
Ma cercare la smaterializzazione è un segno di senilità e quello che è peggio è una senilità dello spirito. È la perdita di un istinto alla lotta che deve essere mantenuto perché la lotta dell’esistenza è lo stesso districarsi della vita. L’illusione della smaterializzazione è un sintomo mortale, di una progressiva sconfitta del senso del cammino, che è vita. Deve essere chiaro. La lotta per la smaterializzazione è già la sconfitta di chi la conduce. Ciò che è presentato come sublimazione è solo la dichiarazione della propria velleità di controllo.
 Avere un corpo virtuale a disposizione può essere di grande utilità, ma non potrà mai portare allo stadio in cui sostituisce quello reale. Gestire il corpo a distanza richiede una coscienza profonda del fatto che quella distanza è un diaframma inesistente e la vita che tocchiamo attraversandolo verrà inevitabilmente a chiederci il conto.
Avere un corpo virtuale a disposizione può essere di grande utilità, ma non potrà mai portare allo stadio in cui sostituisce quello reale. Gestire il corpo a distanza richiede una coscienza profonda del fatto che quella distanza è un diaframma inesistente e la vita che tocchiamo attraversandolo verrà inevitabilmente a chiederci il conto.
Sul tema, nel sito, si cfr.:Federico La Sala
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA" --- UNA BOTTE PIENA DI BUCHI E IL MITO DELLE DANAIDI. Immanuel Kant e l’Alzheimer (di Francesca Rigotti).22 settembre 2019, di Federico La Sala
Fili di pensiero e buchi di memoria. Immanuel Kant e l’Alzheimer
Nell’ultimo decennio della sua vita il filosofo fu affetto da confusione mentale e perdita di memoria: l’intervento di Francesca Rigotti per l’Alzheimer Fest
di FRANCESCA RIGOTTI *
- A Treviso dal 13 al 15 settembre si svolge la terza edizione dell’Alzheimer Fest. Dal dolore nasce una festa, che coinvolge persone affette da demenza, famigliari, medici, operatori, artisti, liberi cittadini. Gli eventi previsti sono circa 150, tutti gratuiti (info su alzheimerfest.it). Qui pubblichiamo un estratto dell’intervento che la filosofa Francesca Rigotti terrà domenica 15 alle 11.30. Sul numero 405 del 1° settembre, «la Lettura» ha anticipato l’originale componimento in versi a staffetta realizzato per l’occasione da Vivian Lamarque, Roberta Dapunt, Flavio Pagano, Stefano Scateni, Giovanna Baglione e altri poeti (con un articolo di Michele Farina). Nel supplemento #406 in edicola fino a sabato 14 settembre, è disponibile l’intervento Donatella Puglia, docente di Lingua e letteratura latina all’università di Siena (anche lei ospite dell’evento).
Parleremo di Alzheimer e di filosofia concentrandoci sulla figura di un filosofo che fu presumibilmente colpito da questa sindrome. Un filosofo che alcuni hanno studiato a scuola, altri solo orecchiato: Immanuel Kant, che nell’ultimo decennio della sua vita fu affetto da confusione mentale e perdita di memoria.
Kant visse tra il 1724 e il 1804, ottant’anni giusti tutti trascorsi a Königsberg, allora nella Prussia orientale, ora Kalinigrad, enclave russa. Alla locale università seguì le lezioni di filosofia, matematica, fisica e dogmatica. È l’autore delle tre critiche (della Ragion Pratica, della Ragion Pura, del Giudizio). Nel campo della morale ha elaborato una dottrina deontologica molto rigorosa basata sul dovere di comportarsi in modo tale che il proprio agire possa diventare massima dell’agire universale (in contrasto con l’utilitarismo e con la dottrina del male minore, capolavoro etico di Tommaso d’Aquino, quella che consiglia di ingoiare tu il rospo piccolo prima che il rospo grande ingoi te). Nel campo teorico-conoscitivo, la dottrina di Kant ha messo al centro della conoscenza il soggetto e le peculiarità del suo apparato conoscitivo categoriale attraverso il quale viene letto e interpretato il mondo.
Un grandissimo filosofo insomma, che proprio perché tale non sfugge allo sport preferito dai piccoli filosofi, che è quello di sparare al grande filosofo. È uno sport di tutti i tempi e di tutte le età, che ai nostri tempi è stato praticato contro Platone (trasformato in fautore dello stato autoritario); Marx (unisono o quasi: «in soffitta, in soffitta!»); Hegel e l’idealismo tedesco (che alcuni professori tedeschi vorrebbero cancellare dal programma di filosofia); Heidegger (ancora quasi un unisono: il bersaglio è facile data l’indulgenza di Martin verso il nazionalsocialismo). Ultimamente ci si è accaniti contro Kant, dapprima attaccando i suoi scritti gnoseologici cui si è voluto dare un bel «good bye», ora rivolgendosi anche alla roccaforte dei suoi scritti etici, troppo rigorosi per la nostra edonista società. Io però sono convinta che lassù, nel cielo dei filosofi, a Platone, Hegel, Marx, Kant, Heidegger e compagni quelle cannonate facciano il solletico.
Anche Kant, dicevo, è oggetto proprio in questi giorni di pesanti bordate che mirano a demolire nientemeno che il suo apparato etico, rigoroso e cogente, non adatto a un’epoca di grandi opportunisti e edonisti di bassa lega pronti a chinarsi a soluzioni di comodo. Ma che cosa c’entra tutto questo con l’Alzheimer? C’entra, c’entra, o almeno vorrei farcelo entrare io mostrando come, se un vero nemico di Kant ci fu, esso fu proprio questa malattia subdola e strisciante che venne a guastare gli ultimi anni di vita del grande pensatore di Königsberg.
Conosciamo bene la biografia di Kant e in particolare gli anni della vecchiaia grazie a ben tre biografie scritte da suoi conoscenti e amici, Borowski, Jachmann e Wasianski, e a un testo letterario del 1827 di Thomas de Quincey, Last days of Immanuel Kant, da cui è stata tratta la suggestiva versione cinematografica, del 1993, del regista francese Philipp Collin, Les derniers jours d’Emmanuel Kant, che purtroppo non posso mostrarvi, neanche un pezzettino. Se siete interessati potete guardarla integralmente su YouTube. Vedrete un anziano signore con parrucca, redingote e scarpini con la fibbia, dagli occhi azzurrissimi (che si possono soltanto immaginare perché il film è in bianco e nero), a volte ancora splendenti di intelligenza, più spesso offuscati dalla malattia che quell’intelligenza si stava portando via. Vedrete un uomo minuto e segaligno, anche se meno magro di come viene descritto nel libro (non portava mai calze nere per non far apparire i polpacci ancora più secchi), vittima del proprio rigore di abitudini di vita, che si autocostringeva a seguire rituali rigidissimi quanto ridicoli per quanto riguarda il dormire (impacchettato strettissimamente tra lenzuola e coperte), il vestirsi, il mangiare, lo scrivere, il fare le passeggiate...
Ma torniamo al Kant filosofo. Oltre che del pensiero critico Kant si interessò, tra l’altro, di estetica, di cosmologia, di antropologia. In relazione a quest’ultimo ambito scrisse nel 1798 una Antropologia dal punto di vista pragmatico, l’ultima opera pubblicata in vita anche se redatta nel corso di anni precedenti . Un’opera senile nella quale Kant tratta, forse non a caso, di memoria e oblio (e qui apro una parentesi per mandare un saluto ossequioso al grande Harald Weinrich, lo studioso autore del più bel libro sull’oblio che sia mai stato scritto e che qui mi ha molto aiutato: Lete. Arte e critica dell’oblio, chiusa parentesi).
Ebbene Kant, che aveva sempre goduto di ottima memoria, trattandone egli stesso teoricamente scriveva che la memoria è importante per prendere parte alle vicende della cultura e della scienza, e per questo la si deve esercitare fin dalla più tenera età. La collega poi ai principi della ragione, soprattutto quella che definisce la terza forma della memoria. La prima infatti, (memoria meccanica), è una specie di facoltà minore, quasi animalesca, con la quale si immagazzina materiale e basta; la seconda (memoria ingegnosa), è un metodo per ricordare attraverso associazioni che non hanno nulla a che fare con il concetto da memorizzare; al gradino più alto sta la memoria giudiziosa, che permette di esercitare scelte opportune e ragionate sui contenuti di memoria, tramite sistemi di classificazione, per es. dei libri delle biblioteche come delle specie naturali; scelte giudiziose perché basate su principi di ragione.
Eppure al teorico della memoria verranno a mancare, paradossalmente, tutte le forme di memoria, condizione che il suo maggior biografo, Wasianski, diacono della chiesa di Tragheim a Königsberg e amico personale e devoto di Kant, tentò di minimizzare e giustificare: «a poco a poco lo colsero le debolezze della vecchiaia, tra cui la mancanza di memoria...». E così continua la descrizione che l’amico diacono effettua delle trasformazioni del filosofo: cominciò a ripetere i suoi racconti più volte nello stesso giorno; vedeva le cose più lontane del suo passato vive e precise davanti a sé, ma il presente, come avviene nei vecchi, gli restava meno impresso; sapeva recitare lunghe poesie tedesche e latine, brani dell’Eneide, senza intoppo, mentre gli sfuggivano le cose apprese un momento prima. Si era accorto anche lui che la memoria gli si affievoliva, sicché annotava le cose su foglietti, buste usate, informi pezzetti di carta. Oltre alla perdita di memoria incominciò a elaborare teorie strampalate, per esempio attribuendo la morìa di gatti a Basilea, Vienna e Copenhagen, a una particolare elettricità dell’aria. Si sentiva debole, astenico. Si addormentava per fiacchezza sulle seggiole, fuori orario; non era in grado di badare al suo denaro, perse la nozione del tempo, talché un minuto gli sembrava esageratamente lungo; l’appetito era sregolato e degenerato (ingollava avidamente bocconi di pane spalmati di burro e premuti su formaggio inglese grattugiato). Si esprimeva in modo sempre meno adeguato e divenne incapace di scrivere il suo nome né riusciva più a figurarsi la forma delle lettere. Il suo linguaggio diventò improprio anche se cercava di spiegarsi con affinità e analogie (parlava di mare e scogli per intendere minestra e bocconi di pane); non riusciva a farsi capire su cose comunissime, poi cominciò a non riconoscere chi gli stava intorno. Non si raccapezzava e allora gridava con voce stridula. Si consumò, e morì il 12 febbraio 1804. La diagnosi di Alzheimer per la «debolezza senile» di Kant venne proposta da Alexander Kurz nel 1992, e poi ripresa e descritta da altri, in particolare Fellin, nel 1997.
Nella sua Antropologia, a proposito della smemoratezza, che Kant chiama obliviositas, il filosofo usa una immagine, per descriverla, con la quale sembra parlare di sè: la smemoratezza è lo stato in cui la testa è come «una botte piena di buchi» (ein durchlöchertes Fass). Per quanto la riempi, rimane sempre vuota, e questo è un grandissimo male (ein größeres Übel). I contenuti versati nella testa scorrono fuori dai buchi come fili d’acqua da un setaccio, e questa perdita rende la mente vuota, sterile.
 Come il vaso che nel mito greco delle Danaidi le spose assassine erano condannate a riempire nell’al di là. E ora racconterò un meraviglioso mito che spiega molte cose di ora e di allora perché il mito tratta di ciò che non è mai e fu sempre.
Come il vaso che nel mito greco delle Danaidi le spose assassine erano condannate a riempire nell’al di là. E ora racconterò un meraviglioso mito che spiega molte cose di ora e di allora perché il mito tratta di ciò che non è mai e fu sempre.Le Danaidi erano le cinquanta figlie di Danaos, re dell’Argolide, regione a nord del Peloponneso, che il padre aveva destinato spose, contro la loro volontà, ai cinquanta figli di Aigyptos, Egitto. Ma durante la prima notte di nozze le ragazze, tranne una, uccisero i loro sposi prima che il matrimonio venisse consumato. Nell’al di là le Danaidi dovevano riempire continuamente d’acqua un recipiente dal fondo bucherellato.
 Io vi leggo un mito di infertilità, desiderata dalle fanciulle ma punita dalla società. Vedo fili d’acqua che escono dai buchi del corpo come vedo, nella metafora kantiana, fili di pensiero che escono dai buchi della mente rendendola sterile e improduttiva come non riproduttivo fu il ventre delle Danaidi.
Io vi leggo un mito di infertilità, desiderata dalle fanciulle ma punita dalla società. Vedo fili d’acqua che escono dai buchi del corpo come vedo, nella metafora kantiana, fili di pensiero che escono dai buchi della mente rendendola sterile e improduttiva come non riproduttivo fu il ventre delle Danaidi.Nel caso del filosofo sono fili di ragionamento che il vecchio professore (Kant aveva insegnato Logica e metafisica nell’Università di Königsberg), non riesce più a annodare, a intrecciare, nemmeno a districare, come si si esprime Kant in un’altra metafora per parlare dello stesso problema. Scrivendo nel 1794 all’allievo Sigismund Beck, Kant così scriveva: «Neppure io riesco a capire...me stesso, e le farò le mie congratulazioni se sarà in grado di mettere in chiara luce uno a uno questi esili fili della nostra facoltà conoscitiva...Districare fili così sottili non fa più per me».
 Con queste parole Kant fornisce almeno due indicazioni; che la sua facoltà di ragionare è carente già nel 1794, e che i pensieri sono fili, nel suo e nel nostro immaginario, che pensa alla mente come a una matassa ingarbugliata (lo «gnommero» del commissario Ingravallo nel Pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda), come a un ciuffo di lana di pecora infilato sulla rocca che attende di essere dipanato e filato dalla mano del pensiero in forma di fili continui, filati, lineari, pronti per essere intrecciati in un tessuto-testo (teXtus).
Con queste parole Kant fornisce almeno due indicazioni; che la sua facoltà di ragionare è carente già nel 1794, e che i pensieri sono fili, nel suo e nel nostro immaginario, che pensa alla mente come a una matassa ingarbugliata (lo «gnommero» del commissario Ingravallo nel Pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda), come a un ciuffo di lana di pecora infilato sulla rocca che attende di essere dipanato e filato dalla mano del pensiero in forma di fili continui, filati, lineari, pronti per essere intrecciati in un tessuto-testo (teXtus).Che cosa succedeva nella mente bucherellata di Kant, da cui uscivano fili che non potevano più essere razionalmente intrecciati? Che essa continuava a lavorare e a pensare, ma in maniera bizzarra. Lo mostra l’episodio del licenziamento del domestico Lampe, Martin Lampe (Lampe è la lampada in tedesco), che aveva seguito e servito il filosofo per quarant’anni, assistendolo in tutte le occasioni, dalla sveglia al mattino alle 5 con il lume a candela, al servizio del pranzo (preparato da una cuoca), all’accompagnamento nelle sue passeggiate ossessive sulle quali la gente di Königsberg regolava le sue attività. Non che Kant fosse molto interessato alla vita privata di Lampe, tant’è che ignorava che fosse stato sposato per diversi anni, e il giorno che il domestico indossò la marsina gialla invece della livrea bianca (e Kant si arrabbiò moltissimo) era perchè andava a risposarsi.
 Ebbene nel 1802 Kant decise di separarsi da questo servo a causa del suo cattivo contegno insorto negli ultimi anni: esigeva supplementi di salario, litigava con la cameriera, e poi commise qualcosa di grave che non ci è dato sapere e su cui Kant così sentenzia: «Lampe ha commesso una tale mancanza che mi vergogno di nominarla». Lampe fu dunque dimesso e al suo posto venne assunto un tale Johann Kaufmann, con il quale il filosofo entrò in
sintonia - dopo un po’ di attrito perché le cose dovevano essere disposte e porte dal domestico sempre nello stesso modo, la teiera/caffettiera, la tazza di caffé/tè, la pipa. A questo punto, decide Kant, «il nome di Lampe va assolutamente dimenticato». E per dimenticarlo meglio che cosa fa? Lo annota su un foglietto di appunti: «dimenticare Lampe». Ma a differenza di quei pensieri che scappavano dai buchi della mente, il nome Lampe non riusciva a uscirgli dalla testa. Weinrich prova a interpretare questo imperativo categorico come un esercizio dell’arte dell’oblio, non dell’arte della memoria, dal momento che proprio le cose che si scrivono (si registrano, si mettono nella memoria, nostra o del computer) possono essere dimenticate. In qualche modo lo scrivere le cose, l’immagazzinarle nella memoria, le consegna all’oblio. Una volta scritte, possiamo anche dimenticarle e di fatto le dimentichiamo. Lo pensava del resto anche Platone, che definisce la vecchiaia l’età della smemoratezza (τό ληθης γηρας, to létes ghêras).
Ebbene nel 1802 Kant decise di separarsi da questo servo a causa del suo cattivo contegno insorto negli ultimi anni: esigeva supplementi di salario, litigava con la cameriera, e poi commise qualcosa di grave che non ci è dato sapere e su cui Kant così sentenzia: «Lampe ha commesso una tale mancanza che mi vergogno di nominarla». Lampe fu dunque dimesso e al suo posto venne assunto un tale Johann Kaufmann, con il quale il filosofo entrò in
sintonia - dopo un po’ di attrito perché le cose dovevano essere disposte e porte dal domestico sempre nello stesso modo, la teiera/caffettiera, la tazza di caffé/tè, la pipa. A questo punto, decide Kant, «il nome di Lampe va assolutamente dimenticato». E per dimenticarlo meglio che cosa fa? Lo annota su un foglietto di appunti: «dimenticare Lampe». Ma a differenza di quei pensieri che scappavano dai buchi della mente, il nome Lampe non riusciva a uscirgli dalla testa. Weinrich prova a interpretare questo imperativo categorico come un esercizio dell’arte dell’oblio, non dell’arte della memoria, dal momento che proprio le cose che si scrivono (si registrano, si mettono nella memoria, nostra o del computer) possono essere dimenticate. In qualche modo lo scrivere le cose, l’immagazzinarle nella memoria, le consegna all’oblio. Una volta scritte, possiamo anche dimenticarle e di fatto le dimentichiamo. Lo pensava del resto anche Platone, che definisce la vecchiaia l’età della smemoratezza (τό ληθης γηρας, to létes ghêras).
 Nel dialogo Fedro infatti, a proposito dell’invenzione della scrittura da parte del dio egiziano Theuth, che presenta la sua invenzione come medicina per la memoria e per la sapienza, così commenta il saggio re Thamus, le cui opinioni riflettono quelle di Platone: «Ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di dar vita alle arti e chi invece di giudicare quale danno o quale vantaggio comportano per chi se ne servirà. E ora tu, che sei il padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa infatti, (la scoperta della scrittura) produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l’avranno imparata, perché fidandosi della scrittura non fanno esercitare la memoria. Infatti, facendo affidamento sulla scrittura, essi trarranno i ricordi dall’esterno, da segni estranei, e non dall’interno, da se stessi».
Nel dialogo Fedro infatti, a proposito dell’invenzione della scrittura da parte del dio egiziano Theuth, che presenta la sua invenzione come medicina per la memoria e per la sapienza, così commenta il saggio re Thamus, le cui opinioni riflettono quelle di Platone: «Ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di dar vita alle arti e chi invece di giudicare quale danno o quale vantaggio comportano per chi se ne servirà. E ora tu, che sei il padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa infatti, (la scoperta della scrittura) produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l’avranno imparata, perché fidandosi della scrittura non fanno esercitare la memoria. Infatti, facendo affidamento sulla scrittura, essi trarranno i ricordi dall’esterno, da segni estranei, e non dall’interno, da se stessi».Se consegno la nozione allo scritto, insomma, la tolgo dalla memoria, la dimentico, e in più indebolisco la memoria stessa. Dimentico, faccio cadere fuori dai buchi della testa, dalla mente, de-mente, demente.
Cent’anni dopo la morte di Kant il medico dei pazzi Alois Alzheimer diagnosticò il morbo che da lui prese il nome: un morbo preciso dunque, una malattia da curare. Non di generica debolezza senile soffriva Kant, quanto di una malattia specifica. Probabilmente qualcuno lo sospettò già prima, ma soltanto nel 1992 il sospetto venne scritto e assunse la forma di certezza. Cosa che apre un altro quesito filosofico riguardante l’attacco innescato pochi anni fa dai filosofi newrealisti contro i pensatori postmodernisti. Alcuni di questi (v. Bruno Latour) hanno sostenuto che il faraone Ramsete non potè morire di tubercolosi (come avrebbero provato alcune moderne autopsie) perchè il bacillo di Koch non era ancora stato isolato. Il che filosoficamente corrisponde a sostenere che «sapere che x» equivale a «essere costitutivo dell’essere x», ovvero afferma che Kant non potè soffrire di Alzheimer perché la malattia non era stata ancora individuata e battezzata. Argomento che secondo alcuni discenderebbe direttamente dalla «rivoluzione copernicana» introdotta da Kant, il quale pose il soggetto/sole al centro della conoscenza/sistema solare, affermando che il soggetto comprende la realtà attraverso le proprie categorie e assegnando dunque al nostro intelletto un ruolo fortemente attivo nel metodo conoscitivo; sono i nostri schemi mentali che determinano il modo in cui un oggetto viene percepito. Ma mentre la prima conclusione (Kant non potè soffrire di Alzheimer perché la malattia non era stata ancora inventata/scoperta), è assurda, non lo è per nulla la seconda conclusione (la centralità del soggetto nella comprensione dei fatti e l’idea che le proposizioni scientifiche in grado di ampliare il nostro sapere sul mondo non si limitano a recepire passivamente dei dati, ma sono di natura critica e deduttiva). Non possiamo però occuparci a fondo della diatriba perchè il discorso ci porterebbe troppo lontano. La lasciamo lì, insieme al marasma senile del povero Kant, e alle sue occupazioni delle ultime settimane di vita, quali togliere e riannodare continuamente la cravatta, abbottonare e sbottonare la veste, in uno stato di continua agitazione, finché, come scrive un altro biografo, Jachmann, «svanì a mano a mano il vigore del più grande filosofo fino alla sua completa impotenza intellettuale».
-
> IL PROGRAMMA DI KANT ---"Der körper". Il corpo non è, cartesianamente, la macchina mossa dall’anima, a lei collegata tramite la ghiandola pineale. Noi siamo un corpo. Soprattutto, il corpo è il veicolo della relazione con l’altro (di Giuseppe Dossetti jr.).26 gennaio 2019, di Federico La Sala
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! *
Giornata della Memoria.
Hitler, radiografia del Male
A Carpi la mostra "Der körper" di Fresu parte da studi clinici sul Führer e apre a molte domande sul perdono, sull’inganno delle dittature e la vigliaccheria del male. L’analisi del teologo Dossetti
di Giuseppe Dossetti jr. (Avvenire, sabato 26 gennaio 2019)
- [Foto] Hitler, radiografia del Male
Di fronte al materiale offerto dalla mostra, si è costretti a cercar di capire i propri sentimenti. Il mio, è duplice. Anzitutto, mi colpisce lo spogliamento radicale di quest’uomo, privato non solo dei suoi vestiti, così importanti per lui, per costruire la propria immagine, ma privato anche della sua epidermide, ’cosificato’. Mi vengono in mente analoghe radiografie di vittime dello sterminio, che ho visto a Mauthausen: l’uomo denudato, violato nella sua intimità, trafitto dal raggio come la farfalla dallo spillone. Nell’ultima stanza della mostra, si cerca di restituire vita a quel corpo, ricostruendo i battiti del suo cuore.
 È come se si dicesse che Hitler continua a vivere o, meglio, continua a vivere il male che ha trovato in lui così terribile manifestazione. Viene in mente l’ultima pagina del romanzo di Camus: il batterio della peste è nascosto negli anfratti della città, per ricomparire a suo tempo. Tuttavia, questa interpretazione seducente non mi tocca, quanto invece la sorte individuale di quest’uomo.
È come se si dicesse che Hitler continua a vivere o, meglio, continua a vivere il male che ha trovato in lui così terribile manifestazione. Viene in mente l’ultima pagina del romanzo di Camus: il batterio della peste è nascosto negli anfratti della città, per ricomparire a suo tempo. Tuttavia, questa interpretazione seducente non mi tocca, quanto invece la sorte individuale di quest’uomo.La mostra potrebbe essere interpretata come una vendetta, la riduzione a numeri e parametri dell’uomo, che aveva voluto questo per i suoi simili. Egli volle che il suo corpo fosse bruciato, proprio per evitare di essere consegnato alle mani di chi avrebbe potuto rivalersi sulle sue spoglie.
 È noto il suo orrore di fronte alla notizia che Mussolini era stato impiccato per i piedi a Piazzale Loreto. Ebbene, l’operazione di cancellare l’ultima traccia di sé non gli è riuscita completamente: un frammento importante, l’impronta del suo corpo è caduta nelle nostre mani. Forse, Antonello Fresu ha voluto gettare nelle nostre mani questo materiale, frammentario e incompleto fin che si vuole, ma sufficiente per porci la domanda: «Adesso che hai nelle mani il corpo di Hitler, che cosa ne intendi fare? ». Infatti, non ci si può sottrarre alla richiesta di prendere posizione. È addirittura possibile che ci sentiamo ancor più coinvolti: «Che cosa avrei fatto io, che cosa farei, se avessi la totale disponibilità del corpo di quest’uomo, del suo cadavere, oppure, ancora di più, di lui ridotto a scheletro vivente, non per una radiografia, ma per la fame, per la violenza, per la spoliazione di ogni dignità?».
È noto il suo orrore di fronte alla notizia che Mussolini era stato impiccato per i piedi a Piazzale Loreto. Ebbene, l’operazione di cancellare l’ultima traccia di sé non gli è riuscita completamente: un frammento importante, l’impronta del suo corpo è caduta nelle nostre mani. Forse, Antonello Fresu ha voluto gettare nelle nostre mani questo materiale, frammentario e incompleto fin che si vuole, ma sufficiente per porci la domanda: «Adesso che hai nelle mani il corpo di Hitler, che cosa ne intendi fare? ». Infatti, non ci si può sottrarre alla richiesta di prendere posizione. È addirittura possibile che ci sentiamo ancor più coinvolti: «Che cosa avrei fatto io, che cosa farei, se avessi la totale disponibilità del corpo di quest’uomo, del suo cadavere, oppure, ancora di più, di lui ridotto a scheletro vivente, non per una radiografia, ma per la fame, per la violenza, per la spoliazione di ogni dignità?».La mia personale reazione si condensa in una domanda, che mi ha colpito, appena ho avuto notizia di questa iniziativa: Questo corpo risorgerà? La fede nella “risurrezione della carne” è uno dei dogmi del credo cristiano. Non è molto considerato e talvolta viene dimenticato per pudore, quasi fosse un residuo mitologico. In realtà, si tratta di qualcosa che ha origine dal centro stesso della fede cristiana. Il corpo non è, cartesianamente, la macchina mossa dall’anima, a lei collegata tramite la ghiandola pineale.
 Noi siamo un corpo. È la materia che ci individua. Noi siamo quello che siamo perché viviamo in un tempo e in un luogo; le nostre esperienze, vissute tramite il corpo, determinano la costituzione del nostro io. Soprattutto, il corpo è il veicolo della relazione con l’altro.
Noi siamo un corpo. È la materia che ci individua. Noi siamo quello che siamo perché viviamo in un tempo e in un luogo; le nostre esperienze, vissute tramite il corpo, determinano la costituzione del nostro io. Soprattutto, il corpo è il veicolo della relazione con l’altro.
 Cartesio, proprio per il legame così lasco tra anima e corpo, pone la felicità massima nella contemplazione del proprio io pensante. Ma l’uomo d’oggi vede in questo solitudine e infelicità, perché aspira all’incontro con un tu che gli stia a fronte. La persona si costituisce tramite la sua storia, e la propria storia l’uomo la vive nel corpo. Il cristiano crede nell’Incarnazione del Figlio di Dio: «Il Verbo si è fatto carne», dice il prologo del Vangelo di Giovanni. L’incontro con il Cristo avviene mediante il sacramento del Corpo, l’Eucaristia.
Cartesio, proprio per il legame così lasco tra anima e corpo, pone la felicità massima nella contemplazione del proprio io pensante. Ma l’uomo d’oggi vede in questo solitudine e infelicità, perché aspira all’incontro con un tu che gli stia a fronte. La persona si costituisce tramite la sua storia, e la propria storia l’uomo la vive nel corpo. Il cristiano crede nell’Incarnazione del Figlio di Dio: «Il Verbo si è fatto carne», dice il prologo del Vangelo di Giovanni. L’incontro con il Cristo avviene mediante il sacramento del Corpo, l’Eucaristia.
 Tutto questo dà un valore assoluto al singolo uomo: ogni uomo è il soggetto al quale si rivolge l’iniziativa divina, ogni uomo è chiamato, come un Tu assolutamente singolare, a dare una risposta assolutamente singolare. La morte non può distruggere questa relazione. Anzi, Gesù ci dà l’esempio della morte come atto supremo di comunione, col Padre e con i suoi fratelli.
Tutto questo dà un valore assoluto al singolo uomo: ogni uomo è il soggetto al quale si rivolge l’iniziativa divina, ogni uomo è chiamato, come un Tu assolutamente singolare, a dare una risposta assolutamente singolare. La morte non può distruggere questa relazione. Anzi, Gesù ci dà l’esempio della morte come atto supremo di comunione, col Padre e con i suoi fratelli.
 Dunque, senza un corpo, la comunione è incompleta o, addirittura, non esiste. Per questa ragione, Dio vuole la risurrezione della carne: la vuole, perché vuole la comunione con l’uomo.
Dunque, senza un corpo, la comunione è incompleta o, addirittura, non esiste. Per questa ragione, Dio vuole la risurrezione della carne: la vuole, perché vuole la comunione con l’uomo.Ora, la domanda è proprio questa: può Dio volere la comunione con Hitler? Se rispondiamo di sì, allora i frammenti che contempliamo in questa mostra sono cosa sacra. Ma il nostro spirito si ribella. Si ribella anche alla formula della “banalità del male”. Di fronte ai campi di sterminio, siamo piuttosto portati a pensare a un male straordinario, eccezionale. Eccezionale vuol dire anche altro da noi, mentre la banalità suggerisce che anche noi saremmo potuti giungere a tali abissi. Condannare Hitler all’inferno, in qualche modo ci rassicura, perché crea una demarcazione tra noi e lui. Siamo noi, però, autorizzati a pronunziare questa sentenza? D’altra parte, coloro che hanno così terribilmente sofferto, non hanno forse il diritto di chiedere al Giudice le sue motivazioni? Certo, potremmo invocare la pietà. Ma sarebbe una pietà a buon mercato, un ’perdonismo’ facilone e ingiusto.
Tuttavia, la domanda va posta, anche perché altri “mostri” continuano a comparire, a Srebrenica, in Congo, in Medio Oriente. Ora, la domanda dev’essere posta a Dio: sei Tu in grado di guardare in faccia questo male? Questi uomini continuano ad appartenerti? Tieni presente che se rispondi di sì, allora ti stai prendendo la responsabilità del male da loro commesso. D’altra parte, se Tu li condanni, in nome di quale giustizia Tu li condanni?
 C’è forse una giustizia superiore a Te, alla quale anche Tu devi inchinarti? Tu ti rendi conto perfettamente che sei stretto nell’alternativa: o diventi anche Tu sottoposto a un sistema di valori, che Tu stesso hai contribuito a creare, ma che ora Ti rendono irrilevante, perché noi li porteremo avanti, magari in nome tuo, ma affrancati dalla tua tutela. Oppure, Tu sei il Totalmente Altro, l’Incomprensibile, che richiedi un’obbedienza cieca: ma l’enormità del male ci autorizza a rifiutare la rinuncia al giudizio e Tu, ancora una volta, sarai convocato al tribunale dell’uomo.
C’è forse una giustizia superiore a Te, alla quale anche Tu devi inchinarti? Tu ti rendi conto perfettamente che sei stretto nell’alternativa: o diventi anche Tu sottoposto a un sistema di valori, che Tu stesso hai contribuito a creare, ma che ora Ti rendono irrilevante, perché noi li porteremo avanti, magari in nome tuo, ma affrancati dalla tua tutela. Oppure, Tu sei il Totalmente Altro, l’Incomprensibile, che richiedi un’obbedienza cieca: ma l’enormità del male ci autorizza a rifiutare la rinuncia al giudizio e Tu, ancora una volta, sarai convocato al tribunale dell’uomo.Di fatto, questo è già avvenuto. La scelta di Barabba è anche la protesta verso un Dio che non dà spiegazioni, che rifiuta di correggere la sua creazione, che osa riconoscere all’uomo una libertà che può giungere fino a costruire Auschwitz. Alla domanda: può Dio prendere la responsabilità del male commesso dall’uomo? la risposta è sì. Questo è avvenuto sul Golgota. Lì, Dio ha accolto radicalmente il rifiuto dell’uomo, ha accettato che l’uomo lo respingesse fuori dalla storia, ha assunto in sé le conseguenze della scelta di Adamo. Ma ha trasformato tutto questo nell’atto supremo della sua presenza. «Dio è morto», proclamò Nietzsche, per dichiararne l’irrilevanza; «Dio è morto», è stato il grido d’angoscia di coloro che hanno rinunciato alla speranza, perché non hanno avuto risposta alla loro richiesta d’aiuto. «Dio è morto», diciamo anche noi, con reverenza, poiché riconosciamo nella croce questa inflessibile volontà di comunione, che acquisisce il diritto di afferrare l’uomo, ogni uomo, poiché si è fatta carico del suo dolore e persino della sua malvagità.
Per questo, penso che anche Hitler risorgerà. Negarlo, vorrebbe dire dichiarare limitata l’efficacia del sangue di Cristo. In mezzo alle infinte croci da lui piantate, questa mostra erige la croce di Hitler, denudando la sua miseria, l’oscenità del male del quale si è reso responsabile.
 Ma in mezzo a queste croci, anzi, vicino a questa, che il giudizio dell’uomo legittimamente considera meritata, c’è la croce di Gesù. Penso che uscirò dalla mostra, allo stesso modo in cui gli spettatori si sono allontanati dal Calvario: «Tutta la folla, che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto» (Lc 23,48).
Ma in mezzo a queste croci, anzi, vicino a questa, che il giudizio dell’uomo legittimamente considera meritata, c’è la croce di Gesù. Penso che uscirò dalla mostra, allo stesso modo in cui gli spettatori si sono allontanati dal Calvario: «Tutta la folla, che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto» (Lc 23,48).
*Sul tema nel sito, si cfr.:
- COME ALL’INTERNO, COSI’ ALL’ESTERNO: "VERE DUO IN CARNE UNA". NOTE SUL PROGRAMMA DI KANT
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". --- Fichte, "L’Arcisenso" di Masullo, e l’univrtsalità dello «spirito» (di Silvia Lanzani).27 luglio 2018, di Federico La Sala
Arcisenso di Aldo Masullo. La bellezza della paticità e la sapienza del relativo. Così ogni storia va ’sentita’
di Silvia Lanzani (Nuova AGENZIA RADICALE, 18 Febbraio 2018)
Gli scenari si costruiscono sempre insieme, al plurale, sapendo tuttavia - come insegnava il Nolano - che ogni punto è centro’. «Patico» è il modo umano della coscienza. Esso è in atto in ogni momento del Sentir-si. Le emozioni vi si umanizzano ed entrano nella “e-sistenza”. Così avviene il sempre nuovo cadere della coscienza fuori del proprio attuale con-sistere. In questo atto si coinvolgono non soltanto le emozioni ma qualsiasi vissuto. Ce lo insegna uno dei più grandi filosofi del nostro tempo, Aldo Masullo, 95 anni il prossimo 12 aprile, che firma uno straordinario testo filosofico, L’Arcisenso. Dialettica della solitudine’ (Quodlibet, pp. 194, euro 17), nel quale il Professore emerito di Filosofia morale alla Federico II di Napoli reimpagina e approfondisce, con nuove e potenti riflessioni, i temi di una intera vita di ricerca filosofica, lasciando una traccia profonda, potremmo dire lavica amando la sua Napoli, negli studi sulla paticità.
Il percorso, infatti, da ’Paticità. L’intoccabile tocco’, a ’Grazia. Il repentino della poesia’, passando per ’Dolore. La scelta di Chirone’, ’Eraclito. il desiderio eroico’, ’Leopardi. Sentire corporalmente il pensiero’, ’Silenzio. L’indecenza della parola’ e ’Sapienza. Nel relativo è la salvezza’. Preziosa anche l’Appendice ’Nel labirinto della soggettività. Appunti per un’autobiografia filosofica’ e, non ultimo, un autentico ’tocco’ di stile con il ’ringraziamento’ ai suoi allievi migliori - migliaia nel tempo - a iniziare da Giuseppe Cantillo e Bianca Maria d’Ippolito, fino ai dialoghi con amici come Matteo Palumbo e Gerardo Picardo.
Per Masullo non solo non vi sono piacere o dolore, ma neppure ragionamento o azione, immaginazione o ricordo, che siano umani, se non sono sentiti, se non recano, sia pure nascosti ma sempre pronti a saltar fuori o almeno a far capolino tra le pieghe del vivere, «lo stupore con cui si manifesta il sé» e «l’angoscia dell’esser toccati da eventi, senza perché». Ogni accadere tocca a me, proprio a me, senza che io sappia perché, così come non so questo me donde venga né dove vada, anzi neppure perché mai proprio a me questo me sia toccato.
Con l’accadermi, la coscienza di me ancora una volta cade fuori del suo con-sistere, e proprio in ciò io e-sisto. Sensus non c’è, se non è sensus sui. Lo stesso sé in nient’altro consiste che nel sensus sui, nel sentimento di sé, nella tensione verso sé come verso l’unità che si ha l’impressione di essere. Esso non è né «prima» né «dopo» questo o quel sentire, ma è sempre di ogni sentire la condizione originaria. Un filosofo tedesco lo chiamerebbe Ursinn. Masullo lo definisce «Arcisenso».
L’avvertimento del sé muove dall’intimo della vita, che nell’individuo umano, sentendo-si, vive. La vita ogni volta accade, e accade in quanto accade al sé che la vita allucina - ad un sé a cui l’accadere tocca, quasi il sé fosse prima dell’accadere, il vissuto fosse prima e non a partire dalla vita vivente. Se una differenza non colpisse, il sé non apparirebbe; né il colpo della differenza, il tempo, apparirebbe senza un sé colpito. Si tocca così la falda più profonda della fenomenalità di ogni fenomeno, il fenomeno primario con cui s’inaugura la possibilità stessa dell’apparire e senza di cui nessun altro fenomeno sarebbe possibile. «Fenomeno» è il calco italiano del greco φαινόμενον, participio del verbo deponente φαίνεσθαι, che in greco vuol dire «apparire», «manifestarsi».
Il φαινόμενον è l’«apparente», il «manifestantesi», cioè l’apparire, il manifestarsi, nel momento stesso in cui appare, si manifesta. È impersonale, senza soggetto, atto con cui tutto appare, tutto si manifesta, il mondo delle cose e di chi le vede e le usa. Il manifestarsi è tutto. L’apparire, il manifestarsi, è puro accadere o, come pur si dice, evento.
Nel vissuto del tempo e del sé, l’emozione di sorpresa nel sentire come contingente l’accadere e l’emozione di angoscia nel sentire come precario il sé strettamente si tengono. Senza il dolore che l’infallibile arciere del tempo infligge, non emergerebbe il sé come il vivente bersaglio di questa offesa. Ma, se il sé non emergesse, il colpo del tempo cadrebbe nel vuoto o riuscirebbe frustrato.
La vita fa come una piega - si «ri-piega su di sé» - . In ciò sta il punto d’origine della fenomenalità, là dove il vivente si converte in umano e si apre a se stesso, si fa soggettivo. La vita stessa si duplica (si complica nel «vivere il proprio vivere», come letteralmente suona il tedesco er-leben), e vivendo prova l’emozione di sé.
Avviene appunto quel che si esprime con il verbo πάσχειν, che vuol dire «patire», non necessariamente nel senso della sofferenza, ma in quello ampio del «provare», cioè del «vivere» usato transitivamente, come nelle espressioni «ho vissuto un brutto momento» e «ho vissuto una bella esperienza». Radice del verbo πάσχειν è παθ, da cui si forma il sostantivo πάθος: il calco italiano ne è «pathos» o più correntemente «patos». Il primo significato di πάθος è «ciò che si prova di bene o di male», in breve il vissuto. Si designa con ciò un’emozione sofferta, umanizzata dalla coscienza del sé.
Al fondo di ogni vissuto sta una rottura. La vita è un incessante rompersi, anche se abitualmente inavvertito. Quando il rompersi è violento e inabituale, l’in-differenza dell’essere esplode nella differenza dell’e-sistere. E’ questo il «repentino» (il platonico ἐξαίφνης). Esso scopre l’inarrestabile passo del cambiamento, ciò che «noi per abitudine chiamiamo tempo».Si mostra qui l’umanità originaria dell’emozione, la falda profonda di ogni emozione propriamente umana. Ci si trova, per essa, presi nella dinamica esistenziale, in cui non soltanto le emozioni occasionali, ma tutti i vissuti, anche quelli intenzionali e semantici, cioè gli sguardi sulle cose e la nominazione di queste, si costituiscono nella loro fenomenalità, nella loro umanità di vissuti. Solamente nel patico si e-siste.
Il sentir-si non è soltanto dell’emozione, ma di qualsiasi vissuto. Non solo non vi sono piacere e dolore, ma neppure percezione e ragionamento, immaginazione e ricordo, che siano tali, umani, se non sono intrisi di sentir-si, se non recano, sia pure nascosti ma sempre pronti a saltar fuori o almeno a far capolino tra le pieghe di qualsiasi atto del vivere, «lo stupore con cui si manifesta il sé» e «l’angoscia dell’esser toccati da eventi, senza perché». Ogni accadere tocca a me, proprio a me, senza che io sappia perché, così come non so questo me donde venga né dove vada, e neppure perché proprio a me questo me sia toccato.
Con l’«accadermi» la coscienza di me ogni volta salta fuori del suo con-sistere, e proprio in ciò io e-sisto. Essa qualifica il vissuto, il riferimento esplicito o implicito a un sé, coscienza riflessiva, autocentrata ancora prima che nella pubblicità della forma linguistica «io» e nella determinazione dialogico-concettuale. Insomma, se il vissuto è l’evento propriamente umano, la paticità è il nucleo intimo del vissuto, la fenomenalità di ogni fenomeno, l’arcisenso.
All’autocentramento però concorrono non soltanto la folgorante emozione del tempo, sofferto trauma della differenza, con la sua oscura figura del sé, ma pure la bruciante inquietudine dell’incontro con l’altro, il tacitamente interpellante, a me familiare o estraneo, seducente o minaccioso, comunque sempre enigmatico, tra me e lui reciprocità interiormente vissuta di speculari rimandi simpatetici o antipatetici. Nell’incontro, in ogni uomo l’immagine dell’altro lo anima del suo sé, e questa a sua volta intanto corrobora il sé di lui e lo arricchisce di tocchi. In questo vivo gioco di reciprocità ognuno si sovradetermina, enfatizzando sé come io e l’altro come tu.
L’emozione, in cui consiste il tempo, l’avvertimento «destabilizzante» di repentini cambiamenti, l’irrompere della differenza in noi, frantuma l’inerte identità dell’ente, ne distrugge l’apaticità, mette in moto la dialettica dell’altro nel sé di ognuno, e di ognuno nel sé dell’altro. La paticità è costitutiva dell’e-sistenza. Nella vertigine patica, sotto l’imperio del tempo, ci si ritrova comunque sempre da capo presso ad una soglia del nuovo, soli nel deserto di un assoluto «inizio». Tutto si ripete, nulla dura. Si danno infinite repliche, ma nessuna identica.
Il vissuto di tempo si rifrange nei molteplici cromatismi emotivi: nella sofferenza per l’identità perduta e l’abitualità sconvolta, nel tremore del destino incombente, nella insicurezza del rapporto con l’altro. Ma esso intero fiammeggia nell’inquietante sfida dell’inizialità, nel muoversi verso il nulla, il vuoto del futuro, a partire dal nulla, dal vuoto del passato. Nella paticità ogni volta, al centro della vita, le occasionali emozioni si “umanizzano”, da fatti naturali si ri-generano in prove umane. In umana anzi si ri-genera la vita tutta, da semplice vita vivente convertendosi in vita vissuta.
Nell’esplosa drammaticità dell’e-sistenza, l’oscuro avvertire che l’identità della coscienza di sé dura solo attraverso la difficile prova del suo incessante perdersi scatena l’emozione originaria, il vissuto decisivo. La morte non è che il caso estremo, la chiusura di partita, di tutte le infinite morti per cui la vita, che è «tempo» ma più propriamente l’incessante cambiamento delle cose (il sempre nuovo irrompere della differenza), fatalmente patisce la sua intrinseca precarietà non solo, dalla parte del dopo, nella straordinaria tragicità della catastrofe finale quanto pure, dalla parte del prima, in certa ordinaria catastroficità del quotidiano.
L’Arcisenso è impenetrabile, ma penetra di sé ogni esperienza. Esso contrasta l’intersoggettività, la relazione d’ogni singolo con gli altri, e tuttavia è condizione necessaria della sua possibilità. È evidente che il principio antropologico - l’idea con cui si comprende il senso di essere «uomo» -, si muove in un circolo. Punto di partenza e punto d’arrivo è sempre la relazione, ma in due versioni diverse. Tra il primo e il secondo funziona una cerniera, un medio: la solitudine. Questa può essere puro sentire o ragionata consapevolezza, ma è comunque paticità del sentir-si. Essa non sarebbe chiaramente e dolorosamente presente senza l’io, che si costituisce nella relazione, a cominciare dalla simbiosi bambino-madre.
A sua volta, senza la patita coscienza della solitudine, della propria separante differenza e unicità, cioè dell’irriducibile esclusività del proprio punto di vista, neppure esisterebbero la pluralità degli individui e la relazione sociale che ognuno d’essi strenuamente e in vari modi persegue, affaticandosi a costruire sistemi di comunicazione con altri soggetti-persone.
Senza l’incontro di un vivente con altri, nessun vissuto si avrebbe. I fenomeni patici e le fenomeno-patie non si originerebbero senza il gioco di una pluralità di viventi. L’ «universalità» della «verità» e dei «valori» in genere non se ne potrebbe generare nell’indifferenza. Essa può dischiudersi soltanto con il crescere dei vissuti nell’assidua e vivente reciprocità della «cura», nell’illimitato complicarsi delle relazioni sin-patetiche; nel sempre nuovo incrociarsi di Aufforderungen («appelli», «pro-vocazioni», «inviti»), come genialmente proponeva Fichte nel dedurre il fondamento intersoggettivo della soggettività e nell’annunziare con esso il significato nuovo dell’universalità dello «spirito».
Pensare l’assoluto non della morte, il nulla, ma della vita, è pensare la relazione, l’illimitata relazione di relazioni. Etico, o più propriamente ’path/ethico’, è il pensiero che, coltivando la sapienza del relativo, ci mantiene nella vita. Liberi.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". --- "L’arcisenso" secondo Aldo Masullo (di Sossio Giametta).24 luglio 2018, di Federico La Sala
L’arcisenso secondo Aldo Masullo
di Sossio Giametta («la Repubblica - Napoli», 06 aprile 2018)
Chi vuol sapere che cos’è la filosofia, in particolare la filosofia contemporanea (ma a partire da Fichte), chi vuole partecipare ai suoi misteri gaudiosi e dolorosi, provare su di sé la sua forza demoniaca, ed è disposto a farsi invadere perquisire violentare per essere affiliato alla ristretta, ma universale e sempiterna setta dei vedenti, raccolga le forze, si compri “L’arcisenso. Dialettica della solitudine” di Aldo Masullo (Quodlibet, pagine 190, euro 20), si liberi dalle incombenze quotidiane e si sprofondi nella lettura del libro. Se tutte queste condizioni non ricorrono e si preferisce rimanere nella beata ignoranza (Ignorance is Bliss), giacché non si tratta di babà e di gattò, anche se si rimane tra le eccellenze napoletane, allora: estote longe profani, statevene lontani, brava gente: si può vivere anche senza filosofia, sebbene non con la stessa larghezza, scialo e dignità.
Alle prime otto pagine mi sono spaventato. Sopra di me un oracolo, un medium, un mago, uno sciamano o non so quale personaggio sovrumano, dettava una dopo l’altra, in uno stile veloce conseguente perfetto ma a cui è arduo tener dietro, verità misteriche sulla vita e sull’uomo, sul soggetto, sulla soggettività, che “non è né essere né divenire, ma il sempre ricominciante “venire-a-sé”, sull’intersoggettività e sulla comunità che ne scaturiscono e sulla solitudine invincibile di fondo: un bagno freddo in un gelo ardente. Solo da pagina nove in poi, a cominciare da una bella citazione di Croce, ho ricominciato a respirare, a trovare un discorso più umano, più alla mia portata.
Ma la distruzione iniziata prima di nozioni e verità consolidate, idola di tutti i tipi, ma in particolare dell’uomo e del soggetto, continua. Si salva la “paticità”. Tutto comincia da essa anche se non finisce con essa. Che cos’è la paticità, “l’intoccabile tocco”? Be’, conoscete l’antipaticità? Il pathos, l’apatia? Sì? E allora ricavatevi anche quella. Tanto, se vi dico che è l’arcisenso, non vi aiuto molto. Ma vediamo se ci può aiutare invece quello che ne dice l’Autore, nel primo e nell’ultimo degli otto esplosivi capitoli del libro.
“Patico è il modo umano della coscienza. Esso è in atto in ogni momento del sentir-si. Le emozioni vi si umanizzano ed entrano nella e-sistenza”. Avete capito? Non ancora? Be’, pensateci sopra, finirete col capire più o meno, come più o meno ho capito io, anche grazie alle tante altre cose che l’Autore aggiunge. Per esempio: “la paticità è il nucleo intimo del vissuto, la fenomenalità di ogni fenomeno, l’Arcisenso”. “Il patico è il sentir-si che accompagna inseparabilmente ogni sentire”. Questa cosa fondamentale non è tuttavia né rappresentabile né comunicabile, e ciò rende la vita “radicalmente autocentrata”, cioè la solitudine di ognuno radicale e insuperabile. Non cominciate a vedere píù chiaro? Non c’è proprio un lume, ma un barlume sì.
L’uomo “non è un ente inerte, apatico”, ma “un e-sistente... esposto alle inquietanti relazioni con gli altri”. Insomma l’apatico è il sordo sentir-si di ognuno, un’oscurità, ma un’oscurità che porta alla luce dell’e-sistenza e della intersoggettività, giacché non c’è un Io senza almeno un altro Io, è un fatto naturale che si rigenera in prove umane. Qual è la sua fonte? È “la tensione dell’assoluta differenza (tra l’essere e il nulla) al cui irrompere si usa dare il nome di tempo”. Sul tempo se ne sentono delle belle nell’apposito capitolo “Durata”, che ha come sottotitolo Eraclito. Il desiderio eroico. Dove il desiderio eroico dell’uomo è il solo garante della durata nel tempo che distrugge tutto e in ogni istante anche se stesso.
Il discorso sulla paticità, che è centrale, è ripreso, come abbiamo detto, nell’ultimo capitolo. Questo è una Appendice. Nel labirinto della soggettività. Appunti per una autobiografia filosofica. Uno magari bada all’autobiografia e non al “labirinto” e pensa di trovare un’autobiografia come quella di Croce, di Vico, di Cartesio o di Spinoza.
 Ma invece no, è proprio un labirinto, un labirinto di concetti, soprattutto della soggettività, in cui a forza di scavare la filosofia contemporanea, a partire da Fichte, si è intrappolata per la sua logica intrinseca, scovando alla fine interessanti passaggi e vie di uscita. Il risultato è la negazione di “essenze, strutture, metaempiriche, universalità, o qualche sovrana architettura logico-ontologica, trascendente o trascendenta-le”: bye bye (se funziona) filosofia classica! Quella contemporanea porta al post-Dove moderno e si basa sulla fattuale e irriducibile differenza vissuta, sempre il patico, che porta alla reciprocità affettiva e al sin-patetico riconoscimento - “riconoscimento della pluralità [nella comunità] in cui consiste l’unità dell’umano”.
Ma invece no, è proprio un labirinto, un labirinto di concetti, soprattutto della soggettività, in cui a forza di scavare la filosofia contemporanea, a partire da Fichte, si è intrappolata per la sua logica intrinseca, scovando alla fine interessanti passaggi e vie di uscita. Il risultato è la negazione di “essenze, strutture, metaempiriche, universalità, o qualche sovrana architettura logico-ontologica, trascendente o trascendenta-le”: bye bye (se funziona) filosofia classica! Quella contemporanea porta al post-Dove moderno e si basa sulla fattuale e irriducibile differenza vissuta, sempre il patico, che porta alla reciprocità affettiva e al sin-patetico riconoscimento - “riconoscimento della pluralità [nella comunità] in cui consiste l’unità dell’umano”.Insomma, cari amici, ho cercato to put you in the picture, di introdurvi un po’ nell’atmosfera del libro, ma di più qui non posso dire, salvo che questo “Arcisenso” è un libro avventurioso, ricchissimo di “scandalose novità”, alle quali hanno contribuito quasi tutti i filosofi contemporanei, che hanno agito in questa impresa rivoluzionaria di concerto allo stesso modo in cui agisce nella scienza la collettività degli scienziati. Ma tutte queste novità sono magistralmente portate a unità con agilità da scoiattolo e piglio giovanile da un uomo che il 12 aprile ha compiuto 95 anni, che invera il detto di chi sostiene che il corpo invecchia solo per far ringiovanire lo spirito. Qui lo spirito è giovanissimo, lucidissimo, e l’Autore, come filosofo, non è affatto pronto per la “pensione”. Lo contrarierebbe infatti chi pensasse che questo libro, una sì vasta silloge, possa essere il “testamento spirituale” di Aldo Masullo. Molto bolle ancora in pentola e fra non troppo ci sorprenderà. Forse ci sconvolgerà. Se qualcosa si può timidamente obiettare ai suoi grandi capitoli (sul Dolore, sulla solitudine - magistrale saggio su Leopardi - sul silenzio, sulla sapienza e sulla grazia, è l’incredibile impetuosità, che lo porta a un’audacia capace di trasformarsi in temerarietà (accadde anche a Nietzsche). Molte sue soluzioni infatti sono così spinte che, pur ammirevoli come frutto di una felicissima inventività filosofica, non è facile, almeno immediatamente, far proprie. Quello che ci sentiamo di dire per un così geniale e illustre filosofo napoletano, che è anche un grande oratore, è quello che del filosofo dice un autore che spicca, rispetto a lui, per la brevità della sua vita, Pico Della Mirandola: “Se vedrai un filosofo discernere ogni cosa con netta ragione, veneralo; è animale celeste, non terrestre”.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA": LA LEZIONE DI DANTE (E NIETZSCHE), OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
Federico La Sala
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA". --- Masullo in «L’Arcisenso» torna al mistero della finitezza e del leopardiano «sentire corporale».25 luglio 2018, di Federico La Sala
Quella solitudine alle radici dell’uomo
Masullo in «L’Arcisenso» torna al mistero della finitezza e del leopardiano «sentire corporale»
di Massimo Adinolfi («Il Mattino», 07 marzo 2018)
La filosofia è preceduta da un nodo che si avverte nella vita vissuta e che esige di essere sciolto»: sono parole di Benedetto Croce, che Aldo Masullo cita nell’appendice del suo ultimo libro L’Arcisenso. Dialettica della solitudine (Quodlibet, pagine 194). È un motivo che non appartiene solo alla sua riflessione, ma anche alla sua vita, e che perciò apre i densissimi appunti per un’autobiografia filosofica, che chiudono il volume. Fosse anche solo per rileggere queste pagine, varrebbe la pena prendere questo volume prezioso. Perché in esse sono presenti tutti i nodi principali del pensiero di Masullo, intrecciati con le vicende della filosofia europea moderna e contemporanea. Di cui si possono cogliere, filtrati attraverso la sensibilità e l’acume di uno dei suoi protagonisti, temi e stili di pensiero: la morte del Soggetto e la ripresa di una filosofia della soggettività libera da ipoteche metafisiche; la fenomenologia e l’esistenzialismo; il recupero della tradizione italiana (Bruno, Vico) fino al confronto con i pensatori del Novecento (Gentile, Paci), e poi la frequentazione con gli autori con i quali Masullo si è intrattenuto una vita intera: Fichte, Husserl, Heidegger.
La densità dei riferimenti storico-culturali non toglie nulla alla felicità di una prosa che si mantiene sempre limpida, in grado di parlare con voce chiara e originale alle inquietudini del nostro tempo. La scelta delle parole guida che compongono questa sorta di piccolo vocabolario portatile è già di per sé indicativa del modo in cui la filosofia si declina per Masullo. Cioè come antropologia, come sapere dell’uomo, come parola dell’uomo per l’uomo, che vive solo nella ricchezza del dialogo, nella dimensione sempre aperta e mai definitiva del logos: paticità, dolore, durata, solitudine, silenzio, sapienza, grazi, definiscono non tanto gli oggetti quanto piuttosto il modo in cui la riflessione viene condotta, proprio come la vita è vita umana non perché riguardi la specie uomo, ma per il modo in cui l’uomo la vive, per il modo in cui la sente e anzi la patisce. Dalla ricca messe di spunti che questo libro offre, può essere utile coglierne tre, che hanno un valore e un interesse non solo per i cultori di cose filosofiche.
Il primo spunto riguarda il tema dell’intersoggettività, che Masullo è stato tra i primi a svolgere in Italia. Tuffala filosofia moderna si è in realtà confrontata con la minaccia del solipsismo, con l’idea cioè che non vi sia modo per riconoscere altra realtà al di fuori dell’Io: da Cartesio a Kant, da Wittgenstein a Gentile, il fantasma del solipsismo compare tutte le volte in cui il soggetto viene innalzato a fondamento, a luogo trascendentale di fondazione del senso. Ma cosa accade rinunciandovi?
Lungi dal trovarvi la «pluralità comunicante» dei soggetti, il pensiero contemporaneo vi ha scorto un risvolto puramente negativo, come se la comunità rappresentasse solo un sogno lontano, impossibile, proibito, invece di essere la fatica quotidiana della effettiva condizione umana.
Il secondo spunto riguarda la difesa del relativismo. Qui l’analisi concettuale condotta da Masullo riesce particolarmente utile, perché permette da un lato di condurre la critica di ogni assolutizzazione del relativo, restituendo all’umano la sua misura, ma anche, dall’altro, di riconoscerne la dignità, contestando «la volgare tendenza a confondere il relativismo con il nichilismo».
Questa confusione è particolarmente grave ai nostri giorni, segnati da ritorni integralisti e fondamentalisti: «Perfino la scuola, le istituzioni della formazione spesso risultano difetto finalizzate a seminare di assoluti i campi della mente giovanile». Masullo denuncia così quello che chiama il paradosso del nostro tempo, per cui «più si depotenziano i supremi assoluti pubblici, come lo Stato, la Chiesa, la nazione, la classe, tanto più si moltiplicano e rafforzano le assolutizzazioni private». In questa osservazione sta peraltro il senso di un intero magistero pedagogico e civile che il filosofo non ha mai smesso di esercitare negli spazi della ragione pubblica.
Il terzo spunto è però il più prezioso, e spiega il sottotitolo del libro: dialettica della solitudine. Perché l’uomo è anzitutto, nella sua radice “incomunicativa”, dolore e solitudine. In un tempo dominato dalla medicina performativa, dall’ossessione per la prestazione, dall’ottimizzazione non solo dei processi produttivi ma anche delle relazioni sociali e della vita stessa, questo richiamo al mistero umano della finitezza, alla fragilità del corpo e all’evento del Sentirsi da parte di un uomo che ha vissuto l’intera parabola del Novecento, contiene un monito ricco di umana saggezza. Non è un caso se l’ultima cosa scritta da Masullo e affidata a questo libro sia un saggio su Leopardi e sul «sentire corporale». Se la filosofia è anzitutto antropologia, il libro di Masullo ne è oggi un piccolo manifesto imprescindibile.
-
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA" -- Quanto è atavica la mentalità maschile. Una "risposta" di U. Galimberti.26 giugno 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!!:
- “De Testicoli delle donne”. Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap.15 dell’ ANATOMIA di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli delle donne”(p. 91).
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Lettere
Quanto è atavica la mentalità maschile
La donna che non genera è esposta a un dubbio logorante.
Ed è guardata ancora con sospetto
Risponde Umberto Galimberti *
- Si parla tanto di femminismo e parità dei sessi, ma io mi trovo all’età di 43 anni a dubitare che questa parità possa esistere davvero. Sostenuta da una famiglia in cui padre e madre hanno sempre avuto ruoli intercambiabili e paritari, pur essendo donna ho vissuto sempre secondo quello che i miei valori e il mio carattere mi avrebbero dettato, senza piegarmi, e ho considerato sopportabile un giusto prezzo da pagare per l’indipendenza. Finché non ho messo piede in quell’età in cui "l’orologio biologico" ticchetta più velocemente e tutti intorno a te si affrettano ad accoppiarsi e a riprodursi. E in un attimo gli amici di una vita spariscono e ti ritrovi davanti a una decisione incombente da cui sembra dipendere tutta la tua vita, la tua identità, il tuo futuro. Eppure tra mille dubbi senti che per te quella strada non funziona, che hai ancora molto da studiare, dare, fare e vedere, e che il tuo corpo intanto è invecchiato e non si convince dell’idea del "puoi avere figli senza rinunciare a niente" venduta dalla società della maternità romanticizzata e idealizzata.
 Concludo che l’idea della parità è una chimera. Arriva un momento in cui l’identità di una donna si arena davanti al bivio madre/non-madre. Qualunque altra cosa tu faccia come donna e come persona, sbiadisce, viene sminuita. Se non desideri essere madre, diventi una non-madre, prima di tutto. Non so perché scrivo a lei, che è un uomo, ma nelle sue risposte e nei suoi libri leggo una visione del mondo e delle cose che illumina ed evolve invece di auto-ribadirsi.
Concludo che l’idea della parità è una chimera. Arriva un momento in cui l’identità di una donna si arena davanti al bivio madre/non-madre. Qualunque altra cosa tu faccia come donna e come persona, sbiadisce, viene sminuita. Se non desideri essere madre, diventi una non-madre, prima di tutto. Non so perché scrivo a lei, che è un uomo, ma nelle sue risposte e nei suoi libri leggo una visione del mondo e delle cose che illumina ed evolve invece di auto-ribadirsi.
 virginial@email.it
virginial@email.it
Alla parità tra maschi e femmine non si arriverà mai, perché, non essendo in grado di generare, i maschi capiscono del mondo femminile unicamente quello che loro ritengono sia proprio della donna, e precisamente ciò che per natura a loro non è concesso. Svincolati dai ritmi della natura, i maschi, per occupare il tempo e non morire d’inedia nell’ozio, hanno inventato la storia, e in questa storia hanno inserito la donna come generatrice, madre dei loro figli, prostituta per le loro soddisfazioni sessuali e, a sentire Lévi-Strauss, il più grande antropologo del ’900, come merce di scambio nei loro traffici.
Un altro antropologo, Bronislaw Malinowski, riferisce che gli abitanti delle numerose tribù da lui visitate ignoravano il ruolo maschile nella generazione, e pur tuttavia, le donne da lui interrogate, rispondevano che tutti i figli assomigliano al padre, mentre la madre, genitrice riconosciuta dai suoi figli, non ha con essi alcuna somiglianza. La coppia parentale, "paritetica" nella riproduzione sessuale, diventa "gerarchica" nella rappresentazione sociale. A questo schema non sfugge neppure Aristotele per il quale "la femmina offre la materia e il maschio la forma", e neanche il mito cristiano di Maria Vergine, che con il suo corpo mette al mondo il figlio di Dio che di sé dice: "Io e il Padre siamo una sola cosa" (Gv. 10,30).
Questo impianto ideologico, che affonda negli abissi del tempo e della storia, governa ancora la mentalità maschile, che da qui prende spunto per esercitare il suo potere sul mondo femminile ridotto al rango di "materia", a proposito della quale Aristotele scrive: "La femmina desidera il maschio come la materia desidera la forma, il brutto desidera il bello".
A questo punto il dominio dell’uomo sulla donna appare come perfettamente "naturale", perché non c’è niente di più naturale e di più evidente del suo corpo fatto apposta per la generazione. Ebbene, proprio nella differenza tra il corpo dell’uomo e il corpo della donna si trova la prova inconfutabile del dominio del primo sulla seconda, di cui sono convinti non solo gli uomini, ma anche le donne che per secoli hanno trovato naturale il dominio esercitato su di loro da parte dell’uomo. Com’è noto, infatti, il potere non sta tanto nell’esercizio della sua forza, ma nel consenso dei dominati alla propria subordinazione.
È da questo consenso, quello dei subordinati, che lei si deve liberare. E liberandosi potrà persuadere la mente di qualche uomo e di qualche donna che la donna non è solo materia per la generazione e i piaceri sessuali, ma al pari dell’uomo può generare anche a un altro livello, quale può essere la realizzazione di sé nel mondo lavorativo, in quello culturale, persino in quello sessuale senza doversi ridurre alla pura e semplice opacità della materia. E se sente sopra di sé la disapprovazione di molti tra quanti le stanno intorno, sappia che dobbiamo fare a meno di mezzo mondo per poter generare il nostro mondo, che non è deciso solo dalla biologia al servizio della specie, perché la specie, come sappiamo, è interessata agli individui unicamente per la sua sopravvivenza. E dopo che hanno generato, nella sua crudeltà innocente, li destina alla morte, perché altri individui, nascendo e generando, le assicurino la sua vita.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. UN NUOVO SOGGETTO E "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA" -- "Utopie. Eterotopie". Di quale corpo ci parla Foucault? (di Francesco Bellusci)8 gennaio 2017, di Federico La Sala
Di quale corpo ci parla Foucault?di Francesco Bellusci *
“Posso andarmene in capo al mondo, nascondermi sotto le coperte la mattina, farmi il più piccolo possibile, posso pure liquefarmi al sole su una spiaggia, lui sarà sempre là dove sono io”. Chi è questo compagno assiduo che anticipa e mette sotto scacco ogni mio tentativo di separarmene? Chi o cos’è questa presenza con cui sono condannato a condividere sempre il mio spazio, le mie destinazioni, i miei soggiorni, persino i miei nascondigli? Chi o cosa non m’impedisce di cambiare posto, di andare altrove, eppure mi rende impossibile prenderne congedo? La risposta che Michel Foucault dà in una delle due conferenze radiofoniche sugli “spazi altri”, trasmesse nel dicembre 1966 (Le corps utopique - Les hétérotopies, Éditions Lignes, trad. it. Utopie. Eterotopie, Cronopio 2004 ) e poi riprese in un intervento presso il Cercle d’études architecturales nel marzo 1967, è semplice, facilmente intuibile, ma è anche l’ingresso nella prima di tante piccole e sorprendenti stanze di un testo tra i più belli, nonché tra i più trascurati, di un autore che pure annovera, come pochi, una bibliografia smisurata su quasi ogni pagina della sua variegatissima produzione. La risposta è: il “mio” corpo. Di quale corpo ci sta parlando Foucault?
Non è il corpo segregato del folle o il corpo medicalizzato del malato, di cui ha parlato nei libri precedenti. Non è nemmeno il corpo investito dai dispositivi del potere disciplinare o del biopotere, di cui parlerà in seguito: il corpo sorvegliato, punito, addestrato, curato, sessuato. Non sono, cioè, i segni del potere sul corpo, né il rapporto tra il potere e il corpo, ma il rapporto tra l’io e il corpo, il “suo” corpo, che Foucault prende in esame.
E lo fa, appunto, parlando in prima persona, con una mossa che spiazza sicuramente quanti, dopo la pubblicazione de Le parole e le cose avvenuta lo stesso anno, lo considerano già uno dei quattro moschettieri dello strutturalismo, insieme con Lévi-Strauss, Lacan e Althusser.
Mossa singolare che, forse, è all’origine del cono d’ombra sotto cui il testo cadrà, per effetto della sua, almeno di primo acchito, inspiegabile e improvvisa biforcazione rispetto ad un percorso che, fino a quel momento, ha posto l’accento sul soggetto come l’effetto e l’“oggettivazione” di strutture (epistemiche, discorsive, istituzionali) e non come la sorgente originaria delle sue esperienze e del senso.
In verità, come sempre accade in Foucault, si tratta di oscillazioni che sono il sintomo di direzioni più profonde della sua ricerca, più squisitamente filosofiche, solo episodicamente esplicitate da Foucault e, sovente, più nelle interviste che nei suoi saggi.
Si muove e mi fa muovere, dunque, il mio corpo, ma, impedendomi di uscire dal suo involucro, mi condanna a un luogo “fisso”, a uno spazio circoscritto e invalicabile, che corrisponde sempre al suo. “Spietata topia”: il corpo appare il contrario di ogni u-topia.
Eppure, se si guarda al corpo realmente vissuto, quel corpo-prigione che bloccherebbe sempre il mio passaggio da un “qui” a un “altrove”, quel corpo a cui appartengo più di quanto esso appartenga a me (ad esempio, quando la mattina, di fronte allo specchio, se potessi, deciderei volentieri di farne a meno o di averne un altro) si rivela inaspettatamente uno stimolo, una rampa di lancio verso i lidi dell’utopia.
All’inizio, è proprio il corpo a suscitare in me l’utopia, a spingermi a riscattarmi da esso, cancellando o contrastando la sua oggettività pesante, la sua materialità spessa. Ecco, allora, che mi ritrovo in un paese favoloso di folletti, fate, geni, maghi, principi e principesse, con corpi belli, splendenti, saettanti, invulnerabili, all’occorrenza invisibili: “È ben possibile - scrive Foucault - che l’utopia prima, quella più impossibile da sradicare dal cuore degli uomini, sia proprio l’utopia di un corpo incorporeo”. Oppure, mi ritrovo in una città sepolcrale, dove i corpi assumono le fattezze eternamente intatte della mummia o quelle marmoree, solide, figurative, di un dio.
Dalle tombe egizie agli abitanti del bosco di Sogno di una notte di mezza estate, dal bassorilievo della giovinetta sepolta del canto XXX di Leopardi al Mausoleo di Lenin, l’utopia del corpo incorporeo attraversa, inossidabile, innumerevoli secoli e civiltà della storia umana. Ma, dal fondo silenzioso di quella città, dal buio della terra cimiteriale, i corpi possono risorgere con lo stigma dell’incorruttibilità che non possedevano prima, come avviene ne
La resurrezione della carne di Luca Signorelli, affresco amato e menzionato da Foucault nella prima versione dell’introduzione all’Archeologia del sapere, intitolata “Le livre et le sujet” (Cahier Foucault, L’Herne 2011), poi derubricata. E cosa permette questa resurrezione se non la più potente tra le utopie che vorrebbero elidere il corpo stesso? Appunto, il mito dell’anima, che alberga nel corpo, dal quale difende e preserva la sua purezza e al quale, alla fine, sopravvive.
Ma queste utopie fiabesche, metafisiche, religiose, non nascono, a guardar bene, dal rigetto della gabbia del corpo o dal cercare di fuggire alla sua fragilità e corruzione nel tempo, bensì, proprio dalla sua costitutiva ambiguità, di cui facciamo sempre esperienza. Già di suo il “mio” corpo è curiosa intersezione di visibile e invisibile, aperture e chiusure, opacità e luminosità: non posso vedere il mio occhio che vede; non posso vedere la mia schiena, la mia nuca, ma solo sentirle appoggiate o toccate; ci sono cavità insondabili che tuttavia comunicano con l’esterno; la mia stessa nudità integrale resta imponderabile e captabile solo per frammenti nel miraggio effimero dello specchio. E così questo corpo è pieno di risorse per la mia fantasia, per le mie proiezioni e “irrealizzazioni” immaginarie, come avrebbe detto Sartre.
Per giunta, scopro che il mio corpo è trascendenza, è sempre fuori di sé, non è mai veramente solo “qui”, come una cosa tra le cose, ma aperto, proteso, impegnato nel mondo e su ciò che esso gli offre, verso le cose che si dispongono e si ordinano rispetto a lui: a destra e a sinistra, in alto e in basso. È qui e altrove, è qui e verso le cose dello spazio esterno che può usare, manipolare, evitare, desiderare, immaginare, e, quindi, anche verso le cose che esistono senza avere un luogo reale, che non si trovano da nessuna parte, ovvero si trovano in spazi fuori dal mondo, meravigliosi, levigati, misteriosi, terrifici, utopici.
È il corpo l’“attore principale di tutte le utopie”, ci dice Foucault, quando, ad esempio, si maschera, si trucca, si colora di tatuaggi, si dilata nella danza, persino quando si veste, per entrare in comunicazione con poteri segreti, codici cifrati e forze invisibili: “È al centro del mondo - scrive ancora Foucault - questo piccolo nucleo utopico a partire dal quale sogno, parlo, procedo, immagino, percepisco le cose al loro posto e anche le nego attraverso il potere infinito delle utopie che immagino. Il mio corpo è come la Città del Sole, non ha luogo, ma è da lui che nascono e si irradiano tutti i luoghi possibili, reali o utopici”. Un fuoco di utopie, che, nate al suo interno, può rivolgere contro se stesso, si rivela, infine, allora, quel corpo che all’inizio avevo percepito in opposizione a ogni utopia.
Ma per Foucault esistono delle esperienze che, seppure momentaneamente, placano la tensione utopica del corpo, lo riportano a rinchiudersi su di sé, gli assegnano uno spazio che lo limitano: la morte, lo specchio, l’amore. Il mio cadavere e la mia immagine riflessa nello specchio restano degli “altrove” inaccessibili e mi costringono a fare corpo col frammento di spazio che è il mio corpo. Analogamente, “nell’amore il corpo è qui”, perché nell’intimità con l’altro o l’altra, sono le sue dita, le sue labbra, che rivelano il mio corpo a se stesso, in tutta la sua densità.
Come si situa, ora, questa narrazione sul corpo originariamente esposto al mondo, punto zero del mondo, in quanto punto in cui si convogliano tutti i punti di riferimento spaziali, immaginari, temporali, sempre fuori di sé, sorgente e volontà di utopia, nella topografia teorica e concettuale di Foucault?
Nel 1980, in occasione di un’importante pubblicazione americana a lui dedicata (H. L. Dreyfus, P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, The University of Chicago Press 1982), Michel Foucault riassume il senso del lavoro svolto in due decenni come la ricerca storica su tre differenti modi di soggettivazione degli esseri umani nella nostra cultura.
Il soggetto che parla, vive, lavora, codificato dai discorsi che hanno vantato uno statuto scientifico. Il soggetto folle versus il soggetto normale, il malato versus il sano, il criminale versus il “bravo ragazzo”, così divisi dai dispositivi disciplinari e biopolitici. Infine, il soggetto che si costruisce nel rapporto di sé con sé, di cui l’ultimo Foucault rintraccia un esempio nelle forme della “cura di sé” dell’antichità greco-romana e ne auspica il reinnesto nel nostro tempo.
In tutti questi casi, il soggetto è immesso in “giochi di verità”, in altri termini è assoggettato oppure perviene a una verità su se stesso, comprendendosi, razionalizzandosi, dando uno sbocco teorico e pratico alla sua volontà di sapere la verità su se stesso.
Eppure, come ha messo bene in luce Davide Tarizzo (Il pensiero libero. La filosofia francese dopo lo strutturalismo, Raffaello Cortina Editore 2003), l’uomo foucaultiano reca con sé non solo l’impronta ontologica di un uomo orientato alla verità, ma anche quella di un fondo irriducibile di libertà, che lo porta, nel contempo, a non cristallizzarsi nei giochi di verità che l’oggettivano in un determinato soggetto, a resistere, a dislocarsi, a rimettere in movimento la sua stessa volontà di verità, di per sé inappagabile, per pensare, fare o essere diversamente.
Questa libertà, che Foucault non ha mai tematizzato direttamente ma sempre agitato come l’ombra dei processi di soggettivazione volta per volta descritti e storicamente contestualizzati, si esprime nella “follia” (intesa non come malattia mentale, “s-ragione”, ma come oscura sospensione del rapporto con la verità), come ragione critica, esemplare nella diagnosi kantiana dell’illuminismo, e, possiamo aggiungere, attraverso la dispersione e il potere utopico del corpo.
Sicché, se è vero che Foucault ha messo al centro delle sue ricerche non il potere ma il soggetto, come egli stesso ha rivendicato in modo insistente negli anni precedenti la sua prematura scomparsa, non avremmo tutti i torti a pensare che questo equivalga a dire che al centro delle sue ricerche c’è la libertà, considerato che, come scrive sempre nel suo contributo al libro di Dreyfus e Rabinow, “nel cuore della relazione di potere, e a provocarla costantemente, c’è la resistenza della volontà e l’intransigenza della libertà”.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO -- Come punto di partenza una formula di Lacan: “l’amore è sempre eterosessuale” (di M. Recalcati)3 maggio 2016, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. IL PROGRAMMA DI KANT: BISESSUALITA’ PSICHICA E DIFFERENZA SESSUALE - UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA":
I tabù del mondo
Si fa presto a dire famiglia
 La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, ha bisogno di casa, radici, appartenenza non si accontenta della biologia, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta
La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, ha bisogno di casa, radici, appartenenza non si accontenta della biologia, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta
 Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il sesso dei genitori o con la capacità di generare
Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il sesso dei genitori o con la capacità di generare
 Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni contengono una profonda contraddizione in termini?
Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni contengono una profonda contraddizione in termini?di Massimo Recalcati (la Repubblica, 01.05.2016)
Famiglia è ancora una parola decente che può essere pronunciata senza provocare irritazione, fanatismi o allergie ideologiche? Famiglia è ancora una condizione fondamentale e irrinunciabile del processo di umanizzazione della vita oppure è un tabù da sfatare? Se c’è stato un tempo nel quale essa appariva circondata da un alone di sacralità inviolabile non rischia forse oggi di essere condannata come una sopravvivenza ottusa della civiltà patriarcale? Sono solo i cattolici più intransigenti a sostenere la sua esistenza come indispensabile alla vita umana?
Dal punto di vista laico della psicoanalisi la famiglia resta una condizione essenziale per lo sviluppo psichico ed esistenziale dell’essere umano. La vita umana ha bisogno di casa, radici, appartenenza. Essa non si accontenta di vivere biologicamente, ma esige di essere umanamente riconosciuta come vita dotata di senso e di valore. Lo mostrava “sperimentalmente” un vecchio studio di Renè Spitz sui bambini inglesi orfani di guerra che dovettero subire il trauma della ospedalizzazione (Il primo anno di vita del bambino, Giunti 2009).
La solerzia impeccabile delle cure somministrate dalle infermiere del reparto nel soddisfare tutti i bisogni cosiddetti primari dei bambini non erano sufficienti a trasmettere loro il segno irrinunciabile dell’amore. Effetto: cadute depressive gravi, anoressia, abulia, marasma, stati di angoscia, decessi. Se la vita del figlio non è raccolta e riconosciuta dal desiderio dell’Altro, resta una vita mutilata, cade nell’insignificanza, si perde, non eredita il sentimento della vita.
 Non è forse questa la funzione primaria e insostituibile di una famiglia? Accogliere la vita che viene alla luce del mondo, offrirle una cura capace di riconoscere la particolarità del figlio, rispondere alla domanda angosciata del bambino donando la propria presenza.
Non è forse questa la funzione primaria e insostituibile di una famiglia? Accogliere la vita che viene alla luce del mondo, offrirle una cura capace di riconoscere la particolarità del figlio, rispondere alla domanda angosciata del bambino donando la propria presenza.La clinica psicoanalitica ha riconosciuto da sempre l’importanza delle prime risposte dei genitori al grido del figlio. Non si tratta solo di soddisfare i bisogni primari perché la vita umana non è la vita di una pianta, né quella dell’animale, non esige solo il soddisfacimento dei bisogni, ma domanda la presenza del desiderio dell’Altro; vive, si nutre del desiderio dell’Altro. La vita umana non vive di solo pane, ma dei segni che testimoniano l’amore.
L’attualità politica ci impone a questo punto una domanda inaggirabile: tutto questo concerne la natura del sesso dei genitori? Essere capaci di rispondere alla domanda d’amore del figlio dipende dalla esistenza di una coppia cosiddetta eterosessuale? La famiglia come luogo dove la vita del figlio viene accolta e riconosciuta come vita unica e insostituibile - ogni figlio è sempre “figlio unico”, afferma Levinas, - è un dato naturale, un evento della biologia?
 Siamo sicuri che l’amore di cui i figli si nutrono scaturisca, come l’ovulo o lo spermatozoo, dalla dimensione materialistica della biologia? Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni che riflettono una concezione naturale della famiglia contengono una profonda e insuperabile contraddizione in termini?
Siamo sicuri che l’amore di cui i figli si nutrono scaturisca, come l’ovulo o lo spermatozoo, dalla dimensione materialistica della biologia? Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni che riflettono una concezione naturale della famiglia contengono una profonda e insuperabile contraddizione in termini?Se, infatti, quello che nutre la vita rendendola umana non è il “seno”, ma il “segno” dell’amore, possiamo davvero ridurre la famiglia all’evento biologico della generazione? Non saremmo invece obbligati a considerare, più coerentemente, che un padre non può essere mai ridotto allo spermatozoo così come una madre non può mai essere ridotta ad un ovulo?
La domanda si allarga inevitabilmente: cosa significa davvero diventare genitori? Lo si diventa biologicamente o quando si riconosce con un gesto simbolico il proprio figlio assumendosi nei suoi confronti una responsabilità illimitata?
 Le due cose non si escludono ovviamente, ma senza quel gesto la generazione biologica non è un evento sufficiente a fondare la genitorialità. In questo senso Françoise Dolto affermava che tutti i genitori sono genitori adottivi.
Le due cose non si escludono ovviamente, ma senza quel gesto la generazione biologica non è un evento sufficiente a fondare la genitorialità. In questo senso Françoise Dolto affermava che tutti i genitori sono genitori adottivi.Generare un figlio non significa già essere madri o padri. Ci vuole sempre un supplemento ultra-biologico, estraneo alla natura, un atto simbolico, una decisione, un’assunzione etica di responsabilità. Un padre e una madre biologica possono generare figli disinteressandosi completamente del loro destino. Meritano davvero di essere definiti padri e madri? E quanti genitori adottivi hanno invece realizzato pienamente il senso dell’essere padre e dell’essere madre pur non avendo alcuna relazione biologico-naturale coi loro figli?
Questo ragionamento ci spinge a riconsiderare l’incidenza del sesso dei genitori. Ho già ricordato come l’amore sia a fondamento della vita del figlio. Ma l’amore ha un sesso?
Prendiamo come punto di partenza una formula di Lacan: “l’amore è sempre eterosessuale”. Come dobbiamo intendere seriamente l’eterosessualità? Questa nozione, per come Lacan la situa a fondamento dell’amore, non può essere appiattita sulla differenza anatomica dei sessi secondo una logica elementare che li differenzia a partire dalla presenza o meno dell’attributo fallico.
L’amore è eterosessuale nel senso che è sempre e solo amore per l’Altro, per l’eteros. E questo può accadere in una coppia gay, lesbica o eterosessuale in senso anatomico. Non è certo l’eterosessualità anatomica - come l’esperienza clinica ci insegna quotidianamente - ad assicurare la presenza dell’amore per l’eteros! È invece solo l’eterosessualità dell’amore a determinare le condizioni migliori affinchè la vita del figlio possa trovare il suo ossigeno irrinunciabile.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO -- LACAN, FACHINELLI, E UNA NUOVA LINGUA PER LA PSICOANALISI (di Massimo Recalcati).11 aprile 2016, di Federico La Sala
- Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
 CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
- PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET.
- METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PIER ALDO ROVATTI INCONTRA ELVIO FACHINELLI.
Elvio Fachinelli: una nuova lingua per la psicoanalisi
di Massimo Recalcati (Doppiozero, 01.04.2016)
La recente pubblicazione di alcuni scritti politici di Elvio Fachinelli, curati con attenzione dal filosofo Dario Borso, col titolo semplice ma suggestivo Al cuore delle cose (DeriveApprodi, Roma), suggerisce un bilancio dell’opera di una tra le figure più notevoli e originali della psicoanalisi italiana.
Non a caso Jacques Lacan aveva sempre considerato, sin dalla fine degli anni sessanta, il giovane Elvio Fachinelli come il suo erede più promettente in Italia, il quale però, non a caso, come tutti i suoi migliori allievi, aveva fatta propria l’indicazione di Lacan: “fate come me, non imitatemi!”. In Fachinelli, nella persona e nell’opera, non ritroviamo, infatti, nessuna di quelle farsesche riproduzioni dello stile di Lacan - alla Verdiglione per intenderci - che hanno contrassegnato e penalizzato gravemente la diffusione del lacanismo in Italia negli anni Settanta.
Fachinelli, pur conservando una posizione critica nei confronti del suo establishment, resta membro della Società psicoanalitica italiana rifiutandosi di finire fagocitato nel culto della personalità del grande psicoanalista francese - destino fatale per quasi tutti i suoi allievi, francesi e non.
 E tuttavia, considerando l’itinerario del suo lavoro teorico, risulta evidente come egli si sia ricollegato, sebbene in modo mai scolastico, ad alcune profonde intuizioni di Lacan conferendo loro uno sviluppo singolare. Prima fra tutte lo sforzo, avvertito da entrambi come necessario, di costruire una nuova lingua della psicoanalisi. Il codice della psicoanalisi si è logorato, cristallizzato, è divenuto un tecnicismo senza vita nel quale il discorso universitario (per Lacan “l’ignoranza consolidata”) ha preso il sopravvento reificando in categorie morte la vitalità che permeava il discorso originario di Freud.
E tuttavia, considerando l’itinerario del suo lavoro teorico, risulta evidente come egli si sia ricollegato, sebbene in modo mai scolastico, ad alcune profonde intuizioni di Lacan conferendo loro uno sviluppo singolare. Prima fra tutte lo sforzo, avvertito da entrambi come necessario, di costruire una nuova lingua della psicoanalisi. Il codice della psicoanalisi si è logorato, cristallizzato, è divenuto un tecnicismo senza vita nel quale il discorso universitario (per Lacan “l’ignoranza consolidata”) ha preso il sopravvento reificando in categorie morte la vitalità che permeava il discorso originario di Freud.
 Si rilegga in questa luce la breve introduzione a La freccia ferma (1979) dove Fachinelli dichiara esplicitamente di voler mettere tra parentesi la terminologia psicoanalitica “classica - “irrigidita in un formulario ipostatizzato che spesso impedisce, anziché facilitare, la comprensione delle situazioni concrete" - al fine di poter seguire con maggiore coerenza il filo della sua interrogazione originale sul senso del tempo.
Si rilegga in questa luce la breve introduzione a La freccia ferma (1979) dove Fachinelli dichiara esplicitamente di voler mettere tra parentesi la terminologia psicoanalitica “classica - “irrigidita in un formulario ipostatizzato che spesso impedisce, anziché facilitare, la comprensione delle situazioni concrete" - al fine di poter seguire con maggiore coerenza il filo della sua interrogazione originale sul senso del tempo.Il punto ancora più rilevante è che la grande e raffinata descrizione della nevrosi ossessiva che egli sviluppa in questo primo lavoro finisce per coincidere con l’involuzione della dottrina psicoanalitica stessa che, alla stregua del suo paziente gravemente ossessivo, dall’essere stata una impresa originariamente sovversiva si è trasfigurata “nel battito impersonale di una macchina morale”. La pietrificazione mortificante del soggetto ossessivo coincide dunque con quella che ha investito la dottrina psicoanalitica. Fu lo stesso problema che attraversò il pensiero di Lacan, il quale si sforzò, nel suo stesso stile di insegnamento, di trovare una lingua in grado di riflettere, se non addirittura di imitare, le infinite tortuosità dell’oggetto di cui la psicoanalisi si occupa (l’inconscio).
 Solo che mentre Lacan prende risolutamente la via di una lingua formalmente barocca ma capace di generare una batteria impressionante di concetti inediti, Fachinelli, meno magistralmente, adotta piuttosto quella di un ricorso sempre più frequente all’esperienza fenomenologica capace di raggiungere il cuore delle “cose stesse” sospendendo, con una epochè di fatto, i codici ormai logori e rituali della dottrina psicoanalitica classica.
Solo che mentre Lacan prende risolutamente la via di una lingua formalmente barocca ma capace di generare una batteria impressionante di concetti inediti, Fachinelli, meno magistralmente, adotta piuttosto quella di un ricorso sempre più frequente all’esperienza fenomenologica capace di raggiungere il cuore delle “cose stesse” sospendendo, con una epochè di fatto, i codici ormai logori e rituali della dottrina psicoanalitica classica.Ma il punto dove più sensibilmente si manifesta il lacanismo originale di Fachinelli concerne proprio lo statuto epistemico dell’inconscio. Come per Lacan, anche per lui l’inconscio non è l’istintuale, l’irrazionale, l’animale che un rafforzamento pianificato dell’Io - posto come obbiettivo principale della terapia analitica - dovrebbe governare sino a sedare. Fachinelli si mantiene sulla via aperta da Lacan nel ritenere che l’inconscio non sia il luogo di una minaccia che deve essere scongiurata ma di una apertura che diventa una occasione di trasformazione del soggetto.
 Più radicalmente, per Fachinelli la dottrina psicoanalitica è stata colpevole di essersi eretta come una vera e propria “difesa” nei confronti dell’inconscio finendo per perdere il contenuto più specifico della propria invenzione. È lo stesso giudizio che Jacques Derrida dava di Freud: se per un lato questi aveva con un primo passo sovversivo aperto la ragione all’incontro con l’alterità radicale della follia, con un secondo passo aveva invece provato a colonizzare quella alterità attraverso la concettualizzazione razionale della propria dottrina.
Più radicalmente, per Fachinelli la dottrina psicoanalitica è stata colpevole di essersi eretta come una vera e propria “difesa” nei confronti dell’inconscio finendo per perdere il contenuto più specifico della propria invenzione. È lo stesso giudizio che Jacques Derrida dava di Freud: se per un lato questi aveva con un primo passo sovversivo aperto la ragione all’incontro con l’alterità radicale della follia, con un secondo passo aveva invece provato a colonizzare quella alterità attraverso la concettualizzazione razionale della propria dottrina.La tesi di Fachinelli diventa sempre più chiara e audace col passare degli anni. Quello che ne La freccia ferma attribuiva a una certa degenerazione scolastica della psicoanalisi, ne La mente estatica (1989) viene descritto come un problema già presente nell’originaria posizione di Freud. Per Fachinelli la psicoanalisi stessa, già con Freud, tende a difendersi dall’inconscio, non essendo altro che un tentativo (“infantile”) di arginare la sua potenza e la sua forza eccedente.
 L’apertura de La mente estatica, nell’intensissimo racconto fenomenologico delle proprie percezioni sulla spiaggia di San Lorenzo, pone al centro l’interpretazione di Freud e della psicoanalisi come barriere, argini, barricate nei confronti dell’eccedenza dell’inconscio.
L’apertura de La mente estatica, nell’intensissimo racconto fenomenologico delle proprie percezioni sulla spiaggia di San Lorenzo, pone al centro l’interpretazione di Freud e della psicoanalisi come barriere, argini, barricate nei confronti dell’eccedenza dell’inconscio.
 La sua tesi è chiara: “la psicoanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi, controllare, stare, attenti, allontanare... Ma certo questo è il suo limite: l’idea di un uomo che sempre deve difendersi, sin dalla nascita, e forse anche prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato”
La sua tesi è chiara: “la psicoanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi, controllare, stare, attenti, allontanare... Ma certo questo è il suo limite: l’idea di un uomo che sempre deve difendersi, sin dalla nascita, e forse anche prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato”Questa “apologia della difesa” dall’inconscio anziché rendere possibile l’incontro con l’inconscio come occasione, apertura, evento stesso dell’apertura, finisce per sbarrarne l’accesso, per richiudere anziché aprire l’inconscio. Vigilanza ossessiva, senso perenne del pericolo, rafforzamento delle barriere difensive. È la metafora, giudicata da Fachinelli “soffocante”, che Freud in Introduzione alla psicoanalisi offre dell’inconscio come “salotto” borghese separato dall’“anticamera”. Metafora “triste come la sua casa in Bergasse, con la finestra dello studio rivolta ad un muro di cemento”[1].
 La stessa tristezza che orienta il simbolismo psicoanalitico che finisce per ridurre in modo angusto la potenza e la bellezza del mare a simbolo della madre senza cogliere che, caso mai, come fa notare Ferenczi, opportunamente citato da Fachinelli, si dovrebbe dire il contrario, ovvero che è la madre a simboleggiare il mare. È la “miseria” che ispira la cosiddetta psicoanalisi applicata all’esperienza estetica che finisce per trasformare l’artista in un paziente e la sua opera nel suo sintomo, quando, invece, come giustamente ricorda Fachinelli, “la legna da ardere non spiega il perché del divampare del fuoco”.
La stessa tristezza che orienta il simbolismo psicoanalitico che finisce per ridurre in modo angusto la potenza e la bellezza del mare a simbolo della madre senza cogliere che, caso mai, come fa notare Ferenczi, opportunamente citato da Fachinelli, si dovrebbe dire il contrario, ovvero che è la madre a simboleggiare il mare. È la “miseria” che ispira la cosiddetta psicoanalisi applicata all’esperienza estetica che finisce per trasformare l’artista in un paziente e la sua opera nel suo sintomo, quando, invece, come giustamente ricorda Fachinelli, “la legna da ardere non spiega il perché del divampare del fuoco”.In gioco come si vede è per Fachinelli, come del resto per Lacan, lo statuto stesso del soggetto dell’inconscio. Come intendere l’inconscio senza ricondurlo paranoicamente a una minaccia? Come pensare l’eccedenza che ci abita? Come interpretare quella trascendenza che pur essendo interna al soggetto lo trascende? In diverse occasioni Fachinelli ha ricordato, a questo proposito, l’importanza della rilettura lacaniana del famoso detto di Freud Wo es war soll Ich werden (tradotto da Cesare Musatti in italiano: “Dove era l’Es deve subentrare l’Io”) che conclude la celebre lezione 31 della nuova serie di lezioni di Introduzione alla psicoanalisi.
 Quello che Fachinelli trova decisivo di questa lettura è l’accento nuovo che Lacan pone non tanto sull’Io come istanza deputata a bonificare l’Es, ma sull’Es come luogo di una apertura inedita, di una possibilità nuova e, al tempo stesso, antica, scritta da sempre, che chiama il soggetto alla sua ripresa, alla sua soggettivazione in avanti. In questo senso Fachinelli si spinge a pensare, con Lacan, l’inconscio al futuro, all’avvenire; non come mera ripetizione del già stato, ma come non ancora realizzato.
Quello che Fachinelli trova decisivo di questa lettura è l’accento nuovo che Lacan pone non tanto sull’Io come istanza deputata a bonificare l’Es, ma sull’Es come luogo di una apertura inedita, di una possibilità nuova e, al tempo stesso, antica, scritta da sempre, che chiama il soggetto alla sua ripresa, alla sua soggettivazione in avanti. In questo senso Fachinelli si spinge a pensare, con Lacan, l’inconscio al futuro, all’avvenire; non come mera ripetizione del già stato, ma come non ancora realizzato.
 Per questa ragione in La mente estatica può scrivere che il sogno non è solo la ripetizione di tracce mnestiche già scritte, ma il testimone di “ciò che vuoi essere” e di “ciò che puoi essere". Si tratta di cogliere “l’inaudita penetranza dell’inconscio”, la sua capacità di “creare il futuro”. In altri termini il sogno non è più il prodotto di una difesa dall’inconscio - di una attività di censura - ma una chiamata dove qualcosa - una trascendenza interna al soggetto, direbbe Lacan - si manifesta, “osa”.
Per questa ragione in La mente estatica può scrivere che il sogno non è solo la ripetizione di tracce mnestiche già scritte, ma il testimone di “ciò che vuoi essere” e di “ciò che puoi essere". Si tratta di cogliere “l’inaudita penetranza dell’inconscio”, la sua capacità di “creare il futuro”. In altri termini il sogno non è più il prodotto di una difesa dall’inconscio - di una attività di censura - ma una chiamata dove qualcosa - una trascendenza interna al soggetto, direbbe Lacan - si manifesta, “osa”.Un secondo grande tema della riflessione di Fachinelli, presentissimo anche in questa ultima raccolta di scritti politici, è quello del legame sociale, o, più precisamente, della possibilità di realizzare una comunità umana non alienata: è possibile emancipare le relazioni tra chi gestisce il potere e chi lo subisce essendone escluso? “È utopico pensare di costituire delle relazioni di eguaglianza tra non uguali?”, si chiede Fachinelli. La relazione di uguaglianza non può essere una relazione che appiattisce le differenze ma che le emancipa dall’incubo della “dipendenza". La relazione di uguaglianza non può mai essere tra uguali. Per questo Fachinelli ribadisce che essa può accadere solo se implica l’esistenza di non eguali. Non si dà, infatti, Comunità possibile se non sullo sfondo di una impossibilità condivisa: l’impossibilità della Comunione, di fare e di essere Uno con l’Altro, di scrivere il rapporto sessuale, direbbe Lacan.
È questo un tema decisivo in Fachinelli (la sola condizione in comune è l’impossibilità del comune), che troverà, in anni più recenti, in Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben e Roberto Esposito sviluppi considerevoli. Ma la particolarità psicoanalitica e non filosofica della riflessione di Fachinelli consiste nel mettere in connessione la problematica della Comunità con quella della femminilità.
 Anche con questa mossa egli mostra di conoscere bene la lezione che Lacan sviluppa a ridosso del 1968, in particolare nel Seminario XX (1972-73), sul rapporto tra sessuazione maschile e sessuazione femminile considerate come possibilità di declinare, in modi diversi, il legame sociale.
Anche con questa mossa egli mostra di conoscere bene la lezione che Lacan sviluppa a ridosso del 1968, in particolare nel Seminario XX (1972-73), sul rapporto tra sessuazione maschile e sessuazione femminile considerate come possibilità di declinare, in modi diversi, il legame sociale.
 Nel caso della sessuazione maschile o fallica il fondamento del legame è concepito a partire dall’eccezione che si sottrae alla regola e che garantisce attraverso la sua sovranità l’immedesimazione e l’eguaglianza dei suoi membri. Si tratta di un modello che trova il suo fondamento nel mito freudiano dell’orda come Freud afferma in Totem e tabù: è il padre totemico, quello che gode di tutte le donne, a garantire l’esistenza dell’eccezione sulla quale si fonda il patto tra i fratelli.
Nel caso della sessuazione maschile o fallica il fondamento del legame è concepito a partire dall’eccezione che si sottrae alla regola e che garantisce attraverso la sua sovranità l’immedesimazione e l’eguaglianza dei suoi membri. Si tratta di un modello che trova il suo fondamento nel mito freudiano dell’orda come Freud afferma in Totem e tabù: è il padre totemico, quello che gode di tutte le donne, a garantire l’esistenza dell’eccezione sulla quale si fonda il patto tra i fratelli.
 Diversamente, la sessuazione femminile non è garantita dall’esistenza di una eccezione esterna a fondamento dell’insieme, dell’eccezione che sfugge, come il padre dell’orda, alla Legge della castrazione. In questo caso non è più l’eccezione che fonda la regola ma è l’eccezione stessa che diventa la regola. L’insieme femminile non è fondato sull’identificazione verticale all’eccezione ma sulla sua distribuzione orizzontale. Se, come ripete Lacan, La donna all’universale non esiste è perché esistono le donne al singolare, una per una, come incarnazioni singolari e non seriali dell’eccezione: è perché l’eccezione non fonda la regola ma è la regola.
Diversamente, la sessuazione femminile non è garantita dall’esistenza di una eccezione esterna a fondamento dell’insieme, dell’eccezione che sfugge, come il padre dell’orda, alla Legge della castrazione. In questo caso non è più l’eccezione che fonda la regola ma è l’eccezione stessa che diventa la regola. L’insieme femminile non è fondato sull’identificazione verticale all’eccezione ma sulla sua distribuzione orizzontale. Se, come ripete Lacan, La donna all’universale non esiste è perché esistono le donne al singolare, una per una, come incarnazioni singolari e non seriali dell’eccezione: è perché l’eccezione non fonda la regola ma è la regola.
 In questo senso Fachinelli concepisce in una pagina fondamentale dell’articolo titolato Desiderio dissidente, apparso originariamente in Il bambino dalle uova d’oro e poi in Al cuore delle cose, riprendendo la classica distinzione lacaniana tra bisogno e desiderio ne propone una applicazione originale alla clinica dei gruppi umani.
In questo senso Fachinelli concepisce in una pagina fondamentale dell’articolo titolato Desiderio dissidente, apparso originariamente in Il bambino dalle uova d’oro e poi in Al cuore delle cose, riprendendo la classica distinzione lacaniana tra bisogno e desiderio ne propone una applicazione originale alla clinica dei gruppi umani.
 Il gruppo che preserva la sua generatività è quello che è capace di interpretare il desiderio non a partire dal suo Oggetto ma come una condizione, come uno “stato” che abbandona l’illusione che possa esistere un Oggetto del desiderio. Solo se il gruppo si sottrare a questa illusione riesce a non scadere in un “gruppo di bisogno” che intrattiene fatalmente rapporti di dipendenza con l’Oggetto che viene incarnato fatalmente dal leader. In questo modo il desiderio da impresa collettiva viene sequestrato in una cristallizzazione transferale all’Uno solo che priva i membri del gruppo di ogni facoltà critica rendendoli degli adepti[2].
Il gruppo che preserva la sua generatività è quello che è capace di interpretare il desiderio non a partire dal suo Oggetto ma come una condizione, come uno “stato” che abbandona l’illusione che possa esistere un Oggetto del desiderio. Solo se il gruppo si sottrare a questa illusione riesce a non scadere in un “gruppo di bisogno” che intrattiene fatalmente rapporti di dipendenza con l’Oggetto che viene incarnato fatalmente dal leader. In questo modo il desiderio da impresa collettiva viene sequestrato in una cristallizzazione transferale all’Uno solo che priva i membri del gruppo di ogni facoltà critica rendendoli degli adepti[2].
 Allora, conclude il suo ragionamento Fachinelli, “il gruppo di desiderio diviene un gruppo di bisogno”. Ma anche in questo caso, come si vede, il punto prospettico resta quello di una valorizzazione del femminile come antidoto alle tendenze settarie e totalitarie, dipendenti, del gruppo.
Allora, conclude il suo ragionamento Fachinelli, “il gruppo di desiderio diviene un gruppo di bisogno”. Ma anche in questo caso, come si vede, il punto prospettico resta quello di una valorizzazione del femminile come antidoto alle tendenze settarie e totalitarie, dipendenti, del gruppo.
 È questo il punto dove la sua concezione dell’inconscio, che ho inizialmente riassunto, si incrocia risolutamente con la problematica della sessuazione femminile. Fachinelli è davvero esplicito su questo punto. Da una parte riconduce il gruppo di bisogno, il gruppo morto a livello del desiderio, a una declinazione solo fallica della Comunità, ovvero a una concezione dell’inconscio come minaccia che dà luogo, come abbiamo visto, a una concezione paranoica della terapia come difesa, arginamento, antagonismo verso l’inconscio stesso.
È questo il punto dove la sua concezione dell’inconscio, che ho inizialmente riassunto, si incrocia risolutamente con la problematica della sessuazione femminile. Fachinelli è davvero esplicito su questo punto. Da una parte riconduce il gruppo di bisogno, il gruppo morto a livello del desiderio, a una declinazione solo fallica della Comunità, ovvero a una concezione dell’inconscio come minaccia che dà luogo, come abbiamo visto, a una concezione paranoica della terapia come difesa, arginamento, antagonismo verso l’inconscio stesso.Questa versione dell’inconscio risente di una priorità del “sistema vigilanza-difesa” ed ha, precisa Fachinelli, una chiara “impostazione virile" L’alternativa all’esclusione dell’inconscio sarà allora quella della sua ospitalità, della sua accoglienza. Si tratta di un movimento di apertura che riguarda innanzitutto gli psicoanalisti e la psicoanalisi: “Accogliere chi? Un ospite interno. Accoglierlo prima di esaminarlo ed eventualmente respingerlo. Intrepidezza, atteggiamento infinitamente più ricco e alla fine forse più efficace della prudenza di chi edifica muraglie". In sintesi estrema si tratta di accogliere l’inconscio come eccedenza, di dare “accoglienza del femminile”. Ci si deve incamminare, come suggeriva anche Lacan, in una direzione opposta a quella della compattezza identitaria che caratterizza la sessuazione maschile: “diminuzione della vigilanza, allentamento della difesa”. Sebbene, come precisa giustamente Fachinelli, questa nuova via non si configuri affatto come il rovesciamento simmetrico della prima. Piuttosto si tratta, ancora una volta, di mettere in movimento “un’altra logica”. Di nuovo risorge il problema della lingua, di un’altra lingua per la psicoanalisi. “Come scrivere tutto questo?”, si chiede Fachinelli. Come, dunque? Come dare figura all’eccedenza irraffigurabile del femminile? All’ospite che ci attraversa? “Vento sulla fronte, rombo del mare, luce, torpore, pensiero dell’accettazione, gioia con senso di gratitudine, verso chi?”.
***
[1] Anche la lettura che Fachinelli propone del noto episodio autobiografico raccontato da Freud relativamente a un disturbo della memoria accadutogli sull’Acropoli è assai significativa. La sua tesi è che questo disturbo denuncia l’avvertimento di una “gioia eccessiva eppure reale, che minaccia di sconvolgere un equilibrio, un’intera economia psichica - di qui un dubbio radicale di realtà, di tale violenza da funzionare come barriera”.
[2] L’opposizione che viene sviluppata ne La mente estatica tra religione e misticismo riflette l’opposizione tra gruppo del bisogno e gruppo del desiderio. Mentre il mistico non teme il rapporto con la “gioia eccessiva”, con l’assoluto tutto o l’assoluto nulla, il religioso si costituisce come argine nei confronti dell’Altro godimento aperto dal mistico: “il mistico eccede ogni religione - e perciò il religioso, nel suo fondo, rifiuta il mistico”.
- Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- E I "PRINCIPI DELLA FILOSOFIA DELL’AVVENIRE" DI FEUERBACH. L’antropologo materialista (di Giuseppe Bedeschi).11 aprile 2016, di Federico La Sala
Ludwig Feuerbach (1804-1872)
L’antropologo materialista
La sua grande fortuna grazie a Karl Marx ha messo in ombra il tema fondamentale del ritorno all’uomo e ai suoi bisogni di fondo
di Giuseppe Bedeschi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 10.04.2016)
- Ludwig Feuerbach, Princìpi della filosofia dell’avvenire, a cura di Piergiorgio Bianchi, Orthotes Editrice, Nocera Inferiore (SA), pagg. 86, 14
Feuerbach ha goduto di una grande fortuna, che però è stata per lui anche una grande maledizione: in una delle sue opere più celebri, L’ideologia tedesca, Karl Marx gli ha reso un importante omaggio, e al tempo stesso gli ha rivolto una severa critica: l’uno e l’altra hanno assicurato larga fama a Feuerbach presso i posteri nei paesi europei nei quali il marxismo ha avuto una presenza massiccia. Ma è legittimo chiedersi se il giudizio del grande rivoluzionario tedesco abbia reso piena giustizia a Feuerbach.
Questi - diceva Marx - aveva avuto sì il merito di concepire l’uomo essenzialmente come un ente naturale (contro Hegel che lo concepiva come autocoscienza, cioè come pura spiritualità), e dunque di sottolineare il rapporto uomo-natura (ignorato dall’idealismo), ma non aveva visto che quel rapporto uomo-natura non era solo un rapporto interno alla natura, bensì era al tempo stesso un rapporto dell’uomo con gli altri uomini nella produzione della vita: un rapporto materiale-sociale, che modifica profondamente e «produce» la natura (nel senso che la lavora e la trasforma continuamente). Sicché, affermava Marx, «fin tanto che Feuerbach è materialista, per lui la storia non appare, e fin tanto che prende in considerazione la storia, non è materialista. Materialismo e storia per lui sono del tutto divergenti».
Il giudizio di Marx su Feuerbach era certamente acuto, ma, come dicevamo, è legittimo chiedersi se esso non perdesse di vista alcuni aspetti fondamentali della filosofia feuerbachiana. E che sia così ce lo conferma un grande saggio del filosofo tedesco, i Princìpi della filosofia dell’avvenire (1844), che viene ora riproposto da Orthotes a cura di Piergiorgio Bianchi. Già Norberto Bobbio, curatore della prima edizione italiana dei Princìpi (presso Einaudi, nel 1946, all’indomani dell’atroce guerra mondiale), riteneva che in essi si trovasse appagata una esigenza fondamentale, dopo tante ubriacature “speculative”: quella di un ritorno all’uomo nella complessità e nella concretezza della sua natura, dei suoi bisogni e delle sue ideologie.
In effetti, nei Princìpi maturano e trovano una splendida espressione i motivi fondamentali del pensiero di Feuerbach, il quale giudica la filosofia di Hegel come «un idealismo teologico», in quanto Hegel ha concepito Dio o l’Assoluto come il complesso dei concetti (da lui esposti dialetticamente nella logica) che costituiscono la trama metafisic a della realtà. Inoltre, nell’opera di Hegel, l’uomo scompare come ente finito, dotato di bisogni materiali, e diventa pura autocoscienza, così come la natura diventa alienazione dell’idea. Perciò Hegel svaluta irrimediabilmente le scienze naturali, in quanto scienze del finito e dell’empirico: di quell’empirico che in realtà non è, in quanto si contraddice in se stesso e si annulla: per Hegel, dunque, le scienze naturali sono pseudoscienze, e a esse va contrapposta la filosofia della natura.
Per Feuerbach, invece, l’uomo è un ente naturale finito, un essere sensibile. «Infatti - egli dice - accade soltanto a un essere sensibile di aver bisogno per esistere di cose che stanno al di fuori di lui. Io ho bisogno di aria per respirare, di acqua per bere, di luce per vedere, di sostanze vegetali e animali per mangiare»... Il mondo naturale ha quindi una importanza vitale per gli uomini, e la conoscenza per eccellenza è la conoscenza di quel mondo, data dalle scienze empiriche o naturali.
D’altro canto, solo se si concepisce l’uomo come ente naturale finito si possono cogliere in tutte le loro multiformi espressioni i suoi rapporti con i suoi simili: che sono rapporti di continuo scambio e arricchimento intellettuale (dunque l’uomo è un ente naturale finito sociale) e di ricerca di amore (il sentimento più nobile ed elevato della specie umana).
Feuerbach ha proposto una filosofia che fosse essenzialmente una antropologia, la quale doveva basarsi su un processo di umanizzazione. Umanizzazione di Dio, in primo luogo. Poiché nella religione l’uomo distacca da sé le proprie qualità più alte (intelligenza, spiritualità, creatività) e le attribuisce a Dio. Questa alienazione delle qualità essenziali della specie umana in Dio comporta un vero e proprio rovesciamento dei rapporti fra uomo e Dio. Il soggetto vero, l’uomo, viene trasformato in un predicato di Dio, mentre Dio, che è creazione dell’uomo, diventa il soggetto, l’elemento creatore. Tutto ciò avviene perché l’uomo, non trovando appagamento nella realtà, crea al di fuori di essa, al di fuori del mondo concreto, una realtà sovrannaturale. Questo rovesciamento dei rapporti fra Dio e uomo - che da soggetto attivo diventa oggetto passivo - ha per effetto di diminuire e umiliare l’uomo, onde, dice Feuerbach, «per arricchire Dio l’uomo deve impoverirsi; affinché Dio sia tutto, l’uomo deve essere nulla».
Come si vede, il programma di Feuerbach mirava a una grande rivoluzione filosofica, che inquadrasse nella natura e nella realtà empirica gli uomini, coi loro pensieri e coi loro sentimenti.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- S.T. COLERIDGE, VIRGINIA WOOLF, ELVIO FACHINELLI. La mente più creativa? È quella androgina.4 aprile 2016, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E CONOSCENZA: IL PROGRAMMA DI KANT, FREUD, FACHINELLI. LA MENTE ACCOGLIENTE:
- Questione antropologica
 IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
- «Al momento di diventare sciamani, si dice, gli uomini cambiano sesso. È così posta in rilievo la profondità del mutamento necessario. Il femminile come atteggiamento recettivo non abolisce però il maschile, gli propone un mutamento parallelo» (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989). (federico la sala)
La mente più creativa? È quella androgina, parola di Virginia Woolf (e degli psicologi)
di Elena Brenna ("spunti di mezzanotte", 12 maggio, 2015)
- «Una mente che è puramente maschile non può creare, tanto quanto non può farlo una mente che sia puramente femminile»
Androgino è un termine che trova la propria origine nel greco. E non è poi così difficile intuirne le parole che gli danno vita e il loro significato. Basti pensare alla medicina che si occupa del corpo maschile e a quella che si occupa del corpo femminile: andrologia e ginecologia. Andròs e gyné, uomo e donna. Ma che cos’è l’androginia? Personalmente, mi piace pensarla come quell’insieme di caratteristiche di un essere umano che trascende la rigida definizione dei generi.
I Sonic Youth cantavano “Androgynous mind, androgynous mind. Hey hey are you gay? Are you God? God is gay, and you were right”. Era il 1994, probabilmente il decennio meno androgino della storia del Novecento. Ma qui non si parlerà di stile, anche se oggi l’androginia sembra essere diventata una moda. Forse, ma poco importa. Quel che conta, in fondo, è il risultato. E il risultato è abituare certe mentalità ad accettare la natura umana, quella natura umana che sono convinte di conoscere ed identificare in due distinte sessualità, ma che in verità è assai più complessa. Complessa, varia, multipla e bella in modo assurdo.
E non sarà certo un caso se è proprio la mente androgina ad essere la più creativa. Un concetto che Virginia Woolf espresse già nel 1929 nel saggio Una stanza tutta per sé, una lucida riflessione sulla condizione femminile. Che l’androginia psicologica sia essenziale alla creatività non è però solo un’idea nata dalla mente della scrittrice inglese: anche gli studi psicologici, come quelli condotti da Mihaly Csikszentmihalyi, lo dimostrano.
Ma facciamo un passo per volta e torniamo a Virginia Woolf, che nel suo saggio scriveva:
- Quando vidi la coppia entrare nel taxi, la mente sentì come se, dopo essere stata divisa, fosse tornata di nuovo insieme in una fusione naturale. La ragione ovvia sarebbe che è naturale per i sessi co-operare. Si ha un istinto profondo, se irrazionale, in favore della teoria secondo cui l’unione di uomo e donna porta alla massima soddisfazione, la felicità più completa. Ma la vista delle due persone che salivano sul taxi e la soddisfazione che mi diede, mi fece anche domandare se ci sono due sessi nella mente che corrispondono ai due sessi nel corpo e se questi richiedono anche di essere uniti perché si ottenga la completa soddisfazione e felicità. E sono andata avanti, in modo dilettantesco, a fare uno schizzo della mappa dell’anima, in modo che in ognuno di noi presiedano due poteri, uno maschile, uno femminile; e nel cervello maschile, l’uomo predomina sulla donna e nel cervello femminile, la donna predomina sull’uomo. Il normale e confortevole stato dell’essere si ha quando entrambi vivono insieme armoniosamente, quando co-operano spiritualmente. Se uno è uomo, la parte femminile del suo cervello deve ancora avere effetto; e anche una donna deve avere un rapporto con l’uomo che c’è in lei.
- Forse Coleridge voleva dire questo quando disse che una grande mente è androgina. È quando questa fusione prende luogo che la mente è pienamente fertilizzata e usa tutte le sue facoltà. Forse una mente che è puramente maschile non può creare, tanto quanto non può farlo una mente che sia puramente femminile, penso. [...] Coleridge voleva dire, forse, che la mente androgina è risonante e permeabile; che trasmette emozione senza impedimenti; che è naturalmente creativa, incandescente e assoluta. In effetti, si torna indietro alla mente di Shakespeare come esempio di androgino, della mente uomo-femminile... E se fosse vero che non pensare specialmente o separatamente del sesso è uno dei gettoni della mente pienamente sviluppata, quanto più difficile è conquistare quella condizione ora più che mai... Nessuna età può essere stata acutamente cosciente del sesso come la nostra...
Quasi 70 anni dopo il saggio di Virginia Woolf, anche lo psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, autore di studi sulla felicità e sulla creatività e celebre per aver ideato il concetto di flusso, ha espresso la stessa opinione nel libro Creativity: The Psychology of Discovery and Invention:
L’androginia mentale, è chiaro, non va confusa con l’omosessualità:
- L’androginia psicologica è un concetto molto più ampio che si riferisce all’abilità di una persona di essere allo stesso tempo aggressiva e protettiva, sensibile e rigida, dominante e remissiva, a prescindere dal genere. Una persona psicologicamente androgina a tutti gli effetti duplica il proprio repertorio di risposte e può interagire con il mondo in termini di un più ricco e vario spettro di opportunità. Non è una sorpresa che gli individui creativi sono più propensi a non avere solo le forze del loro genere ma anche quelle dell’altro.
- Questione antropologica
-
>LA "VIA MAESTRA" DELLA "CRITICA". ORIENTARSI, OGGI - E SEMPRE. LA LEZIONE IMMORTALE DI KANT, DALLA STIVA DELLA "NAVE" DI GALILEI.4 febbraio 2013, di Federico La Sala
 LA RIVOLUZIONE COPERNICANA, L’ILLUMINISMO, E LA "VIA MAESTRA" DELLA "CRITICA"
LA RIVOLUZIONE COPERNICANA, L’ILLUMINISMO, E LA "VIA MAESTRA" DELLA "CRITICA"
 ORIENTARSI, OGGI - E SEMPRE. LA LEZIONE IMMORTALE DI KANT, DALLA STIVA DELLA "NAVE" DI GALILEI.
ORIENTARSI, OGGI - E SEMPRE. LA LEZIONE IMMORTALE DI KANT, DALLA STIVA DELLA "NAVE" DI GALILEI.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- "Chiamami Orlando". Il classico di Virginia Woolf portato in scena da Isabella Ragonese. Che racconta: "Per il mio personaggio androgino attraversare il confine tra i sessi e i ruoli è un’occasione di ironia e di libertà" (di Anna Bandettini)15 gennaio 2012, di Federico La Sala
Chiamami Orlando
teatro dell’ambiguità
Il classico di Virginia Woolf portato in scena da Isabella Ragonese. Che racconta: "Per il mio personaggio androgino attraversare il confine tra i sessi e i ruoli è un’occasione di ironia e di libertà"
di Anna Bandettini (la Repubblica/D, 14.01.2012)
Tanto tempo fa si sapeva con certezza chi erano gli uomini e le donne: imperiosi, padroni e un po’ minacciosi gli uni, timide, segrete le altre. Poi che le cose stessero cambiando, verso identità mescolate, confuse, forse liberate, lo intuì, già un secolo fa, per bisogno d’amore, Virginia Woolf, scrittrice di classe e sregolatezza, dichiarandosi, attraverso un libro, alla poetessa Vita Sackville West con cui ebbe una civettuola relazione. Il libro è Orlando, non il più famoso di quelli della Woolf, ma forse la sua storia più conturbante, su un ragazzo che vive, sempre mantenendosi giovane, in secoli diversi, dal ’600 al ’900, e che un giorno si sveglia da uno dei suoi frequenti sonni trasformato in donna, pur continuando a mantenere memoria dell’identità maschile, Un androgino, con tutto il bagaglio di complesse evocazioni che si porta dietro.
"È un romanzo molto contemporaneo: oggi non sono tempi chiari in niente, figuriamoci nel sesso", commenta ironica Isabella Ragonese, una bella luce negli occhi, sottile, radiosa, soave nei suoi trent’anni vulcanici. È l’attrice che in soli tre anni, dal 2008 al 2011, ha girato undici film tra cui Tutta la vita davanti di Virzì, La nostra vita di Daniele Luchetti, Un altro mondo di Silvio Muccino, Il giorno in più di Massimo Venier, e ora, intrepida, dedicherà tutta questa stagione al teatro, appunto con La commedia di Orlando, che dopo un’anteprima in questi giorni a Cagliari al Teatro Massimo, girerà da metà gennaio tra Firenze, Milano, Bergamo, Roma.
Lo spettacolo è un adattamento molto fedele (a parte un personaggio inventato, Mrs.Virginia) del romanzo di Virginia Woolf, firmato da Emanuela Giordano che è anche la regista del nutrito cast (dieci attori tra cui Erika Blanc, Claudia Gusmano, Laura Rovetto) e di una messa in scena fantasiosa, con cambi a vista, molti costumi, molta musica. Isabella è Orlando, l’uomo-donna, il misterioso androgino che, promette, non avrà nulla dell’espressione fredda e regale di Tilda Swinton nel fortunato film di Sally Potter del ’92. "E se è per questo nemmeno quella algida di Isabelle Huppert nell’altro Orlando celebre, lo spettacolo di Bob Wilson. Noi abbiamo insistito sull’esatto opposto, sulla commedia, sull’aspetto leggero, surreale, ironico del racconto", dice Isabella.
 E che c’è da ridere nell’essere uomo e donna? "Se ci fermiamo al romanzo della Wolf, c’è un deciso lato folle. Orlando è un fantasy senza nessuna coerenza narativa, e per questo è divertente: un ragazzo che si addormenta e si risveglia ogni volta in un secolo diverso e a un certo punto anche con un’altra identità... Si ride, leggendo il testo, anche perché ci sono personaggi al limite del grottesco. Ed è l’aspetto che ci piacerebbe portare in piena luce. Rendendo Orlando più popolare".
E che c’è da ridere nell’essere uomo e donna? "Se ci fermiamo al romanzo della Wolf, c’è un deciso lato folle. Orlando è un fantasy senza nessuna coerenza narativa, e per questo è divertente: un ragazzo che si addormenta e si risveglia ogni volta in un secolo diverso e a un certo punto anche con un’altra identità... Si ride, leggendo il testo, anche perché ci sono personaggi al limite del grottesco. Ed è l’aspetto che ci piacerebbe portare in piena luce. Rendendo Orlando più popolare".
 Per Virginia Woolf quell’essere androgino rappresentava il raggiungimento della felicità, l’unione insperata uomo-donna. È così? "All’inizio Orlando è un ragazzo gioviale, molto naïf, uno che fa domande come quelle di un bambino, e attraverso le domande scardina le ipocrisie di chi gli sta intorno. Ma è anche un inquieto, che sente di non voler restare chiuso in quel cerchio. Diventare donna per lui è dunque liberatorio. Ma è anche vero che una volta diventato donna, pur restando nel nocciolo quel ragazzo gioviale che era, si deve difendere di più, deve essere più determinata per farsi valere... Non so se c’entra la felicità, in tutto questo".
Per Virginia Woolf quell’essere androgino rappresentava il raggiungimento della felicità, l’unione insperata uomo-donna. È così? "All’inizio Orlando è un ragazzo gioviale, molto naïf, uno che fa domande come quelle di un bambino, e attraverso le domande scardina le ipocrisie di chi gli sta intorno. Ma è anche un inquieto, che sente di non voler restare chiuso in quel cerchio. Diventare donna per lui è dunque liberatorio. Ma è anche vero che una volta diventato donna, pur restando nel nocciolo quel ragazzo gioviale che era, si deve difendere di più, deve essere più determinata per farsi valere... Non so se c’entra la felicità, in tutto questo".
 E nella vita "vera" la questione dell’identità di genere com’è, secondo lei? "Mai come facendo questo spettacolo mi sono resa conto che le due anime maschile e femminile sono in ognuno di noi. Se poi penso agli uomini più interessanti che ho conosciuto, avevano tutti una forte componente femminile nel temperamento. Io stessa ho scelto compagni che sapevano aspettare, silenziosi, che non sono mai entrati con irruenza nella mia vita, ma poi, forti nel profondo, sono di grande sostegno. Uomini femminili, appunto, non uomini prigionieri del loro ruolo. Mai invidiati, quegli uomini lì...".
E nella vita "vera" la questione dell’identità di genere com’è, secondo lei? "Mai come facendo questo spettacolo mi sono resa conto che le due anime maschile e femminile sono in ognuno di noi. Se poi penso agli uomini più interessanti che ho conosciuto, avevano tutti una forte componente femminile nel temperamento. Io stessa ho scelto compagni che sapevano aspettare, silenziosi, che non sono mai entrati con irruenza nella mia vita, ma poi, forti nel profondo, sono di grande sostegno. Uomini femminili, appunto, non uomini prigionieri del loro ruolo. Mai invidiati, quegli uomini lì...".
 Vale anche per le donne? "Anche. Io ho sono mascolina, è quella parte di me compagnona, cameratesca, casinara.... La parte femminile, che considero più preziosa, segreta, quel farsi continuamente domande, quell’essere inquieta, la parte bella che considero la più profonda e che certi uomini vedono come una tortura, è la mazzata che riservo nel privato. Mazzata? Si, mazzata, perchè nella vita di coppia non è sempre un regalo".
Vale anche per le donne? "Anche. Io ho sono mascolina, è quella parte di me compagnona, cameratesca, casinara.... La parte femminile, che considero più preziosa, segreta, quel farsi continuamente domande, quell’essere inquieta, la parte bella che considero la più profonda e che certi uomini vedono come una tortura, è la mazzata che riservo nel privato. Mazzata? Si, mazzata, perchè nella vita di coppia non è sempre un regalo".
 Ha mai detto: "Ah, se fossi uomo..?". "Non mi pare, anche perchè ho un fratello e quando ero piccola in campagna venivano i suoi amici e stavo sempre con loro. La forza dell’amicizia femminile invece l’ho scoperta tardi, ha coinciso con la maturità. Prima di allora sono cresciuta con i maschi ed ero un po’ maschio anch’io. A Palermo si giocava nel cortile a pallone e godevo di un doppio vantaggio: giocavo ai loro giochi ed ero coccolata perché ero la più piccola. Comunque sono contenta di essere donna. Per me è un esercizio di libertà. Soprattutto oggi vedo donne più padrone di sé, determinate e più capaci di elaborazioni. Soprattutto le donne hanno più possibilità di esperienze profonde, a cominciare dalla maternità".
Ha mai detto: "Ah, se fossi uomo..?". "Non mi pare, anche perchè ho un fratello e quando ero piccola in campagna venivano i suoi amici e stavo sempre con loro. La forza dell’amicizia femminile invece l’ho scoperta tardi, ha coinciso con la maturità. Prima di allora sono cresciuta con i maschi ed ero un po’ maschio anch’io. A Palermo si giocava nel cortile a pallone e godevo di un doppio vantaggio: giocavo ai loro giochi ed ero coccolata perché ero la più piccola. Comunque sono contenta di essere donna. Per me è un esercizio di libertà. Soprattutto oggi vedo donne più padrone di sé, determinate e più capaci di elaborazioni. Soprattutto le donne hanno più possibilità di esperienze profonde, a cominciare dalla maternità".
 Le è mai capitato di piacere a una donna? "Dopo che ho interpretato il film Viola di mare di Donatella Maiorca mi hanno scritto un mucchio di ragazze innamorate. Era uno dei pochi film che rompeva il blocco culturale in cui l’omosessualità femminile è relegata: parlava di due ragazze giovani innamorate - Valeria Solarino e io - e credo che alle adolescenti sia piaciuto in modo particolare perché non raccontava l’omosessualità al servizio degli uomini, ma solo una storia d’amore. Da lì in poi ho avuto a lungo fan femmine, e la cosa mi lusinga. Le donne in genere sono meno di bocca buona degli uomini, quindi c’è più soddisfazione".
Le è mai capitato di piacere a una donna? "Dopo che ho interpretato il film Viola di mare di Donatella Maiorca mi hanno scritto un mucchio di ragazze innamorate. Era uno dei pochi film che rompeva il blocco culturale in cui l’omosessualità femminile è relegata: parlava di due ragazze giovani innamorate - Valeria Solarino e io - e credo che alle adolescenti sia piaciuto in modo particolare perché non raccontava l’omosessualità al servizio degli uomini, ma solo una storia d’amore. Da lì in poi ho avuto a lungo fan femmine, e la cosa mi lusinga. Le donne in genere sono meno di bocca buona degli uomini, quindi c’è più soddisfazione".
 Se potesse fare come Orlando e trasformarsi in un uomo, che cosa crede che restebbe di Isabella? "Me lo sono chiesta nel lavoro di scavo sul personaggio.E la risposta è: molto. Perché davvero credo che l’androginia, se non esibita ma coltivata, sia una ricchezza, non un tormento. Nel romanzo c’è un pensiero molto bello per spiegare come maschio e femmina convivono in noi ed è solo lo sguardo degli altri a determinare chi siamo, la qualità della nostra identità. È la battuta di Orlando che dice: finché eri un ragazzo eri un ricco aristocratico in cerca di moglie, ora da donna sei una zitella che non ha niente. Eppure Orlando è sempre Orlando. Ma ecco la differenza".
Se potesse fare come Orlando e trasformarsi in un uomo, che cosa crede che restebbe di Isabella? "Me lo sono chiesta nel lavoro di scavo sul personaggio.E la risposta è: molto. Perché davvero credo che l’androginia, se non esibita ma coltivata, sia una ricchezza, non un tormento. Nel romanzo c’è un pensiero molto bello per spiegare come maschio e femmina convivono in noi ed è solo lo sguardo degli altri a determinare chi siamo, la qualità della nostra identità. È la battuta di Orlando che dice: finché eri un ragazzo eri un ricco aristocratico in cerca di moglie, ora da donna sei una zitella che non ha niente. Eppure Orlando è sempre Orlando. Ma ecco la differenza".
 Meglio essere uomo, allora? "No, il meglio o il peggio non è una questione di genere. E in ogni caso la donna è più completa, essendo più abituata a controllare aspetti molteplici della vita perché da subito ne impara le difficoltà. Ma ripeto, non ne farei una questione di genere. Anzi mi dà fastidio che si faccia. Come per esempio, come è successo per il film Primo incarico di Giorgia Cecere, si etichetta come femminile un film solo perché ci sono una regista donna e una protagonista donna. Se fosse il contrario non si direbbe "è un film maschile", perchè quella è considerata la normalità, mentre le donne si preferisce chiuderle nel ghetto della questione femminile"
Meglio essere uomo, allora? "No, il meglio o il peggio non è una questione di genere. E in ogni caso la donna è più completa, essendo più abituata a controllare aspetti molteplici della vita perché da subito ne impara le difficoltà. Ma ripeto, non ne farei una questione di genere. Anzi mi dà fastidio che si faccia. Come per esempio, come è successo per il film Primo incarico di Giorgia Cecere, si etichetta come femminile un film solo perché ci sono una regista donna e una protagonista donna. Se fosse il contrario non si direbbe "è un film maschile", perchè quella è considerata la normalità, mentre le donne si preferisce chiuderle nel ghetto della questione femminile"
 Questa è la sua passione femminista che parla? "No, è che sono una donna e sento che bisogna combattere anche contro la passività degli stereotipi. Lo abbiamo fatto anche con la famosa manifestazione del 13 febbraio scorso, quando scesero in piazza un milione di donne che chiedevano dignità. È vero che mi appassionano i temi politici. È un’abitudine, forse perchè sono siciliana e in Sicilia sapere da che parte stai è importante. A me pare assurdo che la questione femminile da noi sia considerato un problema "qualsiasi", come la raccolta differenziata o il nucleare. No, io dico sempre che è un problema strutturale. Le donne sono le più brave e non arrivano a posti apicali, si laureano di più, lavorano di più ma non esistiamo, men che meno nei media che rilanciano solo un tipo di figura femminile che non esiste, e se esiste è una minoranza... Queste cose le abbiamo dette anche in teatro, con il gruppo di donne di "Se non ora quando" nello spettacolo Libere, di cui sono orgogliosa. Perché mi fa sempre piacere quando il mio lavoro si incrocia con la vita. Anche per questo ho scelto di fare Orlando".
Questa è la sua passione femminista che parla? "No, è che sono una donna e sento che bisogna combattere anche contro la passività degli stereotipi. Lo abbiamo fatto anche con la famosa manifestazione del 13 febbraio scorso, quando scesero in piazza un milione di donne che chiedevano dignità. È vero che mi appassionano i temi politici. È un’abitudine, forse perchè sono siciliana e in Sicilia sapere da che parte stai è importante. A me pare assurdo che la questione femminile da noi sia considerato un problema "qualsiasi", come la raccolta differenziata o il nucleare. No, io dico sempre che è un problema strutturale. Le donne sono le più brave e non arrivano a posti apicali, si laureano di più, lavorano di più ma non esistiamo, men che meno nei media che rilanciano solo un tipo di figura femminile che non esiste, e se esiste è una minoranza... Queste cose le abbiamo dette anche in teatro, con il gruppo di donne di "Se non ora quando" nello spettacolo Libere, di cui sono orgogliosa. Perché mi fa sempre piacere quando il mio lavoro si incrocia con la vita. Anche per questo ho scelto di fare Orlando".
 Le piace Virginia Woolf ? "Ho amato molto Una stanza tutta per sé, riflessione acuta sulla donna che deve essere la madre di, la figlia di, la lavoratrice di, l’amante di, sempre proiettata verso qualcuno e qualcosa ma in cerca di una stanza, quello scrigno dove sei tu e basta. O dove forse la madre di, la figlia di, la lavoratrice di... trovano un raccordo. Ma diciamo la verità: quando mai la trovano, le donne quella stanza? Diciamo che comunque vale la pena fare il percorso per raggiungerla".
Le piace Virginia Woolf ? "Ho amato molto Una stanza tutta per sé, riflessione acuta sulla donna che deve essere la madre di, la figlia di, la lavoratrice di, l’amante di, sempre proiettata verso qualcuno e qualcosa ma in cerca di una stanza, quello scrigno dove sei tu e basta. O dove forse la madre di, la figlia di, la lavoratrice di... trovano un raccordo. Ma diciamo la verità: quando mai la trovano, le donne quella stanza? Diciamo che comunque vale la pena fare il percorso per raggiungerla".-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- Chi sono i transgender? Nati in un corpo che non li rappresenta, vogliono essere al tempo stesso uomini e donne (di Vera Schiavazzi - di Michela Marzano).17 gennaio 2012, di Federico La Sala
 Potere transgender
Potere transgender Nati in un corpo che non li rappresenta, conquistano sempre più spazio nella moda, nello spettacolo, nel lavoro. E rivendicano l’identità del "terzo sesso”. Con orgoglio vogliono essere al tempo stesso uomini e donne
Nati in un corpo che non li rappresenta, conquistano sempre più spazio nella moda, nello spettacolo, nel lavoro. E rivendicano l’identità del "terzo sesso”. Con orgoglio vogliono essere al tempo stesso uomini e donne Sono trentamila i transgender italiani
Sono trentamila i transgender italiani Rappresentano l’avanguardia del movimento per i diritti e le libertà sessuali.
Rappresentano l’avanguardia del movimento per i diritti e le libertà sessuali.
 Lanciano campagne pubblicitarie e lottano contro gli ostacoli di politica e burocrazia.
Lanciano campagne pubblicitarie e lottano contro gli ostacoli di politica e burocrazia.
 Sono testimoni di un cambiamento che potrebbe avere risvolti sociali imprevedibili
Sono testimoni di un cambiamento che potrebbe avere risvolti sociali imprevedibili
 "Vorremmo poter modificare i dati anagrafici anche senza sottoporci ai bisturi"
"Vorremmo poter modificare i dati anagrafici anche senza sottoporci ai bisturi"di Vera Schiavazzi (la Repubblica, 17.01.2012)
Per i trentamila transgender italiani, persone che hanno già cambiato o vorrebbero cambiare la propria identità sessuale, o che rivendicano il diritto di non dichiararla affatto, il serbo Andrej Pejic è un simbolo. Modello (o modella) scelto da Jean-Paul Gaultier per la sua superba e androgina bellezza fuori dal tempo e dagli schemi, ha sfilato vestito da sposa per le collezioni primavera-estate del 2011, posato per Vogue, dichiarato candidamente di salire in passerella «per guadagnare» e di ritenersi «un rischio calcolato» per le grandi firme della moda. E il Courrier International l’ha messo in prima pagina: un mezzo busto senza veli, conturbante e stimolante, per introdurre un’ampia inchiesta sul fenomeno nel mondo.
Anche se la realtà di tutti i giorni è dura, e qualche volta durissima, per chi nasce con caratteristiche fisiche che non corrispondono ai propri sentimenti e alle percezione di sé (un uomo su 30mila, una donna su 100mila), i simboli sono importanti. Non solo nella moda, ma in politica, con parlamentari come la polacca Anna Grodzka o la spagnola Carla Antonelli, nell’arte (la danzatrice cinese Jin Xing), nell’economia (la manager americana Margaret Stumpp). Persone di successo che hanno avuto il coraggio, e la possibilità, di dichiarare senza timidezza la propria trasformazione. Transgender è bello? Ed è un caso che siano proprio le persone dall’identità volutamente ambigua, difficile da definire, "terza" rispetto ai generi tradizionali, a rappresentare oggi l’avanguardia del movimento per i diritti e per le libertà sessuali?
Qualcosa del genere, in effetti, sta accadendo anche in Italia, dove i transgender rappresentano oggi la punta avanzata di un fronte, quello dei gay e delle lesbiche organizzati, che altrimenti potrebbe apparire alquanto stanco. Perché sono loro a affermare che "il re è nudo", e che non esiste alcuna ragione per obbligare le persone a collocarsi, da una parte o dall’altra, o a sottoporsi a lunghi e dolorosi interventi chirurgici per poter avere il nome che vogliono - quello che sentono e che li definisce davvero - sulla carta di identità. Come racconta Fabianna Tozzi Daneri, forse la più nota tra gli attivisti-transgender, donna-immagine del movimento: «Ci battiamo perché la legge del 1982 che consente di modificare i propri dati anagrafici sia estesa anche a chi non sceglie la riattribuzione chirurgica del sesso. E nello stesso tempo chiediamo che questa proceduta, che in Italia è inserita nel sistema sanitario e dunque dovrebbe essere gratuita, venga praticata correttamente e sia davvero accessibile a tutti».
Fabianna, che ha iniziato a lavorare come parrucchiera in un teatro lirico («ero brava, e ho avuto la fortuna di vivere in un ambiente dove la diversità è più accettata che altrove»), è, anche, una politica dotata di grande pragmatismo: «Perché la nostra condizione sia accettata in Italia dobbiamo essere noi, per primi, a renderci conto che non siamo i soli a subire discriminazioni. Tutti hanno problemi di lavoro, oggi, e la vita è difficile per tutti. Il nostro diritto a non essere discriminati deve andare di pari passo con quello di ogni persona a avere condizioni di vita e di impiego dignitose». Nascono così campagne pubblicitarie (come quella che ha avuto per modelli la stessa Fabianna insieme a Gabriele Dario Belli, altro transgender famoso grazie anche alla sua partecipazione a un’edizione del Grande Fratello, o ad un’altra, di questi giorni, che dà voce a genitori e colleghi di gay) che puntano ad uscire dal vittimismo e a restituire all’identità sessuale di ognuno la propria "normalità". E mentre in Australia la battaglia vinta da un transgender per essere individuato sul passaporto come persona "del terzo sesso", né maschio né femmina, è stata salutata tra gli applausi, in Italia una simile possibilità è guardata con sospetto: «È una soluzione che ci spaventa, perché non va d’accordo con le leggi e la cultura del nostro paese - dice Fabianna - Io credo invece che quando non ce n’è bisogno, a partire dai documenti di identità, sarebbe di grande sollievo per tutti noi non indicare il genere. E proteggerebbe le persone transgender anche quando si trovano a viaggiare in paesi dove le libertà sono più ristrette».
Gli stessi paesi, dall’Afghanistan all’Iraq, dai quali è in atto da qualche anno una ristretta e silenziosa, ma spesso drammatica, "migrazione sanitaria" verso l’Italia: chi può, abbandona casa e famiglia per spostarsi dove il cambiamento di sesso è possibile e sicuro. Trieste, Roma, Torino sono le città dove esiste un ospedale che - tra un taglio e l’altro ai bilanci, tra una polemica e un attacco - ha mantenuto e fatto crescere la propria specializzazione nell’aiutare gli uomini che vogliono diventare donne (una tecnica chirurgica oggi relativamente semplice e destinata al successo nel 90 per cento dei casi) o le donne che vogliono diventare uomo (anche questo è possibile, ma il percorso è difficile e sofferto, ed è soprattutto pensando a questi pazienti che si chiede di poter scollegare la mutazione anagrafica da quella fisica).
Intanto anche il mondo dello spettacolo, e del cinema dopo che la tv lo aveva già fatto, si apre al mutamento. «Sarò tra i protagonisti del nuovo film di Marco Bracco, Il tempo delle mimose, insieme a un grande cast, con Fabio Testi, Simona Autieri e Anna Galiena - annuncia con un certo orgoglio Gabriele Dario Belli - Ovviamente, il mio sarà un ruolo maschile. Ma le persone come noi sanno che la transizione non finisce mai. Ho 40 anni, ed è da quando ne avevo 3 che so di essere nato maschio in un corpo di donna: non una lesbica, ma un uomo eterosessuale. Mi sentivo un alieno, fino a quando non ho sentito un altro raccontare una storia uguale alla mia. Mi hanno aiutato anche il mio lavoro (è responsabile del marketing in una grande azienda, ndr) e la mia compagna, che mi ha incoraggiato a mostrarmi in tv. Mi sono detto: ok, lo faccio, ci vado e mostro a tutti che esiste un "prodotto" che non conoscono, una donna che ha scelto di essere uomo. E, credetemi, non lo ha fatto per i vantaggi che ancora oggi essere maschi comporta, ma perché quello era il modo di avvicinare il suo corpo alla sua mente». I risvolti sociali sono, e restano, imprevedibili: «Ci avete mai pensato? A certe aziende piace assumere donne lesbiche, perché sanno che non resteranno a casa in maternità», suggerisce Gabriele.
Persone come Fabianna e Gabriele, o Valentina, Marco sui documenti (lavora come camallo al porto di Genova) sono i testimoni di un cambiamento che potrebbe preludere a un’esplosione del fenomeno: lo dice la moda, con colori, tessuti e tagli sempre più indistinti, lo dice il mondo dei cosmetici, con prodotti e make up progettati senza distinzione, lo dice l’esitazione di moltissimi ragazzi che non vogliono aderire a stereotipi maschili o femminili nei quali non si riconoscono più. Evviva la neve (Mondadori, 2011), il libro di Delia Vaccarello (giornalista e blogger, lavora per il Comune di Venezia come consulente anti-discriminazioni) raccoglie alcune storie drammatiche di cambiamento, compresa quella che l’ha fatta entrare in sala operatoria a Trieste, ed è stato un grande successo anche al di fuori del mondo trans.
Con orgoglio vogliono essere al tempo stesso uomini e donne
Anticonformisti per non sentirsi più prigionieri
di Michela Marzano (la Repubblica, 17.01.2012)
Chi sono i transgender? Si può essere al tempo stesso uomini e donne? Esiste un "terzo sesso"? Come spesso accade nella vita, la risposta a questo tipo di domande è tutt’altro che semplice. A meno che non ci accontenti della solita scelta secca tra il "sì" e il "no". La famosa logica dualistica che pensa il mondo in modo binario: il bene e il male, il vero e il falso, l’anima e il corpo, gli uomini e le donne. Peccato che quando si parli di identità di genere, tutto sia molto più complicato. Perché in ogni persona esistono degli elementi di femminilità e di mascolinità, anche se poi, nel corso della propria vita, si ha tendenza a stabilizzarsi all’interno di un genere specifico. A parte i transgender certo, che a differenza dei transessuali, non rivendicano affatto il diritto di cambiar sesso, ma quello all’indeterminazione sessuale.
Per i transessuali, lo scopo è riconciliare "identità psicologica" e "sesso anatomico": si tratta di persone convinte, fin dalla più tenera età, di appartenere all’altro sesso. Per un brutto scherzo della natura, alcune donne si ritrovano in un corpo d’uomo e alcuni uomini in un corpo di donna, e allora cercano solo di "rimettere le cose a posto". A differenza di tutti coloro per i quali il sentimento di appartenenza all’uno o all’altro genere coincide con la propria conformazione genitale e il proprio corredo cromosomico, i transessuali soffrono a causa dell’esistenza di un divario tra "corpo" e "identità", di uno "sfaldamento" cui vogliono mettere fine, per non sentirsi più prigionieri di un "corpo" o di un "nome" che non riconoscono. Da questo punto di vista, i transessuali non hanno alcuna intenzione di sovvertire l’ordine delle cose: vogliono solo adeguarsi all’immagine che, da sempre, hanno di loro stessi. Ecco perché anche coloro che non vogliono sottoporsi ad un intervento chirurgico, vogliono poter modificare il proprio nome sulla carta di identità. Per diventare agli occhi di tutti quello che loro sanno di essere fin da piccoli.
Rispetto ai transessuali, i transgender sono molto più sovversivi. Rifiutando ogni opposizione binaria, vogliono mettere in scena la dualità uomo/donna senza scegliere a quale sesso appartenere: vogliono essere al tempo stesso uomini e donne. È per questo che la maggior parte dei transgender rivendica l’etichetta queer - letteralmente strano, bizzarro, eccentrico - e trovano all’interno della teoria queer quegli strumenti necessari per rivendicare il diritto di vivere al di fuori delle categorie di genere tradizionali. A differenza dei transessuali, i transgender non si definiscono come prigionieri di un "corpo sbagliato". Non cercano un "vero corpo". L’idea che possa esistere una "verità" legata alla materialità del corpo viene completamente rigettata. Tutto è artificio, protesi, impianto, trucco, vestito... Tutto pur di arrivare a un "corpo accettabile", ossia a quell’apparire ambivalente e androgino, che è poi l’unico ad incarnare il "compromesso".
È per questo che la cultura transgender rifiuta drasticamente l’idea di un passaggio definitivo: la transizione da "lui" a "lei", o da "lei" a "lui", non sarebbe altro che la prova dell’assoggettamento di un individuo ai discorsi e alle pratiche che cercano di normalizzarne l’esistenza assegnandolo ad un’identità specifica. Essere transgender vuol dire, per definizione, incarnare l’eccentrico, sfuggendo a ogni ambito sociale e a qualunque dispositivo istituzionale, anche al linguaggio: il fatto stesso di parlare "del" o "della" transgender significherebbe d’altronde tradirne l’identità multipla. Il/la transgender è sempre "uomo e donna", "né uomo, né donna". Un "terzo sesso" allora?
Ognuno di noi vive come può il rapporto con il proprio corpo. Ognuno organizza la propria identità cercando di accettare le proprie contraddizioni. Rivendicando la possibilità di passare da un sesso all’altro (transessuali) o il diritto di non scegliere a quale sesso appartenere (transgender), i (le) trans ci spingono in fondo a interrogarci non solo sulla nostra identità sessuale, ma anche sui limiti intrinseci della nostra corporeità. E in questo, sono profondamente sovversivi. E hanno ragione. Perché è forse l’unico modo per uscire definitivamente dagli atavici dualismi ontologici. Si può, tuttavia, essere e volere veramente "tutto"? Nel momento in cui rifiutiamo il nome che ci è stato dato e ne scegliamo uno nuovo, non finiamo lo stesso con l’identificarci ad un genere ben preciso? E poi, c’è veramente bisogno di "ontologizzare" un terzo sesso per vivere fino in fondo le ambivalenze della nostra identità de genere?
-
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. ---- Le radici dell’anima secondo Pauli e Jung (di Edoardo Boncinelli)2 dicembre 2011, di Federico La Sala
Le radici dell’anima secondo Pauli e Jung
di Edoardo Boncinelli (Corriere della Sera, 24.10.2011)
«Dal momento che la concezione determinista è stata abbandonata in fisica, non ci sono neanche ragioni per mantenere ancora una concezione vitalista, secondo cui l’anima potrebbe e dovrebbe "violare" le leggi fisiche. Mi sembra piuttosto che una parte essenziale dell’"armonia universale" consista nel far sì che le leggi fisiche lascino proprio un margine per un altro modo di osservare e di considerare le cose (la biologia e la psicologia) in modo che l’anima possa raggiungere tutti i suoi "obiettivi" senza violare le leggi fisiche». Questa dichiarazione di Wolfgang Pauli è posta come una sorta di conclusione delle conclusioni alla fine del libro Pauli e Jung di Silvano Tagliagambe e Angelo Malinconico (Raffaello Cortina Editore, pagine 320, 27). Il fisico teorico Pauli e il fondatore della Psicologia Analitica, Carl Gustav Jung, discussero a lungo su come si potesse giungere a questo «altro modo» di pensare al mondo, nell’ipotesi, ovviamente, che un altro modo esista, che esista in definitiva un «mondo intermedio» fra materia e psiche che possa fondere le due istanze, cercando inoltre di evitare tanto le secche del determinismo e della causalità quanto quelle della casualità.
Fin dall’inizio la scienza occidentale ha proceduto espellendo il soggetto dall’universo delle cose da studiare e da comprendere. Qualcuno si accontenta, ma molti soffrono di tale esclusione e perseguono il disegno di una conciliazione fra lo studio rigoroso della realtà materiale e la comprensione del mondo della psiche individuale e di ciò che si definisce comunemente spiritualità.
Fra quelli che non si sono accontentati figurano certamente Pauli, fortemente critico nei confronti dell’orientamento che aveva preso la fisica atomica dei suoi tempi, e lo psicologo zurighese Jung, infaticabile esploratore della psiche profonda e del suo rapporto con la nostra percezione della realtà. Questi due personaggi molto diversi ne discussero a lungo, fino a produrre insieme anche un libro sull’argomento. Il confronto fra i loro percorsi intellettuali rappresenta un capitolo affascinante della tormentata problematica del Novecento e adesso i nostri autori hanno dedicato un libro non piccolo e molto informato alla disamina degli aspetti più riposti di tale confronto. Tagliagambe da parte sua va avanti con questo suo libro sul progetto di esplorare una originalissima «epistemologia del confine».
Che cosa nacque dal fortunato incontro di queste due fertili menti? Jung si confermò nella sua visione dell’inconscio come «luogo psichico che custodisce in forma primaria e autonoma i contenuti e le immagini individuali e universali, potremmo dire le verità sul singolo individuo, sui gruppi sociali di appartenenza, sull’intera umanità che contiene l’individuo stesso». Fondamentale nella sua concezione è il ruolo degli archetipi, quali «forme senza contenuto, atte a rappresentare solo la possibilità di un certo tipo di percezione e azione. Quando si presenta una situazione che corrisponde a un dato archetipo, allora l’archetipo viene attivato».
Pauli, per parte sua, andava riflettendo su una possibile conciliazione fra cause e significati. Dalla loro relazione scaturì, a quello che ne sappiamo, soprattutto l’idea di sincronicità come nuova forma di significatività e di senso degli eventi della vita. «Il principio di sincronicità afferma che un certo evento psichico trova un parallelo in qualche evento esterno, non psichico e che tra i due non esiste alcun nesso causale. È un parallelismo di significato».
Abbiamo aperto con Pauli; chiudiamo con Jung: «Passerà ancora molto tempo prima che la fisiologia e la patologia del cervello da un lato e la psicologia dell’inconscio dall’altro possano darsi la mano. Anche se alla nostra conoscenza attuale non è concesso di trovare quei ponti che uniscono le due sponde ... esiste tuttavia la sicura certezza della loro presenza. Questa certezza dovrà trattenere i ricercatori dal trascurare precipitosamente e impazientemente l’una in favore dell’altra o, peggio ancora, dal voler sostituire l’una con l’altra. La natura non esisterebbe senza sostanza, ma non esisterebbe neppure se non fosse riflessa nella psiche». La discussione continua.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. ---- Perché la coscienza non è solo interiore. Due saggi di Perconti e Desideri riflettono su esperienze soggettive ed estetiche (di Maurizio Ferraris).4 ottobre 2011, di Federico La Sala
Due saggi di Perconti e Desideri riflettono su esperienze soggettive ed estetiche
Perché la coscienza non è solo interiore
Già nel secolo scorso filosofi e psicologi hanno sostenuto che per individuare la natura di questa facoltà occorre guardare soprattutto alla realtà esterna
di Maurizio Ferraris (la Repubblica, 04.10.2011)
In inglese, ci racconta Schopenhauer, era solito dire «non sono abbastanza ricco da permettermi una coscienza», questa entità nobile e interiore. Ma è davvero così? Se leggiamo Coscienza di Pietro Perconti (il Mulino, pagg. 216, euro 13,50) vediamo quanto sia potentemente determinata da due esteriorità.
La prima è il corpo. Cosa ci succederebbe se di colpo ci trovassimo con una faccia diversa? Impressionante. E questo sottilmente verrebbe a toccare la nostra coscienza. Per la coscienza è essenziale quello che gli studiosi contemporanei chiamano "embodiment", "incorporazione", ma se traducessimo, come è anche del tutto legittimo, con "incarnazione", ci renderemmo conto di quanto antica sia questa intuizione. Perciò nel secolo scorso filosofi e psicologi comportamentisti hanno risolutamente sostenuto che non si tratta di scavare nell’interno, ma di guardare all’esterno, sino a dare argomenti per una famosa barzelletta da professori. Quella dei due comportamentisti che fanno l’amore e poi lui dice a lei: «A te è piaciuto moltissimo. E a me?».
Sono esagerazioni, ma rappresentarsi la coscienza come qualcosa di puramente interiore è insufficiente, per quanto possa apparirci naturale. Perché ci appare altrettanto naturale cercare la coscienza nei volti degli altri, o persino (è un tema a cui Perconti dedica una lunga analisi), nello specchio, un po’ come la regina di Biancaneve. Quando - succede anche questo - ci guardiamo nello specchio dell’ascensore per cercare di capire il nostro umore, non ci comportiamo molto diversamente dai comportamentisti della barzelletta.
Quanto poco sia vero che la nostra coscienza si riduca all’interiorità lo si capisce ancor meglio se si guarda all’esperienza estetica, d’accordo con uno dei fili conduttori di un altro libro uscito di recente, La percezione riflessa (Raffaello Cortina, pagg. 230, euro 23) di Fabrizio Desideri, che getta un ponte tra estetica e filosofia della mente. Che cosa avviene quando troviamo bella una cosa o un paesaggio? Sarebbe sbagliato credere che la bellezza la mettiamo tutta noi, con la nostra coscienza o sensibilità, sarebbe troppo facile. Sicuramente l’apprezzamento viene da noi, non esiste bellezza degli oggetti se non per soggetti che li riconoscono. Però, al tempo stesso, fa parte dell’apprezzamento l’assumere che il bello, una qualità emotiva molto elevata, ha luogo lì fuori, nell’oggetto. Ora, come sottolinea Desideri, qui si crea una strana inversione di ruoli. L’oggetto diventa un quasi-soggetto, sembra rivolgersi a noi come se fosse una persona (Kant notava che in certi giorni sembra che il mondo ci rivolga un sorriso, osservazione giustissima anche se in certi altri giorni sembra invece che ce l’abbia con noi). Il soggetto, invece, diventa un quasi-oggetto, giacché è passivo rispetto all’oggetto, che gli si impone come bello, o brutto, indipendentemente dalla sua volontà.
Con esperienze di questo genere - che non si riducono al bello, si pensi alla fitta di quando si vede la multa sotto il tergicristallo - entriamo in una seconda esteriorità rispetto alla pretesa interiorità della nostra coscienza, ossia nel mondo, naturale e sociale, ciò che gli studiosi contemporanei chiamano "embedment", e che Heidegger, con un altro gergo, chiamava "Dasein", "essere nel mondo". La nostra interiorità si nutre costantemente dell’esterno, e non potrebbe esistere senza di esso. Così non l’interiorità, ma la materia e la memoria, quello che ci imparenta agli archivi e ai computer, è la condizione imprescindibile per la coscienza.
Banalmente, proprio come ci sono delle operazioni intellettuali che sono inattuabili senza supporti esterni, per esempio calcoli complicati che richiedono carta e penna, o pallottolieri, cosi anche funzioni elevatissime come la responsabilità e la decisione morale non potrebbero aver luogo senza memoria. Come si può essere responsabili senza avere a che fare con le vestigia delle nostre azioni? E il fatto che nella nostra vita morale la rimozione (ossia una specie di oblio guidato e artificiale) giochi un ruolo così centrale ci spiega che il fondo della nostra anima è fatto di qualcosa che sta fuori, nel mondo, tanto quanto sta dentro, nella mente, ossia di memoria.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. ---- Il narcisismo ipermoderno e la nuova religione del corpo (di Massimo Recalcati - L’ossessione del corpo diventa una malattia)27 maggio 2011, di Federico La Sala
L’ossessione del corpo diventa una malattia
Così la cura del sé, dalla forma fisica al mangiar sano, è stata esasperata, trasformandosi, nei suoi eccessi, in una patologia Quando il benessere diventa una ideologia non accettiamo più le nostre imperfezioni
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 27.05.2011)
L’anziano protagonista di uno degli ultimi film di Woody Allen, Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, recitato da un raro Anthony Hopkins, esulta scoprendo che il suo DNA gli garantirà una vita inaspettatamente protratta. Il rifiuto dell’avanzare degli anni lo mobilita alla ricerca di una giovinezza perpetua che non implica solo il progetto tragicomico di sposare una escort in carriera, ma anche l’assoluta dedizione al potenziamento atletico e alla purificazione salutista del suo corpo come per suffragare scaramanticamente la previsione esaltante offertagli dal discorso medico. Questo personaggio non è un alieno ma una maschera tipica del nostro tempo. Il corpo diventa un tiranno esigente che non lascia riposare mai.
In uno dei suoi ultimi libri titolato Il governo del corpo (Garzanti 1995), Piero Camporesi aveva abbozzato l’idea che una nuova "religione del corpo" si stesse imponendo nella nostra Civiltà. Peccato non abbia avuto il tempo per elaborare con la giusta ampiezza questa intuizione che oggi si impone ai nostri occhi come un’evidenza. Aveva ragione Camporesi: il nostro tempo ha sposato l’ideale del corpo in forma, del corpo del fitness, del corpo in salute, come una sorta di comandamento sociale inedito. Si tratta di una religione senza Dio che eleva il corpo umano e la sua immagine al rango di un idolo. Così il corpo sempre in forma, obbligatoriamente in salute, assume i caratteri di un dover-essere tirannico, di un accanimento psico-fisico, di una prescrizione moralistica: ama il tuo corpo più di te stesso!
La nuova religione del corpo si suddivide in sette agguerrite. Ma il loro comune denominatore resta l’esasperazione della cura di sé che diventa la sola forma possibile della cura come tale. Quella dimensione la dimensione della cura che per Heidegger definiva in modo ampio l’essere nel mondo dell’uomo e la sua responsabilità di fronte al fenomeno stesso dell’esistenza, sembra oggi restringersi al culto narcisistico della propria immagine.
La nuova religione del corpo richiede infatti una dedizione assoluta per se stessi. Volere il proprio bene, volersi bene, diventa il solo assioma che può orientare efficacemente la vita. Ogni sacrificio di sé, ogni arretramento rispetto a questo ideale autocentrato, ogni operazione di oltrepassamento dei confini del proprio Ego, ogni movimento di dispendio etico di se stessi viene guardato con sospetto dai fedeli di questa nuova religione. La stessa domanda rimbalza come una mantra dalla stanza dello psicoterapeuta sino negli studi dei talk show televisivi: perché non ti vuoi bene, perché non vuoi il tuo bene?
Le espressioni psicopatologiche di questa cultura si moltiplicano. La classificazione psichiatrica dei disturbi mentali (DSM) si arricchisce in ogni edizione di nuove sindromi che sono spesso l’effetto diretto di questa invasione sconsiderata della cura eccessiva di sé. Si pensi, per fare solo un esempio, alla cosiddetta ortoressia che etimologicamente deriva dal greco orhtos (corretto) e orexis (appetito). Si tratta di una nuova categoria psicopatologica che definisce, accanto all’anoressia, alla bulimia o all’obesità, una particolare aberrazione del comportamento alimentare caratterizzata dalla preoccupazione eccessiva per il "mangiare sano".
Ma come è possibile che una giusta attenzione a quello che si mangia sia classificato come una patologia? L’ortoressia esibisce un tratto essenziale del nostro tempo; il perseguimento del benessere, dell’ideale del corpo in salute, del corpo come macchina efficiente, può diventare un vero incubo, un’ossessione, può trasformarsi da rimedio a malattia. Il corpo che deve essere perennemente in forma è in realtà un corpo perennemente sotto-stress.
La vita medicalizzata rischia di diventare una vita che si difende dalla vita. Il corpo si riduce ad una macchina di cui deve essere assicurato il funzionamento più efficiente. Il medico non è più, come indicava Georges Canguilhem, l’"esegeta" della storia del soggetto, ma il "riparatore" della macchina del corpo o del pensiero. La malattia non è un’occasione di trasformazione, ma un semplice disturbo da eliminare il più rapidamente possibile cancellandone ogni traccia.
L’ortoressia riflette questa curvatura paradossale dell’ideologia del benessere mostrando come le attenzioni scrupolose alla protezione del proprio corpo possano trapassare nel loro contrario. Roberto Esposito ha da tempo messo in valore nei suoi studi di filosofia della politica sul paradigma immunologico questa contraddizione interna all’igienismo ipermoderno: il rafforzamento delle procedure di protezione della vita rischia di capovolgersi nel loro contrario facendo ammalare la vita.
Lo sfondo antropologico della nuova religione del corpo è quello del narcisismo ipermoderno che costituisce l’esito più evidente del tramonto di ogni Ideale collettivo. Se la dimensione dell’Ideale si è rivelata fittizia, se il nostro tempo è il tempo che non crede più alla potenza salvifica e redentrice degli Ideali, ciò per cui vale la pena vivere sembra allora ridursi al solo culto di se stessi.
La nuova religione del corpo è un effetto (non certo l’unico) del declino nichilistico dei valori, del perdere valore dei valori. Il corpo eletto a principio assoluto sfida, nel suo furore iperedonista, ogni Ideale per mostrarne tutta l’inconsistenza di fronte alla sola cosa che conta: il proprio corpo in forma come realizzazione feticistica dell’Ideale di sé. L’igienismo contemporaneo opera così un rovesciamento paradossale del platonismo. Il corpo salutista non è affatto il corpo liberato, ma è un corpo che da carceriere è divenuto carcerato. Se per Platone il corpo era il carcere dell’anima, se era la sua follia impropria, il corpo salutista appare invece come un corpo che è divenuto ostaggio, prigioniero di se stesso, carcere vuoto, puro feticcio, idolo senza anima.
Il comandamento del benessere, come accade per tutti gli imperativi che si impongono come obbligazioni sociali, come misure standard alle quali dover uniformare le nostre vite perché siano considerate "normali", rischia di scivolare verso l’integralismo fanatico del salutismo ortoressico. Soprattutto se si considera che questo comandamento punta a rigettare lo statuto finito e leso dell’uomo, la sua insufficienza fondamentale.
L’ideologia del benessere è infatti una ideologia che prova ad esorcizzare lo spettro della morte e della caducità. In questo svela il suo fondamento perverso se la perversione in psicoanalisi è il modo di rigettare la castrazione dell’esistenza, cioè il suo carattere finito. L’ideologia del benessere che alimenta la nuova religione del corpo sbatte la testa contro il muro della morte. E’ questo ostacolo inaggirabile che il nostro tempo vorrebbe espellere, cancellare, sopprimere e che invece ci rivela tutto il carattere di commedia che circonda il culto ipermoderno del corpo.
Dobbiamo ricordarci che la cura di sé non esaurisce la dimensione della vita. La cura è innanzitutto cura dell’Altro. Nietzsche aveva indicato la virtù più nobile dell’umano nella capacità di saper tramontare al momento giusto. Rara virtù nei nostri tempi, da celebrare come una preghiera.
(L’autore è psicanalista e saggista, il suo ultimo libro "Che cosa resta del padre?", è pubblicato da Raffaello Cortina)
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. ---- "Religione e corpo" - Unire cielo e terra serve a ridare un senso al mondo (di Raimon Panikkar).28 agosto 2010, di Federico La Sala
Unire cielo e terra serve a ridare un senso al mondo
di Raimon Panikkar (Corriere della Sera, 28 agosto 2010)
Negli ultimi giorni Raimon Panikkar aveva sulla scrivania un saggio dal titolo «Religione e corpo», un contributo del 1996 per la «Revista de filosofía» di Barcellona. Stava elaborando tali pagine, non ancora tradotte in italiano, per le opere complete. Diamo un estratto di questo scritto a cui lavorava.
Nel corso dei millenni l’uomo è stato attratto, spesso ossessionato e talvolta affascinato, da due forze che i mistici chiamerebbero trascendenza e immanenza, i poeti cielo e terra, i filosofi spirito e materia. L’uomo si è dibattuto tra questi due poli attribuendo di volta in volta più importanza all’uno o all’altro, disprezzando, trascurando o magari negando realtà all’uno dei due (la materia è male, il corpo è schiavitù, il tempo è illusione) oppure viceversa (il cielo non esiste, lo spirito è mera proiezione, l’eternità un sogno).
La religione, intesa quale dimensione umana che potremmo chiamare religiosità, messa di fronte al problema del significato della vita ha oscillato tra questi due poli senza riuscire a dimenticare completamente l’altro. Carpe diem: la terra è troppo attraente per non godere dei suoi piaceri. Fuga mundi: il mondo è troppo fugace per riporvi la nostra fiducia.
Non v’è dubbio, tuttavia, che molte delle principali religioni ai nostri giorni hanno decisamente spostato la bilancia verso il trascendente, lo spirituale, l’ultraterreno. «Come andare in cielo» è il compito della religione; «come vanno i cieli» è l’incombenza della scienza: è stata questa la materia di discussione tra uno scienziato (Galileo Galilei) e un teologo (Roberto Bellarmino).
La dicotomia è stata letale per entrambi. La religione è bandita dagli affari umani e la scienza diventa una specialità astratta, avulsa dalla vita umana. La religione diventa un’ideologia e la scienza un’astrazione. In entrambi i casi il corpo è praticamente irrilevante. Compito della nostra generazione, se non vogliamo contribuire all’estinzione dell’homo sapiens, è di tornare a celebrare l’unione tra cielo e terra, quello hieros gamos o sacra unione di cui parlano tante tradizioni, non esclusa la cristiana.
Lo studio delle tradizioni religiose dell’umanità ci mostra che «scienza» (per non usare altri termini) ha voluto dire qualcosa più che descrizione empirica di comportamenti «religiosi» e delle loro interpretazioni «scientifiche» e che religione non è riducibile a pratiche o credenze definite «religiose» dal punto di vista della razionalità intesa nel senso in cui l’ha interpretata il cosiddetto illuminismo. Dicendo «scienze» non vogliamo escludere alcuna forma di coscienza né di saggezza.
Nel dire «religioni» non vogliamo cadere nel monopolio di questa parola da parte di istituzioni («religiose»); ci riferiamo invece a quel nucleo ultimo di ogni cultura, e anche di ogni vita umana, che si crede dia un certo senso alla vita.
È molto significativo che la parola polisemica «religione» sia stata ritenuta poco meno che sconveniente in alcuni ambienti e che si sia voluto sostituirla con «spiritualità». Ciò però dimostra che l’allergia alla parola «religione» è solo superficiale, dato che la parola «spirito» potrebbe farci cadere a sua volta in un altro «ghetto» esclusivo degli «spiritualisti». Se si critica la religione in quanto oasi chiusa che esclude i cosiddetti non-credenti, la spiritualità a sua volta potrebbe essere intesa come la confederazione di religioni in antitesi a coloro che negano ciò che è spirituale. Sin dai tempi di Confucio si sa che esiste una politica delle parole.
(traduzione di Milena Carrara Pavan)
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA. Note per una rilettura della "Critica della Ragion pura".9 agosto 2010, di Federico La Sala
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- Perché non possiamo più dirci cartesiani (di Antonio Gnoli).1 settembre 2009, di Federico La Sala
 Perché non possiamo più dirci cartesiani
Perché non possiamo più dirci cartesiani Esce in una nuova edizione l’opera completa del filosofo che è all’origine della nostra modernità
Esce in una nuova edizione l’opera completa del filosofo che è all’origine della nostra modernità
 Cosa resta di lui oggi che il suo motto è diventato "Non penso dunque sono"?
Cosa resta di lui oggi che il suo motto è diventato "Non penso dunque sono"?
 Si può sospettare che la sua filosofia sia stata un esempio di militarizzazione del pensiero
Si può sospettare che la sua filosofia sia stata un esempio di militarizzazione del pensiero
 La sovranità assoluta del suo "Io penso" si è frantumata sui muri del Novecento
La sovranità assoluta del suo "Io penso" si è frantumata sui muri del Novecento di Antonio Gnoli (la Repubblica, 01.09.2009)
di Antonio Gnoli (la Repubblica, 01.09.2009)Quando alla fine degli anni venti Edmund Husserl tenne le sue lezioni parigine su Descartes (che poco dopo sarebbero state raccolte con il titolo Meditazioni cartesiane), sembrava che la partita, giocata nel nome di un legame fondamentale tra filosofia e scienza, potesse avere la meglio sulle inquietudini e le incertezze speculative che negli stessi anni cominciavano a serpeggiare nella filosofia europea.
Perfino un acuto poeta aperto al pensiero scientifico, come Paul Valèry, nel ricostruire le algide movenze mentali di Monsieur Teste, rivendicava l’assoluta autonomia cartesiana del pensiero dalle faccende del mondo, lasciando al lettore la sensazione che una efficace macchina solipsistica potesse in qualche modo ristabilire la supremazia del cogito su tutto il resto. Ma quella vicenda, ammantata di razionalismo, andò come è noto in tutt’altro modo.
Del resto, quando René Descartes mise mano a quei due o tre capolavori filosofici che avrebbero segnato i secoli successivi - e tra questi Il discorso sul metodo e le varie Meditazioni - non poteva immaginare che proprio il Novecento avrebbe lasciato esplodere le grandi questioni da lui così efficacemente poste. È probabile perciò che egli stenterebbe a orientarsi tra le tumultuose trasformazioni che il pensiero filosofico ha subìto, allineando accanto alle celebri idee chiare e distinte quelle oscure e complicate di molti altri filosofi, e perfino semplicistiche, come si rileva attraverso il più efficace General Intellect che ci sia rimasto, ossia la televisione.
Ora, chi voglia in qualche modo rendersi conto di che cosa sia stato questo genio che seppe con eguale acutezza misurarsi con i grandi problemi della matematica e della filosofia, lo può fare grazie alla nuova edizione delle Opere che Bompiani pubblica in tre volumi a cura di Giulia Belgioso, studiosa che ha al suo attivo anche la cura di tutte le Lettere apparse sempre da Bompiani nel 2005. Grazie a questo programma meritorio di pubblicazione dei grandi testi della filosofia classica (e il merito è qui soprattutto di Giovanni Reale), abbiamo a disposizione, con testo a fronte, l’intero corpus cartesiano, vero e proprio monumento filosofico che è alle origini di tutte le possibili considerazioni sul moderno.
Ma chi è stato Descartes? Le poche immagini a disposizione lo ritraggono in pose che suggeriscono solidità di vedute e insieme qualcosa di sfuggente. Il capello fluente e mosso fin sulle spalle, la frangia irregolare che gli scende sulla fronte, il baffo e il pizzo à la mode secentesca, l’occhio di un pesce abituato alle profondità marine, restituiscono i tratti di un signore che avrebbe potuto intraprendere la professione del soldato, o quella del borghese se non proprio quella del filosofo. In effetti, non disdegnò le armate. Si arruolò nel reggimento del principe Maurizio di Nassau. Si conosce la sua passione per il gioco d’azzardo, la scherma e l’arte della fortificazione. E a volte si può anche sospettare che sia stato il primo vero esempio di una militarizzazione del pensiero filosofico.
Del resto erano anni in cui le guerre, i dissidi, le imboscate esplodevano improvvisi. L’urto delle armature, il rumore dei primi cannoni, lo spostamento delle truppe, gli assedi, rappresentavano uno spettacolo violento e prolungato nel tempo. Mostravano i segni che l’uomo lasciava sulla terra. Ma l’uomo era questo o anche altro? Il mondo nel quale Descartes si trovò a vivere si era improvvisamente svegliato da un profondo letargo. Il lungo dominio esercitato dalla teologia era minacciato dalle scoperte geografiche e scientifiche. Costruzioni del pensiero ritenute fino ad allora saldissime rischiavano di crollare sotto il peso delle insidie che la scienza, con Galileo, Harvey e poi Newton, aveva scatenato.
La mente prensile di Descartes si muoveva con estrema agilità in quella nuova visione del mondo. Il suo talento per le scienze non era da meno del suo genio filosofico. La sua ambizione era di riuscire a unire saldamente i due saperi: la filosofia non avrebbe dovuto fare a meno della scienza, che a sua volta si sarebbe dovuta servire delle conoscenze filosofiche per dar vita a quel sistema di regole certe senza il quale l’uomo avrebbe continuato a vivere nel disorientamento e nell’oscurità. Quella tensione fu il lascito che Descartes trasmise ai secoli successivi.
Anche nel merchandising filosofico Descartes eccelleva: fu un genio della formula breve. Coniò con tre parole una sentenza il cui successo sarebbe giunto indenne fino ai giorni nostri: Penso dunque sono. Icastica, evidente, esplosiva come un messaggio pubblicitario. Ma davvero pensare equivaleva ad essere? E poi pensare a cosa? Possiamo immaginare il filosofo mentre con cura esamina il dettato della mente e lo separa dal corpo; vederlo chino su quella macchina prodigiosa che è l’uomo, destinata a corrompersi; osservarlo davanti al sorprendente spettacolo che il mondo consegna al suo sguardo, colmo di ammirazione ma non fino al punto da trarlo in inganno. Troppe cose che vi accadono sono soggette alla contraddizione, alle incertezze.
Nasce qui il famoso dualismo cartesiano: separare e dubitare sono le sue armi conoscitive. Il dubbio in lui non ha una portata scettica. È un’arma metodologica per dirimere il vero dal falso, il reale dal sogno, il ragionevole dal folle. In genere queste partite filosofiche finivano ancor prima di cominciare. Prima di René la filosofia armeggiava con le sue certezze, le sue gerarchie, i suoi modi scolastici. Se si scrutava il cielo lo si faceva con gli occhi di Aristotele e guai a sgarrare, guai a controvertire idee e processi stabiliti e saldamente nelle mani dei dotti. Pensare in modo non retto poteva essere molto pericoloso. Descartes, così incline al nuovo, sapeva a cosa sarebbe andato incontro nel sostenere certe tesi. L’accusa di ateismo avrebbe potuto distruggergli la carriera, buttarlo nello sconforto o peggio in qualche buia galera.
Quest’uomo accorto - in corrispondenza con mezza Europa, mentre con l’altra metà litigava - era conscio di ciò che rischiava. Memore delle disavventure accadute a Galileo, della censura e poi dell’abiura nelle quali il grande scienziato era incappato, Descartes agì con cautela. Rinunciò a pubblicare alcuni libri. Il che non gli impedì di imbattersi in lunghe e asfissianti polemiche con chi vedeva nella sua filosofia una temibile rivoluzione, una cancellazione di Dio, un insulto ai grandi e stabili precetti della Chiesa. Il nichilismo, su cui oggi molto si discetta, incubava involontariamente nei pensieri di Descartes, prima che in quelli di Nietzsche.
Eppure egli non voleva sbarazzarsi di Dio. Anzi la sua ambizione era di dare a questa entità somma la dignità ontologica che le spettava. Ma dopo aver sentenziato cogito ergo sum, come poteva credere che i lupi della scolastica lo avrebbero risparmiato?
Proviamo a scendere per un momento nel dettaglio. Al penso dunque sono Cartesio vi giunge dopo un esame che libera il pensiero dalle insidie che la realtà può riservargli. D’altra parte, posso io dubitare di quest’ultima? Certo che sì, dal momento che potrei sognare ciò che ritengo di aver vissuto, o perfino posso essere ingannato da qualche diavolo, per non parlare del folle che ritiene che il suo corpo sia di vetro. La sola cosa che gli appare dotata di inoppugnabile certezza è l’idea stessa del pensare. Anche se sognassi, o fossi ingannato o finissi nei fumi dell’allucinazione, non potrei mettere in dubbio il fatto stesso che quelle cose le ho pensate.
Questa lezioncina di filosofia non sgomenti, perché l’aspetto interessante non è tanto l’argomentazione cartesiana, quanto quello che la celebre frasetta poté produrre sul piano delle conseguenze. Si può sospettare, per esempio, che penso dunque sono sia un duplicato della potenza divina, traducibile in Dio pensa, dunque è, dunque crea.
Ma il fatto di aver ricondotto questa potenza alla natura umana suggerisce questioni ulteriori. Che cosa accade se l’uomo si sostituisce a Dio? Descartes non era del tutto ignaro dei rischi ai quali sarebbe incorso dando all’Io penso lo statuto della sovranità assoluta. Tutte le avventure moderne del Soggetto nascono lì e si sviluppano fino a infrangersi sui muri del Novecento che frantuma quell’Io diventato impensabile.
È dunque un passaggio obbligato chiederci che cosa resta del nostro magnifico filosofo, espropriato di quell’Io sul quale tanta filosofia successiva ha provato in modi diversi a fondarsi. Oggi - che lo slogan è "non penso dunque sono" - oggi che il pensiero è diventato il più futile tra gli strumenti del conoscere, e che pensare equivale a quell’apparire sempre miracolosamente in bilico tra una certa idea di successo e l’essere ricacciati nell’anonimato, oggi che il corpo ha spostato in modo sensibile le argomentazioni filosofiche, non avrebbe molto senso definirsi cartesiani.
La monumentale iniziativa di Bompiani ci restituisce nella sua integrità filologica un’incantevole figura metafisica, dalla quale tutto ci divide tranne il desiderio di misurarsi con la sua intelligenza. Che fu aspra e scevra da pregiudizi, e in ultima analisi egocentrica e introspettiva come poche. Descartes morì nel 1650 a 54 anni per una polmonite. In spregio al medico curante che Cristina di Svezia gli aveva mandato, tentò di curarsi da solo. La leggenda vuole che sia stato avvelenato.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- Le emozioni primordiali. Gli albori della coscienza: le quattro vie che portano alla coscienza. Derek Denton indaga i meccanismi che ci inducono a pensare (di Edoardo Boncinelli).27 giugno 2009, di Federico La Sala
 Esplorazioni
Esplorazioni Il neurobiologo Derek Denton indaga i meccanismi che ci inducono a pensare. E forse ci avvicinano agli animali
Il neurobiologo Derek Denton indaga i meccanismi che ci inducono a pensare. E forse ci avvicinano agli animali Le quattro vie che portano alla coscienza
Le quattro vie che portano alla coscienza La visione del mondo, le emozioni, gli stimoli primari, la percezione del proprio corpo
La visione del mondo, le emozioni, gli stimoli primari, la percezione del proprio corpo di Edoardo Boncinelli (Corriere della Sera, 26.06.2009)
di Edoardo Boncinelli (Corriere della Sera, 26.06.2009)La «mente» è ciò che il cervello fa, afferma candidamente Derek Denton nel suo Le emozioni primordiali. Gli albori della coscienza appena uscito da Bollati Boringhieri. Ci sono persone per le quali tale affermazione suona assurda e inaccettabile e altre, compreso me, per le quali non fa una grinza ed è, anzi, perfino ovvia. Temo che questi due gruppi di persone non potranno mai capirsi. A volere essere precisi la mente è in effetti solo parte di ciò che il cervello fa: quest’ultimo infatti respira e metabolizza zuccheri, ma noi non definiamo mente tali attività. Né definiamo mente molte altre funzioni complicatissime del nostro cervello come quelle di seguire con lo sguardo un uccello in volo o di portarsi un cucchiaio alla bocca. Noi chiamiamo mente ciò che di più alto, cioè a noi più gradito, il cervello fa. Un capitolo particolare, e particolarmente gradito, delle estrinsecazioni della mente è poi rappresentato dalla coscienza, ciò che ci permette (ad esempio) di sapere dove siamo in questo momento e di sapere che lo sappiamo.
Quello della natura, delle proprietà e dell’origine della coscienza è uno degli argomenti più affascinanti dello studio degli animali superiori e dell’uomo, che è stato oggetto di molti libri (ma di pochissimi articoli scientifici) negli ultimi venti o trenta anni. Ci si sono misurati filosofi, psicologi e qualche scienziato, ciascuno con una sua visione e una sua proposta. Si tratta di definire che cosa è la coscienza, di illustrare come agisce e di quale utilità può essere per chi la possiede, di individuarne l’origine evolutiva e magari di indicare quando, approssimativamente, è comparsa nel corso dell’evoluzione degli animali superiori. Qualcuno infatti la considera appannaggio esclusivo della nostra specie, mentre altri ne vedono una certa continuità nelle specie animali diverse dalla nostra.
Derek Denton, neurobiologo di grande esperienza, studia da sempre i meccanismi fisiologici che sottendono la percezione e il soddisfacimento dei bisogni biologici essenziali come la fame, la sete, il sonno, il bisogno d’aria, l’appetito per i diversi sali minerali, nonché la percezione del dolore e il desiderio sessuale. Pensa, giustamente, che questi bisogni abbiano preceduto di gran lunga la comparsa della coscienza e che, forse, possano dirci qualcosa di molto interessante anche su di essa.
Per quanto riguarda l’origine del fenomeno «coscienza» o, per lo meno, del suo primo nucleo costitutivo, la cosiddetta coscienza primaria, c’è chi, come Gerald Edelman, chiama in causa la percezione del mondo esterno e la sua rappresentazione. Su questa base la coscienza primaria sarebbe capace di «creare una scena», cioè una mappa interiore degli eventi, sulla quale poi lavorare per impostare un ragionamento o un’azione. C’è invece chi, come Antonio Damasio, chiama più direttamente in causa il mondo emotivo, per quanto ridotto all’essenziale, e vede la coscienza primaria come un nodo di sensazioni e risonanze emotive sulle quali si può poi costruire tutto il resto.
Denton propone un terzo possibile elemento costitutivo della coscienza primaria, l’enterocezione, cioè la percezione non degli eventi esterni, ma di quelli interni al nostro corpo, come appunto gli stimoli primari della fame e della sete, che non ci abbandonano mai e che accompagnano come un leitmotiv di fondo tutti gli attimi della nostra vita. Il contatto continuo con questa nostra interiorità «corporea» starebbe quindi alla base dell’emergere di una coscienza di sé che dovrebbe poi arricchirsi di tutti gli altri elementi che conosciamo. Il libro ci conduce attraverso i dettagli teorici e sperimentali di questa coinvolgente proposta, che ha anche il merito di tracciare un’affascinante linea di continuità fra le diverse specie animali, che sfocerebbe poi nel nostro complesso, intellettualizzato e autoconversante modo di vivere la coscienza in ogni frangente della quotidianità.
Personalmente, trovo del buono in ciascuna di queste proposte e penso che la coscienza primaria sia un po’ tutto questo. Con l’aggiunta della propriocezione, la percezione che ognuno di noi ha dello stato di tensione dei muscoli del proprio corpo e che mi permette di rendermi conto di stare in posizione eretta oppure di stare seduto, comodo o scomodo, oppure sdraiato o in bicicletta o in macchina, in procinto di compiere questa o quella azione.
La coscienza è quindi il modo nel quale la percezione del mondo esterno, ma anche delle condizioni momentanee del mio proprio corpo, diviene una cosa «mia», interiore, omogenea a tutto ciò che già vi si trova, e «utilizzabile». Per cosa? Per poter «agire», materialmente, mentalmente o anche solo attraverso un’espressione verbale. Può darsi che tutta la magia del fenomeno coscienza si risolva nel portare alla ribalta del mio Io certi contenuti della percezione che siano «pronti per l’azione» o addirittura già azione: cose che stanno a mezza via fra la constatazione e la progettazione, come dire «il progetto».
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. --- La terza via. È nell’arte. Un libro di Alessandro Ferrara rilegge la "Critica del giudizio" Proponendo una soluzione fra fondamentalismo e relativismo (di Giancarlo Bosetti).2 agosto 2008, di Maria Paola Falqui
Un libro di Alessandro Ferrara rilegge la "Critica del giudizio" Proponendo una soluzione fra fondamentalismo e relativismo
In mancanza di un fondamento, chi ci impedisce di diventare una società di pazzi? Sviluppare quella sapienza che consiste nel venire a patti con la pratica
Immanuel Kant. La terza via. È nell’arte
di Giancarlo Bosetti (la Repubblica, 02.8.08)
Ritorna il Kant della terza critica, quella del giudizio. Un libro di Alessandro Ferrara, che appare in questi giorni in italiano a poche settimane dalla pubblicazione in versione inglese, presso la Columbia University Press - La forza dell’esempio, Feltrinelli (pagg. 262, euro 22) - tenta una via di uscita originale dall’impasse filosofica del nostro tempo, quella che blocca un po’ tutte le scuole al bivio tra fondazionismo e relativismo, tra metafisica e nichilismo, tra universalismo e pluralismo. E come si immagina dal sottotitolo, Il paradigma del giudizio, questa via di uscita si ispira a una ardita lettura della terza delle tre celebri critiche, quella che segue, alla Critica della ragione pura (che contiene la dottrina trascendentale della conoscenza) e alla Critica della ragione pratica (che contiene la dottrina morale). La Critica del Giudizio si presenta come un trattato di estetica, nel senso tradizionale di teoria dell’arte, anche se già nel suo autore essa aveva l’ambizione di riconciliare l’ambito della natura e della fisica con quello della libertà umana, introducendo nell’indagine sul bello e il sublime, il paradigma dell’"esempio" e il principio di finalità; ma qui Ferrara ne propone una lettura e uso assai più estesi. Non è una novità che il grande filosofo tedesco sia accreditato di una sorta di "terza via", la novità è che Ferrara ne cerchi la chiave più preziosa non nella epistemologia e non nell’etica, ma nelle pagine sul "giudizio riflettente", il giudizio estetico.
Il confronto filosofico internazionale e interculturale è esposto nei nostri tempi in misura crescente alla frantumazione "provinciale": ogni contesto la sua teoria, ogni contrada le sue categorie e i suoi principi. Le sirene postmoderniste alzano il loro canto: decostruzionismo, ermeneutica, culturalismo, trionfo della differenza e con essa - ammoniscono, e non per caso, i due ultimi pontefici romani - del relativismo. Si capisce che il mercato delle idee sia favorevole per l’offerta di chi presume di disporre ancora - in regime di quasi monopolio - di una Verità di fede e di un Logos accreditato di portata generale.
Tra i filosofi, che non hanno in dote simili certezze, la svolta antimetafisica - detta anche "linguistica" - che ha sepolto, ad opera di Wittgenstein e seguaci, i fondamenti di ogni possibile "pensiero forte" - crea condizioni di gioco molto più difficili. Se non si può disporre di alcun fondamento su cui appoggiare le nostre idee al di fuori degli scambi di discorsi che possiamo farci l’un l’altro, se tutto quello che possiamo fare è dire frasi dentro contesti determinati, locali e datati, se non abbiamo chiodi cui appendere qualche dover essere, che cosa ci può garantire che non finiremo per arrenderci alle più stravaganti e arbitrarie abitudini di una qualsiasi comunità di pazzi, come nei film di Night Shyamalan (The village o Sesto senso) dove non si capisce più chi è il fantasma e chi è "reale"?
Quale pensiero ci garantisce che i decantati - e a tutti gli effetti meritevoli di esserlo! - principi generali dei diritti umani, della libertà, della democrazia, delle garanzie costituzionali siano qualcosa di più che discutibili usanze locali? Che risposta filosofica è in grado di dare la filosofia politica alla osservazione di chi li descrive come un "pacchetto illuministico" di origine locale, inventato tra Parigi e Londra e perfezionato a Philadelphia, ma non utilizzabile a Pechino, a Mosca, nel Darfur o a Ryad? Chi lo stabilisce che in assoluto è sbagliato costringere una donna a portare il burqa? O infliggere a un ladro la condanna del taglio della mano? Quale genere di suprema Ragione può decretare in questi casi?
La risposta di Ferrara consiste nella "forza dell’esempio", che funziona come il "giudizio riflettente" della terza critica: a differenza del "giudizio determinante" esso si aggira tra particolare e particolare, passa da caso a caso, perché il bello non si impone con la forza di una legge della fisica o di un imperativo morale, ma non è neppure inafferrabile. La critica d’arte non consiste in una serie di teoremi, ma nella capacità di discorrere di tante singole situazioni, e sa individuare qualche spiegazione di quel che è "piacevole" o non lo è. Essa esige la maturazione di quel genere di sapienza che Aristotele chiamava phronesis e che consiste nella capacità di venire a patti con la pratica. Il giudizio - avvertiva Hannah Arendt, un’altra fonte che ha guidato Ferrara nell’aprirsi la strada verso la sua filosofia del giudizio e dell’esempio - non si basa soltanto sulla coerenza rispetto a un principio, ma richiede anche capacità di distinguere, immaginazione, distacco, simpatia, imparzialità e integrità ed è la "più politica" delle attitudini umane.
Se sosteniamo, "per esempio", la causa della parità di genere, della uguale dignità e degli uguali diritti tra uomini e donne, non sarà la forza geometrica del principio a trionfare in forza di una sua superiorità logica o morale. Se mai questo principio si affermerà tra i clan somali o nei villaggi indiani e pakistani, imponendo la fine dei matrimoni imposti, o se mai scomparirà la potestà del marito sulla moglie nei paesi arabi dove sopravvive, questo avverrà grazie alla affermazione, nei conflitti politici e nelle infinite battaglie che saranno necessarie, degli esempi più convincenti. È più verosimile, oltre che auspicabile, che la potestà del marito sulla moglie scompaia nei paesi del Magreb piuttosto che non ritorni nelle costituzioni europee. Il che non dipende da un principio celeste, provvidenziale, essenziale o basato su categorie innate dell’intelletto. Sembra basarsi su un sensus communis che attraversa culture, epoche e linguaggi diversi, proprio come il giudizio estetico secondo Kant.
In verità gli allievi della scuola filosofica italiana che hanno faticato sulle pagine di Luigi Scaravelli e Emilio Garroni (anche se Ferrara non li menziona) avevano già imparato qualche decennio fa che la Critica del giudizio si muove verso una idea assai attuale della conoscenza, verso leggi empiriche, secondo un principio dell’unità del molteplice. Il Kant della terza critica, tra contraddizioni e ripensamenti (e propenso a fertili divagazioni) cercava un tertium che gli consentisse di trovare le basi per una composizione mite e accorta di quel problema che oggi noi chiamiamo "della differenza" di tempo e cultura. E lo trovava nella "forza dell’esempio". Che Ferrara isola molto bene e cerca di coniugare aderendo ai problemi posti dalle tensioni del mondo di oggi e dalle relazioni tra le culture. Lo fa in sintonia con uno spostamento generale della filosofia contemporanea: dalle ambizioni di una validità generale extrastorica verso un mondo che è sempre storico, condizionato, datato, attraversato da diversità.
Se Gadamer ha insegnato a tutti che la nostra comprensione e valutazione degli eventi si costruisce a partire dai pregiudizi, Rawls ha corretto la dimensione astratta della sua iniziale teoria della giustizia per avvicinarla al vissuto delle tradizioni culturali, Bernard Williams ha posto la filosofia morale, inevitabilmente incompleta, a contatto con le concrete vicende della politica, Davidson e Hilary Putnam hanno formulato una dottrina del realismo "dal volto umano", capace di resistere alle obiezioni antimetafisiche, più mite, parziale e condizionata.
Tutto inutile? Sembra di sentire sullo sfondo la risata di Richard Rorty, il grande neopragmatista americano scomparso due anni fa: tempo perso cercare ragioni per i problemi del mondo con la filosofia, c’è una unica indiscutibile priorità, quella della democrazia sulla filosofia. Prendiamone atto, punto e basta. Alla filosofia dobbiamo rinunciare e chiudere bottega. Cosa che Rorty fece. Ma possiamo noi seguirlo in questa fine di esercizio? Il tentativo di Ferrara parla per coloro che vogliono continuare onestamente a provarci.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".... L’esperienza. Perché i neuroni non spiegano (interv. a Riccardo Manzotti).28 luglio 2008, di Maria Paola Falqui
RICCARDO MANZOTTI
«La conoscenza non è fatta solo dal cervello» *
Riccardo Manzotti è un ingegnere-filosofo che insegna Psicologia allo Iulm di Milano. E dedica le competenze multidisciplinari al ’mistero della coscienza’. Il punto sulla sua ricerca l’ha fatto in un volume scritto a quattro mani con Vincenzo Tagliasco, decano della robotica italiana, tragicamente scomparso in maggio: L’esperienza. Perché i neuroni non spiegano tutto (Codice edizioni).
Professor Manzotti, quello di ’esperienza’ sembra un concetto immediato, ma forse descriverlo non è così semplice... «Dalla mattina alla sera, ognuno di noi vive dentro la propria esperienza: dei colori, dei sapori, degli aspetti piacevoli e meno piacevoli della vita. L’esperienza è il materiale di cui è fatta la nostra esistenza. Senza l’esperienza il mondo non sarebbe che polvere, atomi, cellule, reazioni chimiche. Per fortuna, il mondo è anche qualcos’altro».
Quello che ci dicono le neuroscienze esaurisce l’esperienza?
«Grazie a nuove tecniche di ’brain imaging’, i neurobiologi sono stati in grado di fare passi da gigante nel comprendere come il cervello distingua stimoli diversi, memorizzi l’informazione, faccia associazioni, controlli il comportamento, che ruolo abbiano i neuroni specchio. Ma se guardiamo all’attività delle cellule nervose, non troviamo niente che assomigli alle nostre esperienza quotidiane. Al massimo il neurobiologo trova una correlazione tra certi neuroni e certe esperienze, ma non quello che il paziente prova. La distanza tra i neuroni e una semplice esperienza quale può essere quella di gustare un buon gelato al cioccolato è incolmabile. Per i neuroscienziati, quindi, resiste il mistero della ’coscienza fenomenica’, il termine filosofico per la capacità di fare esperienza».
Si dice che quello della coscienza sia uno degli ultimi ’misteri’. Che soluzione viene proposta nel libro?
«La rivista Science (che, insieme con Nature, è una delle massime autorità scientifiche al mondo) ha inserito la coscienza tra i cinque più grandi misteri che la scienza dovrà affrontare nei prossimi anni. Nel libro, io e Tagliasco, abbiamo delineato, con un lavoro che ha richiesto una decina di anni, un quadro di riferimento alternativo a quello comunemente utilizzato dalle neuroscienze».
In sintesi, che cosa proponete?
«I neuroscienziati cercano l’esperienza dentro il cervello. Noi suggeriamo di prendere in considerazione un supporto fisico più ampio, che comprende una parte del mondo esterno al corpo. Quando, ad esempio, guardiamo un giglio di montagna, si ha una catena di fenomeni fisici che procedono dalla superficie del giglio, entrano nel nostro occhio, procedono lungo il nervo ottico e scatenano complesse attività nel cervello. Le neuroscienze insistono nel cercare l’esperienza del giglio nell’ultimo tratto di questa catena di fenomeni, nel ’pezzetto neurale’. Noi suggeriamo di considerare tutta la catena. Secondo noi, l’esperienza è fatta anche dal giglio che sta di fronte a noi, e non solo dai neuroni dentro il nostro cervello».
Perché si dice già nel sottotitolo che i neuroni non spiegano tutto, proprio in un momento in cui le neuroscienze affrontano la morale, l’estetica e la politica?
«Ogni tanto nella scienza ci si lascia affascinare da quello che è stato definito il ’pensiero magico’. Si comprende un nuovo fenomeno, in questo caso i neuroni, e si cerca di utilizzarlo per spiegare tutto. È ovvio che il funzionamento del cervello ha un ruolo in tutte le attività del genere umano (estetica, morale, economia); ma non esistono cervelli isolati e autonomi. I cervelli sono necessari per l’esistenza delle persone, le due entità però non coincidono. Il nostro libro cerca di chiarire la differenza».
Una teoria che voglia spiegare come funziona la nostra mente deve essere necessariamente materialistica per risultare scientifica e affidabile?
«La mente non è l’anima. La mente è un fenomeno che, con tutta probabilità, condividiamo con molti animali, anche se in gradi diversi. Chi infliggerebbe dolore a una scimmia o a un cane? Il motivo è che, al di là di tante teorie, riteniamo che questi animali abbiano una mente che fa esperienza del dolore. La mente è probabilmente un fenomeno fisico, ma non limitato al solo cervello. Quanto alla definizione di materialismo, vorrei far notare che non comprendiamo appieno la natura della realtà fisica e quindi si tratta di un confine ancora molto vago».
Chi non aderisce a uno stretto fisicalismo su mente/cervello viene emarginato dalla comunità dei ricercatori?
«Un filosofo e scienziato come Alfred North Whitehead ha scritto che in ogni epoca esistono ipotesi o metafore che vengono accettate implicitamente. Queste ipotesi appaiono così ovvie che la gente non si rende conto di usarle, né delle alternative. Lo scopo della scienza è quello di superare questi limiti. L’occasione è fornita proprio dai grandi interrogativi sull’esperienza e sulla mente».
* Avvenire, 27.07.2008
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".3 luglio 2007, di Federico La Sala
Lo spirito dell’illuminismo, appassionato pamphlet di Tzvetan Todorov
Quei Lumi che devono guidarci
di Umberto Galimberti (la repubblica, 05.05.2007)
Dopo la morte di Dio e dopo il crollo delle ideologie che hanno innescato la tragedie del XIX secolo, quale puo’ essere il fondamento intellettuale e morale della nostra societa’? Per Tzvetan Todorov, uno degli intellettuali europei piu’ autorevoli e piu’ ascoltati, la risposta non puo’ trovarsi se non ritornando all’Illuminismo, qui inteso non tanto come una corrente di pensiero o un compendio di dottrine filosofiche, quanto come una condotta, una pratica di vita, un esercizio del pensiero, da cui l’umanita’, se non vuole abdicare a se stessa, non puo’ esonerarsi.
Quindi l’Illuminismo, non come teoria ma come prassi, come azione capace di ispirarsi a quelli che per Todorov sono i cinque cardini dell’Illuminismo.
Autonomia
L’autonomia del pensiero, innanzitutto, capace di garantire a tutti la liberta’ di analizzare, discutere, criticare, dubitare, al di la’ delle fedi, dei dogmi e delle istituzioni intoccabili. E questo perche’, ce lo ricorda Kant: "L’illuminismo e’ l’uscita dell’uomo da una condizione di minorita’ di cui egli stesso e’ responsabile, dove per minorita’ si deve intendere l’incapacita’ di servirsi del proprio intelletto senza la guida di altri".
Laicita’
La laicita’, che deve essere garantita a tutti i settori della societa’ anche da parte degli individui che aderiscono a una fede, perche’ senza laicita’ la stessa autonomia del pensiero non e’ piu’ garantita e la democrazia rischia di rifluire in quel suo antecedente che e’ la teocrazia da cui l’illuminismo ha emancipato noi occidentali.
Verita’
La verita’ non puo’ essere appannaggio della fede, ma della ricerca scientifica, di cui l’Enciclopedia illuminista ha segnato il primo avvio.
Tra fede e verita’ non c’’e’ infatti compatibilita’, perche’ se una cosa la "so" non la "credo", e se la credo vuol dire che non la so. Inoltre la verita’ scientifica e’ congetturale, ipotetica e disponibile a essere superata da ipotesi piu’ esplicative. Quindi nessuna verita’ assoluta, ma confronto tra verita’ relative che si lasciano sottoporre a verifica.
Umanita’
L’umanita’ puo’ vivere in concordia solo se nessuno pretende di essere il depositario della verita’ assoluta, e quindi la tolleranza che antepone la concordia degli uomini, che provengono dalle piu’ disparate tradizioni, alla difesa delle proprie consuetudini. Sotto questo profilo anche il messaggio cristiano puo’ essere accolto la’ dove con San Paolo dice: "Chi ama il prossimo ha adempiuto la Legge". Motivo questo ripreso da Franklin secondo il quale: "Il culto piu’ gradito a Dio e’ fare del bene agli uomini".
Universalita’
L’universalita’, il cui primato va rivendicato rispetto all’appartenenza all’una o all’altra societa’, trova la sua applicazione nella proclamazione dei "diritti dell’uomo" che sanciscono una rigorosa uguaglianza di fronte alla legge e una chiara distinzione tra diritto e morale perche’, come scrive Beccaria: "I giudici non sono vindici della sensibilita’ degli uomini, ma dei patti che li legano tra loro".
Per effetto del primato della legge non e’ consentito l’uso della forza fuori dall’ordinamento legislativo. E questo sia nel caso dei singoli che non devono essere torturati o messi a morte, sia nel caso della nazioni che non devono essere aggredite per pura espansione del proprio potere.
Da questi brevi spunti si capisce quanto l’Illuminismo non sia tanto la filosofia di un’epoca storica, quanto una pratica di vita e un compito etico, da cui nessuno, che tenga in qualche conto la dignita’ dell’uomo, puo’ sentirsi esonerato.
L’invito di Todorov e’ allora quello di "ricominciare tutti i giorni questa impresa, ben sapendo che non vedra’ mai la fine", perche’ come rispondeva Kant a chi gli chiedeva se eravamo gia’ nell’eta’ dell’illuminismo: "No, bensi’ in un eta’ in via di illuminazione".
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO ...20 gennaio 2007, di Federico La Sala
UNA BELLA E LUCIDA RIFLESSIONE, MA "PRE-COPERNICANA", E "PRE-FACHINELLIANA" !!! (fls)
L’ansia di sapere chi siamo davverodi Umberto Galimberti (“la Repubblica”, 19.01.2007)
Eugenio Scalfari, sull’“Espresso” del 18 gennaio, interviene su un tema che entrambi consideriamo molto importante e che potrebbe essere formulato così: che ne è della nostra identità, oggi, in cui assistiamo all’indebolirsi di tutte le appartenenze territoriali, culturali, religiose, ideologiche, familiari, di genere, sessuali, che finora hanno costituito il perimetro, all’interno del quale, si è costituita, è cresciuta, ha preso forma la nostra identità?
Non stiamo diventando anime perse, senza punti di riferimento, che vagano come naufraghi nel mare di quella malintesa libertà che, svincolata da tutte le appartenenze, ritrova se stessa nella semplice possibilità di revocare tutte le scelte, dove è sottinteso che le identità possono essere indossate e scartate come la cultura del consumo ci ha insegnato a fare con gli abiti, senza la possibilità di costruire una vera biografia?
Entrambi conveniamo che questa è la tendenza del nostro tempo, determinata dai processi di de-territorializzazione indotti dalla globalizzazione e dai processi migratori; dal relativismo culturale conseguente alla conoscenza delle altre culture resa possibile dall’enorme espansione dei mezzi di comunicazione; dal relativismo religioso per cui, chi aderisce a una fede oggi non giudica miscredente e tanto meno combatte chi aderisce ad altre fedi, preferendo, alla posizione di Ratzinger, quella relativista del vescovo del Quattrocento Niccolò Cusano, che giudicava le diverse religioni una semplice variazione di riti dell’unica religione (“una religio in varietate rituum”).
Ancora, entrambi conveniamo che forse incominciano a trovare concreta attuazione i principi illuministici della libertà individuale e della tolleranza in ordine alle modalità di convivenza che possono assumere la forma della famiglia nucleare, allargata o di fatto, in ordine all’appartenenza di genere e all’orientamento sessuale, su cui più non pesano le condanne sociali di un tempo con conseguenti pratiche di emarginazione. Ma se è vero che, da che mondo è mondo, l’identità di ciascuno è stata determinata dalle reti delle proprie appartenenze che la definivano e la identificavano, che ne è della nostra identità oggi che tutte le appartenenze si indeboliscono, si smarginano, si contaminano, diventano ciascuna permeabile all’altra?
Io vedo nell’abbattimento dei confini, entro cui la storia finora ha “confinato” popoli e individui, una grande occasione in ordine non solo a una maggior attuazione del concetto di “tolleranza”, su cui anche Eugenio Scalfari, conoscendo la matrice illuminista del suo pensiero, credo convenga, ma anche la possibilità offerta a tutti di costruire una propria identità senza la comoda protezione dell’appartenenza, e quindi un esser-se-stessi senza che nessun dispositivo territoriale, culturale, religioso, possa davvero codificarci.
Su questo punto Scalfari muove due obiezioni che vanno al cuore del problema. La prima è che “costruire un’identità deprivata delle sue appartenenze equivale a costruire sulla sabbia”, perché le appartenenze non sono solo comodi rifugi per chi non è in grado altrimenti di darsi un’identità, ma sono quelle basi culturali che, trasmesse da generazioni a generazioni, consentono a ciascuno individuo di non partire ogni volta da zero, e soprattutto di non “appiattirsi sul presente” che, senza passato e senza futuro, o come dice Scalfari “senza storia” finisce col non sapere come orientarsi, e soprattutto col non avere alcun punto di riferimento che non siano le occasioni del presente.
Vero. Ho sempre in mente un mio bravissimo studente, che dopo essersi laureato in Filosofia con un’ottima tesi, mi chiese se poteva concorrere per un dottorato. Alla mia osservazione che un dottorato in Filosofia non gli avrebbe dato, rispetto alla laurea, maggiori occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro, mi rispose: “Lo so, ma almeno per tre anni faccio quello che mi piace e quindi sto bene”. Appiattimento sull’assoluto presente, perché la formula del passato, che premiava con una carriera accademica i migliori, oggi non trova più attuazione, e il futuro non appare più come una promessa, ma come un’incognita, quando non come una minaccia.
La storia, fatta di presente, passato e futuro, sembra abbia perso la sua capacità di costruire identità, sostituita in questo dalla tecnica, che ha risolto l’identità di ciascuno nella sua “funzionalità” all’interno degli apparati di appartenenza che si incaricano di distribuire identità. Del resto che significato ha quel gran circolare di biglietti da visita, dove l’identità di ciascuno è data dalla sua collocazione all’interno dell’apparato di appartenenza, e dove il proprio nome e cognome acquista rilievo solo a partire dalla funzione che all’interno dell’apparato ciascuno svolge?
Nell’assegnare identità e appartenenza la tecnica ha sostituito la storia. E questo non è un inconveniente da poco perché, mentre la storia è percorsa dall’idea di “progresso” che porta in sé quel tratto “qualitativo” tendenzialmente indirizzato al miglioramento delle condizioni umane, la tecnica segue solo linee di “sviluppo” che segnano un incremento “quantitativo” molto spesso afinalizzato. Non ci sarebbe infatti tanta inquietudine, tanto stress, tanto consumo di psicofarmaci, tante domande circa il senso della propria esistenza, se un fine, uno scopo, un’idea, un ideale, un valore facesse la sua comparsa nell’età della tecnica. Nasce da qui quel risveglio religioso che fa contenti gli uomini di fede, i quali promettono un senso al di là della terra. Ma è su questa terra che, sia io sia Scalfari, vorremmo trovare tracce di sensatezza, magari potenziando la cultura e quindi la scuola, dove la cultura si trasmette, affinché l’uomo non si rassegni a diventare un semplice ingranaggio nel meccanismo della tecnica, per giunta con qualche inconveniente e qualche inadeguatezza rispetto alle macchine che quotidianamente utilizza (Günther Anders, L’uomo è antiquato).
E qui si affaccia la mia seconda proposta che invita ciascuno di noi, nel desertificarsi di tutte le appartenenze, a riprendere l’antico messaggio dell’oracolo di Delfi: “Conosci te stesso”. A questo proposito Eugenio Scalfari interviene obiettando che, dopo aver seguito per molto tempo questo invito, è giunto alla conclusione (che potrebbe far impallidire tutti gli psicoanalisti) che questa conoscenza di sé è di fatto impossibile perché, scrive opportunamente Scalfari dall’alto della sua biografia: “Si può, sia pure con qualche fatica, oggettivare l’io, la nostra mente a capacità riflessive e può pensare il proprio pensiero e le forme della propria soggettività. Ma il “sé”, cioè l’essenza, la cosa in sé del mio essere, non è pensabile. La mia incostanza impulsiva, le mie crisi neuronali, i miei sentimenti nascenti nel fondo dell’inconscio, non sono pensabili se non nel momento in cui emergono ed entrano nella sfera della coscienza”.
Se la psicoanalisi facesse tesoro di queste considerazioni avrebbe una buona occasione per riattivare il proprio pensiero, oggi un po’ pigro e stantio, abbandonare la propria pretesa, talvolta eccessiva, di trasformare o cambiare la condizione di quanti a lei si rivolgono, e indirizzare la conoscenza di sé là dove Nietzsche la indica: “Diventa ciò che sei”. Prendi coscienza, nei limiti che ti è consentito, delle tue potenzialità e delle tue non idoneità, sviluppa le prime e rinuncia alle seconde, evitando di sognare di poter diventare ciò che non sei, perché attratto dai modelli che questa società ti propone e che non ti corrispondono. “Diventa ciò che sei” potrebbe essere allora il modo di costruire un’identità nel deserto delle apparenze dovuto al defilarsi della storia, e nella coercizione in quell’appartenenza a cui la tecnica ci costringe, senza che noi ci si possa davvero identificare.
Riconosco che le mie, più che proposte, sono possibili vie d’uscita dal dominio incontrastato che la tecnica e l’economia, e non più la storia, sembrano esercitare nella nostra epoca. E perciò ringrazio Eugenio Scalfari per aver prestato attenzione a questo tema, che a me pare alla base delle ansie e anche dei dissesti esistenziali dell’uomo d’oggi. E di essere intervenuto con osservazioni perfettamente mirate che hanno consentito di approfondire il problema venendo così incontro all’inquietudine del nostro tempo in cui, per dirla con Hölderlin: “Più non son gli dèi fuggiti, e ancor non sono i venienti”.
-
> IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO ...5 maggio 2007, di Federico La Sala
IN LUNGHE CATENE DIFFICILI DA SPEZZARE
di AUGUSTO CAVADI *
Per diventare misogino, essere cattolico non e’ necessario. Ma aiuta. Non e’ necessario: infatti i rudimenti della concezione della donna come maschio quasi perfetto me li ha impartiti un padre miscredente, laico, socialista (pre-craxiano: nenniano). Ma aiuta: infatti, quando - con stupore e disappunto da parte dei miei genitori - sono entrato nell’associazionismo cattolico, ho ben presto misurato la distanza fra la rivoluzionarieta’ di certe asserzioni ed il conservatorismo della pratica quotidiana. Da una parte il papa scriveva che l’essere umano puo’ considerarsi "imago Dei" solo in quanto coppia; dall’altra, si dava (e si da’) per scontato che una persona di sesso femminile non possa presiedere una comunita’ celebrante. Il mio esodo - progressivo, ma inarrestabile - dalla cultura cattolica passo’ per un episodio preciso. Un prete piu’ anziano di me - peraltro tra i piu’ preparati della sua generazione - volendo esprimere con forza il suo dissenso da una mia opinione, trovo’ spontaneo apostrofarmi con un inequivoco: "Ma hai proprio un cervello da femmina!". Obiettai solo, con un sorriso amaro, che speravo di averne meta’ femminile e meta’ maschile: in modo che, junghianamente, sarei potuto essere "completo".
So che certe distinzioni risultano fastidiose o, per lo meno, farraginose. Ma non sempre si possono evitare. Per esempio, quella suggerita da un’acuta fucilata di Nietzsche (recentemente definito da Rene’ Girard il piu’ grande teologo dopo san Paolo): c’e’ stato un solo cristiano ed e’ morto sulla croce. Che, tradotto in altri termini, significa: una cosa e’ stata la "buona notizia" annunziata dal maestro nomade di Galilea ed un’altra la dottrina cattolica (e, piu’ in generale, cristiana) che si e’ sviluppata a partire da quel seme. La psicanalista e teologa protestante Hanna Wolff lo ha spiegato in uno dei quattro o cinque libri che mi hanno cambiato la vita (Gesu’, la maschilita’ esemplare, Queriniana, Brescia 1985): il Nazareno (per quanto possiamo cogliere da un’esegesi accurata dei quattro vangeli) ha saputo accettare il femminile dentro di se’ e, proprio per questo, non aver paura del femminile fuori di se’. Egli ha dunque rotto con la tradizione patriarcale precedente, ma la sua rottura e’ stata tanto eclatante che i discepoli non sono riusciti a reggerla: e, subito dopo la sua morte, hanno attivato processi di normalizzazione. Col risultato che, dopo la breve parentesi gesuana, l’antifemminismo ha ripreso vigore, si e’ fatto senso comune e ha improntato di se’ l’occidente cristiano.
Se ci chiediamo se questa mentalita’ della disparita’ ontologica e psicologica fra maschi e femmine (dura a destrutturarsi persino oggi, dopo decenni di femminismo teorico e militante) spieghi, da sola, l’impressionante catena di violenza contro le donne, non possiamo che rispondere negativamente. Che cosa, allora, trasforma una cultura maschilista in pratiche prevaricatrici? Ho l’impressione che entri in gioco non questo o quell’altro fattore, bensi’ un groviglio - difficilmente solubile - di fattori. Tra cui primeggia una connotazione peculiare dell’immagine femminile agli occhi di noi uomini: la diversita’. Sin da bambino, il pianeta-donna ha esercitato nei miei confronti una duplice, contraddittoria, forza: di attrazione e di paura, di curiosita’ e di diffidenza, di desiderio e di minaccia. Per ragioni varie, che solo in minima parte potrei attribuire a meriti miei, maturare come persona ha significato - tra l’altro - sciogliere questa ambiguita’ e lasciar prevalere, di fronte ad ogni diversita’ (le donne, ma anche gli omosessuali, gli immigrati di colore, i portatori di handicap fisici e psichici...), il sapore della familiarita’ rispetto al sentimento di estraneita’. Ovviamente, familiarita’ non equivale ad omologazione. Avvertire cio’ che, in radice, accomuna non implica cecita’ riguardo alle differenze che interpellano le nostre certezze.
Qui, forse, uno dei bivi decisivi. C’e’ chi accetta la sfida della diversita’ (e, nel caso di maschi, del femminile come metafora di ogni diversita’) per mettersi in gioco, per riaffermare alcune convinzioni ma anche liberarsi da pregiudizi e da errati giudizi; e c’e’ chi non la regge e, per quanto sta in lui, tenta di sopprimerla. Non e’ un caso che, di solito, le idiosincrasie s’inanellino in lunghe catene difficili da spezzare: misoginia, omofobia, razzismo... E’ di per se’ evidente che questa mentalita’ sia - gia’ a livello ideologico - violenta. Ma, poiche’ in genere il diverso e’ piu’ debole (fisicamente, economicamente, militarmente...), il pensiero omologante ha mille occasioni per farsi gesto prepotente: stupro, derisione, schiavizzazione... Quando un soggetto allergico alla diversita’ si impossessa - sessualmente o socialmente - dell’altro, ha la sensazione di aver risolto molti problemi in un solo colpo: da una parte ha soddisfatto attrazione, curiosita’, desiderio; dall’altra ha cancellato dal proprio orizzonte ogni fonte di paura, di diffidenza, di minaccia. Ma, proprio nella misura in cui riesce a fagocitare e a spazzar via ogni alterita’, egli desertifica il piccolo mondo che lo circonda e costruisce da se’ la prigione dell’isolamento. Ecco un punto nevralgico: chi progetta ed esercita violenza, nonostante le intenzioni, si condanna alla solitudine. Come i signorotti medievali, deve scavare fossati sempre piu’ profondi per distanziarsi dagli estranei: ma, con cio’, trasforma in gabbie dorate il suo stesso castello. Sara’ proprio perche’ amo la solitudine come opzione, ma la detesterei se la sperimentassi in tempi e modi non programmati, che mi viene abbastanza facile sottrarmi alla tentazione di usare violenza. Cio’ non significa, purtroppo, che di fatto non sia stato troppe volte violento - nel corso della vita - con persone diverse da me per indole, formazione e prospettive (quali, per esempio, delle donne con cui ho condiviso tratti di strada importanti): ma ogni volta che non ho saputo gestire il conflitto, provocando nell’altro/a la decisione di fuggire, l’ho considerata - nonostante le apparenze - una mia sconfitta.
* Fonte: NOTIZIE MINIME DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO Numero 80 del 5 maggio 2007 - articolo apparso su "Mezzocielo", anno XV, n. 1, 2007, dal titolo originale "Un uomo davanti al pianeta donna"
-