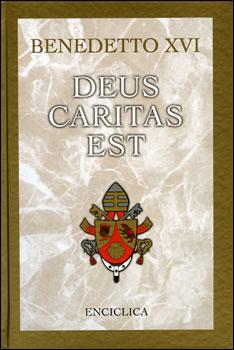
LA TEOLOGIA DI "MAMMONA" ("caritas"), LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO ("Charitas").
giovedì 23 maggio 2019.(Per leggere il saggio in pdf, cliccare sul rosso)
Sul tema, nel sito, si cfr. anche
- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
PIRANDELLO E LA BUONA-NOVELLA.
I DUE CORPI DEL RE, DEL PAPA, E DI OGNI ESSERE UMANO. La lezione di Dante, Marx, Freud, Kantorowicz, e Mandela ...
 GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Doc.:
- CONSTITUTIO DOGMATICA DE ECCLESIA
 LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964):
LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964):
A) Testo latino
- 42. "Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo" (1 Io 4,16). Deus autem caritatem suam in cordibus nostris diffudit per Spiritum Sanctum qui datus est nobis (cf. Rom 5,5); ideoque donum primum et maxime necessarium est caritas, qua Deum super omnia et proximum propter Illum diligimus. Ut vero caritas tamquam bonum semen in anima increscat et fructificet, unusquisque fidelis debet verbum Dei libenter audire Eiusque voluntatem, opitulante Eius gratia, opere complere, sacramentis, praesertim Eucharistiae, et sacris actionibus frequenter participare, seseque orationi, sui ipsius abnegationi, fraterno actuoso servitio et omnium virtutum exercitationi constanter applicare. Caritas enim, ut vinculum perfectionis et plenitudo legis (cf. Col 3,14; Rom 13,10), omnia sanctificationis media regit, informat ad finemque perducit(132). Unde caritate tum in Deum tum in proximum signatur verus Christi discipulus.
B) Testo italiano
COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA
 LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964):
LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964):
42. « Dio è amore e chi rimane nell’amore, rimane in Dio e Dio in lui » (1 Gv 4,16). Dio ha diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci fu dato (cfr. Rm 5,5); perciò il dono primo e più necessario è la carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di lui. Ma perché la carità, come buon seme, cresca e nidifichi, ogni fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e con l’aiuto della sua grazia compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto all’eucaristia, e alle azioni liturgiche; applicarsi costantemente alla preghiera, all’abnegazione di se stesso, all’attivo servizio dei fratelli e all’esercizio di tutte le virtù. La carità infatti, quale vincolo della perfezione e compimento della legge (cfr. Col 3,14; Rm 13,10), regola tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine [132]. Perciò il vero discepolo di Cristo è contrassegnato dalla carità verso Dio e verso il prossimo.
* PAOLO VESCOVO
 SERVO DEI SERVI DI DIO
SERVO DEI SERVI DI DIO
 UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
 A PERPETUA MEMORIA
A PERPETUA MEMORIA
LA "LUCE DELLA FEDE" CATTOLICO-ROMANA, I MIGRANTI, E LA CHIESA COME "SACRA FAMIGLIA". Una "sintesi" .. *
- Super omnia charitas
 Storia dell’Istituto Sacra Famiglia dal 1896 a oggi
Storia dell’Istituto Sacra Famiglia dal 1896 a oggi
 Enrico Palumbo
Enrico Palumbo
 Prefazione del card. Angelo Scola, Ancora, Milano 2016, pp. 386, € 14
Prefazione del card. Angelo Scola, Ancora, Milano 2016, pp. 386, € 14
Nella "Prefazione", il card. Angelo Scola così scrive: -"Nella storia della Chiesa ambrosiana e dell’assistenza l’Istituto Sacra Famiglia possiede un valore centrale [...] La «charitas» paolina del motto dell’istituto e del titolo di questo libro non è, a Cesano Boscone, un titolo ad effetto, ma pratica concreta e quotidiana, che vede nel volto degli ospiti il volto di Cristo. La Sacra Famiglia, infatti, è un luogo di instancabile testimonianza ed educazione a quella gratuità che anzitutto ci precede: «Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi» (1 Gv 4, 10). In questo luogo si saldano la cura dell’anima e la cura del corpo, la fedeltà a una tradizione assistenziale e la continua ricerca del progresso e dell’innovazione.E’ in fondo questa l’immagine dell’articolata e viva eredità che il Concilio Vaticano II ha lasciato a una Chiesa che, attingendo al deposito della sua storia, cerca di rinnovarsi per proporre il messaggio evangelico al mondo contemporaneo. Così la Sacra Famiglia adegua continuamente alla realtà in cui il Padre ci chiama a vivere i "poveri" a cui mons. Pogliani ha voluto consacrare la sua vita e il suo ospizio: ieri gli inabili al lavoro e i figli della guerra, oggi le persone affette da patologie gravi, ma anche gli anziani, che nella società dell’efficienza e della velocità sono tagicamente emarginati, e i migranti, il «dono» - come li ha definiti papa Francesco - che Dio ha fatto alle società ticche, perché riscoprano, nella strutturale condizione di indigenza di ogni persona,il tratto più prezioso della loro comune umanità. Milano 25 aprile 2016 + Angelo Scola Arcivescovo di Milano".
*
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
Forum
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA" ("caritas"), LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO ("Charitas"). -- Campidoglio in retromarcia: restano alla Caritas le monete della Fontana di Trevi.14 gennaio 2019, di Federico La Sala
Roma.
Campidoglio in retromarcia: restano alla Caritas le monete della Fontana di Trevi
Virginia Raggi all’Osservatore Romano: devolveremo anche i 200 mila euro raccolti in altre fontane, è stato un atto della Giunta male interpretato
di Luca Liverani (Avvenire, lunedì 14 gennaio 2019)
- [Foto] Un operaio dell’Acea recupera le monete lanciate dai turisti nella Fontana di Trevi
Contrordine dal Campidoglio. «La Caritas e tutte le migliaia di persone assistite dai suoi operatori possono stare tranquille. Garantisco io, in prima persona - dice la sindaca di Roma Virginia Raggi all’Osservatore Romano - che non verrà mai meno il contributo di questa amministrazione. Per quanto riguarda le monetine, confermo che resteranno a disposizione delle attività caritatevoli dell’ente diocesano. Nessuno ha mai pensato di privare la Caritas di questi fondi».
Dopo giorni di polemiche e una tempesta di reazioni sui social, il Campidoglio dunque innesta la retromarcia. Le monete lanciate dai turisti nella Fontana di Trevi continueranno a essere girate alla Caritas di Roma che le investe per i servizi ai più poveri. Il taglio preannunciato a fine anno avrebbe provocato una perdita secca di un milione e mezzo di euro nel bilancio dell’organismo ecclesiale, pari al 15%, la metà dei soldi che la Caritas spende senza nessuna convenzione con enti pubblici.
Il denaro raccolto nella Fontana di Trevi a Roma resterà dunque alla Caritas diocesana. Anzi, anche le monete raccolte nelle altre fontane della Capitale saranno destinate all’organismo caritativo diocesano, per un totale approssimativo di 200 mila euro aggiuntivi. L’Osservatore Romano sulla questione ha intervistato la sindaca di Roma Virginia Raggi: «L’ente diocesano svolge un compito importante per tanti bisognosi e per la città di Roma - dichiara - che vuole continuare a essere la Capitale dell’accoglienza dei più deboli». Tecnicamente, la questione circa la destinazione delle monetine raccolte nella storica fontana della Capitale sarà risolta in questo modo: spetterà all’Acea il compito della raccolta e della quantificazione delle monete, finora svolto gratuitamente dai volontari della Caritas. Sottratto il compenso per questa attività - si calcola circa 2mila euro - in virtù di un apposito protocollo i fondi saranno trasmessi alla Caritas diocesana.
La sindaca questa mattina - riferisce ancora l’Osservatore Romano - ha contattato la presidente di Acea, Michaela Castelli, la quale ha assicurato il suo appoggio a tale soluzione. Si supererà così l’obbligo imposto dalla Ragioneria generale di far transitare l’importo delle monete nel bilancio comunale, che aveva condotto, secondo quanto spiegano dal Campidoglio, alla sospensione della convenzione con la Caritas. «Lo scorso dicembre - afferma Raggi - abbiamo approvato una memoria di Giunta che è stata mal interpretata. Si tratta di un atto amministrativo dovuto alla necessità di raccogliere e quantificare le monetine che i turisti lanciano, non solo nella fontana di Trevi ma anche in altre fontane monumentali di Roma. Un atto amministrativo che ha il fine di portare ordine e trasparenza. Ora, invece, i turisti e cittadini finalmente sapranno quanto viene raccolto e a chi viene destinato. E lo saprà anche la Caritas che potrà programmare più facilmente le proprie attività di beneficenza. Addirittura avrà più fondi».
La sindaca, nell’intervista al giornale vaticano, tiene a ribadire che l’amministrazione intende continuare la collaborazione con tutti gli enti ecclesiali: «Credo che le parrocchie rappresentino un baluardo importante per la tenuta del territorio. Spesso le parrocchie e i centri di volontariato rappresentano le frontiere all’interno della città, il luogo in cui ci si confronta e si cresce insieme. È evidente - aggiunge - che il terzo settore vada tutelato e incoraggiato».
A formalizzare la cessione delle monete lanciate dai turisti nella Fontana di Trevi alle iniziative di solidarietà della Caritas era stato, il Campidoglio nel 2001. Da allora tutte le giunte successive, di qualsiasi colore politico, da Walter Veltroni a Gianni Alemanno a Ignazio Marino avevano conservato questa consuetudine. Con l’arrivo della giunta Raggi l’iniziativa era stata messa in discussione, con l’istituzione di un gruppo di lavoro nell’ottobre 2017. E il processo sembrava arrivato a conclusione: una Determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2018 aveva affermato che dal 1° aprile la Caritas non sarebbe più stata la destinataria delle monete regalate dai turisti nel tradizionale lancio in fontana - dice la tradizione - per propiziare il ritorno a Roma. In concreto, per la Caritas diocesana sarebbe stato un taglio secco di un milione e mezzo di euro. Una decisione che avrebbe costretto la Caritas a ridurre o chiudere molti servizi per i più poveri. Con prevedibili ripercussioni sul clima sociale della città.
Secondo la sindaca Raggi dunque «nessuno ha mai pensato di privare la Caritas di questi fondi». Un’affermazione che sembra parzialmente contraddetta da quanto si legge nella Determinazione dirigenziale del 31 dicembre scorso. A pagina 4 del documento di otto pagine, si leggeva che «il ricavato della raccolta dovrà essere destinato, al netto di quanto necessario alla copertura delle spese dell’addendum contrattuale con la società ACEA s.p.a., in misura prevalente al finanziamento di progetti sociali e per la restante parte alla manutenzione ordinaria del patrimonio culturale».
Oggi dunque la decisa correzione di rotta. Una svolta su cui contava il direttore della Caritas diocesana, don Benoni Ambarus che nei giorni scorsi, nonostante la decisione del Campidoglio, continuava a dirsi «fiducioso» in un ripensamento: «Mi appello - aveva detto - agli amministratori di buona volontà: non mettano fine all’azione sussidiaria e di welfare generativo che moltiplica l’effetto dei fondi disponibili, crea dignità e giustizia sociale. Non parlo per me, ma a nome di tante persone fragili, italiane e non, che a Roma vivono con difficoltà». Una fiducia stavolta ben riposta.
L’Osservatore Romano non risparmia però una critica alla Giunta Raggi. «Dovrebbe dunque chiudersi così una vicenda la cui gestione non è stata certo felice», scrive il quotidiano vaticano: «Sarebbe sicuramente bastata una comunicazione più chiara con la stessa Caritas per fermare sul nascere qualsiasi malinteso».
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA" ("caritas"), LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO ("Charitas"). --- Fontana di Trevi, il Campidoglio toglie le monetine alla "Caritas".13 gennaio 2019, di Federico La Sala
Fontana di Trevi, il Campidoglio toglie le monetine alla Caritas. "Serviranno a manutenzione vasca"
Diventa operativa da aprile, una decisione assunta dal Comune già lo scorso anno e congelata per le proteste. In ballo un milione e mezzo di euro all’anno
di ROSALIA PALERMI (la Repubblica, 12 gennaio 2019)
I rapporti sono tesi, non è un mistero. Più volte la Curia romana ha punzecchiato l’amministrazione, da ultimo lo ha fatto il Vescovo di Roma Sud, Paolo Lojudice, chiamando alle proprie responsabilità la giunta capitolina in materia di decoro. Sullo sfondo una partita che oltreTevere ha creato parecchi malumori e non solo a livello di vertice.
Riguarda le monetine che i turisti lanciano a Fontana di Trevi. Raccolte da Acea, l’azienda che si occupa della manutenzione della Fontana, finivano nelle mani dei volontari Caritas che le destinavano a scopi sociali. Finivano perché tra qualche mese non sarà più così.
Lo prevede una decisione assunta già l’anno scorso dall’amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi e congelata tra le proteste per altri 12 mesi. Arrivati alla fine dell’anno, i burocrati del Campidoglio hanno notificato alla Caritas che il versamento cesserà dal primo di aprile. In sostanza scadrà la proroga della proroga e oltre non si andrà. Raggi conferma la volontà di incassare le monetine e redistribuirle per finanziare opere di manutenzione, sobbarcandosi anche il costo del conteggio finora svolto gratis dai volontari Caritas.
La partita non è di poco conto: ballano un milione e mezzo di euro, stando al bilancio 2018. Una goccia nel mare del disastrato bilancio capitolino che tuttavia saluta il gettito delle monetine come una provvidenziale boccata d’ossigeno. Una mannaia per la Caritas che stima gli venga a cadere il 15 per cento del proprio bilancio, fatto poi di soldi dell’8 per mille e di decisivi finanziamenti pubblici e solo in minima parte privati. Soldi che finiscono nel circuito dell’assistenza: dall’accoglienza dei senzatetto ai pasti e a iniziative benefiche che sopperiscono ai vuoti del welfare.
Insomma, dove non c’è la mano pubblica a garantire un tetto ai clochard e pasti caldi a chi vive per strada c’è la rete della Caritas. E lo si è visto nel pieno dell’emergenza freddo nella capitale con il circuito del volontariato a fronteggiare una situazione che la rete pubblica dell’assessorato al sociale non è stata in grado di affrontare, tra inadeguatezza, pasticci burocratici e una attività organizzativa partita decisamente in ritardo.
Per questa ragione il malumore crescente nei confronti delle scelte dell’amministrazione è esploso anche su Avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale, che senza mezzi termini ha riportato in prima pagina quella che era una felpata polemica affidata al fioretto della diplomazia con un eloquente “Le monetine tolte ai poveri”.
-
> LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO ("Charitas"). ---IL REGNO. Il mio regno non è di qui (di Piero Stefani).28 novembre 2018, di Federico La Sala
Il mio regno non è di qui
di Piero Stefani ("Il Regno", 22/11/2018)
- Solennità di Cristo re dell’universo
- Dn 7,13-14; Sal 93 (92); Ap 1,5-8; Gv 18,33-37
«Universo» è parola sconosciuta alla Bibbia. Per dire «il tutto», il primo versetto della Scrittura impiega l’espressione «il cielo e la terra» (Gen 1,1; cf. Ef 1,10). Il posto privilegiato che questo modo di dire riserva a ciò che noi definiamo «nostro pianeta» indica una distanza incolmabile tra l’immagine biblica del cosmo e quella attuale. Non ha senso logico definire un campo come fosse costituito da 100 ettari di terreno e da un granello di polvere. I tentativi di intrecciare teologicamente tra loro la visione cosmica biblica con quella odierna non portano da nessuna parte.
Meglio domandarsi allora perché il Nuovo Testamento, e in particolare Giovanni, precludono l’eventualità di qualificare la solennità odierna ricorrendo all’espressione «re del mondo».
«Il mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36), risponde Gesù a Pilato. Subito dopo Gesù aggiunge: «Il mio regno non è di qui (enteuthen)» (Gv 18,36). Le due espressioni kosmos («mondo») ed enteuthen («qui») gravitano dalla stessa parte.
Kosmos è una parola frequente nel quarto Vangelo. Essa è contraddistinta da una forte ambiguità. Il mondo rappresenta la scena sulla quale si svolge il dramma della redenzione: «Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17; cf. Gv 10,36; 11,27). Il mondo è amato da Dio (cf. Gv 1,29; 4,42) eppure odia Gesù, «perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive» (Gv 7,7; cf. Gv 15,18-19; 17,14).
Il Vangelo di Giovanni è caratterizzato da un lessico fortemente duale (luce-tenebre; vita-morte; amore-odio; verità-menzogna...); tuttavia alcuni termini, come appunto «mondo», più che colti in contrapposizione al loro opposto, vanno intesi in relazione a una tensione che sussiste tra vari significati attribuiti alla stessa parola: il mondo è amato e salvato, eppure odia Gesù. «Il mio regno non è di questo mondo» ma io sono venuto a salvare il mondo.
La contraddizione sembra insuperabile. Per cercare di scioglierla è di qualche aiuto seguire l’altro, e assai meno importante, termine: «qui». In effetti esso ricorre poche volte in Giovanni e nella maggior parte dei casi ha un semplice valore spaziale, secondo il senso comune del termine (cf. Gv 2,16; 7,3; 14,31).
Nella risposta a Pilato le cose stanno diversamente. Non ha significato alcuno affermare che «il mio regno non è di qui» perché è «altrove», come se si estendesse su un altro territorio. Tuttavia, guardando all’ultima occasione nella quale Giovanni fa ricorso al termine, si apre all’improvviso uno squarcio. Ciò avviene se nella traduzione, a differenza del solito, si ricorre all’avverbio «qui»: «Lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra (enteuthen kai enteuthen, una specie di «uno di qui e uno di qua»), e Gesù in mezzo» (Gv 19,18).
È solo un cenno, non più di una spia; tuttavia appare calzante pensare a un richiamo tra le due scene; come se si volesse far dire a Gesù: il mio regno non è «qui», ma è sulla croce. Non ci si muove nella logica dei poteri mondani, il tal caso qualcuno avrebbe combattuto (cf. Gv 18,36); il regno si trova invece nella forza attrattiva e salvifica della croce: «“E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire» (Gv 12,32-33).
Gesù afferma che il suo regno non è di qui, egli però rivendica pienamente la propria condizione regale: «Tu lo dici, io sono re» (Gv 18,37). Si tratta di una regalità diversa da quella mondana. «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei» sarebbe stata la frase scritta sulla croce in ebraico, latino e greco, e che Pilato non volle mutare. «Quel che ho scritto ho scritto» (Gv 19,22) è una specie di definitivo sigillo posto al «Tu lo dici» (Gv 18,37) rivolto da Gesù a Pilato. È sulla croce che si dispiega la regalità «altra» e salvifica di Gesù.
*Sul tema, nel sito, si cfr.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA" ("caritas"), LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO ("Charitas"). -- FILOLOGIA E LIBERTA’ (L. Canfora"). Note30 giugno 2018, di Federico La Sala
Filologia e “verità”
di Daniele Ruini (Nazione Indiana, 01 marzo 2009)
Quale importanza abbia avuto, nella storia dell’umanità, la parola scritta è un fatto difficilmente sottostimabile. Per quanto riguarda, più in particolare, la storia delle religioni, ciò è chiaramente evidente in tutti quei culti che riconoscono autorità sacra a uno o più testi, ritenuti frutto della diretta ispirazione divina, ovvero “parola di Dio”. Dato lo speciale statuto assegnato a tali scritture, ogni operazione volta a definirne con esattezza il dettato testuale acquista un valore particolare; se, da un lato, avvicinarsi il più possibile allo stadio originario di un Testo Sacro significa ridurre la distanza che separa dalla supposta Verità in esso contenuta, dall’altro lato, rimettere ogni volta in discussione la lezione di un’opera di tal fatta non può non avere conseguenze delicate per la comunità religiosa che di essa ha fatto il proprio testo di riferimento. Il rapporto tra Sacre Scritture e filologia (la disciplina finalizzata a ricostruire la veste originaria di un testo attraverso lo studio delle varie fasi della sua trasmissione) è infatti necessariamente contraddittorio: il carattere dogmatico della “parola di Dio” può sopportare il libero esercizio critico della filologia? E soprattutto: fino a che punto saranno disposti ad accettarlo i rappresentanti delle gerarchie ecclesiastiche?
È questo il tema al centro di Filologia e Libertà di Luciano Canfora (Mondadori 2008), nel quale si ripercorre la storia delle resistenze del Vaticano dinnanzi all’applicazione della critica testuale alla Bibbia, dando risalto alle figure dei pochi studiosi che quei divieti tentarono di infrangere. Come sottolinea Canfora, riannodare le fila di questo racconto equivale a narrare la storia «della libertà di pensiero attraverso il faticoso e contrastato dispiegarsi della libertà di critica sui testi che l’autorità e la tradizione hanno preservato».
Benché sia sempre esistita una filologia biblica, le cui origini affondano nel giudaismo ellenistico, la Chiesa Cattolica è venuta progressivamente irrigidendosi, assumendo, di fronte alle possibilità di studiare le Sacre Scritture secondo i principi della critica testuale, un atteggiamento di totale chiusura, cui si accompagnò un’azione di repressione nei confronti dei disobbedienti. Tale fu la posizione espressa nelle disposizioni del Concilio di Trento (1545-1563), colle quali fu sancito il primato della Vulgata, ovvero della versione latina della Bibbia tradotta da San Gerolamo nel IV secolo d.C.
In maniera del tutto illogica e fondandosi sulla supposta ispirazione divina del traduttore, veniva riconosciuta la superiorità di una traduzione rispetto al testo originale (ebraico per l’Antico Testamento, greco per il Nuovo). Si trattava di una risposta alle iniziative dei luterani, che rivendicavano invece l’originale biblico e che quello traducevano per la massa dei fedeli. Tali norme rimasero valide fino al Concilio Vaticano II (1965), quando fu finalmente ammessa, anche da parte cattolica, la possibilità di tradurre le Sacre Scritture nelle lingue moderne, favorendone l’accesso al popolo dei credenti.
E nondimeno, la filologia moderna, sviluppatasi storicamente nel XIX secolo sui classici greci e latini, ebbe le sue prime applicazioni proprio in ambito biblico e, più in particolare, neotestamentario. Alla netta chiusura della Chiesa Cattolica - ma atteggiamento non dissimile ebbero le Chiese riformate - si contrappose l’attività di singoli eruditi che, raccogliendo l’eredità di Erasmo da Rotterdam (1466-1536), si prodigarono nello studio della formazione dell’Antico e del Nuovo Testamento, subendo spesso l’ostracismo delle comunità religiose di appartenenza.
 Tra le figure ricordate da Canfora vi sono l’ebreo Baruch Spinoza (1632-1677), il giansenista Richard Simon (1627-1704), i protestanti Pierre Bayle (1647-1706), Johann Jacob Wetstein (1694-1745) e Jean Leclerc (1657-1736). Il loro lavoro fu la principale fonte d’ispirazione della critica illuministica delle religioni, della cui efficacia ed attualità rende conto il fatto che «la condanna dell’illuminismo si replica, di papa in papa, di enciclica in enciclica, fino alla recentissima Spe salvi (par. 19) dell’attuale pontefice».
Tra le figure ricordate da Canfora vi sono l’ebreo Baruch Spinoza (1632-1677), il giansenista Richard Simon (1627-1704), i protestanti Pierre Bayle (1647-1706), Johann Jacob Wetstein (1694-1745) e Jean Leclerc (1657-1736). Il loro lavoro fu la principale fonte d’ispirazione della critica illuministica delle religioni, della cui efficacia ed attualità rende conto il fatto che «la condanna dell’illuminismo si replica, di papa in papa, di enciclica in enciclica, fino alla recentissima Spe salvi (par. 19) dell’attuale pontefice».Le infrazioni ai divieti cattolici in materia di filologia biblica proseguirono nel XIX secolo per merito di alcuni esponenti dell’Institut Catholique di Parigi, ai quali il Vaticano affibbiò l’etichetta di “modernisti”. Tra di essi, Ernest Renan (1823-1892) - autore di una celebre Vita di Gesù in cui si negava la divinità del Cristo -, Louis Duchesne (1843-1922) e Alfred Loisy (1857-1940), cui si devono due volumi sulla Storia del canone dell’Antico e del Nuovo Testamento.
 La durissima presa di posizione del cattolicesimo romano fu affidata alle encicliche Providentissum Deus di papa Leone XIII (1893) e Pascendi dominici gregis di papa Pio X (1907). In quest’ultima, in particolare, il pontefice espresse in termini retrogradi l’allarme risentito verso la critica testuale, il cui carattere eversivo risalirebbe alla pretesa di introdurre nell’ambito dei Testi Sacri il concetto di “evoluzione”, «quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato» (sic).
La durissima presa di posizione del cattolicesimo romano fu affidata alle encicliche Providentissum Deus di papa Leone XIII (1893) e Pascendi dominici gregis di papa Pio X (1907). In quest’ultima, in particolare, il pontefice espresse in termini retrogradi l’allarme risentito verso la critica testuale, il cui carattere eversivo risalirebbe alla pretesa di introdurre nell’ambito dei Testi Sacri il concetto di “evoluzione”, «quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato» (sic).Nessuna posizione ufficiale venne più espressa fino al 1943, quando papa Pio XII compì una svolta inaspettata, ammettendo la legittimità della critica testuale in ambito biblico (enciclica Divino afflante spiritu). Non si trattava, tuttavia, di una netta presa di distanza dalle chiusure del passato; l’enciclica pretende anzi di stabilire una continuità colle dichiarazioni dei pontefici precedenti, disegnando una prospettiva distorta secondo cui la Chiesa avrebbe sempre favorito e appoggiato la critica testuale, ed affermando che il riconoscimento della legittimità dell’indagine filologica sui testi sacri non è in contraddizione coi deliberati tridentini.
 L’apertura di papa Pacelli era in realtà la conseguenza della presa d’atto che alcune significative esperienze filologiche recenti avevano reso del tutto obsoleta e non più sostenibile la condanna vaticana verso la critica testuale; capolavori come l’edizione critica dell’Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea realizzata da Eduard Schwartz (1905-1909), o quella della Bibbia dei Settanta prodotta nel 1935 in ambiente protestante, costituivano una smentita concreta delle preclusioni cattoliche nei confronti della filologia. D’altra parte, pur nella sua apertura di fondo, Pio XII si appella alla cautela degli studiosi; l’enciclica contiene infatti l’invito a produrre nuove edizioni scientifiche del Testo Sacro pur mantenendo nei suoi confronti «somma riverenza».
L’apertura di papa Pacelli era in realtà la conseguenza della presa d’atto che alcune significative esperienze filologiche recenti avevano reso del tutto obsoleta e non più sostenibile la condanna vaticana verso la critica testuale; capolavori come l’edizione critica dell’Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea realizzata da Eduard Schwartz (1905-1909), o quella della Bibbia dei Settanta prodotta nel 1935 in ambiente protestante, costituivano una smentita concreta delle preclusioni cattoliche nei confronti della filologia. D’altra parte, pur nella sua apertura di fondo, Pio XII si appella alla cautela degli studiosi; l’enciclica contiene infatti l’invito a produrre nuove edizioni scientifiche del Testo Sacro pur mantenendo nei suoi confronti «somma riverenza».
 Si tratta, come evidenzia Canfora, di una posizione assurda e insensata, dacché inconciliabile colla pur invocata «rigorosa osservanza di tutte le leggi della critica». Ciò equivarrebbe infatti ad ammettere che “un testo affidabile di Platone possano darlo soltanto dei platonici puri e graniticamente fedeli al “verbo” del maestro (ammesso comunque che tale verbo esista già preconfezionato, prima del necessario, lunghissimo, imprevedibile, lavorio critico)”.
Si tratta, come evidenzia Canfora, di una posizione assurda e insensata, dacché inconciliabile colla pur invocata «rigorosa osservanza di tutte le leggi della critica». Ciò equivarrebbe infatti ad ammettere che “un testo affidabile di Platone possano darlo soltanto dei platonici puri e graniticamente fedeli al “verbo” del maestro (ammesso comunque che tale verbo esista già preconfezionato, prima del necessario, lunghissimo, imprevedibile, lavorio critico)”.
 Questo non-senso nasce dalla convinzione, mai messa in discussione, che i testi inclusi nel canone cattolico - e solo quelli - contengano la verità, una verità «precostituita e testualmente compiuta prima della ricostruzione del testo». L’apparente apertura rivoluzionaria del Vaticano tradisce, quindi, un certo conservatorismo, nell’incapacità di accettare fino in fondo l’idea che «il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della “fede”».
Questo non-senso nasce dalla convinzione, mai messa in discussione, che i testi inclusi nel canone cattolico - e solo quelli - contengano la verità, una verità «precostituita e testualmente compiuta prima della ricostruzione del testo». L’apparente apertura rivoluzionaria del Vaticano tradisce, quindi, un certo conservatorismo, nell’incapacità di accettare fino in fondo l’idea che «il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della “fede”».Il volume di Canfora costituisce, in conclusione, un elogio della filologia, considerata come un antidoto al dogmatismo e all’oscurantismo e come fondamento della libertà di pensiero.
Canfora, la filologia è libertà
Il volume curato da Rosa Otranto e Massimo Pinto (Edizioni di Storia e Letteratura)
di Livia Capponi (Corriere della Sera, 29.06.2018)
Come lavoravano gli autori greci e latini? Nel suo lungo e intenso magistero, Luciano Canfora, a cui gli allievi Rosa Otranto e Massimo Pinto dedicano il volume collettivo Storie di testi e tradizione classica, ha insegnato ad affrontare ogni testo a partire dalla sua storia, reinventando la filologia come disciplina in grado di leggere non solo i testi giunti fino a noi, ma anche le cicatrici, i tagli, i contorni invisibili di ciò che è stato modellato da un censore, da un copista, dal gusto di un’epoca.
Diversamente da Isocrate, famoso per la sua lentezza nel comporre, e da Pitagora, che preferiva depositare la sua dottrina nei libri più sicuri, cioè nella memoria degli alunni, Canfora, la cui bibliografia conta 843 opere, è più simile a Demostene, che cesellava ogni rigo o a Fozio, patriarca bizantino che salvò il patrimonio letterario antico, aiutato da un’affezionata cerchia di studenti.
Nei contributi qui raccolti, l’erudizione è messa al servizio di una coinvolgente ricerca della verità, intesa come integrità testuale, storica ed etica. Sono toccati i temi prediletti, come l’analisi critica della democrazia, la storia della tolleranza e della libertà di parola, la schiavitù e i perseguitati politici e religiosi da Atene ai giorni nostri, attraverso lo studio di storiografia, archivi, biblioteche e pubblicistica d’ogni epoca. Il tutto condito da empatia e indipendenza di giudizio, in grado di far rivivere gli antichi con grande vivacità: Cesare è ritratto mentre elabora il primo sistema crittografico per l’intelligence romana; Fozio nell’atto di divorare romanzi d’amore greci (per poi censurarli). Coerentemente con la lezione canforiana, lo studio dei classici diventa motivo di apertura mentale perché aiuta a capire il presente e noi stessi.
Per materiali sul tema, nel sito, si cfr.:
LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE E SAN PAOLO PRENDONO LE DISTANZE DALLE ENCICLICHE DI PAPA BENEDETTO XVI. Una "preghiera comune" firmata da Bacone
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO --- Verso una nuova finanza: il cammino ora è segnato (di Stefano Zamagni)..12 giugno 2018, di Federico La Sala
TEOLOGIA, ECONOMIA, E STORIA ..... *
Il documento vaticano.
Verso una nuova finanza: il cammino ora è segnato
Il testo della Congregazione per la Dottrina della Fede «Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» offre spunti per un discernimento etico sul sistema attuale e offre soluzioni per il bene comune
di Stefano Zamagni (Avvenire, martedì 12 giugno 2018)
«Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» (Opq) è un documento - reso di dominio pubblico il 17 maggio 2018 - originale e intrigante.
Originale per il taglio espositivo e soprattutto perché è la prima volta che la Congregazione per la Dottrina della Fede - la cui competenza copre anche le questioni di natura morale - interviene su una materia di Dottrina Sociale della Chiesa. Il lavoro congiunto tra Congregazione e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è già di per sé qualcosa che non può passare inosservato e che lascerà il segno.
Opq è poi un contributo intrigante per il modo e per lo spessore con cui affronta una tematica che, come quella della nuova finanza, è oggi al centro delle preoccupazioni della Chiesa e della società in generale. (Papa Francesco ha approvato il Documento che entra pertanto nel Magistero ordinario). Come recita il sottotitolo («considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario» - corsivo aggiunto), non ci troviamo di fronte ad una sorta di esortazione apostolica o ad un testo di taglio pastorale. Piuttosto, vi si legge un’analisi, scientificamente fondata, delle cause remote dei disordini e dei guasti che l’architettura dell’attuale sistema finanziario va determinando.
Si legge al n. 5: «La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria, neutralizzandone gli aspetti predatori e speculativi (sic!) e valorizzandone il servizio all’economia reale. Sebbene siano stati intrapresi molti sforzi positivi... non c’è stata però una reazione che abbia portato a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo».
 A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.
A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.Il punto centrale dell’argomento sviluppato nel Documento è l’affermazione del principio secondo cui etica e finanza non possano continuare a vivere in sfere separate. Ciò implica il rigetto della tesi del Noma (Non Overlapping Magisteria) per primo formulata in economia nel 1829 da Richard Whateley, cattedratico all’Università di Oxford e vescovo della Chiesa Anglicana.
 Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
 I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.
I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.Ben diverso è l’assunto antropologico da cui parte il paradigma dell’economia civile - fondato da Antonio Genovesi nel 1753 a Napoli - che, rifiutando esplicitamente il Noma, riconosce che homo homini natura amicus. («L’uomo è per natura amico dell’altro uomo»).
Seconda novità di rilievo del Documento è la rilevanza attribuita al principio della responsabilità adiaforica, di cui quasi mai si fa cenno. Il par. 14 recita: «Ad li là del fatto che molti operatori siano singolarmente animati da buone e rette intenzioni, non è possibile ignorare che oggi l’industria finanziaria, a causa della sua pervasività e della sua inevitabile capacità di condizionare e di dominare l’economia reale, è un luogo dove gli egoismi e le sopraffazioni hanno un potenziale di dannosità della collettività che ha pochi eguali».
È questo un esempio notevole di struttura di peccato, come la chiamò, per primo nella Dottrina Sociale della Chiesa, Giovanni Paolo II nella sua Sollecitudo Rei Socialis (1987). Non è il solo operatore di borsa, o banchiere o uomo d’affari ad essere responsabile delle conseguenze delle azioni che pone in atto. Anche le istituzioni economiche, se costruite su premesse di valore contrarie ad un’etica amica dell’uomo, possono generare danni enormi a prescindere dalle intenzioni di coloro che in esse operano. Per meglio comprendere la ragione di ciò, conviene fissare l’attenzione su tre caratteristiche specifiche della nuova finanza.
La prima è l’impersonalità dei contesti di mercato, la quale oscura il fatto che da qualche parte vi è sempre un qualcuno sull’altro lato dell’affare. La seconda caratteristica è la complessità della nuova finanza che fa sorgere problemi di agentività indiretta: il principale si riconosce moralmente disimpegnato nei confronti delle azioni poste in essere dal suo ’ingegnere finanziario’, cioè dall’esperto cui affida il compito di disegnare un certo prodotto, il quale a sua volta si mette il cuore in pace perché convinto di eseguire un ordine.
Accade così che ognuno svolge il suo ruolo separando la propria azione dal contesto generale, rifiutandosi di accettare che, anche se solo amministrativamente, era parte dell’ingranaggio. Infine, la nuova finanza tende ad attrarre le persone meno attrezzate dal punto di vista etico, persone cioè che non hanno scrupoli morali e soprattutto molto avide. Riusciamo così a comprendere perché il problema non risiede unicamente nella presenza di poche o tante mele marce; ma è sulla stessa cesta delle mele che si deve intervenire.
Il Documento in questione, infine, prende definitiva ed esplicita posizione contro la tesi della doppia moralità - purtroppo diffusa anche tra alcune organizzazioni di tipo finanziario che dichiarano di ispirarsi alla Dottrina Sociale della Chiesa. Per capire di che si tratta conviene partire dal saggio di Albert Carr, ’Is business bluffing ethical?’ pubblicato sulla prestigiosa Harvard Business Review nel 1968. È questo il saggio che, più di ogni altro, ha guidato fino ad oggi la riflessione etica nel mondo degli affari. Vi si legge che l’uomo d’affari di successo deve essere guidato da «un diverso insieme di standars etici», poiché «l’etica degli affari è l’etica del gioco [d’azzardo], diversa dall’etica religiosa». Assimilando il business al gioco del poker, il noto economista americano conclude che «gli unici vincoli di ogni mossa nel business sono la legalità e il profitto.
Se qualcosa non è illegale in senso stretto (sic!) ed è profittevole allora è eticamente obbligante che l’uomo d’affari lo realizzi». I paragrafi dal 22 al 34 di Opq si soffermano sul faciendum: che fare per cercare di invertire la situazione? Parecchie le proposte - tutte realizzabili - che vengono avanzate. Dal sostegno a istituti che praticano la finanza non speculativa, come le Banche di Credito Cooperativo, il microcredito, l’investimento socialmente responsabile, alle tante forme di finanza etica. Dalla chiusura della finanza offshore e dalle forme di cannibalismo economico di chi, con i credit default swaps, specula sul fallimento altrui, alla regolamentazione dello shadow-banking, soggetti finanziari non bancari che agiscono come banche ma operando al di fuori di ogni quadro normativo ufficiale.
L’obiettivo da perseguire è quello di assicurare una effettiva biodiversità bancaria e finanziaria. Di speciale interesse è inoltre la proposta di affiancare ai Cda delle grandi banche Comitati Etici costituiti da persone moralmente integre oltre che competenti - così come già accade nei grandi policlinici. Nell’aprile 2015 la ’Dutch Banking Association’ (l’Associazione di tutte le banche olandesi) stabilì di esigere dai dipendenti delle banche (circa 87.000 persone) il ’Giuramento del Banchiere’, stilato sulla falsariga del giuramento ippocratico per i medici.
Il giuramento consta di otto impegni specifici. Ne indico solamente un paio: «Prometto e giuro di mai abusare delle mia conoscenze»; «Prometto e giuro di svolgere le mie funzioni in modo etico e con cura, adoperandomi di conciliare gli interessi di tutte le parti coinvolte: clienti, azionisti; occupati; società». Si opera dunque a favore di tutte le classi di stakeholder e non solamente di quella degli azionisti. Sarebbe bello se sull’esempio dell’Olanda - un Paese non certo sprovveduto né arretrato in materia finanziaria - anche l’Italia volesse seguirne la traccia.
Delle tre principali strategie con le quale si può cercare di uscire da una crisi di tipo entropico - quale è l’attuale - e cioè quella rivoluzionaria, quella riformista, quella trasformazionale, il Documento Opq sposa, in linea con il Magistero di papa Francesco, la terza. Si tratta di trasformare - non basta riformare - interi blocchi del sistema finanziario che si è venuto formando nell’ultimo quarantennio per riportare la finanza alla sua vocazione originaria: quella di servire il bene comune della civitas che, come ci ricorda Cicerone, è la «città delle anime», a differenza dell’urbs che è la «città delle pietre». È questa la strategia che vale, ad un tempo, a scongiurare il rischio sia di utopiche palingenesi sia del misoneismo, che è l’atteggiamento tipico di chi detesta la novità e osteggia l’emergenza del nuovo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
 VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggereGUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO - Resurrezione: mito o mistero? (di Michela Dall’Aglio - "Doppiozero").29 maggio 2018, di Federico La Sala
ICONE DELLA LEGGE - DELLA COSTITUZIONE. Icone. Pensare per immagini... *
Resurrezione: mito o mistero?
di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 28.05.2018)
Nel dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio Salita al Calvario del 1564, si scorge a fatica, al centro di una scena super affollata, Gesù salire al Calvario nell’indifferenza generale. Si fatica a vedere la sua piccola figura e la grande croce che trascina con sé. Tutt’intorno a lui brulica una folla indifferente, affaccendata nelle proprie attività. Il clima è festoso, non sembra profilarsi alcuna tragedia all’orizzonte. In primo piano, tre donne piangono, consolate da un giovane che sappiamo essere Giovanni, l’apostolo. Ma le quattro figure sembrano fuori posto, quasi fossero dovute perché non si dà la Passione senza le donne piangenti e Giovanni.
Inizia da qui l’itinerario che Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa percorrono nel loro ultimo libro, Croce e Resurrezione (il Mulino), pubblicato nella collana ’Icone. Pensare per immagini’ diretta da Massimo Cacciari. -Come suggerisce il titolo, il libro è diviso in due parti. Nella prima, dedicata alla passione e crocefissione di Cristo, Maurizio Ciampa commenta la Salita al Calvario accostandola anche a diverse altre raffigurazioni dello stesso soggetto: da Hieronymus Bosch, col suo Cristo portacroce del 1515 - in cui il volto di Gesù sembra l’unico umano, schiacciato e soffocato da facce grottesche e demoniache -, a James Ensor, con L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, in cui la parodia dell’ingresso a Gerusalemme alla vigilia della Pasqua, è un carnevale. Da Matthias Grunewald con il crocifisso dell’Altare di Isenheim, quasi inguardabile nell’atrocità del suo dolore, a I disastri della guerra, di Francisco Goya, 1808-1810, e altri ancora.
La seconda parte del libro è dedicata alla risurrezione di Cristo, evento inimmaginabile accaduto senza testimoni. Com’è possibile, allora, rappresentarlo? In che modo dipingere un uomo che abbia attraversato il confine della morte e abbia trovato, al di là, vita nuova? Di quale strana materia dovrebbe essere fatto, per rimanere attingibile ai sensi?
 Gabriella Caramore sceglie di parlarne commentando La cena di Emmaus dipinta da Rembrandt nel 1629, in cui il risorto è un profilo d’ombra che risalta sulla luce proiettata sul muro alle sue spalle, che il suo stesso corpo emana. Ed è una buona scelta, perché non esiste in tutta la storia dell’arte un volto di Cristo risorto all’altezza dell’evento, neppure quello che forse è il più bello di tutti, ritratto da Piero della Francesca nel dipinto Resurrezione del 1460.
Gabriella Caramore sceglie di parlarne commentando La cena di Emmaus dipinta da Rembrandt nel 1629, in cui il risorto è un profilo d’ombra che risalta sulla luce proiettata sul muro alle sue spalle, che il suo stesso corpo emana. Ed è una buona scelta, perché non esiste in tutta la storia dell’arte un volto di Cristo risorto all’altezza dell’evento, neppure quello che forse è il più bello di tutti, ritratto da Piero della Francesca nel dipinto Resurrezione del 1460.È un libro bello e intenso, traboccante di domande che tutti si fanno davanti ai due pilastri della fede cristiana, la morte in croce di Gesù e il suo ingresso in una nuova vita. Due sono le più dure e drammatiche: interessano ancora a qualcuno la sua storia e la sua tragica fine? Com’è possibile oggi credere alla resurrezione? La risposta, più lasciata intuire che detta esplicitamente, sembra essere ’no’. Forse, suggeriscono gli autori, dovremmo leggere tutta la vicenda in un modo diverso che, allontanandola dalla “leggenda”, ci permettesse di trovarne un senso accettabile oggi per noi.
Nella Salita al Calvario, osserva Ciampa, per la prima volta la passione di Cristo è trasformata in spettacolo, infatti la sua figura quasi scompare tra le tante che affollano la scena, per lo più allegre e ridanciane, prese dai loro vari commerci. Il luogo in cui il condannato sarà crocifisso è lontano e marginale. Come lo sono anche Giovanni e le donne, raffigurati in primo piano sul lato destro del dipinto, e sembrano del tutto estranei rispetto alla folla. Non sono vicini né a Gesù né al luogo del patibolo.
 Maurizio Ciampa si chiede se ce la farà ad arrivare al Golgota questo povero Cristo “trafitto dall’indifferenza” e acutamente osserva: “Possiamo leggere la Salita al Calvario come un triste presentimento di ciò che accadrà, una sorta di presagio della Storia che verrà, una sua sintesi anticipata. La croce nascosta, il Cristo accantonato, la Passione alterata in ‘festa’”.
Maurizio Ciampa si chiede se ce la farà ad arrivare al Golgota questo povero Cristo “trafitto dall’indifferenza” e acutamente osserva: “Possiamo leggere la Salita al Calvario come un triste presentimento di ciò che accadrà, una sorta di presagio della Storia che verrà, una sua sintesi anticipata. La croce nascosta, il Cristo accantonato, la Passione alterata in ‘festa’”.Una festa paesana che James Ensor porterà a termine, trasformandola in carnevale, dopo che Cristo avrà attraversato il male raffigurato nei volti ghignanti di Hieronymus Bosch, quasi a suggerire che egli non può - non ha potuto né potrà - vincere il male sulla Terra. “In Bruegel resiste ancora, nascosto, un residuo di croce” - afferma Ciampa - “in Bosch la croce sembra soccombere, Cristo resta comunque l’ultima traccia dell’umano; in Ensor, gli "uomini vuoti", distratti, confusi, sembrano non averne più memoria.” La passione diventata intrattenimento e un Cristo fragile e svuotato sembrano dichiarare che la sofferenza dell’uomo non troverà mai senso e che il “simbolo cristiano” ha perso efficacia per l’uomo di oggi. Il mondo ha messo Cristo da parte, la sua storia non interessa più, non è più ispiratrice né può dirsi in alcun modo diversa da quella dei tanti uomini e donne buoni e di valore che la Storia ha fatto a pezzi. Non c’è più altro da dire.
A questo punto, però, nella visione cristiana fondata sulla testimonianza della gente del tempo, entra in scena la libertà di Dio. Perché è questo il significato della resurrezione di Gesù: nella loro libertà i potenti nemici di Gesù ne hanno decretata la morte; nella sua libertà, Gesù non vi si è sottratto; ma nella sua libertà, Dio è intervenuto quando la sua azione non avrebbe più forzato e ridotto la libertà degli altri attori in gioco. Con la resurrezione di Gesù ha dichiarato, davanti agli uomini e alla Storia, che quell’uomo diceva la verità, su di loro e su Dio stesso. È possibile crederlo?
 Gli autori sembrano, di nuovo, propendere per una risposta negativa quando si domandano: “Quale narrazione di quell’evento può aiutarci a darne una lettura che non strida con l’esigenza contemporanea di uscire dal linguaggio del mito?”. E più avanti, verso la conclusione del libro, Gabriella Caramore, invitando a non smettere di cercare “per capire se sia possibile estrarne una umile, esile forza su cui far leva per potere stare al mondo”, si chiede se non sia “proprio in questa eclissi di una trascendenza mitologica (corsivo mio) che può condensarsi il senso della ’resurrezione’: qualcosa è stato e ha lasciato un segno sulla terra ... rimane, per chi resta, la possibilità di ridestarsi alla luce, di rialzarsi alla vita. Non è, questo, un segno molto più potente che non attendere il ritorno nella carne, nella materia, o nella leggenda (corsivo mio) di chi ha lasciato quell’incolmabile vuoto?” E riferendosi all’evangelista Luca e alla sua insistenza a dichiarare Gesù il vivente anche dopo la morte, afferma: “In fondo quell’insistenza ... appare come un invito ad allontanarsi dalla visione di un cadavere che torna a rivisitare i vivi, per spalancare invece la possibilità di trovare forza e consolazione in ciò che rimane di una vita trascorsa”.
Gli autori sembrano, di nuovo, propendere per una risposta negativa quando si domandano: “Quale narrazione di quell’evento può aiutarci a darne una lettura che non strida con l’esigenza contemporanea di uscire dal linguaggio del mito?”. E più avanti, verso la conclusione del libro, Gabriella Caramore, invitando a non smettere di cercare “per capire se sia possibile estrarne una umile, esile forza su cui far leva per potere stare al mondo”, si chiede se non sia “proprio in questa eclissi di una trascendenza mitologica (corsivo mio) che può condensarsi il senso della ’resurrezione’: qualcosa è stato e ha lasciato un segno sulla terra ... rimane, per chi resta, la possibilità di ridestarsi alla luce, di rialzarsi alla vita. Non è, questo, un segno molto più potente che non attendere il ritorno nella carne, nella materia, o nella leggenda (corsivo mio) di chi ha lasciato quell’incolmabile vuoto?” E riferendosi all’evangelista Luca e alla sua insistenza a dichiarare Gesù il vivente anche dopo la morte, afferma: “In fondo quell’insistenza ... appare come un invito ad allontanarsi dalla visione di un cadavere che torna a rivisitare i vivi, per spalancare invece la possibilità di trovare forza e consolazione in ciò che rimane di una vita trascorsa”.Se la resurrezione è un mito, non credo ci possa dare alcuna forza, né esile e umile, né d’altro genere; non consola nessuno né cambia alcunché della nostra personale sofferenza. Se non è un mito, è uno sconvolgimento, una forza potente, una rivoluzione dell’interpretazione che ognuno può dare alla propria vita, una direzione totalmente nuova verso cui sentirsi tutti in cammino. La resurrezione di Gesù non è il ritorno a questa vita di un cadavere, ma la rivelazione di un destino sorprendente, di uno stadio successivo alla vita che aspetta ogni essere umano (e non soltanto). È la possibilità di sperare con intelligenza, e non sulla base di favole e miti rassicuranti, che la morte non sia la fine del viaggio. E questa fiducia non si basa su un’adesione emotiva, non è stata conservata nei secoli da cuori fragili incapaci di accettare la morte, ma da spiriti forti e intelligenze acute che vi hanno riflettuto con tutte le proprie forze. È impossibile riassumere qua questo lungo cammino, mai concluso, ma chi volesse può ascoltare, per farsi un’idea della questione, una conferenza molto chiara e interessante dell’astrofisico e teologo Giuseppe Tanzella-Nitti, dal titolo: La visione del cristianesimo tra vita biologica ed immortalità, reperibile su youtube.
L’evento della resurrezione non ha avuto testimoni, per questo non si può definirlo storicamente certo (se lo fosse, probabilmente saremmo tutti cristiani). I fatti storicamente accertati riguardano, invece, quello che i discepoli fecero dopo gli incontri con Gesù successivi alla sua morte, e l’improvviso cambiamento avvenuto nella loro attitudine, nel loro stesso carattere.
 La resurrezione è, ad ogni modo, un mistero che non si può liquidare facilmente né alla leggera, perché la fede cristiana non si fonda sul messaggio di Gesù allo stesso modo in cui, per esempio, il buddismo si fonda sull’insegnamento straordinario del Buddha, ma sulla sua persona e sul mistero che egli rappresenta per l’umanità tutta. A quel mistero appartiene, come elemento non secondario ma fondamentale, che sia risuscitato dalla morte rivelando qualcosa di sostanziale in merito al destino di tutti gli esseri umani.
La resurrezione è, ad ogni modo, un mistero che non si può liquidare facilmente né alla leggera, perché la fede cristiana non si fonda sul messaggio di Gesù allo stesso modo in cui, per esempio, il buddismo si fonda sull’insegnamento straordinario del Buddha, ma sulla sua persona e sul mistero che egli rappresenta per l’umanità tutta. A quel mistero appartiene, come elemento non secondario ma fondamentale, che sia risuscitato dalla morte rivelando qualcosa di sostanziale in merito al destino di tutti gli esseri umani.Credere nella resurrezione di Gesù e in una vita piena dell’intera persona umana, al di là di come questo sia possibile e di quale materia sarà il nostro corpo, fa la differenza tra il cristianesimo e le altre concezioni. È ancora vero quello che ha detto san Paolo: “...se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede ... se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini.” (1Cor 15).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MEMORIA DELLA LIBERAZIONE DALLA SCHIAVITU’: ESODO. In memoria di Mosé, di Elia, e di Gesu’ .... PASQUA: BUONA PASQUA DI RESURREZIONE E DI RISURREZIONE.
KANT ALL’ATTACCO DEI DELIRI E DEGLI INGANNI DEI "GRANDI SAPIENTI": ANNO DI GRAZIA, 1766.
EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX - Un dio chiamato Capitale (di Massimo Cacciari).2 maggio 2018, di Federico La Sala
Due secoli di Marx
Un dio chiamato Capitale
Non è stata l’economia politica il cuore della rivoluzione del grande pensatore. Ma l’Economico come categoria dello spirito. La vera potenza che mette all’opera il mondo
di Massimo Cacciari (l’espresso, 29.04.2018)
Tacete economisti e sociologi in munere alieno. Marx non è affare vostro, o soltanto di quelli di voi che ne comprendano la grandezza filosofica, anzi: teologico-filosofica. Marx sta tra i pensatori che riflettono sul destino dell’Occidente, tra gli ultimi a osare di affrontarne il senso della storia. In questo è paragonabile forse soltanto a Nietzsche. Ma “Il Capitale”, si dirà? Non è l’economia politica al centro della sua opera? No; è la critica dell’economia politica. Che vuol dire? Che l’Economico vale per Marx come figura dello Spirito, come espressione della nuova potenza che lo incarna nel mondo contemporaneo. L’Economico è per Marx ciò che sarà la Tecnica per Heidegger: l’energia che informa di sé ogni forma di vita, che determina il Sistema complessivo delle relazioni sociali e politiche, che fa nascere un nuovo tipo di uomo. Nessuna struttura cui si aggiungerebbe una sovra-struttura a mo’ di inessenziale complemento - l’Economico è immanente in tutte le forme in cui l’agire e il pensare si determinano; ognuna di esse è parte necessaria dell’intero.
Marx è pensatore del Tutto, perfettamente fedele in questo al suo maestro Hegel. Il Sistema è più delle parti, irriducibile alla loro somma. Chi intende l’Economico come una struttura a sé, autonoma, che determinerebbe meccanicisticamente le altre, non ha capito nulla di Marx. Marx non è pensatore astratto, e cioè non astrae mai l’Economico dall’intero sistema delle relazioni sociali, culturali, politiche.
La sua domanda è: quale potenza oggi governa l’Intero e come concretamente essa si esprime in ogni elemento dell’Intero? L’Economico è infinitamente più che Economico. Esso rappresenta nel contemporaneo la potenza che mette all’opera il mondo.
 Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.
Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.Per Marx è questo il “nuovo mondo” che il sistema di produzione capitalistico crea, non certo dal nulla, ma certo sconvolgendo dalle radici forme di vita e relazioni sociali, insomma: l’ethos dell’Occidente, la “sede” in cui l’Occidente aveva ino ad allora abitato È il mondo dove il Logos della forma-merce si incarna in ogni aspetto della vita, per diventarne la religione stessa. E Marx ne esalta l’impeto rivoluzionario. È questo impeto che per lui va seguito, al suo interno è necessario collocarsi per comprenderne le contraddizioni e prevederne scientificamente l’aporia, e cioè dove la strada che esso ha aperto è destinata a interrompersi - per il salto a un altro mondo. Qui bisogna intendere bene: la contraddizione non viene da fuori, da qualcosa che sia “straniero” al Sistema.
Contraddittorio in sé è il capitalismo stesso. Il capitalismo è crisi, è fatto di crisi. Funziona per salti, che ogni volta mettono inevitabilmente in discussione gli equilibri raggiunti. Non vi è riproduzione senza innovazione. Questo è noto anche agli economisti.
 Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
 È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.
È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.Questa contraddizione muove tutto. E ognuno è imbarcato in essa. L’idea di poterne giudicare “dall’alto” costituisce per l’appunto quella ideologia, che Marx sottopone a critica in dalle prime opere. Se la realtà dell’epoca è contraddizione inscindibilmente economica e politica, ogni interpretazione che la riduca a fatti naturalisticamente analizzabili la mistifica. Non è possibile cogliere la realtà del Sistema che collocandosi in esso, e dunque collocandosi nella contraddizione. Soltanto in questa prospettiva l’Intero è afferrabile. Non si comprende la realtà del presente se non in prospettiva e perciò a partire da un punto di vista determinato. Impossibile oggi un sapere astrattamente neutrale. La pretesa all’avalutatività è falsamente scientifica; l’epoca costringe a prender-parte, all’aut-aut. A porsi in gioco, alla scommessa anche. Il momento, o il kairòs, della decisione politica viene cosi a far parte della stessa potenza dell’Economico, resta immanente in essa.
 È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.
È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.Poiché concepisce la storia dell’Occidente come conflitto, e conflitto determinato dal suo carattere di classe, e poiché intende il presente alla luce dell’intrinseca contraddittorietà della stessa potenza rivoluzionaria del Sistema tecnico-economico, Marx pensa di aver posto saldamente sui piedi il pensiero dialettico dell’idealismo. Le epoche della Fenomenologia hegeliana dello Spirito non trovano conclusione in un Sapere assoluto che tutte accoglie e accorda, in una suprema Conciliazione, ma nella insuperabile contraddizione tra la potenza universale del Lavoro produttivo divenuto cosciente di sé e la sua appropriazione capitalistica. Si tratta di ben altro che di calcoli su valore e plusvalore.
 L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
 Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
 Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
 La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX - «Il capitalismo non è eterno». Conversazione tra Marcello Musto e Immanuel Wallerstein.8 aprile 2018, di Federico La Sala
COLLOQUIO. Nasceva duecento anni fa l’autore del «Manifesto del partito comunista»: sul suo pensiero abbiamo interpellato il sociologo Immanuel Wallerstein, che ne rivendica l’attualità. Non può fare a meno di lui una sinistra globale che voglia rappresentare l’80% più povero degli abitanti della terra
«Il capitalismo non è eterno. E Marx è ancora necessario»
conversazione tra Marcello Musto e Immanuel Wallerstein (Corriere della Sera, La Lettura, 08.06.2018)
- L’equivoco sovietico. Il socialismo in un solo Paese di marca staliniana è estraneo a Marx: leggete direttamente lui non i suoi pretesi interpreti
Immanuel Wallerstein, senior research scholar alla Yale University (New Haven, Usa) è considerato uno dei più grandi sociologi viventi. I suoi scritti sono stati molto influenzati dalle opere di Karl Marx ed egli è uno degli studiosi più adatti per riflettere sul perché quel pensiero sia ritornato, ancora una volta, di attualità
MARCELLO MUSTO - Professor Wallerstein, quasi trent’anni dopo la fine del cosiddetto «socialismo reale», in quasi tutto il globo tantissimi dibattiti, pubblicazioni e conferenze hanno come tema la persistente capacità da parte di Marx di spiegare le contraddizioni del presente. Lei ritiene che le idee di Marx continueranno ad avere rilevanza per quanti ritengono necessario ripensare un’alternativa al capitalismo?
IMMANUEL WALLERSTEIN - Esiste una vecchia storia su Marx che dice che ogni volta che si cerca di buttarlo fuori dalla porta, lui rientra dalla finestra. È quanto sta accadendo in questi anni. Marx è ancora fondamentale per quanto scrisse a proposito del capitalismo. Le sue osservazioni furono molto originali e completamente diverse da ciò che affermarono altri autori. Oggi affrontiamo problemi rispetto ai quali egli ha ancora molto da insegnarci e tanti editorialisti e studiosi - non certo solo io - trovano il pensiero di Marx particolarmente utile in questa fase di crisi economica e sociale. Ecco perché, nonostante quanto era stato predetto nel 1989, assistiamo alla sua rinnovata popolarità.
MARCELLO MUSTO - La caduta del Muro di Berlino ha liberato Marx dalle catene degli apparati statali dei regimi dell’Est Europa e da un’ideologia sideralmente lontana dalla sua concezione di società. Qual è il motivo centrale che suscita ancora tanta attenzione verso l’interpretazione del mondo di Marx?
IMMANUEL WALLERSTEIN - Io credo che, se chiedessimo a quanti conoscono Marx di riassumere in una sola idea la sua concezione del mondo, la maggior parte di essi risponderebbe «la lotta di classe». Io leggo Marx alla luce del presente e per me «lotta di classe» significa il perenne conflitto tra quella che io chiamo la «sinistra globale» - che ritengo possa ambire a rappresentare l’80% più povero della popolazione mondiale - e la «destra globale» - che rappresenta l’1% più ricco. Per vincere questo scontro bisogna conquistare il restante 19%; bisogna cercare di portarlo nel proprio campo e sottrarlo a quello dell’avversario. Viviamo in un’era di crisi strutturale del sistema mondo. Credo che il capitalismo non sopravvivrà, anche se nessuno sa con certezza da che cosa potrà essere sostituito. Io sono convinto che vi siano due possibilità. Una prima è rappresentata da quello che chiamo lo «spirito di Davos». L’obiettivo del Forum economico mondiale di Davos è quello di imporre un sistema sociale nel quale permangano le peggiori caratteristiche del capitalismo: le gerarchie sociali, lo sfruttamento e, soprattutto, il dominio incontrastato del mercato con la conseguente polarizzazione della ricchezza. L’alternativa è, invece, un sistema più democratico e più egualitario di quello esistente. Per tornare a Marx, dunque, la lotta di classe costituisce lo strumento fondamentale per influire sulla costruzione di ciò che, in futuro, sostituirà il capitalismo.
MARCELLO MUSTO - Le sue riflessioni circa la contesa per ricevere il sostegno politico della classe media ricordano Antonio Gramsci e il suo concetto di egemonia. Tuttavia, credo che per le forze di sinistra la questione prioritaria sia come ritornare a parlare alle masse popolari, ovvero quell’80% a cui lei fa riferimento, e come rimotivarle alla lotta politica. Questo è particolarmente urgente nel «Sud globale», dove è concentrata la maggioranza della popolazione mondiale e dove, negli ultimi tre decenni, a dispetto del drammatico aumento delle diseguaglianze prodotte dal capitalismo, partiti e movimenti progressisti si sono indeboliti. Lì l’opposizione alla globalizzazione neoliberista è spesso guidata dai fondamentalismi religiosi e da partiti xenofobi, un fenomeno in crescita anche in Europa. La domanda è se Marx può aiutarci in questo scenario. Libri di recente pubblicazione offrono nuove interpretazioni della sua opera. Essi rivelano un autore che fu capace di esaminare le contraddizioni della società capitalista ben oltre il conflitto tra capitale e lavoro. Marx dedicò molte energie allo studio delle società extra-europee e al ruolo distruttivo del colonialismo nelle periferie del sistema. Allo stesso modo, smentendo le interpretazioni che assimilano la concezione marxiana della società comunista al mero sviluppo delle forze produttive, l’interesse per la questione ecologica presente nell’opera di Marx fu ampio e rilevante. Infine, egli si occupò in modo approfondito di numerose tematiche che molti studiosi spesso sottovalutano o ignorano quando parlano di lui. Tra queste figurano le potenzialità emancipatrici della tecnologia, la critica dei nazionalismi, la ricerca di forme di proprietà collettive non controllate dallo Stato, o la centralità politica della libertà individuale nella sfera economica e politica: tutte questioni fondamentali dei nostri giorni. Accanto a questi «nuovi profili» di Marx - che suggeriscono come il rinnovato interesse per il suo pensiero sia un fenomeno destinato a proseguire nei prossimi anni - potrebbe indicare tre delle idee più conosciute di Marx a causa delle quali questo autore non può essere accantonato?
IMMANUEL WALLERSTEIN - Innanzitutto, Marx ci ha insegnato meglio di chiunque altro che il capitalismo non corrisponde al modo naturale di organizzare la società. Già in Miseria della filosofia , pubblicato quando aveva solo 29 anni, schernì gli economisti che sostenevano che le relazioni capitalistiche si fondavano su «leggi naturali, indipendenti dall’influenza del tempo». Marx scrisse che gli economisti avevano riconosciuto il ruolo svolto dagli esseri umani nella storia quando avevano analizzato le «istituzioni feudali, nelle quali si trovavano rapporti di produzione del tutto differenti da quelli della società borghese». Tuttavia, essi mancarono di storicizzare il modo di produzione da loro difeso e presentarono il capitalismo come «naturale ed eterno». Nel mio libro Il capitalismo storico ho tentato di chiarire che il capitalismo è un sistema sociale storicamente determinato, contrariamente a quanto impropriamente sostenuto da alcuni economisti. Ho più volte affermato che non esiste un capitalismo che non sia capitalismo storico e, a tal proposito, dobbiamo molto a Marx. In secondo luogo, vorrei sottolineare l’importanza del concetto di «accumulazione originaria», ossia l’espropriazione della terra dei contadini che fu alla base del capitalismo. Marx capì benissimo che si trattava di un processo fondamentale per la costituzione del dominio della borghesia. È un fenomeno che persiste ancora oggi. Infine, inviterei a riflettere di nuovo sul tema «proprietà privata e comunismo». In Unione Sovietica, in particolare durante il periodo staliniano, lo Stato deteneva la proprietà dei mezzi di produzione. Ciò non impedì, però, che le persone fossero sfruttate e oppresse. Tutt’altro. Ipotizzare la costruzione del «socialismo in un solo Paese», come fece Stalin, costituì una novità mai considerata in precedenza, men che mai da Marx. La proprietà pubblica dei beni di produzione rappresenta una delle alternative possibili, ma non è l’unica. Esiste anche l’opzione della proprietà cooperativa. Tuttavia, se vogliamo costruire una società migliore, è necessario sapere chi produce e chi riceve il «plusvalore» - altro pilastro fondamentale della teoria di Marx. È questo il tema centrale. Va completamente mutato quanto si viene a determinare nei rapporti capitalistici di produzione.
MARCELLO MUSTO - Il 2018 coincide con il bicentenario della nascita di Marx e nuovi libri e film vengono dedicati alla sua vita. Quali sono gli episodi della biografia di Marx che lei considera più significativi?
IMMANUEL WALLERSTEIN - Marx trascorse una vita molto difficile, in perenne lotta contro una povertà terribile. Fu molto fortunato ad avere incontrato un compagno come Friedrich Engels, che lo aiutò a sopravvivere. Marx non ebbe nemmeno una vita affettiva semplice e la sua tenacia nel portare a compimento la missione che aveva assegnato alla propria esistenza - ovvero la comprensione del meccanismo di funzionamento del capitalismo - è davvero ammirevole. Marx non pretese né di spiegare l’antichità, né di definire come avrebbe dovuto essere la futura società socialista. Volle comprendere il suo presente, il sistema capitalistico nel quale viveva.
MARCELLO MUSTO - Nel corso della sua vita, Marx non fu soltanto lo studioso isolato dal mondo tra i libri del British Museum; fu un rivoluzionario sempre impegnato nelle lotte della sua epoca. Da giovane, a causa della sua militanza politica, egli venne espulso dalla Francia, dal Belgio e dalla Germania e, quando le rivoluzioni del 1848 vennero sconfitte, fu costretto all’esilio in Inghilterra. Fondò quotidiani e riviste e appoggiò, in tutti i modi, le lotte del movimento operaio. Inoltre, dal 1864 al 1872 fu il principale animatore dell’Associazione internazionale dei lavoratori, la prima organizzazione transnazionale della classe operaia, e nel 1871 difese strenuamente la Comune di Parigi, il primo esperimento socialista della storia.
IMMANUEL WALLERSTEIN - Sì, è vero, è essenziale ricordare la militanza politica di Marx. Egli ebbe un’influenza straordinaria nell’Internazionale, un’organizzazione composta da lavoratori fisicamente distanti tra loro, in un’epoca in cui non esistevano mezzi che potessero agevolare la comunicazione. Marx fece politica anche attraverso il giornalismo, impiego che svolse per tanta parte della sua vita. Certo, lavorò come corrispondente del «New-York Daily Tribune» prima di tutto per avere un reddito, ma considerò i propri articoli - che raggiunsero un pubblico molto vasto - come parte della sua attività politica. Essere neutrale non aveva alcun senso ai suoi occhi - il che non vuol dire che mancò di rigore nelle sue analisi. Fu sempre un giornalista impegnato e critico.
MARCELLO MUSTO - Lo scorso anno, in occasione del centesimo anniversario della rivoluzione russa, alcuni studiosi sono ritornati a discutere sulle distanze tra Marx e alcuni suoi autoproclamatisi epigoni che sono stati al potere nel XX secolo. Qual è la maggiore differenza tra loro e Marx?
IMMANUEL WALLERSTEIN - Gli scritti di Marx sono illuminanti e molto più sottili e raffinati di molte interpretazioni semplicistiche delle sue idee. È sempre bene ricordare che fu lo stesso Marx, con una famosa boutade, ad affermare dinanzi ad alcune interpretazioni del suo pensiero: «Quel che è certo è che io non sono marxista». Marx, a seguito dei suoi continui studi, non di rado mutò idee e opinioni. Si concentrò sui problemi che esistevano nella società del suo tempo e, a differenza di tanti che si sono richiamati al suo pensiero, fu profondamente antidogmatico. Questa è una delle ragioni per le quali Marx è una guida ancora così valida e utile.
MARCELLO MUSTO - Per concludere, che messaggio le piacerebbe trasmettere a quanti, nella nuova generazione, non hanno ancora letto Marx?
IMMANUEL WALLERSTEIN - La prima cosa che vorrei dire ai più giovani è di leggere direttamente gli scritti di Marx. Non leggete su Marx, ma leggete Marx. Solo pochi - fra tutti quelli che parlano di lui - hanno veramente letto le opere di Marx. È una considerazione che, peraltro, vale anche per Adam Smith. In genere, con la speranza di risparmiare tempo, molte persone preferiscono leggere a proposito dei classici del pensiero politico ed economico e, dunque, finiscono per conoscerli attraverso i resoconti di altri. È solo uno spreco di tempo! Bisogna leggere direttamente i giganti del pensiero moderno e Marx è, senza dubbio, uno dei principali studiosi del XIX e XX secolo. Nessuno gli è pari, né per la molteplicità delle tematiche da lui trattate, né per la qualità della sua analisi. Alle giovani generazioni dico che è indispensabile conoscere Marx e che per farlo bisogna leggere, leggere e leggere direttamente i suoi scritti. Leggete Karl Marx!
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO. -- MEMORIA DI SANT’AMBROGIO.21 marzo 2018, di Federico La Sala
IL "LOGOS" E LA "CHARITAS". Sul Vaticano, e su Roma, il "Logo" del Grande Mercante.Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- SANT’AMBROGIO - AMBROSIUS, In Epistolam Beati Pauli Ad Corinthios Primam, Caput XIII, Vers. 4-8:
- "Charitas Deus est" (I Joan. 4,8).
- Ambrosius, De Officiis ministrorum, Liber 2, Caput XXX, 155:
- "Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil charitate dulcius, nihil pace gratius"()
Il motto dello stemma episcopale del Vescovo Ausiliare di Roma, S.E.R. Mons. Angelo De Donatis
- NIHIL CARITATE DULCIUS (Ambrosius “De Officiis ministrorum” Liber 2, Caput XXX, 155)
Le parole scelte da Don Angelo per il proprio motto episcopale sono tratte dal “De officiis ministrorum” di Sant’Ambrogio laddove dice
 “Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil caritate dulcius,nihil pace gratius...”
“Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil caritate dulcius,nihil pace gratius...”
 (“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”) *
(“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”) **
Fonte: http://www.sanmarcoevangelista.it (ripresa parziale).
Federico La Sala
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO. - Era Francesco. Cinque anni di Bergoglio (di Alessandro Santagata(13 marzo 2018, di Federico La Sala
Il cambio di passo che scopre il valore dei movimenti
Era Francesco. Cinque anni di Bergoglio
- Il papa saluta gli operai dell’Ilva in piazza san Pietro a Roma
di Alessandro Santagata (il manifesto, 13.03.2018)
Scrive Michel Foucault che il «potere pastorale» della Chiesa è stato uno dei dispositivi sui quali si è definita la «governamentalità» occidentale. Comunemente si dà per scontato che a partire dal XVIII secolo, sotto i colpi della secolarizzazione, la Chiesa abbia sostanzialmente perso tale prerogativa, anche in conseguenza dell’erosione del potere temporale.
Una possibile chiave di lettura del pontificato di papa Francesco comporta una messa in discussione di tale considerazione cronologica.
La preoccupazione per le difficoltà di Bergoglio nell’operare le riforme strutturali è il leit-motiv dei settori del cattolicesimo progressista, giustamente in ansia per ciò che succederà dopo la fine del pontificato.
Se però si adotta una prospettiva più larga (ed esterna), il problema della riforma delle strutture appare invece ridimensionarsi. In cosa consiste oggi il potere pastorale della Chiesa? È ormai evidente che il piano della compenetrazione e poi della contesa con lo Stato moderno non è più il principale.
Senza contrasto con quella che è da sempre la funzione principale della cura delle anime, da tempo la partita più importante della Chiesa sembra giocarsi altrove, nel campo dei discorsi, delle identità e delle appartenenze.
Nel corso degli ultimi 50 anni, dal Concilio Vaticano II, la Chiesa cattolica ha riscoperto nella missionarietà la propria funzione principale.
Dopo il Concilio si è assistito però a una sorta di normalizzazione delle aperture alla società contemporanea, che si è tradotta in una campagna di contrasto alla secolarizzazione, in larga parte incentrata sulla sessualità e volta a ricomporre una comunità frammentata. Rispetto a tutto questo, la discontinuità introdotta dal pontificato di Bergoglio è dirompente e riguarda la ridefinizione della pastoralità e dei suoi contenuti.
Nessuna rottura con la tradizione, ma un chiaro cambio di passo che si è manifestato nella sua radicalità in occasione degli incontri mondiali con i movimenti popolari tra il 2014 e il 2016.
Il manifesto ha diffuso i discorsi tenuti dal papa in queste occasioni, con l’idea che la contaminazione che si è venuta a creare in quella sede con altre culture politiche (comprese quelle della sinistra radicale) non possa essere sottovalutata.
È stato qualcosa di inedito nella storia: precari, famiglie senza tetto, contadini senza terra riuniti sotto la regia del Vaticano per discutere di diritti e lotte sociali; una rete di centinaia di organizzazioni internazionali che ha elaborato piattaforme politiche fondate sulle esperienze concrete di movimento, dalle battaglie contro la privatizzazione dell’acqua alla difesa della sovranità alimentare, dall’introduzione di un salario sociale universale alla garanzia dell’inviolabilità della casa familiare (contro gli sgomberi).
Nell’ultimo incontro papa Francesco ha esortato i movimenti a non farsi «incasellare e corrompere» in un sistema di welfare che tende ad addomesticare il conflitto sociale e a non avere paura di entrare «nella Politica con la P maiuscola», pur senza assumere la forma dei partiti politici. Sono affermazioni che evidentemente forzano i confini della dottrina sociale e che sono da interpretare all’interno di un processo complesso - e non privo di retaggi della cristianità - che vuole ripensare gli assetti della presenza cristiana nella società.
La riforma della Chiesa incontra resistenze perché sta liberando energie a lungo sopite. In un momento storico in cui le istituzioni del ‘900 stanno collassando e, contrariamente a quanto previsto negli anni ‘70, il religioso sta assumendo un nuovo rilievo nella sfera pubblica, la trasformazione assume una valenza che non riguarda solo i cattolici e va ben oltre il nodo delle strutture.
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX - LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE E IL CATTOLICISMO DI H. DE LUBAC.10 marzo 2018, di Federico La Sala
- STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO: HENRI DE LUBAC E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO: HENRI DE LUBAC E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
 L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
*****IN MEMORIA***** UN OMAGGIO A EDOARDO SANGUINETI ....
IL DIO MAMMONA (“CARITAS”), IL DENARO, E “IL GATTO CON GLI STIVALI”. LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI ... *
PURGATORIO DE L’INFERNO, 10. “Questo è il gatto con gli stivali” *
- Mentre con il figlio osserva un libro illustrato, il poeta sollecita con amore e affetto a guardare le immagini con attenzione e spirito critico, dietro a ogni cosa in esso rappresentata, e a ogni manifestazione della vita, si nasconde l’onnipotenza del ’dio’ denaro.
Questo è il gatto con gli stivali, questa è la pace di Barcellona
fra Carlo V e Clemente VII, è la locomotiva, è il pesco
fiorito, è il cavalluccio marino: ma se volti pagina, Alessandro,
ci vedi il denaro:
questi sono i satelliti di Giove, questa è l’autostrada
del Sole, è la lavagna quadrettata, è il primo volume dei Poetae
Latini Aevi Carolini, sono le scarpe, sono le bugie, è la scuola di Atene, è il burro,
è una cartolina che mi è arrivata oggi dalla Finlandia, è il muscolo massetere,
è il parto: ma se volti foglio, Alessandro, ci vedi
il denaro:
e questo è il denaro,
e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri
con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette
di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie:
ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente
Edoardo Sanguineti
* SI CFR. : KARL MARX E WALTER BENJAMIN - “PURGATORIO DE L’INFERNO”: IL DIO MAMMONA (“CARITAS”), IL DENARO, E “IL GATTO CON GLI STIVALI”. LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=519#forum3139212
- STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto...
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO. - Walter Benjamin. Il teologo dell’economia (di Donatella Di Cesare)24 gennaio 2016, di Federico La Sala
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
- Materialismo storico e Teologia.
 KARL MARX E WALTER BENJAMIN: L’ "ODIO DI CLASSE" di EDOARDO SANGUINETI
KARL MARX E WALTER BENJAMIN: L’ "ODIO DI CLASSE" di EDOARDO SANGUINETI
- PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
 CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Walter BenjaminIl teologo dell’economia
L’attualità straordinaria di un pensatore che indicò nel capitalismo la religione della nostra epoca
Un culto basato sull’indebitamento generale che non conosce tregua né perdono e cancella la differenza tra il giorno e la notte
Tra i suoi sacerdoti c’è anche Marx, il cui socialismo ne è in fondo l’erede diretto
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 24.01.2016)
È la stella polare della filosofia continentale. Ne traccia la rotta, ne indica la tendenza, la orienta. Da tempo ormai fa quasi ombra a Heidegger e a Wittgenstein. Come se lui, il figlio ribelle, il lucido sognatore, il filosofo malinconico, il critico spietato della modernità, il profeta rivoluzionario che, come un nuovo Isaia, aveva scelto di osservare il mondo dalla soglia del giudizio ultimo, trovasse un riscatto postumo a più di settant’anni dalla morte. Occhiali spessi, sguardo penetrante, espressione interrogativa: non c’è quasi dipartimento di Filosofia, dall’Argentina agli Stati Uniti, dalla Corea, al Giappone, all’Australia, in cui non si stagli la sua foto. Ben riconoscibile, è lui: Walter Benjamin.
La sua immagine è assurta a simbolo di un pensiero che resiste, che non si lascia soffocare nella vuota analitica, né rinchiudere negli steccati di una innocua ricostruzione storica, che non si adatta a diventare normativo, né tanto meno si piega a elogiare le fantomatiche libertà del progresso. Ecco perché nel nome di Benjamin si legge la promessa di una filosofia capace di essere filologicamente rigorosa e, al tempo stesso, aperta alla sperimentazione, in grado di descrivere i particolari apparentemente più irrilevanti, senza per questo rinunciare alle visioni ampie e ardite.
Ha contribuito al riscatto postumo di Benjamin l’uscita dei suoi scritti presso l’editore tedesco Suhrkamp. In Italia la pubblicazione delle Opere complete, avviata da Einaudi nel 2001, si è conclusa nel 2014. La disponibilità degli scritti di Benjamin, tradotti ormai in molte lingue, spiega l’aumento drastico degli studi, il profluvio di monografie, articoli, saggi critici. Il che, peraltro, non vuol dire che non vi siano motivi da scoprire. E in genere la ricerca, in fondo frammentaria, dovrà ancora trovare i nessi segreti che tengono insieme una filosofia più complessa di quanto si immagini, i legami, talvolta sfuggenti, tra i suoi molteplici aspetti. Risponde già a questa esigenza Walter Benjamin. Una biografia critica, di Howard Eiland e Michael W. Jennings (Einaudi).
Ma che cosa rende Benjamin così attuale nella sua dirompente inattualità? Perché i suoi scritti, talvolta brevi frammenti, aneddoti autobiografici, lettere, serbano un potenziale esplosivo? Al punto da indirizzare perfino la riflessione contemporanea? Certo, contribuisce il suo straordinario stile, la prosa costellata di immagini seducenti. Prediligendo i «passaggi», Benjamin ha dischiuso alla filosofia ambiti inconsueti: dai nuovi mezzi di comunicazione al cinema, dalla fotografia ai movimenti di avanguardia, dalla vita nevrotica nella metropoli all’esistenza degli esclusi, dalla letteratura per l’infanzia ai giocattoli, dal gioco d’azzardo all’esperienza dell’hashish, al viaggio. Quel che emerge, però, sempre più chiaramente, è che Benjamin, già molto presto, ha presagito gli esiti del capitalismo, ne ha scrutato i segreti, gli arcana reconditi.
Che un giorno la politica, scaduta a mera amministrazione, esercizio di governance , si sarebbe dissolta nell’economia, è un pensiero che Benjamin condivide con altri filosofi. Ma lui osa un passo ulteriore: quella forma economica, divenuta globale, si sarebbe rivelata per quello è: una religione. Non è forse il capitalismo una religione del debito?
Benjamin è stato il primo grande teologo dell’economia nella modernità. Non ha colto solo i legami strutturali fra teologia e politica, indagati negli stessi anni anche da Carl Schmitt. Né si è limitato a ricostruire la provenienza religiosa del capitalismo. Qui si misura, anzi, la sua distanza da Max Weber, che nel capitalismo aveva indicato l’esito dell’etica protestante.
Per Benjamin le cose stanno diversamente: il capitalismo non è una religione secolarizzata, bensì una religione in senso stretto. Perciò non se ne comprenderebbe la portata, il ruolo e il funzionamento, se non lo si considerasse come un fenomeno religioso. Questa è la tesi delineata nel suo ormai celebre frammento del 1921 Capitalismo come religione, la cui riscoperta ha dato avvio, negli ultimi anni, a una nuova riflessione sulla teologia economica. A prendervi parte sono filosofi non di rado anche distanti fra loro, da Peter Sloterdijk a Giorgio Agamben, da Slavoj Žižek a Thomas Macho, da Norbert Bolz a Roberto Esposito - per ricordarne solo alcuni. Il che conferma l’intuizione di Benjamin, che sembra assumere oggi ulteriore validità.
Esistono alternative? Non appare forse il capitalismo il nostro orizzonte ultimo e insuperabile? Questa società crede nel capitalismo, lo accetta come proprio ineluttabile destino. E come nel passato si pregavano gli dei, se ne indagava l’umore, se ne temeva il volere, così oggi una società dichiaratamente illuminata e secolare è pronta a offrire ogni sorta di sacrifici alle imponderabili potenze del mercato.
«Il capitalismo - scrive Benjamin nel suo testo sibillino - è una pura religione di culto, forse la più estrema che sia mai stata data», dove il culto, che non sa né di teologia né di dogmatica, può contare su una «durata permanente». Non c’è tregua né perdono. La pompa sacrale del marketing, il rito del guadagno, il fasto del consumo, sono inarrestabili. Non si distingue più tra il giorno e la notte là dove il tempo è sempre e solo denaro. Il capitalismo è così un culto che ha annullato persino la settimana, perché richiede una celebrazione ossessiva. Apparentemente è sempre festa - e invece non lo è mai. Se il culto è ininterrotto, è grazie all’apoteosi del debito, Schuld, che nella sua «demoniaca ambiguità» in tedesco significa anche colpa. «Il capitalismo è presumibilmente il primo caso di un culto che non lascia espiare, ma colpevolizza indebitando».
Se Marx aveva visto nel debito pubblico il sigillo dell’era capitalistica, e in fondo il suo terribile lascito ai popoli, Benjamin presagisce l’indebitamento planetario. Non potrebbe essere diversamente per una religione, come il capitalismo, che non permette salvezza né redenzione. Sotto il cielo del capitale resta solo «disperazione cosmica». Perfino Dio sembra venir implicato nel gorgo di questa colpa, nella rovina di questo debito.
Pur evitando una «smisurata polemica universale», Benjamin punta l’indice contro il cristianesimo che si è mutato nei secoli, convertendosi in capitalismo. Ha ceduto cioè al paganesimo, quella tentazione che da sempre lo affligge - e Benjamin avvicina le icone delle banconote alle immagini sacre. Il capitalismo, questo nuovo paganesimo, è l’ordine in cui si stagliano fato e sventura nella circolarità violenta e ripetitiva del mito. Come interromperla?
Nietzsche, Freud, lo stesso Marx appaiono agli occhi di Benjamin i «gran sacerdoti» del culto capitalista, perché le loro teorie sono il prodotto di un potenziamento del capitalismo - non ne costituiscono la rottura. Il socialismo di Marx non è che l’erede diretto del capitalismo. È un socialismo che non conosce Umkehr, che non sa di «inversione», né di rivolta né di rivoluzione, e prosegue lungo il tragitto rettilineo truccato da progresso.
Ma Umkehr è la traduzione tedesca dell’ebraico teshuvà, ritorno - un tornare indietro per andare avanti, una con-versione che è una inversione di rotta, una interruzione. Marx, quel nipote di un rabbino, sembrava averlo dimenticato. E così Benjamin guarda a Gustav Landauer, l’ebreo anarchico, protagonista della Repubblica dei Consigli di Monaco, che aveva scritto: Sozialismus ist Umkehr , il socialismo è inversione, è cambiamento che spezza il «sempreuguale» della storia.
La polemica di Benjamin investe la socialdemocrazia, questa idolatria della modernizzazione, questa cattiva politica incapace - scrive in Strada a senso unico - di darsi scadenze. Nel suo afflato escatologico Benjamin guarda invece al limite estremo, lì dove si consumerà l’apocalissi ultima del capitalismo. Che sia sul modello dello «sciopero generale» di Sorel, o meglio, su quello dell’interruzione anarchica che si impone nel Giubileo ebraico, la rivoluzione va ripensata.
Marx aveva detto che le rivoluzioni sono le «locomotive» della storia. A questa celebre immagine Benjamin oppone nelle sue Tesi sul concetto di storia , scritte nel 1940, una figura speculare. «Forse le rivoluzioni sono il freno d’emergenza azionato dal genere umano che viaggia sul treno». La rivoluzione è una fenditura nella storia, è arresto, cesura, interruzione nel permanere dell’insopportabile, nell’eterno ritorno della catastrofe. Si comprende allora la prossimità di questo «outsider di sinistra» - così Benjamin amava definirsi - alla fronda anarchica.
Come per Landauer, anche per Benjamin la «rivoluzione» non è solo un concetto politico. D’altronde la filigrana dei suoi scritti è un vocabolario teologico, il filo rosso è il messianismo ebraico. Perciò la rivoluzione non riguarda una salvezza dell’anima nell’aldilà, ma la liberazione nella giustizia sociale adesso, jetzt . Quanto al Messia, Benjamin non ha mai dimenticato quell’antico detto rabbinico: «Quando verrà, cambierà nello stato del mondo solo qualcosa di impercettibile, non lo trasformerà con la violenza, ma lo aggiusterà solo di pochissimo».
Il capitalismo, nella sua sacralità, appare non profanabile. Tentare, malgrado ciò, una profanazione? Non è la via d’uscita a cui pensa Benjamin. Non si deve infatti fraintendere: la critica al capitalismo non è una critica alla religione. E la sua teologia, che per quanto eretica resta teologia, attira sempre più l’attenzione degli interpreti per la sua portata sovversiva - come mostrano gli studi più recenti.
L’ateismo di massa si riduce per Benjamin alla ripetizione del culto capitalista, agevolato dalla perdita di ogni contenuto utopico. In tal senso questo «teologo trasferito in campo profano», come l’ha chiamato Scholem, è tra i primi a mettere sotto accusa il vuoto progresso che non distingue tra una migliore riproduzione della vita e una vita realizzata. Il capitalismo è fra l’altro il culto di una emancipazione infelice. Così, accanto al benessere e alla libertà, Benjamin rivendica la felicità.
*
Il personaggio
Filosofo e critico letterario, l’ebreo tedesco Walter Benjamin (1892-1940) è una delle figure intellettuali più originali del Novecento. Esule a Parigi dopo l’avvento al potere di Hitler, si uccise in seguito all’invasione della Francia, temendo di cadere nelle mani dei nazisti
Bibliografia
L’editore Einaudi ha pubblicato tra il 2001 e il 2014 le Opere complete di Walter Benjamin in otto volumi, a cura di Hermann Schweppenhäuser, Hellmut Riediger, Enrico Ganni, Rolf Tiedemann. Nel 2015 è uscito, sempre da Einaudi, il libro di Howard Eiland e Michael W. Jennings Walter Benjamin. Una biografia critica (traduzione di Alvise La Rocca, pp. 695, e 90). Da segnalare anche il volume di Uwe-Karsten Heye I Benjamin. Una famiglia tedesca (traduzione di Margherita Carbonaro, Sellerio, pp. 333, e 18). In Francia è uscito l’anno scorso il saggio di Stéphane Mosès Walter Benjamin et l’esprit de la modernité (Éditions du Cerf), mentre quest’anno uscirà negli Stati Uniti il volume Walter Benjamin and Theology , a cura di Colby Dickinson e Stéphane Symons (Fordham University Press)
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX, E --- «Il nano e il manichino. La teologia come lingua della politica» di Mario Tronti. .16 gennaio 2016, di Federico La Sala
Mario Tronti.
Una battaglia «messianica»
«Il nano e il manichino. La teologia come lingua della politica» di Mario Tronti. Un pamphlet che raccoglie quattro lezioni tenute a Napoli, ragionando su Schmitt, Benjamin e Edgar Allan Poe
di Francesco Marchianò (il manifesto, 15.01.2016)
Cambiare il corso della Storia: istruzioni per l’uso. Potrebbe chiamarsi così un recente pamphlet di Mario Tronti pubblicato da Castelvecchi che raccoglie quattro sue lezioni tenute presso l’Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli nel marzo del 2010. Certo, un titolo del genere suonerebbe oltremodo ambizioso e presuntuoso, specialmente per un volume di poche pagine, eppure è al fondo questo l’obiettivo politico e intellettuale insieme di questo lavoro (Il nano e il manichino. La teologia come lingua della politica, Castelvecchi, pp. 60, euro 7,50).
L’interrogativo, va da sé, è come riuscire a cambiare la Storia, con quali strumenti, con quali modalità. Perché ciò accada, occorre qualcosa che vada di traverso al meccanismo negli avvenimenti e ne modifichi il corso. Ci vuole, cioè, la politica che per Tronti «è un comportamento di pensiero e di azione scorretto rispetto alla Storia: perché si contrappone ad essa, non accetta il suo corso e si propone di deviarlo». Il problema è che oggi si assiste a una forte crisi della politica, o per lo meno di come si è sviluppata lungo tutto il corso del novecento, e per scrutare meglio questa crisi e risolverla è necessario l’apporto che viene dalla teologia politica, «indispensabile strumento ermeneutico del Novecento», sia come metodo per interpretare il potere, sia come strumento per rovesciarlo.
Al centro di questo ragionamento ci sono tre autori, Carl Schmitt, coniatore della teologia politica (al quale sono dedicate due lezione), Walter Benjamin e Jacon Taubes. I loro contributi sul tema sono intrecciati da Mario Tronti secondo uno schema ben preciso che partendo dall’alto, cioè dalla teoria schmittiana, che esalta il sovrano decisore e individua il potere come ordine, arriva alla teologia politica dal basso, vista come strumento delle classi dominate per liberarsi dal potere dei dominanti.
Il passaggio teorico più importante è particolarmente influenzato dal Benjamin delle Tesi sul concetto di storia. E non ha caso è proprio dalla prima tesi di Benjamin che Tronti prende spunto per il titolo al volumetto, quando, ispirato da un racconto di Edgar Allan Poe, il pensatore tedesco parla di un automa che giocava a scacchi e aveva sempre la mossa giusta perché al suo interno si celava un nano gobbo (la teologia) che ne manovrava il funzionamento.
Tronti, che è stato tra i primi in Italia a leggere da sinistra Schmitt, ne sintetizza il pensiero recuperando, come fa il giurista tedesco, la lezione di De Maistre e ancor più Donoso Cortés. La sua preoccupazione principale di fronte alla politica attuale è la stessa che aveva Schmitt nei primi decenni del Novecento. Allora, con parole quasi profetiche, Schmitt registrava la spoliticizzazione della politica a causa dell’imporsi del pensiero tecnico-economico. Oggi, la globalizzazione dei mercati, la finanziarizzazione dell’economia, la vittoria del tecnico sul politico, ben sintetizzata dall’ideologia dell’austerity, ripropongono le stesse problematiche e la stessa esigenza della politica per risolvere la crisi.
Allora, di fronte all’impotenza della Repubblica di Weimar, la soluzione fu trovata nel grande decisore che Schmitt vide, per alcuni anni, nel partito nazista. Oggi, invece, per Tronti, la soluzione va trovata altrove e certamente non è sufficiente per la sua ricerca il materialismo storico che, fondato anch’esso sull’importanza dell’economico, resta all’interno dell’ordine costituito. Qui gli viene in aiuto Benjamin con la sua visione messianica della Storia nella quale si apre la prospettiva di una vittoria per gli oppressi. L’avvento del Messia, infatti, è un elemento esterno alla Storia che ne scompagina le carte, che non appartiene a essa, non è un suo fine, semmai ne determina la fine.
Il Messia ha il compito di redimere chi è oppresso e, facendo ciò, «disordina l’ordine degli oppressori». Per riuscire in questa impresa, però, deve portare a termine un altro obiettivo: sconfiggere l’Anticristo, cioè l’ordine costituito. Per questa ragione il messianico porta con sé sempre l’elemento della lotta ed è, in quest’ottica, una componente rivoluzionaria. Volendo, con prudenza, semplificare si potrebbe dire che una rivoluzione che modifichi il corso degli eventi non si fa da sé, per ragioni storiche, ma solo se interviene qualcosa di esterno a compiere e guidare il mutamento.
Nelle pagine finali del libro compare la teologia di Paolo di Tarso interpretata da Taubes che per Tronti va collocato tra Schmitt e Benjamin. La lezione che viene tratta è la seguente: «nell’attualità nemica, nel qui e ora, tutto in mano agli oppressori, nel processo oggettivo della Storia che accompagna e conferma l’oppressione, è necessario andare a trovare quel “volto interno”, quel nocciolo irriducibile che testimonia, cioè che salva, la libertà dei figli di Dio». Questa è la lezione declinata in senso paolino. In senso politico, invece, ciò si traduce in una possibilità rivoluzionaria che elimini l’oppressione e porti a compimento «il progetto antico della liberazione».
Pur nella sua brevità, Il nano e il manchino è un testo che richiede una buona dose di impegno da parte del lettore. L’ampio spazio dato agli autori trattati, dei quali sono citati molti brani, non impedisce di cogliere l’originalità trontiana del volume nel quale la teologia politica è seguita come un’ombra dal tema dell’autonomia del politico. Entrambe non dipendenti dalle leggi della Storia e anzi orientate alla lotta contro di essa.
-
> LA TEOLOGIA DI "MAMMONA", LA LEZIONE DI MARX, E IL MESSAGGIO EVANGELICO ---- Gli stretti legami che uniscono il Vaticano agli affari italiani. Intervista a Manlio Graziano.13 giugno 2012, di Federico La Sala
«La gerarchia italiana fa fatica ad abituarsi all’internazionalizzazione della Chiesa»
intervista a Manlio Graziano*,
 a cura di Isabelle de Gaulmyn
a cura di Isabelle de Gaulmyn in “La Croix” del 13 giugno 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)
in “La Croix” del 13 giugno 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)Questi scandali mostrano gli stretti legami che uniscono ancora il Vaticano agli affari italiani. Come spiegare questo legame?
Innanzitutto con la storia. La Chiesa cattolica ha esercitato per un millennio il suo potere temporale su una grande parte del territorio della penisola e, anche al di fuori dello Stato pontificio, il clero è stato per moltissimo tempo il più importante proprietario fondiario (del resto, non solo in Italia).
 Tale posizione ha necessariamente lasciato delle tracce, ma in Italia più che altrove, perché, fin dalla sua nascita, lo Stato italiano ha sempre tenuto in considerazione gli interessi della Chiesa. Nella memoria dei responsabili politici italiani, infatti, la mobilitazione organizzata dalla Chiesa, che aveva provocato la caduta della Repubblica napoletana del 1799, è rimasta un ricordo indelebile.
Tale posizione ha necessariamente lasciato delle tracce, ma in Italia più che altrove, perché, fin dalla sua nascita, lo Stato italiano ha sempre tenuto in considerazione gli interessi della Chiesa. Nella memoria dei responsabili politici italiani, infatti, la mobilitazione organizzata dalla Chiesa, che aveva provocato la caduta della Repubblica napoletana del 1799, è rimasta un ricordo indelebile.
 Al momento della presa di Roma, la prima decisione del governo italiano è quindi stata di esentare l’antico Stato pontificio, per un periodo di due anni, dall’applicazione delle leggi di soppressione dei benefici ecclesiastici, e la seconda di votare delle leggi di garanzia (le guarentigie) a favore della persona e dei beni del papa e del Vaticano.
Al momento della presa di Roma, la prima decisione del governo italiano è quindi stata di esentare l’antico Stato pontificio, per un periodo di due anni, dall’applicazione delle leggi di soppressione dei benefici ecclesiastici, e la seconda di votare delle leggi di garanzia (le guarentigie) a favore della persona e dei beni del papa e del Vaticano.
 Durante la sospensione delle leggi dette “anticlericali” a Roma, fu il clero stesso che alienò gran parte delle sue proprietà fondiarie e fece nascere un grande impero finanziario (che in Italia viene chiamato “le banche cattoliche”), che da allora è uno dei protagonisti, di cui non si può non tener conto, della vita economica (e quindi politica) del paese. Ma non tutte le proprietà in mano al clero sono state alienate o espropriate in seguito. Secondo diverse fonti, la Chiesa conserverebbe oggi ancora un controllo diretto o indiretto sul 20-25% del patrimonio immobiliare italiana, e gli accordi del Laterano del 1929 lo autorizzavano a non pagare imposte su tali proprietà.
Durante la sospensione delle leggi dette “anticlericali” a Roma, fu il clero stesso che alienò gran parte delle sue proprietà fondiarie e fece nascere un grande impero finanziario (che in Italia viene chiamato “le banche cattoliche”), che da allora è uno dei protagonisti, di cui non si può non tener conto, della vita economica (e quindi politica) del paese. Ma non tutte le proprietà in mano al clero sono state alienate o espropriate in seguito. Secondo diverse fonti, la Chiesa conserverebbe oggi ancora un controllo diretto o indiretto sul 20-25% del patrimonio immobiliare italiana, e gli accordi del Laterano del 1929 lo autorizzavano a non pagare imposte su tali proprietà.Gli italiani della Santa Sede conservano uno stretto legame con quanto succede nella Chiesa italiana?
Per rispondere a questa domanda, bisogna fare una distinzione tra i cittadini della Repubblica italiana che lavorano per una delle istituzioni della Città del Vaticano, e i vescovi e i cardinali italiani che lavorano nel governo centrale della Chiesa universale. Questi ultimi mantengono certo un legame molto forte con la Chiesa della penisola, e molti di loro fanno ancora fatica ad abituarsi all’internazionalizzazione della Chiesa di Roma. È comunque certo che l’Italia resta il pilastro su cui si basa la Chiesa universale. Questo autorizza una parte della gerarchia di origine italiana a mantenere una certa ambiguità, arrivando a volte perfino a pensare che il governo della Chiesa universale le spetti di diritto. Ora, dal 1978, la direzione centrale della Chiesa è affidata ad un nonitaliano, e oggi sappiamo che una delle ragioni dell’elezione di Karol Wojtyla fu proprio la volontà di sottrarre la Chiesa universale ai conflitti che dividevano i cardinali italiani.
Quali sono le poste in gioco, per la Chiesa italiana, di questa prossimità col Vaticano?
Come ho appena detto, la Chiesa italiana, in generale, si sovrastima. La vicinanza ai sacri palazzi, il suo ruolo storicamente decisivo, l’obiettiva importanza della penisola come “laboratorio” nel quale le scelte del papa e della gerarchia sono sperimentate, e il fatto di rappresentare un “polmone” per l’amministrazione e per il governo della Santa Sede: tutto questo dà ai responsabili della Chiesa italiana la sensazione di potersi in qualche modo “sottrarre” alle regole di funzionamento che sono imposte a tutte le altre Chiese nazionali in nome della centralizzazione della Chiesa universale.
* insegnante di geopolitica e di geopolitica delle religioni alla Sorbona Parigi IV e all’American Graduate School di Parigi, autore di Identité catholique et identité italienne. L’Italie laboratoire de l’Église (Parigi, 2007) et Il secolo cattolico. La strategia geopolitica della Chiesa (Roma, 2010)