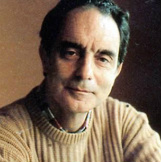
L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE
LA COSCIENZA A POSTO
(Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti)
di Italo Calvino*
C’era un paese che si reggeva sull’illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati (ne aveva bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi non si è più capaci di concepire la vita in altro modo) e questi mezzi si potevano avere solo illecitamente, cioè chiedendoli a chi li aveva in cambio di favori illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori, in genere già aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza; per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di una sua autonomia.
Nel finanziarsi per via illecita, ogni centro di potere non era sfiorato da alcun senso di colpa, perché per la propria morale interna, ciò che era fatto nell’interesse del gruppo era lecito, anzi benemerito, in quanto ogni gruppo identificava il proprio potere col bene comune; l’illegalità formale, quindi, non escludeva una superiore legalità sostanziale.
Vero è che in ogni transazione illecita a favore di entità collettive è usanza che una quota parte resti in mano di singoli individui, come equa ricompensa delle indispensabili prestazioni di procacciamento e mediazione: quindi l’illecito che, per la morale interna del gruppo era lecito, portava con sé una frangia di illecito anche per quella morale.
Ma a guardar bene, il privato che si trovava ad intascare la sua tangente individuale sulla tangente collettiva, era sicuro di aver fatto agire il proprio tornaconto individuale in favore del tornaconto collettivo, cioè poteva, senza ipocrisia, convincersi che la sua condotta era non solo lecita ma benemerita.
Il paese aveva nello stesso tempo anche un dispendioso bilancio ufficiale, alimentato dalle imposte su ogni attività lecita e finanziava lecitamente tutti coloro che lecitamente o illecitamente riuscivano a farsi finanziare. Poiché in quel paese nessuno era disposto non diciamo a fare bancarotta, ma neppure a rimetterci di suo (e non si vede in nome di che cosa si sarebbe potuto pretendere che qualcuno ci rimettesse), la finanza pubblica serviva ad integrare lecitamente in nome del bene comune i disavanzi delle attività che sempre in nome del bene comune si erano distinte per via illecita.
La riscossione delle tasse, che in altre epoche e civiltà poteva ambire di far leva sul dovere civico, qui ritornava alla sua schietta sostanza di atto di forza (così come in certe località all’esazione da parte dello Stato si aggiungeva quella di organizzazioni gangsteristiche o mafiose), atto di forza cui il contribuente sottostava per evitare guai maggiori, pur provando anziché il sollievo del dovere compiuto, la sensazione sgradevole di una complicità passiva con la cattiva amministrazione della cosa pubblica e con il privilegio delle attività illecite, normalmente esentate da ogni imposta.
Di tanto in tanto, quando meno ce lo si aspettava, un tribunale decideva di applicare le leggi, provocando piccoli terremoti in qualche centro di potere e anche arresti di persone che avevano avuto fino ad allora le loro ragioni per considerarsi impunibili.
In quei casi il sentimento dominante, anziché di soddisfazione per la rivincita della giustizia, era il sospetto che si trattasse di un regolamento di conti di un centro di potere contro un altro centro di potere. Così che era difficile stabilire se le leggi fossero usabili ormai soltanto come armi tattiche e strategiche nelle guerre tra interessi illeciti oppure se i tribunali per legittimare i loro compiti istituzionali dovessero accreditare l’idea che anche loro erano dei centri di potere e di interessi illeciti come tutti gli altri.
Naturalmente, una tale situazione era propizia anche per le associazioni a delinquere di tipo tradizionale, che coi sequestri di persona e gli svaligiamenti di banche si inserivano come un elemento di imprevedibilità nella giostra dei miliardi, facendone deviare il flusso verso percorsi sotterranei, da cui prima o poi certo riemergevano in mille forme inaspettate di finanza lecita o illecita.
In opposizione al sistema guadagnavano terreno le organizzazioni del terrore che usavano quegli stessi metodi di finanziamento della tradizione fuorilegge e con un ben dosato stillicidio d’ammazzamenti distribuiti tra tutte le categorie di cittadini illustri e oscuri si proponevano come l’unica alternativa globale del sistema. Ma il loro effetto sul sistema era quello di rafforzarlo fino a diventarne il puntello indispensabile e ne confermavano la convinzione di essere il migliore sistema possibile e di non dover cambiare in nulla.
Cosi tutte le forme di illecito, da quelle più sornione a quelle più feroci, si saldavano in un sistema che aveva una sua stabilità e compattezza e coerenza e nel quale moltissime persone potevano trovare il loro vantaggio pratico senza perdere il vantaggio morale di sentirsi con la coscienza a posto. Avrebbero potuto, dunque, dirsi unanimemente felici gli abitanti di quel paese se non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire: gli onesti.
Erano, costoro, onesti, non per qualche speciale ragione (non potevano richiamarsi a grandi principi, né patriottici, né sociali, né religiosi, che non avevano più corso); erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso, insomma non potevano farci niente se erano così, se le cose che stavano loro a cuore non erano direttamente valutabili in denaro, se la loro testa funzionava sempre in base a quei vieti meccanismi che collegano il guadagno al lavoro, la stima al merito, la soddisfazione propria alla soddisfazione di altra persone.
In quel paese di gente che si sentiva sempre con la coscienza a posto, gli onesti erano i soli a farsi sempre gli scrupoli, a chiedersi ogni momento che cosa avrebbero dovuto fare. Sapevano che fare la morale agli altri, indignarsi, predicare la virtù sono cose che riscuotono troppo facilmente l’approvazione di tutti, in buona o in mala fede. Il potere non lo trovavano abbastanza interessante per sognarlo per sé (o almeno quel potere che interessava agli altri), non si facevano illusioni che in altri paesi non ci fossero le stesse magagne, anche se tenute più nascoste; in una società migliore non speravano perché sapevano che il peggio è sempre più probabile.
Dovevano rassegnarsi all’estinzione? No, la loro consolazione era pensare che, così come in margine a tutte le società durate millenni s’era perpetuata una controsocietà di malandrini, tagliaborse, ladruncoli e gabbamondo, una controsocietà che non aveva mai avuto nessuna pretesa di diventare “la” società, ma solo di sopravvivere nelle pieghe della società dominante ed affermare il proprio modo di esistere a dispetto dei principi consacrati, e per questo aveva dato di sé (almeno se vista non troppo da vicino) un’immagine libera, allegra e vitale, così la controsocietà degli onesti forse sarebbe riuscita a persistere ancora per secoli, in margine al costume corrente, senza altra pretesa che di vivere la propria diversità, di sentirsi dissimile da tutto il resto, e a questo modo magari avrebbe finito per significare qualcosa di essenziale per tutti, per essere immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è stato ancora detto e ancora non sappiamo cos’è.
Questo testo è apparso per la prima volta su “la Repubblica” il 15 marzo 1980, ma appare negli appunti dell’archivio Calvino con il titolo “La coscienza a posto”. È stato ripubblicato in “Romanzi e racconti” (Meridiani Mondadori, 1994, vol. 3, pp. 290-293) come “La coscienza a posto (Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti)”. Ringraziamo Ester Singer Calvino per averci permesso di riproporlo.
*Lo Straniero*, numero 72, giugno 2006: www.lostraniero.net
- ARMONIA ERACLITEA ("FESTINA LENTE"): LEZIONI AMERICANE
OMERO, ULISSE, E CALVINO: "IO HO ASCOLTATO IL CANTO DELLE SIRENE" ("LIVELLI DI REALTà" - Firenze, 1978 - MILANO, FELTRINELLI, 1984):
"[...] Ma quello che il testo dell’Odissea ci dice sul canto delle Sirene è che le Sirene dicono che stanno cantando e che vogliono essere ascoltate, è che il loro canto è
quanto di meglio possa essere cantato. L’esperienza ultima di cui il racconto di
Ulisse vuol rendere conto è un’esperienza lirica, musicale, ai confini dell’ineffabile.
 Una delle più belle pagine di Maurice Blanchot interpreta il canto delle Sirene come
un al di là dell’espressione da cui Ulisse, dopo averne sperimentato l’ineffabilità, si
ritrae, ripiegando dal canto al racconto sul canto.
Una delle più belle pagine di Maurice Blanchot interpreta il canto delle Sirene come
un al di là dell’espressione da cui Ulisse, dopo averne sperimentato l’ineffabilità, si
ritrae, ripiegando dal canto al racconto sul canto.
 Se, per verificare la mia formula,
mi sono servito finora di esemplificazioni narrative, scegliendo tra i classici in versi
o in prosa o in forma teatrale ma sempre con una storia da raccontare, ecco che
ora, giunto al canto delle Sirene, dovrei ripercorrere tutto il mio discorso per verificare se esso, come io credo, possa adattarsi punto per punto alla poesia lirica, e
mettere in evidenza i vari livelli di realtà che l’operazione poetica attraversa.
Se, per verificare la mia formula,
mi sono servito finora di esemplificazioni narrative, scegliendo tra i classici in versi
o in prosa o in forma teatrale ma sempre con una storia da raccontare, ecco che
ora, giunto al canto delle Sirene, dovrei ripercorrere tutto il mio discorso per verificare se esso, come io credo, possa adattarsi punto per punto alla poesia lirica, e
mettere in evidenza i vari livelli di realtà che l’operazione poetica attraversa.
 Io
sono convinto che questa formula possa essere trascritta con adattamenti minimi
mettendo Mallarmé al posto di Omero. Una tale riformulazione forse ci permetterebbe d’inseguire il canto delle Sirene, l’estremo punto d’arrivo della scrittura, il
nucleo ultimo della parola poetica, e forse sulle tracce di Mallarmé arriveremmo
alla pagina bianca, al silenzio, all’assenza. Il tracciato che abbiamo seguito, i livelli
di realtà che la scrittura suscita, la successione di veli e di schermi forse s’allontana
all’infinito, forse s’affaccia sul nulla. Come abbiamo visto svanire l’io, il primo soggetto dello scrivere, così ce ne sfugge l’ultimo oggetto.
Io
sono convinto che questa formula possa essere trascritta con adattamenti minimi
mettendo Mallarmé al posto di Omero. Una tale riformulazione forse ci permetterebbe d’inseguire il canto delle Sirene, l’estremo punto d’arrivo della scrittura, il
nucleo ultimo della parola poetica, e forse sulle tracce di Mallarmé arriveremmo
alla pagina bianca, al silenzio, all’assenza. Il tracciato che abbiamo seguito, i livelli
di realtà che la scrittura suscita, la successione di veli e di schermi forse s’allontana
all’infinito, forse s’affaccia sul nulla. Come abbiamo visto svanire l’io, il primo soggetto dello scrivere, così ce ne sfugge l’ultimo oggetto.
 Forse è nel campo di tensione che si stabilisce tra un vuoto e un vuoto che la letteratura moltiplica gli spessori d’una realtà inesauribile di forme e di significati." (Calvino, 1978 - Saggi I, 1995, pp. 397-398).
Forse è nel campo di tensione che si stabilisce tra un vuoto e un vuoto che la letteratura moltiplica gli spessori d’una realtà inesauribile di forme e di significati." (Calvino, 1978 - Saggi I, 1995, pp. 397-398).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
 IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI.
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI.
"Il romanzo dei rapporti di forza"
 Atlas:
Atlas:
 Italo Calvino, “I promessi sposi”: il romanzo dei rapporti di forza", in Saggi 1945-1985,a c. di M. Barenghi, Mondadori, Milano, 1995.
Italo Calvino, “I promessi sposi”: il romanzo dei rapporti di forza", in Saggi 1945-1985,a c. di M. Barenghi, Mondadori, Milano, 1995.
FLS
Forum
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). --- "COSMICOMICHE" E "LIVELLI DI REALTÀ". Tiresia, il caduceo di Ermes, il segnavia dei "destini incrociati", la via per uscire dall’inferno epistemologico.24 dicembre 2023, di Federico La Sala
#COSMICOMICHE (#CALVINO100):
LA #QUESTIONE DELLA FINE DELLE "EQUE #NOZZE" DEI #SERPENTI, LA #CECITA’ DI #TIRESIA, E L’INIZIO DELLA #TRAGEDIA.
Il #caduceo di #Ermes, il #segnavia dei "destini incrociati", la via per uscire dall’#inferno epistemologico (antropologico e cosmologico).
- Un omaggio alla #memoria di #DanteAlighieri, di "Sigismondo di Vindobona" (#SigmundFreud) e di "#Santiago" (#ItaloCalvino)
"Vi era, a Tebe, l’indovino Tiresia figlio di Evere e della ninfa Cariclo, della stirpe di Udeo, uno degli Sparti. Era cieco: della sua cecità e della sua arte profetica si danno versioni diverse. Alcuni dicono che fu accecato dagli dèi perché rivelava agli uomini cose che essi volevano tenere segrete. Ferecide afferma che fu accecato da Atena; Cariclo era molto cara ad Atena ...
 (Tiresia) vide la dea completamente nuda ed essa gli mise le mani sugli occhi e lo rese cieco. Cariclo la supplicò di restituire la vista a Tiresia, ma la dea non aveva il potere di farlo: allora gli purificò le orecchie in modo che potesse intendere il linguaggio degli uccelli e gli fece dono di un bastone di legno di corniolo, con l’aiuto del quale poteva camminare come coloro che vedevano.
(Tiresia) vide la dea completamente nuda ed essa gli mise le mani sugli occhi e lo rese cieco. Cariclo la supplicò di restituire la vista a Tiresia, ma la dea non aveva il potere di farlo: allora gli purificò le orecchie in modo che potesse intendere il linguaggio degli uccelli e gli fece dono di un bastone di legno di corniolo, con l’aiuto del quale poteva camminare come coloro che vedevano.
 Esiodo invece narra che, nei pressi del monte Cillene, Tiresia vide dei serpenti che si accoppiavano, li ferì e, da uomo, fu mutato in donna; poi di nuovo spiò gli stessi serpenti in amore e ridivenne uomo. Per questo #Era e #Zeus, che discutevano se nei rapporti amorosi provassero maggior piacere le donne oppure gli uomini, interrogarono lui. Egli disse che, se nell’amore la somma del godimento era uguale a diciannove parti, nove spettavano all’uomo, dieci alla donna. Per questo Era lo accecò e Zeus gli fece dono dell’arte mantica."
Esiodo invece narra che, nei pressi del monte Cillene, Tiresia vide dei serpenti che si accoppiavano, li ferì e, da uomo, fu mutato in donna; poi di nuovo spiò gli stessi serpenti in amore e ridivenne uomo. Per questo #Era e #Zeus, che discutevano se nei rapporti amorosi provassero maggior piacere le donne oppure gli uomini, interrogarono lui. Egli disse che, se nell’amore la somma del godimento era uguale a diciannove parti, nove spettavano all’uomo, dieci alla donna. Per questo Era lo accecò e Zeus gli fece dono dell’arte mantica."
 (#Apollodoro, Biblioteca III 6, 7: cfr. APOLLODORO, "I MITI GRECI", A CURA DI PAOLO SCARPI TRADUZIONE DI MARIA GRAZIA CIANI. FONDAZIONE LORENZO VALLA / ARNOLDO MONDADORI EDITORE).
(#Apollodoro, Biblioteca III 6, 7: cfr. APOLLODORO, "I MITI GRECI", A CURA DI PAOLO SCARPI TRADUZIONE DI MARIA GRAZIA CIANI. FONDAZIONE LORENZO VALLA / ARNOLDO MONDADORI EDITORE). -
> L’URLO DI ITALO CALVINO --- "SIDEREUS NUNCIUS" E "LEZIONI AMERICANE": LA SFIDA AL LABIRINTO PUO’ ESSERE VINTA E IL "SENNO DI ORLANDO" PUO’ ESSERE RECUPERATO..5 dicembre 2023, di Federico La Sala
CALVINO, LA SFIDA A INTERI MILLENNI DI LABIRINTO PUO’ ESSERE VINTA E IL "SENNO DI ORLANDO" (LUDOVICO ARIOSTO) PUO’ ESSERE RITROVATO.
- "Ed ecco: meraviglioso caso! /che ritornò la mente al primier uso;/e ne’ suoi bei discorsi l’intelletto/rivenne, più che mai lucido e netto ("Orlando Furioso", Canto XXXIX, 46-57).
COSMICOMICHE (#CALVINO100), ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E SORGERE DELLA TERRA (EARTHRISE):
Con "Leggerezza": "[...] la lentezza della coscienza umana a uscire dal parochialism antropocentrico può essere annullata in un istante dall’invenzione poetica. [...] Abituato come sono a considerare la letteratura come ricerca di conoscenza, per muovermi sul terreno esistenziale ho bisogno di considerarlo esteso all’antropologia, all’etnologia, alla mitologia. [...]
 Credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. E’ questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua" (Italo Calvino, "Lezioni americane").
Credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. E’ questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua" (Italo Calvino, "Lezioni americane").- Un omaggio a "Insula Europea": la condivisione dell’articolo di Giulio Pantalei sulla mostra su Calvino da lui curata (cfr. "Con Calvino, nel labirinto di Caracalla", 3 Dicembre 2023).
CIELOSTELLATO E MALINCONIA BAROCCA. COSMOLOGIA, RIVOLUZIONESCIENTIFICA E ARTISTICA, MA NON ANTROPOLOGICA: QUANDO L’ITALIA E L’EUROPA CADDERO IN UN VICOLO CIECO (1618-1648).
Una sollecitazione a ripensare la storiografia dei primi decenni del Seicento... *
- Un omaggio al lavoro di Maura Sgarro ("Colloqui con quattordici artisti del Seicento europeo", Kimerik 2023) e di Aurelio Musi ("Malinconia barocca", Neri Pozza 2023).
MEMORIA E STORIA: ELSHEIMER E RUBENS. "Adam Elsheimer (Francoforte sul Meno, 16 settembre 1578 - Roma, 11 dicembre 1610): [...] Secondo i biografi, Elsheimer, che lavorava molto lentamente e che lasciò pochissime opere (oggi se ne contano una trentina), morì perciò quasi in povertà. Una famosa lettera, piena di dolore, di #Rubens a Johann Faber che lo informava da Roma della scomparsa dell’amico, è forse il miglior tributo fatto a questo artista. Fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, dove nel 2010 è stata apposta una lapide-cenotafio con profilo in bronzo e l’iscrizione che ricorda tra l’altro: "Nel 1609 dipinse / il cielo stellato / osservandolo / con uno dei primi / telescopi". (https://it.wikipedia.org/wiki/Adam_Elsheimer...).
ARTE E SCIENZA: CIGOLI, GALILEO GALILEI, E LA LUNA. [...] Quella fra Galileo e il Cigoli è, semplicemente, l’amicizia di una vita. Ce ne resta la testimonianza attraverso 29 lettere di Cigoli a Galileo e solo due dello scienziato al pittore perché gli eredi dell’artista, con eccessivo zelo, ritennero di dover distruggere tutte le prove di un sodalizio compromettente dopo la condanna papale. [...] Cigoli si trasferisce da Firenze a Roma nel 1604; Galileo all’epoca è ancora a Padova. Tornerà a Firenze nel 1610. [...]
 Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...]
Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...]
 Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.
Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.
 Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "Galileo e Ludovico Cigoli: la Luna e le #macchiesolari fra scienza ed arte")
Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "Galileo e Ludovico Cigoli: la Luna e le #macchiesolari fra scienza ed arte")RAGIONE E FEDE: GALILEO E LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA: "(...) Il 25 febbraio 1616 il papa ordinò al cardinale Bellarmino di «convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione; e se si fosse rifiutato di obbedire, il Padre Commissario, davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla». Nello stesso anno il De revolutionibus di Copernico fu messo all’Indice donec corrigatur (fino a che non fosse corretto). Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane: forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell’illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. [...]" (cf. https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei ).
NOTE:
GALILEO E LA PITTURA. "[...] Galileo era appassionato di pittura e pittore dilettante. Era amico di tutti i maggiori pittori dell’epoca, tra i quali in particolare Ludovico Cigoli, con il quale tenne una nutrita corrispondenza e al quale aveva regalato un cannocchiale per osservare la Luna di cui il Cigoli doveva aver fatto un ottimo uso, come si deduce dalla rappresentazione della Madonna in Santa Maria Maggiore a Roma. Il Cigoli aveva rappresentato la Luna ai piedi della Santa Vergine così com’è vista al telescopio «con le divisioni merlate e le sue isolette». (cfr. Lamberto Maffei, "Il cervello artistico di Galileo Galilei", Il Sole-24 Ore, 10 aprile 2011).
OLTRE L’ORIZZONTE•ITALO CALVINO•SUPERLUNA•ARTE E LETTERATURA
 La Luna cancellata (di Stefano Sandrelli, Edu-Inaf, 18 Maggio 2021/ Aggiornato 10 Maggio 2023).
La Luna cancellata (di Stefano Sandrelli, Edu-Inaf, 18 Maggio 2021/ Aggiornato 10 Maggio 2023).FLS
-
>PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- LETTERATURA STORIA E COSMICOMICHE: LA FIABA DI UN PELLEGRINO "CHE FA LA CONCHIGLIA". Una nota a margine della mostra "Pavese incontra Calvino".24 novembre 2023, di Federico La Sala
LETTERATURA STORIA E "COSMICOMICHE":
UNA FIABA SUL FILO DELLA MEMORIA DEL MONDO DELLA PAROLA, A PARTIRE DA "JAGO", "SANT-JAGO", "SAN - GIACOMO","SANTIAGO DI COMPOSTELA" E "SANTIAGO DI LAS VEGAS".
- In memoria di Italo Calvino e di Cesare Pavese...
CONSIDERANDO CHE NEL Comune di Santo Stefano Belbo, nella chiesa dei SS. #Giacomo e #Cristoforo, sede della Biblioteca Civica e della Fondazione Cesare Pavese, è stata inaugurata (aperta al pubblico fino al 1 aprile 2024) "la #mostra di inediti, originali e prime edizioni PAVESE OSPITA CALVINO",
 FORSE, è bene avere presente anche la connessione simbolica con il #Cammino di #Santiago ("Sancti Jacobi", in spagnolo Sant-Jago), e con il fatto che Italo Calvino nacque il 15 ottobre 1923 a Santiago de las Vegas, a Cuba, e, ancora, che, durante la Resistenza, come combattente partigiano, scelse di chiamarsi "Santiago"
FORSE, è bene avere presente anche la connessione simbolica con il #Cammino di #Santiago ("Sancti Jacobi", in spagnolo Sant-Jago), e con il fatto che Italo Calvino nacque il 15 ottobre 1923 a Santiago de las Vegas, a Cuba, e, ancora, che, durante la Resistenza, come combattente partigiano, scelse di chiamarsi "Santiago"
 e, infine, che la brillante #biografia di Domenico Scarpa unificchi sorprendentemente, nel titolo stesso "Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore" (Hoepli Editore, 2023), la figura di un pellegrino che si reca con la sua conchiglia sul petto al "campo della stella", a Santiago di Compostela ("campus stellae"), a Santiago de las Vegas (dei "prati").
e, infine, che la brillante #biografia di Domenico Scarpa unificchi sorprendentemente, nel titolo stesso "Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore" (Hoepli Editore, 2023), la figura di un pellegrino che si reca con la sua conchiglia sul petto al "campo della stella", a Santiago di Compostela ("campus stellae"), a Santiago de las Vegas (dei "prati").Nota 1.
- STORIAELETTERATURA E COSTITUZIONE.
- Leggere "Le fiabe italiane": *
- "Quando, negli anni Cinquanta, finito il fascismo e fatta l’Italia bisognava rifare gli italiani, saldarli in un’unità politica e culturale che fosse ampia, giocosa, senz’altro libera, l’editore #GiulioEinaudi concordò con #ItaloCalvino la raccolta di duecento fiabe che, attingendo ai patrimoni regionali, andassero a costituire un solo serbatoio per tutti, dentro il quale chiunque potesse riconoscersi, dalle Alpi al Mediterraneo. Fu così che #Calvino visse per anni "in mezzo a boschi e palazzi incantati”, come lui stesso racconta, cercando le magie e gli archetipi che ritornavano di città in città, di paese in paese, unendo i fili rossi e lasciando emergere le caratteristiche brillanti, uniche e ancestrali che rendevano ogni storia meritevole di essere narrata in quella precisa versione e in nessun’altra. Una parte del suo lavoro si concentrava sui contenuti e una parte sulla lingua - sempre inscindibili gli uni dall’altra, perché i dialetti nei quali lo scrittore rinveniva le fiabe non si limitavano a colorirle ma li caratterizzavano nell’esistenza; bisognava allora tradurle senza impoverirle, tradurle senza snaturarle ma facendo sì che i bambini di tutte le regioni arrivassero a sentire un affratellamento di origine, non retorico, con i bambini delle altre regioni. [...]" *cfr. Nadia Terranova, "Doppiozero", 19 Ottobre 2023.
Nota 2
- LETTERATURA, MITO E RICERCA SCIENTIFICA.
- "GIORGIO DE SANTILLANA E LA NASCITA DELLA SCIENZA:
- [...] Nella rubrica “Osservatorio del signor Palomar”, sul “Corriere della sera”, del settembre del 1975, Calvino, attratto dall’idea di una #riconciliazione fra scienza moderna e sapienza antica, evocava “la forza mitica delle nuove immagini celesti”, riferendosi in particolare a una stella della costellazione del Cigno che ruota attorno a un buco nero.
 [...] se Cesare Pavese, l’amico suicida, guardava al mito in prospettiva sacrificale, Calvino ha appreso da Santillana e dall’antropologia di Lévi-Strauss la sua valenza cosmologica. La “vocazione mitopoietica” può consentire alla letteratura d’#incrociare le strutture mitiche dell’#uomoprimitivo e dell’#infanzia con le #congetture delle scienze contemporanee, dalle quali però è fuggita ogni speranza di cosmos. [...]"
* cfr. Mario Porro, Doppiozero, 21 Novembre 2023.
[...] se Cesare Pavese, l’amico suicida, guardava al mito in prospettiva sacrificale, Calvino ha appreso da Santillana e dall’antropologia di Lévi-Strauss la sua valenza cosmologica. La “vocazione mitopoietica” può consentire alla letteratura d’#incrociare le strutture mitiche dell’#uomoprimitivo e dell’#infanzia con le #congetture delle scienze contemporanee, dalle quali però è fuggita ogni speranza di cosmos. [...]"
* cfr. Mario Porro, Doppiozero, 21 Novembre 2023.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). --- USCIRE CON "RAPIDITA", DALL’INFERNO: "FESTINA LENTE ("Lezioni americane"), "NATI A FORMAR L’ANGELICA FARFALLA (Purg. X, 125).13 novembre 2023, di Federico La Sala
STORIA E LETTERATURA, TEOLOGIA-POLITICA, E MEMORIA DELLA TERRA PROMESSA, DEL PARADISO TERRESTRE:
WALTER BENJAMIN, LA MUSICA DEGLI ANGELI (E DELLE SIRENE), E LA METASTORIA "COSMICOMICA".
- In memoria di Walter Benjamin e di Italo Calvino
- Le "Tesi di #filosofia della #storia" (o Tesi "Sul concetto di storia") di W. Benjamin hanno una grande consonanza con l’opera di #DanteAlighieri, #MarcelProust, e #Michelangelo (e anche con la nuova-Polis, "Nea-Polis", #Napoli): sono un messaggio in #bottiglia, una #mappa per non perdersi nell’#oceano dello spazio-tempo dell’immane #catastrofe (#caduta) in avanzamento progressivo (#progresso) e andare "alla ricerca del tempo perduto" (#Proust)! #Benjamin, come #Ulisse e come #Calvino, sa della "memoria del mondo" (#ItaloCalvino) e ha ascoltato "il canto delle sirene" e degli #angeli, ed era più che fiducioso che il suo messaggio sarebbe stato r-accolto.
 (Federico La Sala)
(Federico La Sala)
MEMORIA COSMICOMICA DI ITALO CALVINO E DANTE ALIGHIERI. STORIA, LETTERATURA E ANTROPOLOGIA:
USCIRE DALLA CADUTA "COSMOLOGICA", DALL’ ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA, DALL’INFERNO (DIVINA COMMEDIA),
 CON RAPIDITA’ (ITALO CALVINO):
CON RAPIDITA’ (ITALO CALVINO):"FESTINA LENTE ("Lezioni americane"), "NATI A FORMAR L’ANGELICA FARFALLA (Purg. X, 125).
"O superbi cristian, miseri lassi,
 che, de la vista de la mente infermi,
che, de la vista de la mente infermi,
 fidanza avete ne’ retrosi passi,
fidanza avete ne’ retrosi passi,
 non v’accorgete voi che noi siam vermi
non v’accorgete voi che noi siam vermi
 nati a formar l’angelica farfalla,
nati a formar l’angelica farfalla,
 che vola a la giustizia sanza schermi?"
che vola a la giustizia sanza schermi?"
 (Dante Alighieri, Purg., 121-126).
(Dante Alighieri, Purg., 121-126).- P. S. - ITALO CALVINO, "Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio [...]
- 1. Leggerezza
 2. Rapidità
2. Rapidità
 3. Esattezza
3. Esattezza
 4. Visibilità
4. Visibilità
 5. Molteplicità
5. Molteplicità
 6. Coerenza (solo progettata)
6. Coerenza (solo progettata)
 [...]".
[...]".
-
>"L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" E "IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI": NOTE A MARGINE DELLA TRADIZIONE ICONOGRAFICA DEL BASTONE FIORITO DI SAN GIUSEPPE E DEL TEMA DELL’ANNUNCIAZIONE NELLA STORIA DELL’ARTE.11 novembre 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI ("INTERPRETAZIONE DEI SOGNI"), E LETTERATURA ("IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI").
DUE NOTE A MARGINE DELLA TRADIZIONE ICONOGRAFICA DEL BASTONE FIORITO DI SAN GIUSEPPE E DEL TEMA DELL’ANNUNCIAZIONE NELLA STORIA DELL’ARTE:
A. - LA STORIA DI UN’ANTICA MEMORIA CARMELITANA PROVENIENTE DAL SUSSEX...
"Bastone fiorito di San Giuseppe venerato a Napoli": [....] Sulla collina di San Potito a Napoli la Congregazione di San Giuseppe dei Nudi detiene una collezione di reliquie unica in Italia. Tra queste, la più importante si trova in un una bella teca di legno cedrino: il bastone fiorito appartenuto a san Giuseppe. Secondo la tradizione Giuseppe, come altri pretendenti (ciascuno munito di una verga), aveva chiesto a Dio un segno su chi dovesse sposare la Vergine Maria, e proprio il bastone di Giuseppe germogliò e fiorì miracolosamente. Venerato da quasi tre secoli, il bastone-reliquia è stato rubato in un convento di padri carmelitani del Sussex, in Inghilterra, dove si trovava esposto fin dal XIII secolo. Alla fine la reliquia si è fermata a Napoli nel 1712 come dono al cantante d’opera Giuseppe Grimaldi, detto Nicolino. Quest’ultimo acconciò a casa propria l’esposizione del bastone per la pubblica venerazione a partire dal 1714. Il 17 gennaio 1795, la reliquia fu definitivamente trasferita nella chiesa di San Giuseppe dei Nudi. (cfr. Marzena Wilkanowicz-Devoud, "Dove si trovano le reliquie di san Giuseppe?", Aleteia, 09.06.2021).
B - VITA E POESIA: LA NASCITA DI UN ESSERE UMANO. Un bastone fiorito in generale sembra plausibile, e particolarmente adatta al contesto di un’ Annunciazione? Certamente! A mio parere, tutto il tradizionale storico contesto iconografico sul tema dell’Annunciazione appare chiaramente collegato alla figura di Giuseppe e alla cosiddetta "radice Iesse" (Is., 11:1), all’albero di Jesse, alla "Casa di Davide" ("De Domo David") della tradizione ebraica e, al contempo, al senso stesso del messaggio evangelico ("eu-angelico"), al problema di tutti i problemi, al come nascono gli esseri umani, al "come nascono i bambini: vale a dire, alla lezione di Francesco di Assisi (1223), al presepe e alle sue figure fondamentali, memoria di Adamo ed Eva - e Caino, di Giuseppe e Maria - e Gesù.
- P. S. - Kafka: "[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" (F. Kafka, Lettera a Helli Hermann, autunno 1921).
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980) --- LA CELESTE "CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI" E LA RICERCA DI ITALO CALVINO DI USCIRE "FUORI DEL SELF" EGOICO ED EDIPICO.3 novembre 2023, di Federico La Sala
LA "MEMORIA DEL MONDO", LA CELESTE "CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI" DI FOSCOLO (OMERO/ULISSE), E LA RICERCA DI ITALO CALVINO DI USCIRE "FUORI DEL SELF" DELLA TRADIZIONE SOFISTICA (IDEALISTICA E MATERIALISTICA), PER COMPRENDERE ANTROPOLOGICAMENTE (NON ANTROPOMORFICAMENTE) LE RADICI COSMICOMICHE DELLA INFINITA E COMPLESSA MOLTEPLICITÀ... *
CALVINO (OMERO/ULISSE): "IO HO ASCOLTATO IL CANTO DELLE SIRENE" ("La letteratura e la realtà dei livelli", 1978). Non dimentico della lezione di #DanteAlighieri, #Calvino cerca di trovare la via che lo possa portare al "punto di arrivo cui tendeva #Ovidio nel raccontare la continuità delle forme, il punto di arrivo cui tendeva #Lucrezio nell’identificarsi con la natura comune a tutte le cose" ( "Molteplicità", "Lezioni Americane").
I "LIVELLI DI REALTÀ" (Feltrinelli, Milano 1984) E LA PSICOANALISI. Una traccia, per orientarsi nell’attraversamento dei livelli di realtà delle opere di #Calvino100: ricordare il suo incontro ("Anch’io cerco di dire la mia"), nella "taverna dei destini incrociati", con "Sigismondo di #Vindobona", e ricordare il ruolo di #Venere (#Afrodite) e di #Eros (#Cupìdo) nella mitica versione di Ovidio del "Ratto di #Proserpina", di #Persefone, figlia di #Demetra (#Cerere), da parte di #Ade (#Plutone):
- "Plutone, re degli Inferi, preoccupato che i movimenti tellurici causati dal gigante Tifeo sepolto sotto la #Sicilia potessero far penetrare la luce nel suo oscuro regno, perlustrava quella regione quando Venere scortolo esortò Cupido ad estendere il proprio dominio anche sul regno infero, colpendo con una delle sue frecce il sovrano infernale. Nei pressi di un lago poco distante da #Enna, Proserpina, la giovane figlia di Cerere, coglieva fiori con le proprie compagne. Plutone, colpito dallo strale di Cupido, se ne invaghì e rapitala la condusse con sé negli Inferi. Al rapimento della fanciulla assistette la #ninfa #Ciane la quale, tentato invano di impedire il misfatto, si dissolse nella fonte che da lei prende nome. A seguito della scomparsa della figlia la dea Cerere disperata intraprese la sua #ricerca." (cfr. "Le metamorfosi di Ovidio").
#Eleusis2023
*
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). --- "ANCH’IO CERCO DI DIRE LA MIA": "IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI", "SIGISMONDO DI VINDIBONA", E IL NODO DEL "MODELLO PATRIARCALE".29 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’ AMLETICA “QUESTION” DI ELISABETTA I (REGINA D’INGHILTERRA E PAPA DELLA CHIESA ANGLICANA), LA LEZIONE SULLA “VISIBILITA” (“VISIBILITY”) DI ITALO CALVINO, E IL PROBLEMA DEL “MODELLO PATRIARCALE”.
- “C’è un verso di Dante nel Purgatorio (XVII, 25) che dice: «poi piovve dentro a l’alta fantasia»”: una nota in memoria di “Sigismondo di Vindibona” (1856-1939) e di Italo Calvino (1923 -1985). *
A MARGINE E A PROPOSITO DELL’ “USO PERSUASIVO E PROPAGANDISTICO DELLA FAMIGLIA” (DEL “PRESEPE”) E DEGLI ANTROPOMORFISMI MESSI IN LUCE NELLA RIFLESSIONE SUL “BENTORNATO MASCHIO” (Gianfranco Pellegrino, "Le parole e le cose", 26 ottobre 2023), FORSE, non sarebbe male se la sollecitazione a riflettere venisse accolta soprattutto dalle antropologhe, dalle filosofe, dalle psicoanaliste, e dalle teologhe:
- “Alcune autrici hanno proposto una definizione sociale delle donne. Per loro, essere donna significa occupare una specifica posizione sociale, e essere trattate in certi modi, subire certe reazioni, e così via. [...] Semplificando, in questo tipo di visioni, essere una donna o un uomo è un fatto di potere. Sei donna se subisci un certo tipo di potere, quello patriarcale, sei uomo se non lo subisci e lo eserciti.
 L’obiezione che viene subito in mente, e che è stata fatta più volte, è: ma allora la regina Elisabetta I non è una donna? [...]
L’obiezione che viene subito in mente, e che è stata fatta più volte, è: ma allora la regina Elisabetta I non è una donna? [...]
 la narrazione femminista, sostenuta dai maschi democratici dalla lunga, lunga coda di paglia, non prevede donne che non siano vittime del sistema e uomini che non siano carnefici [...] Il maschio tossico è ancora qui, anche se s’incarna nella prima donna premier d’Italia. [...]” (G. Pellegrino, cit.).
la narrazione femminista, sostenuta dai maschi democratici dalla lunga, lunga coda di paglia, non prevede donne che non siano vittime del sistema e uomini che non siano carnefici [...] Il maschio tossico è ancora qui, anche se s’incarna nella prima donna premier d’Italia. [...]” (G. Pellegrino, cit.).
*
VISTO CHE il “modello patriarcale” come strumento di analisi fa acqua da tutte le parti, almeno dal tempo della “dialettica” di Hegel, e, ancor di più, dopo Freud e la sua indicazione a muoversi ad usare il “modello edipico completo”, è più che augurabile fare qualche passo avanti teorico e pensare a un modello “patriarcale-matriarcale” (padrone-serva e padrona-servo), alla luce delle “Lezioni americane” (non solo la quarta, la “Visibilità”) e del “Castello dei destini incrociati” (in particolare, del capitolo della seconda parte, “La taverna dei destini incrociati”, col titolo “Anch’io cerco di dire la mia”).
 Federico La Sala
Federico La SalaP. S. - LETTERATURA E PSICOANALISI: “IL CASTELLO DEI #DESTINI INCROCIATI” (ITALO CALVINO). L’INCONTRO CON “SIGISMONDO DI VINDIBONA” [VIENNA] NELLA “TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI”. Una “presentazione” del mito di Edipo con le carte dei Tarocchi:
“ANCH’IO CERCO DI DIRE LA MIA. [...] Tutto questo è come un sogno che la parola porta in sé e che passando attraverso chi scrive si libera e lo libera. Nella scrittura ciò che parla è il represso. E allora Il Papa dalla barba bianca potrebbe essere il gran pastore d’anime e interprete di sogni Sigismondo di Vindobona, e per averne conferma non c’è che verificare se da qualche parte del quadrato dei tarocchi si riesce a leggere la storia che, a quanto insegna la sua dottrina, si nasconde nell’ordito di tutte le storie. [...]” (cfr. I. Calvino, “Anch’io cerco di dire la mia”, “Romanzi e racconti” II, Meridiani, Mondadori, 1992, pp. 592-595).
 Federico La Sala
Federico La SalaP. S. 2 - ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, MATEMATICA, E FILOLOGIA...
“Bentornato maschio”( v. sopra) non è solo una chiamata in causa di intellettuali di ogni genere e di ogni specie, ma anche, e prima di tutto, è un segnavia “storico” per ogni cittadino e ogni cittadina per dare alla amletica “question” teologico-politica posta da Shakespeare, in stretto collegamento alla presenza sul trono d’Inghilterra di Elisabetta I, regina e papessa della Chiesa anglicana, una propria risposta all’altezza dell’attuale “presente storico” - è una chiamata ad uscire dall’epocale “stato di minorità”, personale e politico (Immanuel Kant, 1784 - Michel Foucault, 1984) !
“DUE SOLI” (DANTE ALIGHIERI). Re-interrogarsi alla Kantorowicz sulla “regalità antropocentrica: Dante”, sui “due corpi del re” e, ovviamente, anche sui “due corpi della regina”, forse, può essere una buona occasione per svegliarsi dal sonno dogmatico e portarsi fuori dalla cosmoteandria, atea e devota! Se non ora, quando?!
QUESTIONE MATEMATICA E ANTROPOLOGICA. Per approfondimenti, volendo accogliere alcune indicazioni sul tema, si potrebbe ricominciare a contare da almeno da due o, meglio da “Quattro”, dal poema di Italo Testa (“Le parole e le cose”, 3 Settembre 2021).
-
>COSMOLOGIA E LETTERATURA: MEMORIA DEL MONDO. A STORIA DI FETONTE ("IL MULINO DI AMLETO"), LA FASCINAZIONE DEL «MALO OCCHIO», E L’OCCHIO RITROVATO A RIACE.25 ottobre 2023, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, LETTERATURA (EPIGENETICA), IMMAGINARIO, ANTROPOLOGIA CULTURALE E... MEMORIA DEL MONDO.
LA STORIA DI FETONTE ("IL MULINO DI AMLETO"), LA FASCINAZIONE DEL «MALO OCCHIO», E L’OCCHIO RITROVATO A RIACE. Alcuni appunti sul tema...
- Un omaggio a Italo Calvino (1923 - 1985).
- "ESATTEZZA" E... BILANCIA (LA TERZA DELLE "LEZIONI AMERICANE"): "La precisione per gli antichi Egizi era simboleggiata da una piuma che serviva da peso sul piatto della bilancia dove si pesano le anime. Quella piuma leggeraaveva nome Maat, dea della bilancia. Il geroglifico di Maat indicava anche l’unità di lunghezza, i 33 centimetri del mattone unitario, e anche il tono fondamentale del flauto.
 Queste notizie provengono da una conferenza di Giorgio de Santillana sulla precisione degli antichi nell’osservare i fenomeni celesti: una conferenza che ascoltai in Italia nel 1963 e che ebbe una profonda influenza su di me [...] "( cfr. I. Calvino, Lezioni americane, Garzanti, Milano, 1988, p. 57).
Queste notizie provengono da una conferenza di Giorgio de Santillana sulla precisione degli antichi nell’osservare i fenomeni celesti: una conferenza che ascoltai in Italia nel 1963 e che ebbe una profonda influenza su di me [...] "( cfr. I. Calvino, Lezioni americane, Garzanti, Milano, 1988, p. 57).
- ANTROPOLOGIA E ... CONOSCENZA. Una questione di antropocentrismo (non di antropomorfismo, andro-centrico o gineco-centrico): "[...] Ascoltando la conferenza [«Fato antico e fato moderno»] nel 1963, ne ebbi come la rivelazione d’un nodo di idee che forse già ronzavano confusamente nella mia testa ma che m’era difficile da esprimere; e sarebbero state difficili da esprimere anche dopo, ma da quel momento sono stato cosciente d’una distanza da colmare, d’un qualcosa a cui “far fronte”. (Santillana: “Ed è cosa da poco che il nome stesso della scienza in greco, «epistéme», significhi far fronte?”).
 Dico l’idea che nessuna storia e nessun pensiero umani possano darsi se non situandoli in rapporto a tutto ciò che esiste indipendentemente dall’uomo; l’idea d’un sapere in cui il mondo della scienza moderna e quello della sapienza antica si riunifichino [...]
Dico l’idea che nessuna storia e nessun pensiero umani possano darsi se non situandoli in rapporto a tutto ciò che esiste indipendentemente dall’uomo; l’idea d’un sapere in cui il mondo della scienza moderna e quello della sapienza antica si riunifichino [...]
 "La sua monumentale opera «Il mulino di Amleto», scritta in collaborazione con una etnologa tedesca (allieva di Frobenius), Herta von Dechend, ha per sottotitolo «Saggio sul mito e sulla struttura del tempo» ed è paragonabile al «Ramo d’oro» di Frazer per la sterminata ricchezza di fonti antropologiche e letterarie che intesse in una fitta rete attorno a un tema comune. [...] (I. Calvino, «Fato antico e fato moderno di Giorgio de Santillana», in Id., "Saggi 1945-1985", Mondadori).
"La sua monumentale opera «Il mulino di Amleto», scritta in collaborazione con una etnologa tedesca (allieva di Frobenius), Herta von Dechend, ha per sottotitolo «Saggio sul mito e sulla struttura del tempo» ed è paragonabile al «Ramo d’oro» di Frazer per la sterminata ricchezza di fonti antropologiche e letterarie che intesse in una fitta rete attorno a un tema comune. [...] (I. Calvino, «Fato antico e fato moderno di Giorgio de Santillana», in Id., "Saggi 1945-1985", Mondadori).
1 - "IL MULINO DI AMLETO": "[...] La storia di Fetonte è stata spesso intesa come commemorazione di un qualche grandioso e abbagliante fenomeno celeste, una cometa o una meteora [...] Comunqe sia, ne abbiamo una conferma indipendente nella versione platonica di questa ’crisi’ nel #Timeo (22 c. e). Il sacerdote egizio che parla con #Solone afferma che la leggenda di Fetonte ha «l’aria di una favola: ma la verità è una deviazione [parallasse] dei corpi che ruotano in cielo attorno alla terra, e una distruzione, che avviene a lunghi intervalli di tempo, delle cose sulla terra in una grande conflagrazione». E’ una affermazione chiara, che concorda inoltre con quanto dicono Nonno e #Ovidio, com’è giusto del resto, trattandosi di una tradizione pitagorica: ce lo dice #Aristotele. [...] In Egitto, comunque, Fetonte sbalzato dal cocchio sarebbe stato detto «l’occhio perduto» o meglio, uno degli «occhi perduti». L’occhio andò «perduto» nella cosiddetta «mitica sorgente del Nilo», la sorgente di tutte le acque" (Giorgio de Santillana, Hertha von Dechend, "Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, Adelphi, Milano 1983, pp. 304-305).
"IL MULINO DI AMLETO" E IL «MALO OCCHIO»): "Indice delle illustrazioni. [...] 52. Il «Malo Occhio» su una mattonella di mosaico romano [...]; 53. Il «Malo Occhio» attorniato da una civetta, un serpente, un cervo, uno scorpione, un cane, un leone, una folgore [...]; 54. Amuleto d’oro proveniente dalla Sicilia raffigurante il «Malo Occhio» attorniato da una lucertola, un cigno, un serpente, un cane, un un leone, un fallo, uno scorpione, una folfore [...]; 55. Il «Malo Occhio» su un amuleto d’oro di Ercolano, attorniato da una folgore, una lucertola, un fallo, uno scorpione, una stella (stella marina?), un elefante, un cigno, un oggetto non identificato, un serpente [...]; 56. Il «Malo Occhio» su una lampada ad olio proveniente da Pompei con corna di toro e scorpione [...] (cfr. op. cit., nuova ed. ampliata, Adelphi 2003).
2) - FASCINAZIONE E MALOCCHIO. Béatrice Delaurenti, "Fascination. Une histoire intellectuelle du mauvais œil (1140-1440)", Paris, Cerf, 2023. ["Fascination. An Intellectual History of the Evil Eye (1140-1440)", Éditions du Cerf, 2023]: "
- [...] La réflexion sur la fascination mettait à la disposition des théologiens et des philosophes un cas d’école pour penser le pouvoir de l’incantation comme un pouvoir naturel. Le pouvoir du regard et le pouvoir des mots ont posé le même problème scientifique aux universités du Moyen Âge : le problème de l’action à distance, sans contact. Guillaume d’Auvergne, Roger Bacon, Thomas d’Aquin et Nicole Oresme ont en commun de s’être intéressés aux deux aspects du problème : leurs écrits illustrent avec éclat les liens profonds qui unissaient, dans le monde médiéval, le fascinator qui trouble par son regard et l’incantator qui trouble par ses mots."(https://journals.openedition.org/medievales/1420).
3) - "ARTE & CULTURA. [...]Reggio di Calabria. Nelle stesse acque in cui furono trovati i Bronzi di Riace è stato ritrovato un manufatto simile a un occhio: l’ipotesi sulla nuova scoperta.
 Una nuova scoperta, risalente al mese di agosto del 2023 ma illustrata pubblicamente solo sabato 21 ottobre, potrebbe riaprire il dibattito sui Bronzi di Riace: lo scrittore Giuseppe Braghò ha reso noto di aver ritrovato, proprio nelle stesse acque che restituirono al mondo le due statue greche uniche al mondo, un manufatto bronzeo dalla forma di occhio con iride e pupilla e completo anche di alette di fissaggio. Questo complemento scultoreo potrebbe essere ricondotto a uno dei Bronzi di Riace, anche se la scoperta è ancora al vaglio della Soprintendenza. [...] Il particolare ritrovamento è stato fatto sulla riva a circa 60 metri dal punto esatto in cui 50 anni fa vennero ritrovati i Bronzi di Riace, una scoperta che cambiò la storia. [...]" ("Bronzi di Riace, spunta un "occhio" in mare: la nuova scoperta").
Una nuova scoperta, risalente al mese di agosto del 2023 ma illustrata pubblicamente solo sabato 21 ottobre, potrebbe riaprire il dibattito sui Bronzi di Riace: lo scrittore Giuseppe Braghò ha reso noto di aver ritrovato, proprio nelle stesse acque che restituirono al mondo le due statue greche uniche al mondo, un manufatto bronzeo dalla forma di occhio con iride e pupilla e completo anche di alette di fissaggio. Questo complemento scultoreo potrebbe essere ricondotto a uno dei Bronzi di Riace, anche se la scoperta è ancora al vaglio della Soprintendenza. [...] Il particolare ritrovamento è stato fatto sulla riva a circa 60 metri dal punto esatto in cui 50 anni fa vennero ritrovati i Bronzi di Riace, una scoperta che cambiò la storia. [...]" ("Bronzi di Riace, spunta un "occhio" in mare: la nuova scoperta").- Archeologia, uno dei Bronzi di Riace (forse) ritrova il suo "occhio". Il presunto occhio di uno dei Bronzi (cf. Francesco Sorgiovanni, Il Quotidiano del Sud, 22.10.2023).
-
> COSMOLOGIA E LETTERATURA: MEMORIA DEL MONDO. --- Giorgio de Santillana e la nascita della scienza (di Mario Porro - "Doppiozero).23 novembre 2023, di Federico La Sala
Giorgio de Santillana e la nascita della scienza
di Mario Porro (Doppiozero, 21 Novembre 2023)
“Da quando sono qui penso spesso a Santillana, perché fu lui a farmi da guida nel Massachusetts al tempo della mia prima visita in questo paese nel 1960. In memoria della sua amicizia, apro questa conferenza sull’esattezza in letteratura, col nome di Maat, dea della bilancia. Tanto più che la bilancia è il mio segno zodiacale”. Così scrive Italo Calvino in apertura della terza Lezione americana, “Esattezza”, uno dei six memos che la letteratura dovrebbe custodire per il millennio a venire. La frase era stata scritta in Italia, ma già pensando alla comunicazione da tenere all’università di Harvard nel 1985; il viaggio non avrà luogo a causa della morte dello scrittore in settembre. Gli antichi Egizi ponevano una piuma leggera, che aveva nome Maat, sul piatto della bilancia per pesare le anime; il geroglifico corrispondente indicava l’unità di lunghezza, i 33 centimetri del mattone e anche il tono fondamentale del flauto. Il richiamo alla precisione con cui gli antichi osservavano il cosmo era il modo con cui Calvino saldava il debito di riconoscenza verso l’amico, morto nel 1974.
 In una dichiarazione riportata da Ernesto Ferrero in “Tuttolibri” (gennaio 1984), Calvino segna proprio all’epoca del viaggio negli Stati Uniti l’inizio delle letture sistematiche di testi di astronomia, frutto dell’ascolto a Boston di una conferenza di de Santillana, “che anticipava alcuni temi di quello che sarebbe poi diventato Il mulino di Amleto”. È lo spunto che, insieme alla lettura dei racconti dell’amico Primo Levi, poi confluiti in Storie naturali (1966), sorregge la scommessa intrapresa dalle Cosmicomiche (1965) e due anni dopo da Ti con zero: far riemergere dalle ipotesi della cosmologia contemporanea l’immaginario primitivo sepolto in noi, far scaturire “storie capaci di evocare suggestioni elementari come i miti cosmogonici dei popoli dell’Antichità” (Postilla del 1975).
In una dichiarazione riportata da Ernesto Ferrero in “Tuttolibri” (gennaio 1984), Calvino segna proprio all’epoca del viaggio negli Stati Uniti l’inizio delle letture sistematiche di testi di astronomia, frutto dell’ascolto a Boston di una conferenza di de Santillana, “che anticipava alcuni temi di quello che sarebbe poi diventato Il mulino di Amleto”. È lo spunto che, insieme alla lettura dei racconti dell’amico Primo Levi, poi confluiti in Storie naturali (1966), sorregge la scommessa intrapresa dalle Cosmicomiche (1965) e due anni dopo da Ti con zero: far riemergere dalle ipotesi della cosmologia contemporanea l’immaginario primitivo sepolto in noi, far scaturire “storie capaci di evocare suggestioni elementari come i miti cosmogonici dei popoli dell’Antichità” (Postilla del 1975).Giorgio Diaz de Santillana era nato a Roma nel 1901. Dopo la laurea in Fisica, promosse l’insegnamento di Storia della scienza all’università di Roma La Sapienza, su incitamento di Federigo Enriques, con il quale compose nel ’36 un Compendio di storia del pensiero scientifico (l’editore Zanichelli nel 1973 ne ha proposto la ristampa anastatica), sintesi di un abortito progetto di Storia del pensiero scientifico in più volumi. Nella prefazione, Paolo Casini ricordava che il progetto di Enriques mirava a “ricercare le intime ragioni dell’evoluzione delle idee”, inseguendo il progredire della “razionalizzazione dell’empirico”: era una lezione di modestia che intendeva demolire le illusioni di oggettività assoluta delle teorie, nel consapevole rifiuto sia delle mitologie (neo)-positiviste fondate sul culto dei fatti, sia delle svalutazioni scettiche promosse dal dominante clima neo-idealista, presuntuosamente convinto dell’insignificanza filosofica della scienza.
 Nel ’36, mentre si celebra il patto del regime fascista con il nazismo, Santillana, di origine ebraica, decide di trasferirsi negli Stati Uniti, dove poi assume al MIT di Boston la cattedra di “Storia e filosofia della scienza”. Alle spalle agiva un’idea di cultura in cui la scienza non fosse ridotta alla sua efficacia tecnologica, ma fosse vista come vettore determinante nell’istruire la ragione e nel modificare le forme dell’immaginario. Un’idea non certo estranea allo sguardo da “Terzo Istruito” di Calvino, per il quale la letteratura è luogo di scambi ermetici fra i diversi saperi, spazio in cui si tessono insieme forze della natura e forme della cultura, al fine di promuovere “una visione plurima e sfaccettata del mondo” (Lezioni americane).
Nel ’36, mentre si celebra il patto del regime fascista con il nazismo, Santillana, di origine ebraica, decide di trasferirsi negli Stati Uniti, dove poi assume al MIT di Boston la cattedra di “Storia e filosofia della scienza”. Alle spalle agiva un’idea di cultura in cui la scienza non fosse ridotta alla sua efficacia tecnologica, ma fosse vista come vettore determinante nell’istruire la ragione e nel modificare le forme dell’immaginario. Un’idea non certo estranea allo sguardo da “Terzo Istruito” di Calvino, per il quale la letteratura è luogo di scambi ermetici fra i diversi saperi, spazio in cui si tessono insieme forze della natura e forme della cultura, al fine di promuovere “una visione plurima e sfaccettata del mondo” (Lezioni americane).
 Quel progetto d’integrazione delle scienze nella cultura sarà risvegliato nel dopoguerra dal Giulio Preti della Storia del pensiero scientifico (Mondadori, 1957), dai sette volumi della Storia del pensiero filosofico e scientifico (Garzanti, 1970) di Ludovico Geymonat, dall’approccio storico-critico alla matematica di Lucio Lombardo Radice. Un canone “minore” della filosofia del Novecento, forse, ma la sua marginalità non è stata priva di conseguenze per “l’avvenire delle nostre scuole” e ancora si paga con la scarsa diffusione di una cultura scientifica. Le conoscenze “positive” rischiano di ripiegarsi negli specialismi e nei tecnicismi, mentre la scarsa consapevolezza del tortuoso percorso senza fine di approssimazione alla verità si traduce in semplificazioni ideologiche o dogmatiche - lo hanno mostrato i dibattiti recenti sulla pandemia, sull’utilizzo dei vaccini o sul cambiamento climatico.
Quel progetto d’integrazione delle scienze nella cultura sarà risvegliato nel dopoguerra dal Giulio Preti della Storia del pensiero scientifico (Mondadori, 1957), dai sette volumi della Storia del pensiero filosofico e scientifico (Garzanti, 1970) di Ludovico Geymonat, dall’approccio storico-critico alla matematica di Lucio Lombardo Radice. Un canone “minore” della filosofia del Novecento, forse, ma la sua marginalità non è stata priva di conseguenze per “l’avvenire delle nostre scuole” e ancora si paga con la scarsa diffusione di una cultura scientifica. Le conoscenze “positive” rischiano di ripiegarsi negli specialismi e nei tecnicismi, mentre la scarsa consapevolezza del tortuoso percorso senza fine di approssimazione alla verità si traduce in semplificazioni ideologiche o dogmatiche - lo hanno mostrato i dibattiti recenti sulla pandemia, sull’utilizzo dei vaccini o sul cambiamento climatico.Negli Stati Uniti, Santillana progettò per la University of Chicago Press una Storia del pensiero scientifico, il cui piano prevedeva sei volumi. Il primo, Le origini del pensiero scientifico (1961), venne tradotto da Giulio De Angelis per le edizioni Sansoni nel ’66 e ora è riproposto per i tipi di Adelphi, con la sola aggiunta di una nota del curatore Mauro Sellitto. Nel cammino che da Anassimandro giunge a Proclo, dal 600 a.C. al 500 d.C., Santillana assegna funzione primaria alla ricerca presocratica di un ordine di giustizia e di reciprocità nel succedersi degli eventi “secondo l’ordine del tempo”, come già in Anassimandro. Nel linguaggio del legislatore e non più in quello delle caste sacerdotali, la norma del cosmo - ordine e bellezza a un tempo - è leggibile nel ciclico rinnovarsi dei moti dei corpi celesti. La prospettiva pitagorica di un’armonia naturale, espressa in proporzioni numeriche, dotata di ritmo (rhythmus nel primo atomismo indica l’atomo come figura in moto) e melodia, apre il cammino per una spiegazione quantitativa della Natura. Già si delinea quel principio di ragion sufficiente per cui dobbiamo indicare una causa del prodursi di un fenomeno e che sarà alla base del razionalismo scientifico. Il “logos che si canta”, la lingua segreta degli dei, si formula ancora nel “linguaggio poetico” che risuonava nei versi di Omero e nei cori della tragedia; ma se ne ritrovano le tracce nel ciclico alternarsi di Amicizia e Odio nella physis di Empedocle, nell’idea della salute ippocratica come giusto equilibrio fra gli umori, e gli esempi potrebbero continuare.
Lo sguardo non canonico di Santillana propone di rileggere Parmenide purgandolo dall’interpretazione dello “spiritualismo” platonico che, volgendo lo sguardo alla “Sfinge della metafisica”, ne fa il fondatore dell’ontologia. La moderna storia della filosofia - rileva Santillana nel “Prologo a Parmenide”, saggio raccolto in Fato antico e fato moderno (Adelphi, 1985) - è stata scritta da idealisti desiderosi d’indicare nel pensatore eleatico l’apertura dell’interrogazione sull’Essere che dalla Grecità giunge al neoplatonismo e poi alla Gnosi del Divino. Ma così si fa passare per appendice insignificante alla sua “Via della verità” quel che Parmenide scrive sui meccanismi planetari e sulla luce della luna, come se in un trattato che pure ha nome Perì physeos (Sulla natura) tutto si racchiudesse in quella copula “è”, considerata in termini logici e verbali. E se, chiede Santillana, i predicati di unicità, continuità e omogeneità, invece di applicarli all’Essere, venissero rivolti al puro spazio geometrico? Il cammino di Parmenide resta così iscritto nell’ambito di una proto-fisica a base logico-matematica, che s’interroga sulle grandezze distribuite nello spazio. Lo confermano i temi implicati nei paradossi con cui l’allievo Zenone, per colpire l’atomismo aritmo-geometrico dei pitagorici, affronta le questioni attinenti alla natura dello spazio percorso da una freccia o da Achille all’inseguimento della tartaruga.
La ricchezza del pensiero pre-socratico viene “adulterata”, sostiene Santillana, prima dalle sottigliezze ingannevoli della sofistica, poi dal gesto platonico che separa il piano matematico dalla realtà fisica. Certo, il platonismo resterà per venti secoli la struttura teorica entro la quale la matematica potrà svolgere la funzione di garante della forza della razionalità, ma al prezzo di perdere il contatto con la physis; quando Eudosso elabora il modello dell’universo a sfere concentriche lo fa per “salvare i fenomeni”, per rendere conto del loro apparire, ma senza porsi il problema della corrispondenza con la realtà. L’atteggiamento da scienziato-biologo di Aristotele, che si sforza di restare prossimo all’osservabile, si smarrisce nella ricerca d’invarianti a causa di un pregiudizio anti-matematico; in modo opposto e complementare, l’approccio “ingegneresco” di Archimede viene schernito da chi non vuole infangare la purezza della geometria nelle cose sensibili. Sta in questo il “blocco mentale” che impedisce al pensiero greco di operare la matematizzazione della realtà che sarà propria della scienza moderna: di qui la scissione fra l’ordine del mondo celeste, ciclico, immutabile e divino, e il divenire terreno, imperfetto e contingente, lasciato all’imprecisione dell’osservabile. Così il mondo antico rimane privo di una dinamica, anche se l’origine della scienza, al tempo di Galileo e Keplero, è per larghi tratti una ripresa di lontani annunci greci, dell’atomismo, di Archimede, dei solidi platonici, delle antiche dottrine “metafisiche”; anche le “erbacce” astrologiche e teurgiche del neoplatonismo conservano per tutto il Medioevo il germe addormentato della matematica. L’episteme di Santillana è ben lontana dagli anatemi dei neopositivisti, dalle condanne nei confronti della “metafisica”: la civiltà moderna e tecnologica non ha da temere granché dalle oscurità filosofiche, deve se mai preoccuparsi di se stessa.
Nel Prologo delle Origini del pensiero scientifico, dal titolo “Di tempi remoti”, emerge uno dei nuclei forti del pensare di Santillana: la convinzione che sia esistita una scienza ancor prima del mito, anzi che il mito fosse il segreto custode di un patrimonio immenso di saperi relativo alla regolarità dei moti celesti, dai periodici ritorni del sole e della luna al cammino delle costellazioni lungo la fascia dello zodiaco. Si preannuncia quel che sarà Il Mulino di Amleto (1969, Adelphi, 1983), scritto con Hertha von Dechend, sua collaboratrice dal ’58, come ricorda Mauro Sellitto nella postfazione alla raccolta di saggi di Santillana e von Dechend, Sirio (Adelphi, 2020). Il mito è essenzialmente e originariamente cosmologico: un ordine d’immagini astrali, un logos retto dal principio d’invarianza soggiacente alla molteplicità dei fenomeni, si ritrova in tutte le culture tra il 6000 e il 4000 a. C., al tempo della tarda rivoluzione neolitica, prima della storia documentata dagli scritti dei Sumeri. Quei presunti “primitivi” non furono “ingegni dozzinali”, ma genii ignoti che “seppero tracciare percorsi molteplici convolti e intrecciati degli astri del cielo”, “spiriti sopraumani”, scrive Santillana citando l’amato Galileo a cui dedicherà Il processo a Galileo (1955, Mondadori, 1960).
I calcoli relativi alle vicende celesti, noti all’Arte regale dell’astronomia, si traducevano nelle storie di quei personaggi eroici che erano le potenze stellari e i pianeti: contare equivaleva a raccontare. I miti di dei e fondatori di città, che intraprendono lunghi viaggi e partono per la “Caccia al Sole”, le leggende di suonatori di flauto scorticati vivi o di Orfeo con la sua lira (cioè la costellazione) - tutti predecessori del Pifferaio magico -, le strane storie di Orione-Sansone, ferito al tallone e accecato, vanno decifrati come il linguaggio tecnico degli astronomi arcaici che dettero nomi alle costellazioni. Da quella tradizione orale emerge uno scadenziario dei momenti critici della storia del cosmo, una comprensione già matematica del Tempo e il senso “ancor più che geometrico, musicale, dell’importanza del ‘cadere giusto’ nel tempo”. La mappa delle posizioni astrali, conservata nella memoria orale, forniva una “visione sinottica” del succedersi delle stelle che serviva da orientamento ai popoli nomadi o marinari: “Le norme di navigazione per i marinai polinesiani nel Pacifico presero la forma di una sequenza ben articolata di racconti imperniati su eroi ben noti”, ricorda il prologo delle Origini del pensiero scientifico. Ed è quanto ribadirà Calvino: “il primo bisogno di fissare sulla carta i luoghi è legato al viaggio: è il promemoria della successione delle tappe, il tracciato d’un percorso”; la mappa geografica sottende “un’idea narrativa”, traccia l’itinerario di un’Odissea (Il viandante nella mappa in Collezione di sabbia).
“Sulle rovine di questa grande costruzione arcaica mondiale si era già posata la polvere dei secoli quando i Greci entrarono in scena”, ricorda Il mulino di Amleto (il sottotitolo è Saggio sul mito e sulla struttura del tempo). Se Platone sa ancora parlare in linguaggio mitico, cioè seguendo l’ordine del Numero e del Tempo, è perché dietro di lui si erge il corpus delle dottrine pitagoriche, eredi del severo calcolo dei Babilonesi.
 Sotto le più diverse latitudini, dall’India alle Americhe precolombiane, dall’Islanda alla Polinesia, dalla Cina alle sponde del Mediterraneo, si racconta per metafore la lacerazione di un’armonia originaria, il dissesto della fabbrica dell’universo a causa dell’inclinarsi della circonferenza dell’eclittica rispetto all’equatore. Di qui si origina il grande conflitto che oppone i Titani agli dei dell’Olimpo, lo scontro fratricida o la vendetta di un nipote contro lo zio usurpatore. La posizione del Sole, fissata all’equinozio di primavera, scorre lungo le costellazioni dello zodiaco che, a sua volta, percorre un circolo lentissimo, di un grado ogni 72 anni, finché in 26.900 anni circa tutto si ritrova come prima. L’asse terrestre gira come una trottola sulla punta del polo settentrionale celeste, una sorta di boccola entro cui ruota “il ferro del mulino” e intorno al quale girano i sette “buoi laboriosi” (i septem Triones) dell’Orsa maggiore. Ma l’età dell’oro dell’armonia originaria si è spezzata, si è prodotto un peccato originale cosmogonico, il pilastro del cielo è stato scosso per l’inclinarsi del cerchio dell’eclittica, insieme alle costellazioni, rispetto all’equatore.
Sotto le più diverse latitudini, dall’India alle Americhe precolombiane, dall’Islanda alla Polinesia, dalla Cina alle sponde del Mediterraneo, si racconta per metafore la lacerazione di un’armonia originaria, il dissesto della fabbrica dell’universo a causa dell’inclinarsi della circonferenza dell’eclittica rispetto all’equatore. Di qui si origina il grande conflitto che oppone i Titani agli dei dell’Olimpo, lo scontro fratricida o la vendetta di un nipote contro lo zio usurpatore. La posizione del Sole, fissata all’equinozio di primavera, scorre lungo le costellazioni dello zodiaco che, a sua volta, percorre un circolo lentissimo, di un grado ogni 72 anni, finché in 26.900 anni circa tutto si ritrova come prima. L’asse terrestre gira come una trottola sulla punta del polo settentrionale celeste, una sorta di boccola entro cui ruota “il ferro del mulino” e intorno al quale girano i sette “buoi laboriosi” (i septem Triones) dell’Orsa maggiore. Ma l’età dell’oro dell’armonia originaria si è spezzata, si è prodotto un peccato originale cosmogonico, il pilastro del cielo è stato scosso per l’inclinarsi del cerchio dell’eclittica, insieme alle costellazioni, rispetto all’equatore.
 Il regno di Saturno-Kronos, Signore di un mulino che produceva pace e abbondanza, ha fine quando il figlio Zeus lo detronizza gettandolo dal carro: è questo mutamento dell’asse cosmico il “crepuscolo degli dei”, il delitto compiuto dai figli del cielo, di cui parlano Esiodo, l’Edda, il Mahābhārata e tante altre narrazioni mitiche. La grande macina è stata sbalzata dal suo perno per effetto della precessione degli equinozi e invano divinità ed eroi cercano di riportarla al suo posto. È questa la storia che sta alle spalle dell’Amleto shakespeariano, la leggenda danese riportata da Saxo Grammaticus (intorno al 1200) nel suo Gesta Danorum: la vendetta di Amleth, malinconico e folle, nei confronti dello zio che gli ha ucciso il padre e ne ha sposato la vedova. -Nel Kalevala, in area linguistica ugrofinnica, si racconta una storia analoga in cui la sequenza principale ruota attorno alla conquista di un grande mulino chiamato Sampo, il cui albero corrisponde all’asse del mondo, caduto in fondo al mare dove macina le rocce creando un vasto gorgo, il Maelstrom. In quel passato di credenze e di riti, una “profonda infrastruttura universale delle nostre culture storiche”, il Ramo d’oro di Frazer indicava come chiave il sacrificio rituale del re e i culti della vegetazione. Santillana-Dechend, transitando dalle leggende africane dei Dogon (riscoperte da Marcel Griaule) all’induismo, dagli Aztechi agli autori greci e latini, la scorgevano invece nella memoria remota degli spostamenti celesti, nella catastrofe che ha detronizzato antiche divinità cosmiche.
Il regno di Saturno-Kronos, Signore di un mulino che produceva pace e abbondanza, ha fine quando il figlio Zeus lo detronizza gettandolo dal carro: è questo mutamento dell’asse cosmico il “crepuscolo degli dei”, il delitto compiuto dai figli del cielo, di cui parlano Esiodo, l’Edda, il Mahābhārata e tante altre narrazioni mitiche. La grande macina è stata sbalzata dal suo perno per effetto della precessione degli equinozi e invano divinità ed eroi cercano di riportarla al suo posto. È questa la storia che sta alle spalle dell’Amleto shakespeariano, la leggenda danese riportata da Saxo Grammaticus (intorno al 1200) nel suo Gesta Danorum: la vendetta di Amleth, malinconico e folle, nei confronti dello zio che gli ha ucciso il padre e ne ha sposato la vedova. -Nel Kalevala, in area linguistica ugrofinnica, si racconta una storia analoga in cui la sequenza principale ruota attorno alla conquista di un grande mulino chiamato Sampo, il cui albero corrisponde all’asse del mondo, caduto in fondo al mare dove macina le rocce creando un vasto gorgo, il Maelstrom. In quel passato di credenze e di riti, una “profonda infrastruttura universale delle nostre culture storiche”, il Ramo d’oro di Frazer indicava come chiave il sacrificio rituale del re e i culti della vegetazione. Santillana-Dechend, transitando dalle leggende africane dei Dogon (riscoperte da Marcel Griaule) all’induismo, dagli Aztechi agli autori greci e latini, la scorgevano invece nella memoria remota degli spostamenti celesti, nella catastrofe che ha detronizzato antiche divinità cosmiche.Calvino, che aveva letto da ragazzo L’universo in espansione di Arthur Eddington (Zanichelli, 1934, tradotto da Santillana), segue nel maggio del ’63, al teatro Carignano di Torino, la conferenza dell’amico che è all’origine di Fato antico e fato moderno e quando Adelphi lo raccoglierà, insieme ad altri saggi, nel volumetto omonimo, ne scriverà una recensione su “Repubblica” nel luglio del 1985. L’aspirazione al ritrovamento d’un’armonia iscritta nel cosmo, quella che negli oscuri testi delle Piramidi forniva all’anima del re le istruzioni di rotta per trovare il luogo celeste dell’eterno soggiorno, si radicava nella fiducia in un universo dominato dalla Necessità matematica. Era questo il Fato antico, spiegava Santillana, in cui il corso delle stelle fungeva da predestinazione e anche, nonostante le tragedie e il dolore dell’esistenza, da riconciliazione. Il mondo industriale e l’avvento del macchinismo “nega ogni futuro assegnabile, liquida la fatalità”; venuta meno l’armonia delle sfere, è la macchina a fare la Storia, è la logica della tecnologia a rappresentare la “Necessità delle cose” e a fare del Tempo una continua catastrofe. Con accenti francofortesi, Santillana vede nel mondo moderno cancellarsi il lume della Ragione per un “eccesso di bagliore”, annunciato nelle potenzialità degli esperimenti atomici. Contro lo “spirito arrogante dello scientismo”, il finale del Mulino di Amleto si richiamava a Simone Weil, “l’ultima grande santa - ancorché gnostica - della cristianità”; lei, che aveva definito l’Iliade il poema della forza, esortava a riprendere il senso della misura e del limite che guidava il pensiero della Grecità, quel limite che la scienza ha varcato spingendosi dentro il nucleo dell’atomo e al cuore delle nebulose. Nel nostro mondo, a cui non si adatta più il termine kosmos, il firmamento “si è trasformato in uno spazio infinito brulicante di galassie, che si sottrae alla forza dell’immaginazione”.
Nella rubrica “Osservatorio del signor Palomar”, sul “Corriere della sera”, del settembre del 1975, Calvino, attratto dall’idea di una riconciliazione fra scienza moderna e sapienza antica, evocava “la forza mitica delle nuove immagini celesti”, riferendosi in particolare a una stella della costellazione del Cigno che ruota attorno a un buco nero. “Il signor Palomar ricorda un poeta da lui conosciuto in gioventù e poi morto suicida, che gli raccontava come la sua passione per la mitologia fossa nata da quella per l’astronomia, dai nomi delle stelle che aveva imparato a riconoscere da ragazzo” (“I buchi neri”, in Riga 9, a cura di M. Belpoliti, 1966). Ma se Cesare Pavese, l’amico suicida, guardava al mito in prospettiva sacrificale, Calvino ha appreso da Santillana e dall’antropologia di Lévi-Strauss la sua valenza cosmologica. La “vocazione mitopoietica” può consentire alla letteratura d’incrociare le strutture mitiche dell’uomo primitivo e dell’infanzia con le congetture delle scienze contemporanee, dalle quali però è fuggita ogni speranza di cosmos. Quel che rimane è l’inquieta incertezza del signor Palomar mentre si sforza di ritrovare un ordine nelle stelle; o la sorte di Perinzia nelle Città invisibili: una città di mostri fondata in base alle norme indicate dagli astronomi per rispecchiare l’armonia del firmamento.
-
> LETTERATURA E PSICOANALISI: L’INCONTRO CON "SIGISMONDO DI VINDOBONA" [DI VIENNA] NELLA "TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI".24 ottobre 2023, di Federico La Sala
LETTERATURA E PSICOANALISI: "IL CASTELLO DEI #DESTINI INCROCIATI" (ITALO CALVINO).
L’INCONTRO CON "SIGISMONDO DI VINDOBONA" [DI VIENNA] NELLA "TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI".
 Una "presentazione" del mito di Edipo con le carte dei Tarocchi... *
Una "presentazione" del mito di Edipo con le carte dei Tarocchi... *"ANCH’IO CERCO DI DIRE LA MIA. [...] Tutto questo è come un #sogno che la parola porta in sé e che passando attraverso chi scrive si libera e lo libera. Nella scrittura ciò che parla è il #represso. E allora Il Papa dalla barba bianca potrebbe essere il gran pastore d’anime e interprete di sogni Sigismondo di Vindobona, e per averne conferma non c’è che verificare se da qualche parte del quadrato dei tarocchi si riesce a leggere la storia che, a quanto insegna la sua dottrina, si nasconde nell’ordito di tutte le storie.
 (Si prenda un giovane, Fante di Denari, che vuole allontanare da sé una nera #profezia: #parricidio e #nozze con la propria #madre. Lo si faccia partire alla ventura su un Carro riccamente addobbato. Il Due di Bastoni segnala un crocicchio sulla polverosa strada maestra, anzi: è il crocicchio, e chi c’è stato può riconoscere il posto in cui la strada che viene da Corinto incrocia quella che va a #Tebe. L’Asso di Bastoni testimonia una rissa da strada, anzi da trivio, quando due carri non vogliono darsi il passo e restano coi mozzi delle ruote incastrati e i conducenti saltano a terra imbestialiti e polverosi, sbraitando appunto come carrettieri,insultandosi, dando del maiale e della vacca al padre e alla madre dell’altro, e se uno tira fuori dalla tasca un’arma da taglio è facile che ci scappi il morto.
(Si prenda un giovane, Fante di Denari, che vuole allontanare da sé una nera #profezia: #parricidio e #nozze con la propria #madre. Lo si faccia partire alla ventura su un Carro riccamente addobbato. Il Due di Bastoni segnala un crocicchio sulla polverosa strada maestra, anzi: è il crocicchio, e chi c’è stato può riconoscere il posto in cui la strada che viene da Corinto incrocia quella che va a #Tebe. L’Asso di Bastoni testimonia una rissa da strada, anzi da trivio, quando due carri non vogliono darsi il passo e restano coi mozzi delle ruote incastrati e i conducenti saltano a terra imbestialiti e polverosi, sbraitando appunto come carrettieri,insultandosi, dando del maiale e della vacca al padre e alla madre dell’altro, e se uno tira fuori dalla tasca un’arma da taglio è facile che ci scappi il morto.
 Difatti qui c’è l’Asso di Spade, c’è Il Matto, c’è La Morte: è lo sconosciuto, quello proveniente da Tebe, che è rimasto in terra, così impara a controllare i suoi nervi, tu Edipo non l’hai fatto apposta, lo sappiamo, è stato un raptus, ma intanto ti ci eri buttato addosso a mano armata come se non avessi aspettato altro per tutta la tua vita. Tra le carte che vengono dopo c’è la Ruota della Fortuna o #Sfinge, c’è l’ingresso in Tebe come un Imperatore trionfante, c’è le Coppe del #banchetto di nozze con la regina #Giocasta che vediamo qui ritratta come Regina di Denari, in panni vedovili, donna desiderabile benché matura.
Difatti qui c’è l’Asso di Spade, c’è Il Matto, c’è La Morte: è lo sconosciuto, quello proveniente da Tebe, che è rimasto in terra, così impara a controllare i suoi nervi, tu Edipo non l’hai fatto apposta, lo sappiamo, è stato un raptus, ma intanto ti ci eri buttato addosso a mano armata come se non avessi aspettato altro per tutta la tua vita. Tra le carte che vengono dopo c’è la Ruota della Fortuna o #Sfinge, c’è l’ingresso in Tebe come un Imperatore trionfante, c’è le Coppe del #banchetto di nozze con la regina #Giocasta che vediamo qui ritratta come Regina di Denari, in panni vedovili, donna desiderabile benché matura.
 Ma la profezia si compie: la peste infesta Tebe, una nuvola di bacilli cala sulla città, inonda di miasmi le vie e le case, i corpi dànno fuori bubboni rossi e blu e cascano stecchiti per le strade, lambendo l’acqua delle pozzanghere fangose con le labbra secche. In questi casi non c’è che ricorrere alla #Sibilla Delfica, che spieghi quali leggi o tabù sono stati violati: la vecchia con la tiara e il libro aperto, etichettata con lo strano epiteto di #Papessa, è lei.
Ma la profezia si compie: la peste infesta Tebe, una nuvola di bacilli cala sulla città, inonda di miasmi le vie e le case, i corpi dànno fuori bubboni rossi e blu e cascano stecchiti per le strade, lambendo l’acqua delle pozzanghere fangose con le labbra secche. In questi casi non c’è che ricorrere alla #Sibilla Delfica, che spieghi quali leggi o tabù sono stati violati: la vecchia con la tiara e il libro aperto, etichettata con lo strano epiteto di #Papessa, è lei.
 Se si vuole, nell’arcano detto del Giudizio o dell’Angelo si può riconoscere la scena primaria a cui rimanda la dottrina sigismondiana dei sogni: il tenero angioletto che si sveglia nottetempo e tra le nuvole del sonno vede i grandi che non si sa cosa stanno facendo, tutti nudi e in posizioni incomprensibili, mamma e papà e altri invitati. Nel sogno parla il fato.
Se si vuole, nell’arcano detto del Giudizio o dell’Angelo si può riconoscere la scena primaria a cui rimanda la dottrina sigismondiana dei sogni: il tenero angioletto che si sveglia nottetempo e tra le nuvole del sonno vede i grandi che non si sa cosa stanno facendo, tutti nudi e in posizioni incomprensibili, mamma e papà e altri invitati. Nel sogno parla il fato.
 Non ci resta che prenderne atto. Edipo, che non ne sapeva niente, si strappa il lume degli occhi: letteralmente il tarocco dell’Eremita lo presenta mentre si toglie dagli occhi un lume, e prende la via di Colono col mantello e il bastone del pellegrino. Di tutto questo la scrittura avverte come l’oracolo e purifica come la tragedia. Insomma, non c’è da farsene un problema [...]"
Non ci resta che prenderne atto. Edipo, che non ne sapeva niente, si strappa il lume degli occhi: letteralmente il tarocco dell’Eremita lo presenta mentre si toglie dagli occhi un lume, e prende la via di Colono col mantello e il bastone del pellegrino. Di tutto questo la scrittura avverte come l’oracolo e purifica come la tragedia. Insomma, non c’è da farsene un problema [...]"- (cfr. I. Calvino, "Anch’io cerco di dire la mia", "Romanzi e racconti" II, Meridiani, Mondadori, 1992, pp. 592-595).
*
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980) --- SCIENZA, LETTERATURA E "LIVELLI DI REALTÀ" (1978): MEMORIA (2023) DI UNA LEZIONE DI "NUOVO REALISMO" DAL "VECCHIO" CALVINO.23 ottobre 2023, di Federico La Sala
SCIENZA, LETTERATURA E "LIVELLI DI REALTÀ" (1978):
UNA LEZIONE DI "NUOVO REALISMO" DAL "VECCHIO" ITALO CALVINO (1923-1985).
- "Storie su storie, piani su piani, o la realtà in livelli" (di Nelson Goodman - Relazione tenuta al Convegno internazionale «Livelli della realtà» (Palazzo Vecchio, Firenze, 9-13 settembre 1978): cfr. AA. VV., Livelli di realtà, a c. di Massimo Piattelli Palmarini, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 111-121);
- "La letteratura e la realtà dei livelli" (di Italo Calvino - Relazione tenuta al Convegno internazionale «Livelli della realtà» (Palazzo Vecchio, Firenze, 9-13 settembre 1978): cfr. AA. VV., Livelli di realtà, a c. di Massimo Piattelli Palmarini, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 432 - 443);
ITALO CALVINO, "Je ne suis pas satisfait de la littérature actuelle en Italie (“Gazzette de Lausanne”, 3-4 giugno 1967): *
- «Io non sono tra coloro che credono che esista solo il linguaggio, o solo il pensiero umano. (Ce ne sono
anche tra coloro che passano per "realisti"). Io credo che esista una realtà e che ci sia un rapporto (seppure
sempre parziale) tra la realtà e i segni con cui la rappresentiamo. La ragione della mia irrequietudine
stilistica, dell’insoddisfazione riguardo ai miei procedimenti, deriva proprio da questo fatto. Io credo che il
mondo esiste indipendentemente dall’uomo; il mondo esisteva prima dell’uomo ed esisterà dopo, e l’uomo è
solo un’occasione che il mondo ha per organizzare alcune informazioni su se stesso. Quindi la letteratura è
per me una serie di tentativi di conoscenza e di classificazione delle informazioni sul mondo, il tutto molto
instabile e relativo ma in qualche modo non inutile» («Gazzette de Lausanne», 3-4 giugno)".
 (cfr. I. CALVINO, Je ne suis pas satisfait de la littérature actuelle en Italie, in “Gazzette de Lausanne”, 3-4
giugno 1967, citato da C. Milanini in I. C., "Romanzi e racconti" II, Meridiani, Mondadori, 1992, pag. XXIII).
(cfr. I. CALVINO, Je ne suis pas satisfait de la littérature actuelle en Italie, in “Gazzette de Lausanne”, 3-4
giugno 1967, citato da C. Milanini in I. C., "Romanzi e racconti" II, Meridiani, Mondadori, 1992, pag. XXIII).
B)
ITALO CALVINO, "La letteratura e la realtà dei livelli":
- "I vari livelli di realtà esistono anche in letteratura, anzi la letteratura si regge proprio sulla distinzione di diversi livelli di realtà e sarebbe impensabile senza la coscienza di questa distinzione. L’opera letteraria potrebbe essere definita come un’operazione nel linguaggio scritto che coinvolge contemporaneamente più livelli di realtà. Da questo punto di vista una riflessione sull’opera letteraria può essere non inutile allo scienziato e al filosofo della scienza [...].
- [...] Al termine di questa relazione m’accorgo d’aver sempre parlato di “livelli di realtà” mentre il tema del nostro convegno suona (almeno in italiano): “I livelli della realtà”. Il punto fondamentale della mia relazione forse è proprio questo: la letteratura non conosce la realtà ma solo livelli. Se esista la realtà di cui i vari livelli non sono che aspetti parziali, o se esistano solo i livelli, questo la letteratura non può deciderlo. La letteratura conosce la realtà dei livelli e questa è una realtà che conosce forse meglio di quanto non s’arrivi a conoscerla attraverso altri procedimenti conoscitivi. È già molto" (cfr. I. Calvino, "La letteratura e la realtà dei livelli, op. cit., p. 432, e, p. 443).
C)
Per gli Atti del Convegno Internazionale «Livelli della realtà» (Palazzo Vecchio, Firenze, 9-13 settembre 1978), pubblicati anni dopo, cfr. il volume, "Livelli di realtà", a c. di Massimo Piattelli Palmarini (Feltrinelli, Milano 1984), e, per una recensione, cfr. Federico La Sala, "Livelli di realtà" ("Alfabeta", 66, 1984).
fls
-
>SCIENZA, LETTERATURA E "LIVELLI DI REALTÀ": "IO HO ASCOLTATO LE SIRENE" (ITALO CALVINO, 1978): --- LE SIRENE, TRA SILENZIO E CANTO (DI GIUSEPPE ZUCCARINO).23 ottobre 2023, di Federico La Sala
LE SIRENE, TRA SILENZIO E CANTO
DI GIUSEPPE ZUCCARINO (La dimora del tempo sospeso,, 3 giugno 2009)
Una delle Nuove poesie di Rilke introduce una insolita trattazione del tema dell’incontro fra Ulisse e le sirene. L’eroe greco, non nominato ma facilmente identificabile, confessa la difficoltà che sperimenta quando, nel narrare la storia dei suoi viaggi, tenta di trasmettere agli ascoltatori un’adeguata sensazione di spavento, allorché giunge a parlare «di quell’isole // la cui vista fa sì che muti volto / il pericolo, e non è più nel rombo, / non nel tumulto come sempre era; / ma senza suono assale i marinai // i quali sanno che là su quell’isole / dorate qualche volta s’ode un canto, / ed alla cieca premono sui remi, / come accerchiati // da quel silenzio che tutto lo spazio / immenso ha in sé e nelle orecchie spira / quasi fosse la faccia opposta del silenzio / il canto cui nessun uomo resiste»(1).
La lirica è volutamente ambigua, e si offre a diverse interpretazioni. I marinai della nave di Odisseo sono forse impauriti da ciò che hanno sentito dire sull’efficacia micidiale del canto delle sirene e si affrettano per timore che esso li raggiunga loro malgrado; ma secondo la narrazione omerica hanno le orecchie turate con la cera, quindi un simile timore parrebbe privo di fondamento. D’altro canto la cera che li protegge impedisce loro di appurare se il silenzio che odono è effettivo o illusorio. Chi non dovrebbe avere dubbi al riguardo è Ulisse, ma su di lui e sul suo ascolto i versi rilkiani si mostrano reticenti: non sappiamo dunque se l’idea, suggeritagli da Circe, di farsi legare all’albero maestro della nave per poter udire senza pericolo il canto delle sirene abbia avuto un senso, o se invece la precauzione si sia rivelata vana, poiché nessuna voce melodiosa è risuonata a partire dalle isole dorate. Neppure il fatto che nel finale si dica che il canto irresistibile può essere pensato come l’altra faccia del silenzio ci soccorre, intanto perché non sappiamo se tale riflessione abbia origine dall’esperienza dei marinai o da quella (che in ogni caso sarà stata diversa) di Ulisse, e poi perché ignoriamo in quale rapporto si trovino fra loro le due facce. La loro differenza potrebbe infatti essere estrema, come quella che separa due realtà di natura opposta, oppure assai minore, analoga a quella che distingue i due lati, inseparabili, di una stessa moneta o medaglia.
C’è un altro testo del primo Novecento che, se scioglie il dubbio sul prodursi o meno del canto, ne crea però altri. È un famoso brano di Kafka, rimasto inedito durante la vita dell’autore ma incluso da Brod fra i racconti postumi col titolo Il silenzio delle sirene(2). Se lo si ricolloca nel contesto originario costituito dai quaderni di appunti kafkiani, esso può prestarsi ad essere letto, oltre che in chiave narrativa, anche in modi differenti, ad esempio come una riflessione o una parabola(3). In questa annotazione, di cui conosciamo con esattezza la data (23 ottobre 1917), Kafka trasforma la versione omerica della storia, arricchendola di implicazioni inattese. Qui i marinai non compaiono più, e il confronto fra Odisseo e le sirene si fa diretto. È lui stesso che ha turato le proprie (e non le altrui) orecchie con la cera e si è legato alla nave. Si tratta, a ben vedere, di vani espedienti, in quanto «il canto delle sirene penetrava tutto, figurarsi la cera, e la passione di coloro che venivano sedotti avrebbe spezzato ben altro che catene e alberi maestri». Ma l’eroe non sospetta che i mezzi di difesa da lui adottati siano inefficaci, così come ignora che l’arma più terribile delle sirene non è la loro voce bensì il loro silenzio, capace di suscitare in chi ritenga di averle sconfitte un orgoglio smisurato e rovinoso. «E davvero, quando Odisseo arrivò, le potenti cantatrici non cantavano, sia che credessero che solo il silenzio potesse aver la meglio su quell’avversario, sia che la vista della felicità sul viso di Odisseo, che non pensava ad altro che a cera e catene, facesse loro dimenticare ogni canto». Il silenzio, però, non viene avvertito come tale da Ulisse, il quale, nella sua ingenuità, crede che le sirene stiano cantando, e che solo la cera gli impedisca di udirle. Esse, pur essendo munite di artigli, devono così accontentarsi di «afferrare, finché era possibile, il riflesso lucente degli occhi immensi di Odisseo». La loro arma più potente, il silenzio, è stata neutralizzata dall’eroe, ma la sconfitta non le ha condotte all’annientamento, come sarebbe accaduto «se le sirene avessero coscienza»: anche per loro dunque, come per Ulisse, l’inconsapevolezza sembra essere il mezzo migliore per garantirsi la sopravvivenza.
Però a proposito del greco, precisa Kafka, «la tradizione aggiunge un’appendice», da cui si apprende che forse la sua fama di scaltrezza era giustificata, in quanto egli potrebbe aver finto di non accorgersi che le sirene tacevano, recitando una commedia rivelatasi comunque efficace. Questa aggiunta rende ancor più problematico il senso della storia, poiché se già non si capiva come un Ulisse ingenuo potesse evitare di incorrere in quell’orgoglio che - a detta del narratore - costituisce l’effetto più temibile prodotto dal silenzio delle sirene, tanto meno dovrebbe esserne esente l’individuo capace di una così abile finzione di inconsapevolezza. Se quel che Kafka si proponeva inizialmente di dimostrare era che «anche mezzi insufficienti, anzi infantili, possono servire alla salvezza», dobbiamo dedurne che né l’ingenuità né l’astuzia riescono a sottrarsi ai difetti di insufficienza e infantilismo, pur potendo risultare, in qualche caso, salvifiche.
Ma non sempre, in Kafka, le sirene tacciono. In una lettera, commentando una missiva di mano femminile che giudica «tanto bella quanto ripugnante», egli osserva: «Anche le sirene cantavano così, si fa loro torto se si pensa che volessero sedurre, sapevano di avere gli artigli e il grembo sterile, di ciò si lamentavano a gran voce, non avevano colpa se il loro lamento era così bello»(4). All’origine del canto delle sirene vi sono quindi, secondo lo scrittore praghese, dei gemiti di dolore. Esse soffrono di una sorta di complesso di inferiorità nei riguardi delle donne, o in genere degli esseri femminili di una sola specie, che a differenza degli ibridi hanno la possibilità di trovare un compagno e di riprodursi. Ciò che le rende infelici è la loro natura biforme: gli artigli fanno pensare che si tratti di donne-uccello, secondo la tradizione più antica (certo condivisa da Omero, che peraltro non le descrive), e non di donne-pesce. Il fatto che i loro lamenti risuonino come un canto non ne allevia il dolore, e nel contempo le rende un pericolo per chi ascolta. La condizione delle sirene è dunque per certi versi paragonabile a quella di un’altra creatura kafkiana, l’agnello-gatto del racconto Un incrocio, innocuo e amato dai bambini (i quali però, in un momento di lucidità, non mancano di chiedersi «perché non ha cuccioli») e tuttavia isolato dagli altri animali, tanto che il suo proprietario, che pure gli è affezionato, non può impedirsi di pensare che per un simile essere «il coltello del macellaio» sarebbe forse la migliore liberazione(5).
Che quello delle sirene non sia un canto felice è anche l’opinione di Maurice Blanchot: «Pare che cantassero, ma in un modo che non soddisfaceva, che lasciava appena intendere in quale direzione si aprissero le vere sorgenti e la vera felicità del canto. Tuttavia, coi loro canti imperfetti che erano un canto ancora a venire, guidavano il navigante verso quello spazio dove il canto potrebbe cominciare veramente»(6). E si tratta di uno spazio insidioso, raggiunto il quale non resta che sparire. Ignoriamo quale difetto contrassegnasse il modo di cantare delle sirene, conferendogli al tempo stesso un potere irresistibile: forse suonava come disumano, estraneo all’uomo, oppure somigliava al nostro, ma a un punto tale «da suscitare in chi lo ascoltasse il sospetto della non umanità di ogni canto umano». Blanchot aggiunge: «C’era qualcosa di meraviglioso in questo canto reale, canto comune, segreto, canto semplice e quotidiano, che tutto a un tratto si dava a riconoscere, cantato irrealmente da potenze estranee e (diciamolo) immaginarie, canto dell’abisso: che, ascoltato una volta, apriva in ogni parola un abisso e invitava con forza a sparirvi dentro». Lo scrittore non vede in un simile invito alcun intento malevolo, e trova ingiusta l’accusa tradizionalmente rivolta alle sirene di essere menzognere e ingannevoli. Il suo biasimo si rivolge semmai ad Ulisse, a colui che perfidamente ha voluto «godere dello spettacolo delle Sirene, senza rischio e senza accettarne le conseguenze, vile, mediocre e pacifico godimento, misurato come si addice a un Greco della decadenza che non meritò mai di essere l’eroe dell’Iliade».
E nonostante ciò, l’illusione, da parte di Ulisse, di essersi liberato delle sirene, di averle sconfitte con il suo buon senso, si è rivelata infondata, perché «esse l’attirarono là dove egli non voleva cadere, e, nascoste dentro l’Odissea divenuta il loro sepolcro, lo impegnarono, lui e molti altri, a quella navigazione felice, infelice, che è il racconto». Ulisse, dunque, ha avuto bisogno di accostarsi alle sirene tanto da ascoltarne il canto, per avere un’esperienza realmente profonda da raccontare, ma ha dovuto sottrarsi a questo canto per poter sopravvivere e dar vita alla narrazione. Così - riassume in una fulminea sintesi Blanchot - «Ulisse diventa Omero»(7).
Michel Foucault ci aiuta a capire meglio il senso del discorso blanchotiano, e nel contempo lo sposta leggermente; finisce, come tutti, col narrare a suo modo la stessa storia, che cessa quindi di essere la stessa. «Le sirene sono la forma inafferrabile e proibita della voce che attrae. Non sono altro che canto. [...] La loro musica è il contrario di un inno: nessuna presenza scintilla nelle loro parole immortali; solo la promessa di un canto futuro ne percorre la melodia. È per questo che le sirene seducono, non tanto per ciò che fanno udire, ma per ciò che brilla nella lontananza delle loro parole, l’avvenire di quel che stanno per dire. Il loro fascino non nasce dal canto attuale, ma da quello che s’impegna a essere. Ora, ciò che le sirene promettono a Ulisse di cantare è il passato delle sue stesse imprese, trasformate per il futuro in poema: “Noi conosciamo le sventure, tutte le sventure che gli dèi nei campi della Troade hanno inflitto alle genti di Argo e di Troia”. Offerto come in cavo, il canto non è che l’attrazione del canto, ma non promette all’eroe nient’altro se non la copia di quel che ha già vissuto, conosciuto, sofferto, nient’altro se non lui stesso»(8). Ciò che le sirene promettono è falso, perché chi si lasciasse sedurre dalla loro voce incontrerebbe la morte, ma nel contempo è vero, «poiché è attraverso la morte che il canto potrà elevarsi e narrare all’infinito l’avventura degli eroi»(9). L’astuto greco, quindi, si è fermato sulla soglia dell’abisso, e grazie a ciò ha potuto in seguito raccontare quel poco che gli è giunto del canto delle sirene. E tuttavia - ipotizza Foucault - «può darsi che sotto il racconto trionfante di Ulisse regni il pianto inudibile per non aver ascoltato meglio e più a lungo, per non essersi immerso il più vicino possibile alla mirabile voce, là dove il canto forse si sarebbe compiuto»(10).
Degli autori finora citati, Foucault è il solo a far presente che quello udito da Ulisse non è, nel poema che ce ne ha trasmesso la storia, un canto senza parole. Cos’abbiano detto - o meglio, cominciato a dire - le sirene, ci è noto grazie all’eroe stesso, che ce lo riferisce: «Qui, presto, vieni, o glorioso Odisseo, grande vanto degli Achei, / ferma la nave, la nostra voce a sentire. / Nessuno mai si allontana di qui con la sua nave nera, / se prima non sente, suono di miele, dal labbro nostro la voce; / poi pieno di gioia riparte, e conoscendo più cose. / Noi tutto sappiamo, quanto nell’ampia terra di Troia / Argivi e Teucri patirono per volere dei numi; / tutto sappiamo quello che avviene sulla terra nutrice»(11). Come notava Foucault, la promessa contenuta in questi versi è quella di cantare le vicende della guerra di Troia, quindi anche la storia dello stesso Ulisse. Che un passo del genere presenti forti implicazioni metapoetiche è stato rilevato con acume da Italo Calvino: «Cosa cantano le Sirene? Un’ipotesi possibile è che il loro canto non sia altro che l’Odissea. La tentazione del poema d’inglobare se stesso, di riflettersi come in uno specchio si presenta varie volte nell’Odissea, specialmente nei banchetti dove cantano gli aedi; e chi meglio delle Sirene potrebbe dare al proprio canto questa funzione di specchio magico?»(12). Benché Calvino richiami subito dopo, elogiandolo, il testo di Blanchot, il ragionamento che propone nel passo citato conduce di fatto a una diversa conclusione: per lui sono le sirene, e non Ulisse, a diventare Omero.
In un saggio successivo, tornando ad esaminare in modo più articolato i diversi effetti di autoreferenzialità presenti nel poema, Calvino riprende la tesi che già conosciamo, ma con una correzione di non poco rilievo: «Ulisse incontra le Sirene che cantano; che cosa cantano? Ancora l’Odissea, forse uguale a quella che stiamo leggendo, forse diversissima»(13). L’ultima ipotesi nasce dalla constatazione che nell’opera omerica la storia di Ulisse viene raccontata varie volte in modi differenti, da altri personaggi ma anche dallo stesso protagonista, che del resto ha fama di essere un provetto ingannatore. A questo punto risulta difficile stabilire quale sia la versione più «autentica» delle avventure dell’eroe, e a fortiori immaginare se proprio quella e non un’altra sarebbe divenuta oggetto del canto delle sirene.
Forse, si potrebbe aggiungere, la lusinga irresistibile legata a quel canto dipendeva proprio dal fatto che esso offriva ad ogni navigante una versione, se non fantasiosa, quanto meno abbellita, e resa dunque più affascinante, della sua storia. Anche per questo le sirene si prestano a diventare un’immagine del discorso letterario, che, proprio perché sa mentire (e sa di mentire), è sempre persuasivo e coinvolgente. Questa capacità di trasformare i dati del reale è ciò che, più di ogni altra cosa, accomuna davvero quelle tre entità mitiche - e sia pure diversamente mitiche - che sono le sirene, Ulisse ed Omero. Infatti anche quest’ultimo appare per molti versi assimilabile ai personaggi dei poemi che la tradizione gli attribuisce: «Come gli antichi hanno sempre saputo, l’esistenza di Omero poeta è mitologia, come partecipa della mitologia il leggere Omero»(14). Chi legge l’Odissea può percepire le vicende narrate come irreali, ma può ugualmente - come infatti avviene da un buon numero di secoli - farsi catturare nello spazio della finzione, fino a interrogarsi e fantasticare su simili eventi. Fra questi l’incontro di Ulisse con le sirene è stato e continuerà ad essere uno dei più suggestivi, specie per quei particolari lettori (ricettivi, ma inclini a reinventare) che sono gli scrittori.
Tratto da: Giuseppe Zuccarino, Da un’arte all’altra, Novi Ligure (AL), Edizioni Joker, “Materiali di Studio”, 2009.
Note
(1) Rainer Maria Rilke, L’isola delle sirene (1907), in Nuove poesie - Requiem, tr. it. Torino, Einaudi, 1992, p. 203.
 (2) Franz Kafka, Il silenzio delle sirene, in Racconti, tr. it. Milano, Mondadori, 1970, pp. 428-429.
(2) Franz Kafka, Il silenzio delle sirene, in Racconti, tr. it. Milano, Mondadori, 1970, pp. 428-429.
 (3) Lo si veda in F. Kafka, Il silenzio delle sirene. Scritti e frammenti postumi (1917-1924), tr. it. Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 44-46 (da cui si cita).
(3) Lo si veda in F. Kafka, Il silenzio delle sirene. Scritti e frammenti postumi (1917-1924), tr. it. Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 44-46 (da cui si cita).
 (4) F. Kafka, lettera a Robert Klopstock del novembre 1921, in Lettere, tr. it. Milano, Mondadori, 1988, p. 430.
(4) F. Kafka, lettera a Robert Klopstock del novembre 1921, in Lettere, tr. it. Milano, Mondadori, 1988, p. 430.
 (5) Cfr. F. Kafka, Un incrocio (1917, ma pubblicato postumo nel 1931), in Racconti, cit., pp. 422-424.
(5) Cfr. F. Kafka, Un incrocio (1917, ma pubblicato postumo nel 1931), in Racconti, cit., pp. 422-424.
 (6) M. Blanchot, Le chant des Sirènes, I. La rencontre de l’imaginaire, in Le livre à venir, Paris, Gallimard, 1959; 1986, p. 9 (tr. it. Il canto delle Sirene, I. L’incontro con l’immaginario, in Il libro a venire, Torino, Einaudi, 1969, p. 13).
(6) M. Blanchot, Le chant des Sirènes, I. La rencontre de l’imaginaire, in Le livre à venir, Paris, Gallimard, 1959; 1986, p. 9 (tr. it. Il canto delle Sirene, I. L’incontro con l’immaginario, in Il libro a venire, Torino, Einaudi, 1969, p. 13).
 (7) Per tutte le citazioni, cfr. ibid., pp. 10-14 (tr. it. pp. 13-16).
(7) Per tutte le citazioni, cfr. ibid., pp. 10-14 (tr. it. pp. 13-16).
 (8) M. Foucault, La pensée du dehors (1966), Montpellier, Fata Morgana, 1986, pp. 41-42 (tr. it. Il pensiero del fuori, Milano, SE, 1998, pp. 43-44).
(8) M. Foucault, La pensée du dehors (1966), Montpellier, Fata Morgana, 1986, pp. 41-42 (tr. it. Il pensiero del fuori, Milano, SE, 1998, pp. 43-44).
 (9) Ibid., p. 42 (tr. it. p. 44).
(9) Ibid., p. 42 (tr. it. p. 44).
 (10) Ibid., p. 44 (tr. it. p. 45).
(10) Ibid., p. 44 (tr. it. p. 45).
 (11) Omero, Odissea, XII, vv. 184-191, tr. it. Torino, Einaudi, 1963; 1984, p. 339.
(11) Omero, Odissea, XII, vv. 184-191, tr. it. Torino, Einaudi, 1963; 1984, p. 339.
 (12) I. Calvino, I livelli della realtà in letteratura (1978), in Una pietra sopra (1980); ora in Saggi, Milano, Mondadori, 1995, p. 396.
(12) I. Calvino, I livelli della realtà in letteratura (1978), in Una pietra sopra (1980); ora in Saggi, Milano, Mondadori, 1995, p. 396.
 (13) I. Calvino, Le Odissee nell’Odissea (1981), in Saggi, cit., pp. 888-889.
(13) I. Calvino, Le Odissee nell’Odissea (1981), in Saggi, cit., pp. 888-889.
 (14) Giorgio Manganelli, Omero: Odissea (1981), in Laboriose inezie, Milano, Garzanti, 1986, p. 18.
(14) Giorgio Manganelli, Omero: Odissea (1981), in Laboriose inezie, Milano, Garzanti, 1986, p. 18.
-
>"FESTINA LENTE": IL MOTTO DI ITALO CALVINO, L’ARMONIA NASCOSTA DI ERACLITO, E LA VIA CRITICA DI KANT.1 novembre 2022, di Federico La Sala
Filologia e Letteratura...
"FESTINA LENTE": IL MOTTO DI ITALO CALVINO, L’ARMONIA NASCOSTA DI ERACLITO, E LA VIA CRITICA DI KANT. Alcuni appunti...
A) LA FARFALLA E IL GRANCHIO. In "Rapidità", una delle "Lezioni americane", Italo Calvino così scrive: "Già dalla mia giovinezza ho scelto come mio motto l’antica massima latina Festina lente, affrettati lentamente. Forse più che le parole e il concetto è stata la suggestione degli emblemi ad attrarmi. [...] Come la farfalla e il granchio che illustrano il Festina lente nella raccolta d’emblemi cinquecenteschi di Paolo Giovio, due forme animali entrambe bizzarre ed entrambe simmetriche, che stabiliscono tra loro un’inattesa armonia".
B) LA TARTARUGA E LA VELA. A Firenze, a PalazzoVecchio, l’ impresa di Cosimo I de’ Medici: tartaruga con la vela
C) ARISTOTELISMO RINASCIMENTALE. Su un libro delle opere di Aristotele, stampato a Lione intorno alla prima metà del 1500 dall’editore Jean Frellon, c’è la "marca tipografica, granchio che afferra una farfalla con la scritta «Matura»".
D) SERENDIPITY. "L’armonia nascosta vale di più di quella che appare" (Eraclito, fr. 54): per chi, per primo ha esortato a seguire il Logos (fr. 2), non c’è motivo di dubitarne!
E) LA FARFALLA (anima) E IL GRANCHIO (corpo): I "SOGNATORI della ragione", I "SOGNATORI dell’ esperienza", e la via critica di KANT. In un passaggio del suo lavoro sui "Sogni di un visionario spiegati coi sogni della metafisica", all’inizio del terzo capitolo della prima parte, Kant cita Eraclito e, incredibilmente, scrive: "Aristotele dice in qualche punto: «Quando siamo svegli abbiamo un mondo comune, ma quando sogniamo, ciascuno ha il proprio». Mi pare che si potrebbe benissimo invertire l’ultima proposizione e dire: se di diversi uomini ciascuno ha il suo mondo proprio, è da supporre che essi sognino" (Kant, 1766).
 A ben pensare e, al di là di tutta la vecchia idealistica e materialistica storiografia, l’errore di Kant non è né un refuso né un lapsus: egli ha colto l’armonia nascosta al fondo della riflessione di Eraclito e Aristotele, e, come Ulisse-Dante, ha capito l’unione di "Scilla e Cariddi", e riprende la sua navigazione nell’oceano celeste (Keplero): una seconda rivoluzione copernicana è già cominciata! Un altro mondo è possibile... la colomba ha imparato a "orientarsi nel pensiero" e nella realtà.
A ben pensare e, al di là di tutta la vecchia idealistica e materialistica storiografia, l’errore di Kant non è né un refuso né un lapsus: egli ha colto l’armonia nascosta al fondo della riflessione di Eraclito e Aristotele, e, come Ulisse-Dante, ha capito l’unione di "Scilla e Cariddi", e riprende la sua navigazione nell’oceano celeste (Keplero): una seconda rivoluzione copernicana è già cominciata! Un altro mondo è possibile... la colomba ha imparato a "orientarsi nel pensiero" e nella realtà. -
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- "ASTEROID DAY". Cosmicomiche - non cosmitragiche! "Divinacommedia" si trova nella fascia degli asteroidi fra Marte e Giove, a 381 milioni di chilometri dal Sole (Ansa).30 giugno 2021, di Federico La Sala
#AsteroidDay:
#Dante2021.
#Cosmicomiche - non cosmitragiche!
aveva perfettamente #ragione.
"Divina commedia"
si trova nella fascia degli asteroidi
fra #Marte e #Giove,
a 381 milioni di chilometri dal
#Sole
***
L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE
(#Dante).
#Storia dell’#astronomia:
"La conoscenza degli effetti e la ignoranza delle cause produsse l’#astrologia"
(#Giacomo Leopardi).
#SapereAude!
(#Kant):
#Ingenuity
(Pianeta #Marte, 2021).
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- Italo Calvino: vivere ogni secondo per vincere il tragico divenire. Intervista del 1985 (di Michele Neri).9 maggio 2021, di Federico La Sala
IL TEMPO NELLA LETTERATURA E NELLA REALTA’
di Italo Calvino (Le parole e le cose, 1 Luglio 2013)*
[Sono nato in America (Mondadori) - a cura di Luca Baranelli, e con un saggio introduttivo di Mario Barenghi - raccoglie 101 interviste a Italo Calvino disposte in un arco di tempo di trentacinque anni (1951-1985). Molte erano rimasta finora confinate e nascoste nei giornali e nelle riviste che le avevano a suo tempo ospitate. Presentiamo un’intervista che Calvino concesse nel gennaio del 1985 a Michele Neri. Ringraziamo l’editore e il curatore del volume per averci permesso di ripubblicarla in questa sede]
- «Riassumendo: per fermarmi in t0 devo stabilire una configurazione oggettiva di t0; per stabilire una configurazione oggettiva di t0 devo spostarmi in t1; per spostarmi in t1 devo adottare una qualsiasi prospettiva soggettiva, quindi tanto vale che mi tenga la mia. Riassumendo ancora: per fermarmi nel tempo devo muovermi col tempo, per diventare oggettivo devo mantenermi soggettivo [...] Ma il pericolo che corro è che il contenuto di t1, dell’istante-universo t1, sia talmente più ricco di t0, in emozioni e sorprese non so se trionfali o rovinose, che io sia tentato di dedicarmi tutto a t1, voltando le spalle a t0, dimenticandomi che sono passato a t1 solo per informarmi meglio su t0».
Sono le riflessioni conclusive dell’esitante protagonista di Ti con zero, un racconto di Italo Calvino dedicato al tema del tempo e ristampato ora nella raccolta Cosmicomiche vecchie e nuove. Che cosa ne pensa, a diciassette anni dalla pubblicazione? Perché una notazione scientifica per descrivere l’istante?
In Ti con zero cerco di vedere il tempo con la concretezza con cui si vede lo spazio. Nel racconto, ogni secondo, ogni frazione di tempo è un universo. Ho abolito tutto il prima e tutto il dopo fissandomi così sull’istante nel tentativo di scoprirne l’infinita ricchezza. Vivere il tempo come tempo, il secondo per quello che è, rappresenta un tentativo di sfuggire alla drammaticità del divenire. Quello che riusciamo a vivere nel secondo è sempre qualcosa di particolarmente intenso, che prescinde dall’aspettativa del futuro e dal ricordo del passato, finalmente liberato dalla continua presenza della memoria. Ti con zero contiene l’affermazione del valore assoluto di un singolo segmento del vissuto staccato da tutto il resto.
Si tratta allora di un racconto che accoglie una visione «felice» del tempo? O piuttosto di un’estrema tragicità?
Ti con zero è lo sforzo di trovare la maniera migliore di abitare la tragicità. C’è ovviamente anche un modo migliore per superare la tragicità: dare una forma al divenire. Ma per far questo bisogna credere alla possibilità di dare una forma qualsivoglia alla propria vita, creando una storia con un senso compiuto. Ma a questa possibilità, che consentirebbe probabilmente un grado maggiore di felicità, credo sempre meno.
Proust e Joyce, Borges e Valéry, Baudelaire e Musil: la letteratura moderna sembra costituire un ponte emotivo e razionale tra uomo e tempo, percezione del tempo universale, storico e sociale e esperienza del tempo mentale. Italo Calvino è lo scrittore italiano più sensibile alle problematiche temporali della letteratura, il più adatto a trovare i punti di contatto tra tempo e scrittura.
Il tempo interviene in letteratura in modi diversi. Ci sono alcuni autori che trattano il tempo come un problema: è proprio il tempo l’unico argomento dei loro romanzi. Un esempio straordinario è un racconto di Borges intitolato Il giardino dei sentieri che si biforcano in cui, sotto l’insolita veste del thriller, l’autore presenta una suggestiva teoria del tempo secondo la quale questo è plurimo e a ogni istante della vita si aprono due tracce temporali diverse, che, appunto, si biforcano. Il tempo è un ente sempre più complesso, proprio come conferma l’intuizione. Fanno parte di questa categoria un romanzo come La macchina del tempo di Herbert George Wells, il mio racconto Ti con zero, o ancora il romanzo I fiori blu di Raymond Queneau. In quest’ultimo la storia è vista come sogno, deposito tangibile del nostro inconscio. Queneau è stato a lungo in analisi e il tempo dell’analisi, dell’inconscio, è il vero protagonista di questo libro. E la delicata ironia di Queneau contrappone ai massacri, ai rivolgimenti della storia una saggezza perfettamente statica, ma non per questo meno ricca della romantica ansia del divenire. C’è poi chi rappresenta il tempo nel suo fluire, confuso, immenso. È il caso della Recherche di Marcel Proust.
Qual è la suggestione maggiore del romanzo di Proust?
Il fascino più grande è nel fatto che nel romanzo, tutto, ogni singola azione, gravita naturalmente verso il finale, verso il ritrovamento del tempo come spinto da una corrente. È il libro che in assoluto si avvicina di più a rendere quella sensazione inesprimibile che è poi il modo con cui noi abitiamo il tempo. In un terzo gruppo metterei chi affronta il tempo nella forma che dà alla narrazione. Joyce, per esempio, con il monologo interiore. O ancora Joseph Conrad con il continuo ribaltamento della prospettiva con cui è vista la realtà grazie all’intervento di narratori diversi, ognuno con un suo tempo, un suo spazio.
È tipico della natura del tempo presentarsi in ogni situazione sotto un aspetto molteplice, occupando sempre un posto più importante del previsto. Il tempo non è solo argomento, sfondo in eterno movimento ed espediente dell’opera letteraria. Il tempo, attraverso la forma che assume nel ritmo, è il cuore della scrittura. Calvino, lei non ha mai pubblicato poesie: per una questione di ritmo?
In un certo senso sì: preferisco la prosa perché questa vive di ritmo ancora più della poesia. La poesia si può appoggiare a una metrica dichiarata o implicita mentre la prosa deve continuamente inventarsi un tempo, una musicalità. E la resa ritmica è fondamentale: un episodio straordinario può scomparire una volta sulla pagina se non si riesce a comunicare al lettore il tempo necessario. Trasmettere il senso della rapidità, oppure una pausa, dove la scrittura prende un respiro lento, diventando quasi un adagio, un largo musicale è di fatto lavorare sul tempo, perché la rapidità non è necessariamente espressa con parole e frasi corte, ma con un lavoro stilistico che la faccia sentire come una naturale accelerazione del battito del tempo.
Come nasce il suo ritmo?
La ricerca del ritmo giusto è per me un lavoro molto complesso. Spesso significa scrivere e riscrivere fino a quando la parola non ha trovato la vibrazione giusta. Ogni tanto il ritmo voluto può venire spontaneamente, ma sono casi eccezionali. E poi io non credo al ritmo innato, immediato. È l’effetto finale che deve essere spontaneo e vitale. Dietro c’è sempre molta fatica.
Regolando i cicli di funzionamento dell’organismo, amministrando con regolarità inconoscibile e pertanto incorreggibile gli alti e bassi della prestazione intellettuale, il tempo conosce un altro punto di contatto con la scrittura: il corpo umano. La cronobiologia ha per esempio individuato nella prima fascia del mattino, dalle sei e mezzo alle otto e mezzo, nove, il momento migliore per la produzione intellettuale. Sono molti gli scrittori che appena svegli si mettono subito al lavoro. Un esempio per tutti: Paul Valéry. Ogni giorno, con regola monacale, dalle cinque alle otto riempiva pagine e pagine del suo diario. E a questo proposito scriveva: «Ore otto. Svegliato prima delle cinque, mi sembra, alle otto, di aver già vissuto tutta una giornata con la mente e di aver diritto di essere bestia fino a sera». Anche lei è mattiniero?
No, la mia giornata è fatta di tanti sistemi per perdere il tempo, per ritardare il più possibile il momento in cui mi metto alla scrivania. Non sono certo mattiniero e finisce sempre che scrivo quando posso, alternando il tempo dedicato alla scrittura a quello destinato alle altre attività della giornata. Poi, nel mio lavoro, non c’è una netta separazione tra attività e riposo. Il tempo libero non esiste.
Palomar, Ti con zero, un costante interesse per le verità insieme precise e insufficienti della scienza e per le più recenti scoperte della ricerca... Calvino, si ritiene uno scrittore rivolto al domani e alle speculazioni sul futuro?
Sì, perché anche quando parlo del passato c’è sempre una forte tensione verso un futuro fantastico. In me persiste comunque la tentazione del passato e della memoria e tra i tanti libri che ho cominciato e non ho mai portato avanti ce n’è anche uno autobiografico. Avendo formato però la mia educazione letteraria in un’epoca in cui la letteratura della memoria e l’esempio di Proust erano molto in auge, ho sempre cercato di trascurare questa strada perché era già percorsa da tanti scrittori. Ma non ho dubbi: un giorno dovrò fare i conti anche con la mia autobiografia. Prima che il mio passato esca definitivamente dalla mia visuale. C’è però un libro, Le città invisibili, in cui cerco di esprimere la sensazione del tempo rimasto cristallizzato negli oggetti, contenuto nelle cose che ci circondano. Perché noi ci muoviamo in un presente che contiene sempre in sé anche un tempo passato. Le città non sono altro che forme del tempo. Di questo ho parlato nel capitolo La forma del tempo di Collezione di sabbia, dove cerco immagini visive del tempo. Per esempio, un albero millenario di cui non si distinguono più rami e radici o i fuochi dei riti zoroastriani che si perpetuano in continuità.
Ma questa memoria riguarda un tempo non suo, un passato che appartiene alle cose. Non tiene un diario per conservare il contenuto del suo passato?
Non scrivo un diario vero e proprio. Da parecchi anni sento però il bisogno di segnare su un taccuino gli eventi che hanno riempito le mie giornate. Quindi fatti abbastanza banali come cene, spettacoli e anche le tasse. E non posso più fare a meno di segnarli. Altrimenti mi sembrerebbe di perdere tutto il senso di ciò che ho fatto. Vedo gli anni in cui non mi ero ancora fissato questa pratica come una distesa dai contorni vaghi, da cui affiorano solo piccole isole, a caso.
In Palomar lei ha scritto: «Essere morto per Palomar significa abituarsi alla delusione di ritrovarsi uguale a se stesso in uno stato definitivo che non può più sperare di cambiare». Vivere è un continuo modificarsi?
Certo: quello che conta è la possibilità di dare un senso al passato con continue correzioni apportate al presente. La vita ha sempre bisogno di ritocchi, aggiunte, note a piè di pagina. Proprio come la pagina scritta. La morte interviene interrompendo questo processo e tutto diviene irrevocabile.
Il cambiamento inteso quale forza creatrice dell’universo avvicina la filosofia del tempo di Calvino alle teorie dello scienziato russo-belga Ilya Prigogine. E quando, nel 1980, uscì in Francia il saggio «La nuova alleanza», Calvino fu uno dei primi a elogiare questo libro sui giornali italiani.[1] La filosofia del tempo di Prigogine può avere un riflesso anche per l’uomo?
In un certo senso sì: come uomo la posizione di Prigogine m’interessa contrapposta a quella di Jacques Monod, che vedeva l’uomo completamente solo e sospeso tra caso e necessità nell’assoluta indifferenza dell’universo. Prigogine avanza invece l’immagine di una natura grande organismo di cui facciamo anche noi parte. È l’integrazione dell’uomo nel cosmo attraverso un intimo legame che passa per il tempo. E a questa comunione sono particolarmente sensibile. Anche se non ho il coraggio di esplicitare una filosofia, mi appassiona l’immagine di un universo unitario a cui siamo tutti chiamati a collaborare. Ho provato lo stesso fascino anche per le teorie di Mach, per cui anche quello che avviene su una stella lontanissima ha conseguenze su quello che ci capita. A cominciare dal principio d’inerzia: se sull’autobus che frena bruscamente sbatto contro il vicino questo fatto dipende dalla quantità di materia presente nell’universo. Prigogine ha compreso e spiegato che in quella fascia di universo in cui avvengono i fenomeni che ci toccano, il tempo ha un senso più ricco che non ha, per esempio, in un cosmo nelle sue continue oscillazioni o nell’invisibile del mondo subatomico.
Non c’è niente da fare: la tentazione di separare il tempo dell’uomo da quello della natura è troppo forte. Eppure l’intuizione dice che c’è un luogo e un momento in cui i due tempi si confondono: all’infinito. E non è forse questo il messaggio di una pagina dell’Uomo senza qualità di Robert Musil: «Aspettare a ogni momento già il successivo è soltanto un’abitudine; chiudi la diga e il tempo straripa come un lago. Le ore scorrono, è vero, ma sono più larghe che lunghe. Si fa sera, ma il tempo non è passato»?
Questa citazione ci mette effettivamente nel cuore del problema delle due accezioni del tempo. Quello scandito dai giorni, dalle notti, dai minuti misurati dalla nostra vita e dalla storia, e il tempo nel suo fluire infinito e incontrollato, sordo alle nostre esperienze temporali che non sono altro che granelli di sabbia nel deserto. Ed è basilare di ogni tentativo di «saggezza» farsi più vicini possibile al senso del tempo nella sua incommensurabilità. Invecchiando ho capito che questo vale anche su scala storica: ogni pretesa di accelerare la storia costringendola a tempi brevi è solo un’illusione. Contano solo i mutamenti lentissimi.
Nel libro che contiene Ti con zero c’è un altro racconto, L’inseguimento, dedicato al tema dello spazio. È più difficile parlare del tempo o dello spazio?
Pensare allo spazio e quindi scriverne è senz’altro meno tragico, perché lo spazio, se c’è, se ne sta buono buono. Il tempo, si sa, non sta mai fermo...
* Italo Calvino: vivere ogni secondo per vincere il tragico divenire, intervista di Michele Neri, «Panorama mese», IV, 1, gennaio 1985, pp. 71-74. Poi in Italo Calvino, Sono nato in America... Interviste 1951-1985, a cura di Luca Baranelli, Introduzione di Mario Barenghi, Mondadori, Milano 2012, pp. 597-603.
[1] No, non saremo soli, «la Repubblica», 3 maggio 1980, pp. 18-19; poi, col titolo Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, «La nuova alleanza», in Saggi, pp. 2038-44; poi in Mondo scritto e mondo non scritto, a cura di Mario Barenghi, Oscar Mondadori, Milano 2002, pp. 277-84.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- I DIRITTI DELLE DONNE E LE "POSIZIONI" DI PASOLINI, MAGRIS, CALVINO. Quel corpo è nostro (di Ilaria Romeo).8 novembre 2020, di Federico La Sala
I diritti delle donne
Quel corpo è nostro
di Ilaria Romeo (Collettiva, 08.11.2020)
L’8 novembre 1975 la Cassazione dichiara valido il numero di firme raccolte per il referendum abrogativo delle norme che vietano l’aborto. Il voto si terrà l’anno successivo tra polemiche e dibattiti spesso animati da una chiara misoginia come lo scontro tra Italo Calvino che difendeva la libertà femminile e Claudio Magris e Pier Paolo Pasolini, antiabortisti
Per stimolare ed affrettare il Parlamento all’approvazione di una legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, nel 1975 il Partito Radicale e il Mld prendono l’iniziativa di raccogliere le firme per un Referendum abrogativo delle norme del Codice penale che vietano l’aborto.
L’8 novembre 1975 la Cassazione dichiara valido il numero di firme per il referendum (se non subentrerà una nuova legge le votazioni dovranno tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno 1976). Scriveva Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera il 19 gennaio di quell’anno:
- Io sono per gli otto referendum del partito radicale, e sarei disposto ad una campagna anche immediata in loro favore. Condivido col partito radicale l’ansia della ratificazione, l’ansia cioè del dar corpo formale a realtà esistenti: che è il primo principio della democrazia. Sono però traumatizzato dalla legalizzazione dell’aborto, perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio.
 Nei sogni, e nel comportamento quotidiano - cosa comune a tutti gli uomini - io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente. Mi limito a dir questo, perché, a proposito dell’aborto, ho cose più urgenti da dire. Che la vita è sacra è ovvio: è un principio più forte ancora che ogni principio della democrazia, ed è inutile ripeterlo. La prima cosa che vorrei invece dire è questa: a proposito dell’aborto, è il primo, e l’unico, caso in cui i radicali e tutti gli abortisti democratici più puri e rigorosi, si appellano alla Realpolitik e quindi ricorrono alla prevaricazione “cinica” dei dati di fatto e del buon senso. Se essi si sono posti sempre, anzitutto, e magari idealmente (com’è giusto), il problema di quali siano i “principi reali” da difendere, questa volta non l’hanno fatto. Ora, come essi sanno bene, non c’è un solo caso in cui i “principi reali” coincidano con quelli che la maggioranza considera propri diritti. Nel contesto democratico, si lotta, certo per la maggioranza, ossia per l’intero consorzio civile, ma si trova che la maggioranza, nella sua santità, ha sempre torto: perché il suo conformismo è sempre, per propria natura, brutalmente repressivo. Perché io considero non “reali” i principi su cui i radicali ed in genere i progressisti (conformisticamente) fondano la loro lotta per la legalizzazione dell’aborto? Per una serie caotica, tumultuosa e emozionante di ragioni.
Nei sogni, e nel comportamento quotidiano - cosa comune a tutti gli uomini - io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente. Mi limito a dir questo, perché, a proposito dell’aborto, ho cose più urgenti da dire. Che la vita è sacra è ovvio: è un principio più forte ancora che ogni principio della democrazia, ed è inutile ripeterlo. La prima cosa che vorrei invece dire è questa: a proposito dell’aborto, è il primo, e l’unico, caso in cui i radicali e tutti gli abortisti democratici più puri e rigorosi, si appellano alla Realpolitik e quindi ricorrono alla prevaricazione “cinica” dei dati di fatto e del buon senso. Se essi si sono posti sempre, anzitutto, e magari idealmente (com’è giusto), il problema di quali siano i “principi reali” da difendere, questa volta non l’hanno fatto. Ora, come essi sanno bene, non c’è un solo caso in cui i “principi reali” coincidano con quelli che la maggioranza considera propri diritti. Nel contesto democratico, si lotta, certo per la maggioranza, ossia per l’intero consorzio civile, ma si trova che la maggioranza, nella sua santità, ha sempre torto: perché il suo conformismo è sempre, per propria natura, brutalmente repressivo. Perché io considero non “reali” i principi su cui i radicali ed in genere i progressisti (conformisticamente) fondano la loro lotta per la legalizzazione dell’aborto? Per una serie caotica, tumultuosa e emozionante di ragioni.
Un mese dopo anche lo scrittore Claudio Magris interverrà sulle pagine del Corriere esprimendo una posizione fortemente antiabortista e a tratti misogina che arrivava a irridere le misure igieniche in un articolo intitolato Gli sbagliati (nel 1981, imperterrito, Magris, in occasione del referendum sull’aborto, scriverà un altro articolo per il Corriere, schierandosi con gli avversari dell’aborto, come aveva già fatto. In questo caso però la testata aspetterà a pubblicare il pezzo all’indomani del referendum).
 A Pasolini - e a Claudio Magris - risponde, a caldo, Italo Calvino:
A Pasolini - e a Claudio Magris - risponde, a caldo, Italo Calvino:- Caro Magris, con grande dispiacere leggo il tuo articolo Gli sbagliati. Sono molto addolorato non solo che tu l’abbia scritto, ma soprattutto che tu pensi in questo modo.
- Mettere al mondo un figlio ha un senso solo se questo figlio è voluto, coscientemente e liberamente dai due genitori. Se no è un atto animalesco e criminoso. Un essere umano diventa tale non per il casuale verificarsi di certe condizioni biologiche, ma per un atto di volontà e d’amore da parte degli altri. Se no, l’umanità diventa -come in larga parte già è- una stalla di conigli. Ma non si tratta più della stalla “agreste”, ma d’un allevamento “in batteria” nelle condizioni d’artificialità in cui vive a luce artificiale e con mangime chimico. Solo chi - uomo e donna - è convinto al cento per cento d’avere la possibilità morale e materiale non solo d’allevare un figlio ma d’accoglierlo come una presenza benvenuta e amata, ha il diritto di procreare; se no, deve per prima cosa far tutto il possibile per non concepire e se concepisce (dato che il margine d’imprevedibilità continua a essere alto) abortire non è soltanto una triste necessità, ma una decisione altamente morale da prendere in piena libertà di coscienza.
 Non capisco come tu possa associare l’aborto a un’idea d’edonismo o di vita allegra. L’aborto è una cosa spaventosa. Nell’aborto chi viene massacrato, fisicamente e moralmente, è la donna; anche per un uomo cosciente ogni aborto è una prova morale che lascia il segno, ma certo qui la sorte della donna è in tali sproporzionate condizioni di disfavore in confronto a quella dell’uomo, che ogni uomo prima di parlare di queste cose deve mordersi la lingua tre volte.
Non capisco come tu possa associare l’aborto a un’idea d’edonismo o di vita allegra. L’aborto è una cosa spaventosa. Nell’aborto chi viene massacrato, fisicamente e moralmente, è la donna; anche per un uomo cosciente ogni aborto è una prova morale che lascia il segno, ma certo qui la sorte della donna è in tali sproporzionate condizioni di disfavore in confronto a quella dell’uomo, che ogni uomo prima di parlare di queste cose deve mordersi la lingua tre volte.
 Nel momento in cui si cerca di rendere meno barbara una situazione che per la donna è veramente spaventosa, un intellettuale impiega la sua autorità perché la donna sia mantenuta in questo inferno. Sei un bell’incosciente, a dir poco, lascia che te lo dica. Non riderei tanto delle “misure igienico-profilattiche”; certo, a te un raschiamento all’utero non te lo faranno mai. Ma vorrei vederti se t’obbligassero a essere operato nella sporcizia e senza poter ricorrere agli ospedali, pena la galera. Il tuo vitalismo dell’“integrità del vivere” è per lo meno fatuo. Che queste cose le dica Pasolini, non mi meraviglia. Di te credevo che sapessi che cosa costa e che responsabilità è il far vivere delle altre vite.
Nel momento in cui si cerca di rendere meno barbara una situazione che per la donna è veramente spaventosa, un intellettuale impiega la sua autorità perché la donna sia mantenuta in questo inferno. Sei un bell’incosciente, a dir poco, lascia che te lo dica. Non riderei tanto delle “misure igienico-profilattiche”; certo, a te un raschiamento all’utero non te lo faranno mai. Ma vorrei vederti se t’obbligassero a essere operato nella sporcizia e senza poter ricorrere agli ospedali, pena la galera. Il tuo vitalismo dell’“integrità del vivere” è per lo meno fatuo. Che queste cose le dica Pasolini, non mi meraviglia. Di te credevo che sapessi che cosa costa e che responsabilità è il far vivere delle altre vite.
Non dimentichiamo che fino a non tantissimi anni fa in Italia le donne non potevano votare, non potevano abortire né divorziare, potevano essere licenziate in caso di matrimonio, non potevano - da sposate - usare il proprio cognome, e se venivano uccise non era poi così grave, almeno non se si erano macchiate della colpa di aver leso l’onore maschile. Non dimentichiamo “che sarà sufficiente una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne siano rimessi in discussione”. Non dimentichiamo e soprattutto rEsistiamo, ieri, oggi, sempre.
- Io sono per gli otto referendum del partito radicale, e sarei disposto ad una campagna anche immediata in loro favore. Condivido col partito radicale l’ansia della ratificazione, l’ansia cioè del dar corpo formale a realtà esistenti: che è il primo principio della democrazia. Sono però traumatizzato dalla legalizzazione dell’aborto, perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- "LEGGEREZZA" Ed "ETERNO RITORNO". Due obiezioni a Kundera (di I. Calvino).14 ottobre 2019, di Federico La Sala
DUE OBIEZIONI A KUNDERA
di ITALO CALVINO *
"FRANZ aveva dodici anni quando il padre abbandonò la madre all’ improvviso. Il ragazzo intuì che era accaduto qualcosa di grave, ma la madre velò il dramma dietro parole misurate e neutre, per non turbarlo. Quello stesso giorno erano andati in città e Franz, uscendo di casa, si era accorto che la madre aveva ai piedi scarpe diverse. Rimase confuso, voleva farglielo notare, ma allo stesso tempo temeva in quel modo di ferirla. E così aveva passato due ore con lei in giro per la città e per tutto il tempo non aveva potuto staccare gli occhi dai suoi piedi. Allora, per la prima volta, aveva cominciato a capire che cos’ è la sofferenza". Questo passo dà bene la misura dell’ arte di raccontare di Milan Kundera - della sua concretezza, della sua finezza - e ci avvicina a comprendere il segreto per cui nel suo ultimo romanzo (L’ insostenibile leggerezza dell’ essere, traduzione di Antonio Barbato, Adelphi, pagg. 318, lire 20.000: quando uscì in Francia ne parlò su queste pagine Elena Guicciardi) il piacere della lettura si riaccenda di continuo.
Tra tanti scrittori di romanzi, Kundera è un romanziere vero, nel senso che le storie dei personaggi sono il suo primo interesse: storie private, sopratutto storie di coppie, nella loro singolarità e imprevedibilità. Il suo modo di raccontare procede a ondate successive (gran parte dell’ azione si sviluppa nelle prime trenta pagine; la conclusione è già annunciata a metà romanzo; ogni storia viene completata e illuminata strato a strato) e attraverso divagazioni e commenti che trasformano il problema privato in problema universale, dunque anche nostro. Ma questa problematicità generale, anzichè aggiungere gravità, fa da filtro ironico, alleggerisce il pathos delle situazioni.
Tra i lettori di Kundera ci può essere chi s’ appassiona di più alla vicenda e chi (io, per esempio) alle divagazioni. Ma anche queste si trasformano in racconto. Come i suoi maestri settecenteschi Sterne e Diderot, Kundera fa delle sue riflessioni estemporanee quasi un diario dei suoi pensieri e umori. L’ironica problematicità universal-esistenziale coinvolge anche ciò che, trattandosi di Cecoslovacchia, non può essere dimenticato neanche per un minuto, cioè quell’ insieme di vergogne e insensatezze che una volta si chiamava la Storia e che ora può solo dirsi la maledetta sfortuna d’ essere nato in un paese piuttosto che in un altro. Ma Kundera, facendone non "il problema" ma solo una complicazione in più dei guai della vita, elimina quel doveroso, allontanante rispetto che ogni letteratura degli oppressi incute in noi immeritatamente privilegiati, e in questo modo ci coinvolge nella disperazione quotidiana dei regimi comunisti molto di più che se facesse appello al pathos.
Il nucleo del libro sta in una verità tanto semplice quanto ineludibile: è impossibile agire valendosi dell’ esperienza perchè ogni situazione cui ci troviamo di fronte è unica e ci si presenta per la prima volta. "Qualsiasi studente nell’ ora di fisica può provare con esperimenti l’ esattezza di un’ ipotesi scientifica. L’ uomo, invece, vivendo una sola vita, non ha alcuna possibilità di verificare un’ ipotesi mediante un esperimento, e perciò non saprà mai se avrebbe dovuto o no dare ascolto al proprio sentimento". Kundera collega questo assioma fondamentale con corollari non altrettanto solidi: la leggerezza del vivere per lui sta nel fatto che le cose avvengono una volta sola, fugacemente, dunque è quasi come se non fossero avvenute. La pesantezza invece sarebbe data dall’ "eterno ritorno" ipotizzato da Nietzsche: ogni fatto diventa spaventoso se sappiamo che si ripeterà infinite volte.
Ma - obietterei - se l’ "eterno ritorno" (sul cui possibile significato esatto non ci si è mai messi d’ accordo) è ritorno dell’ identico, una vita unica e irripetibile equivale esattamente a una vita infinitamente ripetuta: ogni atto è irrevocabile, non modificabile per l’ eternità. Se invece l’ "eterno ritorno" è una ripetizione di ritmi, di schemi, di strutture, di geroglifici del destino, che lasciano spazio per infinite piccole varianti nei dettagli, allora si potrebbe considerare il possibile come un insieme di fluttuazioni statistiche, in cui ogni evento non escluderebbe alternative migliori o peggiori, e la definitività d’ ogni gesto risulterebbe alleggerita.
Leggerezza del vivere è per Kundera ciò che si oppone alla irrevocabilità, alla univocità esclusiva: tanto in amore (il medico praghese Toms vorrebbe praticare solo l’ "amicizia erotica", evitando coinvolgimenti passionali e convivenze coniugali) quanto in politica (questo non è detto esplicitamente, ma la lingua batte dove il dente duole, e il dente è naturalmente l’ impossibilità dell’ Europa dell’ Est di cambiare - o almeno alleviare - un destino che non si è mai sognata di scegliere). Ma Toms finisce per accogliere in casa e sposare Tereza, cameriera d’ un ristorante di provincia, per "compassione". Non solo: dopo l’ invasione russa del ’ 68, Toms riesce a scappare da Praga e a emigrare in Svizzera, con Tereza; la quale però, dopo qualche mese viene presa da una nostalgia che si manifesta come vertigine di debolezza verso la debolezza del suo paese senza speranza: e rimpatria. Ecco allora che Toms, che avrebbe tutte le ragioni, ideali e pratiche, per restare a Zurigo, decide di tornare a Praga anche lui, pur sapendo di chiudersi in una trappola e d’ andare incontro a persecuzioni e umiliazioni (non potrà più fare il medico e finirà lavatore di vetri).
 Perchè lo fa? Perchè, pur professando l’ ideale della leggerezza del vivere, e pur avendone un esempio pratico nel rapporto con una sua amica, la pittrice Sabina, ha sempre avuto il dubbio che il vero valore non sia nell’ idea contraria, nel peso, nella necessità. "Es muss sein!" "Ciò deve essere!" dice l’ ultimo movimento dell’ ultimo quartetto di Beethoven. E Tereza, amore nutrito di compassione, amore non scelto ma impostogli dal destino, assume ai suoi occhi il significato di questo fardello dell’ ineluttabile, dell’ "Es muss sein!".
Perchè lo fa? Perchè, pur professando l’ ideale della leggerezza del vivere, e pur avendone un esempio pratico nel rapporto con una sua amica, la pittrice Sabina, ha sempre avuto il dubbio che il vero valore non sia nell’ idea contraria, nel peso, nella necessità. "Es muss sein!" "Ciò deve essere!" dice l’ ultimo movimento dell’ ultimo quartetto di Beethoven. E Tereza, amore nutrito di compassione, amore non scelto ma impostogli dal destino, assume ai suoi occhi il significato di questo fardello dell’ ineluttabile, dell’ "Es muss sein!".
 Si viene a sapere più in là (ecco come le divagazioni formano quasi un romanzo parallelo) che l’ occasione che aveva portato Beethoven a scrivere "Es muss sein!" non era nulla di sublime, ma una banale storia di quattrini prestati da recuperare; così come il destino che aveva portato Tereza nella vita di Toms era solo un seguito di coincidenze fortuite. In realtà questo romanzo intitolato alla leggerezza ci parla sopratutto della costrizione: la fitta rete di costrizioni pubbliche e private che avvolge le persone, che esercita il suo peso su ogni rapporto umano (e non risparmia neppure quelli che Toms vorrebbe considerare fuggevoli couchages).
Si viene a sapere più in là (ecco come le divagazioni formano quasi un romanzo parallelo) che l’ occasione che aveva portato Beethoven a scrivere "Es muss sein!" non era nulla di sublime, ma una banale storia di quattrini prestati da recuperare; così come il destino che aveva portato Tereza nella vita di Toms era solo un seguito di coincidenze fortuite. In realtà questo romanzo intitolato alla leggerezza ci parla sopratutto della costrizione: la fitta rete di costrizioni pubbliche e private che avvolge le persone, che esercita il suo peso su ogni rapporto umano (e non risparmia neppure quelli che Toms vorrebbe considerare fuggevoli couchages).
 Anche il dongiovannismo, su cui Kundera ci dà una pagina di definizioni originali, ha motivazioni tutt’ altro che "leggere": sia quando risponde a una "ossessione lirica", cioè ricerca tra le molte donne della donna unica e ideale, sia quando è motivato da una "ossessione epica", cioè ricerca d’ una conoscenza universale nella diversità. Tra le storie parallele il maggior rilievo va alla storia di Sabina e di Franz. Sabina come rappresentante della leggerezza e portatrice dei significati del libro è più persuasiva del personaggio a cui si contrappone, cioè Tereza. (Direi che Tereza non arriva ad avere il "peso" necessario per giustificare una decisione tanto autodistruttiva da parte di Toms).
Anche il dongiovannismo, su cui Kundera ci dà una pagina di definizioni originali, ha motivazioni tutt’ altro che "leggere": sia quando risponde a una "ossessione lirica", cioè ricerca tra le molte donne della donna unica e ideale, sia quando è motivato da una "ossessione epica", cioè ricerca d’ una conoscenza universale nella diversità. Tra le storie parallele il maggior rilievo va alla storia di Sabina e di Franz. Sabina come rappresentante della leggerezza e portatrice dei significati del libro è più persuasiva del personaggio a cui si contrappone, cioè Tereza. (Direi che Tereza non arriva ad avere il "peso" necessario per giustificare una decisione tanto autodistruttiva da parte di Toms).
 E’ attraverso Sabina che la leggerezza acquista evidenza come "fiume semantico", cioè rete d’ associazioni e immagini e parole su cui si basa l’ intesa amorosa di lei e Toms, una complicità che Toms non può ritrovare con Tereza, nè Sabina con Franz. Franz, scienziato svizzero, è l’ intellettuale progressista occidentale come lo può vedere chi, dall’ Europa dell’ Est, lo considera con l’ impassibile oggettività d’ un etnologo che studi i costumi d’ un abitante degli antipodi.
E’ attraverso Sabina che la leggerezza acquista evidenza come "fiume semantico", cioè rete d’ associazioni e immagini e parole su cui si basa l’ intesa amorosa di lei e Toms, una complicità che Toms non può ritrovare con Tereza, nè Sabina con Franz. Franz, scienziato svizzero, è l’ intellettuale progressista occidentale come lo può vedere chi, dall’ Europa dell’ Est, lo considera con l’ impassibile oggettività d’ un etnologo che studi i costumi d’ un abitante degli antipodi.La vertigine d’ indeterminatezza che ha sostenuto gli entusiasmi di sinistra negli ultimi vent’ anni è indicata da Kundera con il massimo di precisione compatibile a così inafferrabile oggetto: "Dittatura del proletariato o democrazia? Rifiuto della società dei consumi o aumento della produzione? Ghigliottina o abolizione della pena di morte? Non è questo l’ importante". -Ciò che caratterizza la sinistra occidentale, secondo Kundera, è quella che lui chiama la Lunga Marcia, che si svolge con la stessa vaghezza di propositi e di emozioni "ieri contro gli americani che occupavano il Vietnam, oggi contro il Vietnam che occupa la Cambogia, ieri per Israele, oggi per i palestinesi, ieri per Cuba, domani contro Cuba e sempre contro l’ America, ogni volta contro i massacri e ogni volta in appoggio ad altri massacri, l’ Europa marcia e per seguire il ritmo degli avvenimenti e non lasciarsene sfuggire nessuno il suo passo diventa sempre più veloce, sicchè la Grande Marcia è un corteo di gente che corre e si affretta e la scena è sempre più piccola, fino a che un giorno non sarà che un punto senza dimensioni".
Seguendo i tormentosi imperativi del senso del dovere di Franz, Kundera ci porta alle soglie del più mostruoso inferno generato dalle astrazioni ideologiche quando diventano realtà, la Cambogia, e descrive una marcia internazionale umanitaria in pagine che sono un capolavoro di satira politica. Al polo opposto di Franz, la sua partner temporanea, Sabina, fa da portavoce dell’ autore in quanto mente lucida nello stabilire confronti e contrasti e paralleli tra l’ esperienza della società comunista in cui è cresciuta e l’ esperienza dell’ Occidente. Uno dei cardini di questi confronti è la categoria del Kitsch.
Kundera considera il Kitsch nell’ accezione di rappresentazione edulcorata, edificante, "vittoriana", e naturalmente pensa al "realismo socialista" e alla propaganda di regime, maschera ipocrita di tutti gli orrori. Sabina che, stabilitasi negli Stati Uniti, ama New York per quanto vi è di "bellezza non intenzionale", "bellezza per errore", è sconvolta quando vede affiorare il Kitsch americano, tipo pubblicità della Coca-Cola, che gli ricorda le immagini radiose di salute e di virtù tra le quali è cresciuta. Ma Kundera giustamente precisa:
 "Il Kitsch è l’ ideale estetico di tutti gli uomini politici, di tutti i partiti e i movimenti politici. In una società dove coesistono orientamenti politici diversi e dove quindi la loro influenza si annulla o si limita reciprocamente, possiamo ancora in qualche modo sfuggire all’ inquisizione del Kitsch... Ma là dove un unico movimento politico ha tutto il potere, ci troviamo di colpo nel regno del Kitsch totalitario".
"Il Kitsch è l’ ideale estetico di tutti gli uomini politici, di tutti i partiti e i movimenti politici. In una società dove coesistono orientamenti politici diversi e dove quindi la loro influenza si annulla o si limita reciprocamente, possiamo ancora in qualche modo sfuggire all’ inquisizione del Kitsch... Ma là dove un unico movimento politico ha tutto il potere, ci troviamo di colpo nel regno del Kitsch totalitario".Il passo che resta da compiere è liberarsi dalla paura del Kitsch, una volta che ci si è salvati dal suo totalitarismo e lo si può vedere come un elemento in mezzo a tanti altri, una immagine che perde velocemente il proprio potere mistificatorio per conservare solo il colore del tempo che passa, la testimonianza della mediocrità o dell’ ingenuità di ieri. E’ quello che mi pare succeda a Sabina, per cui possiamo riconoscere nella sua storia un itinerario spirituale di riconciliazione col mondo. Alla vista, tipica dell’ idillio americano, delle finestre illuminate in una casa di legno bianco su un prato, Sabina sorprende in se stessa un moto di commozione. E non le resta che concludere: "Per quanto forte sia il nostro diprezzo, il Kitsch fa parte della condizione umana".
 Una conclusione molto più triste è quella della storia di Tereza e Toms; ma qui, attraverso la morte d’ un cane, e la cancellazione di se stessi in una sperduta località di campagna, si arriva quasi a un assorbimento nel ciclo della natura, in un’ idea del mondo che non ha al suo centro l’ uomo, anzi che non è assolutamente fatto per l’ uomo.
Una conclusione molto più triste è quella della storia di Tereza e Toms; ma qui, attraverso la morte d’ un cane, e la cancellazione di se stessi in una sperduta località di campagna, si arriva quasi a un assorbimento nel ciclo della natura, in un’ idea del mondo che non ha al suo centro l’ uomo, anzi che non è assolutamente fatto per l’ uomo.Le mie obiezioni a Kundera sono due: una terminologica e una metafisica. L’ obiezione terminologica riguarda la categoria del Kitsch, di cui Kundera prende in considerazione solo una tra le varie accezioni. Ma del cattivo gusto della cultura di massa fa parte anche il Kitsch che pretende di rappresentare la spregiudicatezza più audace e "maledetta" con effetti facili e banali. Certo è meno pericoloso dell’ altro, ma ne va tenuto conto per evitare di crederlo un antidoto. Per esempio, vedere l’ assoluta contrapposizione al Kitsch nell’ immagine d’ una donna nuda con in testa una bombetta da uomo non mi pare del tutto convincente.
L’ obiezione metafisica ci porta più lontano. Riguarda "l’ accordo categorico con l’ essere", atteggiamento che per Kundera sarebbe alla base del Kitsch come ideale estetico. "La differenza che separa coloro che mettono in discussione l’ essere così come è stato dato all’ uomo (non importa in che modo o da chi) da coloro che vi aderiscono senza riserve" è data dal fatto che l’ adesione impone l’ illusione d’ un mondo in cui non esista la defecazione, perchè secondo Kundera la merda è la negatività assoluta, metafisica.
 Obietterò che per i panteisti e per gli stilistici (io appartengo a una di queste due categorie, non preciserò quale) la defecazione è una delle più grandi prove della generosità dell’ universo (della natura o provvidenza o necessità o cos’ altro si voglia). Che la merda sia da considerare tra i valori e non tra i disvalori, è per me una questione di principio.
Obietterò che per i panteisti e per gli stilistici (io appartengo a una di queste due categorie, non preciserò quale) la defecazione è una delle più grandi prove della generosità dell’ universo (della natura o provvidenza o necessità o cos’ altro si voglia). Che la merda sia da considerare tra i valori e non tra i disvalori, è per me una questione di principio.
 Da ciò derivano conseguenze fondamentali. Per non cadere nei vaghi sentimenti d’ una redenzione universale che finiscono per produrre regimi polizieschi mostruosi, nè nei ribellismi generalizzati e temperamentali che si risolvono in obbedienze pecorili, è necessario riconoscere come sono fatte le cose, ci piacciano o meno, nel moltissimo a cui è vano opporsi e nel poco che può essere modificato dalla nostra volontà. Credo dunque che sia necessario un certo grado di accordo con l’ esistente (merda compresa) proprio in quanto incompatibile col Kitsch che Kundera giustamente detesta.
Da ciò derivano conseguenze fondamentali. Per non cadere nei vaghi sentimenti d’ una redenzione universale che finiscono per produrre regimi polizieschi mostruosi, nè nei ribellismi generalizzati e temperamentali che si risolvono in obbedienze pecorili, è necessario riconoscere come sono fatte le cose, ci piacciano o meno, nel moltissimo a cui è vano opporsi e nel poco che può essere modificato dalla nostra volontà. Credo dunque che sia necessario un certo grado di accordo con l’ esistente (merda compresa) proprio in quanto incompatibile col Kitsch che Kundera giustamente detesta. -
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- IL TELESCOPIO, PALOMAR, E LA LUNA. Note sull’immaginario platonico e sulla immaginazione "edenica".22 luglio 2019, di Federico La Sala
LETTERATURA EUROPEA*, IMMAGINARIO PLATONICO, E IMMAGINAZIONE “EDENICA”. Nella speranza, e con l’augurio, che il dono del Sessantotto non risulti esser stato sprecato ...
Note a margine di "Volevamo la Luna" di Andrea Cortellessa (Alfabeta-2, 21 luglio 2019):
SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL “TELESCOPIO” (DI LEOPARDI) E DEL “PALOMAR” (DI CALVINO), FORSE, E’ MEGLIO RI-DISCENDERE “SOTTO COVERTA DI ALCUN GRAN NAVILIO” E RIPRENDERE LA “NAVIGAZIONE” CON GALILEO ...
«Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. (..)
 Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II);
Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II);.... E CON NOE’ - IL CORVO E LA COLOMBA (“PALOMA”):
“E in capo a quaranta giorni, Noè aprì la finestra che avea fatta nell’arca,
 7 e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono asciugate sulla terra.
7 e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono asciugate sulla terra.
 8 Poi mandò fuori la colomba, per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra.
8 Poi mandò fuori la colomba, per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra.
 9 Ma la colomba non trovò dove posar la pianta del suo piede, e tornò a lui nell’arca, perché c’eran delle acque sulla superficie di tutta la terra; ed egli stese la mano, la prese, e la portò con sé dentro l’arca.
9 Ma la colomba non trovò dove posar la pianta del suo piede, e tornò a lui nell’arca, perché c’eran delle acque sulla superficie di tutta la terra; ed egli stese la mano, la prese, e la portò con sé dentro l’arca.
 10 E aspettò altri sette giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell’arca.
10 E aspettò altri sette giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell’arca.
 11 E la colomba tornò a lui, verso sera; ed ecco, essa aveva nel becco una foglia fresca d’ulivo; onde Noè capì che le acque erano scemate sopra la terra” (“Genesi”: 8, 6-11 );
11 E la colomba tornò a lui, verso sera; ed ecco, essa aveva nel becco una foglia fresca d’ulivo; onde Noè capì che le acque erano scemate sopra la terra” (“Genesi”: 8, 6-11 );* ... E CON DANTE ( ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica).
P. S. - LE RADICI DELLA TERRA SONO “COSMICOMICHE”! Un’ipotesi di ri-lettura della DIVINA COMMEDIA, e un omaggio a Ennio Flaiano e a Italo Calvino (cfr. LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI “DUE SOLI”).
Federico La Sala
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). --- Quello scontro tra Di Vittorio e Togliatti sulla repressione del 1956 in Ungheria25 ottobre 2018, di Federico La Sala
Quello scontro tra Di Vittorio e Togliatti sulla repressione del 1956 in Ungheria
di Ilaria Romeo ("striscia rossa", 24 ottobre 2018)
Il 23 ottobre 1956 a Budapest un largo corteo popolare di solidarietà con la rivolta di Poznań, in Polonia, degenera in scontri tra polizia e dimostranti. La notte stessa il governo, presieduto dagli stalinisti Gerö e Hegedüs, viene sciolto. La formazione del governo Nagy non impedisce il divampare della rivolta nella capitale e nel resto del paese.
Il 27 ottobre, di fronte alla decisione dei sovietici di intervenire militarmente in Ungheria, la segreteria della Cgil assume una posizione di radicale condanna dell’invasione. La condanna non è soltanto dell’intervento militare: il giudizio è netto e investe tanto i metodi antidemocratici di governo di quelle società, quanto l’insufficienza grave dello stesso movimento sindacale di quei paesi (LEGGI).
Nella stessa giornata del 27, Di Vittorio rilascia a un’agenzia di stampa una dichiarazione nella quale vengono ribadite le cose dette nel comunicato della Segreteria. Sulla “situazione del Partito in relazione ai fatti di Ungheria” il 30 ottobre si riunisce la Direzionedel Pci. Per Di Vittorio è di fatto un processo. Presenti Togliatti, Longo, Amendola, Li Causi, Scoccimarro, Sereni, Roveda, Pajetta, Dozza, Di Vittorio, Colombi, Berlinguer, Secchia, Roasio, M. Montagnana, R. Montagnana, Pellegrini, Terracini, Boldrini, D’Onofrio e Ingrao. Assenti Novella, Spano e Negarville. Partecipano alla discussione Pajetta, Di Vittorio, Roveda, Roasio, Secchia, Pellegrini, Amendola, Ingrao, Boldrini, Li Causi, M. Montagnana, Colombi, Sereni, Dozza, Terracini, Berlinguer, Pajetta, Longo, Di Vittorio.
Così, sulla presa di posizione di Di Vittorio, Emilio Sereni: “L’unità nella nostra direzione è di importanza fondamentale e questa unità non può avvenire che attorno al compagno Togliatti. Con la sua dichiarazione il compagno Di Vittorio si è contrapposto alla direzione”. Aggiunge Dozza: “È noto in tutto il quadro confederale che Di Vittorio dà poca importanza al parere della Direzione. Esigenza della disciplina. Sono per la lotta sui due fronti, ma deve essere lotta e ogni membro della Direzione deve assumersi le sue responsabilità”. Duro anche Scoccimarro: “Gravissimo errore di DiVittorio nell’aver ignorato l’esperienza storica”.
Più morbido Roveda: “Sono d’accordo anche con l’articolo di Togliatti di stamattina (apparso su Rinascita, n. 10/1956, ndr) che pone il problema sul terreno di classe di fronte alla canea avversaria. Gli operai non avrebbero capito che l’esercito sovietico non fosse intervenuto per difendere il socialismo. Gli intellettuali dopo il XX Congresso vanno tutti alla ricerca del partito. Capisco la situazione molto difficile nella Cgil, ma si poteva evitare quella presa di posizione. I socialisti vogliono indebolire il nostro partito e dobbiamo evitare atti che li aiutino in questo. Non è vero che la posizione della classe operaia sia quella della Cgil”.
Conclude Palmiro Togliatti: “Dopo aver risposto alle argomentazioni sviluppate dai compagni - si legge sempre nel verbale - egli sottolinea che la posizione del comunicato della Cgil non è giusta. Ritiene che i comunisti della segreteria confederale avrebbero potuto e dovuto insistere per ottenere una posizione più giusta e che non disorientasse l’opinione dei lavoratori. In particolare osserva e deplora che il compagno Di Vittorio abbia aggiunto al comunicato un suo commento, non concordato con la segreteria del partito e divergente dalla linea del partito”. “La dichiarazione [di Di Vittorio] - aggiunge il segretario del Pci - non è stata concordata con noi e ha aumentato il disorientamento nel partito [...] In questo momento come si può solidarizzare con chi spara contro di noi mentre si cerca di creare una grande ondata reazionaria? [...] Si sta con la propria parte anche quando questa sbaglia”.
Di Vittorio replica ai suoi interlocutori con due interventi che non soddisferanno Togliatti. Dirà il Segretario a conclusione della riunione che “la risposta di Di Vittorio non è stata quella necessaria”.
Ricorderà anni dopo Bruno Trentin: “Dopo quella riunione l’ho trovato molto provato umanamente - scrive con Adriano Guerra in Di Vittorio e l’ombra di Stalin (Ediesse 1997, pp. 205-206) -: un uomo, se non stroncato, ferito e umiliato. Credo che si sia trovato di fronte a un aut aut drammatico. Al successivo direttivo della Cgil, Di Vittorio dichiarò che aveva dovuto tener conto delle esigenze unitarie interne alla Cgil. Non era una ritrattazione, perché non sconfessava il documento, ma sosteneva che esso non corrispondeva alla posizione dei comunisti [...]. A riprova del carattere compromissorio e transitorio di questa presa di posizione sta l’intervento di Di Vittorio al Congresso del Partito, in cui non ritorna sugli errori eventualmente commessi a proposito dell’intervento militare in Ungheria, ma rilancia la tematica del sindacato nei paesi socialisti e del superamento della cinghia di trasmissione”.
Al medesimo Congresso (VIII, Roma, 8-14 dicembre 1956), il delegato di Cuneo Antonio Giolitti denuncerà l’impossibilità di continuare a definire legittimo, democratico e socialista ‘un governo come quello contro cui è insorto il popolo di Budapest’, definendo ingiustificabile l’intervento sovietico ‘in base ai principi del socialismo’. Sul finire del successivo mese di luglio Giolitti spedirà la sua lettera di dimissioni, pregando che sia pubblicata entro il 24.
Esattamente una settimana più tardi (il 7 agosto 1957) la stessa «Unità» pubblicherà la lettera di dimissioni di Italo Calvino, una lettera che l’autore medesimo definirà ‘d’amore’: “Cari compagni - scrive nella prosa scorrevole ed incisiva che contraddistingue le sue opere Calvino - devo comunicarvi la mia decisione ponderata e dolorosa di dimettermi dal Partito [...] Sono consapevole di quanto il Partito ha contato nella mia vita: vi sono entrato a vent’anni, nel cuore della lotta armata di liberazione; ho vissuto come comunista gran parte della mia formazione culturale e letteraria; sono diventato scrittore sulle colonne della stampa di Partito; ho avuto modo di conoscere la vita del Partito a tutti i livelli, dalla base al vertice, sia pure con una partecipazione discontinua e talora con riserve e polemiche, ma sempre traendone preziose esperienze morali e umane; ho vissuto sempre (e non solo dal XX Congresso) la pena di chi soffre gli errori del proprio campo, ma avendo costantemente fiducia nella storia; non ho mai creduto (neanche nel primo zelo del neofita) che la letteratura fosse quella triste cosa che molti nel Partito predicavano, e proprio la povertà della letteratura ufficiale del comunismo m’è stata di sprone a cercar di dare al mio lavoro di scrittore il segno della felicità creativa; credo d’esser sempre riuscito ad essere, dentro il Partito, un uomo libero. Che questo mio atteggiamento non subirà mutamenti fuori dal Partito, può esser garantito dai compagni che meglio mi conoscono, e sanno quanto io tenga a esser fedele a me stesso, e privo di animosità e di rancori” (l’articolo-lettera di Calvino appare sulla settima pagina del giornale che titolerà Le dimissioni di Calvino dal Pci condannate dal C.D. di Torino, pubblicando subito sotto, in basso a destra, la risposta del Comitato).
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE -- Addio a Chichita l’altra metà di Calvino. Esther Judith Singer sposò lo scrittore nel ’64 all’Avana.24 giugno 2018, di Federico La Sala
Addio a Chichita l’altra metà di Calvino
Aveva 93 anni, sposò lo scrittore nel ’64 all’Avana
di Mauretta Capuano (Ansa, 23 giugno 2018)
ROMA.
Lucidissima fino alla fine, Chichita Calvino, è morta a quasi 93 anni, nella sua casa di Campo Marzio a Roma, per problemi respiratori. Donna fortissima e colta, famosa per il suo humour, la moglie di Italo Calvino ha attraversato il Novecento ed è stata amica di grandi scrittori ed artisti. Persona di straordinaria cultura e intelligenza, è stata protagonista di un sodalizio intellettuale prezioso per lo scrittore, che aveva conosciuto a Parigi all’inizio degli anni ’60 negli ambienti editoriali e poi sposato nel ’64 all’Avana. "Amica di scrittori come Borges, Cortazar, Rushie e Gore Vidal, Calvino le sottoponeva ogni sua nuova pagina, sicuro di averne il riscontro critico che gli serviva", racconta all’ANSA Ernesto Ferrero, suo amico di lunga data e collega di Calvino all’Einaudi.
Esther Judith Singer, questo il suo vero nome, era nata in Argentina da una famiglia della borghesia colta di Buenos Aires. Bella e spigliata, sin da allora capace di parlare con tutti e di tutto, narratrice avvolgente e formidabile, come ricordano oggi tutti quelli che l’hanno conosciuta, cominciò prestissimo ad avere contatti con il mondo dell’arte e della letteratura. In Europa era arrivata a metà degli anni ’50, prima a Cannes e poi a Vienna e Parigi, dove lavorava come traduttrice, inizialmente da freelance poi come interprete per le Nazioni Unite e per altre organizzazioni internazionali.
L’incontro con Calvino risale al 1962, l’occasione fu un evento organizzato da Elvira Orphee, una scrittrice argentina che allora lavorava come attaché culturale a Parigi. Due anni più tardi, nel 1964, i due si sposarono all’Avana. Lei era già madre di un bimbo, Marcello Weill, nato da una precedente relazione, nel 1965 arrivò Giovanna. Un amore intenso, quello tra Chichita e Calvino, nato da due caratteri in qualche modo opposti e complementari, riservato e super taciturno lui, espansiva e immaginifica lei, nutrito da una condivisione intellettuale fortissima.
Dopo la morte prematura dello scrittore, scomparso a soli 62 anni a Siena nel 1985, Chichita, ricorda ancora Ernesto Ferrero, "ha gestito con mano fermissima una eredità difficile, guadagnandosi il rispetto di editori, agenti e traduttori. Difficile sapere di non poter più contare sulla lucidità brillante e corrosiva con cui sino all’ultimo ha ’letto’ il mondo e la letteratura contemporanea".
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE - Stato-Mafia. Pm Di Matteo: Silenzio assordante, chi speravamo ci difendesse ha taciuto.23 aprile 2018, di Federico La Sala
Stato-Mafia: Pm Di Matteo: ’Dell’Utri tramite dopo il ’92’
’Da Anm e Csm nessuna difesa. Silenzio assordante, chi speravamo ci difendesse ha taciuto’
- Stato-mafia: pm Di Matteo, da Anm e Csm nessuna difesa © ANSA FOTO
di Redazione ANSA *
"La sentenza è precisa e ritiene che Dell’Utri abbia fatto da cinghia di trasmissione nella minaccia mafiosa al governo anche nel periodo successivo all’avvento alla Presidenza del Consiglio di Berlusconi. In questo c’è un elemento di novità. C’era una sentenza definitiva che condannava Dell’Utri per il suo ruolo di tramite tra la mafia e Berlusconi fino al ’92. Ora questo verdetto sposta in avanti il ruolo di tramite esercitato da Dell’Utri tra ’Cosa nostra’ e Berlusconi". Lo ha detto il pm della Dna Nino Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre.
La replica dell’Anm, sempre difeso magistrati attaccati - "L’Associazione Nazionale Magistrati ha sempre difeso dagli attacchi l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati". Lo dice il presidente dell’Anm Francesco Minisci. "Lo ha fatto - prosegue - a favore dei colleghi di Palermo e continuerà sempre a difendere tutti i magistrati attaccati, pur non entrando mai nel merito delle vicende giudiziarie".
"Né Silvio Berlusconi, né altri hanno denunciato le minacce mafiose, né prima né dopo" ha anche detto il pm Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, su Rai tre. "Nel nostro sistema costituzionale le sentenze vengono pronunciate nel nome del popolo italiano e possono essere criticate e impugnate. Il problema è che quando le sentenze riguardano uomini che esercitano il potere devono essere conosciute", ha aggiunto. "C’è una sentenza definitiva - ha spiegato - che afferma che dal ’74 al ’92 Dell’Utri si fece garante di un patto tra Berlusconi e le famiglie mafiose palermitane. Ora questa sentenza dice che quella intermediazione non si ferma al ’92, ma si estende al primo governo Berlusconi, questi sono fatti che devono essere conosciuti"
"I carabinieri che hanno trattato sono stati incoraggiati da qualcuno. Noi non riteniamo che il livello politico non fosse a conoscenza di quel che accadeva. Ci vorrebbe ’un pentito di Stato’, uno delle istituzioni che faccia chiarezza e disegni in modo ancora più completo cosa avvenne negli anni delle stragi". Lo ha detto il pm della dna Nino Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre.
"Quello che mi ha fatto più male è che rispetto alle accuse di usare strumentalmente il lavoro abbiamo avvertito un silenzio assordante e chi speravamo ci dovesse difendere è stato zitto. A partire dall’ Anm e il Csm". Lo ha detto il pm della Dna Nino Di Matteo, dopo la sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre a proposito delle critiche subite, negli anni, dal pool che ha coordinato l’inchiesta.
* ANSA,23 aprile 2018 (ripresa parziale, senza immagine).
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE - LA FIABA DI "COLA PESCE": IL PALOMBARO E LA CORONA DEL REGNO..15 aprile 2018, di Federico La Sala
PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE...
LA CORONA DEL REGNO, IL PALOMBARO, E LA LEGGENDA DI "(NI) COLA PESCE" *
- In Italia la scelleratezza comincia presto, dopo la Liberazione. Da allora siamo impigliati nel cortocircuito colpa-nemesi, senza produrre la catarsi: il momento della purificazione in cui - nelle Supplici di Eschilo - s’alza Pelasgo, capo di Argo, e dice: «Occorre un pensiero profondo che porti salvezza. Come un palombaro devo scendere giù nell’abisso, scrutando il fondo con occhio lucido e sobrio così che questa vicenda non rovini la città e per noi stessi si concluda felicemente».[...] Scrive Davide Susanetti, nel suo bel libro sulla tragedia greca, che il tuffo di Pelasgo implica una più netta visione dei diritti della realtà: «Per mutare non bisogna commuoversi, ma spostarsi fuori dall’incantesimo funesto del cerchio» che ci ingabbia (Catastrofi politiche, Carocci 2011) [...] (Barbara Spinelli, Un pensiero profondo per la politica, la Repubblica, 23.11.2011)
*
Cola Pesce
Una volta a Messina c’era una madre che aveva un figlio a nome Cola, che se ne stava a bagno nel mare mattina e sera. La madre a chiamarlo dalla riva:
 Cola! Cola! Vieni a terra, che fai? Non sei mica un pesce?
Cola! Cola! Vieni a terra, che fai? Non sei mica un pesce?E lui, a nuotare sempre più lontano. Alla povera madre veniva il torcibudella, a furia di gridare. Un giorno, la fece gridare tanto che la poveretta, quando non ne poté più di gridare, gli mandò una maledizione:
 Cola! Che tu possa diventare un pesce!
Cola! Che tu possa diventare un pesce!Si vede che quel giorno le porte del Cielo erano aperte, e la maledizione della madre andò a segno: in un momento, Cola diventò mezzo uomo mezzo pesce, con le dita palmate come un’anatra e la gola da rana. In terra Cola non ci tornò più e la madre se ne disperò tanto che dopo poco tempo morì.
La voce che nel mare di Messina c’era uno mezzo uomo e mezzo pesce arrivò fino al Re; e il Re ordinò a tutti i marinai che chi vedeva Cola Pesce gli dicesse che il Re gli voleva parlare.
Un giorno, un marinaio, andando in barca al largo, se lo vide passare vicino nuotando.
 Cola! - gli disse. - C’è il Re di Messina che ti vuole parlare!
E Cola Pesce subito nuotò verso il palazzo del Re.
Cola! - gli disse. - C’è il Re di Messina che ti vuole parlare!
E Cola Pesce subito nuotò verso il palazzo del Re.Il Re, al vederlo, gli fece buon viso.
 Cola Pesce, - gli disse, - tu che sei così bravo nuotatore, dovresti fare un giro tutt’intorno alla Sicilia, e sapermi dire dov’è il mare più fondo e cosa ci si vede!
Cola Pesce, - gli disse, - tu che sei così bravo nuotatore, dovresti fare un giro tutt’intorno alla Sicilia, e sapermi dire dov’è il mare più fondo e cosa ci si vede!Cola Pesce ubbidì e si mise a nuotare tutt’intorno alla Sicilia.
Dopo un poco di tempo fu di ritorno. Raccontò che in fondo al mare aveva visto montagne, valli, caverne e pesci di tutte le specie, ma aveva avuto paura solo passando dal Faro, perché lì non era riuscito a trovare il fondo.
 E allora Messina su cos’è fabbricata? - chiese il Re. - Devi scendere giù a vedere dove poggia.
E allora Messina su cos’è fabbricata? - chiese il Re. - Devi scendere giù a vedere dove poggia.Cola si tuffò e stette sott’acqua un giorno intero. Poi ritornò a galla e disse al Re:
 Messina è fabbricata su uno scoglio, e questo scoglio poggia su tre colonne: una sana, una scheggiata e una rotta.
Messina è fabbricata su uno scoglio, e questo scoglio poggia su tre colonne: una sana, una scheggiata e una rotta. O Messina, Messina,
O Messina, Messina,
 Un dì sarai meschina!
Un dì sarai meschina!Il Re restò assai stupito, e volle portarsi Cola Pesce a Napoli per vedere il fondo dei vulcani. Cola scese giù e poi raccontò che aveva trovato prima l’acqua fredda, poi l’acqua calda e in certi punti c’erano anche sorgenti d’acqua dolce.
Il Re non ci voleva credere e allora Cola si fece dare due bottiglie e gliene andò a riempire una d’acqua calda e una d’acqua dolce. Ma il Re aveva quel pensiero che non gli dava pace, che al Capo del Faro il mare era senza fondo. Riportò Cola Pesce a Messina e gli disse:
 Cola, devi dirmi quant’è profondo il mare qui al Faro, più o meno.
Cola, devi dirmi quant’è profondo il mare qui al Faro, più o meno.Cola calò giù e ci stette due giorni, e quando tornò sù disse che il fondo non l’aveva visto, perché c’era una colonna di fumo che usciva da sotto uno scoglio e intorbidava l’acqua. Il Re, che non ne poteva più dalla curiosità, disse:
 Gettati dalla cima della Torre del Faro
Gettati dalla cima della Torre del FaroLa Torre era proprio sulla punta del capo e nei tempi andati ci stava uno di guardia, e quando c’era la corrente che tirava suonava una tromba e issava una bandiera per avvisare i bastimenti che passassero al largo. Cola Pesce si tuffò da lassù in cima.
Il Re ne aspettò due, ne aspettò tre, ma Cola non si rivedeva. Finalmente venne fuori, ma era pallido.
 Che c’è, Cola? - chiese il Re.
Che c’è, Cola? - chiese il Re. C’è che sono morto di spavento, - disse Cola. - Ho visto un pesce, che solo nella bocca poteva entrarci intero un bastimento! Per non farmi inghiottire m son dovuto nascondere dietro una delle tre colonne che reggono Messina!
C’è che sono morto di spavento, - disse Cola. - Ho visto un pesce, che solo nella bocca poteva entrarci intero un bastimento! Per non farmi inghiottire m son dovuto nascondere dietro una delle tre colonne che reggono Messina!Il Re stette a sentire a bocca aperta; ma quella maledetta curiosità di sapere quant’era profondo il Faro non gli era passata.
E Cola:
 No, Maestà, non mi tuffo più, ho paura.
No, Maestà, non mi tuffo più, ho paura.Visto che non riusciva a convincerlo, il re si levò la corona dal capo, tutta piena di pietre preziose, che abbagliavano lo sguardo, e la buttò in mare.
 Va’ a prenderla, Cola!
Va’ a prenderla, Cola! Cos’avete fatto, Maestà? La corona del Regno!
Cos’avete fatto, Maestà? La corona del Regno! Una corona che non ce n’è altra al mondo, - disse il Re. - Cola, devi andarla a prendere!
Una corona che non ce n’è altra al mondo, - disse il Re. - Cola, devi andarla a prendere! Se voi così volete, Maestà, - disse Cola - scenderò. Ma il cuore mi dice che non tornerò più su. Datemi una manciata di lenticchie. Se scampo, tornerò su io; ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno che io non torno più.
Se voi così volete, Maestà, - disse Cola - scenderò. Ma il cuore mi dice che non tornerò più su. Datemi una manciata di lenticchie. Se scampo, tornerò su io; ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno che io non torno più.Gli diedero le lenticchie, e Cola scese in mare.
Aspetta, aspetta; dopo tanto aspettare, vennero a galla le lenticchie. Cola Pesce s’aspetta che ancora torni.
 (Palermo)
(Palermo)*Cfr.: Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino, Einaudi, Torino 1971, vol. II, pp. 602-604.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz...
 LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
 I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!Federico La Sala
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE - BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE", E LA VITA DI UN "PALOMBARO LETTERARIO".20 aprile 2018, di Federico La SalaVITA, FILOSOFIA, STORIA E LETTERATURA...
 BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE", E LA VITA DI UN "PALOMBARO LETTERARIO". Una brillante ricognizione di Luisella Mesiano
BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE", E LA VITA DI UN "PALOMBARO LETTERARIO". Una brillante ricognizione di Luisella Mesiano
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE - LA LEGGENDA DI "COLAPESCE", SCHILLER, E LA "LEZIONE" DI FREUD A ROMAIN ROLLAND.23 aprile 2018, di Federico La Sala
LA PSICOANALISI, LA LEGGENDA DI "COLAPESCE", E LA "LEZIONE" DI FREUD A ROMAIN ROLLAND.
Una nota
di Federico La Sala
All’interno di un lavoro portata avanti da più Autori, sul tema “L’India della psicoanalisi. Il subcontinente dell’inconscio” (IPOC, Milano 2014), Livio Boni, a conclusione del suo contributo specifico, dedicato a “Freud e l’India: un percorso ermeneutico lungo/un itinerario mancato”, e, in particolare, allo sforzo di fornire chiarimenti sul “dialogo con Romain Rolland” e sulla “equazione freudiana: India = misticismo”, scrive:
- A mo’ di epilogo riportiamo infine, per dovere di esaustività, la testimonianza del poeta tedesco Bruno Goetz circa le proprie conversazioni con Freud (1904-1905), che avrebbero avuto l’India quale soggetto privilegiato. Ne trascriviamo qui di seguito il brano concernente la critica rivolta dal fondatore della psicoanalisi a una certa fascinazione esercitata dal pensiero indiano, e più in particolare dalla Bhagavadgita, premettendo che non ci pare opportuno conferire a questo testo lo statuto di un documento a pieno titolo, non tanto per i problemi di attendibilità che esso pone (Goetz pretende di aver ritrovato, a mezzo secolo di distanza, degli appunti dell’epoca, nei quali si era sforzato di riportare alla lettera il resoconto dei propri incontri con Freud), ma in quanto tanto il contenuto che il tono di questo testo sono in aperto contrasto con tutto ciò che Freud afferma altrove, non solo circa l’India, ma riguardo al misticismo più in generale. Passiamo dunque la parola, in ultimo, a questo dialogo Freud-Goetz, senza però lasciargli l’ultima parola.
- Dispose dunque [Freud] di vederci alle nove della sera. Dopo essersi interessato al mio stato di salute mi interrogò circa i miei studi, e io gli parlai entusiasticamente delle letture della Bhagavadgita svolte all’Università da Leopold von Schroeder. Non appena cominciai a parlare Freud balzò in piedi e cominciò ad andare avanti e indietro per la stanza.
 “Fai attenzione ragazzo mio, fai attenzione” esclamò non appena ebbi finito di parlare. “Hai certo le tue ragioni a mostrarti entusiasta, le tue parole testimoniano del tracimare del tuo cuore. Il cuore ha sempre la meglio, ma cerca di mantenere la testa fredda, come finora, fortunatamente, mi pare tu sia riuscito a fare. Non abbassare la guardia. Un’intelligenza chiara e limpida è il più grande dei doni. Il poeta della Bhagavadgita sarebbe il primo a confermarlo. Resta guardingo, tieni sempre gli occhi ben aperti, prendi coscienza di ogni cosa, sii di un coraggio indefettibile, non lasciarti mai abbagliare, non imbrogliarti. La Bhagavadgita è un poema grande e profondo che apre però su dei precipizi.
“Fai attenzione ragazzo mio, fai attenzione” esclamò non appena ebbi finito di parlare. “Hai certo le tue ragioni a mostrarti entusiasta, le tue parole testimoniano del tracimare del tuo cuore. Il cuore ha sempre la meglio, ma cerca di mantenere la testa fredda, come finora, fortunatamente, mi pare tu sia riuscito a fare. Non abbassare la guardia. Un’intelligenza chiara e limpida è il più grande dei doni. Il poeta della Bhagavadgita sarebbe il primo a confermarlo. Resta guardingo, tieni sempre gli occhi ben aperti, prendi coscienza di ogni cosa, sii di un coraggio indefettibile, non lasciarti mai abbagliare, non imbrogliarti. La Bhagavadgita è un poema grande e profondo che apre però su dei precipizi.
 E ancora giace sotto di me celato nella purpurea tenebra afferma il tuffatore di Schiller, che mai rivenne dal suo secondo temerario tentativo. Se invece, senza la guida di un intelletto lucido ti immergi nel mondo della Bhagavadgita, laddove nulla sembra costante e ogni cosa si confonde con ogni altra, allora ti troverai improvvisamente di fronte al nulla. Sai cosa vuol dire trovarsi di fronte al nulla? Te lo puoi immaginare? Eppure questo nulla è solo il frutto del fraintendimento di noi Europei: il Nirvana indù non è il nulla, è ciò che trascende ogni contraddizione. Esso non è, come gli Europei spesso tendono a credere, un’estasi dei sensi, ma l’ultimo gradino dell’intendimento umano. Un’intuizione raggelante,onnicomprensiva e difficilmente rappresentabile. Ora, se frainteso, esso conduce alla follia. Che cosa conoscono mai questi sedicenti mistici d’Europa della profondità dell’ Oriente? Fantasticano, ma non sanno nulla. E poi si stupiscono quando perdono la testa e non di rado escono di senno - sono trasportati letteralmente fuori di sé”.
E ancora giace sotto di me celato nella purpurea tenebra afferma il tuffatore di Schiller, che mai rivenne dal suo secondo temerario tentativo. Se invece, senza la guida di un intelletto lucido ti immergi nel mondo della Bhagavadgita, laddove nulla sembra costante e ogni cosa si confonde con ogni altra, allora ti troverai improvvisamente di fronte al nulla. Sai cosa vuol dire trovarsi di fronte al nulla? Te lo puoi immaginare? Eppure questo nulla è solo il frutto del fraintendimento di noi Europei: il Nirvana indù non è il nulla, è ciò che trascende ogni contraddizione. Esso non è, come gli Europei spesso tendono a credere, un’estasi dei sensi, ma l’ultimo gradino dell’intendimento umano. Un’intuizione raggelante,onnicomprensiva e difficilmente rappresentabile. Ora, se frainteso, esso conduce alla follia. Che cosa conoscono mai questi sedicenti mistici d’Europa della profondità dell’ Oriente? Fantasticano, ma non sanno nulla. E poi si stupiscono quando perdono la testa e non di rado escono di senno - sono trasportati letteralmente fuori di sé”.
 Tacque e tornò a sedere.“Spero mi perdoniate”, cominciai io dopo una breve pausa, “ma c’è una domanda che mi assilla. Posso porvela?” “Senza esitazione”, mi rispose. “La cosa più importante è non esitare a porre domande. In questo momento voi vi interessate alla filosofia indù. Quest’ultima si spinse spesso tanto lontano da formulare le proprie risposte in forma di domande. I filosofi indiani sapevano perché.”
Tacque e tornò a sedere.“Spero mi perdoniate”, cominciai io dopo una breve pausa, “ma c’è una domanda che mi assilla. Posso porvela?” “Senza esitazione”, mi rispose. “La cosa più importante è non esitare a porre domande. In questo momento voi vi interessate alla filosofia indù. Quest’ultima si spinse spesso tanto lontano da formulare le proprie risposte in forma di domande. I filosofi indiani sapevano perché.”
LA PAURA DELLA "GIOIA ECCESSIVA". Alla luce di un “vecchio” lavoro di Giampaolo Lai (“Due errori di Freud”, Boringhieri, Torino 1979), di Elvio Fachinelli (“La mente estatica”, Adelphi, Milano 1989) e, mi sia consentito, di una altrettanto mia “vecchia” analisi della “provocazione” fachinelliana di portarsi oltre Freud (si cfr. “La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica”, Antonio Pellicani Editore, Roma 1991, pp. 138-161), pur volendo accogliere l’opinione della lettura di Boni (2002/2014) sul valore della “soprendente” testimonianza di Goetz relativa alle dichiarazioni di Freud sull’India, con tutte le implicazioni che esse hanno anche sul dialogo con Rolland, è da dire che nel testo di Goetz c’è un elemento, che sollecita attenzione e invita non a semplificare (“Questo riduzionismo - scriveva Fachinelli - non ci serve: ci serve piuttosto un adduzionismo”) ma ad “approfondire” ulteriormente la lettura della “lezione” di Freud a Goetz, proprio per fare possibilmente più chiarezza sul “percorso ermeneutico lungo" e su "l’itinerario mancato".
L’elemento è la citazione ripresa dalla ballata di Schiller - un vero e proprio “iceberg” del “mare” interno di Freud: “La Bhagavadgita è un poema grande e profondo che apre però su dei precipizi. E ancora giace sotto di me celato nella purpurea tenebra afferma "il tuffatore" di Schiller, che mai rivenne dal suo secondo temerario tentativo” (sul tema, si cfr. la brillante tesi di laurea di Malvina Celli, "La simbologia di Friedrich Schiller nella ballata "Der Taucher": amore o ambizione?", Università di Pisa 2014/2015).
Tale elemento illumina con molta forza un “impensabile” ancora da pensare: esso non è affatto “in aperto contrasto con tutto ciò che Freud afferma altrove” ma, al contrario, esprime solo e già tutto “il disagio della civiltà”, quella occidentale, nei confronti dell’altra civiltà, quella orientale in questo caso e, in particolare, dell’India.
Nel 1904-1905, a pochi anni dalla pubblicazione della Interpretazione dei sogni, avvenuta nel 1899 (con la data “1900”), e con la consapevolezza che la sua autoanalisi - interminata e interminabile - non è affatto finita, egli sa bene in quale impresa si è “tuffato”! Il motto virgiliano, “Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo” («Se non posso muovere gli dei superiori, muoverò quelli degli inferi»), posto ad esergo dell’opera, già dice bene a se stesso di quali e quanti pericoli e difficoltà dovrà affrontare il “conquistador” nel suo cammino.
Un’ombra lo seguirà fino alla fine: è quella di Josef Popper-Lynkeus (1838-1921), ingegnere, filantropo, e scrittore, che con le sue “Fantasie di un realista”, opera pubblicata a Vienna nel 1899, contemporaneamente a “L’interpretazione dei sogni”, che lo "tormenterà" a non rassegnarsi (“I miei rapporti con Josef Popper-Lynkeus”, 1932) e ... a non perdere il coraggio degli inizi!
Nel 1929, nel “Disagio della civiltà”, «un’opera essenziale, di primo piano per la comprensione del pensiero freudiano, nonché il compendio della sua esperienza» (J. Lacan), nella parte finale del primo capitolo, a Romain Rolland, chiudendo con modi da “animale terrestre” la porta in faccia al “suo amico oceanico” (così dalla dedica sulla copia del libro inviatagli), ripete la “lezione” data a Goetz nel 1904-1905, con altri versi dalla stessa ballata: -“(...) ancora una volta sono indotto ad esclamare con le parole del Tuffatore di Schiller: “... Es frue sich, / Wer da atmet im rosigten Licht. [...Gioisca, / Chi qui respira nella luce rosata.]” (S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Boringhieri, Torino 1971, p. 208).
A ulteriore precisazione, per chi ancora possa avere qualche dubbio sul senso del suo discorso e del suo percorso, alla fine del capitolo 7 del "Disagio", richiama alcuni versi dalla canzone dell’arpista nel “Wilhelm Meister” di Goethe e commenta:
- “Ricordate la commovente accusa del grande poeta contro le “potenze celesti”?
- Voi ci sospingete nella vita,
 Voi fate il misero divenir colpevole,
Voi fate il misero divenir colpevole,
 Poi alla sua pena lo lasciate,
Poi alla sua pena lo lasciate,
 Perché ogni colpa s’espia sulla terra.
Perché ogni colpa s’espia sulla terra. - E ci sia consentito trarre un sospiro di sollievo vedendo che a singoli uomini è dato ricavare senza una vera fatica dal vortice dei propri sentimenti le più profonde intuizioni, mentre a noialtri non resta che farci strada a tastoni, senza posa, in tormentosa incertezza, verso le medesime verità” (op.cit., p. 268).
Il Conquistador comincia a deporre le armi e ammette: “(...) mi manca il coraggio di erigermi a profeta di fronte ai mei simili e accetto il rimprovero di non saper portare loro nessuna consolazione, perché in fondo questo è ciò che tutti chiedono, i più fieri rivoluzionari non meno appassionatamente dei più virtuosi credenti” (op. cit., p. 280).
Nel 1930, a Freud viene conferito l’ambito “Premio Goethe”. Il riconoscimento segnava per lui, come dichiarò, la vetta più alta della sua vita. Nel “Discorso nella casa natale di Goethe a Francoforte”, (S. Freud, Opere, XI, Torino 1979, pp. 7-12), egli scrive: “Io penso che Goethe, a differenza di tanti altri nostri contemporanei, non avrebbe respinto di malanimo la psicoanalisi”. Certamente non si sbagliava, ma forme di immaginario “prometeico”, condiviso sia con Goethe sia con gli “altri nostri contemporanei”, lo accecano ancora. I suoi “sogni” personali erano più le “fantasie” di un idealista (platonico-hegeliano ), che di un realista, alla Popper-Lynkeus e alla Rolland!
Nel 1931, alla fine dell’ultimo capitolo del “Disagio della civiltà”, dopo l’ultima frase: “Gli uomini adesso hanno esteso talmente il proprio potere sulle forze naturali, che giovandosi di esse sarebbe facile sterminarsi a vicenda, fino all’ultimo uomo [...]. E ora c’è da aspettarsi che l’altra delle due potenze celesti, l’Eros eterno, farà uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo avversario altrettanto immortale.”, aggiungerà: “Ma chi può prevedere se avrà successo e quale sarà l’esito” (op. cit., p. 280).
Nel 1938, con grandissime difficoltà, a stento riesce a lasciare Vienna e a raggiungere, sognando "Guglielmo il Conquistatore", l’Inghilterra - un’isola in mezzo all’oceano! Morirà a Londra il 23 settembre 1939.
A sua memoria e gloria, è da ricordare che, se il suo primo lavoro "L’interpretazione dei sogni" richiama alla memoria la figura di Giuseppe, e il suo lavoro di interpretatore dei sogni del Faraone, l’ultimo lavoro risollecita a riflettere su “L’uomo Mosè e la religione monoteistica” e a proseguire il suo lavoro, quello di interpretatori e interpretatrici dei sogni dell’intera umanità. Uscire dallo Stato di minorità è possibile, non è “l’avvenire di un’illusione”. Non dimentichiamo di «coltivare il nostro giardino»!
Sul tema, nel sito, si fr.:
- L’INCONSCIO, OGGI: FREUD, LA ’SFIDA’ DI POPPER-LINKEUS, E L’INDICAZIONE DI ELVIO FACHINELLI.
FILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..
 FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio FachinelliVITA, FILOSOFIA, STORIA E LETTERATURA...
 BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE", E LA VITA DI UN "PALOMBARO LETTERARIO". Una brillante ricognizione di Luisella Mesiano
BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE", E LA VITA DI UN "PALOMBARO LETTERARIO". Una brillante ricognizione di Luisella MesianoFREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). - BENEDETTO CROCE, LO SPIRITO DI "COLAPESCE" - SCHILLER, FREUD, E IL SENTIMENTO OCEANICO" DI ROLLAND.26 aprile 2018, di Federico La SalaLA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.
-
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). -- IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’, EPIMENIDE, E LA LEZIONE ITALO-AMERICANA.25 gennaio 2017, di Federico La Sala
UNA RISPOSTA "SPECIALE C17": IL POPULISMO DELLA POST-VERITA’, EPIMENIDE, E LA LEZIONE ITALO-AMERICANA. In memoria di Italo Calvino *
Siamo nella post-verità da sempre, a quanto pare!
SIAMO PROPRIO CONCIATI MALE, MALISSIMO!
Dopo ventanni di berlusconismo stiamo ancora a commentare i giochini di mentitori istituzionalizzati. E a riflettere sulle “spine del C17 - spine nel fianco di un pingue potere” (https://www.alfabeta2.it/2017/01/21/c17-spine-nel-fianco-un-pingue-potere/).
DOPO IL 1917, E DOPO IL 1922, ANCORA NON SAPPIAMO NULLA DELLA “MORTE NERA” (cfr.: Massimo Palma,”Waler Benjamin, l’inquilino in nero; cfr.: https://www.alfabeta2.it/2017/01/11/walter-benjamin-linquilino-nero/) E DELLA MISTICA FASCISTA (cfr.: mia nota a “Infanzia salentina”, pagine del lavoro di Nicola Fanizza, “Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini” - https://www.nazioneindiana.com/2017/01/21/infanzia-salentina/).
Tanto tempo, in un’isola del Mediterraneo, un tale chiamato EPIMENIDE (con questo nome è rimasto nella storia, come persona degna di essere ricordata per la sopravvivenza della stessa isola), indignato contro i suoi stessi concittadini (che evidentemente lo accusavano di chissà quali malefatte), fece il primo passo nella terra della post-verità, gridò infuriato: “Tutti i cretesi mentono”! Se molti risero, altrettanto molti lo applaudirono.
Qualche anno dopo, sempre in quell’isola, ci furono le elezioni: tra i partiti (quello che la storia non ci ha tramandato) comparve uno strano partito, con il nome “Forza Creta”, e il leader era proprio il vecchio EPIMENIDE!
CONQUISTATO IL POTERE LEGALMENTE, IL SUO GRIDO AI CRETESI CHE AVEVANO RISO DELLA SUA “BATTUTA” FU QUASI SIMILE A QUELLO DI BRENNO CONTRO I ROMANI SORPRESI NEL SONNO, ANZI, NEL SONNAMBULISMO: “GUAI AI VINTI”!
SOLO CHE A ROMA CI FURONO LE OCHE CHE SVEGLIARONO UN POCO TUTTI E I GALLI FURONO CACCIATI, MA A CRETA ALLA FINE NESSUNO PIU’ OSO’ RIDERE E ... “TUTTI I CRETESI MENTONO” ANCORA!!! A MEMORIA (E A VERGOGNA) ETERNA.
Federico La Sala
*
LA COSCIENZA A POSTO. Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti
 L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE
L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE
 C’era un paese che si reggeva sull’illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere (...)
C’era un paese che si reggeva sull’illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere (...) -
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA - LA CARTA STRUMENTALIZZATA: IL PARADOSSO DELLA COSTITUZIONE (di Giovanni De Luna)..9 dicembre 2016, di Federico La Sala
IL PARADOSSO DELLA COSTITUZIONE:
LA ’NAZIONALIZZAZIONE’ DEL MENTITORE
- UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
- L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
Il paradosso della Costituzione
Difesa oggi dagli antipartito, 70 anni fa nel mirino degli “apolitici” dell’Uomo Qualunque. Bobbio li definiva il “pantano in cui finirà per impaludarsi il rinnovamento democratico”
di Giovanni De Luna (La Stampa, 09.12.2016)
Il paradosso del referendum del 4 dicembre è questo: la Costituzione del 1948 è stata vittoriosamente difesa dalle forze politiche che ne hanno sempre criticato il carattere «comunista» (Berlusconi e la Lega) o denunciato la fissità «talmudica» (così Grillo, nel 2011 sul suo blog). Il paradosso è anche più evidente se lo si confronta con le polemiche che - tra il 1945 e il 1947 - accompagnarono il varo della Carta Costituzionale.
Allora, il passaggio dalla dittatura alla democrazia fu accolto con sospetto e diffidenza da una larga fetta dell’opinione pubblica, abituata da venti anni di fascismo a considerare la politica una pratica «inconcludente» e incline a guardare agli uomini dei partiti con la diJffidenza dovuta a chi svolgeva «non un’attività disinteressata al servizio della collettività e della nazione, cercando invece di procurare potere, ricchezza, privilegi a sé stesso, alla propria famiglia, fazione, clientela elettorale». Queste frasi - tratte da uno dei tanti rapporti dei carabinieri che allora funzionavano come oggi i sondaggi di opinione - fotografavano un diffuso sentimento «antipartito» che si tradusse negli impetuosi successi elettorali dell’Uomo Qualunque.
La nuova Repubblica
Anche tra le file del Partito d’Azione - al quale oggi viene attribuita la paternità della Costituzione - all’inizio la forma partito era vista con sospetto. La nuova Repubblica che nasceva dalla Resistenza avrebbe dovuto puntare direttamente sugli uomini (con un rinnovamento della classe dirigente) e sulle istituzioni (con un allargamento della partecipazione politica fondata sulle autonomie e sull’autogoverno). Lo scriveva un giovane Norberto Bobbio (non aveva ancora 40 anni): «Una responsabilità pubblica ciascuno può assumerla dentro o fuori dei partiti, secondo le sue capacità e le sue tendenze, e magari meglio fuori che dentro».
Ma proprio i suoi articoli di allora sul quotidiano Giustizia e Libertà ci consentono oggi di capire che intorno alla Costituzione la partita si giocò essenzialmente tra la politica e l’antipolitica, meglio - come si diceva a quel tempo - tra gli «apolitici» e gli uomini dei partiti. Il qualunquismo nascondeva dietro la maschera della «apoliticità» e dell’«indipendenza» una lotta senza quartiere ai partiti del Cln, giudicati come il lascito più significativo e più pericoloso della Resistenza. BJobbio lo diceva esplicitamente: «gli indipendenti [...] non sono né indipendenti, né apolitici. Sono politici, ecco tutto, di una politica che non è quella dei comitati di liberazione o del fronte della Resistenza».
«Vizi tradizionali» italiani
L’«apoliticismo» (per Bobbio «l’indifferenza o addirittura l’irrisione per ogni pubblica attività in nome dell’imperioso dovere di lavorare senza ambizioni né distrazioni per la famiglia, per i figli e soprattutto per sé») si traduceva in una critica alla «politica di partito» che, scriveva, «lusinga e quindi rafforza inveterate abitudini, vizi tradizionali del popolo italiano, incoraggia gli ignavi, fa insuperbire gli ottusi e gli inerti [...], offre infine a tutti gli apolitici un motivo per allearsi, facendo di una folla di isolati una massa organica, se non organizzata, di persone che la pensano allo stesso modo e hanno di fronte lo stesso nemico [...] generando di nuovo quel pantano in cui finirà per impaludarsi lo sforzo di rinnovamento democratico dello Stato italiano».
Per gli uomini della Resistenza il nemico era quindi diventato quella «sorta di alleanza dei senza partito», «scettica di quello scetticismo che è proprio delle classi medie italiane», alimentata «da un dissenso di gusti, un disaccordo di stati d’animo, uno scontro di umori, una gara di orgogli, dai quali null’altro può derivare che invelenimento di passioni, impacci all’azione ricostruttrice».
La Carta strumentalizzata
Sembra che Bobbio parli proprio di quell’estremismo di centro che caratterizza oggi una parte della società italiana e un movimento come quello di Grillo. Allora fu un passaggio decisivo per l’approdo a una sua convinta adesione alla «democrazia dei partiti», frutto di una riflessione approfondita su un «modello», quello inglese, che, partendo dai capisaldi fondamentali delle origini (la divisione dei tre poteri, la monarchia costituzionale e il governo parlamentare), era stato in grado di rinnovarsi, spostando progressivamente verso il basso, verso il corpo elettorale, rappresentato e diretto dai partiti, il baricentro del sistema politico.
Le cifre del referendum del 4 dicembre ci dicono come l’elettorato dei movimenti più tipicamente antipartito (Cinque Stelle e Lega) abbia votato massicciamente per il No (l’80%), affiancato da una ristretta fascia di elettori appartenenti al Pd (23%) o alle varie sigle accampate alla sua sinistra. Essere salvata da quelli che volevano affossarla, adesso come nel 1948: da questo duplice paradosso cronologico la Costituzione esce come schiantata, degradata a puro pretesto, con una torsione innaturale che la espone, in futuro, a ogni tipo di uso strumentale.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE -- il Calvino di Ossola, oltre che rabdomante capace di prefigurare il futuro, è anche moralista classico, “grande stoico”, custode di un umanesimo sempre incompiuto.9 maggio 2016, di Federico La Sala
Italo Calvino custode dell’invisibile
di Franco Marcoaldi (la Repubblica, 08.05.2016)
- Italo Calvino. L’invisibile e il suo dove di Carlo Ossola Vita e Pensiero, pagg. 120, euro 13
Nel suo intenso saggio su Italo Calvino. L’invisibile e il suo dove, Carlo Ossola ripercorre l’ultradecennale tragitto letterario dello scrittore ligure. A partire dal romanzo d’esordio ( Il sentiero dei nidi di ragno), per passare poi alla trilogia fantastica, alla “filosofia del vivere” delle Città invisibili e Palomar, fino alle Lezioni americane.
È un’opera variegata quant’altre mai, quella di Calvino, ma in cui ricorrono due elementi portanti: l’ inesausto esercizio della ragione critica (con tutte le sue virtù di trasparenza, ordine, esattezza) e lo scatenamento fantastico, l’uso tumultuoso dell’immaginazione. Lo scrittore è perfettamente consapevole delle frizioni a cui questo sguardo stereoscopico può dare luogo. E soprattutto sa che “il mondo scritto” non necessariamente riesce a dare voce al “mondo non scritto”. Purtuttavia, con infinita tenacia, prosegue nel suo cammino, convinto che l’unico modo di contrastare “la perdita di forma” che dolorosamente constata nella vita, risieda proprio nella parola letteraria.
Sempre sospeso tra “fiamma” e “cristallo”, aporia e geometria, passione e calcolo, il Calvino riletto da Ossola combatte “il pulviscolo informe” che caratterizza il mondo di fuori, l’universo esteriore, con un’attenzione crescente allo sviluppo della vita interiore, a quanto si sottrae di continuo al nostro sguardo. È lì che si situa l’invisibile a cui allude il titolo ed è da lì che bisogna ripartire per riscoprire la “grana della voce”, quel timbro morale che risuona in ciascuno di noi e che va preservato a ogni costo. Non per caso il Calvino di Ossola, oltre che rabdomante capace di prefigurare il futuro, è anche moralista classico, “grande stoico”, custode di un umanesimo sempre incompiuto.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- La democrazia senza morale (di Stefano Rodotà)16 aprile 2016, di Federico La Sala
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
La democrazia senza morale
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 8 aprile 2016) *
Nel marzo di trentasei anni fa Italo Calvino pubblicava su questo giornale un articolo intitolato “Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti”. Vale la pena di rileggerlo (o leggerlo) non solo per coglierne amaramente i tratti di attualità, ma per chiedersi quale significato possa essere attribuito oggi a parole come “onestà” e “corruzione”.
Per cercar di rispondere a questa domanda, bisogna partire dall’articolo 54 della Costituzione, passare poi ad un detto di un giudice della Corte Suprema americana e ad un fulminante pensiero di Ennio Flaiano, per concludere registrando il fatale ritorno dell’accusa di moralismo a chi si ostina a ricordare che senza una forte moralità civile la stessa democrazia si perde.
Quell’articolo della Costituzione dovrebbe ormai essere letto ogni mattina negli uffici pubblici e all’inizio delle lezioni nelle scuole (e, perché no?, delle sedute parlamentari).
Comincia stabilendo che «tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» . Ma non si ferma a questa affermazione, che potrebbe apparire ovvia. Continua con una prescrizione assai impegnativa: « i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore». Parola, quest’ultima, che rende immediatamente improponibile la linea difensiva adottata ormai da anni da un ceto politico che, per sfuggire alle proprie responsabilità, si rifugia nelle formule «non vi è nulla di penalmente rilevante», «non è stata violata alcuna norma amministrativa». Si cancella così la parte più significativa dell’articolo 54, che ha voluto imporre a chi svolge funzioni pubbliche non solo il rispetto della legalità, ma il più gravoso dovere di comportarsi con disciplina e onore.
Vi è dunque una categoria di cittadini che deve garantire alla società un “ valore aggiunto”, che si manifesta in comportamenti unicamente ispirati all’interesse generale. Non si chiede loro genericamente di essere virtuosi. Tocqueville aveva colto questo punto, mettendo in evidenza che l’onore rileva verso l’esterno, « n’agit qu’en vue du public », mentre «la virtù vive per se stessa e si accontenta della propria testimonianza».
Ma da anni si è allargata un’area dove i “servitori dello Stato” si trasformano in servitori di sé stessi, né onorati, né virtuosi. Si è pensato che questo modo d’essere della politica e dell’amministrazione fosse a costo zero. Si è irriso anzi a chi richiamava quell’articolo e, con qualche arroganza, si è sottolineato come quella fosse una norma senza sanzione. Una logica che ha portato a cancellare la responsabilità politica e a ridurre, fin quasi a farla scomparire, la responsabilità amministrativa. Al posto di disciplina e onore si è insediata l’impunità, e si ripresenta la concezione «di una classe politica che si sente intoccabile», come ha opportunamente detto Piero Ignazi. Sì che i rarissimi casi di dimissioni per violato onore vengono quasi presentati come atti eroici, o l’effetto di una sopraffazione, mentre sono semplicemente la doverosa certificazione di un comportamento illegittimo.
Questa concezione non è rimasta all’interno della categoria dei cittadini con funzioni pubbliche, ma ha infettato tutta la società, con un diffusissimo “così fan tutti” che dà alla corruzione italiana un tratto che la distingue da quelli dei paesi con cui si fanno i più diretti confronti.
Basta ricordare i parlamentari inglesi che si dimettono per minimi abusi nell’uso di fondi pubblici: i ministri tedeschi che lasciano l’incarico per aver copiato qualche pagina nella loro tesi di laurea: il Conseil constitutionnel francese che annulla l’elezione di Jack Lang per un piccolo sforamento nelle spese elettorali; il vice-presidente degli Stati Uniti Spiro Agnew si dimette per una evasione fiscale su contributi elettorali (mentre un ministro italiano ricorre al condono presentandolo come un lavacro di una conclamata evasione fiscale).
Sono casi noti, e altri potrebbero essere citati, che ci dicono che non siamo soltanto di fronte ad una ben più profonda etica civile, ma anche alla reazione di un establishment consapevole della necessità di eliminare tutte le situazioni che possono fargli perdere la legittimazione popolare.
In Italia si è imboccata la strada opposta con la protervia di una classe politica che si costruiva una rete di protezione che, nelle sue illusioni, avrebbe dovuto tenerla al riparo da ogni sanzione. Illusione, appunto, perché è poi venuta la più pesante delle sanzioni, quella sociale, che si è massicciamente manifestata nella totale perdita di credibilità davanti ai cittadini, di cui oggi cogliamo gli effetti devastanti. Non si può impunemente cancellare quella che in Inghilterra è stata definita come la “constitutional morality”.
In questo clima, ben peggiore di quello degli anni Ottanta, quale spazio rimane per quella “controsocietà degli onesti” alla quale speranzosamemte si affidava Italo Calvino? Qui vengono a proposito le parole di Louis Brandeis, giudice della Corte Suprema americana, che nel 1913 scriveva, con espressione divenuta proverbiale, che «la luce del sole è il miglior disinfettante». Una affermazione tanto più significativa perché Brandeis è considerato uno dei padri del concetto di privacy, che tuttavia vedeva anche come strumento grazie al quale le minoranze possono far circolare informazioni senza censure o indebite limitazioni (vale la pena di ricordare che fu il primo giudice ebreo della Corte).
L’accesso alla conoscenza, e la trasparenza che ne risulta, non sono soltanto alla base dell’einaudiano “conoscere per deliberare”, ma anche dell’ancor più attuale “ conoscere per controllare”, ovunque ritenuto essenziale come fonte di nuovi equilibri dei poteri, visto che la “democrazia di appropriazione” spinge verso una concentrazione dei poteri al vertice dello Stato in forme sottratte ai controlli tradizionali. Tema attualissimo in Italia, dove si sta cercando di approvare una legge proprio sull’accesso alle informazioni, per la quale tuttavia v’è da augurarsi che la ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione voglia rimuovere i troppi limiti ancora previsti.
Non basta dire che limiti esistono anche in altri paesi, perché lì il contesto è completamente diverso da quello italiano, che ha bisogno di ben più massicce dosi di trasparenza proprio nella logica del riequilibrio dei poteri. E bisogna ricordare la cattiva esperienza della legge 241 del 1990 sull’accesso ai documenti amministrativi, dove tutte le amministrazioni, Banca d’Italia in testa, elevarono alte mura per ridurre i poteri dei cittadini. Un rischio che la nuova legge rischia di accrescere.
Ma davvero può bastare la trasparenza in un paese in cui ogni giorno le pagine dei giornali squadernano casi di corruzione a tutti livelli e in tutti i luoghi, con connessioni sempre più inquietanti con la stessa criminalità? Soccorre qui l’amara satira di Ennio Flaiano. «Scaltritosi nel furto legale e burocratico, a tutto riuscirete fuorché ad offenderlo. Lo chiamate ladro, finge di non sentirvi. Gridate che è un ladro, vi prega di mostrargli le prove. E quando gliele mostrate: “Ah, dice, ma non sono in triplice copia!”». Non basta più l’evidenza di una corruzione onnipresente, che anzi rischia di alimentare la sfiducia e tradursi in un continuo e strisciante incentivo per chi a disciplina e onore neppure è capace di pensare.
I tempi incalzano, e tuttavia non vi sono segni di una convinta e comune reazione contro la corruzione all’italiana che ormai è un impasto di illegalità, impunità ostentata o costruita, conflitti d’interesse, evasione fiscale, collusioni d’ogni genere, cancellazione delle frontiere che dovrebbero impedire l’uso privato di ricorse pubbliche, insediarsi degli interessi privati negli stessi luoghi istituzionali (che non si sradica solo con volenterose norme sulle lobbies). Fatale, allora, scocca l’attacco alla magistratura e l’esecrazione dei moralisti, quasi che insistere sull’etica pubblica fosse un attacco alla politica e non la via per la sua rigenerazione. E, con una singolare contraddizione, si finisce poi con l’attingere i nuovi “salvatori della patria” proprio dalla magistratura, così ritenuta l’unico serbatoio di indipendenza. Il caso del giudice Cantone è eloquente, anche perché mette in evidenza due tra i più recenti vizi italiani. La personalizzazione del potere ed una politica che vuole sottrarsi alle proprie responsabilità trasferendo all’esterno questioni impegnative. Alzare la voce, allora, non può mai essere il surrogato di una politica della legalità che esige un mutamento radicale non nelle dichiarazioni, ma nei comportamenti.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE - LA FIABA: L’ALLARME DI COLLODI E LA "CONFUSIONE" DI MASSIMO GRAMELLINI.13 gennaio 2016, di Federico La Sala
"PINOCCHIO" E L’ALLARME DI COLLODI: LA FIABA, LA FAVOLA, E ... LA "CONFUSIONE" DI GRAMELLINI.
- Innanzitutto invito a leggere l’articolo, e, nello stesso tempo, invito a tenere ben distinte le due parole "favola" e "fiaba" (due generi diversi di "racconti"), e, poi, a riflettere di più e meglio sull’inizio (tragico!) di "Pinocchio": "C’era una volta. - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno"!!!
 SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
 Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su...
Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su...
- INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
Non sappiamo più raccontare le favole
Un saggio americano: solo gli inglesi riescono a inventarle. Non hanno paura del lato oscuro
di Massimo Gramellini (La Stampa, 08/01/2016)
La rivista letteraria The Atlantic, americana, ha condotto un’inchiesta dettagliata ed è giunta alla conclusione che in quest’epoca di ansie assortite e lettori bisognosi di cure affabulatorie, soltanto gli inglesi siano ancora capaci di popolare l’immaginario dei bambini di ogni nazione ed età. Alla notizia che l’Inghilterra, magari con l’aggiunta dell’Irlanda, detenga l’esclusiva delle favole qualcuno storcerà il naso e opporrà le sue eccezioni, però è un fatto che il più formidabile parto fantastico degli ultimi decenni è stato il maghetto Harry Potter, britannico, la cui saga si inserisce in un filone avviato dai personaggi di Tolkien e C.S Lewis, britannici anch’essi. Sarà il rapporto più stretto con la natura e con i miti fondativi pagani, l’assenza di una religione troppo moralista e inibente, la passione diffusa per i saperi esoterici, ma gli inglesi (e gli irlandesi) sembrano avere conservato un seme di conoscenze antichissime e la capacità di diffonderle attraverso un codice di immagini e archetipi che non parla all’emisfero razionale del cervello, ma si rivolge direttamente al subconscio di tutti gli esseri umani.
Uno dei momenti più emozionanti della mia vita è stata la scoperta che, accanto al significato letterale, le favole ne celavano un altro simbolico. Uno dei momenti più tristi è stato accorgermi che di questa scoperta non importava niente quasi a nessuno. Eppure mi vengono ancora i brividi quando penso agli artisti illuminati che dalla notte dei tempi hanno rivestito i segreti dell’esistenza e persino le future rivelazioni della fisica quantistica con le metafore dei racconti per l’infanzia. Quando penso che la Bella e la Bestia è la storia dello spirito che si riconcilia con la materia. Che la spada nella roccia è un simbolo fallico e la sua estrazione da parte del giovane Artù un rito di iniziazione sessuale. Che il bacio del principe azzurro alla bella addormentata è la metafora di quel risveglio consapevole che sta alla base di ogni antica tradizione spirituale. Che la rinuncia al simbolo del potere - sia esso l’anello elfico che Frodo va a gettare nel vulcano di Mordor o la bacchetta di sambuco che Harry Potter decide di spezzare dopo averla vinta a lord Voldemort nel duello finale - è l’atto supremo di distacco che completa l’evoluzione interiore dell’eroe.
Non è importante comprenderli con la mente, certi significati reconditi. L’emozione della favola li porta egualmente là dove devono andare: al di sotto della corteccia dell’Ego, nel regno della coscienza che Jung chiamava il Sé. La lettura delle favole procede su due livelli. Il subconscio infatti non comprende le parole. Il suo alfabeto è fatto di immagini e suoni. Mentre il piccolo lettore ascolta le avventure di principi e principesse, da qualche parte dentro di lui si forma l’immagine simbolica su cui potrà fare affidamento per il resto della vita. Quando, smarrita la sbornia di “realtà” tipica dell’età dello sviluppo, sentirà il bisogno di attingere a una conoscenza eterna per lenire le proprie paure e sviluppare i propri talenti.
Tutto questo gli inglesi non lo hanno dimenticato. E hanno avuto la forza di ricordarlo al mondo. Non è solo questione di lingua. Anche gli americani scrivono in inglese, ma le loro trame per l’infanzia esprimono un intento educativo, e dunque pragmatico, che smorza sul nascere lo sbrigliarsi della fantasia. Huck Finn è un capolavoro e Mark Twain un genio, ma si tratta di un capolavoro e di un genio intrisi di realtà. Persino la metafisica Moby Dick di Melville è appesantita da decine di pagine francamente noiose sulle varie tipologie di balene, quasi che lo scrittore avesse voluto rimarcare la base scientifica della sua straordinaria creazione. La cultura nordamericana ha compresso l’irrazionale fin dalle origini, assieme ai nativi indiani che ne sarebbero stati i naturali cantori. La concretezza etica della società fondata dai Padri Pellegrini ha spinto i compositori di favole a interpretarle non come una vacanza del pensiero, ma come il rivestimento zuccheroso di una medicina fatta di regole morali da impartire sotto forma di apologo con morale incorporata.
E gli italiani? Avendo copiato gli americani praticamente in tutto, non potevamo che seguirli anche in questa strage della fantasia immolata sull’altare della cosiddetta realtà. Pinocchio è un gigante della narrativa universale, eppure fu ignorato per un certo periodo persino dai suoi contemporanei. Le biografie di Collodi pubblicate dai giornali dopo la sua morte liquidano il burattino in poche righe. L’autore stesso non ebbe piena consapevolezza della sua opera, che toccò a Benedetto Croce sdoganare almeno dal punto di vista letterario. Collodi era un massone e non c’è pagina di Pinocchio che non contenga un riferimento alchemico (a cominciare dal nome del protagonista che si rifà alla ghiandola pineale, il “terzo occhio” di cui ogni tradizione esoterica si ripropone l’attivazione). Ma non ha lasciato eredi. Oggi si scrivono favole anche molto poetiche, intasate soprattutto di animali che parlano e ragionano come gli umani, ma manca la magia della spiritualità che in un Paese cattolico come il nostro viene ancora associata esclusivamente alla religione. Mentre il misticismo pagano che è alla base delle fantasie immortali degli inglesi si nutre di boschi, di orfani e di lettori che abbiano voglia di lasciarsi lambire dalla loro ombra a costo di perdervisi.
- Innanzitutto invito a leggere l’articolo, e, nello stesso tempo, invito a tenere ben distinte le due parole "favola" e "fiaba" (due generi diversi di "racconti"), e, poi, a riflettere di più e meglio sull’inizio (tragico!) di "Pinocchio": "C’era una volta. - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno"!!!
-
> ITALO CALVINO --- “Tutto il British Museam in una castagna” (1968)! La memoria del mondo: Italo Calvino, Google e la NSA (di Domenico Talia)30 ottobre 2015, di Federico La Sala
- “Per uscire dalle abitudini dell’immaginazione” (Italo Calvino, La memoria del mondo, Club degli editori, Milano 1968, p. 5).
La memoria del mondo: Italo Calvino, Google e la NSA
di Domenico Talia (Nazione Indiana, 30 ottobre 2015) escher-scale
«La nostra organizzazione garantisce che questa quantità di informazione non si disperda, indipendentemente dal fatto che essa venga ricevuta o no da altri. Sarà scrupolo del direttore far sì che non resti fuori niente, perché quel che resta fuori e come se non ci fosse mai stato. E nello stesso tempo sarà suo scrupolo fare come se non ci fosse mai stato tutto ciò che finirebbe per impasticciare o mettere in ombra altre cose più essenziali, cioè tutto quello che anziché aumentare l’informazione creerebbe disordine e frastuono.
L’importante è il modello generale costituito dall’insieme delle informazioni, dal quale potranno essere ricavate altre informazioni che noi non diamo e che magari non abbiamo.» Al contrario di quello che si potrebbe pensare, questo brano non è tratto da un discorso del generale Alexander, direttore della National Security Agency americana, ma da un breve racconto che Italo Calvino ha scritto nella metà degli anni ’60 e al quale lo scrittore delle cosmicomiche ha dato un titolo che sicuramente piacerebbe al capo della NSA: La memoria del mondo. Un racconto quasi dimenticato anche se ha dato il nome al libro, pubblicato per la prima volta nel 1968 dal Club degli Editori, che raccoglie insieme a questo racconto profetico, venti cosmicomiche calviniane.
Il discorso fatto in occasione di un finto passaggio di consegne tra due direttori dell’”archivio generale del tutto” riempie le sette pagine de La memoria del mondo, e in quel discorso scritto circa cinquanta anni fa, Calvino narra uno scenario reale al punto che oggi appare del tutto usuale. Uno scenario che i casi Wikileaks e Datagate (con protagonisti Julian Assange e Edward Snowden) hanno svelato in tutta la loro preoccupante drammaticità. Raccontando di un’organizzazione che costruisce “un catalogo di tutto momento per momento”, Calvino in pochissime pagine mostra come la spasmodica necessità di archiviare tutto quello che si conosce o si vuol conoscere di persone e fatti (“una memoria centralizzata del genere umano”) generi inevitabilmente intrighi, drammi e infine morte.
Quasi sicuramente il generale Alexander non ha mai letto quel racconto, ma ha fatto di tutto per farlo transitare dallo stato di una semplice cosmicomica a quello che una descrizione perfetta, fatta con decenni di anticipo, di uno scenario concreto, tangibile. Stessa cosa varrà anche per Larry Page e Sergey Brin, fondatori di Google, che pur non avendo sicuramente mai avuto il tempo di leggere il racconto di Calvino, hanno stabilito che la missione della loro azienda è “organizzare l’informazione del mondo”. Page e Brin fondarono Google mentre, da dottorandi della Stanford University, lavoravano allo sviluppo di algoritmi di data mining per analizzare grandi quantità di dati ed estrarre le piccole parti più interessanti da essi. Per uno strano parallelo, Müller, il quasi neo direttore della fondazione che archivia tutto nel racconto di Calvino, viene assunto vincendo il concorso di ammissione con il progetto “Tutto il British Museam in una castagna”.
Il Müller di Calvino viene istruito dal direttore uscente sul compito della fondazione che, oltre a riempire gli archivi di informazioni importanti su fatti e persone, spesso cataloga «sbadigli, starnuti, foruncoli, associazioni di idee sconvenienti, fischiettii» e li nasconde «nel pacco delle informazioni più qualificate.» Perché il ruolo del direttore, a cui Müller sembra essere stato chiamato, ha il privilegio «di poter dare un’impronta personale alla memoria del mondo.» E qui il racconto di Calvino prende una piega preoccupante, una piega che assomiglia in maniera sorprendente a quella del caso Snowden e all’uso improprio che delle informazioni raccolte negli USA si potrebbe fare in quella nazione o in altre a danno dei cittadini e delle regole democratiche. Quella piega preoccupante per tutti noi si disvela quando il vecchio direttore informa Müller del fatto che «nel materiale finora raccolto si nota qua e là l’intervento della mia mano; vi sono disseminati giudizi, reticenze, anche menzogne.» Ovviamente il tutto sarebbe fatto a fin di bene perché «in molti casi le menzogne ... sono indicative quanto o più della verità.»
Calvino nell’epilogo del racconto mette un sigillo finale al rischio che è insito nella raccolta pervasiva e indiscriminata di informazioni sui privati cittadini e sui loro rappresentati pubblici. Raccolta di dati che la NSA, e non solo lei, fa esplicitamente, ma che tanti colossi del Web come Google e Facebook fanno grazie all’aiuto che gli utenti forniscono loro inserendo motu proprio moltissime informazioni personali e private che potranno essere usati anche contro la loro privacy e la loro libertà. Specialmente quando le informazioni diventano strumento di potere e potere stesso, può accadere quello che avviene nel racconto di Calvino sotto la guida del vecchio direttore dell’archivio del mondo che forza la realtà e la vita delle persone, comprese quella di Müller, perché «Se nella memoria del mondo non c’è niente da correggere, la sola cosa che resta da fare è correggere la realtà dove essa non concorda con la memoria del mondo.» E qui le informazioni conservate nel “catalogo di tutto” s’impongono come la verità che guida il mondo e piegano la realtà come i corpi celesti piegano il campo gravitazionale fino a renderla funzionale agli obiettivi e ai desideri dei detentori del potere, dei padroni della memoria del mondo.
Questa cosmicomica conferma lo scopo dichiarato di Calvino di voler non tanto costruire con la sua narrazione fantastica un nuovo tipo di fantascienza ma piuttosto tentare di narrare il quotidiano nei termini più lontani dalla nostra esperienza per elevare quello che è vicino alla nostra vita fino a farlo diventare paradigma che possa spiegare quello che ci accade al di là della contingenza. Calvino a suo modo pone con un anticipo sorprendente, il problema della verità dei dati oggi disponibili in Rete e delle informazioni - anche quelle spesso apparentemente banali e senza significato - che i governi e le loro agenzie raccolgono su ognuno di noi per le tracce digitali che ormai ci lasciamo dietro ogni giorno.
E’ interessante un confronto tra la narrazione di Calvino e le teorie sull’intelligenza digitale collettiva di Derrick de Kerckhove, allievo di McLuhan e studioso dei nuovi media e della cultura digitale. In una recente intervista, de Kerckhove ha espresso ottimismo circa la possibilità che gli uomini siano capaci di padroneggiare l’enorme massa di dati e informazioni che circolano nella Rete e, pur esprimendo preoccupazioni sull’uso che il potere fa della Rete e delle informazioni digitali oggi disponibili, crede nell’intelligenza collettiva che la Rete rende possibile come antidoto ai totalitarismi. Derrick de Kerckhove, pur cosciente dell’uso politico che di Internet si fa, crede che «i Big Data rappresentano una situazione in cui noi siamo bagnati d’informazione e dobbiamo capire se il nostro corpo, bagnato dentro quest’acqua, continua ad avere la sua individualità o se diverremo completamente trasparenti. Sono un momento di transizione in cui la comunità diventa più forte di quell’individuo che abbiamo conosciuto nel Rinascimento.»
In effetti, grazie alle tecnologie digitali e alla loro pervasività, oggi gli individui diventano sempre più trasparenti, perdono la loro interiorità, la loro privatezza per apparire sulla Rete in tutti i loro aspetti, anche quelli più intimi. Una società composta da questi individui diventa una società trasparente purtroppo non nel senso illuministico del termine - più trasparente, più illuminata - né il quello che il filosofo Gianni Vattimo cercava nel suo libro pubblicato una diecina di anni fa e intitolato appunto La società trasparente. Gli individui diventano trasparenti rispetto a chi li conosce per quello che mostrano e per come agiscono nella Rete, divengono un libro aperto per chi accede o “ruba” le loro personalità digitali (disegnate sempre più perfettamente dai loro dati) e la società diventa trasparente per chi accentra e analizza tutti i dati su tutti gli individui, per il potere che vuole avere la memoria del mondo, ma non necessariamente per le strutture democratiche che i cittadini hanno costruito e che devono garantire i loro diritti e la loro privacy. Alla fine i singoli sono meno liberi in una società trasparentemente esposta e pedinata tramite la Rete. Sono cittadini di una democrazia spiata e resa debole dalla sua trasparenza.
In un mondo in cui l’informazione spoglia le nostre individualità e ci attraversa, è pervasiva nel tempo e nello spazio, appariamo tutti meno protetti. Dunque diventa una necessità riflettere su come comportarsi, su cosa e come fare: imparare a convivere o difendersi? La nostra intimità diventa sempre più digitale e può essere invasa dagli strumenti tecnologici che l’uomo ha imparato a costruire. Un uomo che nelle sue élite diventa sempre più capace di approntare oggetti complessi e intelligenti e nella sua massa non riesce a costruire la necessaria coscienza per gestire la nuova vita che fa largo uso delle potenti tecnologie digitali. Gli individui diventano sempre più sensori nell’ambiente, sensori mobili viventi che alimentano la memoria del mondo accumulata dai pochi Grandi Fratelli che sorvegliano e guidano il mondo.
I sistemi perfetti non esistono, dunque anche la sicurezza perfetta non è di questo mondo e se qualcuno alla NSA mirava alla perfezione, la vicenda di Edward Snowden, tecnico che loro hanno selezionato e assunto, sta lì a dimostrarlo. Il caso Snowden è un effetto della costruzione della memoria del mondo, un effetto che potrà essere utile almeno per riflettere se la difesa della sicurezza dei cittadini e di una nazione richieda necessariamente uno spionaggio di massa, per comprendere quanto potere ha il popolo in una democrazia sorvegliata e per rifiutare una sorveglianza di massa condotta senza il consenso della maggioranza dei cittadini e senza che i cittadini stessi siano avvertiti di ciò.
Ogni tecnologia può essere usata per il bene o per il male. L’immensa quantità di informazione che viaggia sulle reti telematiche mette a nostra disposizione un’incredibile montagna di dati e informazioni che soltanto pochi sembrano in grado di padroneggiare. E ogni volta che la cerchia degli accumulatori e dei gestori si restringe il rischio per i cittadini e per le democrazie aumenta. Se questo rischio non si può del tutto eliminare, bisogna almeno lavorare per limitarlo richiamando i singoli e gli organismi della società ad ruolo attivo per creare leggi e strumenti critici basati sulla cultura della Rete e sulla coscienza dell’uso individuale e sociale delle tecnologie che eviti la vendita delle identità in Rete e vigili su tutti quelli che vogliono costruire la memoria del mondo e sui rischi di tali operazioni di gigantismo informativo che possono trasformarsi in manipolazioni di massa basate su verità fabbricate perché funzionali al dominio di pochi.
-
> ITALO CALVINO, La memoria del mondo --- Una “clinica dell’anima” che resiste da duemila anni. Bibliotech - Borges sognava una biblioteca illimitata.2 novembre 2015, di Federico La Sala
Una “clinica dell’anima” che resiste da duemila anni
di Alberto Manguel (la Repubblica, 2.11.2015)
Platone, nel Timeo, racconta che quando uno degli uomini più saggi di tutta la Grecia, lo statista Solone, visitò l’Egitto, un vecchio sacerdote gli disse che i greci erano come bambini, perché non possedevano tradizioni realmente antiche o insegnamenti «canuti per l’età». In Egitto, proseguiva orgoglioso il sacerdote, «tutte quante le cose che sono accadute presso di voi o qui o in altro luogo di cui abbiamo sentito notizia, se ve ne sia qualcuna che sia onorevole, o grande, o che si sia distinta per qualche altra ragione, sono state scritte qui nei templi e vengono conservate».
Questo progetto tanto ambizioso prese forma durante la dinastia tolemaica. Nel III secolo a.C., più o meno nello stesso periodo in cui Platone scriveva i suoi dialoghi, i re egiziani ordinarono che ogni libro esistente nel mondo conosciuto venisse raccolto e collocato nella grande biblioteca che avevano fondato ad Alessandria. Di questa biblioteca non si sa quasi nulla, a parte la sua fama, eppure, come uno dei fantasmi più illustri della storia, la Biblioteca di Alessandria è divenuta l’archetipo di tutte le biblioteche. Le biblioteche hanno le forme e le dimensioni più diverse. Possono essere enormi come la Biblioteca Vaticana o minuscole come quella del campo di concentramento per bambini di Birkenau, dove le bambine più grandi custodivano otto volumi che dovevano essere nascosti ogni sera per evitare che i secondini nazisti li confiscassero.
È nella natura delle biblioteche esistere nel pericolo costante di essere distrutte, dalla guerra, dai parassiti, dal fuoco, dall’acqua o dalle dabbenaggini della burocrazia. Ma oggi il pericolo maggiore viene da cambiamenti sconsiderati che rischiano di far perdere alle biblioteche il loro triplice ruolo tradizionale: custodi della memoria della nostra società, fornitrici dei resoconti delle nostre esperienze e degli strumenti per esplorarle, e infine (non meno importante) simboli della nostra identità.
Dai tempi di Alessandria le biblioteche rivestono una funzione simbolica, ma dalla metà del Novecento sembrano trattate come semplici magazzini di una tecnologia giudicata defunta non sono considerate degne di adeguata conservazione e finanziamenti. Eppure resistono. Decise a sopravvivere in un’epoca in cui l’atto intellettuale ha perso quasi tutto il suo prestigio, le biblioteche sono diventate in buona parte centri sociali.
Ma se si vuole che diventino il cuore di centri sociali più ampi, allora occorreranno cambiamenti operati in modo consapevole da un’istituzione intellettualmente forte che ne riconosca il ruolo esemplare, preservando la centralità del libro e insegnandoci che cosa possono fare i libri; mostrarci le nostre responsabilità gli uni verso gli altri, aiutarci a mettere in discussione i nostri valori e minare i nostri pregiudizi, fornirci il coraggio e l’ingegno per continuare a vivere insieme e offrirci parole illuminanti che ci consentano di immaginare tempi migliori. Secondo lo storico greco Diodoro Siculo, le biblioteche dell’antico Egitto recavano scritte sopra l’ingresso queste parole: «Clinica dell’anima».
(Traduzione di Fabio Galimberti)
Benvenuti nelle Biblio-tech
C’è chi digitalizza il proprio patrimonio librario chi si trasforma in museo chi organizza eventi chi fa accordi con Google
Nell’era della crisi del libro e della concorrenza della Rete ecco come cambiano le vecchie biblioteche
di Raffaella De Santis (la Repubblica, 2.11.2015)
All’entrata della Boston Public Library c’è scritto “free to all”, aperta a tutti. La prima biblioteca pubblica al mondo è fondata nel 1852 dal finanziere Joshua Bates con questo intento: mettere i libri a disposizione di chiunque. Ma oggi, nell’era di Internet, che fine fanno le biblioteche? Per sopravvivere cambiano pelle: alcune puntano sulla tecnologia, altre si reinventano come musei, organizzano mostre e vanno a caccia di eventi da proporre al pubblico.
I numeri non confortano. In Gran Bretagna negli ultimi dieci anni sono state chiuse 350 biblioteche e in Canada la biblioteca pubblica di Toronto è stata salvata in extremis grazie a una campagna di mobilitazione caldeggiata da Margaret Atwood. Ovunque sono stati tagliati i finanziamenti, è stato ridimensionato il personale e le ore di apertura al pubblico sono diminuite. In Italia, secondo una ricerca fatta dal Centro per il Libro e dall’Istat, nel 2012 risultavano chiuse 224 biblioteche di pubblica lettura sulle 3.854 che avevano risposto all’indagine (su un totale di 6.890 censite) e nel 2013 88 (su un campione di 5.842).
Il pericolo ha però messo in moto il cambiamento. Di fronte al rischio di sparizione le biblioteche vogliono reinventarsi. E lo fanno in due direzioni: da una parte diventando sempre più digitali, dall’altra trasformandosi in spazi espositivi, sale concerto, luoghi di incontro e letture pubbliche. «La nostra idea è quella di presentare la biblioteca come fosse un museo, sul modello di quanto già avviene alla British Library di Londra», dice Andrea De Pasquale, direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma, nella quale lavorano poco più di 200 persone e che conserva sette milioni di volumi. La biblioteca ha da poco allestito uno spazio dedicato a Elsa Morante che ricostruisce lo studio di via dell’Oca 27, quello affacciato su Piazza del Popolo, dove l’autrice de La Storia si rintanava a scrivere (ci sono la sua scrivania, la sua macchina da scrivere, le sue carte) e sta per aprire un piccolo museo dedicato a Pier Paolo Pasolini, che sarà inaugurato mercoledì prossimo.
Insomma, se la British Library mette in mostra gli autografi di Shakespeare perché non farlo anche noi? A Milano, alla Biblioteca Braidense, c’è una sala dedicata a Lalla Romano, grazie alle donazioni di manoscritti e mobili fatte dagli eredi. Ma se da una parte si punta su incunaboli, autografi, carteggi, dall’altra si cerca di sbarcare in rete. Le tre principali biblioteche statali italiane, Roma, Napoli e Firenze, hanno aderito al progetto Google, che prevede la digitalizzazione entro il prossimo anno di 500mila volumi. «Mandiamo a digitalizzare cinquemila volumi ogni settimana», racconta De Pasquale.
La Bibliotech italiana ha preso il via da un paio d’anni, ma già conta più progetti. Accanto al trasferimento dei libri su Google (solo di quelli fuori dal diritto d’autore) c’è il progetto “Magazzini Digitali”, una piattaforma online per conservare ebook e materiale internet che non abbia un corrispettivo cartaceo. Il magazzino, dunque, non è più un archivio polveroso, dove perdersi tra pile di documenti, è una nuvola che vive solo sul web. I documenti (tutti nativi digitali) vengono custoditi in tre differenti server, di modo che se un sito perde le informazioni, i dati continuano ad esistere negli altri due.
Il problema con il digitale sono i costi di conservazione e di aggiornamento, molto più alti. Giovanni Bergamin, responsabile dei servizi informatici della Biblioteca nazionale di Firenze, spiega: «Bisogna investire soldi per evitare l’obsolescenza del software e dell’hardware, ma il vantaggio è che grazie ad Internet aumenta l’accessibilità ai documenti». Per consultare le collezioni digitali delle biblioteche è stata creata Media Library Online, una rete a cui hanno aderito 4000 biblioteche pubbliche. “Free to all”, la scritta all’entrata della Boston Public Library, potrebbe tranquillamente essere usata come motto della rete. Da noi la digitalizzazione al momento si ferma alla seconda metà dell’Ottocento, ma negli Stati Uniti sono stati digitalizzati tutti i libri non oltre il 2004, fino a quando un contenzioso con gli editori ha costretto Google a fermarsi.
Ora che alle biblioteche arriveranno nuovi fondi dalla legge di Stabilità del Mibact, bisognerà vedere come verranno redistribuiti i 45 milioni messi a disposizione (sono previste anche cinquecento nuove assunzioni). Di certo alla Nazionale di Roma andranno cinque milioni di euro (finanziamento raddoppiato rispetto al passato) e tre andranno a quella di Firenze, in cui attualmente lavorano 157 persone e che conserva sei milioni e 700 mila volumi e 120mila periodici (oltre a quattro mila incunaboli, un milione di autografi e 25mila manoscritti). Dice però Rossana Rummo, direttrice generale Biblioteche: «Sono soprattutto le biblioteche di pubblica lettura a svolgere un ruolo importante di aggregazione sociale, come la rete delle biblioteche romane che svolge un ruolo importante in zone degradate della città ». A questo tipo di realtà di quartiere, si rivolge la campagna “Libriamoci” promossa dal Centro per il Libro, che punta a incentivare la lettura tra i ragazzi delle scuole anche attraverso iniziative nelle biblioteche comunali.
Tra i modelli di biblioteca del futuro a cui noi mediterranei guardiamo c’è l’Idea Store di Londra, un posto in cui seguire corsi di ogni tipo: fotografia, scrittura, perfino cucina. Non a caso qualcuno l’ha ribattezzate biblioteca Starbucks. Alla nazionale di Napoli (che custodisce più di 1700 papiri preziosissimi ercolanesi, oltre a 19mila manoscritti, 4.563 incunaboli, un milione e 800mila volumi a stampa) si è appena organizzata una mostra sul cibo. «Ci interessa raccontare la nostra storia, far conoscere la nostra identità e il cibo fa parte della nostra cultura », spiega la direttrice Vera Valitutto.
Forse è qui il segreto delle biblioteche, nella loro capacità di adattamento ai tempi. In Italia il processo è appena iniziato. Due anni fa John Palfrey, studioso americano esperto della rete, pubblicava un libro intitolato proprio Bibliotech. Sosteneva: «La biblioteca ha bisogno di un aggiornamento » e ne incoraggiava la mutazione digitale. La biblioteca mutante ha preso forma, tra papiri e pagine web. Borges sognava una biblioteca illimitata. Oggi quel sogno potrebbe avverarsi, ma sul web.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- Le vere lezioni americane di Calvino sono i libri che ha scelto (di Gaetano Moraca)20 settembre 2015, di Federico La Sala
Le vere lezioni americane di Calvino sono i libri che ha scelto
Per quasi 15 anni Calvino ha diretto la collana di romanzi Centopagine di Einaudi, mettendo in pratica il suo ultimo “testamento”
di Gaetano Moraca (LINKiesta, 19/09/2015)
Tracciare un profilo del Calvino letterato è cosa sicuramente complessa. Se poi si pensa all’altra faccia di Calvino, l’editore, la faccenda potrebbe subire ulteriori complicazioni. Anche perché, come il recto e il verso di un foglio, Calvino è indivisibile, in questo per niente simile al visconte Medardo di Terralba. Ma se, per gioco, accettiamo l’affascinante sfida di perderci nel suo labirinto, forse potremmo anche trovare un’originale via d’uscita.
- Poco più che ventenne, Calvino entra a far parte dell’Einaudi iniziando dall’ufficio stampa fino a diventarne redattore e consulente a tutti gli effetti per quasi 40 anni
Poco più che ventenne, Italo Calvino entra a far parte dell’Einaudi iniziando dall’ufficio stampa fino a diventarne redattore e consulente a tutti gli effetti per quasi 40 anni. Il lavoro editoriale gli offre la possibilità di suggerire e divulgare la sua idea di letteratura, aspetto in cui crede fermamente. Specie quando, nel 1971, diventa padre assoluto della collana einaudiana dei «Centopagine» che mantiene in vita fino al 1985, nonostante le cicliche crisi finanziarie della casa editrice. Oltre alla scelta dei titoli da pubblicare (principalmente racconti lunghi o romanzi brevi - sulle cento pagine appunto - provenienti per oltre la metà dall’Ottocento e di nazionalità francese, inglese, tedesca, russa, americana e italiana) Calvino ne cura personalmente quasi tutti i paratesti, dalle quarte di copertina alle note introduttive. Da quelle scelte e da quei paratesti appare evidente che Calvino aveva già le idee molto chiare sul modello di letteratura che intendeva diffondere. E lo fa con le armi dell’editore e con il pathos del letterato.
Se come Marco Polo ci poniamo nella condizione mentale del viaggio e ci perdiamo dentro questi apparati critici e nelle motivazioni che hanno portato alla pubblicazione di questi libri (spesso alla ripubblicazione, seppur con vesti rinnovate) vuol dire che abbiamo accettato la sfida di Calvino e che vogliamo recuperare quelle tracce di sé che ci ha lasciato generosamente “nei libri degli altri”; e che poi ha deciso di “fissare” nel suo ultimo sforzo intellettuale, le Lezioni americane (uscito postumo nel 1985), in cui dedica pagine preziose a leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, canoni che considerava indispensabili alla letteratura del terzo millennio.
- Tutta la letteratura per Calvino deve implicare una sottrazione di peso, altrimenti si rischia di cadere nell’opacità, nell’inerzia e nella pesantezza del mondo, che inesorabilmente si riversa nella scrittura
Prendiamo il primo canone, la leggerezza, intesa come «narrazione d’un ragionamento o d’un processo psicologico in cui agiscono elementi sottili e impercettibili»: Calvino cita apertamente la scrittura di Henry James. Tutta la letteratura per Calvino deve implicare una sottrazione di peso, altrimenti si rischia di cadere nell’opacità, nell’inerzia e nella pesantezza del mondo, che inesorabilmente si riversa nella scrittura. E sono 5 i libri di James (Daisy Miller, Il carteggio Aspern, La fonte sacra, Una vita londinese, Il riflettore) che compaiono tra i 77 dei «Centopagine». E della capacità di trasformare in letteratura, attraverso la sottrazione di peso accessorio, il grave e fisico mondo circostante, ne abbiamo contezza nella quarta di copertina scritta da Calvino per L’uomo che corruppe Hadleyburg di Mark Twain (pubblicato in «Centopagine» nel 1972). Calvino presenta Twain come un «instancabile sperimentatore e manipolatore di congegni linguistici e retorici [...]: basta mettergli in mano un testo scritto qualsiasi e lui si mette a giocarci finché non salta fuori un racconto. Ma dev’essere un testo che con la letteratura non abbia nulla a che fare». Letteratura contro mondo fisico, leggerezza contro gravità.
Per introdurre il canone della rapidità Calvino ci parla di quanto sia fondamentale l’economia di tempo nella letteratura: tanto tempo si risparmia, tanto più se ne può perdere. E visto che non intende escludere il canone opposto, lo scrittore considera “rapida” quella «scrittura pronta alle divagazioni, a saltare da un argomento all’altro, a perdere il filo cento volte e a ritrovarlo dopo cento giravolte». Il romanzo tutto composto da digressioni è la grande invenzione di Lawrence Sterne, presente in «Centopagine» nel 1981 con Un romanzo politico; e di contro nella quarta di copertina del libro, Calvino ci fa notare come l’autore concepisca i suoi testi «come scatole a sorpresa o trappole o ragnatele sospese nel vuoto». Esempio seguito da Diderot che si appropriò del metodo della digressione e della divagazione per cercare di rinviare la conclusione e moltiplicare il tempo all’interno dell’opera: operazione evidente in Jacques le fataliste (che uscirà nella collana nel 1979) in cui, nota Calvino, “lo schema del «racconto differito» è per Diderot la sola veritiera immagine del mondo vivente”.
- Sdegnato dall’«uso approssimativo, casuale, sbadato» del linguaggio, Calvino si affanna per trovarci la cura. «Solo la letteratura può creare gli anticorpi che contrastino l’espandersi della peste del linguaggio
Sdegnato dall’«uso approssimativo, casuale, sbadato» del linguaggio, Calvino si affanna per trovarci la cura. «Solo la letteratura può creare gli anticorpi che contrastino l’espandersi della peste del linguaggio», una letteratura dotata di esattezza, di assoluta precisione, di un linguaggio dosato maniacalmente, capace di farci intuire e vedere anche quello che non è scritto. Esattezza descrittiva che rintraccia ne I tre racconti di Flaubert (nell’80 per «Centopagine»), dove «la trasparenza delle frasi del racconto è il solo mezzo possibile per rappresentare la purezza e la nobiltà naturale nell’accettare il male e il bene della vita». Così Balzac che con l’esattezza di un linguaggio limpido e altamente descrittivo ci permette di conoscere la città di Parigi in ogni suo angolo, in Ferragus (1973) e l’arredamento dei salotti della media borghesia francese de I piccoli borghesi (1981).
- La grandezza della letteratura consiste nella miracolosa capacità di trasformare «le visioni polimorfe degli occhi e dell’anima» in «pagine di segni allineati fitti fitti come granelli di sabbia»
Esattezza e visibilità, terza e quarta lezione, sono canoni strettamente connessi. Quanto più una pagina è dotata di esattezza tanto più permette di evocare immagini, di essere vivida e icastica. La grandezza della letteratura consiste nella miracolosa capacità di trasformare «le visioni polimorfe degli occhi e dell’anima» in «pagine di segni allineati fitti fitti come granelli di sabbia». In un articolo Calvino affermerà che «la visività romanzesca comincia in Stendhal e Balzac, e tocca con Flaubert il rapporto perfetto tra parola e immagine» (Stendhal presente in «Centopagine» nel 72 con La badessa di Castro), aggiungendo che Flaubert concepisce, come lui, il «romanzo come arte di far vedere persone e cose». E dell’esattezza della scrittura in grado di rendere visibile anche quello che non c’è, parla nella nota introduttiva di Due ussari di Tolstoj (in «Centopagine» nel 72): «Capire come Tolstoj costruisce la sua narrazione non è facile. Quel che tanti narratori tengono allo scoperto in lui resta nascosto, ma nascosto non vuol dire che non ci sia [...]. Tale occultamento della meccanica narrativa» permette di intuire che «ciò che conta in Tolstoj è ciò che non si vede, ciò che non è detto, ciò che potrebbe esserci e non c’è»; allo stesso modo questa dissimulazione dei reali intenti dell’autore rappresenta il solco lungo cui scorre la penna di Henry James in Daisy Miller, il quale «sembra sempre sul punto di dire qualcosa che non dice», come Calvino ci fa notare nella nota introduttiva del ’73.
Nella lezione sulla visibilità cita Hoffmann, von Arnim, Eichendorff, Gogol, Leskov, che compaiono anche nei «Centopagine», attratto dalla vena visionaria e spettacolare di cui traboccano i loro romanzi. E arriva fino a Stevenson, in «Centopagine» con Olalla nel ’74 e con Il padiglione delle dune nel ’73. Nella nota introduttiva di quest’ultimo, Calvino addirittura asserisce: «The Pavilion on the Links è la storia che vien fuori da un paesaggio. Dalle dune desolate delle coste scozzesi». E ancora afferma, nella quarta di copertina che compone per La prateria del Giacinto di Charles Sealsfield, (nella collana einaudiana nel 1974) che il racconto non è altro che «un’allucinante cavalcata attraverso le deserte praterie del Texas, tra rare “isole” d’alberi e solitari elci ricoperti di lunghe barbe di muschio».
- Il padre di Marcovaldo diceva che i libri sono fatti per essere affiancati da altri innumerevoli libri e «la verità si trova solo inseguendola dalle pagine d’un volume a quelle d’un altro volume»
Approdando infine alla molteplicità, citazione obbligata è la polifonia bachtiniana, concetto che il critico russo ha elaborato da un’originale lettura di Rabelais e Dostoevsky, quest’ultimo in «Centopagine»» con ben cinque titoli, tra cui Le notti bianche (1971), uno dei più venduti della collana. Con la molteplicità in letteratura Calvino intende quell’insieme di piani, d’intrecci, di suggestioni che permette di approdare alla struttura propria del genere romanzesco. Sia nella nota introduttiva di Pierre e Jean di Maupassant, pubblicato nel 1971 (in cui dichiara «In questa densità del mondo dell’esperienza sta il naturalismo di Maupassant, per la chiara coscienza che Maupassant possiede [...] che questa verosimiglianza è anch’essa un codice di convenzioni, uno speciale criterio d’accumulazione e d’economia di “piccoli fatti” per evidenziare e insieme dissimulare le “intenzioni”, il “piano” del racconto») sia nella quarta che scrive per Il viaggiatore incantato di Nikolaj Leskov del 1978 (in cui afferma «Il piacere del raccontare [...] Uno sconosciuto comincia a rievocare episodi della sua vita, e ogni storia che racconta è più incredibile della precedente, e una storia tira l’altra, e infine è tutta una vita fitta di vagabondaggi e avventure che viene fuori, [...] in cui è impossibile sceverare verità da affabulazione») è possibile rinvenire tutta una serie di analisi introspettive, descrizioni psicologiche e innumerevoli suggestioni che mirano alla creazione del «romanzo come grande rete». Proprio come lo intendeva Calvino.
Il padre di Marcovaldo diceva che i libri sono fatti per essere affiancati da altri innumerevoli libri e «la verità si trova solo inseguendola dalle pagine d’un volume a quelle d’un altro volume». Accettare la sfida e giocare oggi con l’eredità di Calvino, a trent’anni dalla sua morte, resta un nostro dovere. Inoltre è l’unico modo che abbiamo per dirgli ancora grazie, specie nell’anno in cui tanti maturandi avranno (presumibilmente) vituperato il suo nome.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- Calvino. Una morte seguita in diretta (di Paolo Di Paolo)13 settembre 2015, di Federico La Sala
Calvino Una morte seguita in diretta di Paolo Di Paolo La Stampa 13.9.15
«Calvino sta morendo». Fa un certo effetto, a trent’anni dalla morte, ritrovare le cronache de La Stampa nei giorni del lungo addio allo scrittore. Colpito da emorragia cerebrale nel pomeriggio del 6 settembre 1985 a Castiglione della Pescaia, viene ricoverato a Siena: i giornali seguono con un’attenzione oggi forse impensabile il congedo, l’alternarsi di speranze e di peggioramenti. «Calvino si aggrava» si legge ancora su La Stampa due giorni prima della morte.
«La testa fasciata»
«Alterazione febbrile, ulteriore spasmo cerebrale»: il bollettino medico è pubblico, curioso paradosso per uno scrittore tanto schivo e insofferente alle biografie. C’è l’ansia dei lettori e del mondo della cultura internazionale, il viavai degli amici all’ospedale: Natalia Ginzburg racconterà di averlo visto, dopo l’intervento, con «la testa fasciata, le braccia nude fuori dal lenzuolo, abbronzate e forti, ed era assopito». «Mi riesce difficile pensarlo morto - aggiunge Ginzburg - Non so perché, ma la morte mi sembrava quanto mai lontana dalla sua persona».
Calvino era poco più che sessantenne, stava lavorando alle Lezioni americane, che avrebbe tenuto ad Harvard nell’autunno. Forse non immaginava con quanta ansia gli studenti lo aspettavano. Uno di loro, Jonathan Lethem, diventato poi scrittore, si trovò davanti un avviso con su scritto che erano annullate: «Vissi la sua morte come un affronto personale», ha raccontato. Le cronache di questa morte inattesa e insieme annunciata fanno cortocircuito con i testi a cui Calvino stava lavorando: una conferenza dal titolo eloquente, Cominciare e finire, e la lezione americana non scritta, Coerenza.
Il silenzio
In entrambe, il silenzio è un tema centrale. Forse, agli studenti di Harvard (e a noi), Calvino avrebbe detto che sì, certo, aveva parlato molto di scrittura, lui che molto aveva scritto, ma che l’ultima lezione non poteva che essere sul contrario di scrivere. Stare zitti ancora per un po’, pensare, evitare di aggiungere altre parole, «preferire di no». Fermi, e solidi, nel ronzio di fondo, in ascolto, convinti che un silenzio - il silenzio - non solo è più eloquente, perfino più utile di molti discorsi. È più «coerente», e più onesto. Quanto a Palomar, il suo romanzo ultimo, finisce così: «Se il tempo deve finire, lo si può descrivere, istante per istante, pensa Palomar, e ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine. Decide che si metterà a descrivere ogni istante della sua vita e finché non li avrà descritti tutti non penserà più d’esser morto. In quel momento muore».
Lo scrittore che più progetta, combina, esplora le possibilità della scrittura, i generi e le forme, sembra infine ossessionato da ciò che nega le parole, le interrompe. Dal silenzio, dalla pagina che finalmente resta bianca, come la distesa di neve alla fine di Marcovaldo. Ma ci parla del «senso di una fine» anche la chiusa del Barone rampante, con quell’ultimo «grappolo insensato di parole idee sogni». «Per me invece è la fine che conta» dice un lettore in Se una notte d’inverno un viaggiatore, «ma la fine vera, ultima, nascosta nel buio, il punto d’arrivo a cui il libro vuole portarti». Un altro confessa che il suo sguardo scava tra le parole «per cercare di scorgere cosa si profila in lontananza, negli spazi che si estendono al di là della parola ’fine’».
Il non dire
È là che va cercato e riletto Calvino, in questo suo eterno corpo a corpo col non dire, con il non dicibile e non detto, con la parola assediata dal suo contrario. All’indomani della scomparsa, su La Stampa, Nico Orengo ricordava come Calvino - «per ragionare, per riflettere un attimo di più» - fosse capace di inventarsi una finta balbuzie. Forse proprio per questo aveva scelto lo scrivano di Melville come protagonista dell’ultima lezione. Bartleby, con il suo «avrei preferenza di no», diventa inespugnabile, invisibile, muto. Rinuncia a parlare, e soprattutto a scrivere. Una forma di sublime apatia, contro un mondo che chiede troppo, contro la vitalità dei tempi, «rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante»?
È un ripiegamento difensivo o una più alta forma di presenza - sospesa, senza arroganza, senza illusioni? Forse ad Harvard avrebbe spiegato che scrivere ha molto a che fare col non scrivere. Forse avrebbe spiegato che dire no, o non dire, è il gesto di coerenza più grande. Forse avrebbe difeso anche la scelta di farsi da parte, di rinunciare quasi a esserci: scomparire, farsi tentare dalla rinuncia. Forse avrebbe detto che essere sé stessi fino in fondo può somigliare anche a un gesto di mitezza estrema. A un silenzio.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- Le lezioni messicane del Calvino filosofo - e una scolaresca di piccoli toltechi: (di Massimo Rizzante)11 settembre 2015, di Federico La Sala
Le lezioni messicane del Calvino filosofo
Nel trentennale della morte viaggio a Tula, luogo in cui il grande scrittore rinnegò il suo “sguardo da archeologo”sul mondo dei segni: “Interpretare è tradire”
di Massimo Rizzante (la Repubblica, 11.09.2015)
Di stanza a Città del Messico per un mese. Abito per un po’ nella Casa Refugio Chitlatépetl, tra Condesa e Hipódromo, quartieri sicuri e ricchi della capitale. Basta uscire in strada e osservare il passo tranquillo dei cani d’alto bordo e dei loro padroni. Dopo qualche giorno decido di andare a Tula, l’antica capitale dei toltechi, un popolo prudente e saggio, il cui regno durò cinque secoli e che fu sempre fedele a Quetzalcóatl, il celebre dio raffigurato come un serpente piumato.
Dopo un’ora e mezza di corriera mi trovo di fronte a una zona archeologica dominata da una grande piramide sopra la quale quattro enormi guerrieri in basalto, gli Atlanti, guardano l’orizzonte. Perché sono salito fin quassù? Per vedere gli Atlanti? Non proprio.
Sono qui per rendere onore a Italo Calvino. È morto trent’anni fa. Ho come la sensazione che in Italia sia stato prima postmodernizzato, accusato cioè con frivolezza di tutte le derive di quella stagione che ormai nessuno ricorda più, poi canonizzato, quindi messo nel dimenticatoio dove stanno tutti i morti.
Sono qui perché anche lui molto tempo fa è stato da queste parti. Ho come la sensazione che in mezzo a tutte queste rovine il suo “sguardo d’archeologo”, come scrisse nel lontano 1972, mi sia ancora utile a descrivere pezzo per pezzo il mio mondo. Quando è morto, stava componendo le Lezioni americane, dove descrive i valori letterari che avrebbe voluto conservare: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità.
Oggi, agli inizi del millennio che Calvino non fece in tempo a vedere, le sue conferenze mi sembrano lettere inviate ad amici ignoti. Ricordo la fine del libro: «Magari fosse possibile un’opera concepita al di fuori del self, un’opera che ci permettesse d’uscire dalla prospettiva limitata d’un io individuale, non solo per entrare in altri io simili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola, l’uccello che si posa sulla grondaia, l’albero in primavera e l’albero in autunno, la pietra, il cemento, la plastica...».
Che senso avrebbe la letteratura se non fosse divorata dalla pretesa impossibile di uscire da se stessa? Sarebbe un gioco che si inventa le sue regole e basta. Proprio questa domanda è il valore essenziale, implicito in ogni pagina delle Lezioni americane.
Prima di scrivere le lezioni, nel 1983 Calvino pubblica Palomar. In un capitolo del libro, Serpenti e teschi, il protagonista è in Messico. Visita le rovine dell’antica Tula. Con lui c’è un amico, esperto delle civiltà precolombiane. Palomar lo ascolta con attenzione, attratto dal gioco di rimandi che viene dai reperti del passato. Però è incuriosito anche dall’atteggiamento opposto, apparentemente rinunciatario, di un maestro elementare che sta accompagnando la sua scolaresca. Il maestro non offre una spiegazione - analogica, simbolica, allegorica, mitologica - dei monumenti, ma termina invariabilmente il suo discorso agli allievi con un laconico: «No se sabe lo que quiere decir» («Non si sa quello che vuol dire»).
Palomar è a disagio. Si rende conto che le parole del maestro, pur non avendo nulla di scientifico, possiedono una certa saggezza. Riflette: «Il rifiuto di comprendere più di quello che queste pietre ci mostrano è forse il solo modo possibile per dimostrare rispetto del loro segreto; tentare di indovinare è presunzione, tradimento di quel vero significato perduto».
Per il maestro elementare, le pietre di Tula non sono segni, puntelli su cui far leva per almanaccare castelli di significati; sono apparenze che si presentano alla percezione e che perciò richiedono da parte di chi guarda una certa remissione delle facoltà razionali. Mentre Palomar sa già quel che vede, il maestro elementare si meraviglia e tace perché non lo sa. Per lui l’ignoto è all’ordine del giorno. Le cose sono mute. Possono emanare uno stato di quiete, ma che cosa possono dirci? Palomar, malgrado si sforzi, non riesce al contrario a trattenersi dal compiere l’eterna ubris, non smette cioè di pensare, di interpretare ogni cosa che vede, con tutto il fardello di nevrosi e scacchi che ciò comporta.
Ecco cos’è stata Tula per Calvino: la possibilità di sospendere la danza ermeneutica attorno alle cose, di cominciare un’altra danza. Il suo destino, come nel caso di Palomar, è stato poi quello di interpretare fino al suo ultimo giorno, tanto che il suo erratico tentativo di descrivere i valori letterari da trasmettere al millennio che non vide, si può ben definire, come nel caso del suo personaggio, una lunga esercitazione alla morte. Però qualcosa, alla fine delle sue Lezioni americane, è rimasto della laconica lezione del maestro elementare di Tula. Per questo mi piace immaginarlo qui, pieno di meraviglia di fronte a queste rovine mute, un po’ meno incredulo di fronte alle apparenze del mondo, mentre scende in silenzio le scale della grande piramide con al seguito una scolaresca di piccoli toltechi dalla testa impiumata.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- Ripensare Calvino oltre il cliché della leggerezza. A trent’anni dalla morte le Lezioni americane restano la sua opera meno compresa13 settembre 2015, di Federico La Sala
Ripensare Calvino oltre il cliché della leggerezza
A trent’anni dalla morte le Lezioni americane restano la sua opera meno compresa
di Marco Belpoliti (La Stampa, 13.09.2015)
Calvino? Le Lezioni americane. La leggerezza. Il brand dello scrittore, se così si può dire, è saldamente legato a quel libro postumo, all’idea del «togliere peso»; del resto, viviamo da vari decenni dentro il mondo dell’immateriale. E se, invece di lasciarci all’improvviso in quel settembre del 1985 , Calvino avesse potuto terminare le sue conferenze a Harvard, scrivendo l’ultima, quella sulla Consistency, dedicata a Bartleby lo scrivano di Melville, quale immagine avremmo di lui? E se la sua idea di autobiografia senza Io, di cui ci resta l’abbozzo de La strada di San Giovanni, fosse stata portata a termine, come lo considereremmo?
Insieme a Pasolini e Primo Levi, Calvino è il più noto scrittore italiano della seconda metà del XX secolo. Certamente è ancora uno dei più letti, se è vero che nelle nostre scuole circola il Sentiero dei nidi di ragno, unico libro sulla Resistenza che i giovani hanno tra le mani, e anche la trilogia dei Nostri antenati che sembra reggere nel tempo, mentre non c’è architetto che non citi Le città invisibili, il suo capolavoro letterario, anche se sovente a sproposito.
Non si può fare la storia con i se e con i ma, tuttavia le Lezioni americane hanno prodotto nella vulgata corrente una distorsione nella percezione del lungo, ampio e complesso lavoro di Calvino. Le citazioni prevalenti vanno alla lezione sulla Leggerezza, o al massimo a quella sulla Rapidità, mentre quasi nessuno richiama Visibilità o Molteplicità, ben più complesse, e certamente meno cool.
La lezione mai scritta
Il titolo americano delle Lezioni era più concreto e diretto: Six memos for the next millennium. Più un post it che una Bibbia del futuro. Calvino era intenzionato a riscrivere e sistemare i capitoli dei suoi interventi americani pensando ai lettori italiani. Inoltre, senza la finale lezione sulla «coerenza» (consistenza o compattezza) è difficile dare un senso a quello che viene passato come il suo testamento.
A leggere gli apparati che Mario Barenghi ha allestito nel Meridiano dei Saggi, ci si rende facilmente conto che gli autori che Calvino avrebbe citato nella lezione mancante erano tutti personaggi, da Bartleby a Wakefild, che dicevano di no, che scomparivano, sottraendosi ai legami sociali: lavoro, matrimonio, residenza.
Decisamente le Lezioni americane non hanno giovato alla comprensione di Calvino, non certo per colpa sua, ma per demerito di molti lettori, anche colti, che l’hanno eletto a profeta della leggerezza, là dove lui era invece il cantore da almeno venti anni del suo contrario: la pesantezza.
La pesantezza
Si è confuso, e si continua a confondere la leggerezza della scrittura di Calvino, frutto di un lavoro incredibile, come testimoniano gli autografi, con l’idea di leggerezza in generale. A partire dal 1968, Calvino ha cercato di contrastare la pesantezza che era entrata nel nostro mondo in modo forse definitivo. La nuova pesantezza, che egli cercava di diradare con l’utopia pulviscolare di Fourier, lascito del suo Sessantotto, gli era apparsa alla fine dei Sessanta più densa e consistente di quella degli anni di ferro del comunismo staliniano; con grande realismo il fantasioso autore del Barone rampante aveva cercato di contrastare la visione cupa subentrata allora mobilitando i suoi personaggi di carta, come il signor Palomar, un Marcovaldo redivivo, con tanto di occhiali, biblioteca di letture e pensieri da scrittore.
Calvino non può essere compreso se non si considera che è stato, oltre che uno scrittore, un intellettuale, il quale pensava il proprio lavoro letterario tarandolo sull’attualità sociale e politica, mediando continuamente tra questa e il suo talento e il suo carattere. Non c’è un libro di Calvino uguale all’altro, per quanto si continui a considerarlo uno scrittore unitario, o al massimo con due movimenti: primo e secondo Calvino. Come Levi, Calvino è un poliedro con tante facce. Certo, la coerenza era uno dei suoi problemi principali, ma non è solo su questo metro che possiamo oggi valutarlo.
Un doppio metro
Cos’è vivo e cosa morto del suo lavoro? Vivissimo è il suo libro d’esordio, Il sentiero, che ha guadagnato con il passare degli anni; anche i libri della Trilogia hanno una loro vitalità, Il barone rampante più di tutti. Le città invisibili sono un libro indecifrabile, misterioso e inafferrabile, che attende ancora i suoi lettori ideali. Meno efficaci sono invece i libri «realisti» come La speculazione edilizia o La giornata di uno scrutatore, per quanto sia uno dei suoi libri che amo di più. La vena favolistica continua a mantenere vive Le cosmicomiche, sebbene meno riuscite di altre parti della sua opera, tuttavia anche questi racconti contengono temi - la biologia ad esempio - che probabilmente torneranno utili in prossimo futuro.
Calvino non è stato solo un letterato; la sua valutazione non va compiuta tenendo conto del valore estetico dei suoi testi, o almeno non solo. Vale per lui, come per Pasolini e Levi, la considerazione su quanto la letteratura illumini aspetti decisivi della nostra esistenza, dalla psiche individuale ai grandi problemi sociali. La sua durata si misura su questo doppio metro.
-
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- MATURITA’ 2015: PROVA DI ITALIANO. Calvino ("Il sentiero dei nidi di ragno") per l’analisi del testo17 giugno 2015, di Federico La Sala
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE -- Non basta essere nel giusto. Una lezione morale che non riguarda la leggerezza, ma l’impegno di affrontare il male che ci circonda7 giugno 2015, di Federico La Sala
Italo Calvino (1923-1985)
Non basta essere nel giusto
Una lezione morale che non riguarda la leggerezza, ma l’impegno di affrontare il male che ci circonda
di Carlo Ossola (Il Sole-24 Ore, Domenica, 07.06.2015)
Più il tempo ci allontana dagli anni della sua vita, più la figura di Italo Calvino cresce - nel bilancio critico del Novecento - come uno dei nostri più alti autori di contes philosophiques; senza attendere Palomar, la meditazione di Calvino si dichiara sin da una lettera a Valentino Gerratana, del 15 ottobre 1950: «Credi sempre che la guarigione sia nel ragionamento, nell’aver chiarito teoricamente il problema, mentre invece la coscienza della via di soluzione d’un problema morale non si può avere che contemporaneamente alla sua soluzione pratica effettiva».
Calvino ha saputo dar forma a una lingua capace dell’universo, precisa, esatta e tuttavia senza confini, classica nel conferire il primato alle idee, il posto giusto agli oggetti, alle forme, ai tempi, allo sguardo che li mette in prospettiva. Come la sua lingua, egli è il nostro classico del Novecento, nella sua capacità di cancellare tutto l’inessenziale, tutto il transeunte, per ottenere il supremo dono dell’arte, la «trasparenza», quale egli vede sorgere dallo sguardo di Félicité, la più umile delle figure dei Trois contes di Flaubert: «la trasparenza delle frasi del racconto è il solo mezzo possibile per rappresentare la purezza e la nobiltà naturale nell’accettare il male e il bene della vita».
La levità combinatoria di Calvino è stata spesso accostata a quella dell’Ariosto (sul quale del resto egli ha scritto pagine mirabili): e tuttavia quando si mediti il suo ultimo lascito, Perché leggere i classici (apparso postumo nel 1991), non all’Ariosto ma a Flaubert va ricondotta la sua arte e il suo dono, a noi più prezioso, quello di aver ricreato, per il XXI secolo, lo sguardo di Félicité: così «possiamo riconoscere l’arduo punto d’arrivo cui tende l’ascesi di Flaubert come programma di vita e di rapporto col mondo. Forse i Trois contes [come la trilogia di Calvino: Le città invisibili, Palomar, Six memos] sono la testimonianza d’uno dei più straordinari itinerari spirituali che mai siano stati compiuti al di fuori di tutte le religioni».
Occorre oggi piuttosto varcare quella «levità» per accedere a una zona più profonda, e leopardiana, dell’invenzione di Calvino : quella sua visione cosmica ardita e disincantata che manifesta la statura di un grande stoico, di un ultimo Marc’Aurelio senza impero, ma con troppa coscienza storica, quale Calvino stesso figurava -in parte come autoritratto- nella disperata perfezione di Kublai Khan, in una lettera a Suso Cecchi D’Amico del 1960: «Altro personaggio che va messo in rilievo è Kublai Khan, questo sovrano perfetto, dalla assoluta saggezza e gusto per i piaceri della vita, ma - e qui interveniamo noi - malinconico [...]. Ne voglio fare un tipo di nobiltà e malinconia shakespeariana, un principe ancor giovane, bello raffinato, con tristezza metafisica, tipo il Duca (se non sbaglio) della Dodicesima notte e anche un po’ Marco Aurelio».
Una «vanità del tutto» che matura e culmina nella Giornata di uno scrutatore, 1963, ove l’analisi serrata dell’ideologia : «vorrà dire che il comunismo ridarà le gambe agli zoppi, la vista ai ciechi? Cioè lo zoppo avrà a disposizione tante e tante gambe per correre che non s’accorgerà se gliene manca una delle sue? Cioè il cieco avrà tante e tante antenne per conoscere il mondo che si dimenticherà di non avere gli occhi?» verrà a sancire che vana è tale “giustizia ausiliaria”, supplettiva, poiché: «La vanità del tutto e l’importanza d’ogni cosa fatta da ognuno erano contenute tra le mura dello stesso cortile. [...] “Chi agisce bene nella storia, - provò a concludere-, anche se il mondo è il ’Cottolengo’, è nel giusto”. E aggiunse in fretta: “Certo, essere nel giusto è troppo poco”».
Questa la sfida utopica, l’assillo etico di Calvino: «essere nel giusto è troppo poco». Un altro ordine di valori si affaccia allora, contemplando il reciproco aiuto che si danno due idioti: «Ecco, pensò Amerigo, quei due, così come sono, sono reciprocamente necessari. E poi: l’umano arriva dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli che gli diamo». E quella sarà la conclusione, nell’ultimo sguardo sulla città della sofferenza, sul Cottolengo: «Donne nane passavano in cortile spingendo una carriola di fascine. Il carico pesava. Venne un’altra, grande come una gigantessa, e lo spinse, quasi di corsa, e rise, e tutte risero. [...] Anche l’ultima città dell’imperfezione ha la sua ora perfetta, pensò lo scrutatore, l’ora, l’attimo in cui in ogni città c’è la Città».
Dentro le nostre città imperfette, sfrangiate, violente, altre città Calvino disegna, «invisibili», che ’riparino’, almeno progettualmente l’aporia del vivente ; così, nelle tante prospettive che costellano Le città e il cielo, da «Eudossia, che si estende in alto e in basso» a Bersabea, vagheggiata come una Gerusalemme celeste («Si tramanda a Bersabea questa credenza: che sospesa in cielo esista un’altra Bersabea, dove si librano le virtù e i sentimenti più elevati della città, e che se la Bersabea terrena prenderà a modello quella celeste diventerà una cosa sola con essa»), si delinea una tensione utopica: occorrerebbe insomma arrivare a quella così alta perfezione che ogni mutamento terreno comportasse un riordino conseguente dei cieli: « - Così perfetta è la corrispondenza tra la nostra città e il cielo, - risposero, - che ogni cambiamento d’Andria comporta qualche novità tra le stelle-» (Le città e il cielo).
Tale meditazione sarà sviluppata e radicalizzata in Palomar: «Ogni processo di disgregazione dell’ordine del mondo è irreversibile, ma gli effetti vengono nascosti e ritardati dal pulviscolo dei grandi numeri che contiene possibilità praticamente illimitate di nuove simmetrie, combinazioni, appaiamenti». Così noi siamo di fronte, ogni giorno, a un dilemma che si fa oggi più stringente - e conferma il valore profetico per il XXI secolo dell’opera di Calvino - : o ci si avvolge nel « pulviscolo dei grandi numeri » (finanza, teoria delle masse, sofisticazione statistica, etc.) oppure si sceglie radicalmente la conclusione di Marco Polo: «E Polo: - L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio». (Le città invisibili, clausola finale). Un lungo, strenuo, esercizio di discernimento.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- FISCHIA IL VENTO. Felice Cascione che acchiappò il vento e lo fece poi fischiare (di Emilio Marrese)20 aprile 2014, di Federico La Sala
La canzone
Felice che acchiappò il vento e lo fece poi fischiare
di Emilio Marrese (la Repubblica, 20.04.2014)
FU SCRITTA su un foglietto staccato da un ricettario medico. Quello del dottor Felice Cascione, via Asclepio Gandolfo 5 a Imperia. Una prescrizione per l’anima: “Soffia il vento, urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna agir / a conquistare la nostra (?) primavera in cui sorge il sol dell’Avvenire”, recitava la prima strofa a matita in calligrafia ordinata. La spedì dai monti liguri, dov’era salito partigiano dopo l’8 settembre del ’43, alla mamma Maria, maestra elementare. Che gliela fece riavere corretta e dattiloscritta: soffia era diventato fischia, agir era ardir, e la primavera non aveva più punto interrogativo, non era più nostra ma rossa.
La prima volta venne intonata dalla brigata di Cascione, ventisei anni, ex campione di pallanuoto e “medico dei poveri”, davanti al portone della chiesa di San Michele a Curenna, borghetto del savonese, la sera della vigilia di Natale dopo la messa, davanti a un pentolone di castagne. Pochi giorni più tardi Cascione fu trucidato dai fascisti, mentre i suoi versi adottati dal vento continuarono a volare di bosco in bosco fino a diventare l’inno ufficiale della Resistenza.
Prima ancora della più trasversale Bella ciao. Ognuno si masticò la sua versione: ardir può essere anche andar , e c’è chi aggiunge una strofa con falce e martello. Perché quelle parole sono già di tutti, sono fiorite per esserlo. Al punto di poter perlopiù ignorare, oggi come allora, chi ne fosse veramente l’autore. «È una vera e propria arma contro i fascisti. Li fa impazzire, mi dicono, solo a sentirla. Se la cantasse un neonato l’ammazzerebbero col cannone», dice il partigiano Johnny nel romanzo di Beppe Fenoglio.
La storia di Felice Cascione, u Megu, e del suo canto ribelle è stata ricostruita da Donatella Alfonso in Fischia il vento ( Castelvecchi, 140 pagine, 16,50 euro). Bello e carismatico come dev’essere un eroe, Felice rimane orfano a cinque mesi di Giobatta, commerciante d’olio, ma la madre riesce a farlo studiare. Nelle poco limpide acque marine davanti al porto diventa centrovasca e capitano del Guf Imperia, che scala tra il ‘37 e il ‘39 dalla serie C alla A del campionato di pallanuoto. In quella stessa estate arriva secondo ai Mondiali con la nazionale universitaria a Vienna, tre giorni prima dell’invasione della Polonia.
Lascia Genova per la Sapienza a Roma (dove si ritrova in squadra il portiere Massimo Girotti, non ancora divo del cinema), e infine si laurea in Medicina a Bologna nel ’42, al termine della sua fuga dalla burocrazia fascista che lo ostacolava negli esami e nelle graduatorie per un posto alla Casa dello Studente.
Il giovane Felice era nel mirino per le sue frequentazioni, in particolare quella di Giacomo Castagneto detto Mumuccio che lo aveva introdotto nel partito comunista clandestino, e presentato a Natta e Pajetta. Il dottorino diventa subito popolare a Oneglia perché non fa pagare né medicine né visite a chi non può. In agosto si fa venti giorni di prigione per adunata sediziosa e, dopo l’armistizio, si rifugia sui monti coi compagni a capo di un manipolo che arriverà presto a contare una cinquantina di uomini.
Tra loro c’è Giacomo Sibilla detto Ivan, operaio che ha fatto la campagna di Russia e porta una chitarra a tracolla accanto al mitra. È lui che la sera, nei casolari diroccati, strimpella questa Katiuscia, la celebre melodia popolare russa. Il testo del poeta Isakovskij parlerebbe di meli e peri in fiori, ma già i soldati italiani nella steppa l’avevano storpiato con riferimenti al vento e alle loro scarpe di cartone. Si tratta di metterla giù meglio, per quest’altra battaglia. Ci pensa u Megu.
Le camicie nere stanano e giustiziano Felice il 27 gennaio 1944, lasciandone il corpo su un pendio. «Ma non fu vano il tuo sangue, Cascione, primo, più generoso e più valoroso di tutti i partigiani. Il tuo nome è leggendario» scriverà, un anno dopo, su La voce della democrazia, un altro giovane partigiano noto come Santiago. La sua firma è Italo Calvino.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE ---Nome di battaglia «Santiago» - ll giovane Calvino partigiano nei racconti di alcuni compagni11 dicembre 2013, di Federico La Sala
 Nome di battaglia «Santiago»
Nome di battaglia «Santiago»
 ll giovane Calvino partigiano nei racconti di alcuni compagni
ll giovane Calvino partigiano nei racconti di alcuni compagni
 Dall’archivio dell’Anpi spuntano documenti che ricostruiscono il periodo della montagna e della Resistenza
Dall’archivio dell’Anpi spuntano documenti che ricostruiscono il periodo della montagna e della Resistenza di Wladimiro Settimelli (l’Unità, 11.12.2013)
di Wladimiro Settimelli (l’Unità, 11.12.2013)E UN BEL GIORNO ITALO POSÒ LA PENNA E PRESE IL FUCILE. PER ANDARE IN MONTAGNA CON I PARTIGIANI E FARE LA COSA CHE RITENEVA GIUSTA. Lui, Calvino, ha sempre parlato poco di questa durissima esperienza perché odiava la retorica e soprattutto la retorica della Resistenza, in un periodo in cui tutti raccontavano di averla fatta e spiegavano, centellinavano dettagli e storie, spesso messe insieme subito dopo la Liberazione.
Il grande scrittore era orgoglioso di quei giorni e dei suoi compagni di lotta. Con molti era rimasto in contatto fino alla fine della vita. Con uno in particolare: Giovanni Nicosia, “Sam” originario di Caltanissetta, un severo caposquadra sui monti, che diventerà poi correttore di bozze per la Einaudi e dunque vicinissimo ad Italo nel lavoro quotidiano.
Sì, appunto, Italo Calvino in qualche articolo e in qualcuno dei suoi libri, farà affiorare il periodo resistenziale, ma senza dettagli e particolari, in modo schivo e quasi sottovoce e il perché lo abbiamo detto.
Ero all’ospedale della Scala, di Siena, il giorno della morte dello scrittore. Per il giornale, ovviamente. La bara era stata sistemata in uno stanzone enorme e non c’era nessuno. Era uno stanzone carico di affreschi, stemmi e orpelli quasi gioiosi, che rendevano ancora più desolata e solitaria quella bara e quella morte. Stavo ascoltando, in una stanzetta, alcuni colleghi che chiedevano notizie alla moglie di Calvino sul periodo della montagna, ma anche lei sapeva pochissimo. Qualche passo più in là, forse un avvocato o uno dei dirigenti della Einaudi, già parlava dei diritti d’autore per i tanti libri dello scrittore di fama mondiale, ma io sentivo quelle parole come una specie d’insulto a Calvino, abbandonato, solo, nello stanzone rinascimentale senza un fiore, una corona, una rosa. Ovviamente, sciocchi sentimentalismi i miei, in quel momento. Ma non riuscivo, comunque, a metter via i pensieri, angosciosi, che mi si affollavano in testa.
Del periodo della montagna e della Resistenza, invece, volli sapere tutto e non seppi niente. Ho dovuto aspettare qualche anno e leggere e rileggere i racconti di alcuni dei compagni di Calvino pubblicati da Patria indipendente, la rivista dei partigiani, per sapere dettagli e particolari.
Italo Calvino era nato a Santiago de Las Vegas (Cuba) il 15 ottobre 1923 da Mario Calvino e da Eva Mameli. La famiglia, ad un certo momento, era tornata in Italia e si era stabilita a Sanremo. Con la guerra, la tragedia incombeva.
Ed eccola la storia di lui. Calvino è un giovane sveglio, già entrato in contatto con alcuni antifascisti. Poi arriva l’8 settembre del 1943 e il colonnello Lodovig, che comanda il 178° fanteria tedesca con sede a Savona, scatta all’attacco con i suoi e occupa Sanremo il 9 settembre. L’esercito italiano, anche in tutta la Liguria, si è ormai dissolto.
Nasce la repubblichina di Salò e subito vengono affissi i manifesti per il richiamo alle armi della classe 1923: proprio quella di Calvino. Per i disertori, come si sa, è prevista la fucilazione.
Il giovane, per non essere arrestato, prende la via delle colline e si rifugia in boschi e boschetti, nelle terre di proprietà del padre. Poi, con un gruppo di amici, Aldo Baggioli, Massimo Porre, Renzo Barbieri e altri, decide di salire in montagna. Viene accolto nella formazione partigiana «Brigata Alpina» presso Beulla.
È una brigata, la sua, che si muove tra Baiardo e Ceriana ed è comandata da Candido Bertassi, conosciuto come Capitano Umberto. È una prima esperienza molto, molto difficile. Calvino è ormai conosciuto da tutti con il nome di battaglia di «Santiago». Il primo grande scontro con i nazisti avviene in località Carpenosa il 15 giugno 1944 ed è una vittoria. Poi la formazione si scioglie. Lo scrittore entra allora a far parte della «IX Brigata Garibaldi», comandata da Bruno Luppi, «Erven» e partecipa alla battaglia di Sella Carpe. «Erven» rimane ferito gravemente e molti partigiani ci lasciano la pelle. A luglio, i nazisti incendiano i paesi di Molini di Triora e Triora e lo scontro, in tutta la zona, si fa ancora più duro. Calvino, intanto, è passato alla Divisione d’assalto Garibaldi «Felice Cascione» e partecipa alla difesa di Baiardo. Durante un rastrellamento «Santiago» viene arrestato, ma si salva. Deve però arruolarsi, per un breve periodo, tra i repubblichini come scritturale.
Poco dopo riesce a fuggire e torna in montagna con tanto di armamento individuale. A lui si unisce il fratello Floriano che ha appena sedici anni. Ora, i fratelli, sono in una formazione diversa. L’inverno del 1944-’45 è terribile: freddo, gelo, fame, rastrellamenti, arresti e torture.
Italo Calvino partecipa a tantissimi scontri: a Ciabaudo, a Gerbonte, a Bregalla e ancora a Baiardo a Triora e nella Valle Argentina. Il 25 aprile arriva la Liberazione e anche lui sfila per le strade di Sanremo con la sua formazione. Durante la lotta in montagna non ha mai smesso di scrivere per Il Garibaldino, La nostra lotta e l’Unità, stampata localmente. Il 25 maggio 1945 torna a casa e si laurea. Poi, si iscrive al Pci che rimarrà il suo partito per una decina di anni. Riceve anche il diploma Alexander numero 165545 ed e riconosciuto partigiano combattente. Poco dopo, dal Distretto militare di Savona, riceverà lire 6.687: è la paga da soldato per tutto il tempo della montagna.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE --- Novanta anni fa. A scuola da Calvino Lo scrittore nasceva il 15 ottobre del 1923 Numerose le iniziative che oggi lo ricordano.15 ottobre 2013, di Federico La Sala
 Novanta anni fa. A scuola da Calvino
Novanta anni fa. A scuola da Calvino
 Lo scrittore nasceva il 15 ottobre del 1923
Lo scrittore nasceva il 15 ottobre del 1923
 Numerose le iniziative che oggi lo ricordano.
Numerose le iniziative che oggi lo ricordano.
 Autore di tanti libri straordinari sapeva sempre indicare una possibilità
di narrare, senza mai essere banale.
Autore di tanti libri straordinari sapeva sempre indicare una possibilità
di narrare, senza mai essere banale.
 Ed era molto curioso
Ed era molto curiosodi Sandra Petrignani ( l’Unità, 15.10.2013)
LA GENERAZIONE DI SCRITTORI CHE HA ESORDITO NEGLI ANNI 80, QUELLI CHE ERANO GIOVANI O «NUOVI» IN QUEL PERIODO, NUTRIVA PER ITALO CALVINO UN RISPETTO E UN’AMMIRAZIONE MOLTO DIVERSA DAL CULTO O IDOLATRIA che suscitavano Pier Paolo Pasolini e Elsa Morante. È questa la ragione per cui Calvino ha fatto scuola, mentre gli altri no, chiusi nell’aura eccezionalità delle loro vite e dei loro estremismi biografici. Era una generazione, la nostra, presa fra due fuochi: quello della decretata fine dell’arte e quello della sempre più invadente società dei consumi che aveva trasformato in consumo anche la letteratura. Calvino, come e più di Giorgio Manganelli perché meno nevrotico e ricercato, indicava una strada percorribile, una possibilità di narrare cercandosi un pubblico senza cadere nella banalizzazione di stilemi usurati. Non si poteva più scrivere una frase come «la signora uscì alle cinque» d’accordo, ma si poteva ancora indagare la complessità combinatoria delle storie conquistando il lettore, utilizzando vecchi trucchi come la suspense, ingabbiandolo in una trama affascinante.
E poi Calvino aveva, nell’asfittica società letteraria italiana, dimensione internazionale quale solo Alberto Moravia si era guadagnato già giovanissimo e ancora continuava ad avere. Calvino viveva più a Parigi che in Italia, era stato partigiano, non si sottraeva alle grandi polemiche degli anni 50-60 sui rapporti fra letteratura e politica, era stato fra i pochissimi, dopo i fatti d’Ungheria nel ’56, a uscire dal Pci con una lettera clamorosa, sfidando le ire e gli sfottò di Togliatti, e la conseguente emarginazione che ne sarebbe potuta derivare. Certo aveva alle spalle la forza di una casa editrice leggendaria e culturalmente potentissima, l’Einaudi, di cui era una colonna, ma il prestigio di scrittore e polemista che si era conquistato era solo suo, ottenuto sul campo.
A Parigi, con Elio Vittorini, aveva frequentato il cosiddetto «gruppo di rue Saint-Benoît», che raccoglieva a casa di Marguerite Duras e Robert Antelme le menti internazionali più lucide e coraggiose in materia di opposizione alla politica culturale sovietica che si riverberava sui vari partiti europei e che pretendeva per capirci di liquidare Gide, considerato di destra, come «pederasta», criticandone il Nobel. Tutti poi fuoriusciti o cacciati dal partito con ignominia (la Duras fu radiata perché di «costumi immorali», insomma scopava troppo!) ma tutti o quasi rimasero convintamente marxisti, al pari degli eretici Sartre e de Beauvoir. Oggi si userebbe l’orrenda definizione «diversamente marxisti».
Anche Calvino rimase di sinistra, nel suo modo elegante e superiore, e continuando a frequentare circoli culturali francesi, come l’Oulipo, che gli dava l’occasione di sperimentare con la narrativa (e di divertirsi) pur continuando a comunicare con un pubblico sempre più vasto e non necessariamente d’élite attraverso racconti e romanzi sempre sorprendenti, intelligenti, appassionanti.
La contestazione sessantottesca (la parte acculturata di quella temperie) l’aveva scelto non estranea la sua posizione critica verso il Pci come scrittore prediletto per la sua lucidità geometrica, la sua ironia cifra dei tempi quanto altri preferivano l’adesione viscerale al Movimento della passionale Morante. Pasolini si era messo contro e attaccò anche l’ex amico Calvino per certe simpatie, che giudicava ipocrite, verso gli studenti in rivolta. Anche se poi di simpatie, veramente, Calvino ne aveva pochissime e certamente i sessantottini dovevano apparirgli troppo ignoranti per riconoscersi loro compagno di strada. Forse gli piaceva tutto ciò che si muoveva di nuovo nel mondo e nella vita culturale, salvo ritrarsi subito deluso il più delle volte, e quanto al ’68 a Pasolini rispose così: «Verso le nuove politiche le riserve e le allergie da mia parte sono più forti delle spinta a contrastare le vecchie politiche».
Pesava sulla sua figura umana un fare antipatico e sprezzante, che era soprattutto timidezza, profondamente smentito poi dalla forte carnalità di tanti suoi libri. La Trilogia innanzitutto, ma non solo. Come avrebbe potuto una personalità davvero fredda riscrivere con tanta forza e calore le meravigliose fiabe italiane? La curiosità non è mai fredda, e Calvino era una persona, uno scrittore curioso. Hanno avuto una grande fortuna postuma le celebrate (ma incompiute) Lezioni americane, particolarmente utili nella loro schematicità persino facile a contrapporre il lucido, coerentissimo Calvino al tanto più contraddittorio e dunque umano Pasolini. Una contrapposizione che, come tutto ciò che appoggia su preconcetti manichei, fa solo male alla giusta comprensione delle cose.
Per evitare simili approssimazioni inviterei a leggere non solo tutta la produzione narrativa del grandissimo Italo, ma altrettanto attentamente quella saggistica. I tesori che si trovano nei godibilissimi scritti di Una pietra sopra o di Collezione di sabbia aprono scenari infiniti (ben più fecondi delle incompiute e francamente deludenti lezioncine americane) sul mondo com’è e sul mondo immaginario in una vivacissima coabitazione di realismo e visionarietà, sanità mentale e follia. Raramente l’enciclopedismo di un autore ha saputo parlare con tanta fantasiosa emozione, leggerezza, esattezza ai cuori alla deriva di naufraghi lettori.
A ROMA Mostre e incontri per il suo «compleanno»
Sono tante le iniziative che celebrano il novantesimo «compleanno» di Italo Calvino. Alla Biblioteca nazionale di Roma il 25 ottobre si apre la mostra «I libri degli altri. Il lavoro editoriale di Calvino», che racconta il ruolo di critico militante. Oggi alle 18,30 a Roma, presso Casa delle Letterature, si inaugura la mostra «Caro Calvino. Immagini e parole per i novant’anni di uno scrittore», con opere di giovani artisti e illustratori ispirate a Calvino e raccolte in un numero speciale della rivista «Orlando Esplorazioni».
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE ---- DOVE VOLA L’AVVOLTOIO? (di Italo Calvino).12 ottobre 2011
ITALO CALVINO
DOVE VOLA L’AVVOLTOIO?
Un giorno nel mondo finita fu l’ultima guerra,
il cupo cannone si tacque e piu’ non sparo’
e, privo del tristo suo cibo, dall’arida terra
un branco di neri avvoltoi si levo’.
 Dove vola l’avvoltoio?
Dove vola l’avvoltoio?Avvoltoio vola via,
vola via dalla terra mia,
che e’ la terra dell’amor.
L’avvoltoio ando’ dal fiume
ed il fiume disse: "No,
avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via:
nella limpida corrente
ora scendon carpe e trote,
non piu’ i corpi dei soldati
che la fanno insanguinar".
 Dove vola l’avvoltoio...
Dove vola l’avvoltoio...L’avvoltoio ando’ dal bosco
ed il bosco disse: "No
avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via:
tra le foglie, in mezzo ai rami
passan sol raggi di sole,
gli scoiattoli e le rane,
non piu’ i colpi del fucil".
 Dove vola l’avvoltoio...
Dove vola l’avvoltoio...L’avvoltoio ando’ dall’eco,
anche l’eco disse "No
avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via:
sono canti che io porto,
sono i tonfi delle zappe,
girotondi e ninne nanne,
non piu’ il rombo del cannon".
 Dove vola l’avvoltoio...
Dove vola l’avvoltoio...L’avvoltoio ando’ ai tedeschi
e i tedeschi disser: "No,
avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via:
non vogliam mangiar piu’ fango,
odio e piombo nelle guerre,
pane e case in terra altrui
non vogliamo piu’ rubar".
 Dove vola l’avvoltoio...
Dove vola l’avvoltoio...L’avvoltoio ando’ alla madre
e la madre disse: "No,
avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via:
i miei figli li do’ solo
a una bella fidanzata
che li porti nel suo letto,
non li mando piu’ a ammazzar".
 Dove vola l’avvoltoio...
Dove vola l’avvoltoio...L’avvoltoio ando’ all’uranio
e l’uranio disse: "No,
avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via:
la mia forza nucleare
fara’ andare sulla Luna,
non deflagrera’ infuocata
distruggendo le citta’".
 Dove vola l’avvoltoio...
Dove vola l’avvoltoio...Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto
in un luogo deserto a complotto si raduno’
e vide nel cielo arrivare girando quel branco
e scendere scendere, finche’ qualcuno grido’:
 Dove vola l’avvoltoio?
Dove vola l’avvoltoio?avvoltoio, vola via,
vola via dalla testa mia...
ma il rapace li sbrano’.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- L’URLO DI GRAMSCI DEL 1924. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà.12 aprile 2011, di Federico La Sala
 INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
 ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo".
ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo".
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- UN’INCHIESTA SULL’INCHIESTA. L’URLO DI FURIO COLOMBO (1993-2011).26 giugno 2011, di Federico La Sala
Un’inchiesta sull’inchiesta
Perché uomini di governo vanno da Bisignani a ricevere istruzioni? Perché sono disorientati o perché il vero potere è altrove? L’opposizione dovrebbe saper rispondere a questa domanda
di Furio Colombo (il Fatto, 26.06.2011)
“Perché uno come Gianni Letta, che ha un ruolo rilevante, direi eccezionale, nel governo del Paese e nelle relazioni istituzionali, deve sapere da Bisignani se nei suoi confronti ci sono o no indagini giudiziarie ? Perché ministri in carica vanno nell’ufficio di Bisignani a chiedere consigli, a ricevere istruzioni e segnalazioni per incarichi pubblici?". Sto citando da un articolo di Emanuele Macaluso (Il Riformista, 22 giugno) perché la sequenza di domande da lui proposta ci porta nell’occhio del tifone. Stiamo assistendo a un muoversi frenetico di personaggi influenti sotto e sopra la linea di galleggiamento delle principali istituzioni, un andare e venire poco chiaro e poco spiegabile fra il sottofondo della Repubblica e gli apparenti titolari del potere.
TUTTI I PEZZI del gioco, qualunque sia il gioco, sono in movimento, si spostano o vengono spostati, si espongono o vengono spinti ad esporsi, ascoltano, non si capisce da chi e si confidano, non si capisce con chi. Qui mi discosto dalle conclusioni di Macaluso che dice, accantonando le sue stesse domande: "Ci sono sempre stati dei Bisignani, perché lo Stato è debole". È vero, ma ciò che sta accadendo è molto di più. Si è scoperto che, nelle vene della politica, è in circolazione un batterio misterioso che ha più forza del potere, nel senso che fa apparire l’intera collezione delle persone di potere come ombre a cui si può sempre cambiare (o far cambiare) posizione, dislocazione, funzione, decisione.
È possibile che Bisignani sia l’artefice di tanta autorità operativa, che sia il punto da cui emanano ordini e comando, secondo un disegno del dinamico ex giornalista che ha abilmente messo le mani su leve che altri, pur vicini al potere, non avevano notato? Poiché so, fin da ora, che il percorso giudiziario, per quanto accurato e meticoloso, ci dirà molto sul modo di operare (ed eventualmente di violare la legge) di Bisignani, ma poco o niente su “chi è Bisignani?” e “perché si va da Bisignani a chiedere istruzioni per esercitare il potere?”. Non resta che un altro percorso, un percorso narrativo .
Qui comincia il racconto, con la dovuta avvertenza che esso si basa sulla pura immaginazione del narratore e che non ha nulla a che fare con documenti e rivelazioni. Nel racconto, il vivace ex giornalista Bisignani viene così intensamente frequentato non perché abbia o rappresenti il potere, o partecipi al potere, o possa dare il giusto consiglio o mettere una buona parola.
Bisignani è un raccordo necessario. Chi deve saperlo sa che si passa attraverso di lui. Non come luogo di saggezza, di esperienza e di eventuale favore, ma come camera di consultazione, ascolto o confessione con un potere che conta.
Un potere o il potere? La domanda è romantica. Nessun potere è il potere. Ma certo la camera di ascolto e conversazione a cui si accede tramite Bisignani conta abbastanza perché il ministro Stefania Prestigiacomo "si rovini" facendosi intercettare al telefono di Bisignani. Quel rischio, forse, non è temuto davvero. Forse è un modo di mostrare il giusto comportamento. A chi? Poiché, come il lettore intuisce, il narratore non ha la risposta finale deve prendere tempo. In quel tempo dobbiamo inserire gli incontri, che non possono essere furtivi e le telefonate, che non possono essere ingenue, del sottosegretario Letta (foto) con l’agile Bisignani.
LETTA È UNA persona saggia, niente affatto impulsiva, capace di una attenzione ferrea e ininterrotta al filo dei suoi rapporti, molti dei quali, comprensibilmente, coperti da discrezione accurata. Non sembra, valutando il personaggio nell’insieme, che il rapporto con Bisignani sia stato un passo falso che interrompe in un punto la sequenza perfetta di ciò che si fa ma non si deve sapere. Sembra una necessità, o così la racconterei se scrivessi questo racconto. Voglio dire: questo tipo di potere terminale che sta al di là e al di sopra del potere fatto di figure e di simboli che potremmo chiamare (ma solo nel racconto) i prestanome, esige un certo rispetto delle forme. Ciò che è dovuto è dovuto. Rimane nell’ombra ciò che deve rimanere nell’ombra. Evidentemente la folla dei potenti-impotenti (nel senso che rappresentano molto e decidono poco) è bene che abbia costantemente la misura del proprio limite e si conformi senza impropri e sconsigliabili gesti di ridicola ribellione.
QUANDO POI entrano in scena personaggi dei Servizi segreti che, a nome e per conto del predetto Bisignani, si recano a conferire con il parlamentare che presiede la commissione di controllo sui Servizi segreti, il narratore si persuade, pur in assenza di evidenze documentali, di essere sulla strada giusta. C’è qualcosa che conta oltre la siepe, cose che noi cittadini non vediamo e non sappiamo, ma che evidentemente smuovono molto e cambiano molto, tanto che fanno correre di qua e di là dei generali appena entrati in possesso delle presunte chiavi della Repubblica.
Se ti è accaduto di avere visto alla Camera Silvio Berlusconi, il 22 giugno, esaltare se stesso, con un discorso identico al 1993, al 1994, al 2001, al 2008, e hai appena notato (e fatto notare in aula) che per lui i deputati della Lega non applaudono e, al momento dell’ovazione, nessuno di loro si alza in piedi per lui, una cosa sai e constati: Berlusconi non è e non ha il potere. E il trucco (persino nel senso cosmetico) non funziona più. “Perché Gianni Letta, che ha un ruolo rilevante, deve sapere da Bisignani...”, si domanda Macaluso nell’articolo che ho citato all’inizio. Ma Letta è Berlusconi. Dunque, fino a questo punto abbiamo un indizio prezioso per la versione narrativa che ho proposto. Continua Macaluso, che di politica ne ha vista tanta: “Perché ministri in carica vanno da Bisignani per ricevere istruzioni?”. Perché sono deboli e disorientati o perché il potere è altrove? Il narratore si ferma qui. Ma chi guida l’opposizione deve saper rispondere a questa domanda.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- Grazie, Capitano (di Aldo Grasso).18 gennaio 2012, di Federico La Sala
Grazie, Capitanodi Aldo Grasso *
Quando ci vuole ci vuole. Ci sono espressioni che, pur usurate dalla quotidianità, conservano una loro volgarità di fondo. Ma in circostanze come queste, quando l’intontito comandante della Concordia sembra non rendersi conto del disastro che ha combinato, assumono persino un che di nobile, quasi fossero l’ultima risorsa della disperazione.
La drammatica telefonata tra Francesco Schettino e il capitano di fregata Gregorio Maria De Falco della Capitaneria di porto di Livorno è forse il documento che meglio testimonia le due anime dell’Italia. Da una parte un uomo irrimediabilmente perso, un comandante codardo e fellone che rifugge alle sue responsabilità, di uomo e di ufficiale, e che si sta macchiando di un’onta incancellabile.
Dall’altra un uomo energico che capisce immediatamente la portata della tragedia e cerca di richiamare con voce alterata il vile ai suoi obblighi. In mezzo un mondo che affonda, con una forza metaforica persino insolente, con una ferita più grande di quello squarcio sulla fiancata.
Il capitano De Falco fosse stato sulla nave sarebbe sceso per ultimo, come vuole l’etica del mare. Al telefono non può che appellarsi al bene più prezioso ed esigente che possediamo: la responsabilità personale. Ogni volta che succede un dramma la colpa è sempre di un altro, persona o entità astratta non importa. Eppure la responsabilità personale - quell’insieme di competenza e di senso del dovere, di cura e di coscienza civica - dovrebbe essere condizione necessaria per ogni forma di comando, in terra come in mare. E invece le nostre miserie e le nostre fragilità ci indicano sempre una via di fuga, ben sapendo che il coraggio rende positivi anche i vizi e la viltà rende negative le virtù.
Quella frase «Vada a bordo, cazzo!» («Get on Board, Damn it!» così tradotta nei tg americani) è qualcosa di più di un grido di dolore, di un inno motivazionale, di un segnale di riscossa. Il naufragio è uno degli archetipi di ogni letteratura perché illustra i rischi dell’esistenza umana nel corso della «navigazione della vita». Esso rinvia agli atteggiamenti fondamentali che si assumono nei confronti del mondo: in favore della sicurezza o del rischio, dell’estraneità o del coinvolgimento negli eventi, del ruolo di chi sprofonda e di chi sta a guardare dalla terraferma.
Ma ci vuole un grido che scuota e ci infonda coraggio, che, ancora una volta, ci richiami alle nostre responsabilità. Ecco perché ieri su Twitter era l’hashtag più utilizzato, una sorta di mantra collettivo. Ecco perché vorremmo, in ogni occasione, per chi guida il Paese o per chi fa semplicemente il suo mestiere, ci fosse qualcuno come il capitano De Falco che ci richiamasse perentoriamente all’ordine. (Intanto, su Internet, c’è già chi vende la t-shirt con la frase. E qui torniamo all’Italia degli Schettino).
Vada a bordo, e quello non ci è andato (ora è a casa agli arresti domiciliari in attesa che la giustizia faccia il suo corso e che la coscienza gli ridesti il senso dell’onore). Due uomini, casualmente due marinai campani, due storie: l’una che ci umilia, l’altra che tenta di riscattarci. Grazie capitano De Falco, il nostro Paese ha estremo bisogno di gente come lei.
Aldo Grasso
* Corriere della Sera, 18 gennaio 2012
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- IL NAUFRAGIO DELLA CONCORDIA. Un naufragio dai molti padri (di Aldo Grasso - Incapaci inattivi e sciocchi zitti, un sogno).22 gennaio 2012, di Federico La Sala
 Incapaci inattivi e sciocchi zitti
Incapaci inattivi e sciocchi zitti
 un sogno che non si avvererà
un sogno che non si avvererà Si è dissolto il principio di autorità, non si sa più chi comandi
Si è dissolto il principio di autorità, non si sa più chi comandidi Aldo Grasso *
Prima che la tragedia si inabissi nella farsa, prima che la Concordia diventi un format per una soap, prima che la flottiglia degli opinionisti decida se mi-si-nota-di-più se parlo male di De Falco o se parlo bene di Schettino, prima che la retorica dell’antiretorica («lo Schettino che è in noi») ci stordisca, prima che la lapidazione faccia il suo corso... Ecco, un attimo prima cerchiamo di capire cosa rappresenta questo naufragio dai molti padri. Non basta l’Istat a fotografare l’Italia, a volte le sventure servono anche a emulsionare la lastra dell’anima di una nazione, a ridarci il coraggio di ricominciare.
Una cosa l’abbiamo capita. Da noi si è dissolto il principio di autorità, non si sa più chi comandi. E chi comanda non sa più comandare. Sulla Concordia, «nave senza nocchiere», è saltata tutta la catena di comando, da Genova all’Isola del Giglio. Schettino è il capro espiatorio, ma tutti sapevano, a terra e in mare.
Se una maestra sgrida un ragazzino, il giorno dopo i genitori protestano. Se bocci qualcuno, quello ricorre al Tar. La delegittimazione di chi ricopre un qualsiasi incarico è continua: il concetto di responsabilità personale è uno dei beni più preziosi che abbiamo perduto, tanto c’è sempre qualcuno che discolpa o giustifica. Alla lunga, non c’è da stupirsi se un comandante viene meno al suo principale compito, perché il suo ruolo ormai è completamente svuotato. Il dovere resta una sorta di rassegnazione endemica.
Forse l’enorme chiacchiericcio che sta sommergendo una seconda volta questo bateau ivre vacanziero serve solo a coprire il vero dramma: il naufragio della Concordia è stato quello della nostra mediocrità o incuranza. Se un regista mettesse assieme tutti i filmini che sono stati girati nel momento del disastro verrebbe fuori il Grande Fratello che ci manca: quello capace di scrutarci dentro.
Ci consoliamo con la grandiosa mobilitazione, con la solidarietà, con i gesti di eroismo che in queste occasioni, per fortuna, non mancano. Ma vedremo mai l’alba di un giorno in cui gli incapaci restano inattivi e gli sciocchi zitti? Già Longanesi diceva che in Italia «è meglio assumere un sottosegretario che una responsabilità».
Aldo Grasso
* Corriere della Sera, 22 gennaio 2012
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- LA CRISI ITALIANA E IL CAPITALISMO IN CRISI. All’origine del sisma c’è l’indebolimento della democrazia (Michele Ciliberto))24 gennaio 2012, di Federico La Sala
All’origine del sisma c’è l’indebolimento della democrazia
 Lo scacco del modello liberista getta luce sulle radici materiali della crisi
Lo scacco del modello liberista getta luce sulle radici materiali della crisi
 dei sistemi rappresentativi. Non se ne esce rivolgendosi ai buoni sentimenti
dei sistemi rappresentativi. Non se ne esce rivolgendosi ai buoni sentimentidi Michele Ciliberto (l’Unità, 24.01.2012)
È vero: nel dibattito politico italiano c’è un elemento di grave provincialismo. Non so se questo dipenda, come pensa Donald Sassoon, dalla fine del Pci che si muoveva in un orizzonte internazionale e abituava i suoi militanti a guardare a ciò che accadeva nel mondo. Non c’è però dubbio che ciò pesi profondamente sia nell’analisi della situazione attuale che nella individuazione di nuove prospettive strategiche.
Basta pensare al modo con cui è stato, in generale, interpretato il fenomeno berlusconiano: come un fatto tipicamente italiano, caratteristico del «populismo» nostrano o, addirittura, come una rinascita, in forme diverse, del fascismo. Mentre è stato la forma specifica assunta in Italia dalla egemonia, a livello europeo, della destre, e si è inserito in un generale processo di crisi e di degenerazione delle forme democratiche.
In questi giorni si è osservato che in Italia, «per governare non è più necessario essere “rappresentanti del popolo”, cioè passati attraverso il filtro del voto». È una tesi discutibile; ma se così fosse, sarebbe, precisamente, l’effetto diretto della crisi della democrazia che si è avuta in Italia negli ultimi due decenni. Non lo sottolineo della generica «crisi della politica» di cui oggi tanto si parla, a proposito e a sproposito; così come, in termini altrettanto generici, e spesso retorici, si parla della necessità di una sua «rigenerazione». Quasi si trattasse di una questione di buona volontà o di un impulso di carattere morale; e non invece di un problema strettamente materiale, che su questo piano deve essere affrontato.
La «crisi» del capitalismo liberista (o finanziario) di cui si parla finalmente in modo aperto getta luce sulle radici materiali della crisi attuale della democrazia e della politica democratica (e sulle stesse ragioni dell’avvento e della fine del berlusconismo), spingendo a guardare oltre i confini nazionali e ad afferrare l’“intero” in cui va situata la vicenda italiana, senza illudersi che essa possa essere risolta adeguandosi al «rigore» di Bruxelles o limitandosi ad avviare una politica certo importante di liberalizzazioni.
Oggi ed è questo il punto centrale c’è un indebolimento generale delle democrazie, una perdita di credibilità delle istituzioni democratiche che viene da molto lontano e che si manifesta anche nella tendenza sempre più diffusa a risolvere direttamente, cioè senza intermediazioni politiche o parlamentari, problemi sia personali che collettivi.
Ma questa crisi ha matrici materiali assai precise e concrete: nei Paesi dell’Ocse per citare un solo, e drammatico, esempio fatto da Sapelli ci sono 250 milioni di disoccupati, e di questi una buona parte sono destinati a restare disoccupati per sempre. Né si intravede, a livello europeo, una presa d’atto di questa situazione; mentre le società diventano, giorno per giorno, più disuguali, più divise, più lacerate e le democrazie perdono sempre più credito, come avviene quando gli individui, volenti o nolenti, sono sospinti nella difesa del cerchio ristretto del proprio interesse particolare.
In una crisi di questo tipo non serve rivolgersi ai buoni sentimenti o indossare i panni di Menenio Agrippa, appellandosi ai valori dell’«ordine sociale». La democrazia vive e si sviluppa se ha solide basi materiali; altrimenti entra in crisi, decade, può morire. Si è sviluppata e diffusa dal 1945 agli anni 70 del secolo corso perché era basata su un organico e conflittuale compromesso tra capitale e lavoro. Oggi è come sospesa per aria, senza fondamento materiale.
Se oggi il problema centrale è quello di «rimotivare» la democrazia, la prima cosa da fare è perciò lavorare per darle nuove basi materiali, ridefinendo i termini di un nuovo «compromesso». E per far ciò le forze riformatrici devono far sentire senza timore la loro voce scegliendo se necessario anche il terreno del conflitto. Fino a poco tempo fa era di moda dire che Marx era morto e sepolto; ora se ne ricomincia a fare il nome.
Certo, i rapporti fra capitale e lavoro oggi si pongono in forme del tutto inedite rispetto al XX secolo; ma come si vede anche dalla crisi attuale, il nesso fra democrazia e lavoro è centrale, strutturale: simul stabunt, simul cadent. È da qui che bisogna perciò ripartire ma ed è un punto altrettanto importante oltrepassando gli orizzonti tradizionali del movimento operaio e costruendo legami materiali, culturali, etici, politici di tipo nuovo che consentano all’Europa di imboccare strade originali, svolgendo il compito che le spetta nel millennio che si è aperto.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- CONRAD E FELLINI. La linea d’ombra del comando... in che condizioni è esercitato, come degenera in urlo, e perché degenera (di Barbara Spinelli))..25 gennaio 2012, di Federico La Sala
La linea d’ombra del comando
di BARBARA SPINELLI *
CI VIENE spesso dalle esperienze di mare, perché il mare ha baratri imprevisti e quindi ferree leggi, la sapienza del comando. Quest’arte ruvida, che in democrazia è sempre guardata con un po’ di diffidenza, quasi fosse arte legale ma non del tutto legittima. C’è diffidenza perché l’immaginario democratico è colmo di miraggi: là dove governa il popolo ognuno è idealmente padrone di sé, e fantastica di poter fare a meno del comando. Nella migliore delle ipotesi parliamo di responsabilità, che del comando è la logica conseguenza, in qualche modo l’ornamento. Ma la responsabilità è obbligo di ciascuno, governanti e governati. Il comandoha un ingrediente in più, un occhio in più: indispensabile. Ancora una volta dal mare, dunque, ci giunge in questi giorni un esempio di cosa sia questo mestiere che impaura ed è al contempo profondamente anelato: il mestiere di guidare gli uomini nelle situazioni-limite, quando tutto, salvezza o disastro, dipende da chi è al comando, sempre che qualcuno ci sia. L’esempio lo conosciamo ormai: ce l’ha dato Gregorio De Falco, capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno. Nella notte del 13 gennaio fu lui a intimare, al comandante Schettino, di tornare subito a bordo anziché cincischiare frasi sull’inaudita trasgressione appena commessa: l’abbandono del posto di comando sulla nave, prima del salvataggio di passeggeri e equipaggio. Un peccato imperdonabile in mare.
Difficile dimenticare il tono di quell’ingiunzione a rispettare le regole: incaponito, incorruttibile. Una voce analoga s’era udita a Capodanno, inattesa, quando le Guardie di finanza diedero la caccia agli evasori fiscali di Cortina, ricordando che la legge non solo esiste ma può essere applicata, per castigare chi vitupera lo Stato esattore e al tempo stesso ne profitta - le parole sono di Mario Monti - "mettendo le mani nelle tasche degli italiani onesti, che pagano le tasse". È come se da tempi immemorabili non avessimo ascoltato voci simili. Come se la chiamata che intima, stronca imperiosamente egoismi, tergiversazioni, fosse la cosa che più ci manca. Manca d’altronde non solo da noi ma anche fuori, in Europa, dove un marasma senza precedenti incancrenisce perché è assente, ai vertici dell’Unione, l’occhio in più che dia l’ordine di trasformare il coordinamento dei singoli soccorsi in salvataggio di tutti.
Ma in Italia la questione è incandescente, perché sono in tanti a reagire alla nuova severità dello Stato con la fuga o lo scompiglio. Non che sia mancata, per anni, la voce dei padroni. Ma non era intimazione, la loro: era intimidazione, al tempo stesso strillata e sterile. Abbiamo udito l’urlo di chi s’indigna e l’urlo di chi dall’alto dei propri scranni insulta, lancia ukase, grida menzogne per difendere gli interessi propri o dei propri clan. Per oltre un decennio abbiamo vissuto in mezzo a indistinte cacofonie: e vediamo in questi giorni, con le rivolte antistataliste che straripano, la potenza accumulata dalla cultura dell’urlo. L’intimazione stentorea di autorità emblematiche come il comandante di Livorno o le Guardie di finanza è di natura differente, ci sorprende come ladro di notte, come bisturi che ricuce ma resta pur sempre lama che offende. Abbiamo visto in de Falco un eroe ma non è un eroe. Il suo modo d’essere dovrebbe essere la normalità: è contro un muro di norme indiscusse che dovrebbero sbattere i battelli ebbri senza comando né legge che metaforicamente ci rappresentano. Che impazzano addosso alle coste per fare inchini a amici complici in irresponsabilità, e impunemente s’avvolgono nella propria incuria come in un manto.
Chi ha letto Joseph Conrad sa le grandezze e i segreti fardelli del comando. Quasi tutti i suoi romanzi ruotano attorno a questa vocazione, che mette alla prova e decide chi sei, se vali oppure no. Anche qui, niente di eroico. Ecco il protagonista di Tifone: "Il capitano MacWhirr, del piroscafo Nan-Shan, aveva, per quanto concerne l’aspetto esteriore, una fisionomia che rispecchiava fedelmente l’animo suo: non presentava alcuna distinta caratteristica di fermezza o di stupidità; non aveva caratteristiche pronunciate d’alcun tipo; era soltanto comune, insensibile e imperturbabile".
Il comando non è solo imperio della legge, rule of law. C’è un elemento aggiuntivo, che nasce dal carisma (la gravitas degli antichi latini) che il comandante possiede o non possiede. In democrazia è dura arte anche per questo, perché la gravitas ha qualcosa di aristocratico, di insensibile: la schiviamo, se possibile. Invece ce n’è bisogno, perché sempre possiamo incrociare una crisi, un’emergenza, ed è qui che servono le forze congiunte del comando, dell’imperio della legge e del carisma.
Torniamo ancora a Conrad, quando narra la nostra Linea d’ombra: d’un colpo scorgiamo innanzi a noi "una linea d’ombra che ci avverte che la regione della prima giovinezza, anch’essa, la dobbiamo lasciare addietro". Il protagonista del racconto affronta a quel punto la massima prova esistenziale: l’esercizio del comando. Alcuni soccombono: è il caso di Lord Jim, che tutta la vita pagherà il prezzo - in dolore, rimpianto, vita d’angoscia - del peccato originale commesso quando abbandonò la nave. La linea d’ombra, in Italia, è come se non la scorgessimo mai. C’è qualcosa di ostinatamente minorenne, nel nostro rapporto con l’autorità, la legge, lo Stato.
Stentiamo a capire una cosa, dell’ordine dato in nome del bene pubblico: il comando è quello che ci protegge dall’esplosione dell’urlo scomposto, dal caos propizio allo Stato d’eccezione. Fu con l’urlo che Hitler s’affacciò al mondo: la democrazia di Weimar non era stata capace di comando. Kurt Tucholsky, scrittore veggente, descrisse fin dal ’31 quel che nel futuro dittatore più spaventava: "Non l’uomo in sé, che non esiste. Ma il rumore, che egli scatena". Stentiamo a capire soprattutto in Italia, perché siamo da poco una nazione e ogni comune, ogni corporazione, usa urlare più che dirigere. Fellini descrisse questa cacofonia anarcoide - era il ’79, dilagava il terrorismo - nell’apologo Prova d’Orchestra. Il tema cruciale era il comando: in che condizioni è esercitato, come degenera in urlo, e perché degenera.
L’Italia benpensante accolse il film con enorme diffidenza, sospettò nell’autore buie propensioni fascistoidi. Fellini le aveva messo davanti uno specchio, perché contemplasse i suoi vizi, e gli italiani voltarono la faccia sdegnati. Il film non perse mai da noi un odore di zolfo che altrove non ebbe. "Tutto è prova d’orchestra", disse il regista. E sulla pellicola capimmo perché la prova falliva: ogni violinista, flautista, clarinettista, pensava agli affari suoi, alcuni addirittura erano armati e ciascuno aveva a fianco un sindacalista tutore.
Qualcosa di simile accade a Monti, assalito da proteste quando si sforza di ammansire l’ego di corporazioni, lobby, clan semimafiosi (le grandi mafie suppongo siano in attesa: non ancora toccate, fanno quadrato attorno ai propri referenti, ne cercano di nuovi, sfruttano alla meglio i malcontenti di chi si sente ferito dal bisturi). Nonostante questo clima di sbandamento il Premier resta popolare, nell’Italia smarrita e infine conscia della crisi. Lo aiutano le virtù del comando: la gravitas, il rispetto meticoloso delle istituzioni, l’autorevolezza che accresce l’autorità dandole sostanza. Lo aiuta la vocazione a tenere i conti, e a chieder conto. Non dimentichiamo la fine del film di Fellini: il direttore d’orchestra che non ha saputo comandare esplode in urla scomposte, mescolando vocaboli italiani e parole d’ordine naziste. "Estrema pazienza e estrema cura", questo il comando secondo Conrad: oltrepassata la linea d’ombra, sempre possiamo mancare la prova, sottrarci al dovere di portare la nave sana e salva in porto. Ecco perché la via di Monti è così stretta.
* la Repubblica, 25 gennaio 2012
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- Onestà nello Stato e nella Chiesa, a Montecitorio e in Vaticano, L’elogio dell’onestà di Küng premiato al «Nonino» (di Hans Küng)28 gennaio 2012, di Federico La Sala
L’elogio dell’onestà di Küng premiato al «Nonino»
di Hans Küng (l’Unità, 28 gennaio 2012)
Gli organizzatori mi hanno chiesto quale canto si debba intonare in questa solenne occasione. Ho pensato prima a un canto del tempo dei miei studi a Roma, per esempio «Lo sai che i papaveri son’ alti, alti, alti...» oppure «Funiculì, funiculà». Però ho scelto finalmente il coro composto da Giuseppe Verdi esattamente 170 anni fa, nel 1842: «Va, pensiero, sull’ali dorate». Non ho scelto, si capisce, il più popolare dei cori italiani per favorire un certo partito che desidera dividere l’Italia usandolo come «inno della Padania». Il suo autore, del resto, era il sostenitore più appassionato dell’unità nazionale: «O mia patria sì bella e perduta». Che cosa direbbe Verdi sulla sua patria di oggi? «O membranza sì cara e fatal»? Non si potrebbe pensare che lui che ha creato questo potente simbolo musicale per il Risorgimento «del tempo che fu» parlerebbe di un altro risorgimento, che conduca, come ci auguriamo, a un tempo migliore?
Con un Presidente del Consiglio serio, competente, onesto, con un governo di esperti, con un Parlamento dove gli onorevoli tornino a essere onorabili. L’inno di Verdi culmina nella strofa: «O t’ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù!». Verdi oggi probabilmente direbbe: «Che ne infonda all’agire virtù!».
E una virtù che si richiede oggi specialmente per questo risorgimento è l’onestà: onestà nello Stato e nella Chiesa, a Montecitorio e in Vaticano, nella politica e anche nell’economia. Onestà è il titolo che l’editore italiano ha scelto per il mio libro premiato dal Nonino: Onestà. Perché l’economia ha bisogno di un’etica. Questo premio è un vero incoraggiamento per tutti quelli che in Italia e nel mondo hanno una sete inestinguibile di onestà.
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- Onestà nello Stato e nella Chiesa. Küng critica la Chiesa «troppo tenera» con Berlusconi (di Marisa Fumagalli)29 gennaio 2012, di Federico La Sala
Küng critica la Chiesa «troppo tenera» con Berlusconi
di Marisa Fumagalli (Corriere della Sera, 29 gennaio 2012)
L a magia del Premio Nonino, che si ricrea ormai da 37 anni, sta nel tenere insieme, armonicamente, la civiltà della terra nelle varie espressioni, la cultura internazionale e i suoi massimi rappresentanti. Cominciando dal presidente della Giuria, V.S. Naipaul (Nobel per la Letteratura 2001), in degna compagnia di una squadra di alto livello.
Temi importanti percorrono le produzioni intellettuali (e non, come nel caso dei contadini degli «Orti di Gorizia», premio Risit d’Aur) dei vincitori. Ma può succedere - ed è successo ieri, durante la cerimonia dell’edizione 2012 - che, nella distilleria di Percoto (Udine), trasformata in teatro, irrompa la politica italiana con i suoi protagonisti, evocati in questo caso dal teologo svizzero Hans Küng. Gli è stato assegnato il Nonino 2012, per il saggio Onestà. Perché l’economia ha bisogno di un’etica (Rizzoli). Küng non è un tipo che le manda a dire: dopo essere stato consulente del Concilio Vaticano II (lo ha ricordato, presentandolo, il neuroscienziato Antonio R. Damasio), osò mettere in dubbio l’infallibilità del Papa.
Fatto sta che Küng, citando il «Va’ pensiero» di Verdi, si rivolge alla platea dicendo che «è possibile un nuovo Risorgimento italiano, con un presidente del Consiglio serio, competente, onesto. Con un governo di esperti e con un Parlamento dove gli onorevoli tornino ad essere "onorabili"». «Viva l’Italia», chiude. Poi precisa: «La Chiesa, per opportunismo, è stata condiscendente con l’ex premier Berlusconi e i suoi comportamenti. Ora, se Monti, uomo integro, andrà fino in fondo, conciliando economia ed etica, il vostro Paese uscirà dalla crisi». (...)
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- "QUEL CHE RIMPIANGO": LETTERA APERTA DI PIER PAOLO PASOLINI (1974).30 aprile 2023, di Federico La Sala
LETTERA APERTA DI PIER PAOLO PASOLINI A ITALO CALVINO (1974) *
"QUEL CHE RIMPIANGO"
Caro Calvino,
Maurizio Ferrara dice che io rimpiango un’«età dell’oro», tu dici che rimpiango l’«Italietta»: tutti dicono che rimpiango qualcosa, facendo di questo rimpianto un valore negativo e quindi un facile bersaglio. Ciò che io rimpiango (se si può parlare di rimpianto) l’ho detto chiaramente, sia pure in versi («Paese sera», 5-1-1974). Che degli altri abbiano fatto finta di non capire è naturale. Ma mi meraviglio che non abbia voluto capire tu (che non hai ragioni per farlo). Io rimpiangere l’«Italietta»? Ma allora tu non hai letto un solo verso delle Ceneri di Gramsci o di Calderón, non hai letto una sola riga dei miei romanzi, non hai visto una sola inquadratura dei miei films, non sai niente di me! Perché tutto ciò che io ho fatto e sono, esclude per sua natura che io possa rimpiangere l’Italietta. A meno che tu non mi consideri radicalmente cambiato: cosa che fa parte della psicologia miracolistica degli italiani, ma che appunto per questo non mi par degna di te.
L’«Italietta» è piccolo-borghese, fascista, democristiana; è provinciale e ai margini della storia; la sua cultura è un umanesimo scolastico formale e volgare. Vuoi che rimpianga tutto questo? Per quel che mi riguarda personalmente, questa Italietta è stata un paese di gendarmi che mi ha arrestato, processato, perseguitato, tormentato, linciato per quasi due decenni. Questo un giovane può non saperlo. Ma tu no. Può darsi che io abbia avuto quel minimo di dignità che mi ha permesso di nascondere l’angoscia di chi per anni e anni si attendeva ogni giorno l’arrivo di una citazione del tribunale e aveva terrore di guardare nelle edicole per non leggere nei giornali atroci notizie scandalose sulla sua persona. Ma se tutto questo posso dimenticarlo io, non devi però dimenticarlo tu...
D’altra parte questa «Italietta», per quel che mi riguarda, non è finita. Il linciaggio continua. Magari adesso a organizzarlo sarà l’«Espresso», vedi la noterella introduttiva («Espresso», 23-6-1974) ad alcuni interventi sulla mia tesi («Corriere della Sera», 10-6-1974): noterella in cui si ghigna per un titolo non dato da me, si estrapola lepidamente dal mio testo, naturalmente travisandolo orrendamente, e infine si getta su me il sospetto che io sia una specie di nuovo Plebe: operazione di cui finora avrei creduto capaci solo i teppisti del «Borghese».
Io so bene, caro Calvino, come si svolge la vita di un intellettuale. Lo so perché, in parte, è anche la mia vita. Letture, solitudini al laboratorio, cerchie in genere di pochi amici e molti conoscenti, tutti intellettuali e borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente perbene. Ma io, come il dottor Hyde, ho un’altra vita. Nel vivere questa vita, devo rompere le barriere naturali (e innocenti) di classe. Sfondare le pareti dell’Italietta, e sospingermi quindi in un altro mondo: il mondo contadino, il mondo sottoproletario e il mondo operaio. L’ordine in cui elenco questi mondi riguarda l’importanza della mia esperienza personale, non la loro importanza oggettiva. Fino a pochi anni fa questo era il mondo preborghese, il mondo della classe dominata. Era solo per mere ragioni nazionali, o, meglio, statali, che esso faceva parte del territorio dell’Italietta. Al di fuori di questa pura e semplice formalità, tale mondo non coincideva affatto con l’Italia. L’universo contadino (cui appartengono le culture sottoproletarie urbane, e, appunto fino a pochi anni fa, quelle delle minoranze operaie - ché erano vere e proprie minoranze, come in Russia nel ’17) è un universo transnazionale: che addirittura non riconosce le nazioni. Esso è l’avanzo di una civiltà precedente (o di un cumulo di civiltà precedenti tutte molto analoghe fra loro), e la classe dominante (nazionalista) modellava tale avanzo secondo i propri interessi e i propri fini politici (per un lucano - penso a De Martino - la nazione a lui estranea, è stato prima il Regno Borbonico, poi l’Italia piemontese, poi l’Italia fascista, poi l’Italia attuale: senza soluzione di continuità).
È questo illimitato mondo contadino prenazionale e preindustriale, sopravvissuto fino a solo pochi anni fa, che io rimpiango (non per nulla dimoro il più a lungo possibile, nei paesi del Terzo Mondo, dove esso sopravvive ancora, benché il Terzo Mondo stia anch’esso entrando nell’orbita del cosiddetto Sviluppo).
Gli uomini di questo universo non vivevano un’età dell’oro, come non erano coinvolti, se non formalmente con l’Italietta. Essi vivevano quella che Chilanti ha chiamato l’età del pane. Erano cioè consumatori di beni estremamente necessari. Ed era questo, forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita (tanto per essere estremamente elementari, e concludere con questo argomento).
Che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino, resta comunque affar mio. Ciò non mi impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale così com’è la mia critica: anzi, tanto più lucidamente quanto più ne sono staccato, e quanto più accetto solo stoicamente di viverci.
Ho detto, e lo ripeto, che l’acculturazione del Centro consumistico, ha distrutto le varie culture del Terzo Mondo (parlo ancora su scala mondiale, e mi riferisco dunque appunto anche alle culture del Terzo Mondo, cui le culture contadine italiane sono profondamente analoghe): il modello culturale offerto agli italiani (e a tutti gli uomini del globo, del resto) è unico. La conformazione a tale modello si ha prima di tutto nel vissuto, nell’esistenziale: e quindi nel corpo e nel comportamento. È qui che si vivono i valori, non ancora espressi, della nuova cultura della civiltà dei consumi, cioè del nuovo e del più repressivo totalitarismo che si sia mai visto. Dal punto di vista del linguaggio verbale, si ha la riduzione di tutta la lingua a lingua comunicativa, con un enorme impoverimento dell’espressività. I dialetti (gli idiomi materni!) sono allontanati nel tempo e nello spazio: i figli sono costretti a non parlarli più perché vivono a Torino, a Milano o in Germania. Là dove si parlano ancora, essi hanno totalmente perso ogni loro potenzialità inventiva. Nessun ragazzo delle borgate romane sarebbe più in grado, per esempio, di capire il gergo dei miei romanzi di dieci-quindici anni fa: e, ironia della sorte!, sarebbe costretto a consultare l’annesso glossario come un buon borghese del Nord!
Naturalmente questa mia «visione» della nuova realtà culturale italiana è radicale: riguarda il fenomeno come fenomeno globale, non le sue eccezioni, le sue resistenze, le sue sopravvivenze.
Quando parlo di omologazione di tutti i giovani, per cui, dal suo corpo, dal suo comportamento e dalla sua ideologia inconscia e reale (l’edonismo consumistico) un giovane fascista non può essere distinto da tutti gli altri giovani, enuncio un fenomeno generale. So benissimo che ci sono dei giovani che si distinguono. Ma si tratta di giovani appartenenti alla nostra stessa élite, e condannati a essere ancora più infelici di noi: e quindi probabilmente anche migliori. Questo lo dico per una allusione («Paese sera», 21-6-1974) di Tullio De Mauro, che, dopo essersi dimenticato di invitarmi a un convegno linguistico di Bressanone, mi rimprovera di non esservi stato presente: là, egli dice, avrei visto alcune decine di giovani che avrebbero contraddetto le mie tesi. Cioè come a dire che se alcune decine di giovani usano il termine «euristica» ciò significa che l’uso di tale termine è praticato da cinquanta milioni di italiani.
Tu dirai: gli uomini sono sempre stati conformisti (tutti uguali uno all’altro) e ci sono sempre state delle élites. Io ti rispondo: sì, gli uomini sono sempre stati conformisti e il più possibile uguali l’uno all’altro, ma secondo la loro classe sociale. E, all’interno di tale distinzione di classe, secondo le loro particolari e concrete condizioni culturali (regionali). Oggi invece (e qui cade la «mutazione» antropologica) gli uomini sono conformisti e tutti uguali uno all’altro secondo un codice interclassista (studente uguale operaio, operaio del Nord uguale operaio del Sud): almeno potenzialmente, nell’ansiosa volontà di uniformarsi.
Infine, caro Calvino, vorrei farti notare una cosa. Non da moralista, ma da analista. Nella tua affrettata risposta alle mie tesi, sul «Messaggero», (18 giugno 1974) ti è scappata una frase doppiamente infelice. Si tratta della frase: «I giovani fascisti di oggi non li conosco e spero di non aver occasione di conoscerli.» Ma: 1) certamente non avrai mai tale occasione, anche perché se nello scompartimento di un treno, nella coda a un negozio, per strada, in un salotto, tu dovessi incontrare dei giovani fascisti, non li riconosceresti; 2) augurarsi di non incontrare mai dei giovani fascisti è una bestemmia, perché, al contrario, noi dovremmo far di tutto per individuarli e per incontrarli. Essi non sono i fatali e predestinati rappresentanti del Male: non sono nati per essere fascisti. Nessuno - quando sono diventati adolescenti e sono stati in grado di scegliere, secondo chissà quali ragioni e necessità - ha posto loro razzisticamente il marchio di fascisti. È una atroce forma di disperazione e nevrosi che spinge un giovane a una simile scelta; e forse sarebbe bastata una sola piccola diversa esperienza nella sua vita, un solo semplice incontro, perché il suo destino fosse diverso.
8 luglio 1974
* Fonte: Nicola Fanizza (Facebook, 30.04.2023)
NOTA:
"ESSERE, O NON ESSERE?" (AMLETO): OMAGGIO A LUTERO, A CALVINO, A SHAKESPEARE, E A GIAMBATTISTAVICO (E A MARX). Leggere e ri-leggere con attenzione: nella Lettera di PPP (del 1974)non è strano che non ci sia una parola su Carlo Levi e che non si faccia alcun riferimento alla storica egemonia di tutte le storicistiche egemonie, quella del cattolicesimo della "famosa" donazione di Costantino (Lorenzo Valla, 1440)?
 Questo meta-orizzonte epocale e storico (religioso e laico) viene colto per lo più e solo da Carlo Levi (che ora e qui Pasolini non cita). Per dirla velocemente, egli fa di tutte le erbe della sinistra un fascio e non riesce a comprendere che il riflesso del suo "penso a De Martino" (come scrive in una parentesi), che suona quasi come un "penso a Pasolini": a ben leggere la Lettera, non c’è una parola che faccia riferimento al paolinismo della cultura atea e devota.
Questo meta-orizzonte epocale e storico (religioso e laico) viene colto per lo più e solo da Carlo Levi (che ora e qui Pasolini non cita). Per dirla velocemente, egli fa di tutte le erbe della sinistra un fascio e non riesce a comprendere che il riflesso del suo "penso a De Martino" (come scrive in una parentesi), che suona quasi come un "penso a Pasolini": a ben leggere la Lettera, non c’è una parola che faccia riferimento al paolinismo della cultura atea e devota.Federico La Sala
Sul tema, nel sito, si cfr.: L’URLO DI PIER PAOLO PASOLINI (1974). PER L’ITALIA E LA COSTITUZIONE
-
> L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). ---- LA GRAN BONACCIA DELLE ANTILLE (di Italo Calvino, 1957).20 dicembre 2024, di Federico La Sala
ITALO CALVINO
La gran bonaccia delle Antille [1957] *
- "[...] Una fantasiosa parabola marinara, ambientata nel Millecinquecento, che pare descrivere l’immobilismo in cui si trovava il PCI, per la responsabilità del suo gruppo dirigente, in particolare del segretario Palmiro Togliatti, nel racconto "il capitano", incapace di liberarsi dallo stalinismo. Il narratore, zio Donald (Calvino), un vecchio lupo di mare, racconta la storia della nave corsara (il PCI) sulla quale ha navigato che, a causa di una improvvisa bonaccia, rimane ferma per diversi mesi di fronte ai galeoni dei Papisti (la DC). [...]"
Dovevate sentire mio zio Donald, che aveva navigato con l’ammiraglio Drake, quando attaccava a narrare una delle sue avventure.
- - Zio Donald, zio Donald! - gli gridavamo nelle orecchie, quando vedevamo il guizzo di uno sguardo affacciarsi tra le sue palpebre perennemente socchiuse, - raccontateci come andò quella volta della gran bonaccia delle Antille!
 Eh? Ah, bonaccia, sì, sì, la gran bonaccia... - cominciava lui, con voce fioca. - Eravamo al largo delle Antille, procedevamo a passo di lumaca, sul mare liscio come l’olio con tutte le vele spiegate per acchiappare qualche raro filo di vento. Ed ecco che ci troviamo a tiro di cannone da un galeone spagnolo. Il galeone stava fermo, noi ci fermiamo pure, e lì, in mezzo alla gran bonaccia, prendiamo a fronteggiarci. Non potevamo passare noi, non potevano passare loro. Ma loro, a dire il vero, non avevano nessuna intenzione di andare avanti: erano lì apposta per non lasciar passare noi. Noialtri invece, flotta di Drake, avevamo fatto tanta strada non per altro che per non dar tregua alla flotta spagnola e togliere da quelle mani di papisti il tesoro della Grande Armada e consegnarlo in quelle di Sua Graziosa Maestà Britannica la Regina Elisabetta. Però ora, di fronte ai cannoni di quel galeone, con le nostre poche colubrine non potevamo reggere e così ci guardavamo bene dal far partire un colpo. Eh, sì, ragazzi, tali erano i rapporti di forza, voi capite. Quei dannati del galeone avevano provviste d’acqua, frutta delle Antille, rifornimenti facili dai loro porti, potevano stare lì quanto volevano: anche loro però si trattenevano dallo sparare, perché per gli ammiragli di Sua Maestà Cattolica quella guerricciuola con gli Inglesi così come stava andando era proprio quel che ci voleva, e se le cose si mettevano diversamente, per una battaglia navale vinta o persa, tutto l’equilibrio andava all’aria, certo ci sarebbero stati dei cambiamenti, e loro di cambiamenti non ne volevano. Così passavano i giorni, la bonaccia continuava, noi continuavamo a star di qua e loro di là, immobili a largo delle Antille...
Eh? Ah, bonaccia, sì, sì, la gran bonaccia... - cominciava lui, con voce fioca. - Eravamo al largo delle Antille, procedevamo a passo di lumaca, sul mare liscio come l’olio con tutte le vele spiegate per acchiappare qualche raro filo di vento. Ed ecco che ci troviamo a tiro di cannone da un galeone spagnolo. Il galeone stava fermo, noi ci fermiamo pure, e lì, in mezzo alla gran bonaccia, prendiamo a fronteggiarci. Non potevamo passare noi, non potevano passare loro. Ma loro, a dire il vero, non avevano nessuna intenzione di andare avanti: erano lì apposta per non lasciar passare noi. Noialtri invece, flotta di Drake, avevamo fatto tanta strada non per altro che per non dar tregua alla flotta spagnola e togliere da quelle mani di papisti il tesoro della Grande Armada e consegnarlo in quelle di Sua Graziosa Maestà Britannica la Regina Elisabetta. Però ora, di fronte ai cannoni di quel galeone, con le nostre poche colubrine non potevamo reggere e così ci guardavamo bene dal far partire un colpo. Eh, sì, ragazzi, tali erano i rapporti di forza, voi capite. Quei dannati del galeone avevano provviste d’acqua, frutta delle Antille, rifornimenti facili dai loro porti, potevano stare lì quanto volevano: anche loro però si trattenevano dallo sparare, perché per gli ammiragli di Sua Maestà Cattolica quella guerricciuola con gli Inglesi così come stava andando era proprio quel che ci voleva, e se le cose si mettevano diversamente, per una battaglia navale vinta o persa, tutto l’equilibrio andava all’aria, certo ci sarebbero stati dei cambiamenti, e loro di cambiamenti non ne volevano. Così passavano i giorni, la bonaccia continuava, noi continuavamo a star di qua e loro di là, immobili a largo delle Antille...- - E come andò a finire? Diteci, zio Donald! - facemmo noi, vedendo che il vecchio lupo di mare già piegava il mento sul petto e riprendeva a sonnecchiare.
 Ah? Sì, sì, la gran bonaccia! Settimane durò. Li vedevamo coi cannocchiali, quei rammolliti di papisti, quei marinai da burla, sotto gli ombrellini con le frange, il fazzoletto tra il cranio e la parrucca per detergere il sudore, che mangiavano gelati di ananasso. E noi che eravamo i più valenti marinai di tutti gli oceani, noi che avevamo per destino di conquistare alla Cristianità tutte le terre che vivevano nell’errore, noi ce ne dovevamo star lì con le mani in mano, pescando alla lenza dalle murate, masticando tabacco. Da mesi eravamo in rotta sull’Atlantico, le nostre scorte erano ridotte all’estremo e avariate, ogni giorno lo scorbuto si portava via qualcuno, che piombava in mare in un sacco mentre il nostromo borbottava in fretta due versetti della Bibbia. Di là, sul galeone, i nemici spiavano col cannocchiale ogni sacco che sprofondava in mare, e facevano segni con le dita come affaccendati a contare le nostre perdite. Noi inveivamo contro di loro: ce ne voleva prima di darci tutti morti, noialtri che eravamo passati attraverso tanti uragani, altro che quella bonaccia delle Antille...
Ah? Sì, sì, la gran bonaccia! Settimane durò. Li vedevamo coi cannocchiali, quei rammolliti di papisti, quei marinai da burla, sotto gli ombrellini con le frange, il fazzoletto tra il cranio e la parrucca per detergere il sudore, che mangiavano gelati di ananasso. E noi che eravamo i più valenti marinai di tutti gli oceani, noi che avevamo per destino di conquistare alla Cristianità tutte le terre che vivevano nell’errore, noi ce ne dovevamo star lì con le mani in mano, pescando alla lenza dalle murate, masticando tabacco. Da mesi eravamo in rotta sull’Atlantico, le nostre scorte erano ridotte all’estremo e avariate, ogni giorno lo scorbuto si portava via qualcuno, che piombava in mare in un sacco mentre il nostromo borbottava in fretta due versetti della Bibbia. Di là, sul galeone, i nemici spiavano col cannocchiale ogni sacco che sprofondava in mare, e facevano segni con le dita come affaccendati a contare le nostre perdite. Noi inveivamo contro di loro: ce ne voleva prima di darci tutti morti, noialtri che eravamo passati attraverso tanti uragani, altro che quella bonaccia delle Antille...- - Ma una via d’ uscita come la trovaste, zio Donald?
 Cosa dite? Via d’ uscita? Mah, ce lo domandavamo di continuo per tutti quei mesi che durò la bonaccia... Molti dei nostri, specie tra i più vecchi e i più tatuati, dicevano che noi eravamo sempre stati una nave da corsa, buona per azioni rapide, e ricordavano i tempi in cui le nostre colubrine sguarnivano delle alberature le più potenti navi spagnole, aprivano falle nelle murate, giostravano con brusche virate... Ma sì, nella marineria di corsa, certo eravamo stati bravi, ma allora c’era il vento, si andava svelto... Adesso, in quella gran bonaccia, questi discorsi di sparatorie e d’abbordaggi erano solo un modo di trastullarci aspettando chissacché; una levata di libeccio, un fortunale, addirittura un tifone... Perciò gli ordini erano che non dovessimo neanche pensarci, e il capitano ci aveva spiegato che la vera battaglia navale era quello star lì fermi guardandoci, tenendoci pronti, ristudiando i piani delle grandi battaglie navali di Sua Maestà Britannica e il regolamento del maneggio delle vele e il manuale del perfetto timoniere, e le istruzioni per l’uso delle colubrine, perché le regole della flotta dell’ammiragio Drake restavano in tutto e per tutto le regole della flotta dell’ammiragio Drake: se si cominciava a cambiarenon si sapeva dove...
Cosa dite? Via d’ uscita? Mah, ce lo domandavamo di continuo per tutti quei mesi che durò la bonaccia... Molti dei nostri, specie tra i più vecchi e i più tatuati, dicevano che noi eravamo sempre stati una nave da corsa, buona per azioni rapide, e ricordavano i tempi in cui le nostre colubrine sguarnivano delle alberature le più potenti navi spagnole, aprivano falle nelle murate, giostravano con brusche virate... Ma sì, nella marineria di corsa, certo eravamo stati bravi, ma allora c’era il vento, si andava svelto... Adesso, in quella gran bonaccia, questi discorsi di sparatorie e d’abbordaggi erano solo un modo di trastullarci aspettando chissacché; una levata di libeccio, un fortunale, addirittura un tifone... Perciò gli ordini erano che non dovessimo neanche pensarci, e il capitano ci aveva spiegato che la vera battaglia navale era quello star lì fermi guardandoci, tenendoci pronti, ristudiando i piani delle grandi battaglie navali di Sua Maestà Britannica e il regolamento del maneggio delle vele e il manuale del perfetto timoniere, e le istruzioni per l’uso delle colubrine, perché le regole della flotta dell’ammiragio Drake restavano in tutto e per tutto le regole della flotta dell’ammiragio Drake: se si cominciava a cambiarenon si sapeva dove...- - E poi, zio Donald? Ehi zio Donald! Come riusciste a muovervi?
 Uhm... Uhm... Cosa vi dicevo? Ah sì, guai se non si teneva la più rigida disciplina e obbedienza alle regole nautiche. Su altre navi della flotta di Drake c’erano stati cambiamenti ufficiali e anche ammutinamenti, sommosse: si voleva ormai un altro modo di andar per i mari, c’erano semplici uomini della ciurma, marinai di quarto e pure mozziche ormai s’erano fatti esperti e avevano da dir la loro sulla navigazione... Questo i più degli ufficiali e quartiermastri ritenevano il pericolo più grave, perciò guai se sentivano in aria discorsi di chi voleva ristudiare da capo il regolamento navale di Sua Maestà Elisabetta. Niente, dovevamo continuare a ripulire le spingarde, lavare il ponte, assicurarci del funzionamento delle vele, che pendevano flosce nell’aria senza vento, e nelle ore libere delle lunghe giornate lo svago ritenuto più sano erano i soliti tatuaggi sul petto e sulle braccia, che inneggiavano alla nostra flotta dominatrice dei mari. E nei discorsi si finiva per chiudere un occhio su quelli che non riponevano altra speranza che in un aiuto del cielo, come un uragano che magari ci avrebbe mandato a picco tutti, amici e nemici, piuttosto che quelli che volevano trovare un modo per muovere la nave nella condizione presente... Capitò che un gabbiere, certo Slim John, non so se il sole in testa gli avesse fatto male o che cos’altro, cominciò a trastullarsi con unacaffettiera. Se il vapore solleva il coperchio della caffettiera, - diceva questo Slim John, - allora anche la nostra nave, se fosse fatta come una caffettiera potrebbe andare senza vele... Era un discorso un po’ sconnesso, bisogna dire, ma forse, studiandoci ancora sopra, se ne poteva cavare qualche costrutto. Macché: gli buttarono in mare la caffettiera e poco mancò che ci buttassero anche lui. Queste storie di caffettiere, presero a dire, erano poco meno che idee da papisti... è in Spagna che si costuma il caffè e le caffettiere, non da noi... Mah, io non ne capivo nulla, ma purché si muovessero, con quello scorbuto che continuava a falciar gente...
Uhm... Uhm... Cosa vi dicevo? Ah sì, guai se non si teneva la più rigida disciplina e obbedienza alle regole nautiche. Su altre navi della flotta di Drake c’erano stati cambiamenti ufficiali e anche ammutinamenti, sommosse: si voleva ormai un altro modo di andar per i mari, c’erano semplici uomini della ciurma, marinai di quarto e pure mozziche ormai s’erano fatti esperti e avevano da dir la loro sulla navigazione... Questo i più degli ufficiali e quartiermastri ritenevano il pericolo più grave, perciò guai se sentivano in aria discorsi di chi voleva ristudiare da capo il regolamento navale di Sua Maestà Elisabetta. Niente, dovevamo continuare a ripulire le spingarde, lavare il ponte, assicurarci del funzionamento delle vele, che pendevano flosce nell’aria senza vento, e nelle ore libere delle lunghe giornate lo svago ritenuto più sano erano i soliti tatuaggi sul petto e sulle braccia, che inneggiavano alla nostra flotta dominatrice dei mari. E nei discorsi si finiva per chiudere un occhio su quelli che non riponevano altra speranza che in un aiuto del cielo, come un uragano che magari ci avrebbe mandato a picco tutti, amici e nemici, piuttosto che quelli che volevano trovare un modo per muovere la nave nella condizione presente... Capitò che un gabbiere, certo Slim John, non so se il sole in testa gli avesse fatto male o che cos’altro, cominciò a trastullarsi con unacaffettiera. Se il vapore solleva il coperchio della caffettiera, - diceva questo Slim John, - allora anche la nostra nave, se fosse fatta come una caffettiera potrebbe andare senza vele... Era un discorso un po’ sconnesso, bisogna dire, ma forse, studiandoci ancora sopra, se ne poteva cavare qualche costrutto. Macché: gli buttarono in mare la caffettiera e poco mancò che ci buttassero anche lui. Queste storie di caffettiere, presero a dire, erano poco meno che idee da papisti... è in Spagna che si costuma il caffè e le caffettiere, non da noi... Mah, io non ne capivo nulla, ma purché si muovessero, con quello scorbuto che continuava a falciar gente...- - E allora, zio Donald, - esclamammo noi, gli occhi lucidi d’impazienza, prendendolo per i polsi e scuotendolo, - sappiamo che vi salvaste, che sgominaste il galeone spagnolo, ma spiegateci come avvenne, zio Donald!
 Ah sì, anche là nel galeone, mica che fossero tutti della stessa idea, manco per sogno! Lo si vedeva, osservandoli col cannocchiale,anche lì c’erano quelli che volevano muoversi, gli uni contro di noi a cannonate, altri che avevano capito che non c’era altra via che affiancarsi a noi, perché il prevalere della flotta d’Elisabetta avrebbe fatto rifiorire i traffici da tempo languenti... Ma anche lì, gli ufficiali dell’ammiragliato spagnolo non volevano che si muovesse nulla, per carità! Su quel punto i capi della nostra nave e quelli della nave nemica, pur odiandosi a morte, andavano proprio d’accordo.
Ah sì, anche là nel galeone, mica che fossero tutti della stessa idea, manco per sogno! Lo si vedeva, osservandoli col cannocchiale,anche lì c’erano quelli che volevano muoversi, gli uni contro di noi a cannonate, altri che avevano capito che non c’era altra via che affiancarsi a noi, perché il prevalere della flotta d’Elisabetta avrebbe fatto rifiorire i traffici da tempo languenti... Ma anche lì, gli ufficiali dell’ammiragliato spagnolo non volevano che si muovesse nulla, per carità! Su quel punto i capi della nostra nave e quelli della nave nemica, pur odiandosi a morte, andavano proprio d’accordo.
 Cosicché, la bonaccia non accennando a finire, si prese a lanciare dei messaggi, con le bandierine da una nave all’ altra come si volesse aprire un dialogo. Ma non si andava più in là d’un Buon giorno! Buona sera! Neh, che fa bel tempo! e così via.
Cosicché, la bonaccia non accennando a finire, si prese a lanciare dei messaggi, con le bandierine da una nave all’ altra come si volesse aprire un dialogo. Ma non si andava più in là d’un Buon giorno! Buona sera! Neh, che fa bel tempo! e così via.- - Zio Donald! Zio Donald! Non riaddormentatevi, per carità! Diteci, come riuscì a muoversi la nave di Drake!
 Ehi, ehi, non sono mica sordo! Capitemi, fu una bonaccia che nessuno s’aspettava durasse tanto, addirittura per degli anni, là al largo delle Antille, e con un’afa, un cielo pesante, basso, che pareva fosse lì lì per scoppiare in un uragano. Noi stillavamo sudore, tutti nudi, arrampicati su per le sartie, cercando un po’ d’ombra sotto le vele avvoltolate. Tutto era così immobile, che anche quelli di noi che erano più impazienti di cambiamenti e di novità, stavano immobili anche loro, uno in cima all’albero di parrocchetto, un altro sulla randa di maestra, un altro ancora cavalcioni del pennone, appollaiati lassù a sfogliare atlanti o carte nautiche...
Ehi, ehi, non sono mica sordo! Capitemi, fu una bonaccia che nessuno s’aspettava durasse tanto, addirittura per degli anni, là al largo delle Antille, e con un’afa, un cielo pesante, basso, che pareva fosse lì lì per scoppiare in un uragano. Noi stillavamo sudore, tutti nudi, arrampicati su per le sartie, cercando un po’ d’ombra sotto le vele avvoltolate. Tutto era così immobile, che anche quelli di noi che erano più impazienti di cambiamenti e di novità, stavano immobili anche loro, uno in cima all’albero di parrocchetto, un altro sulla randa di maestra, un altro ancora cavalcioni del pennone, appollaiati lassù a sfogliare atlanti o carte nautiche...- - E allora, zio Donald! - ci buttammo in ginocchio ai suoi piedi, lo supplicavamo a mani giunte, lo scuotevamo per le spalle, urlando - diteci come andò a finire, in nome del cielo! Non possiamo più aspettare! Continuate il vostro racconto, zio Donald!
-
-
-
-
-
-
-
-
-