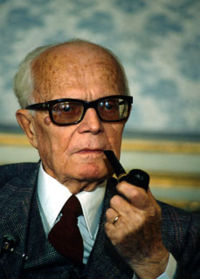
LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006) - a c. di Federico La Sala
- [...] Quello che si tratta di salvare o non salvare è il corpo duraturo, metafisico, non transeunte del re. I re passano, e ciascuno di essi preso individualmente è mortale e triste - ha «occhi pieni di lacrime», subisce usurpazioni e quando precipita non può che «parlare di tombe, di vermi e di epitaffi», dicono i re spodestati nel ciclo delle Guerra delle Rose di Shakespeare. Quel che non cambia di contro è la Corona, è la regalità [...]
LA COSTITUZIONE E L’OPA: O.P.A. - OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
L’Opa politica sulla Costituzione
di Barbara Spinelli (La Stampa, 18.06.2006)
Se tre Presidenti della Repubblica hanno parlato della Costituzione italiana con parole che rimandano al sacro - Oscar Luigi Scalfaro la ricorda come resurrezione civile, Carlo Azeglio Ciampi la chiama sua Bibbia laica, Giorgio Napolitano la paragona alla mosaica tavola dei valori e dei principi in cui riconoscersi - vuol dire che c’è qualcosa di essenziale, nella scelta che gli italiani compiranno il 25-26 giugno quando approveranno o respingeranno la riforma costituzionale varata dalla precedente maggioranza.
Secondo alcuni si tratta di scegliere tra il vecchio e il nuovo, fra conservazione e modernità. Altri hanno l’occhio fisso sui futuri negoziati tra partiti, e danno al voto un valore puramente strumentale: c’è chi sostiene che il No faciliterà la ripresa di trattative bicamerali, e chi invece ritiene che solo il Sì la permetterà. Difficile sapere esattamente dove stia la verità, ma non è questa l’essenza su cui saremo chiamati a pronunciarci.
L’essenza su cui voteremo è la natura non immediatamente politica della carta costituzionale: il suo esistere e durare a dispetto dei governi che passano, delle maggioranze che prendono il sopravvento, del voto che porta al potere queste maggioranze, della morte che naturalmente caratterizza il loro destino e sempre sta loro allato.
Nell’aureo libretto che ha scritto sulla Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky sottolinea proprio questo punto, pur non negando affatto che la Costituzione e la Corte siano anch’esse figure del vivere politico.
Ma lo sono in modo radicalmente diverso, distinto dalla politica che si fa tutti i giorni in Parlamento, nei partiti, e a intervalli regolari nelle urne.
La prima politica, quella della Carta, fonda il pactum societatis: il patto fra cittadini, le condizioni istituzionali che consentono loro di non perire in guerre civili, la fiducia che le norme saranno rispettate da tutti. Esso presuppone l’adesione a regole condivise.
La seconda politica è il pactum subjectionis: essa produce il governo, e ha al suo centro la forza (Zagrebelsky, Principî e voti, Einaudi 2005).
La Costituzione ritaglia nella democrazia uno spazio sacro che protegge la cosa pubblica dalla contingenza e non a caso predispone argini contro il prevalere del numero, contro il dispotismo potenziale d’ogni maggioranza.
È fin da principio che Dio dice a Mosè: «Non seguirai la maggioranza per agire male e non deporrai in processo per deviare verso la maggioranza, per falsare la giustizia. Non favorirai nemmeno il debole nel suo processo» (Esodo 23: 2-3).
Quel che Zagrebelsky scrive a proposito della Consulta vale per la Costituzione: la sua funzione «è politica, ma allo stesso tempo non appartiene alla politica; è essenziale al nostro modo d’intendere la democrazia, ma allo stesso tempo non viene dalla democrazia». In democrazia sono cruciali il numero, la maggioranza. Nella Costituzione il numero non è tutto: le sue leggi valgono quale che sia il numero dei vincenti, e protegge dall’annientamento i perdenti.
 Sulla Costituzione «non si vota». I suoi principi «non dipendono dall’esito di nessuna votazione».
Sulla Costituzione «non si vota». I suoi principi «non dipendono dall’esito di nessuna votazione».
Precisamente su quest’essenza voteremo: sull’opportunità o no di sottrarre la Costituzione alle peripezie della politica intesa come governo e come forza basata sui numeri. Sull’opportunità o no di restringere lo spazio sempre più grande, soffocante, che la seconda politica rischia di prendere nella vita dei cittadini e nel loro patto di convivenza.
 Sul principio che quando è in gioco la Carta non si vota, e in ogni caso non si delibera nei modi in cui ordinariamente si vota in democrazia: a maggioranza.
Sul principio che quando è in gioco la Carta non si vota, e in ogni caso non si delibera nei modi in cui ordinariamente si vota in democrazia: a maggioranza.
Per questo la scelta non è tra innovazione e conservazione. Non è il vecchio che vale la pena conservare né l’immutabilità d’un ordine, ma l’idea che debbano esistere regole e patti le cui tradizioni e i cui tempi non coincidono con quelli di partiti, governi, programmi.
Quello che si tratta di salvare o non salvare è il corpo duraturo, metafisico, non transeunte del re. I re passano, e ciascuno di essi preso individualmente è mortale e triste - ha «occhi pieni di lacrime», subisce usurpazioni e quando precipita non può che «parlare di tombe, di vermi e di epitaffi», dicono i re spodestati nel ciclo delle Guerra delle Rose di Shakespeare.
Quel che non cambia di contro è la Corona, è la regalità: acquisite in tempi passati per elezione divina, incarnate nel pactum societatis a partire dal giorno in cui il diritto divino venne meno.
 I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
Nella ricostruzione di Ernst Kantorowicz la Corona è il corpo mistico e immortale del re, ha un carattere sacramentale e indelebile (character indelebilis), non ha i naturali difetti che possiede il monarca: a seconda dei due corpi sono diversi gli onori, il tempo, la natura della forza, l’idea di ciò che è privato e di ciò che è pubblico (I due corpi del Re, Einaudi 1989).
La modernità democratica mostra ogni giorno di non poter fare a meno di queste categorie. Le rivoluzioni stesse sono state negli ultimi secoli stratagemmi cruenti per restaurare il corpo mistico di re che avevano perso la regalità, e che avevano fuso quel che non andava fuso (i due corpi, il privato e il pubblico). Anche i tumulti hanno spesso quest’obiettivo inconfessato.
Nel ’68 tutto era votato a negazione, distruzione. Nel Policlinico a Roma ogni cosa venne imbrattata, disfatta: pareti, mobili, autorità. Una sola cosa gli studenti non toccarono mai, misteriosamente: il busto di Umberto I che sta a metà scalinata all’ingresso della direzione dell’ospedale. Il corpus indelebilis doveva restare tale. -Sulla corona «non si vota», come non si vota sulla Costituzione.
Può sembrare un paradosso ma proprio su questo voteremo: se sia lecito votare, sulla Costituzione. Se bastino i numeri e le maggioranze tipiche delle democrazie, per riscriverla senza violare magari la lettera della Carta, ma violando di sicuro l’etica istituzionale che l’impregna. Se l’ultima riforma risponda all’esigenza della prima politica o della seconda, se sia il risultato d’una adesione o d’una prova di forza. Per il modo in cui è stata imposta contro la minoranza sembrerebbe che il corpo mistico sia stato offeso, gravemente, anche se l’offesa non è nuova.
Già prima di Bossi e Berlusconi fu un governo di sinistra a imporre modifiche unilaterali, riformando nel 2001 il titolo V della Carta con la sola forza dei propri numeri, e in fine legislatura.
 Quella fu la prima rottura, irresponsabile; quella la breccia attraverso cui poi ha fatto irruzione Berlusconi. Quel che venne dopo fu una riscrittura ben più sostanziale (non qualche paragrafo ma ben 52 articoli, cui se ne aggiungono 3 nuovi), ma è con piccole smagliature che l’etica istituzionale comincia ad alterarsi. Tanto più che nella riforma del 2005 non mancano correttivi - è lo stesso Augusto Barbera, costituzionalista Ds, a dirlo - che son stati introdotti «per rimediare ai pericoli per l’unità nazionale del federalismo sgangherato del Titolo V dell’Ulivo»: è il caso della clausola sull’interesse nazionale, che può esser invocato per far valere le ragioni dello Stato unitario in caso di crisi di competenze.
Quella fu la prima rottura, irresponsabile; quella la breccia attraverso cui poi ha fatto irruzione Berlusconi. Quel che venne dopo fu una riscrittura ben più sostanziale (non qualche paragrafo ma ben 52 articoli, cui se ne aggiungono 3 nuovi), ma è con piccole smagliature che l’etica istituzionale comincia ad alterarsi. Tanto più che nella riforma del 2005 non mancano correttivi - è lo stesso Augusto Barbera, costituzionalista Ds, a dirlo - che son stati introdotti «per rimediare ai pericoli per l’unità nazionale del federalismo sgangherato del Titolo V dell’Ulivo»: è il caso della clausola sull’interesse nazionale, che può esser invocato per far valere le ragioni dello Stato unitario in caso di crisi di competenze.
Tuttavia non è questo il punto: non è la bontà o malvagità di singoli paragrafi, anche se i paragrafi malvagi sono davvero numerosi. Quel che insidia la Costituzione è l’Opa che vien lanciata su di essa dalla politica, dai partiti, non per ultimo dalle Regioni. Altri modi di mutarla ci devono pur essere, basati sul consenso non di una maggioranza - di parlamentari o Regioni - ma su alleanze ampie almeno quanto fu ampio l’arco costituzionale.
Quel che mina la Carta sono le molte bicamerali non sempre trasparenti, che hanno preceduto il finale colpo di forza di Berlusconi. La minoranza di sinistra presentò nel settembre 2003 un suo disegno di legge (i relatori erano Villoni e Bassanini), proponendo alla maggioranza un testo comune, ma quest’ultima la respinse perché ormai voleva una Costituzione nata dalla sola forza dei numeri: una Costituzione non costituzionale, dicono alcuni.
È così che ha prevalso il corpo naturale e mortale del re, sulla regalità dell’istituzione che lo trascende perché gli sopravvive.
 Il corpo naturale s’è impossessato del secondo corpo, ha deciso di far tutt’uno con esso, e lo ha stritolato.
Il corpo naturale s’è impossessato del secondo corpo, ha deciso di far tutt’uno con esso, e lo ha stritolato.
Tutti i punti contestati discendono da questa volontà: il potere assoluto dato al primo ministro, il depotenziamento e l’abolizione di un’enorme quantità di contrappesi (presidenza della Repubblica, opposizione, Parlamento), la politicizzazione della Corte Costituzionale (le nomine politiche aumentano rispetto a quelle non politiche). Discende da questa volontà anche il potere esclusivo dato alle Regioni in materie come scuola, polizia, sanità, cultura. Il giurista Andrea Manzella ricorda come i poteri esclusivi siano assurdi, in una Carta destinata a intrecciarsi con future costituzioni europee e con l’esigenza (già presente nel nostro profetico articolo 11) di superare i poteri sovrani assoluti dello Stato nazione.
Certo è importante che la Costituzione si adatti a un ordinamento mutato, dove la scelta del governo è ormai nelle mani dei cittadini anziché del Parlamento. Il referendum che introdusse il maggioritario, nel 1993, prolungò discussioni già iniziate negli Anni 80.
Ma qui siamo di fronte a un patologico accanimento terapeutico, come scrive Luciano Vandelli in Psicopatologia delle riforme quotidiane (il Mulino 2006): siamo di fronte a riforme ciclotimiche, che - come la devoluzione - oscillano tra frenesie e lunghe indolenze; a riforme autistiche, elaborate da un legislatore che è stato indifferente a ogni critica e stimolo esterno; a riforme schizofreniche, che predicano il decentramento e praticano l’accentramento massimo dei poteri del Premier.
La Costituzione sarà cambiata ma - si spera - con metodi diversi da quelli adottati dalla sinistra e poi, con decuplicata faziosità giacobina, dalla destra. Si spiega così, forse, il tiepido impegno del nuovo governo in una campagna referendaria che pure concerne l’essenza del rapporto fra cittadini e potere.
Si spera che la Carta cambi non in segrete baite montane come ai tempi di Berlusconi, non in esoteriche bicamerali dove solo conta il rapporto di forza tra partiti: ma all’aperto, sapendo che in discussione è il patto della società, è il corpo non transeunte della cosa pubblica, è la regola di Montesquieu riguardante i contropoteri («È necessario, perché non ci sia abuso di potere, che il potere arresti il potere»).
 Questo è il sacro che conviene salvare: non la politica alta rispetto alla bassa, ma la sussistenza di due politiche, ciascuna con tempi e aspirazioni differenti.
Questo è il sacro che conviene salvare: non la politica alta rispetto alla bassa, ma la sussistenza di due politiche, ciascuna con tempi e aspirazioni differenti.
Questa è la dissacrazione (la de-regalizzazione, dice Kantorowicz) cui non sarà irragionevole dire no.
- "[...] il re ha due corpi. In età Tudor si sviluppa quest’idea e nel suo discorso di investitura la Regina Elisabetta I nel 1559 disse: «Sono solo un corpo, dal punto di vista naturale, ma, con il permesso di Dio, un Corpo politico fatto per governare».
 Il corpo naturale è quello che invecchia, si ammala e muore. Il corpo politico è quello metafisico della comunità politica intesa come corpo mistico ed eterno. Il re, o la regina, come vicario di Dio in terra.
Il corpo naturale è quello che invecchia, si ammala e muore. Il corpo politico è quello metafisico della comunità politica intesa come corpo mistico ed eterno. Il re, o la regina, come vicario di Dio in terra. - Scrive Kantorovicz: «Secondo il diritto comune nessun atto che il re compie come re potrà essere annullato a causa del suo difetto di età. Perché il re ha in sé due corpi, cioè il corpo naturale e il corpo politico. Il corpo naturale (se deve essere considerato di per sé) è un corpo mortale, soggetto a tutte le infermità naturali e accidentali,alla debolezza dell’infanzia e della vecchiaia e a tutti i consimili inconvenienti cui vanno incontro i corpi naturali delle altre persone. Ma il suo corpo politico è un corpo che non può essere visto o toccato, consistente di condotta politica e di governo e costituito per la direzione del popolo e la conservazione del bene pubblico, e questo corpo è palesemente privo di infanzia e di vecchiaia e di tutti gli altri difetti e debolezze cui è soggetto il corpo naturale e, per questo motivo, ciò che il re fa con il suo corpo politico non può essere invalidato o annullato a causa di alcuna debolezza del suo corpo naturale». (M. Peruzzo, "La Regina ha due corpi. Alan Turing solo uno", 03.01.2014)

- TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
I DUE CORPI DEL PAPA-RE E LA NOSTRA SOVRANITA’ PENSARE UN ALTRO ABRAMO: GUARIRE LA NOSTRA TERRA. Una lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla),di Federico La Sala
Federico La Sala
Forum
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. --- "QUIS UT DEUS?". UNA NOTA SUL TEMA TEOLOGICO-POLITICO DEI "DUE CORPI DELLA REGINA" (Aurelio Musi)....19 aprile 2024, di Federico La Sala
"QUIS UT DEUS?". UNA NOTA SUL TEMA TEOLOGICO-POLITICO DEI "DUE CORPI DEL RE" - E I DUE CORPI DELLA #REGINA...
- ANTROPOLOGIA, #TEOLOGIA-#POLITICA, E #STORIOGRAFIA: LA #SOVRANITÀ, LA #COSTITUZIONE, E LA #DIGNITÀ DI OGNI #CITTADINO E DI OGNI #CITTADINA...
PLAUDENDO ALL’INIZIATIVA ANNUNCIATA DAL PROF. AURELIO MUSI ,
- "Mercoledì, 24 aprile, ore 15, all’Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli, Via Mezzocannone 8, terrò una conferenza su "I due corpi della regina" , ossia sulla sovranità femminile: i due corpi sono quello fisico e quello politico, il tema è il loro rapporto nelle regine regnanti, consorti, reggenti, supplenti nell’Europa moderna",
FORSE, è da pensare che sia opportuno riprendere la riflessione a tutti i livelli "sulla sovranità femminile: i due corpi sono quello fisico e quello politico" (Aurelio Musi) e, al contempo, ricordare il "caso" di Elisabetta I d’Inghilterra (e della #Riforma anglicana), e, unitariamente, considerare il #cruciverba e l’#enigmistica della #hamletica #question (#Shakespeare) del "#corpomistico" sia del #re (E. H. #Kantorowicz) sia della #regina (#AurelioMusi), e, quindi, non solo del corpo fisico, ma anche il #corpo teologico-politico.
"CHI E’ COME DIO?". Il problema, come aveva già capito e indicato Kantorowicz, è riprendere a riflettere sulla "#regalità #antropocentrica: #Dante" (così il titolo di un capitolo conclusivo del libro "I due corpi del re") e, possibilmente, tentare di uscire dalla caverna platonica e dall’orizzonte della #cosmoteandria logico-filosofica e teologico-politica del PianetaTerra.
- NOTE:
- STORIA E FILOSOFIA. Ernst H. #Kantorowicz, "I due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale"
- ARTE #ANTROPOLOGIA E #TEOLOGIA: "QUIS UT DEUS?" (CHI E’ COME DIO?"). L’INTERPRETAZIONE DELLA FIGURA DELL’#ARCANGELO #MICHELE, DI SAN MICHELE, DA PARTE DI #LUCA GIORDANO (1657): Chiesa dell’Ascensione a #Chiaia, Napoli.
- STORIA E #MEMORIA. #AURELIO #MUSI. "Maria Sofia", Neri Pozza, 2022.
- SINOSSI: Ultima #regina di #Napoli per poco più di un anno, #MariaSofia di #Baviera è l’eroina che dagli spalti di Gaeta infonde coraggio a quel che rimane dell’esercito borbonico annientato dall’arrembaggio piemontese. Alta, slanciata, elegante nel portamento no - bile e grazioso, con una magnifica capigliatura castana, bellissimi occhi di color azzurro-cupo, Maria Sofia trascorre l’infanzia e l’adolescenza nel castello di Possenhofen, dove le giovani Wittelsbach si esercitano in lunghe galoppate a caccia di animali selvatici. Oltre alle passeggiate a cavallo, pratica la scherma, il nuoto, la ginnastica, la danza, riceve una solida educazione musicale e una formazione al gusto estetico secondo i modelli ereditati dalle corti europee d’antico regime. È molto affascinata dalla fotografia [...].
- FILOLOGIA #ANTROPOLOGIA #STORIAELETTERATURA E #TEOLOGIA-#POLITICA. "Il significato spirituale del nome di San Michele... ( Philip Kosloski - 30/09/19).
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. --- TEATRO E METATEATRO: "ST. VALENTINE, OPHELIA, & CLAUDIUS in HAMLET" (Paul Adrian Fried) E "THRE BODY IN MYSTERY" (Jennifer Rust).18 febbraio 2023, di Federico La Sala
TEATRO E METATEATRO: ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, E CINEMA...
- SHAKESPEARE, L’AMORE, E IL MESSAGGIO EVANGELICO.
A PROPOSITO DI "ST. VALENTINE, OPHELIA, & CLAUDIUS in HAMLET", nel post del "February 14, 2018" del suo blog, Paul Adrian Fried, nella sua lodevole ricerca intesa a precisare il senso ’nascosto’ della intenzione shakespeariana di mostrare nel comportamento del personaggio Amleto un continuo riferimento alla tradizione biblica e, in particolare, alla vita del personaggio Gesù, ha toccato il punto nevralgico e messo il dito nella piaga.
A proposito di quanto succede nel giorno di San Valentino, egli scrive:
- "ALSO CONSIDER: St. Valentine’s day was probably more of a Catholic and popular feast (taken over from paganism) than a Protestant church feast in Shakespeare’s time, because although it included a tale of martyrdom and divine "caritas" love (a theological virtue), it is transformed in popular culture into a feast of Eros or human and romantic love." (cit.).
A mio parere, il "progetto" di Shahespeare è un tentativo di trovare con Amleto, in un tempo fuori dai cardini, la via per operare una "instauratio magna" alla Dante Alighieri (la "Monarchia" dei "Due Soli"), non alla Francesco Bacone (con il "parto maschio del tempo", 1602 ca.), che riporti l’intera umanità nella condizione (simbolicamente indicata e indicabile con la metafora) del "paradiso terrestre".
Per potersi orientare, su quanto è successo storicamente e culturalmente nel tempo di Shakespeare (considerando, in particolare, gli effetti della Riforma Protestante), credo sia opportuno e necessario chiarirsi le idee sul significato della parola "caritas", che non parla affatto e per nulla dell’amore evangelico (lat. Charitas, gr. Xàpitas), ma solo di Mammona (ricchezza e carestia)!
SAPEREAUDE!: PER CAPIR(SI), FORSE, CONVIENE RITORNARE NELLA CAVERNA (AL CINEMA). Per cominciare a riflettere, e anche in modo piacevole, si potrebbe rivedere il film di Steven Spielberg "Indiana Jones e l’ultima crociata" (1989) e, al contempo, ripensare alla connessione che il titolo ha con la stessa metodologia della ricerca archeologica (e, se si vuole, shakespeariana): "La X è il punto dove scavare" (cit.).
"AUT - AUT". “To be, or not to be, that is the question”(HAMLET, III.1): "Voi non potete servire Dio ["Deus charitas est"] e Mammona ["Deus caritas est"] (Luca 16, 13).
- COMMENTO DI PAUL ADRIAN FRIED: "We allow Mammon to invade and dominate the realms where love should rule. Dowries, "bride-price," capitalist pressure to turn Valentine’s day into increased profits for florists, corporate chocolatiers, corporate greeting cards.
- There have also been other collective acts of thievery, as Jennifer Rust explains in her book, "The Body in Mystery":
 What was once a communal mystery, the Corpus Mysticum, was taken over by church hierarchy:
What was once a communal mystery, the Corpus Mysticum, was taken over by church hierarchy:
 Then it was also stolen by secular politics, where instead of Christ as head of the mysterious body of the church, a living body where all members had things to contribute, instead the monarch is the Head, and the parliament and Body Politic are the monarch’s "second body."
Then it was also stolen by secular politics, where instead of Christ as head of the mysterious body of the church, a living body where all members had things to contribute, instead the monarch is the Head, and the parliament and Body Politic are the monarch’s "second body." - It was as you say, Federico: A time unhinged - in many ways!
- There have also been other collective acts of thievery, as Jennifer Rust explains in her book, "The Body in Mystery":
- AMORE, MORTE, E PSICOANALISI. DISAGIO NELLA CIVILTA’:
- COME FARE LA FESTA AGLI INNAMORATI E ALLE INNAMORATE E PORTARLI E PORTARLE ALL’INFERNO...
Chiarissimo Paul Adrian Fried ... condivido pienamente: onore al suo lavoro su "Hamlet". Il suo commento sul "giorno di San Valentino" coglie nel segno e arriva a fare chiarezza sul puttanesimo (di cui già parlava Giambattista Vico, nella sua "Scienza Nuova" del 1730), in cui pericolosamente navighiamo sempre più.
La saggezza, la lucidità, la pazienza, la lungimiranza di Shakespeare, come di Dante Alighieri, a mio parere, riposano sulla consapevolezza indistruttibile che Amore (lat. Charitas, gr. Xàpitas) è più forte di Mammon (Mammona) e che sa ben guidare Eros e Psiche al loro incontro Amore (Love)!
- PSICOANALISI. "L’infelicità nella civiltà ("Das Ungluck in der Kultur"): "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. Non fu un puro caso che il sogno germanico del dominio del mondo facesse appello all’antisemitismo come a suo complemento, e non è inconcepibile che il tentativo di stabilire una nuova civiltà comunista in Russia trovi il suo sostegno psicologico nella persecuzione della borghesia. Ci si chiede soltanto, con apprensione, che cosa si metteranno a fare i Sovieti, dopo che avranno sterminato la loro borghesia [...]" (S. Freud, Il disagio della civiltà, 1929).
In principio era la Costituzione (il Logos), non il Logo di "corporate chocolatiers, corporate greeting cards".
Federico La Sala
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE" --- DANTE, KANTOROWICZ, E LA REGALITA’ ANTROPOCENTRICA.5 marzo 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E COSTITUZIONE:
RIPENSARE COSTANTINO E LA TEOLOGIA E LA POLITICA DELL’EUROPA.
Un omaggio a Beatrice Maria e Lucia (8 marzo) e a Dante Alighieri (25 marzo - Dantedì)...
USCIRE A RIVEDERE IL CIELO STELLATO. Non avendo sottratto alla teologia e alla logica dell’ Imperatore Costantino l’opera di Dante Alighieri (ridotto dalla Chiesa Cattolica di Giovanni XXII, prima che da Ugo Foscolo, a "ghibellino fuggiasco"), filosofi e storici hanno finito per banalizzare anche il lavoro di Ernst H. Kantorowicz! Si tenga presente, per capire bene e meglio l’uno e l’altro, che l’ultimo capitolo (l’ottavo) dei "Due corpi del re" è intitolato "La regalità antropocentrica: Dante" e, al contempo, che la regalità antropocentrica è da leggersi in senso antropologico (di ogni essere umano, "ecce homo"), non in senso di una andrologia costantiniana (di ogni essere umano-maschio, "ecce vir")!
COSTITUZIONE. La "Monarchia" dei "due Soli" non dice né della dittatura dell’Imperatore né della dittatura del Papa, ma indica che l’uno e l’altro, semplicemente (la cosa più difficile a farsi), dia a "Dio" (l’amor che muove il sole e le altre stelle) ciò che è di "Dio" e ognuno all’altro (entrambi sovrani - memoria di don Milani) ciò che tocca all’uno e all’altro - nel riconoscimento della sovranità di "Dio" stesso, della Legge dei nostri Padri Costituenti e delle nostre Madri Costituenti. Se in principio era la Costituzione (il Logos), "Quis Ut Deus?" ("Chi è come Dio")?!
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. --- ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA-POLITICA E SCIENZA. IMPARARE A CONTARE: DUE SOGGETTI, DUE SOLI, DUE LIBRI.15 febbraio 2021, di Federico La Sala
Tweet
#DANTE2021 A 700 anni dalla #morte di #Dante, ancora non compresi i #due significati (i #duesoli) del "vicisti, #Galilaee". PER #Keplero, come per #Kant, la vittoria di #GalileoGalilei è filosofico-scientifica!
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5061
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5061#Mathematics #anthropology #Theology #philosophy In #memoria di #GalileoGalilei (nato il #15febbraio 1564), ricordare i #duesoli (#Dante2021) e i #duelibri di #Galilei e che il #logos non è un #logo
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1205
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1205FLS
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. -- CSM A PEZZI. "Una ferita profonda e dolorosa", un "passaggio delicato" che richiede una reazione forte e immediata: o si riscatta "con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti" (David Ermini).5 giugno 2019, di Federico La Sala
CRONACA
Csm a pezzi*
- [Foto] La sala del Plenum straordinario del Csm presso Palazzo dei Marescialli, con i posti vuoti dei magistrati Corrado Cartoni e Antonio Lepre (Fotogramma)
"Una ferita profonda e dolorosa", un "passaggio delicato" che richiede una reazione forte e immediata: o si riscatta "con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti". E’ affidato alle parole del vicepresidente David Ermini il senso di una crisi istituzionale senza precedenti che ha scosso il Consiglio superiore della magistratura per effetto dell’Inchiesta di Perugia, nella quale sono indagati Luca Palamara, e Stefano Rocco Fava, pm a Roma, e il togato dimissionario del Csm Luigi Spina. Ma la sua non era l’unica sedia vuota ieri pomeriggio nell’aula Bachelet dove si è riunito un plenum straordinario convocato a seguito della bufera che ha travolto il Consiglio e l’interra magistratura italiana: quattro togati si sono autosospesi.
Lunedì sera Corrado Cartoni e Antonio Lepre, di Magistratura Indipendente, non indagati ma che avevano preso parte a incontri con gli esponenti del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri per discutere della nomina del procuratore di Roma, e ieri, annunciandolo poco prima del plenum, Gianluigi Morlini, di Unicost, e Paolo Criscuoli di Mi. Ma dall’assemblea di Palazzo dei Marescialli, insieme alla presa d’atto della gravità della situazione, arriva anche una forte assunzione di responsabilità e un richiamo alla compattezza: con un documento approvato all’unanimità tutti i consiglieri, laici e togati, si dicono "sgomenti e amareggiati", denunciano comportamenti da cui "prendere con nettezza le distanze" e richiamano la necessità di "un radicale percorso di autoriforma. E da più parti arriva il riconoscimento al vicepresidente Ermini di una gestione saggia, ferma e responsabile della situazione e al valore imprescindibile della guida del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che del Csm è il presidente.
Di "un giorno cupo come pochi altri" per il Csm parla il togato di Autonomia &indipendenza Piercamilo Davigo, che esprime apprezzamento per la posizione unitaria su cui tutti i consiglieri si sono ritrovati facendo prevalere allo "spirito di appartenenza o di fazione" la "tutela dell’Istituzione". Michele Ciambellini, di Unicost, invita il Consiglio a dare "una risposta seria energica senza ambiguità e a percorrere insieme una strada che riaffermi il prestigio dell’Istituzione". Da Giuseppe Cascini, di Area, il paragone forte del momento "grave e drammatico" con i tempi dello scandalo della P2. Invita a una "generale presa di coscienza" il primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone, che esprime l’auspicio che "la consapevolezza costituisca un valido deterrente a che ulteriori comportamenti individuali vengano adottati in violazione delle regole fondamentali della deontologia".
Il laico M5S Fulvio Gigliotti si dice certo che il Csm "continuerà a mantenere quell’alto livello di garanzia e credibilità istituzionale" attraverso "il più attento rigore e la massima fermezza" nelle funzioni che tutti i componenti sono chiamati a esercitare. Al centro delle riflessioni di Ermini, inevitabilmente, anche il tema delle nomine ai vertici degli uffici che devono essere "trasparenti", compiute "fuori da logiche spartitorie", e preservate dalle "degenerazioni correntizie" e dai "giochi di potere" che sono emersi dall’inchiesta dei pm perugini. E ogni determinazione del Consiglio deve essere assunta "al riparo da interessi esterni" e "al solo fine di assicurare l’efficienza e la conformità alla costituzione dell’attività giurisdizionale" il tutto sotto la "guida illuminata" del Capo dello Stato. Il plenum ha anche preso atto delle dimissioni di Spina e ha deliberato il suo rientro in ruolo alla procura di Castrovillari, suo ufficio di provenienza.
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006) - a c. di Federico La Sala26 gennaio 2019, di Federico La Sala
PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo").
 A EMIL L. FACKENHEIM, (...) il merito di aver ri-proposto la domanda decisiva: “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?”
A EMIL L. FACKENHEIM, (...) il merito di aver ri-proposto la domanda decisiva: “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?”
La spettrale presenza. Hitler, la radiografia e l’inconscio ottico
di Marco Senaldi *
- Inaugura domani 26 gennaio la personale “Der Körper” di Antonello Fresu al Palazzo dei Pio di Carpi. Anticipiamo qui il testo critico di Marco Senaldi, che parte da un passo della Montagna incantata di Thomas Mann e arriva alle radiografie di Hitler.
 [Foto] Antonello Fresu. Der Körper, still da video. Palazzo dei Pio, Carpi 2019
[Foto] Antonello Fresu. Der Körper, still da video. Palazzo dei Pio, Carpi 2019In un brano indimenticabile de La montagna incantata di Thomas Mann, pubblicato nel 1924 ma ambientato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, il protagonista Hans Castorp è oggetto di una radiografia.
 “E Castorp vide [...] in anticipo, grazie alla potenza della luce, la futura opera della decomposizione, la carne, che lo rivestiva, dissolta, distrutta, sciolta in una nebbia evanescente, e dentro a questa lo scheletro della sua destra finemente tornito, dove intorno alla falange dell’anulare era sospeso, nero e isolato, il suo anello col sigillo ereditato dal nonno [...] e per la prima volta in vita sua si rese conto che sarebbe morto. Behrens disse: ‘Spettrale, vero? Eh, una punta di spettralità c’è davvero’”.
“E Castorp vide [...] in anticipo, grazie alla potenza della luce, la futura opera della decomposizione, la carne, che lo rivestiva, dissolta, distrutta, sciolta in una nebbia evanescente, e dentro a questa lo scheletro della sua destra finemente tornito, dove intorno alla falange dell’anulare era sospeso, nero e isolato, il suo anello col sigillo ereditato dal nonno [...] e per la prima volta in vita sua si rese conto che sarebbe morto. Behrens disse: ‘Spettrale, vero? Eh, una punta di spettralità c’è davvero’”.Si tratta di un passaggio sintomatico per diverse ragioni. Sia pur attribuendola a Castorp, esso descrive, con grande precisione, una delle prime immagine a raggi X realizzata da Röntgen, quella della mano dell’amico Albert von Kölliker, in cui, attorno allo scheletro “finemente tornito” delle dita, spicca un anello maschile. La meraviglia dell’eroe di Mann testimonia che, ai suoi esordi, lungi dall’essere considerata un semplice dispositivo clinico, la radiografia a raggi X rivestiva ben altri significati che toccavano la consapevolezza e la fisicità del soggetto. E, in effetti, la diffusione delle immagini radiografiche fu all’inizio accolta non tanto come un avanzamento nella scienza medica, quanto come una curiosità scientifica, e anche una tecnica artistica, in grado di far vedere l’invisibile, in un periodo in cui le innovazioni nel campo della riproduzione delle immagini si succedevano l’una all’altra con grande rapidità.
L’anno della scoperta di Röntgen, il 1895, infatti, coincide con quello dell’invenzione del cinematografo, ma anche con la prima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia (antenata della futura Biennale d’arte) e con uno straordinario articolo di Georg Simmel sulla psicologia della moda. Moda, cinema, arte, sono altrettanti fenomeni legati alle immagini, intese non solo come rappresentazioni del reale, ma anche come rappresentazioni di noi stessi, e dunque della nostra identità. Possiamo perciò intendere queste invenzioni come altrettanti dispositivi, cioè strumenti che ci permettono di amplificare le capacità umane, ma, consentendoci di modificare la nostra visione del mondo, contemporaneamente modificano modo in cui vediamo e consideriamo noi stessi.
- [Foto]Antonello Fresu. Der Körper. Installation view at Palazzo dei Pio, Carpi 2019
È questo il motivo per cui tutte queste invenzioni evidenziano un carattere ancipite e fortemente antinomico. Da un lato il cinema, come nota ottimisticamente Walter Benjamin, risponde al diritto di ogni uomo ad essere ripreso, dall’altro introduce una drammatica spaccatura all’interno del soggetto, come testimonia Varia Nestoroff, l’attrice russa protagonista del romanzo di Pirandello Si gira!, del 1913, che non si riconosce nelle immagini di se stessa sullo schermo. Allo stesso modo l’arte moderna - inaugurata appunto dall’esposizione veneziana - intesa come “evento temporaneo”, da un lato libera dal giogo della tradizione, ma dall’altro avvia un processo di destabilizzazione permanente nel fare creativo dell’artista; e infine, suprema contraddizione è quella che Simmel attribuisce alla moda, che, tramite la manipolazione dell’immagine offerta dall’abito, da un lato promette all’individuo di distinguersi dalla folla, e dall’altro risponde esattamente al bisogno opposto, quello di uniformarsi con la massa.
Questa discordanza diventa esplosiva nel caso dei raggi X. Scoperti quasi casualmente nel corso di una ricerca sui raggi catodici, solo in seguito vennero utilizzati per scopi diagnostici, in quanto in grado di osservare la struttura ossea al di sotto della pelle, ma quasi subito ci si rese conto della loro pericolosità per la salute. In pratica, i raggi X rendono evidente il paradosso epistemologico della modernità, la quale, nello sforzo di conoscere l’essenza al di là delle apparenze, finisce col contaminarla o persino per distruggerla. Questa ambiguità radicale riaffiora in un altro grande romanzo sul destino delle immagini, cioè L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares, apparso non per caso nel 1940.
 Il dispositivo di Morel consiste infatti in una macchina da presa e da proiezione in grado di restituire non solo l’apparenza visiva delle cose riprese, ma la loro consistenza, generando per così dire dei doppioni “tangibili” identici agli originali. Il solo difetto della macchina - ma è un difetto fatale - è che gli esseri viventi che ne subiscano le riprese patiscono effetti devastanti, e sono destinati in breve tempo a una morte certa.
Il dispositivo di Morel consiste infatti in una macchina da presa e da proiezione in grado di restituire non solo l’apparenza visiva delle cose riprese, ma la loro consistenza, generando per così dire dei doppioni “tangibili” identici agli originali. Il solo difetto della macchina - ma è un difetto fatale - è che gli esseri viventi che ne subiscano le riprese patiscono effetti devastanti, e sono destinati in breve tempo a una morte certa.Il valore politico della metafora di Bioy Casares, concepita alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, è evidente: la massima riproducibilità dell’esistente è anche ciò che ne cancella l’esistenza; la duplicazione perfetta della vita non è che un modo inconsapevolmente perfetto per creare un universo di morte. In un certo senso, la parabola del nazismo corre lungo binari paralleli a questi: la sua esaltazione inconsulta della vitalità superomistica, dell’agonismo estetico e della kalokagathia olimpica (così ben raffigurati nelle immagini sublimi dei film di propaganda di Leni Riefenstahl, come appunto Olympia, 1936) non è che l’altra faccia, la proiezione splendente e solare, dell’oscuro desiderio di morte, di distruzione e di annientamento che viene simbolicamente rappresentato, nelle uniformi dei dittatori, dall’icona del teschio.
- [Foto]Antonello Fresu. Der Körper. Palazzo dei Pio, Carpi 2019
E torniamo così alle ossa, il residuo incancellabile che viene messo in evidenza per la prima volta dai raggi X. Si dice che la moglie di Röntgen, Bertha, che fu in effetti la prima persona ad essere sottoposta a una radiografia dal marito, abbia mormorato, osservando l’immagine radiografica della propria mano, “ho visto la mia morte”. Aveva ragione - salvo che non si trattava della morte in senso tradizionale, come termine delle funzioni vitali, distacco del corpo dall’anima o semplicemente dissolvimento della materia nei suoi componenti atomici: ciò a cui la radiografia ci mette di fronte è piuttosto l’enigmatico carattere inorganico della nostra natura animale, il suo residuo ancestrale, quasi l’impronta scheletrica di un fossile, il sigillo della morte catturato però dentro un essere vivente. Questa presa di coscienza della nostra inconsapevole origine minerale ha effetti devastanti: ci si rende infatti conto non solo della nostra fragile natura mortale, ma anche del fatto contrario - reso possibile solo da una tecnica essenzialmente moderna come i raggi X - cioè dell’esistenza in noi stessi di qualcosa di alieno che ci sopravvivrà. Da qui l’elemento fantasmatico, ossia non-del-tutto-mortale, testimoniato dalla radiografia, cioè la “punta di spettralità” così ben individuata da Behrens, il medico di Castorp.
Il fatto che anche Hitler sia stato sottoposto, come milioni di altri pazienti, ad una indagine radiografica, potrebbe essere preso come un fatto del tutto normale. Ma cessa immediatamente di esserlo se pensiamo che lo stesso individuo è stato anche uno dei primi personaggi storici ad essere filmato e fotografato con una tale frequenza e una tale assiduità che non hanno precedenti. Tuttavia, mentre le fotografie e i filmati ci restituiscono un Hitler sempre presente a se stesso, sempre attentissimo a interpretare un ruolo pubblico divenuto in lui come una autentica “seconda natura”, le sue radiografie colgono un aspetto inedito e sconcertante della sua personalità. Guardarle è come osservare il fossile di un temibile Tirannosaurus Rex, il mostruoso dinosauro predatore del giurassico, il cui scheletro, anche se ridotto a una curiosità da Museo di scienze naturali, incute ancora timore. In esse cogliamo un Hitler che nemmeno Hitler sapeva di possedere, il suo estremo residuo umano, la struttura inorganica che testimonia due cose: sia il fatto che anche lui apparteneva - che gli piacesse o no - alla nostra specie -, sia il fatto che non ne era al corrente. Se c’è un’immagine che rappresenta il concetto benjaminiano di “inconscio ottico”, questa è certamente la radiografia di Hitler - cioè non la descrizione del suo inconscio psicologico (fin troppo scandagliato), ma l’istantanea del suo inconscio per così dire antropologico, la sua essenza “umana”, troppo umana, da cui certamente avrebbe desiderato liberarsi.
Non è un caso che uno dei più implacabili satireggiatori del regime nazista, cioè quel Helmut Herzfeld che cambiò il suo nome in John Heartfield in dispregio alle sue origini germaniche, abbia rappresentato nel 1932 il “vero” Hitler, utilizzando una radiografia in cui, sotto il volto del Fürher si vede il suo busto pieno di monete d’oro, in un fotomontaggio dall’ironico titolo Hitler Superuomo - ingoia oro e sputa schifezze.
 Allo stesso modo, nell’operazione di Antonello Fresu, le riproduzioni ingigantite delle radiografie del Fürher e i suoi esami medici ci mettono di fronte a un enigma che certamente era enigmatico per Hitler stesso: come può un superuomo simile condividere con la vile razza umana la stessa misera impalcatura scheletrica?
Allo stesso modo, nell’operazione di Antonello Fresu, le riproduzioni ingigantite delle radiografie del Fürher e i suoi esami medici ci mettono di fronte a un enigma che certamente era enigmatico per Hitler stesso: come può un superuomo simile condividere con la vile razza umana la stessa misera impalcatura scheletrica?
 L’aspetto spettrale che promana da queste gigantografie è fantasmatico in un duplice senso: da un lato perché accende in chi guarda la sensazione di un morire incompleto, che si lascia dietro il resto ineliminabile dello scheletro osseo; dall’altro perché questo scheletro appartiene veramente a un fantasma, anzi al peggior incubo possibile, quello dell’individuo più disumano di sempre, Adolf Hitler. Il sottile senso di inquietudine che ne promana è anch’esso quindi duplice perché da un lato riguarda genericamente la paura della morte, ma dall’altro concerne una paura ancor più radicale, cioè che lo spettro qui radiografato non sia veramente morto, e che la sua scheletrica presenza possa ancora, in un dato momento, rianimarsi.
L’aspetto spettrale che promana da queste gigantografie è fantasmatico in un duplice senso: da un lato perché accende in chi guarda la sensazione di un morire incompleto, che si lascia dietro il resto ineliminabile dello scheletro osseo; dall’altro perché questo scheletro appartiene veramente a un fantasma, anzi al peggior incubo possibile, quello dell’individuo più disumano di sempre, Adolf Hitler. Il sottile senso di inquietudine che ne promana è anch’esso quindi duplice perché da un lato riguarda genericamente la paura della morte, ma dall’altro concerne una paura ancor più radicale, cioè che lo spettro qui radiografato non sia veramente morto, e che la sua scheletrica presenza possa ancora, in un dato momento, rianimarsi.- [Foto] Antonello Fresu. Der Körper. Palazzo dei Pio, Carpi 2019
Si dice che, poco prima di morire, Hitler abbia affermato che “bisogna eliminare l’ebreo che è in noi”. Un’affermazione ambigua e inquietante, che sembra far presagire il vero futuro dell’antisemitismo “classico” - cioè non tanto e non più solo lo sterminio di una “razza” considerata inferiore, e tuttavia esterna a quella superiore, ma la cancellazione dell’ultima traccia di altruismo all’interno del soggetto “superiore” stesso, la distruzione dell’umano all’interno del superuomo. La visione dell’installazione di Antonello Fresu fornisce una possibile risposta alla sconcertante affermazione di Hitler: ciò da cui egli avrebbe voluto liberarsi, senza per questo riuscirci, era proprio ciò che le sue radiografie ci permettono invece di vedere: il suo scheletro, il suo teschio, i suoi organi interni, così miseramente identici a quelli di chiunque. D’altra parte, queste immagini ricordano a tutti noi che liberarsi dal fantasma di Hitler ci è altrettanto impossibile che per lui liberarsi dal fantasma dell’ebreo interiore: lo spettro di questo “Hitler interiore” è dentro di noi come le nostre ossa e i nostri organi interni, ci appartiene più di quanto noi stessi non ci apparteniamo e incarna quel fantasma del Male da cui, anche nei nostri sogni più radiosi, continuiamo a essere ossessionati.
* Marco Senaldi (Artribune, 25,01,2019)
Radiografie e battiti del cuore va in mostra il corpo di Hitler
Si inaugura a Carpi il controverso allestimento curato dallo psicoanalista Antonello Fresu
di Marco Belpoliti (la Repubblica, 26.01.2019)
- [Foto] Adolf Hitler; in alto, l’allestimento della mostra Der Körper al Palazzo dei Pio di Carpi (fino al 31 marzo) con le radiografie di Hitler
Hitler a Carpi? Cosa ci fa la radiografia del capo nazista nella Sala dei Cervi dell’antico Palazzo dei Pio insieme al battito tambureggiante del suo cuore?
Hitler è morto suicida il 30 aprile 1945 nel bunker della Cancelleria di Berlino. Il suo corpo fu cosparso di benzina e bruciato, quindi la salma carbonizzata sepolta insieme ai resti di altri cadaveri irriconoscibili. I soldati sovietici cercarono il corpo del dittatore, fino a che rinvennero un osso mandibolare e due ponti dentari; presentati al suo odontotecnico, Fritz Echtmann, furono identificati grazie alla cartelle cliniche. Nonostante questo, restò l’ipotesi che fosse ancora vivo e nascosto da qualche parte, una leggenda che circolò negli anni ’50 e ’60. Nel 1945 l’esercito americano realizzò un dossier sul capo nazista utilizzando le cartelle cliniche del suo medico, Theodor Morrell: 47 pagine che contenevano la radiografia del cranio del leader e alcuni elettrocardiogrammi, intitolate Investigation into whereabouts. Nel 1983 sono state rese accessibili insieme alle ricerche dell’Fbi per "ritrovare" il dittatore.
Antonello Fresu, psicoanalista junghiano, ha usato quelle pagine e realizzato l’installazione Der Körper che s’inaugura oggi nello spazio del castello di Carpi sotto l’egida della Fondazione Fossoli (fino al 31 marzo). Nella prima stanza buia appaiono le imponenti radiografie del cranio di Hitler, alte tre metri, retroilluminate: sono fantasmi neri su fondo bianco, e insieme impressionanti opere grafiche, il cui significato luttuoso appare subito evidente.
 Nella seconda sala i referti clinici analizzati da specialisti medici di oggi, come si trattasse di un paziente qualsiasi, mentre sulla volta appaiono parate naziste, Hitler che arringa la folla e raduni militari. Nella terza stanza sono riportati i documenti del dossier americano, mentre nella quarta, e ultima, su uno schermo compare la simulazione del battito del cuore e un elettrocardiografo dell’epoca emette il tracciato di quell’esame clinico in presa diretta: si attiva appena le persone entrano nella sala come un misterioso saluto di benvenuto.
Nella seconda sala i referti clinici analizzati da specialisti medici di oggi, come si trattasse di un paziente qualsiasi, mentre sulla volta appaiono parate naziste, Hitler che arringa la folla e raduni militari. Nella terza stanza sono riportati i documenti del dossier americano, mentre nella quarta, e ultima, su uno schermo compare la simulazione del battito del cuore e un elettrocardiografo dell’epoca emette il tracciato di quell’esame clinico in presa diretta: si attiva appena le persone entrano nella sala come un misterioso saluto di benvenuto.L’idea di Fresu, attento indagatore dell’Ombra, per dirla con Jung, ha qualcosa d’inquietante: stende un mantello di nere tenebre in questo luogo e obbliga i visitatori a incontrare, come scrive Marco Senaldi in un testo che apparirà nel catalogo della mostra, a guardare il fossile di un Tirannosaurus Rex, il cui scheletro è stato conservato e trasformato in curiosità espositiva da Museo di Scienze Naturali. Già di per sé le radiografie sono qualcosa di conturbante, e queste di grandi dimensioni, anche senza sapere che appartengono al cranio di Hitler, inquietanti. Pare che la moglie dell’uomo che ha inventato questo metodo d’indagine, Wilhelm C. Röntgen, dopo essere stata sottoposta alla prima radiografia, abbia detto: ho visto la mia morte. Questi light box contengono una doppia morte: quella del paziente Adolf Hitler e quella del dittatore che ha provocato la più immane catastrofe del XX secolo. Un uomo e insieme il peggior criminale della storia. È come se, per una nera magia, il doppio corpo del Re, per dirla con Ernst Kantorowicz, corpo materiale e corpo sacrale, corpo che muore e quello che invece si trasmette sotto forma di regalità, si fossero ricongiunti per un imponderabile maleficio. Fresu, nel suo doppio ruolo di psicoanalista e di artista, ha messo in mostra un’ombra e il suo fantasma. Come se i fantasmi potessero avere un’ombra. Batte il cuore di uno spettro mentre i soldati camminano a passo dell’oca sulle volte ricurve del Castello.
Spettro perché, mentre i fantasmi sono bianchi, Hitler è nero, anzi nerissimo. Il capo nazista è stato e resta un enigma. Il suo maggior biografo, l’inglese Ian Kershaw, s’è chiesto come un uomo così bizzarro abbia potuto prendere il potere in uno Stato moderno com’era la Germania dell’inizio del XX secolo. Dotato di grandi abilità demagogiche e di una capacità straordinaria di sfruttare le debolezze dei suoi avversari, Hitler resta un mistero per chi l’ha indagato: di quali poteri era dotato per riuscire a trascinare le classi dirigenti tedesche in un’avventura così nefanda e disastrosa? Risposta non c’è. Salvo ricorrere alla metafisica del Male, o a spiegazioni che esorbitano dalla nostra comprensione razionale. Der Körper bordeggia quello spazio irrazionale, lo lambisce e per questo scuote il visitatore, lo mette in allerta. Persegue questo scopo e anche quello di indicare che Hitler era un uomo come noi, che aveva un corpo simile al nostro: era normale. Non era un mostro?
Possibile? Il concetto di "mostro" non è facile da maneggiare; fa vacillare, perché spiega qualcosa d’inspiegabile. Primo Levi, al termine del suo I sommersi e i salvati, sostiene di non aver mai incontrato dei mostri nel lager, solo degli uomini che erano stati educati male. L’arcano di Hitler resta irrisolto.
 La mostra è elegante e la sua provocazione colpisce. Tra tutti i dittatori del XX secolo, Hitler era quello che sembrava avere meno corpo di tutti; lo nascondeva persino ai propri intimi: nessuno l’ha mai visto a torso nudo. Come aveva detto Jung, intervistato da un giornalista americano, poco dopo la sua ascesa al potere, quello che colpiva era prima di tutto la voce del dittatore, la vibrazione isterica che conteneva, una voce che stregava milioni di tedeschi e li coinvolgeva. Come controcanto a questa ostensione fantasmatica della testa e del cuore del dittatore funziona la voce tremenda di Hitler che echeggia nelle sale, una voce uscita da un corpo così piccolo e modesto, che non riusciamo a dimenticare, e che come uno spettro circola ancora oggi per l’Europa dei suoi tardi, assurdi e fanatici ammiratori.
La mostra è elegante e la sua provocazione colpisce. Tra tutti i dittatori del XX secolo, Hitler era quello che sembrava avere meno corpo di tutti; lo nascondeva persino ai propri intimi: nessuno l’ha mai visto a torso nudo. Come aveva detto Jung, intervistato da un giornalista americano, poco dopo la sua ascesa al potere, quello che colpiva era prima di tutto la voce del dittatore, la vibrazione isterica che conteneva, una voce che stregava milioni di tedeschi e li coinvolgeva. Come controcanto a questa ostensione fantasmatica della testa e del cuore del dittatore funziona la voce tremenda di Hitler che echeggia nelle sale, una voce uscita da un corpo così piccolo e modesto, che non riusciamo a dimenticare, e che come uno spettro circola ancora oggi per l’Europa dei suoi tardi, assurdi e fanatici ammiratori. -
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. --- FEDERICO II DI SVEVIA, LA "SIMBOLOGIA DI CASTEL DEL MONTE", E DANTE.22 agosto 2018, di Federico La Sala
RIPENSARE COSTANTINO. LA LEZIONE DI DANTE (E DI KANTOROWICZ) .... *
Musica, architettura e cosmo: una rilettura di Castel del Monte
di Cesare Cavalleri (Avvenire, mercoledì 22 agosto 2018)
Tantissimi anni fa, cioè nel 1970, lessi Pietre che cantano, di Marius Schneider, spinto dall’entusiasmo di Elémire Zolla che aveva spiegato come Schneider, osservando i chiostri romanici di San Cugat, di Gerona e di Ripoll in Catalogna, aveva annotato le figure effigiate sui capitelli assegnando a ciascuna un valore musicale; quindi lesse come simboli di note le singole figure, basandosi sulle corrispondenze tramandate dalla tradizione indù, e scoprì infine che la serie corrispondeva alla esatta notazione degli inni gregoriani dedicati ai santi di quei chiostri. Abbagliante erudizione che non ho mai smesso di ammirare.
Con questo precedente, non potevo evitare di tuffarmi (siamo in estate) nel saggio di Giulia Ferraro, Simbologia di Castel del Monte. Rilettura di un’ipotesi sui rapporti tra musica e architettura, pubblicato nel più recente quaderno del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, a cura di Massimo Venuti con Giovanni Acciai e Gabriele Manca (Edizioni ETS, pagine 228, euro 23,00).
Castel del Monte, che si erge solitario nel paesaggio collinare delle Murge, in territorio di Andria, è un enigma che da otto secoli affatica gli studiosi che finora sono riusciti soltanto a scalfirlo. Enigmatico quant’altri mai, del resto, è chi lo fece costruire, l’imperatore Federico II di Svevia (1194-1250), guerriero, astronomo, falconiere, politico antagonista del papato, protettore degli artisti da cui amava circondarsi. Enigmatica anche la destinazione del Castello, che non sembra di difesa né di delizie, con la sua pianta ottagonale e le otto torri angolari.
L’ipotesi che Giulia Ferraro intende rileggere è del musicologo Vasco Zara, autore nel 2000 del saggio L’intelletto armonico. Il linguaggio simbolico musicale nell’architettura di Castel del Monte. Zara collega le forti implicazioni astronomiche, matematiche e geometriche racchiuse nell’architettura del Castello, con le conoscenze musicali dell’epoca. In particolare, viene proposto l’antico accostamento tra pianeti e note musicali, «introducendo il concetto di “musica delle sfere”, per il quale il movimento di ciascun pianeta produce un preciso suono».
È un concetto di ascendenza platonica, che Dante riprenderà nel Canto XII del Paradiso. Zara, «dopo aver associato a ogni facciata interna del pianterreno del Castello un pianeta e del piano superiore una delle gerarchie angeliche, abbina a questi una nota musicale», secondo uno schema rinvenuto in alcuni fogli liberi di un manoscritto del XII secolo, contenente il De institutione musica di Boezio.
Il passaggio dal giro pagano dei pianeti al cielo abitato dalle gerarchie angeliche è scandito nella facciata nord-ovest del Castello dalla statua equestre di un cavaliere, peraltro semidistrutta: «L’immagine è quella di mediatore tra Cielo e Terra, adatta a un imperatore come Federico, autoincoronatosi, in una Gerusalemme da lui liberata, Re del Mondo contro il volere del Papa che l’aveva scomunicato, Re per grazia di Dio e non della Chiesa».
Dunque, l’architettura di Castel del Monte riprodurrebbe in forma plastica la musica delle sfere, la cui inudibilità è così spiegata da sant’Ambrogio in Exameron, II,7: «Alcuni dicono che il suono delle sfere non arriva fino alla terra, per la ragione che gli uomini, sia in Oriente che in Occidente, sedotti dalla soavità e dal fascino di quel suono originato dal movimento velocissimo dei cieli, trascurerebbero ogni dovere e attività e tutto quaggiù rimarrebbe ozioso, perché lo spirito umano sarebbe come portato in estasi da quelle musiche celesti».
Il Quaderno del Conservatorio intitolato “I volti della musica: allegoria, Spirito, realtà”, contiene, oltre allo studio di Giulia Ferraro, altri due saggi: Lutero e la riforma. Alle origini del Corale, di Ivana Valotti; Luigi Nono, al gran sole carico d’amore. La rivoluzione in musica, di Claudia Ferrari. Finché ci saranno studiosi che si dedicano ad approfondimenti come questi, il mondo non cadrà nell’insignificanza.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
- PER L’ITALIA, "DUE SOLI". Per una nuova laicità, un nuovo cristianesimo!!! Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò i mosaici" dei "faraoni", ma soprattutto la Legge del "Dio" di Mosè di Elia e di Gesù, del "Dio" dei nostri "Padri" e delle nostre "Madri". L’Amore che muove il Sole e le altre stelle ... e la fine del cattolicesimo costantiniano!!!
DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. --- KANTOROWICZ, UN GRANDE LETTORE DI DANTE. Una nota
LA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz.... L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
Federico La Sala
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. -- ’Contropotere Capo Stato per evitare abusi’. Discorso di Mattarella in ricordo di Einaudi.13 maggio 2018, di Federico La Sala
Mattarella: ’Contropotere Capo Stato per evitare abusi’
Discorso in ricordo di Einaudi. Dopo elezioni 1953 non si avvalse delle indicazioni della Dc
- Il capo dello Stato Sergio Mattarella durante la celebrazione per l’anniversario dell’insediamento al Quirinale di Luigi Eiunaudi (foto Quirinale) © ANSA FOTO
di Redazione ANSA *
"Solo una società libera e robusti contropoteri avrebbero impedito abusi": questa, secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fu una delle "convinzioni più profonde" dello studioso Einaudi che, "sin dal suo messaggio alle Camere riunite in occasione del giuramento ricordò il ruolo di ’tutore’ dell’osservanza della legge fondamentale della Repubblica. Questo un passaggio dell’intervento del Capo dello Stato a Dogliani. Quello del presidente della Repubblica - ha detto - è un ruolo di "tutore dell’osservanza della legge fondamentale della Repubblica".
Einaudi, riferendosi alla prerogativa del sovrano (e, vien da pensare, interrogandosi implicitamente sul ruolo del Presidente della Repubblica), osservava che essa "può e deve rimanere dormiente per lunghi decenni e risvegliarsi nei rarissimi momenti nei quali la voce unanime, anche se tacita, del popolo gli chiede di farsi innanzi a risolvere una situazione che gli eletti del popolo da sé, non sono capaci di affrontare".
"Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento - ha detto ancora - Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario".
"Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi delle indicazioni espresse dal principale gruppo parlamentare, quello della Dc", aggiunge.
Era "tale l’importanza che Einaudi attribuiva al tema della scelta dei ministri, dal volerne fare oggetto di una nota, nel 1954, in occasione dell’incontro con i presidenti dei gruppi parlamentari della Dc, dopo le dimissioni del governo Pella", ha aggiunto Mattarella. "E’, scrisse nella nota, dovere del Presidente evitare si pongano precedenti grazie ai quali accada che egli non trasmetta al suo successore, immuni da ogni incrinatura, le facoltà che la Carta gli attribuisce".
"Solo una società libera e robusti contropoteri avrebbero impedito abusi": questa, secondo il presidente della Repubblica fu una delle "convinzioni più profonde" dello studioso Einaudi che, "sin dal suo messaggio alle Camere riunite in occasione del giuramento ricordò il ruolo di ’tutore’ dell’osservanza della legge fondamentale della Repubblica.
* ANSA 12 maggio 2018 (ripresa parziale, senza foto).
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. -- Stato-Mafia. Pm Di Matteo: ’Da Anm e Csm nessuna difesa. Silenzio assordante, chi speravamo ci difendesse ha taciuto’.23 aprile 2018, di Federico La Sala
Stato-Mafia: Pm Di Matteo: ’Dell’Utri tramite dopo il ’92’
’Da Anm e Csm nessuna difesa. Silenzio assordante, chi speravamo ci difendesse ha taciuto’
- Stato-mafia: pm Di Matteo, da Anm e Csm nessuna difesa © ANSA FOTO
di Redazione ANSA *
"La sentenza è precisa e ritiene che Dell’Utri abbia fatto da cinghia di trasmissione nella minaccia mafiosa al governo anche nel periodo successivo all’avvento alla Presidenza del Consiglio di Berlusconi. In questo c’è un elemento di novità. C’era una sentenza definitiva che condannava Dell’Utri per il suo ruolo di tramite tra la mafia e Berlusconi fino al ’92. Ora questo verdetto sposta in avanti il ruolo di tramite esercitato da Dell’Utri tra ’Cosa nostra’ e Berlusconi". Lo ha detto il pm della Dna Nino Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre.
La replica dell’Anm, sempre difeso magistrati attaccati - "L’Associazione Nazionale Magistrati ha sempre difeso dagli attacchi l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati". Lo dice il presidente dell’Anm Francesco Minisci. "Lo ha fatto - prosegue - a favore dei colleghi di Palermo e continuerà sempre a difendere tutti i magistrati attaccati, pur non entrando mai nel merito delle vicende giudiziarie".
"Né Silvio Berlusconi, né altri hanno denunciato le minacce mafiose, né prima né dopo" ha anche detto il pm Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, su Rai tre. "Nel nostro sistema costituzionale le sentenze vengono pronunciate nel nome del popolo italiano e possono essere criticate e impugnate. Il problema è che quando le sentenze riguardano uomini che esercitano il potere devono essere conosciute", ha aggiunto. "C’è una sentenza definitiva - ha spiegato - che afferma che dal ’74 al ’92 Dell’Utri si fece garante di un patto tra Berlusconi e le famiglie mafiose palermitane. Ora questa sentenza dice che quella intermediazione non si ferma al ’92, ma si estende al primo governo Berlusconi, questi sono fatti che devono essere conosciuti"
"I carabinieri che hanno trattato sono stati incoraggiati da qualcuno. Noi non riteniamo che il livello politico non fosse a conoscenza di quel che accadeva. Ci vorrebbe ’un pentito di Stato’, uno delle istituzioni che faccia chiarezza e disegni in modo ancora più completo cosa avvenne negli anni delle stragi". Lo ha detto il pm della dna Nino Di Matteo, a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre.
"Quello che mi ha fatto più male è che rispetto alle accuse di usare strumentalmente il lavoro abbiamo avvertito un silenzio assordante e chi speravamo ci dovesse difendere è stato zitto. A partire dall’ Anm e il Csm". Lo ha detto il pm della Dna Nino Di Matteo, dopo la sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre a proposito delle critiche subite, negli anni, dal pool che ha coordinato l’inchiesta.
* ANSA,23 aprile 2018 (ripresa parziale, senza immagine).
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE" -- IL PALOMBARO E LA LEGGENDA COLA PESCE".15 aprile 2018, di Federico La Sala
PER L’ITALIA E PER LA COSTITUZIONE...
LA CORONA DEL REGNO, IL PALOMBARO, E LA LEGGENDA DI "(NI) COLA PESCE" *
- In Italia la scelleratezza comincia presto, dopo la Liberazione. Da allora siamo impigliati nel cortocircuito colpa-nemesi, senza produrre la catarsi: il momento della purificazione in cui - nelle Supplici di Eschilo - s’alza Pelasgo, capo di Argo, e dice: «Occorre un pensiero profondo che porti salvezza. Come un palombaro devo scendere giù nell’abisso, scrutando il fondo con occhio lucido e sobrio così che questa vicenda non rovini la città e per noi stessi si concluda felicemente».[...] Scrive Davide Susanetti, nel suo bel libro sulla tragedia greca, che il tuffo di Pelasgo implica una più netta visione dei diritti della realtà: «Per mutare non bisogna commuoversi, ma spostarsi fuori dall’incantesimo funesto del cerchio» che ci ingabbia (Catastrofi politiche, Carocci 2011) [...] (Barbara Spinelli, Un pensiero profondo per la politica, la Repubblica, 23.11.2011)
*
Cola Pesce
Una volta a Messina c’era una madre che aveva un figlio a nome Cola, che se ne stava a bagno nel mare mattina e sera. La madre a chiamarlo dalla riva:
 Cola! Cola! Vieni a terra, che fai? Non sei mica un pesce?
Cola! Cola! Vieni a terra, che fai? Non sei mica un pesce?E lui, a nuotare sempre più lontano. Alla povera madre veniva il torcibudella, a furia di gridare. Un giorno, la fece gridare tanto che la poveretta, quando non ne poté più di gridare, gli mandò una maledizione:
 Cola! Che tu possa diventare un pesce!
Cola! Che tu possa diventare un pesce!Si vede che quel giorno le porte del Cielo erano aperte, e la maledizione della madre andò a segno: in un momento, Cola diventò mezzo uomo mezzo pesce, con le dita palmate come un’anatra e la gola da rana. In terra Cola non ci tornò più e la madre se ne disperò tanto che dopo poco tempo morì.
La voce che nel mare di Messina c’era uno mezzo uomo e mezzo pesce arrivò fino al Re; e il Re ordinò a tutti i marinai che chi vedeva Cola Pesce gli dicesse che il Re gli voleva parlare.
Un giorno, un marinaio, andando in barca al largo, se lo vide passare vicino nuotando.
 Cola! - gli disse. - C’è il Re di Messina che ti vuole parlare!
E Cola Pesce subito nuotò verso il palazzo del Re.
Cola! - gli disse. - C’è il Re di Messina che ti vuole parlare!
E Cola Pesce subito nuotò verso il palazzo del Re.Il Re, al vederlo, gli fece buon viso.
 Cola Pesce, - gli disse, - tu che sei così bravo nuotatore, dovresti fare un giro tutt’intorno alla Sicilia, e sapermi dire dov’è il mare più fondo e cosa ci si vede!
Cola Pesce, - gli disse, - tu che sei così bravo nuotatore, dovresti fare un giro tutt’intorno alla Sicilia, e sapermi dire dov’è il mare più fondo e cosa ci si vede!Cola Pesce ubbidì e si mise a nuotare tutt’intorno alla Sicilia.
Dopo un poco di tempo fu di ritorno. Raccontò che in fondo al mare aveva visto montagne, valli, caverne e pesci di tutte le specie, ma aveva avuto paura solo passando dal Faro, perché lì non era riuscito a trovare il fondo.
 E allora Messina su cos’è fabbricata? - chiese il Re. - Devi scendere giù a vedere dove poggia.
E allora Messina su cos’è fabbricata? - chiese il Re. - Devi scendere giù a vedere dove poggia.Cola si tuffò e stette sott’acqua un giorno intero. Poi ritornò a galla e disse al Re:
 Messina è fabbricata su uno scoglio, e questo scoglio poggia su tre colonne: una sana, una scheggiata e una rotta.
Messina è fabbricata su uno scoglio, e questo scoglio poggia su tre colonne: una sana, una scheggiata e una rotta. O Messina, Messina,
O Messina, Messina,
 Un dì sarai meschina!
Un dì sarai meschina!Il Re restò assai stupito, e volle portarsi Cola Pesce a Napoli per vedere il fondo dei vulcani. Cola scese giù e poi raccontò che aveva trovato prima l’acqua fredda, poi l’acqua calda e in certi punti c’erano anche sorgenti d’acqua dolce.
Il Re non ci voleva credere e allora Cola si fece dare due bottiglie e gliene andò a riempire una d’acqua calda e una d’acqua dolce. Ma il Re aveva quel pensiero che non gli dava pace, che al Capo del Faro il mare era senza fondo. Riportò Cola Pesce a Messina e gli disse:
 Cola, devi dirmi quant’è profondo il mare qui al Faro, più o meno.
Cola, devi dirmi quant’è profondo il mare qui al Faro, più o meno.Cola calò giù e ci stette due giorni, e quando tornò sù disse che il fondo non l’aveva visto, perché c’era una colonna di fumo che usciva da sotto uno scoglio e intorbidava l’acqua. Il Re, che non ne poteva più dalla curiosità, disse:
 Gettati dalla cima della Torre del Faro
Gettati dalla cima della Torre del FaroLa Torre era proprio sulla punta del capo e nei tempi andati ci stava uno di guardia, e quando c’era la corrente che tirava suonava una tromba e issava una bandiera per avvisare i bastimenti che passassero al largo. Cola Pesce si tuffò da lassù in cima.
Il Re ne aspettò due, ne aspettò tre, ma Cola non si rivedeva. Finalmente venne fuori, ma era pallido.
 Che c’è, Cola? - chiese il Re.
Che c’è, Cola? - chiese il Re. C’è che sono morto di spavento, - disse Cola. - Ho visto un pesce, che solo nella bocca poteva entrarci intero un bastimento! Per non farmi inghiottire m son dovuto nascondere dietro una delle tre colonne che reggono Messina!
C’è che sono morto di spavento, - disse Cola. - Ho visto un pesce, che solo nella bocca poteva entrarci intero un bastimento! Per non farmi inghiottire m son dovuto nascondere dietro una delle tre colonne che reggono Messina!Il Re stette a sentire a bocca aperta; ma quella maledetta curiosità di sapere quant’era profondo il Faro non gli era passata.
E Cola:
 No, Maestà, non mi tuffo più, ho paura.
No, Maestà, non mi tuffo più, ho paura.Visto che non riusciva a convincerlo, il re si levò la corona dal capo, tutta piena di pietre preziose, che abbagliavano lo sguardo, e la buttò in mare.
 Va’ a prenderla, Cola!
Va’ a prenderla, Cola! Cos’avete fatto, Maestà? La corona del Regno!
Cos’avete fatto, Maestà? La corona del Regno! Una corona che non ce n’è altra al mondo, - disse il Re. - Cola, devi andarla a prendere!
Una corona che non ce n’è altra al mondo, - disse il Re. - Cola, devi andarla a prendere! Se voi così volete, Maestà, - disse Cola - scenderò. Ma il cuore mi dice che non tornerò più su. Datemi una manciata di lenticchie. Se scampo, tornerò su io; ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno che io non torno più.
Se voi così volete, Maestà, - disse Cola - scenderò. Ma il cuore mi dice che non tornerò più su. Datemi una manciata di lenticchie. Se scampo, tornerò su io; ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno che io non torno più.Gli diedero le lenticchie, e Cola scese in mare.
Aspetta, aspetta; dopo tanto aspettare, vennero a galla le lenticchie. Cola Pesce s’aspetta che ancora torni.
 (Palermo)
(Palermo)*Cfr.: Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino, Einaudi, Torino 1971, vol. II, pp. 602-604.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA SOVRANITÀ, LA DIGNITÀ DI OGNI CITTADINO E DI OGNI CITTADINA, E "I DUE CORPI DEL RE". La lezione di Kantorowicz...
 LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli (2006)
 I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.
I due corpi del re vanno tenuti disgiunti, perché resti vivo l’inaugurale patto che dissuade dalla guerra di tutti contro tutti, e che fonda un rapporto non effimero, non continuamente modificabile, fra i cittadini e chi li comanda.FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!Federico La Sala
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. -- Per una biopolitica illuminista. "Vivere la democrazia": l’ultima lezione di Stefano Rodotà (di Roberto Esposito).31 marzo 2018, di Federico La Sala
SENZA PIU’ PAROLA E SENZA PIU’ CARTA D’IDENTITA’. Alla ricerca della dignità perduta...
Le idee. Per una biopolitica illuminista
L’ultima lezione di Stefano Rodotà
di Roberto Esposito (la Repubblica, 31.03.2018)
«Per vivere occorre un’identità, ossia una dignità. Senza dignità l’identità è povera, diventa ambigua, può essere manipolata». Il nuovo libro, postumo, di Stefano Rodotà, Vivere la democrazia, appena pubblicato da Laterza, può essere letto come un ampio e appassionato commento a questa frase di Primo Levi. Tutti e tre i termini evocati da Levi - identità, dignità e vita - s’incrociano in una riflessione aperta ma anche problematica, che ha fatto di Rodotà uno dei maggiori analisti del nostro tempo.
 Composto da saggi non tutti rivisti dall’autore, scomparso lo scorso giugno nel pieno del suo lavoro, il libro ci restituisce il nucleo profondo di una ricerca che definire giuridica è allo stesso tempo esatto e riduttivo. Esatto perché il diritto costituisce l’orizzonte all’interno del quale Rodotà ha collocato il proprio lavoro. Riduttivo perché ha sempre riempito la propria elaborazione giuridica di contenuti storici, filosofici, antropologici che ne eccedono il linguaggio. Rodotà ha posto il diritto, da altri irrigidito in formulazioni astratte, a contatto diretto con la vita. E non con la vita in generale, ma con ciò che è diventato oggi la vita umana nel tempo di una tecnica dispiegata al punto da penetrare al suo interno, modificandone profilo e contorni.
Composto da saggi non tutti rivisti dall’autore, scomparso lo scorso giugno nel pieno del suo lavoro, il libro ci restituisce il nucleo profondo di una ricerca che definire giuridica è allo stesso tempo esatto e riduttivo. Esatto perché il diritto costituisce l’orizzonte all’interno del quale Rodotà ha collocato il proprio lavoro. Riduttivo perché ha sempre riempito la propria elaborazione giuridica di contenuti storici, filosofici, antropologici che ne eccedono il linguaggio. Rodotà ha posto il diritto, da altri irrigidito in formulazioni astratte, a contatto diretto con la vita. E non con la vita in generale, ma con ciò che è diventato oggi la vita umana nel tempo di una tecnica dispiegata al punto da penetrare al suo interno, modificandone profilo e contorni.Ma cominciamo dalle tre parole prima evocate, a partire dall’identità. Come è noto a chi si occupa di filosofia, l’interrogazione sul significato della nostra identità attraversa l’intera storia del pensiero, trovando un punto di coagulo decisivo nell’opera di John Locke.
Cosa fa sì che il vecchio riconosca sé stesso nel ragazzo, e poi nell’adulto, che è stato nonostante i tanti cambiamenti che ne hanno segnato l’aspetto e il carattere? La risposta di Locke è che a consentire alla coscienza di sperimentarsi identica a se stessa in diversi momenti dell’esistenza è la memoria. Ma tale risposta bastava in una stagione in cui natura, storia e tecnica costituivano sfere distinte e reciprocamente autonome. Una condizione oggi venuta meno. Nel momento in cui politica e tecnica hanno assunto il corpo umano a oggetto del proprio operato tutto è cambiato. Sfidata dalle biotecnologie e immersa nel cyberspazio, l’identità umana si è andata dislocando su piani molteplici, scomponendosi e ricomponendosi in maniera inedita.
È precisamente a questa mutazione antropologica che Rodotà rivolge uno sguardo acuminato. A chi appartiene il nostro futuro? - egli si chiede con Jaron Lanier (La dignità ai tempi di internet, Il Saggiatore) - quando l’identità non è più forgiata da noi stessi, ma modificata, e anche manipolata, da altri? Si pensi a come è cambiato il ruolo del corpo in rapporto alla nostra identificazione. Dopo essere stato centrale, al punto che sulla carta d’identità comparivano, insieme alla foto, colore di occhi e capelli, il corpo è stato in qualche modo soppiantato dalle tecnologie informatiche - password, codici, algoritmi. Per poi tornare, una volta tecnologizzato, come oggetto di attenzione da parte delle agenzie di controllo. Impronte digitali, geometrie della mano, iride, retina, per non parlare del dna.
 Tutto ciò quando la chirurgia plastica è in grado di cambiare i nostri connotati.
E qui entra in gioco il secondo termine del libro, la dignità, assunta non in maniera generica, ma come un vero principio giuridico. Che ha già trovato spazio nella nostra Costituzione e poi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ma ciò non basta, se si vuol passare dal tempo dell’homo aequalis a quello dell’homo dignus. Il richiamo alla dignità, che è stato un lascito importante del costituzionalismo del Dopoguerra diventa, per Rodotà, un elemento costitutivo dell’identità personale.
Tutto ciò quando la chirurgia plastica è in grado di cambiare i nostri connotati.
E qui entra in gioco il secondo termine del libro, la dignità, assunta non in maniera generica, ma come un vero principio giuridico. Che ha già trovato spazio nella nostra Costituzione e poi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ma ciò non basta, se si vuol passare dal tempo dell’homo aequalis a quello dell’homo dignus. Il richiamo alla dignità, che è stato un lascito importante del costituzionalismo del Dopoguerra diventa, per Rodotà, un elemento costitutivo dell’identità personale.
 Naturalmente a patto che il concetto stesso di “persona” spezzi il guscio giuridico di matrice romana, per incarnarsi nel corpo vivente di ogni essere umano, senza distinzione di etnia, religione, provenienza.
Naturalmente a patto che il concetto stesso di “persona” spezzi il guscio giuridico di matrice romana, per incarnarsi nel corpo vivente di ogni essere umano, senza distinzione di etnia, religione, provenienza.Anche la questione, largamente discussa, dei beni comuni va inquadrata in questo orizzonte storico, misurata alle drastiche trasformazioni che stiamo vivendo. Solo in questo modo anche il terzo termine in gioco - la vita - può diventare oggetto di una biopolitica affermativa. Rodotà ne offre un esempio illuminante.
Nel 2013 la Corte suprema dell’India ha stabilito che il diritto di una casa farmaceutica di fissare liberamente il prezzo di un farmaco di largo consumo è subordinato al diritto fondamentale alla salute di chi ne ha bisogno. Che prevale sull’interesse proprietario.
Come è noto, a partire dall’entrata in vigore del Codice civile napoleonico, il principio della proprietà è stato sostituito a quello, rivoluzionario, di fraternità, anteponendo la figura del proprietario a quella del cittadino. Che non sia arrivato il momento di riattivare la fraternità ricucendo il filo, spezzato dell’uguaglianza?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
-
POLITICA, CONFLITTO D’INTERESSE, E ... "UNDERSTANDING MEDIA" ("GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE"). I nuovi media non sono giocattoli e non dovrebbero essere messi nelle mani di Mamma Oca o di Peter Pan.
 LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA.
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA.
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!Federico La Sala
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE" - Nella Costituzione senza esserlo. Il destino ambiguo del Concordato. Nel saggio di Daniele Menozzi (Carocci) la storia di come la Carta regolò i rapporti tra Stato e Chiesa.30 marzo 2018, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ... *
Diritto
Nel saggio di Daniele Menozzi (Carocci) la storia di come la Carta regolò i rapporti tra Stato e Chiesa
Nella Costituzione senza esserlo. Il destino ambiguo del Concordato
I tessitori. Dossetti e Togliatti con il liberale Lucifero trovarono la soluzione sancita nell’articolo 7
di Roberto Finzi (Corriere della Sera, 30.03.2018)
Non c’è dubbio che tra i «principi fondamentali» che reggono la nostra Repubblica racchiusi nei primi dodici articoli della Carta del 1948 (cui Carocci dedica una serie diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati) il più controverso sia stato (in parte continui a essere) l’articolo 7 o meglio, e soprattutto, il primo asserto del suo secondo comma. Se, al di là delle sfumature, ogni forza politica e ogni cittadino, poteva ammettere che «lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» perplessità e opposizioni nascevano e continuarono dalla affermazione che seguiva: «I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi», firmati, come si sa, da Benito Mussolini e dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri l’11 febbraio 1929, regnante Achille Ratti, Papa Pio XI. Sanavano la «questione romana» apertasi con la presa di Roma. Con accordi e norme complicate tra cui due particolarmente odiose per un Paese che - dopo un decennio di guerre e la doppia occupazione nazista e alleata - si era scrollato di dosso la dittatura anche attraverso la Resistenza e stava lavorando non solo al ritorno delle civili libertà ma a una democrazia nuova, repubblicana come aveva decretato il voto del 2 giugno 1946.
Si trattava dell’asserto che quella cattolica era la religione «di Stato» e, per la sua pervasività, dell’attribuzione degli effetti civili al matrimonio religioso. Con il paradosso che chi riteneva il matrimonio un sacramento poteva, per le norme del diritto canonico, ottenerne la nullità, riconosciuta poi dallo Stato e chi invece aveva del matrimonio una concezione puramente civile era destinato a essere legato a vita, indissolubilmente, non per diretta conseguenza dei Patti, ma per la coincidenza nella visione della famiglia tra Chiesa e fascismo. Nel quadro per di più di un diritto di famiglia in cui era sancita una netta subordinazione della donna.
Nella sua ricostruzione del formarsi del dettame costituzionale e poi dei suoi effetti nella vita democratica italiana ( Art.7. Costituzione italiana ), Daniele Menozzi non nega le conseguenze negative del permanere di quelle norme specie nel quindicennio successivo alla emanazione della Carta Costituzionale. Ci offre però una chiave di lettura della formazione e del senso della norma più articolata, che affonda le sue radici nella complessità del problema cattolico nella storia dell’Italia unita e soprattutto a quel punto della vicenda del nostro Paese.
La Chiesa, lo dimostreranno le successive elezioni del 18 aprile 1948, aveva ancora un forte ascendente sulla popolazione ed era una Chiesa che, seppure - si vedrà di lì a poco - intimamente percorsa da interne pulsioni verso il nuovo, era ancora fortemente contraria al mondo moderno e alle sue forme politiche. In particolare a quelle di matrice socialista e comunista. Ora, si trattava, in sostanza - spiega Menozzi con precisione e acribia filologica - di attirare, per così dire, la Chiesa verso la accettazione piena di quella democrazia che si andava delineando nel lavoro della Costituente, cedendo in via formale alle sue richieste anche se nell’immediato contraddittorie con quella visione.
Protagonista di questa operazione complicata e sottile fu in primis Giuseppe Dossetti che univa alla sua profonda fede cristiana una visione non ierocratica della Chiesa, la competenza giuridica del canonista di vaglia, cristalline convinzioni democratiche, saldi legami con le altre culture politiche formatisi nella Resistenza. Dossetti trovò una sponda in Palmiro Togliatti, a lungo, e tutt’oggi, accusato di avere, in qualche modo permesso un inquinamento della Costituzione con il riconoscimento nel suo testo dei famigerati Patti Lateranensi.
L’atteggiamento del leader del Pci derivava dal convincimento che nella Repubblica dovessero riconoscersi per davvero tutti gli italiani e pure, dice Menozzi, da considerazioni più immediatamente politiche. Mentre stava costruendo il «partito nuovo» guardava alla possibilità di una adesione al Pci di cattolici. Così temuta dalla Chiesa pacelliana che nel 1949 il Papa scomunicherà i comunisti.
Io aggiungerei due aspetti. Togliatti era ben consapevole di quanto Milovan Gilas nelle sue Conversazioni con Stalin ricorda avergli detto il dittatore sovietico: «Questa guerra (...) è diversa da tutte quelle del passato; chiunque occupa un territorio gli impone anche il suo sistema sociale». E infine la lotta per l’egemonia all’interno della sinistra. In quel campo i socialisti, allora sotto la sigla Psiup, erano ancora, seppure non di molto, maggioritari rispetto al Pci.
Per ben intendere la vicenda al quadro manca un tassello. Decisivo. Si tratta della seconda parte del secondo comma dell’articolo 7 che recita: «Le modificazioni dei Patti (Lateranensi), accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». In tal modo si eliminava una delle più forti obiezioni all’inserimento dei Patti in Costituzione. Per tale via infatti non venivano «costituzionalizzati» ché la loro modifica poteva avvenire per legge ordinaria. L’artefice di questo accorgimento essenziale fu Roberto Lucifero, liberale e monarchico.
Così l’articolo, nota Menozzi, «appariva formulato con il concorso di tre diverse famiglie politiche: la democristiana, la comunista e la liberale».
La «non costituzionalizzazione» dei Patti - in un modo profondamente cambiato all’interno e soprattutto all’esterno della Chiesa - sarà uno degli elementi che permetterà all’Italia l’adozione formale, prima sul terreno parlamentare e quindi - con i referendum del 1974 e del 1981 - attraverso la conferma popolare di decisive riforme come il divorzio e l’interruzione volontaria di gravidanza. E del nuovo diritto di famiglia.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
 LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
 CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e la testimonianza di venti cristiani danesi
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
Federico La Sala
- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO. - La bilancia della giustizia. Ripensare lo spazio politico in un mondo globalizzat (Nancy Fraser).10 marzo 2018, di Federico La Sala
N. Fraser, Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World, Polity Press, Cambridge (UK) 2008, pp. 224, ISBN 978-07456-4486-8 *
di Brunella Casalini (Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale)
Giocando sulla plurivocità semantica del termine inglese "scales", con il titolo Scales of Justice Nancy Fraser evoca due immagini: la bilancia come simbolo classico della capacità della giustizia di agire in modo imparziale e lo spazio cui necessariamente deve far riferimento qualsiasi teoria della giustizia. Sia il concetto di imparzialità sia la dimensione spaziale della giustizia sono oggi oggetto di una contestazione radicale. La contrapposizione tra paradigma redistributivo e paradigma del riconoscimento si è mossa oltre la problematica della risoluzione equa dello scontro tra rivendicazioni conflittuali; è infatti la sostanza stessa dell’idea di giustizia ad essere messa in discussione da coloro che si dividono sulla priorità di redistribuzione e riconoscimento, presentandole come istanze incommensurabili che non possono trovare risposta semplicemente pesandole sulla stessa bilancia.
 Una teoria della giustizia che tenga conto delle diverse concezioni sostantive della giustizia oggi presenti nel dibattito politico, qualora ritenga che ciascuna di esse colga aspetti importanti e diversi del fenomeno dell’ingiustizia, secondo la Fraser, deve rispondere a due sfide: la prima consiste nel vedere cosa possa essere salvato dell’ideale dell’imparzialità e come esso possa essere riformulato, la seconda nel decidere contestualmente, accettando l’esistenza di una pluralità di prospettive, a quale visione della giustizia dare di volta in volta maggiore attenzione.
Una teoria della giustizia che tenga conto delle diverse concezioni sostantive della giustizia oggi presenti nel dibattito politico, qualora ritenga che ciascuna di esse colga aspetti importanti e diversi del fenomeno dell’ingiustizia, secondo la Fraser, deve rispondere a due sfide: la prima consiste nel vedere cosa possa essere salvato dell’ideale dell’imparzialità e come esso possa essere riformulato, la seconda nel decidere contestualmente, accettando l’esistenza di una pluralità di prospettive, a quale visione della giustizia dare di volta in volta maggiore attenzione.Da Justice Interruptus (1997) all’acceso confronto con Axel Honneth, contenuto in Recognition or Redistribution?, la Fraser ha tentato di superare la contrapposizione tra paradigma del riconoscimento e paradigma redistributivo, mediante due operazioni principali: 1) una teorizzazione del riconoscimento incentrata sulla differenza di status, che tende a separare la politica del riconoscimento dalla politica dell’identità, e a vedere nel mancato riconoscimento un’ingiustizia, un impedimento alla parità partecipativa, e non un ostacolo all’autorealizzazione e una ferita psichica (come nei modelli di Honneth e Taylor); e 2) la formulazione di un dualismo di prospettiva capace di cogliere analiticamente tanto le dinamiche di esclusione connesse alle caratteristiche intrinseche del sistema economico capitalistico quanto quelle legate al sistema simbolico-culturale, così da poter proporre soluzioni di volta in volta diverse a seconda delle specifiche condizioni di particolari gruppi sociali e dei presupposti necessari a garantire la parità partecipativa.
Accusata di aver dimenticato il ruolo autonomo della sfera politico-giuridica e l’importanza delle discriminazioni che avvengono sul piano prettamente giuridico e politico, a cominciare dal saggio Redefining Justice in a Globalizing World (2005, qui ripubblicato), Nancy Fraser ha posto accanto alla dimensione culturale del riconoscimento e alla dimensione economica della redistribuzione, una terza dimensione specificamente politica: la dimensione della rappresentanza.
 Il criterio della rappresentanza risponde a una questione decisiva oggi nei dibattiti intorno alle diverse teorie della giustizia, dibattiti che non vertono più sul "che cosa" la giustizia deve riconoscere, ma sempre più su "a chi" deve riconoscerlo, su quali sono e come si determinano i confini della comunità cui una teoria della giustizia intende applicarsi.
Il criterio della rappresentanza risponde a una questione decisiva oggi nei dibattiti intorno alle diverse teorie della giustizia, dibattiti che non vertono più sul "che cosa" la giustizia deve riconoscere, ma sempre più su "a chi" deve riconoscerlo, su quali sono e come si determinano i confini della comunità cui una teoria della giustizia intende applicarsi.La theory of justice as parity of participation della Fraser viene così a configurarsi come una teoria tridimensionale, che costituisce una sorta di ripresa e revisione della triade weberiana di classe, status e partito - cui, del resto, l’autrice esplicitamente si è richiamata fin dall’inizio nella sua ridefinizione del paradigma del riconoscimento.
 L’aggiunta della terza dimensione appare inscindibile dall’attenzione per la questione del framing, dell’inquadratura dello spazio entro cui si pongono problemi di giustizia. In un contesto post-socialista, post-fordista e soprattutto post-westphaliano le ingiustizie sono insieme incentrate su questioni di misrecognition, misredistribution e misframing. Distribuzione e riconoscimento potevano essere considerate come le due dimensioni cruciali della giustizia finché il quadro di riferimento dello stato-nazione era dato per scontato.
L’aggiunta della terza dimensione appare inscindibile dall’attenzione per la questione del framing, dell’inquadratura dello spazio entro cui si pongono problemi di giustizia. In un contesto post-socialista, post-fordista e soprattutto post-westphaliano le ingiustizie sono insieme incentrate su questioni di misrecognition, misredistribution e misframing. Distribuzione e riconoscimento potevano essere considerate come le due dimensioni cruciali della giustizia finché il quadro di riferimento dello stato-nazione era dato per scontato.
 Con la globalizzazione e la contestazione della cornice keynesiano-westphaliana, la dimensione politica emerge come la terza dimensione fondamentale nell’ambito delle teorie della giustizia. Domanda cruciale diviene infatti se la teoria della giustizia debba continuare a muoversi nello spazio della cittadinanza nazionale, se debba divenire cosmopolitica o se debba venire a riguardare le "comunità transnazionali del rischio".
Con la globalizzazione e la contestazione della cornice keynesiano-westphaliana, la dimensione politica emerge come la terza dimensione fondamentale nell’ambito delle teorie della giustizia. Domanda cruciale diviene infatti se la teoria della giustizia debba continuare a muoversi nello spazio della cittadinanza nazionale, se debba divenire cosmopolitica o se debba venire a riguardare le "comunità transnazionali del rischio".
 La Fraser si è sentita inizialmente vicina alle posizioni di coloro che - come Iris Marion Young - hanno cercato di arrivare alla formulazione di una concezione transazionale mediante l’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia in base al c.d. "all affected principle", ovvero in base ad un principio che fa riferimento alla possibile co-implicazione oggettiva di soggetti anche lontani tra loro in una rete di relazioni causali che può scavalcare i confini nazionali. Ora, Fraser riconosce due limiti a questa soluzione teorica: da un lato, il rimando a reti causali oggettive sembra delegare alle scienze sociali l’individuazione dei soggetti interessati; dall’altro, a causa del paradosso prodotto dal c.d. butterfly principle, per cui siamo tutti influenzati da tutto, rischia di non riuscire a delimitare lo spazio di relazioni sociali rilevanti.
La Fraser si è sentita inizialmente vicina alle posizioni di coloro che - come Iris Marion Young - hanno cercato di arrivare alla formulazione di una concezione transazionale mediante l’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia in base al c.d. "all affected principle", ovvero in base ad un principio che fa riferimento alla possibile co-implicazione oggettiva di soggetti anche lontani tra loro in una rete di relazioni causali che può scavalcare i confini nazionali. Ora, Fraser riconosce due limiti a questa soluzione teorica: da un lato, il rimando a reti causali oggettive sembra delegare alle scienze sociali l’individuazione dei soggetti interessati; dall’altro, a causa del paradosso prodotto dal c.d. butterfly principle, per cui siamo tutti influenzati da tutto, rischia di non riuscire a delimitare lo spazio di relazioni sociali rilevanti.
 Per ovviare a questi inconvenienti, l’autrice propone quale alternativa il c.d. all subjected principle, in base al quale chi è soggetto ad una data struttura della governance (concepita in senso lato in modo da poter comprendere non solo gli stati, ma anche, per esempio, le organizzazioni non governative e agenzie come il WTO e il IMF), ha diritto ad essere riconosciuto come destinatario di giustizia da parte di quella medesima struttura. Il principio all subjected individua non un unico "chi" destinatario della giustizia, ma una pluralità di "chi" collocati a livello locale, nazionale, regionale e, in alcuni casi, globale.
Per ovviare a questi inconvenienti, l’autrice propone quale alternativa il c.d. all subjected principle, in base al quale chi è soggetto ad una data struttura della governance (concepita in senso lato in modo da poter comprendere non solo gli stati, ma anche, per esempio, le organizzazioni non governative e agenzie come il WTO e il IMF), ha diritto ad essere riconosciuto come destinatario di giustizia da parte di quella medesima struttura. Il principio all subjected individua non un unico "chi" destinatario della giustizia, ma una pluralità di "chi" collocati a livello locale, nazionale, regionale e, in alcuni casi, globale.L’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia transazionale può avvenire soltanto lasciando voce alla contestazione e al dialogo ai diversi livelli e creando canali istituzionali formali che consentano di arrivare a decisioni vincolanti. In questa direzione, la Fraser guarda al ruolo che rivestono oggi i movimenti sociali globali: la loro contestazione del quadro westphaliano è insieme un modo per rivendicare il diritto a determinare il "chi" della giustizia e il "come" arrivare alla sua definizione.
 Sbagliano tuttavia, secondo la Fraser, i sostenitori delle visioni populiste, à la Negri e Hardt, che collocano il nesso contestazione/decisione nella società civile, perché le formazioni presenti nella società civile non sono da sole capaci di trasformare le loro proposte in decisioni politiche stringenti e perché esse mancano di rappresentatività e democraticità per poter rivendicare il diritto a ridisegnare i confini della giustizia. Una giustizia transnazionale richiede adeguati canali istituzionali che rispondano alla società civile, ma funzionino al tempo stesso secondo eque procedure e un sistema di rappresentanza che ne assicuri il carattere democratico dando legittimità alle decisioni prodotte. I tratti delle nuove sfere pubbliche transnazionali e delle nuove istituzioni democratiche globali rimangono, tuttavia, al momento, estremamente vaghi nel disegno della Fraser, che evita qui, per altro, di confrontarsi criticamente con le istituzioni sovranazionali esistenti, con i loro limiti e le loro possibilità di riforma.
Sbagliano tuttavia, secondo la Fraser, i sostenitori delle visioni populiste, à la Negri e Hardt, che collocano il nesso contestazione/decisione nella società civile, perché le formazioni presenti nella società civile non sono da sole capaci di trasformare le loro proposte in decisioni politiche stringenti e perché esse mancano di rappresentatività e democraticità per poter rivendicare il diritto a ridisegnare i confini della giustizia. Una giustizia transnazionale richiede adeguati canali istituzionali che rispondano alla società civile, ma funzionino al tempo stesso secondo eque procedure e un sistema di rappresentanza che ne assicuri il carattere democratico dando legittimità alle decisioni prodotte. I tratti delle nuove sfere pubbliche transnazionali e delle nuove istituzioni democratiche globali rimangono, tuttavia, al momento, estremamente vaghi nel disegno della Fraser, che evita qui, per altro, di confrontarsi criticamente con le istituzioni sovranazionali esistenti, con i loro limiti e le loro possibilità di riforma.* La bilancia della giustizia. Ripensare lo spazio politico in un mondo globalizzato di Nancy Fraser edito da Pensa Multimedia, 2012.
-
> LA COSTITUZIONE, "I DUE CORPI DEL RE", E I DUE PATTI DEL CITTADINO -- GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ” E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO6 marzo 2018, di Federico La SalaMEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO...
 GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO.
GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO.
 Di Gioacchino se si è conservato memoria del suo lavoro come del suo messaggio, lo si deve sicuramente alla sua "posterità spirituale" - è da dire con H. De Lubac, ma contro lo stesso De Lubac (...)
Di Gioacchino se si è conservato memoria del suo lavoro come del suo messaggio, lo si deve sicuramente alla sua "posterità spirituale" - è da dire con H. De Lubac, ma contro lo stesso De Lubac (...)
-
> LA COSTITUZIONE E I "DUE CORPI DEL RE" - DEL CITTADINO. -- ELEZIONI 4 MARZO 2018. Partiti e candidati. Il valore di chi è più capace (di Sabino Cassese)27 febbraio 2018, di Federico La Sala
Partiti e candidati
Il valore di chi è più capace
di Sabino Cassese (Corriere della Sera, 27.02.2018)
Per il prossimo 4 marzo circa 50 milioni di italiani sono chiamati al voto. Questo - lo dice la Costituzione - è un «dovere civico».
Quel voto servirà a scegliere i membri del Parlamento, non il governo. In una repubblica parlamentare, il popolo elegge chi dovrà esercitare il potere legislativo, non chi è chiamato a svolgere compiti esecutivi. I sistemi elettorali e la divisione in due grandi forze politiche (centrodestra e centrosinistra), avevano permesso per circa vent’anni di conoscere la sera delle elezioni chi avrebbe governato. L’attuale tripolarismo e la nuova legge elettorale impediranno, di fatto, che questo avvenga.
Nel seggio, i votanti non potranno decidere liberamente chi votare, ma dovranno approvare o respingere le candidature proposte dai movimenti politici. È, quindi, importante sapere come queste siano state selezionate, quale è stato l’equilibrio tra popolarità, esperienza, legame con il «territorio» (cioè con un collegio elettorale), rappresentanza della «società civile», che le forze politiche hanno stabilito.
Di tutto questo sappiamo poco, ma possiamo evincere alcuni elementi da uno studio dell’Istituto Cattaneo sulle pluricandidature e sul ricambio dei candidati. Alle molto temute pluricandidature, le forze politiche hanno fatto ricorso con moderazione: solo un sesto dei candidati è nelle liste di più di un collegio.
Questo vuol dire che non c’è stato quello strapotere delle segreterie dei partiti o dei leader, che prima si temeva, nel collocare i candidati preferiti in più posti, per assicurarne l’elezione.
Altro elemento importante è il ricambio della classe politica (almeno, per ora, quello «in entrata», perché solo al termine delle elezioni potremo misurare quello «in uscita»). Oltre il 75 per cento dei candidati nei collegi uninominali non ha mai seduto in Parlamento (ma la percentuale varia molto da partito a partito). Il 79 per cento dei candidati nei collegi plurinominali non è stato in precedenza parlamentare (ma i «nuovi» sono per lo più nelle posizioni ultime delle liste, e quindi il numero dei volti nuovi è destinato ad essere ridimensionato dopo le elezioni).
Questo ricambio ha un aspetto positivo ed uno negativo. Ci si può aspettare che il prossimo Parlamento avrà molti volti nuovi, perché molti volti vecchi non hanno meritato. Dai candidati nuovi ci si può anche attendere molta inesperienza: occorrerà che essi si «facciano le ossa». Tanto più che un ricambio così forte si aggiunge al ricambio degli anni precedenti, mentre un certo grado di «professionismo» politico è necessario. Non va dimenticato che non esistono più i partiti di una volta, i partiti-macchina, quelli che servivano a selezionare, formare, promuovere, una classe politica, dal basso, fino ai livelli più alti.
Tra i candidati, il corpo elettorale (i votanti) dovrà scegliere. Il criterio di questa scelta, dicevano i costituenti americani alla fine del ’700, è «quello di assicurarsi come governanti uomini dotati di molta saggezza per ben discernere, e molta virtù per perseguire il bene comune della società» («Il federalista» n. 57). Uno dei padri fondatori dello Stato italiano, Vittorio Emanuele Orlando, scriveva nel 1889 che l’elezione è «una designazione di capacità», perché l’esercizio delle funzioni pubbliche «spetta ai più capaci».
Si è, invece, diffusa l’idea che i parlamentari non vadano scelti per le loro qualità e per lo scrupolo negli impegni che prendono, perché basta che ascoltino il proprio elettorato. Chi pensa questo non sa che i Parlamenti discutono prima di votare, che la maggior parte del loro lavoro si svolge in commissione, che i rappresentanti del popolo non sono macchinette per votare ma esseri pensanti, che debbono discutere, soppesare le varie opzioni, convincersi, prima di decidere.
Un grande uomo politico inglese, e uno dei più acuti osservatori dello sviluppo della democrazia, Edmund Burke, disse nel 1774 ai suoi elettori di Bristol che il Parlamento non è un «congresso di ambasciatori d’interessi diversi, l’un l’altro ostili», che agiscono come mandatari, e che la legislazione è questione di ragione e di discernimento e i deputati non possono essere teleguidati da un mandato imperativo dei loro elettori. Questo è ancor più vero in Italia, dal momento che il Parlamento invade continuamente l’area di azione del governo e dell’amministrazione, nella quale sono necessarie competenza, esperienza e preparazione tecnica.
Insomma, se chiediamo all’idraulico o al falegname, al chirurgo o all’ingegnere che sappiano fare (e bene) il loro mestiere, perché la competenza non dovrebbe essere uno dei criteri per scegliere coloro che debbono svolgere una funzione molto più importante e gravida di conseguenze per la collettività, di quella del falegname, dell’ingegnere, del medico? La politica non è e non dovrebbe essere un mestiere, perché essere eletti deputati non vuol dire trovare un impiego e non è auspicabile che i politici siano tali a vita. Tuttavia, essa è una professione, ed è anche una professione difficile, che bisogna imparare e saper esercitare.
-
> LA COSTITUZIONE E I "DUE CORPI DEL RE" - DEL CITTADINO. --- IL SOLENNE ADDIO DI CUBA A FIDEL CASTRO. La scomparsa del Capo (di Marino Niola)29 novembre 2016, di Federico La Sala
LA DIGNITA’ NON MUORE MAI
- "I DUE CORPI DEL RE" - E DI OGNI ESSERE UMANO. La lezione di Dante, Kantorowicz, Freud e Mandela ...
- DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. --- KANTOROWICZ, UN GRANDE LETTORE DI DANTE.
- LA COSTITUZIONE E I "DUE CORPI DEL RE" - DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
La storia Come nelle antique esequie reali, un autentico teatro sacralizza l’ultimo viaggio del Comandante
La scomparsa del Capo
Così l’isola celebra l’apoteosi dell’ultimo sovrano del secolo breve
di Marino Niola (la Repubblica, 29.11.2016)
HASTA SIEMPRE Comandante. Ieri in Plaza de la Revolución è cominciato il solenne addio di Cuba a Fidel Castro. Una folla oceanica sfila davanti all’urna con le ceneri del Líder Máximo, circondata da un picchetto d’onore di militari in alta uniforme e sovrastata da una sua foto in bianco e nero. Il lutto per l’ultima icona del Novecento durerà nove giorni. E culminerà il 4 dicembre a Santiago, città madre della rivoluzione, da dove nel 1959 partì la marcia vittoriosa della Carovana della Libertad. Il compagno presidente riposerà a Santa Ifigenia, il cimitero dei padri della patria, accanto a José Marti, il liberatore di Cuba dalla colonizzazione spagnola e a Compay Segundo, l’entrañable presencia del Buena Vista Social Club, che toccava la chitarra con la grazia di un Orfeo tropicale.
Adesso un’isola senza voce e senza musica si prepara a celebrare l’apoteosi laica dell’ultimo sovrano del secolo breve. E lo fa ricorrendo a una simbologia millenaria che, sin dai tempi degli imperatori romani, fa della scomparsa del capo, un autentico teatro della morte. Una grande drammatizzazione dello scarto che sussiste tra l’immortalità del potere e la mortalità dell’uomo che lo incarna. Quello stesso scarto che separa le ceneri di Fidel dalla gigantografia dell’eroe rivoluzionario. I resti mortali dell’uomo dalla sua effigie immortale. Che, ora come allora, serve a rappresentare e garantire la continuità del potere e dunque la continuità della vita di tutti.
Nel Medio Evo, un’autorevole dottrina politica, destinata a sopravvivere fino alla fine delle monarchie assolute, accreditava ai regnanti due nature, a immagine e somiglianza di Cristo. È la cosiddetta teoria dei due corpi del re, secondo la quale il sovrano possiede sia un corpo fisico, che palpita, sanguina, si ammala, muore. Sia un corpo politico, che coincide con la sua nazione e il suo popolo, di cui è il simbolo supremo. Questa seconda natura invece è considerata immortale. La simbiosi tra queste due facce della sovranità rendeva indispensabile scongiurare in tutti i modi il contagio di malattie e lo stesso invecchiamento del re, perché l’indebolirsi del suo organismo fisico non contagiasse l’organismo sociale. Perché in un certo senso l’uomo può morire, ma lo Stato assolutamente no. Tanto che nella Francia e nell’Inghilterra rinascimentali per esorcizzare il pericolo dell’interregno, cioè del vuoto di potere che si apriva alla morte del sovrano, si nutriva e si trattava come persona viva un simulacro del defunto, una sorta di manichino regale, fino all’incoronazione del successore. Insomma, il re è morto, viva il re!
Si trattava di una sorta di transfert simbolico dal potere verso l’immagine. Come dire che la mano del defunto non ha più la forza di reggere lo scettro, ma non ha ancora lasciato la presa. Paradossalmente per allungare la vita del morto, ogni giorno veniva visitato dai medici il suo avatar, fatto di cera o di cuoio, che per tutta la durata del periodo di lutto ne constatavano il peggioramento. Come se il cadavere fosse ancora gravemente ammalato, ma non spirato. Questa messa in scena si chiamava funus imaginarium, ovvero funerale dell’immagine. Un rito che prevedeva una lunghissima processione attraverso l’intera nazione, durante la quale i due corpi del sovrano erano inseparabili. Il climax veniva raggiunto con il rogo finale del fantoccio su una pira di aromi e incensi, che trasportavano l’immagine del sovrano in cielo tra gli dei. Solo allora il re veniva dichiarato morto. E sepolto.
Il caso più celebre è quello del funerale di Francesco I di Francia, avvenuto nel 1547 e che durò alcuni mesi, perché il feretro regale doveva toccare tutte le città più importanti e non poteva saltarne nemmeno una, senza provocare una rivolta popolare.
Questa necessità di sospendere il tempo prima della sepoltura trova la sua spiegazione nel fatto che il rito funebre ha un fortissimo senso politico, sociale, culturale. E soprattutto emotivo. In questo senso l’urna cineraria del Jefe Máximo toccherà insieme alle città e ai villaggi, anche e soprattutto i cuori del suo popolo. Anche perché l’itinerario ripercorre a ritroso il cammino dei barbudos. È un ritorno nel ventre materno della revolución. Che torna sui suoi passi. Fino a quella prova generale che è stato l’assalto fallito alla caserma Moncada di Santiago del 26 luglio del 1953, quando Fidel lanciò il primo guanto di sfida a Fulgencio Batista.
Insomma proprio come nelle antiche esequie reali, e come nelle processioni delle icone religiose, l’ultimo viaggio del Comandante sacralizza un percorso che è fatto di spazio e di tempo, di sentimenti e di avvenimenti. Così il corpo cremato del capo riassume insieme la storia e la geografia dell’isola. Con un rituale solenne che chiude per sempre una pagina memorabile del Novecento e al tempo stesso ne apre una nuova.
-
> LA COSTITUZIONE E I "DUE CORPI DEL RE" - DEL CITTADINO. --- E I DUE CORPI DELLA REGINA. Come Elisabetta I d’Inghilterra inventò la rappresentazione della politica al femminile (di Nadia Fusini)29 maggio 2015, di Federico La Sala
Così una regina cambiò sesso alla parola potere
Come Elisabetta I d’Inghilterra inventò la rappresentazione della politica al femminile
di Nadia Fusini (la Repubblica, 28.05.2015)
- IL CONVEGNO A PISA Domani alla Scuola Normale Superiore di Pisa (ore 10) Donne e sovrane . Interverranno oltre a Nadia Fusini, di cui anticipiamo l’intervento, Lina Bolzoni, Monica Centanni, Benedetta Craveri, Manuela Fraire, Bahiyyih Nakhjavani, Victoria Rimell, Massimo Stella, Andrea Torre
NELLA storia e nel mito, nella realtà e nella leggenda, le donne sono state sovrane, hanno stretto nelle loro mani i simboli del potere. Ma hanno inventato un nuovo gesto? Una donna al comando si ispira a modelli diversi rispetto a un uomo? E oggi che alle donne sono aperti i luoghi del potere, le donne che vi giungono sanno di portare con sé una differenza, non singolare, ma di genere? Elisabetta I Tudor lo sa. Lo dimostra nel modo della costruzione del suo corpo simbolico, come ad esempio nel “ritratto dell’Armada”, in cui si celebra il trionfo sulla Spagna.
Quando dall’alto della costa dell’Essex, a Tilbury, Elisabetta vide la possente e magnifica flotta di Filippo II veleggiare in mare aperto, pronta a perpetrare quello che nella sua esaltazione della verginità, lei viveva come uno stupro, ebbe paura, forse. Però era lì, rivestita di una posticcia armatura guerresca, a cavallo di un bianco destriero.
Elisabetta era venuta tra il suo popolo in armi; senza esitazione s’era lanciata nel campo di battaglia, sito privilegiato della storia patriarcale. Come il padre Enrico VIII anni prima aveva assicurato al Parlamento che avrebbe in ogni cosa “messo in gioco” la sua persona, allo stesso modo Elisabetta ora è pronta a rischiare “il sangue regale”. Non nasconde la sua differenza, anzi, la denuncia: «so di avere un corpo di donna fragile e delicato», poi fa una pausa, di indubbia efficacia retorica, e aggiunge: «ma ho lo stomaco e il cuore di un re, e di un re d’Inghilterra ». Nomina due organi, il cuore, sede del coraggio, e lo stomaco, e cioè la pancia, come se lì si collocasse la capacità biologica, neutra - una potenza d’organo, capace di digerire e tenere fronte agli eventi. Non dice “grembo”, termine più femminile per indicare l’addome; dice appunto “stomaco”, che è assai virile.
Quand’ecco che un uragano arruffa le onde, e quelle tramutano in pareti d’acqua, che inghiottono i sontuosi vascelli. Si leva una tempesta - propizia per la sua causa e per il suo popolo, e l’Invincibile Armata sparisce tra i flutti. È la conferma del credo che nessuno mai potrà violare il corpo dell’isola, né quello della regina, che si fondono nella stessa iniziale, la Edi Elizabeth valendo come la E iniziale di England - lettera che la regina ha fatto miniare con lo stesso identico ricamo sulle sue vesti.
Come altrimenti interpretare la provvidenziale tempesta, se non come la prova provata dell’impenetrabilità dell’isola? È un fatto che se all’immagine dell’isola Elisabetta ha sempre associato un’idea di purezza, di non contaminazione, di perfetto e assoluto controllo dei confini, dopo Tilbury il motivo diventerà un tema profondo della sua regalità, una immagine sacra, quasi un ta- lismano magico.
Elisabetta diventa nell’immaginazione popolare la stessa cosa della terra su cui regna, l’isola impenetrabile che il mare difende, quasi fosse un vallo, dall’invidia delle nazioni meno felici, perché “non elette”. Così recita la propaganda, e la parola fa da spia all’orgoglio della fede riformata, che si rappresenta in Elisabetta Rex.
Se nei ritratti, nelle medaglie, nelle incisioni volte a diffondere all’epoca la fede nella efficacia del simbolo regale, la magnificenza del padre Enrico VIII è esaltata nella potenza muscolare del maschio; se, come nel celebre ritratto di Holbein, il diritto di Enrico a regnare è confermato dalla virilità della gonfia brachetta, il diritto di Elisabetta sempre più si confonde con la sua sessualità mistica, verginale. Al posto della gonfia brachetta, il ritratto dell’Armada esibisce una perla gigantesca. Alla base del triangolo che dal seno e dalla vita scende sul grembo, lo sguardo è condotto sulla perla della regina. Le perle sono dappertutto; chiudono la veste, stringono il corpetto, decorano la fronte. Ma sulla fronte e sul sesso spiccano le più grandi: enormi gemme che definiscono Elisabetta Rex come una creatura impermeabile, impenetrabile, potente perché inviolabile. Una donna al potere genera angoscia, una donna sul trono non fa parte delle idee condivise, che si sostengono alla tradizione. Secondo una immagine paolina, molto attestata nelle letture bibliche della religione riformata, e secondo una pratica intesa al sesso riproduttivo, l’unico giustificato sempre dallo stesso punto di vista, la donna deve stare sotto, non sopra.
Il miracolo di Elisabetta è che una volta sul trono, riuscirà in un paradosso: si creerà una “persona”, e cioè una maschera che incorpora il “corpo politico” idealizzato del padre, senza però nascondere i propri attributi femminili. Compone così un ibrido, è Re e regina insieme, è due in uno. Vede chiaramente il suo ruolo di governante come un ruolo maschile, che però, proprio perché un ruolo, anche lei, che è donna, può recitare - allo stesso modo delle eroine delle commedie shakespeariane, Porzia del Mercante, Viola nella Dodicesima notte . Non ha il principe un corpo doppio? un corpo sessuale e un corpo simbolico? un corpo fisico e un corpo metafisico? un corpo di carne e sangue e un corpo spirituale, come un arto fantasma? Non è forse il corpo del re questa meraviglia di un costrutto biosimbolico capace di trascendenza? di metamorfosi? o transustanziazione?
Se questo valeva per il corpo infantile di Edoardo, e prima ancora per il corpo gracile di Riccardo II, principe con il quale Elisabetta sente una strana consonanza, perché non può valere per il suo corpo naturale, che è quello fragile di una donna? Elisabetta è coraggiosa come un leone, scaltra come una volpe e soprattutto è una incomparabile teatrante. E sa sostenere lo sguardo sul mistero del potere: chiunque lo detenga, uomo o donna che sia, il potere sempre ha bisogno della mistificazione e dell’inganno. Diventa nell’immaginazione popolare la stessa cosa della terra su cui regna, l’isola impenetrabile che il mare difende.
-
> LA COSTITUZIONE E I "DUE CORPI" DEL RE-CITTADINO. ---- La politica del pancione (di Barbara Spinelli).7 settembre 2008, di Federico La Sala
La politica del pancione
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 7/9/2008)
D’un tratto in politica s’accampa un Nuovo che scompiglia ogni cosa, che promette addirittura di ricominciare il mondo. Il Nuovo è il corpo del candidato, e non del solito candidato ma del candidato-donna. E neppure di una donna che ha speciali esperienze: quando i giornali americani scrivono che con Sarah Palin «è nata una stella» alludono a un candidato forte perché enormemente simile a tutte le donne e alla loro vita quotidiana, fatta di tanti bambini, tante famiglie accidentate. È la prima volta e questa formula («È la prima volta») ha le virtù d’un mantra: è un cumulo di sillabe che protegge con magica efficacia.
Tutto sembra tramutarsi in mantra, non appena sul palcoscenico fa irruzione la biologia femminile: non intercambiabile con quella dell’uomo, perciò primeva, inaugurale. Nel rifare il mondo, la donna può anche ricorrere all’arma suprema, all’atomica che dissuade l’avversario azzittendolo. Mette in mostra, modernamente disinibita, quel che ancor ieri era intimo: la pancia incinta, dunque il rapporto primordiale con la vita e la morte. Giacché questa è la politica al grado zero: vita o morte, pace o guerra, tutto o nulla. Nella favola di Esopo erano le membra del corpo che si ribellavano alla pancia oziosa. Adesso fa secessione la pancia, reclama il primato assoluto.
C’erano una volta due corpi del Re - accadeva nelle monarchie medievali descritte da Kantorowicz negli Anni 50: il corpo mortale e quello eterno, santo, che raffigura l’istituzione e la Corona e s’incarna in questo o quel re. Ora s’aggiunge un terzo corpo: la pancia incinta che la donna politica, non senza cinismo, eleva come trofeo. La pancia della diciassettenne Bristol, figlia della candidata alla vice presidenza. O la pancia del ministro della giustizia Rachida Dati, in Francia. Un mistero circonda quasi sempre il Terzo Corpo. Il padre è figura secondaria: trascurabile nel caso di Bristol Palin, incerta per Rachida Dati. Il Mondo Nuovo non appartiene ai padri. In questi giorni in America è nata una santa, oltre che stella: il ventre immemorialmente è benedetto. Il corpo politico, chiamato per secoli body politic perché paragonato all’organismo umano, diventa body e null’altro, senza più i parafernali della politica.
In realtà quest’irrompere del corpo non è nuovo. Accadde all’inizio del ’900, quando si cominciò a paragonare le virtù dello sportivo con quelle dell’intelligenza o dello spirito. Robert Musil costruisce un romanzo su questa scoperta: improvvisamente l’Uomo Senza Qualità s’accorge che lo spirito del tempo (lo spirito della comunità) esalta il corpo come la cosa più autentica dell’uomo. Ulrich lo annuncia a Diotima, la cugina borghese che di autenticità è insaziabilmente affamata: «Dio, per ragioni che non ci sono ancora note, sembra aver inaugurato un’epoca della cultura del corpo; perché l’unica cosa che in qualche modo sostiene le idee è il corpo, cui esse appartengono». Aprendo il giornale, un mattino, Ulrich s’imbatte sulla vittoria di un «geniale cavallo da corsa». Il corpo (animale o femminile) ha occupato l’intera scena, divorando la genialità letteraria o politica: è diventato totem, simbolo soprannaturale in cui il clan si identifica. Basta dire corpo di donna ed è Mondo Nuovo, Moderno. Non importa quel che la donna fa: conta l’apparire corporeo, con cui il suo essere coincide perfettamente specie quando la pancia ne è sintesi e apoteosi.
Eventi simili non cadono dal cielo. Hanno antecedenti. In principio c’è un ammalarsi della politica, della democrazia, non per ultimo dei mezzi di comunicazione. Basta sfogliare i giornali, non solo in America, e si vedranno analoghe fatali attrazioni per ciò che è considerato autentico nell’uomo politico. In Italia non avremo forse l’infame curiosare su una diciassettenne incinta, ma lo spazio è egualmente invaso dal gossip, dalla cronaca rosa oltre che nera. Perfino la critica letteraria è spesso solo rosa. Attrae il privato dei politici, in particolare se donne. Si fruga nelle loro vite, nelle pance, come i rotocalchi che spiano divi e sportivi. Da tempo diminuiscono i giornalisti che indagano su altro che questo, con la stessa continuità. In Francia questa metamorfosi si chiama pipolisation: dai rotocalchi people emulati da giornali e tv. Il fenomeno concerne inizialmente sia uomini che donne. Sarkozy ha sfoggiato i propri matrimoni. Ancor prima s’è distinto Berlusconi: il corpo, i capelli, la prestanza fisica sono stati sue sciabole. I giornali si sono adattati al gusto del tempo, al finto realismo che inghiotte il reale.
La donna in politica tende a impigliarsi nella pipolisation: non fosse altro perché viene presentata come nuova e migliore in sé, a prescindere da quello che fa o pensa. Ségolène Royal era ineguagliabile in quanto donna, Hillary Clinton è caduta nella stessa trappola e ora si trova davanti la nemesi che è Sarah Palin. In Italia non è diverso. Di recente, Veltroni s’è augurato un direttore nuovo all’Unità. Non s’è soffermato sulla bravura o non-bravura del direttore Antonio Padellaro, sulla nuova linea che auspicava, sulla vecchia che esecrava. S’è limitato a proferire il mantra, lo scorso 25 maggio sul Corriere della Sera: «Ci vorrebbe una donna alla direzione dell’Unità». Senza spiegare in cosa consistesse l’ancien régime, disse che la rivoluzione era questa. Qualcuno ha commentato, con saggezza: Padellaro era un uomo, purtroppo.
McCain è tutt’altro che maldestro. Adopera la crisi della politica, della democrazia, dei media. Sa di poter contare sull’estensione del gossip, della cultura del corpo. La pancia della povera figlia di Sarah Palin e il corpo del neonato down ostentato nella campagna portano voti, perché riaccendono la guerra culturale che il populismo di destra conduce contro la presunta egemonia della sinistra. Gli studiosi George Lakoff e Thomas Frank denunciano da tempo, in libri e articoli, la fuga della destra nel falso realismo dell’autenticità e nel risentimento dei piccoli verso i forti. È una destra che s’è impossessata di molte bandiere di sinistra: la discriminazione delle piccole città, della povera gente, di chi «non è stato cooptato dall’élite cosmopolita», infine delle donne.
Obama è considerato elitario, cooptato: quindi cosmopolita, non genuinamente americano. Palin invece incarna il nuovo valore dell’Autenticità ed è contro tutte le élite, specie mediatiche. Alla convenzione repubblicana ha entusiasmato: «Ecco una notizia flash per tutti i reporter e commentatori - ha gridato -: vado a Washington non per strappare la loro buona opinione. Vado a Washington per servire il popolo di questo Paese. Non sono parte dell’establishment politico. In questi giorni ho presto imparato che se non sei parte dell’élite, alcuni media non ti considereranno il candidato qualificato». Il politico più seduttore oggi è un maverick: un cane sciolto, una personalità più che una persona. McCain è maverick e anche Sarah Palin perché - così pare - la donna in quanto tale ieri era mobile e oggi è maverick.
La vecchia guerra contro la sinistra dominatrice riprende, e permette a McCain di fingersi nuovo pur continuando Bush. Ma è guerra assai temibile, ricorda Lakoff su Huffington Post: i repubblicani la maneggiano perfettamente da quando Nixon, nel ’69, convocò la maggioranza silenziosa contro il Sessantotto. È guerra che seduce giornali e intellettuali; che ha fatto vincere Reagan e Bush jr. Viene rispolverata ogni volta che i repubblicani, pur di non evocare quel che hanno fatto, si gettano su valori che dividono la sinistra e la intimidiscono sino a incastrarla (famiglia, aborto). Anche l’uso delle donne serve a tale scopo. Se attacchi Sarah Palin sarai accusato di sessismo ed è massima ingiuria. Forse la candidata inciamperà; son numerose le sue azioni passate non pulite. Ma finché resta un totem è vincente, e inattaccabile.