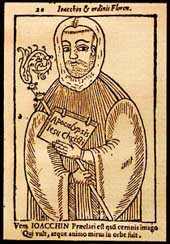
VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e la testimonianza di venti cristiani danesi (ricerca scientifica) - a cura di Federico La Sala
- [...] L’11 marzo 1947 Benedetto Croce esortò l’Assemblea Costituente della nuova Italia a elevare un’implorazione allo Spirito Santo con le parole (così disse) dell’«inno sublime»
Veni creator Spiritus.
 Era una proposta inattesa, tanto più che proveniva da un «laico». Ed era una proposta illuminata: richiamava a tutti la solennità e la rilevanza del momento, suggerendo addirittura di cogliere una certa «sacralità» immanente nell’impresa che si stava affrontando; «sacralità» se non altro nel senso di una prospettiva doverosamente più alta dei pensieri e degli interessi politici, sociali, economici, che parevano occupare in quel contesto l’animo della generalità dei presenti.
Era una proposta inattesa, tanto più che proveniva da un «laico». Ed era una proposta illuminata: richiamava a tutti la solennità e la rilevanza del momento, suggerendo addirittura di cogliere una certa «sacralità» immanente nell’impresa che si stava affrontando; «sacralità» se non altro nel senso di una prospettiva doverosamente più alta dei pensieri e degli interessi politici, sociali, economici, che parevano occupare in quel contesto l’animo della generalità dei presenti.
 Era anche, nei termini in cui veniva formulata, una scelta felice: l’attenzione dell’illustre filosofo si fissava su un canto risonato in tutte le chiese della penisola fin dai primordi di quella coscienza nazionale che era già viva nella nostra storia, secoli e secoli prima dell’unificazione statuale raggiunta sotto dalla monarchia sabauda [...]
Era anche, nei termini in cui veniva formulata, una scelta felice: l’attenzione dell’illustre filosofo si fissava su un canto risonato in tutte le chiese della penisola fin dai primordi di quella coscienza nazionale che era già viva nella nostra storia, secoli e secoli prima dell’unificazione statuale raggiunta sotto dalla monarchia sabauda [...]
 CERVELLO
CERVELLO
 Studio rivela: rivolgersi a Dio
Studio rivela: rivolgersi a Dio
 è come parlare a un amico
è come parlare a un amico
La ricerca su venti fedeli cristiani condotta da Uffe Schjodt, dell’università di Aarhus in Danimarca pubblicato su "New Scientist" *
NON c’è nulla di mistico in una preghiera. Per il nostro cervello rivolgersi a dio è come parlare a un amico in carne e ossa. Un gruppo di scienziati ha infatti esaminato le reazioni cerebrali di un gruppo di fedeli impegnati nella ricerca di un conforto spirituale attraverso un dialogo con dio, scoprendo che si attivano le stesse aree di una normalissima conversazione. Cosa che non capita quando ci si rivolge a Babbo Natale. Mentre quando si recita una preghiera a memoria si attivano esclusivamente le zone adibite alla ripetizione.
Lo studio si è concentrato esclusivamente sulla religione cristiana ed è stato condotto da Uffe Schjodt, dell’università di Aarhus in Danimarca pubblicato sulla rivista Social Cognitive and Affective Neuroscience e riportato sul magazine britannico New Scientist. Gli esperti hanno chiesto ai venti devoti volontari in prima battuta di recitare il Padrenostro o una filastrocca per bambini: in entrambi casi la risonanza magnetica mostra che nel loro cervello si accendono aree associate alla ripetizione.
Poi hanno chiesto loro di parlare con Dio, con preghiere personali, o di parlare con Babbo Natale per esprimere i propri desideri sotto l’albero. In questo caso la risonanza mostra che si accendono le aree della conversazione e che, in particolare, quando ci si rivolge a Dio sono attive anche aree della corteccia prefrontale che servono a capire intenzioni ed emozioni altrui, cosa che succede sempre di fronte a un interlocutore in carne ed ossa. Ciò però non avviene quando si parla con Babbo Natale.
In base a questi risultati, secondo Schjodt rivolgersi a Dio è come parlare con una persona, mentre Babbo Natale non sprigiona gli stessi effetti perché si è consapevoli dell’aspetto simbolico e lo si considera più un "oggetto", il protagonista di una leggenda.
* la Repubblica, 7 aprile 2009
IDEE.
Quando il filosofo esortò l’Assemblea Costituente a cantare il «Veni creator». Una riflessione dell’arcivescovo emerito di Bologna
E Croce invocò lo Spirito
di GIACOMO BIFFI (Avvenire, 08.04.2009) *
L’11 marzo 1947 Benedetto Croce esortò l’Assemblea Costituente della nuova Italia a elevare un’implorazione allo Spirito Santo con le parole (così disse) dell’«inno sublime» Veni creator Spiritus.
Era una proposta inattesa, tanto più che proveniva da un «laico». Ed era una proposta illuminata: richiamava a tutti la solennità e la rilevanza del momento, suggerendo addirittura di cogliere una certa «sacralità» immanente nell’impresa che si stava affrontando; «sacralità» se non altro nel senso di una prospettiva doverosamente più alta dei pensieri e degli interessi politici, sociali, economici, che parevano occupare in quel contesto l’animo della generalità dei presenti.
Era anche, nei termini in cui veniva formulata, una scelta felice: l’attenzione dell’illustre filosofo si fissava su un canto risonato in tutte le chiese della penisola fin dai primordi di quella coscienza nazionale che era già viva nella nostra storia, secoli e secoli prima dell’unificazione statuale raggiunta sotto dalla monarchia sabauda.
Il Veni creator è una composizione del secolo nono, di un autore che non ci è dato identificare con certezza. Di lui si può dire solo che dimostra di stimare e venerare sant’Ambrogio, tanto da ispirarsi a lui e da volerne proseguire il magistero ecclesiale e poetico.
Sant’Ambrogio è stato nel quarto secolo uno degli ultimi e tra i più ammirevoli testimoni della grande civiltà di Roma; dalla cattedra episcopale di Milano ha giovato come pochi altri al bene del nostro Paese. Tanto che un uomo come il conte Silicone (primo collaboratore e apprezzato ministro dell’imperatore Teodosio), quando apprese la probabile imminenza della morte del vescovo, ritenne di poter pubblicamente affermare che «con la dipartita dal corpo di un uomo del suo valore, la rovina avrebbe sovrastato l’Italia» (Paolino, Vita Ambrosii 45, 1: «Tanto viro recedente de corpore, interitus immineret Italiae»).
Ambrogio si è davvero distinto come pastore geniale per la straordinaria efficacia nel governo ecclesiale e per il prestigio del suo magistero. Ma è stato anche il «cantautore dei misteri cristiani», l’inventore degli inni liturgici della Chiesa latina. L’ignoto artefice del Veni creator ha mutuato da lui, oltre che la forma metrica del testo (strofe di quattro dimetri giambici acatalettici), anche la melodia (la stessa che il vescovo di Milano aveva composto per il suo inno In die Paschae). E, quasi a notificare esplicitamente questa sua dipendenza, ha riprodotto alla lettera nel Veni creator due versi di un altro inno ambrosiano (quello natalizio): Infirma nostri corporis - virtute firmans perpeti. Benedetto Croce, come si vede, non avrebbe potuto offrire evocazione più nobile e pertinente di questa.
Lo «storico» invito, che quel giorno ha senza dubbio colpito i rappresentanti del popolo italiano, non ci appare così sorprendente, se pensiamo al fascino che il tema dello «spirito» e lo stesso vocabolo (traduzione del greco pnèuma) - così fortemente presenti nella tradizione ecclesiale fin dalle origini - hanno esercitato su diversi pensatori che, cresciuti e maturati entro la civiltà europea, hanno naturalmente assorbito (anche quando non erano credenti) una cultura profondamente segnata dalle prospettive del cristianesimo.
Sicché dell’idea dello «spirito» essi si sono spesso serviti per dare forma organica ai loro sistemi. Proprio Benedetto Croce aveva qualificato «filosofia dello spirito» la sua costruzione concettuale. Simmetricamente, l’altro eminente protagonista della nostra vita intellettuale nel secolo ventesimo, Giovanni Gentile, assegnava il titolo di Teoria generale dello spirito come atto puro a una delle sue opere più rilevanti e significative.
Ambedue si mantenevano entro il solco tracciato da Georg Friederich Hegel, elaboratore di una «filosofia dello spirito», intesa da lui come «la scienza dell’idea che dal suo essere ’altro’ ritorna in sé».
E già questa locuzione ci dice come si indicasse con la medesima parola qualcosa di ben diverso da ciò che era inteso dalla Rivelazione di Dio culminata in Gesù di Nazaret. Per il cristianesimo lo Spirito non è una «idea» o una suggestiva etichetta speculativa: è una Persona divina; è l’attore efficace della totale trasnaturazione dell’uomo concreto quando è raggiunto dalla misericordia del Creatore; è il principio ontologico di una storia nuova e più vera dell’universo.
Il fascino di cui si parlava è dunque innegabile, ma è, come si vede, un fascino esclusivamente «culturale»: consente a chi vi cede di utilizzare qualcosa della nomenclatura cristiana, evitando però con ogni cura la «fattualità» del messaggio salvifico.
Ci si avvicina in astratto allo «Spirito», ma si resta ben remoti dalla realtà centrale dell’universo, risolutiva per la vicenda umana e per il nostro destino: ben remoti, cioè, dall’evento redentivo della morte e risurrezione dell’Unigenito del Padre, Gesù di Nazaret; «evento» clamorosamente proclamato nella teofanìa della Pentecoste e attualizzato in ogni luogo e in ogni momento nell’esistenza, nella vita, nella storia della Chiesa Cattolica. Per la salvezza dell’uomo non serve la «filosofia dello Spirito»; occorre lasciarsi raggiungere dallo Spirito della verità.
*
 IL LIBRO
IL LIBRO
 La rivoluzione cristiana
La rivoluzione cristiana
Pubblichiamo un estratto dalla prefazione del libro «Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale» (Edizioni Studio Domenicano, pagine 234, euro 12) del cardinale Giacomo Biffi (nella foto), da oggi in libreria, sulla «sola vera rivoluzione, sempre urgente e sempre in atto, capace di rigenerare ogni giorno la vicenda umana: la rivoluzione cristiana, il cammino di santità di ogni donna e di ogni uomo».
 Il Veni Creator Spiritus, in italiano Vieni Spirito Creatore è un inno liturgico dedicato allo Spirito Santo ed attribuito a Rabano Mauro, arcivescovo di Magonza, del IX secolo.
Il Veni Creator Spiritus, in italiano Vieni Spirito Creatore è un inno liturgico dedicato allo Spirito Santo ed attribuito a Rabano Mauro, arcivescovo di Magonza, del IX secolo.
 La versione più conosciuta è quella gregoriana, ma è stato musicato anche da numerosi autori di musica polifonica e classica.
La versione più conosciuta è quella gregoriana, ma è stato musicato anche da numerosi autori di musica polifonica e classica.
 Viene regolarmente cantato nell’ufficio delle Lodi e dei Vespri della festa di pentecoste e viene spesso accostato alla sequenza Veni Sancte Spiritus.
Viene regolarmente cantato nell’ufficio delle Lodi e dei Vespri della festa di pentecoste e viene spesso accostato alla sequenza Veni Sancte Spiritus.
 Oltre che a pentecoste, viene anche cantato in particolari avvenimenti solenni per invocare lo Spirito Santo, quali in occasione del conferimento del sacramento della confermazione, durante l’elezione del nuovo Papa dai cardinali nella Cappella Sistina, per la consacrazione dei vescovi, per l’ordinazione dei sacerdoti, per i concili ed i sinodi e per l’incoronazione di un sovrano. (Wikipedia. Per leggere tutta la scheda, con il testo dell’Inno, clicca sul rosso)
Oltre che a pentecoste, viene anche cantato in particolari avvenimenti solenni per invocare lo Spirito Santo, quali in occasione del conferimento del sacramento della confermazione, durante l’elezione del nuovo Papa dai cardinali nella Cappella Sistina, per la consacrazione dei vescovi, per l’ordinazione dei sacerdoti, per i concili ed i sinodi e per l’incoronazione di un sovrano. (Wikipedia. Per leggere tutta la scheda, con il testo dell’Inno, clicca sul rosso)
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
- VENI CREATOR SPIRITUS [1932]:"[...] La fede nello spirito al contrario deve dispiegarsi in una dottrina dello spirito. Deve rappresentarsi filosoficamente. Questa dottrina dello spirito può essere solo una metafisica dello spirito. Qui non è possibile neppure farvi cenno. Una delle sue parti principali sarà a ogni modo la dottrina della creatività dello spirito. Questo pensiero universale, che si estende a tutti i popoli, ha trovato proprio sul suolo tedesco una potente espressione nell’inno del franco-renano Rabano Mauro Veni creator spiritus. Mille anni più tardi un altro franco-renano, Goethe, ha tradotto questo “splendido canto religioso” e lo ha definito un “appello al genio”. Sotto questo segno la fede nella Germania e la fede nello spirito possono trovarsi legate e confermate"(Ernst Robert Curtius [1932], LO SPIRITO TEDESCO IN PERICOLO - pp. 235-325).
POPULISMO: IL ’GIOCO’ DEL "MENTITORE" ISTITUZIONALIZZATO.
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
- QUESTIONE DI DIGNITA’ UMANA, POLITICA E INTELLETTUALE. PERCHE’ DOBBIAMO DIRCI CRISTIANI E CRISTIANE, MA MAI "CATTOLICI" E "CATTOLICHE". E NON CONFONDERE DA MENTITORI LE PAROLE!!!
 IL "GRANDE RACCONTO" EDIPICO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E’ FINITO.
IL "GRANDE RACCONTO" EDIPICO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E’ FINITO.
FLS
Forum
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. ---- FILOLOGIA, "RELIGIONE DEL DOVERE", E "DIVINA COMMEDIA". Una nota sul "lascito morale di Benedetto Croce".9 febbraio 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA, "RELIGIONE DEL DOVERE", E "DIVINA COMMEDIA":
LA PUNTA FILOSOFICA DI UN ICEBERG COSMOTEANDRICO.
Sul "lascito morale di Benedetto Croce", forse, è opportuno ricordare storiograficamente (filologicamente e antropologicamente) che "la lingua batte dove il dente duole": può essere condivisibile, oggi, la considerazione che “ciò che si richiede e che si ubbidisca ad una necessità morale. La quale comanda che si attenda con ogni rischio, a tutelare gli umani valori e le umane virtù, il rispetto della personalità, il dir no al male e sì al bene, ciò che si chiama insomma il culto della libertà; la quale è il principio direttivo a cui sempre deve si deve far ricorso. Quale che sia lo schema di ciò verso cui il mondo va, quello schema sarà riempito da uomini e sarà reale solo nei pensieri, nei sentimenti e negli atti degli uomini, e avrà quella realtà che essi gli daranno, e tanto migliore quanto migliori quegli uomini. Non vi date dunque pensiero di dove vada il mondo, ma dove bisogna che andiate voi, per non calpestare cinicamente la vostra coscienza, per non vergognarvi di voi stessi” (cfr. Tito Lucrezio Rizzo, "Il lascito morale di Benedetto Croce", L’Opinione delle Libertà, 08 febbraio 2024)?!
All’interno dell’attuale presente storico (dell’Europa del 2024), proprio per non vergognarsi di sé e ri-accogliere come indicazione antropologica piena l’affermazione che «L’uomo morale - affermerà nuovamente il #Croce - è il "Vir bonus agendi peritus", chiamato ad operare nel quotidiano sorretto da una retta #coscienza che ne ispirava l’agire concreto, perseguendo i fini di utilità generale da raggiungere e di cui farsi strumento» (T. L. Rizzo, cit.), non è , forse, necessario re-interrogarsi e re-interpretare il rapporto tra la tradizione greco-romana e la tradizione cristiana (con spirito critico, con le famose "virgolette" crociane, del saggio del 1942), proprio a partire da questa "ovvia" (ma indebita) generalizzazione, in cui l’uomo (#Vir) vale immediatamente come l’Uomo (#Homo), come il #genereumano nella sua totalità (cioè, per l’#uomo e per la #donna, per "Adamo ed Eva", e per "Giuseppe e Maria")?
Non è bene riprendere il filo almeno dalla "Divina Commedia" e reinterrogarsi non solo sul significato della lezione di #Beatrice a #Dante sul senso di quel "sarai meco sanza fine cive / di quella #Roma onde #Cristo è romano" (Purg. XXXII, 101-102), ma anche sul "Tu devi" kantiano, sul problema dell’imperativo categorico di Immanuel Kant, se si vuole vivere secondo Coscienza, cioè secondo la Costituzione della Repubblica italiana?
Federico La Sala
-
>Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e ... il "mormorio sottile" della "Divina Commedia".24 gennaio 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA #ARTE #ANTROPOLOGIA E DIVINA COMMEDIA: MEMORIA DELLO "SPOSALIZIO DI GIUSEPPE E MARIA" (#23GENNAIO) E UN "VECCHIO" INVITO AD ACCOGLIERE IL "MORMORIO SOTTILE" DELL’OPERA DI DANTE ALIGHIERI.
STORIA E LETTERATURA: #RICAPITOLAZIONE E #POESIA. Dopo le sollecitazioni "#cosmicomiche" (#ItaloCalvino) di #DanteAlighieri a uscire dal "#letargo" (Par. XXXIII, 94), forse, è proprio il tempo di riaprire la #Commedia e non rinchiuderla per sempre nell’orizzonte del "#Boccaccio" e del "#Petrarca"; e, togliendo le virgolette al "Perché non possiamo non dirci «cristiani»"(Benedetto Croce, 1942), comprendere antropologicamente, che, come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO": e, riprendere proprio quel filo perduto (quel "#paradigma perduto") che collega benevolmente e cosmologicamente il passato e il presente, l’alto e il basso, il sopra e il sotto, e #cielo e la #terra: in principio era il #Logos...
#FILOLOGIA E #AMORE (#CHARITAS), NON #MAMMONA (#CARITAS)! Dante non "cantò i #mosaici" dei "faraoni", ma soprattutto la Legge del "Dio" di Mosè di Elia e di Gesù, del "Dio" dei nostri "Padri" e delle nostre "Madri". L’Amore "che muove il Sole e le altre stelle".
NOTE:
- ARTE,#POESIA, #ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA), E #PSICOANALISI: EARTHRISE ( Foto allegata, 1968). Riprendendo e rilanciando (cum grano salis) "il messaggio è: allargate l’area della coscienza” (Allen Ginsberg); è una viva e #critica #sollecitazione a riprendere proprio quel filo perduto (quel "#paradigma perduto") che collega benevolmente il passato e il presente, l’alto e il basso, il sopra e il sotto, e il #cielo e la #terra: in principio era il #Logos (non un #logo).
- CATTOLICESIMO E CRISTIANESIMO: "LA PRIMA #RINASCITA". Storiograficamente, forse, è ora di #capovolgere, il "tempo" proprio dell’#Umanesimo e del #Rinascimento: per la società e la cultura del cosiddetto "#MedioEvo" (così dagli "umanisti"), l’epoca (al contrario) "fu sentita - così scrive E. Gilson - come un’età di innovazione in tutti i sensi della cultura, una #modernità in progresso". A mio parere, a ben vedere, Ernesto #Buonaiuti aveva ragione: il formidabile processo della "prima rinascita" cominciò con Gioacchino da Fiore, Francesco di Assisi, e Dante Alighieri.
- ARTE, STORIA, ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA), E #TRADIZIONE DEI #CARMELITANI SCALZI: MARIA E GIUSEPPE E TERESA D’AVILA:
- . Il "Matrimonio mistico di santa #Teresa d’Avila" (di #Francesco del Cairo, 1640-1650, #Parma): Il quadro [...] Raffigura la Vergine e san Giuseppe che appaiono a Santa Teresa d’Avila, inginocchiata in preghiera con le mani incrociate sul petto, nell’atto di ricevere dalla Madonna che si sporge verso di lei una catena d’oro. Santa Teresa, vissuta tra 1515 e 1582, ebbe un ruolo primario nella dell’ordine del Carmelo Scalzo. Ella fu anche particolarmente devota a San #Giuseppe, sposo di #Maria e suo protettore, contribuendo alla diffusione del culto del santo e alla sua rappresentazione nell’arte devozionale. L’episodio raffigura una visione mistica che Teresa aveva avuto il 15 agosto 1561, giorno dell’Assunzione, in cui la Madonna e Giuseppe comparivano insieme ponendole sulle spalle un manto bianco sfolgorante e al collo un ornamento d’oro con appesa una croce, segno dell’approvazione divina al suo progetto di fondazione di un monastero. [...] ".
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. --- LA MONTAGNA INCANTATA ("DER ZAUBERBERG") DI THOMAS MANN (1924) E LA "STORIA D’ITALIA DAL 1871 AL 1915" DI BENEDETTO CROCE (1928)20 novembre 2023, di Federico La Sala
L’EUROPA, "L’ELOGIO DELLA FOLLIA" (1511) E L’UTOPIA (1516). CULTURA E SOCIETÀ: "LA MONTAGNA INCANTATA" (1924) e "IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929).
- In memoria di Ferrante Sanseverino (Principe di Salerno) e Girolamo Seripando (Arcivescovo di Salerno)
Una nota a margine di una "citazione" di una lettera di #Tommaso Moro a #Erasmo di Rotterdam:
«Non puoi immaginarti quanto ora io m’imbaldanzisca, quanto mi gonfi, quanto mi tenga più su. Immagino di continuo che i miei Utopiani mi vorranno eleggere loro sovrano perpetuo, tanto che mi vedo già incedere del diadema di frumento, mi vedo cospicuo nel paludamento francescano, mi vedo portare lo scettro venerabile di un covone di messi. Circondato da un’insigne accolta di cittadini di Amauroto, mi vedo, in pompa solenne, andare incontro agli ambasciatori e ai principi delle genti straniere, ben miseri al nostro confronto, pieni di sciocca superbia, perché ornati fanciullescamente, pieni di vanità femminile, carichi di disprezzabile oro, ridicoli per la porpora, per le gemme, per altre bazzecole.» (Cfr. E. Scelza, "LE CITAZIONI: il sogno ad occhi aperti di Tommaso Moro", "Gente e Territorio", 15 novembre 2023).
SE SI CONSIDERA CHE TOMMASO MORO (1478-1535) scrive quello che scrive ad ErasmodiRotterdam (1469-1536) il 4 dicembre 1516, e che, al contempo, Martin #Lutero (1483-1546) nell’ottobre del 1517 diffonde le sue #95Tesi, c’è da pensare che ognuno sognasse un proprio #sogno ad occhi aperti e non avessero affatto un #mondo "unico e comune" (#Eraclito) : questo spiega, soprattutto da parte di Erasmo e Moro, anche la loro presa di distanza dalle sollecitazioni di riforma della Chiesa da parte di Lutero.
Non è un caso che, pochi anni dopo (al tempo di Carlo V, dopo il Sacco di Roma nel maggio del 1527), la richiesta di un tentativo di edizione della "#Monarchia" di #DanteAlighieri, fatto da Alonzo de #Valdès (1490 - 1532) e Mercurino di #Gattinara (1465-1530), è lasciato cadere nel vuoto da Erasmo da Rotterdam (nel marzo del 1527), e, ancora e purtroppo, di lì a poco c’è la rottura di #EnricoVIII con Chiesa cattolica e l’avvio della Riforma Anglicana (1534).
All’indomani della Prima Guerra Mondiale, alla fine della sua "Montagna Incantata" (#Zauberberg, 1924), #ThomasMann scrive: "Chi sa se anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla febbre maligna che incendia tutt’intorno il cielo piovoso di questa sera, sorgerà un giorno l’amore?" (trad. di E. Pocar).
Nel 1929, in Italia, la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano sottoscrivono il "Concordato" (#PattiLateranensi, 11 febbraio 1929): a Vienna, intanto, #SigmundFreud porta avanti il suo lavoro e pubblica il risultato delle sue ricerche e delle sue riflessioni sul "Disagio della civiltà" (e nella civiltà).
P.S. - STATO ITALIANO E STATO PONTIFICIO (CHIESA CATTOLICA): LA QUESTIONE ROMANA E IL "20 SETTEMBRE 1870" (Festa della liberazione della capitale e dell’unificazione nazionale, abolita dal Fascismo). BENEDETTO CROCE, NELLA "STORIA D’ITALIA DAL 1871 AL 1915" (1928), A PROPOSITO DEL PERSONAGGIO "LUDOVICO SETTEMBRINI" DELLA "MONTAGNA INCANTATA" ("DER ZAUBERBERG", 1924) DI THOMAS MANN, COSI’ SCRIVE:
- «Fu creduto, e io credetti, che con questo nome egli alludesse al nostro Luigi Settembrini; ma alcuni anni dopo, in un incontro col Mann in Germania, egli mi confessò di avere ignorato affatto l’esistenza di Luigi Settembrini, e di aver composto quel nome derivandolo dal “20 settembre”!» (cfr. #SantoMazzarino, "#Pirandello. La storia dell’Italia moderna e antica", a c. di Maria Adele Cavallaro, Roma 2022, p. 203).
-
>Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce --- Il cardinale G. B. Re ricorda l’ antropologia cristocentrica di Giovanni Paolo II e il suo «perché non possiamo non dirci "cristiani"».20 ottobre 2023, di Federico La Sala
PER UN’ANTROPOLOGIA E UNA TEOLOGIA CRISTIANA, OLTRE L’ANDROCENTRISMO PAOLINO E LA COSMOTEANDRIA "CATTOLICO-COSTANTINIANA" (NICEA 325-2025) *
Il 16 ottobre di 45 anni fa l’elezione di san Giovanni Paolo II
Ha insegnato a non aver paura di dirsi cristiani
[di Giovanni Battista Re (L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023
Il 16 ottobre di 45 anni fa, ero sulla terrazza della Segreteria di Stato quando il cardinale Pericle Felici, dopo la fumata bianca, annunciò il nome del nuovo Papa: Karol Wojtyła. Monsignor Agostino Casaroli (divenuto cardinale l’anno dopo), che era lì con noi, commentò: «Che coraggio hanno avuto i cardinali, scegliendo un arcivescovo di un Paese oltre la “cortina di ferro”! Che coraggio!».
Circondammo tutti monsignor Casaroli, facendogli domande, mentre aspettavamo che il nuovo Papa si affacciasse al balcone della basilica Vaticana.
Ci rispose: è una personalità forte e affascinante per le tante sue doti, ma mai avevo pensato all’eventualità che il nuovo Papa potesse venire da oltre la “cortina di ferro”.
A 45 anni di distanza, il lungo pontificato di Giovanni Paolo II colpisce per la vastità e la grandiosità delle opere realizzate, per il grande numero di eventi e di iniziative, per il consenso ottenuto e per ciò che la sua guida spirituale e morale ha rappresentato per oltre un quarto di secolo.
Papa Wojtyła tuttavia ha stupito non solo per quello che ha fatto, ma anche per l’amore che lo animava e il desiderio che aveva di aiutare tutti nella ricerca di Dio e nel far crescere nel mondo il rispetto dei diritti umani, la fraternità e la solidarietà.
San Giovanni Paolo II è stato una personalità fuori dall’ordinario, un Papa che si è inserito nel solco della tradizione della Chiesa con un innegabile timbro di novità, ma anche di piena fedeltà alla dottrina che viene dagli apostoli.
Non possiamo non riconoscere che la Divina Provvidenza gli ha assegnato grandi compiti nella storia mondiale del suo tempo.
- Uomo di Dio
San Giovanni Paolo II è stato innanzi tutto un grande uomo di Dio, animato da una fede incrollabile.
La prima e fondamentale dimensione del suo pontificato è stata quella religiosa. Il movente dell’intero suo pontificato, il centro ispiratore dei suoi pensieri e di tutte le sue iniziative è stato di natura religiosa: tutti gli sforzi del Papa miravano ad avvicinare gli uomini a Dio e a fare rientrare Dio da protagonista in questo mondo. Voleva che in questo nostro mondo vi fosse ancora posto per Dio.
Il vibrante appello pronunciato nella sua prima celebrazione eucaristica in piazza San Pietro: «Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo», esprimeva bene la linea ispiratrice e il programma di tutto il suo pontificato. Quelle parole manifestavano l’ansia apostolica che lo avrebbe spinto sulle strade del mondo, incontro a popoli di ogni cultura e di ogni razza per annunciare a tutti che solo in Dio, che in Cristo si è fatto a noi vicino, l’umanità può trovare la vera salvezza.
Questa verità egli l’ha proclamata con fedeltà e con un coraggio che nemmeno le due pallottole sparategli contro il 13 maggio 1981 riuscirono a indebolire o a scalfire.
La grandezza del suo lungo pontificato sta soprattutto nell’avere risvegliato nel mondo il senso religioso. Nella società secolarizzata del suo tempo, egli ha aiutato i cristiani a liberarsi dai falsi sensi di inferiorità nei confronti della cultura laicista dominante, e a non avere timore ad essere e a dirsi cristiani. Instancabile fu il suo richiamo a ritornare a Dio, rivolto ad una società che in Occidente lo stava dimenticando e che oltre la “cortina di ferro” lo combatteva.
Ha fatto capire che non si possono limitare a questa terra gli orizzonti di noi, uomini e donne. Ha insegnato che la coscienza, «in cui l’uomo si trova solo con Dio e scopre una legge scritta nel cuore» (Gaudium et spes, 16), conferisce un’altissima dignità all’uomo e alla donna ed ha esortato a rinnovare la società facendole ritrovare la forza del messaggio di Cristo (Cfr. Insegnamenti 1986, i, p. 1379).
Giovanni Paolo II ha avuto fiducia nella forza delle istanze spirituali e morali ed è stato un testimone di eccezionale statura anche per la sua limpida coerenza: in lui non esisteva frattura fra ciò che pensava e ciò che diceva; fra ciò in cui credeva e ciò che egli era. In lui vi era piena unità di fede e di vita.
- Difensore dei diritti umani
Oltre che uomo di Dio, Giovanni Paolo II è stato un appassionato difensore dell’uomo, della dignità, dei diritti e della libertà di ogni persona umana. Fu anche questo un tema caratterizzante il suo insegnamento, che ha aiutato molte persone a scoprire il senso etico della vita. Alla radice di questo impegno per l’uomo si staglia una chiara visione della dignità di ogni persona umana, «unica e irrepetibile», come soleva dire. Ogni attentato contro la dignità di qualsiasi essere umano è un’offesa a Dio, nostro Creatore. I diritti umani erano da lui proclamati e difesi come diritti che Dio ha posto nella natura umana. Si schierò sempre in difesa del carattere inviolabile della vita umana, dal primo istante del concepimento fino al naturale tramonto.
L’uomo e la donna erano da lui visti con gli occhi di Dio e amati col cuore di Dio. La sua era un’antropologia cristocentrica: la creatura umana trova il senso della sua vita al di sopra di sé; lo trova in Dio, che in Cristo si è fatto uomo.
- Uomo di preghiera
Lavorando vicino a Giovanni Paolo II, molte erano le cose che colpivano (impressionavano la sua sicurezza, le sue certezze, la capacità di parlare alle folle... la capacità di veder più lontano degli altri), ma ciò che mi ha sempre stupito di più è stata la profonda intensità della sua preghiera. Non si può comprendere Papa Giovanni Paolo II se si prescinde dal suo rapporto con Dio. È stato un grande uomo di preghiera, animato da una forte spiritualità cristocentrica e mariana. Aveva in sé una tensione spirituale e mistica inconfondibile ed è dalla preghiera che fluivano la sua sicurezza, l’assoluta padronanza di sé e la sua serenità in ogni circostanza.
Colpiva come si abbandonava alla preghiera: si notava in lui un totale coinvolgimento, che lo assorbiva come se non avesse avuto problemi e impegni urgenti che lo chiamavano alla vita attiva. Il suo atteggiamento era raccolto e insieme spontaneamente naturale.
Dal modo con cui pregava si avvertiva come l’unione con Dio era per lui respiro dell’anima e umile ascolto della voce di Dio.
Commuovevano la facilità e la prontezza con le quali passava dal contatto umano con la gente al raccoglimento del colloquio intimo con Dio. Aveva una grande capacità di concentrazione. Quando era raccolto in preghiera, quello che accadeva attorno a lui sembrava non toccarlo e non riguardarlo, tanto si immergeva nell’incontro con Dio.
Durante la giornata, il passaggio da un’occupazione all’altra era sempre segnato da una breve preghiera.
Maturava ogni scelta importante nella preghiera. Prima di ogni decisione significativa Giovanni Paolo II vi pregava sopra a lungo, a volte per più giorni. Sembrava che trattasse con Dio i vari problemi.
Nelle scelte di un certo peso non decideva mai subito. Ai suoi interlocutori che gli chiedevano o proponevano qualcosa, rispondeva che desiderava riflettere prima di dare risposta. In realtà, guadagnava tempo per ascoltare qualche parere, ma soprattutto intendeva pregare per ottenere luce dall’alto prima di decidere.
Ricordo un caso, negli anni in cui ero sostituto della Segreteria di Stato, in cui mi sembrò che il Papa fosse già decisamente a favore di una determinata difficile scelta. Gli chiesi pertanto se si potesse procedere a darne comunicazione. La risposta fu: «Aspettiamo, voglio pregare ancora un po’ prima di decidere».
Nelle decisioni il suo primo interesse era di operare davanti a Dio secondo verità, giustizia ed equità, e non se esse fossero popolari o no. Non gli mancò mai il coraggio necessario.
Quando si stava studiando un problema e non si riusciva a trovare una soluzione giusta e adeguata, il Papa concludeva dicendo: «Dobbiamo pregare ancora, perché il Signore ci venga in aiuto». Si affidava alla preghiera per trovare luce sulla strada da seguire.
Punto forte della sua spiritualità è stata la devozione alla Madonna: la dimensione mariana, espressa nel motto “Totus tuus”, ha contrassegnato l’intera sua esistenza. Era un’eredità lasciatagli dalla mamma scomparsa prematuramente, che poi ha approfondito e sviluppato accompagnato dal padre nel cammino di maturazione spirituale. Karol Wojtyła nacque il 18 maggio 1920, alcuni minuti dopo le ore 17, mentre nella chiesa parrocchiale, vicinissima a casa sua, era in corso la funzione mariana del mese di maggio. Appena il piccolo Karol era venuto alla luce, la mamma, sentendo il canto delle litanie lauretane che giungeva dalla chiesa, disse: «Aprite le finestre, perché voglio che le prime voci ed i primi suoni che il mio bambino ascolta siano i canti della Madonna».
Nel periodo in cui andava a lavorare alla cava di pietra e poi alla fabbrica Solvay, Karol Wojtyła lesse il libro di san Luigi Maria Grignion de Montfort Trattato della vera devozione a Maria, che gli era stato dato da un laico, Jan Tyranowski. Questi aveva creato in parrocchia un gruppo di 15 giovani, fra i quali Karol Wojtyła, che si impegnavano a recitare ognuno una decina del rosario al giorno.
Non è senza significato che due settimane dopo la sua elezione alla sede di Pietro, nel pomeriggio della prima domenica per lui libera, sia andato al santuario della Mentorella per pregare la Madonna, ma anche per parlare della preghiera, affermando che considerava suo primo compito come Papa quello di pregare per la Chiesa e per il mondo e desiderava che la preghiera fosse «il primo annuncio del Papa« (Omelia al santuario della Mentorella, «L’Osservatore Romano», 30-31 ottobre 1978).
La messa era per lui la realtà più alta, più importante e più sacra. In un incontro con i sacerdoti nel 1995 disse: «la messa è in modo assoluto il centro della mia vita e di ogni mia giornata». «Celebrare ogni giorno la messa è per me un bisogno del cuore».
Il mondo intero ha seguito gli ultimi giorni di Papa Giovanni Paolo II. Col suo esempio ci ha insegnato che la vita è un dono che va vissuto fino alla fine con fiducia in Dio e accettando con serenità i disagi della malattia. Ci ha indicato come si percorre il cammino verso il mistero che ci attende, quando anche per ciascuno di noi si apriranno le porte dell’eternità. È stato questo il suo ultimo insegnamento: un insegnamento da Papa.
di Giovanni Battista Re
 Decano del Collegio cardinalizio
Decano del Collegio cardinalizio
NOTA:
Carlo Wojtyla,
 AMORE E RESPONSABILITA’.
AMORE E RESPONSABILITA’.
 Morale sessuale e vita interpersonale,
Morale sessuale e vita interpersonale,
 Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)
Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)fls
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e ... una memoria del 1944: Quando Hitler "rubò Dante" e venne beffato (di Franco Gabici).5 luglio 2021, di Federico La Sala
Il caso.
Quando Hitler "rubò Dante" e venne beffato
Nel 1944 Hitler aveva affidato a Speer la costruzione di un Pantheon che avrebbe dovuto accogliere le ossa di grandi personaggi e fra questi Dante. Ma don Mesini le salvò nascondendole in casa
di Franco Gàbici (Avvenire, domenica 4 luglio 2021)
- [Foto] Mesini, Fusconi e Valgimigli
Da sette secoli Ravenna conserva gelosamente le ossa di Dante e per proteggere questo prezioso tesoro ha fatto di tutto, disubbidendo perfino a papa Leone X che nel 1519 aveva autorizzato l’Accademia medicea a recarsi a Ravenna per prelevare le ossa e portarle a Firenze. Tutti sanno come andò a finire la storia. Prima dell’arrivo a Ravenna della delegazione fiorentina i frati Francescani, che si sono sempre considerati custodi delle spoglie del poeta, a notte fonda praticarono un buco nella tomba e nascosero le ossa nell’attiguo convento. Nel 1810, a seguito delle soppressioni napoleoniche degli ordini religiosi, dovettero abbandonare il convento e prima di lasciare la città nascosero la cassetta delle ossa nella cavità di un muro. Qui vennero ritrovate per caso da un muratore alla fine di maggio del 1865 durante i lavori di restauro della zona in occasione del sesto centenario della nascita del poeta. Ci fu grande festa in città per questo ritrovamento, definito l’evento del secolo, e le ossa ritornarono nella tomba.
Ora, secondo un articolo del ravennate Sergio Roncucci pubblicato il 1° luglio sulla rivista ’Pen Italia’ la vicenda delle ossa di Dante si arricchisce di un nuovo capitolo che si discosta dalle versioni ufficiali a suo tempo fornite. Nel 1944 Hitler aveva affidato all’architetto del regime Albert Speer la costruzione di un Pantheon che avrebbe dovuto accogliere le ossa di grandi personaggi e fra questi Dante. L’Oss, il servizio segreto statunitense precursore della Cia, viene a conoscenza del progetto e informa l’Organizzazione per la Resistenza italiana che faceva capo a Raimondo Craveri, genero di Benedetto Croce. Essendo in ballo le ossa di Dante, Croce mette al corrente l’illustre grecista Manara Valgimigli e quest’ultimo, che alcuni anni dopo sarebbe stato chiamato a dirigere la Biblioteca Classense di Ravenna, informa don Giovanni Mesini che subito prende le contromisure.
Don Mesini, conosciuto come ’il prete di Dante’, insieme a Bruno e a Giorgio Roncucci, padre e fratello di Sergio, e del custode della tomba Antonio Fusconi, si reca al cimitero di Ravenna, preleva le ossa da una tomba abbandonata e nella notte fra il 23 e il 24 marzo del 1944 le sistema al posto di quelle del Poeta.
Sergio Roncucci, che all’epoca aveva dieci anni, ricorda che don Mesini si era recato a casa sua portando la cassetta con le ossa del Poeta e alle domande legittime dei familiari aveva risposto col dito indice sulle labbra. «Zitti tutti!». Nel frattempo, sempre secondo Roncucci, le Ss trafugano le ossa di Dante e le portano a Berlino. Quando si accorgono della beffa è tardi, la guerra è ormai alla fine e hanno altro a cui pensare. La storia, dunque, si ripete. E come all’inizio del Cinquecento i Francescani, disobbedendo a papa Leone X, trafugarono le ossa del poeta, allo stesso modo don Mesini e i suoi amici beffarono Hitler.
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. --- E LA SPERANZA DEL MISERABILE. L’altro nome della fede (di Luigino Bruni).25 maggio 2020, di Federico La Sala
CIELO PURO E LIBERO MARE.... *
L’anima e la cetra /9.
L’altro nome della fede
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 23 maggio 2020)
- In questo Spirito che è l’amore tra il Padre e il Figlio, tra il Figlio e noi, tra noi e noi, quanti abbiamo un’anima, in questo Spirito che è il nostro amore, sta tutta la nostra salvezza: gettata nel suo fuoco, la nostra salvezza umana diventa la nostra divina pazzia. Oh fosse così, oh sia così.
- Giuseppe de Luca, L’intelligenza e la salvezza dell’anima .
«Il cuore degli ottenebrati parla così: "Dio non c’è". Il Signore dal cielo si affaccia e si china sui figli dell’uomo per vedere se c’è un uomo saggio, uno che cerchi Dio» (Salmo 14, 1-2). Un inizio originale per un salmo unico nel salterio. Un inizio speciale perché speciale è la posta in gioco. È infatti la sola volta che nella Bibbia troviamo scritto: Dio non c’è. Anche il mondo religioso antico conosceva il dubbio che gli dèi fossero una invenzione dell’uomo. L’uomo biblico è più vicino a noi di quanto pensiamo e scriviamo. Anche la domanda sull’esistenza di Dio tra le domande legittime della Bibbia.
Il Salmo 14 fu scritto con ogni probabilità durante l’esilio babilonese. I babilonesi non erano atei. Ci hanno lasciato raccolte di preghiere bellissime, avevano in grande considerazione i loro dèi che onoravano con processioni, templi e statue spettacolari. Quindi i babilonesi non dicevano esplicitamente "Dio non c’è", tantomeno lo dicevano gli ebrei. Quella del salmista era allora un’accusa alla falsa religione? Era una critica idolatrica? No. La forma della negazione di Dio di cui parla questo salmo non è quella idolatrica. Quale allora?
Ce lo rivelano due elementi, uno linguistico e l’altro teologico. La parola ebraica che il salmo 14 usa per dire «Dio non c’è» è Elohim, che nella Bibbia è il nome generico della divinità (gli dèi). Se il salmista avesse voluto criticare l’idolatria, il culto di dèi «falsi e bugiardi», il nome di Dio usato doveva essere YHWH, il nome proprio del Dio biblico. Anche perché YHWH è il nome di Dio più usato nel salterio e quasi esclusivamente nel primo libro (salmi 1-41). Usare qui Elohim significa allora voler dare a quella negazione - Dio non c’è - un valore che va oltre la critica idolatrica. In quel «Elohim non c’è» si nasconde allora qualcosa di universale e di tremendamente importante per ogni religione (e per ogni ateismo). Di quale "ateismo" parla questo salmo?
Lo scopriamo guardando il secondo elemento: «Sono distorti tutti, è un reciproco guastarsi: non c’è nessuno che agisca bene, neppure uno. Si divorano il mio popolo come mangiassero un tozzo di pane... Voi deludete la speranza del miserabile» (3-4,6). Qui ritroviamo la tesi profetica che la negazione di Dio si rivela nella negazione dell’uomo, soprattutto dei poveri. «Dio non c’è» non va dunque letta come una affermazione atea del tipo di quelle che abbiamo iniziato a conoscere in Europa con la modernità, ma come una conseguenza di un’idea centrale nella Bibbia: Dio c’è se c’è l’uomo - è l’uomo l’altro nome della fede biblica. È il «divorare il popolo come un tozzo di pane» che dice questo tipo di ateismo. Non è faccenda filosofica né intellettuale, è molto di più.
Certamente la vita sociale dei babilonesi dovette esercitare un grande effetto sugli ebrei deportati. Quelle banche che prestavano a interesse e che generavano debitori schiavi, la corruzione del potere in quel grande impero, impressionarono molto gli ebrei e i loro profeti. Ezechiele, profeta in esilio, arrivò persino a formulare una versione del peccato dell’Adam nell’Eden come peccato economico: «Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profanato i tuoi santuari» (Ez 28,18). Ma l’ateismo pratico iscritto nelle prassi socio-economiche era qualcosa di ancora più generale di quanto avveniva in Babilonia. Lo ritroviamo già in Isaia, prima dell’esilio: «Smettete di presentare offerte inutili, l’incenso è un abominio per me... Ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1, 13-17). Isaia accusava i suoi concittadini non i babilonesi; stigmatizzava gli assidui frequentatori del tempio e i praticanti che offrivano i sacrifici mentre calpestavano il diritto e la giustizia.
Il salmista vede allora l’assenza di Dio nell’assenza dell’uomo. Sono questi i passaggi da cui si comprende che la teologia biblica è immediatamente umanesimo: il Dio biblico si onora onorando gli uomini, le donne, i poveri. Ritorna ancora l’antropologia della Genesi: siamo immagine di Dio anche perché quando qualcuno - un impero o una cultura - non vede più l’uomo non vede più Dio, anche quando continua a pregarlo e lodarlo nei templi. È già ateo, anche se non lo sa ancora. Ci sono molti modi per dire "Elohim non c’è", "Elohim è nulla" (nella traduzione di Ceronetti). Quello che sta più a cuore alla Bibbia è chiaro: "l’uomo è nulla", "il povero è nulla". E che sia nulla lo dice l’unico linguaggio che davvero conta: quello del comportamento e dell’azione. Il mondo è stato sempre popolato di uomini religiosi che onoravano Dio e disonoravano gli uomini, che apprezzavano gli dèi e disprezzavano i propri simili. Non basta essere religiosi per non essere atei. E se il salmista ha scelto Elohim e non YHWH per parlarci di questo tipico ateismo, è anche per dirci che questa malattia di <+CORSIVO50>ateismo devoto<+TONDO50> attraversa tutte le religioni, comprese quelle bibliche. Gli uomini dicono "Dio non c’è" con il loro modo di trattarsi a vicenda e di trattare i poveri. La Bibbia non è un trattato di etica, ma dall’etica degli uomini si capisce se nel popolo c’è o non c’è la fede.
Il salmo chiama «stolto», «ottenebrato», «stupido», chi dice «Dio non c’è». Quale è la stoltezza di questo ateismo? Innanzitutto è un ateismo collettivo, una malattia che ha infettato l’intero popolo: «Non c’è nessuno che agisca bene, neppure uno». Questa stoltezza che porta a negare Dio non è dunque faccenda che riguarda qualche singolo intellettuale o filosofo scettico; quello denunciato dal salmista è un ateismo popolare: non è rimasto neppure un credente. Siamo in una situazione simile a quella di Sodoma e Gomorra, alla Gerusalemme dove Geremia non trovò neanche un giusto (Ger 5,1). Peggiore della terra osservata dal Satan in ricognizione che vi trovò almeno un uomo giusto: Giobbe (cap.1); un mondo più corrotto di quello prima del diluvio, dove almeno vi era rimasto un giusto: Noè.
È bellissima la radicalità della Bibbia - tutti, neppure uno. Tutti stolti. Lo siamo tutti quando dentro istituzioni, comunità, movimenti, imprese, chiese, si annida e si diffonde la corruzione. Precipitiamo in "un reciproco guastarsi". Il (raro) verbo ebraico usato qui, ’alàh, esprime il contagio reciproco, la mutua contaminazione. Anche se molti sono asintomatici la corruzione raggiunge tutti. Per uscire da queste situazioni ci vorrebbe un Noè, un Geremia, un Abramo, Maria. Ma non sempre ci sono. Quasi mai. Perché quell’«uno solo» per non essere stolto dovrebbe denunciare l’ingiustizia, resistere a lungo nella sua denuncia, sopportare le persecuzioni, e se non ottiene nessun risultato dimettersi, licenziarsi, uscire, dissociarsi. Ma queste azioni sono molto costose e quindi molto rare sulla terra. Anche in queste dinamiche di "guastarci a vicenda" siamo tutti figli di Adamo, siamo solidali nella corruzione, e anche quando i sintomi non sono evidenti siamo quantomeno complici e quindi stolti.
La parola che il salmo usa per dire "stolto" è nabal. Nabal era il nome del marito di Abigail. Nell’episodio del primo Libro di Samuele, Nabal non capì come doveva comportarsi con Davide. Non rispose ai suoi doni con altri doni, non "riconobbe" Davide. Stava per scatenare una guerra se non fosse intervenuta Abigail, che fece tutto quanto non aveva fatto suo marito: fu grata, riconobbe Davide, lo riempì di doni, fu generosa, e seppe onorare il suo ospite: «Non faccia caso il mio signore a quell’uomo cattivo che è Nabal, perché egli è come il suo nome: stolto si chiama e stoltezza è in lui» (25, 25). Abigail ricostruì il rapporto spezzato da suo marito, e con il suo dono ottenne il per-dono di Davide, che riconobbe in quelle relazioni curate la presenza di Dio: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, che ti ha mandato oggi incontro a me» (32). Abigail fu l’anti-Nabal, disse "Dio c’è" dicendo "l’uomo c’è", tramutando la guerra in pace. Non c’è modo migliore per dire-bene Dio, per bene-dire Elohim - le donne lo sanno bene, le donne lo sanno meglio.
Il Salmo definisce il "saggio" (maskil) non trovato da Dio sulla terra uno "che cerca Dio". L’opposto dello stolto è dunque il cercatore di Dio. Ma il primo cercatore che troviamo nel salmo è Dio-Elohim, che si affaccia dal suo balcone dei cieli per cercare almeno un uomo giusto. Dio cerca per trovare qualcuno che lo cerchi. La fede è un incontro di ricerche, una reciprocità di desideri, che diventa rapporto ternario: Dio cerca un uomo capace di cercarlo cercandolo nell’uomo - «...e il secondo comandamento è simile al primo». Ma allora ci può essere ancora un altro senso di questo Salmo 14: se il saggio è chi cerca Dio, allora lo stolto dice "Dio non c’è" perché, semplicemente, non lo cerca: e se l’ateismo stolto fosse quello di chi ha smesso di cercare?
Un giorno, un altro folle uomo «cercava Dio». Non lo trovò e annunciò a tutti che era morto. Forse perché lo aveva cercato nel «mercato», dove «si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio» (F. Nietzsche, La gaia scienza). Il mondo dove abbiamo trovato morto quel Dio che stavamo cercando è preferibile a quel mondo corrotto dove nessuno può dire "Dio c’è". E se lo dicesse direbbe qualcosa di più falso del "Dio non c’è" detto, in quella stessa situazione, dallo stolto. C’è un ateismo meno stolto di una fede proclamata in mezzo all’ingiustizia generale. Se il Dio cercato è morto possiamo sempre sperare e pregare che risorga.
Quando il «Figlio dell’uomo tornerà» non andrà nei templi e nelle chiese per vedere se «la fede è ancora sulla terra» (Lc 12,7-8). Guarderà ai nostri rapporti sociali: guarderà a come ci vorremo bene o male, guarderà le nostre banche, la nostra evasione fiscale, i nostri ospedali, gli stipendi ai braccianti e quelli ai manager. E se ci sarà ancora la fede la troverà soltanto dentro la giustizia e la verità dei nostri rapporti; se ci sarà ancora la potrà riconoscere da come risponderemo alla speranza del miserabile.
*
Sul tema nel sito, si cfr.:
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA : VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’ -- "Psicoterapia di Dio". Lo studio dello psichiatra Boris Cyrulnik (di Massimo Ammaniti).3 novembre 2018, di Federico La Sala
Lo studio dello psichiatra Boris Cyrulnik
Le zone del cervello in cui ha sede lo spirito religioso
di Massimo Ammaniti (la Repubblica, 03.11.2018)
È ben noto che la fede religiosa e la spiritualità aiutano lo stato psichico delle persone che soffrono di depressione e addirittura potrebbero rallentare l’evoluzione dei tumori. Non si tratta di un’ipotesi, la conferma sperimentale viene da una ricerca pubblicata dalla rivista Cancer su un ampio campione di pazienti che presentavano un tumore. Non è ancora chiaro, tuttavia, come la fede possa influire sull’evoluzione dei tumori, se aiuti a cambiare l’attitudine psicologica con cui si affronta la malattia oppure influisca sul funzionamento neurobiologico e immunitario potenziando le difese.
È un tema appassionante approfondito da Boris Cyrulnik, psichiatra francese di origine ebraica, sopravvissuto nella sua infanzia alle persecuzioni naziste.
Il libro Psicoterapia di Dio (Bollati Boringhieri) esplora in vari capitoli l’influenza crescente delle religioni nel mondo occidentale. E questa religiosità riguarda i cristiani, gli ebrei e i musulmani che vivono un’esperienza totalizzante che incide sulle pratiche della vita quotidiana e sulla loro visione del mondo. E mentre la religione ha le proprie cerimonie di culto, la spiritualità indica spesso un vissuto e un viaggio interiore che non necessita di una pratica religiosa.
E se tutto questo aiuta a trascendere le sofferenze della vita quotidiana e raggiungere uno stato di pacificazione personale, la fede troppo esclusiva può anche generare intolleranze, violenze e addirittura guerre che hanno segnato la storia dell’umanità.
L’adesione e l’appartenenza alla religione si costruisce giorno per giorno fin dall’infanzia, come il linguaggio, scrive Cyrulnik. Infatti attraverso l’esempio e le sollecitazioni dei genitori i bambini introiettano la fede che diventa parte integrante della loro identità. Nel film di Woody Allen Crimini e misfatti il protagonista, che appartiene a una famiglia ebraica praticante, racconta che da piccolo i genitori gli ripetevano «Dio ti guarda continuamente qualsiasi cosa fai»: «Forse per questo - commenta ironicamente - sono diventato oculista».
Il sentimento religioso si intreccia fin dall’inizio con l’attaccamento amoroso ai genitori e aiuta a sentirsi più sicuri. Quando si devono affrontare compiti impegnativi oppure si è vittime di traumi e avversità, ci si rivolge a Dio con la speranza che il suo intervento possa essere risolutivo. E anche quando ci si sente soli e disperati la relazione affettiva con Dio può essere consolatoria, aiutando a ritrovare la propria sicurezza personale.
Ma il sentimento religioso non riguarda solo la mente, anche il corpo ne viene coinvolto. Nelle pratiche religiose i fedeli si inginocchiano e si stendono a terra, si battono il petto, si muovono ritmicamente col corpo quasi a rafforzare con un coinvolgimento totale la propria partecipazione religiosa. Lo stesso cervello viene chiamato in causa quando ci si rivolge alla religione, soprattutto quando si raggiungono esperienze di ascesi e di estasi, nelle quali ci si libera del corpo e ci si avvicina a Dio.
Forse nel libro non viene abbastanza approfondito il coinvolgimento del cervello nel vissuto religioso, nonostante negli ultimi anni siano stati pubblicati interessanti studi. Fra questi una ricerca italiana che ha documentato quali aree cerebrali vengono attivate quando ci si immerge nella meditazione e si entra in un mondo trascendente, nel quale si perde il senso del tempo e si raggiunge una fusione ideale. Non sarebbe una singola area cerebrale che spiegherebbe la spiritualità, interverrebbero ampie aree cerebrali che interagiscono fra loro, dalla corteccia frontale a quella parietale e temporale.
Il pregio maggiore del libro consiste nell’affrontare i significati dell’esperienza religiosa con spirito critico, ma anche profondamente rispettoso, anche perché le religioni stanno assumendo una rilevanza sempre più grande nel mondo contemporaneo.
-
> Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e --- Heidegger e Barth nella Germania del 1933 (di Benedetto Croce)).21 ottobre 2018, di Federico La Sala
BENEDETTO CROCE, Recensione 1934*:
- MARTIN HEIDEGGER. -Die Selbstbehauptung der deutschen Universitaten. Rede gehalten bei der feierlichen Uebernahme des Rektorats der Universitat Freiburg i. E. anl 27.5.1933 - Breslau, Korn, 1933 (8.o, pp. 22).
- KARL BARTH. - Theologische Existenz heute! - Munchen, Kaiser, 1933 (8.o, PP. 40).
Il prof. Heidegger non vuole che la filosofia e la scienza siano altro, per i tedeschi, che un affare tedesco, a vantaggio del popolo tedesco. Gli studenti tedeschi, a suo dire, hanno tre «Bindungen», tre obblighi, il primo e fondamentale dei quali è la «Volksgemeinschaft», il nazionalismo. Ma se egli si ripiegasse davvero sulla sua coscienza morale (l’ha ogni uomo e l’avrà anche lui), direbbe piuttosto che il primo obbligo, di studenti e di professori, è il timor Dei, come sta scritto sul frontone della Sapienza di Roma.
Scrittore di generiche sottigliezze, arieggiante a un Proust cattedratico, egli che nei suoi libri non ha dato mai segno di prendere alcun interesse o di avere alcuna conoscenza della storia, dell’etica, della politica, della poesia, dell’arte, della concreta vita spirituale nelle sue varie forme - quale decadenza a fronte dei filosofi, veri filosofi, tedeschi di un tempo, dei Kant, degli Schelling, degli Hegel! -, oggi si sprofonda di colpo nel gorgo del più falso storicismo, in quello, che la storia nega, per il quale il moto deila storia viene rozzamente e materialisticamente concepito come asserzione di etnicismi e di razzismi, come celebrazione delle gesta di lupi e volpi, leoni e sciacalli, assente l’unico e vero attore, l’umanità.
Scrive nel bello stile che ci è già noto dai suoi libri filosofici: «Der Wille zum Wesen der deutschen Universitat ist der Wille zur Wissenschaft als Wille zum geschichtlichen geistigen Auftrag des deutschen Volkes als eines in seinem Staat sich selbst wissende Volkces. Wissenschaft und deutsche. Schicksal mussen zumal in Wesenswillen zur Macht kommen» (p. 7). E così si appresta o si offre a rendere servigi filosofico-politici: che è certamente un modo di prostituire la filosofia, senza con ciò recare nessun sussidio alla soda politica, e, anzi, credo, neppure a quella non soda, che di cotesto ibrido scolasticume non sa che cosa farsi, reggendosi e operando per mezzo di altre forze, che le son proprie.
Ben diverso atteggiamento è quello del teologo Karl Barth, che dice il fatto loro ai «Deutschen Christen», ai tedesco-cristiani, pronti a gridare che la chiesa evangelica deve servire alla fortuna del popolo tedesco e del terzo Impero, a richiedere un capo, una sorta cli papa, che fermamente li governi nella nuova vita cominciata con la primavera del 1933, e ad escludere, per intanto, dal loro seno i cristiani di sangue giudaico o a trattarli come cristiani di second’ordine, e via per simili turpitudini.
«Noi - scrive il Barth - abbiamo l’ufficio di portare al popolo tedesco la parola di Dio; e pecchiamo non solo verso Dio, ma anche verso questo popolo stesso se perseguiamo altri ideali e fini, che non sono cominessi a noi. Nella natura del nostro ufficio è che esso non possa essere subordinato o coordinato ad alcun’altra istanza; e di nuovo peccheremmo verso Dio e verso il nostro popolo, se lasciassirilo scuotere anche solo menomamente quest’ordine gerarchico!».
Il Barth degnamente tutela l’indipendenza della teologia, mentre il prof. Heidegger si è affrettato a far getto di quella della filosofia.
B. C.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e la testimonianza di venti cristiani danesi (ricerca scientifica)
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. --- “CHARISMA: I COLORI DELLO SPIRITO“. La mostra di un pittore teologo, M. Ferragina, promossa dall’Arcidiocesi di Milano.23 maggio 2018, di Federico La Sala
CHARISMA: I COLORI DELLO SPIRITO
Un pittore teologo. Arte, emozioni, spiritualità. Tutto questo in: “CHARISMA: I COLORI DELLO SPIRITO“, una mostra straordinaria che potrete ammirare presso la chiesa ex-parrocchiale di Pozzo d’Adda, sabato 26 e domenica 27 maggio. *
L’artista Massimiliano Ferragina - Ph_Fulvio Mandrini
L’ARTISTA
Massimiliano Ferragina nasce a Catanzaro il 17 settembre 1977. Si trasferisce giovanissimo a Roma, dove si laurea in filosofia e teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. La sua espressione artistica è influenzata notevolmente sia dal suo percorso accademico, sia da un viaggio di tre mesi in Sud America e da tre formative residenze d’artista a Parigi (2005), Dublino (2011) e Copenaghen (2012). Esordisce in Italia nel gennaio 2012, con il premio Open Art, presso le sale del Bramante a piazza del Popolo (RM). I suoi numerosi progetti artistici, presenti in tutta Italia e in vari Paesi del Nord Europa, hanno sempre un profondo ed introspettivo messaggio, in cui il mondo interiore è protagonista e “motore immobile“.
Massimilano Ferragina alla conferenza di apertura della personale “Charisma: i colori dello Spirito” - Ph_Fulvio Mandrini
La sua arte e la sua formazione teologica si fondono completamente, dando forma, nella forza dei colori primari, al potente mondo spirituale di Massimiliano. Un mondo che, per mezzo dell’emozione, vuole interrogarvi, porvi domande, condurvi alla riflessione, dialogare con quello che è il vostro mondo interiore e la vostra spiritualità. La pittura di Ferragina nasce dalla preziosa radice della meditazione, che si apre in una testimonianza che diviene dialogo spirituale, che difficilmente può lasciare indifferenti.
Fiamme
 Lo Spirito soffia dove vuole - Acrilico e stucco su tela Ph_Fulvio Mandrini
Lo Spirito soffia dove vuole - Acrilico e stucco su tela Ph_Fulvio MandriniLA MOSTRA
La mostra “CHARISMA: I COLORI DELLO SPIRITO”, promossa dall’Arcidiocesi di Milano-Unità pastorale S. Antonio Abate SS. Redentore a cura di p. Michele M. Pirotta, è l’idea di un percorso creativo ispirato allo Spirito Santo, che irrompe nel giorno di Pentecoste nel cenacolo e infiamma i cuori degli apostoli che trovano il coraggio di alzare la testa ed annunciare quello che hanno vissuto. Quello di Ferragina è il tentativo di decifrare, dal testo biblico, lo Spirito Santo e la sua azione, per mezzo dei colori che esplodono sulla tela.
Blu
 Come rombo di tuono - Acrilico e stucco su tela - Ph_Fulvio Mandrini
Come rombo di tuono - Acrilico e stucco su tela - Ph_Fulvio MandriniIl “come rombo di tuono” dell’evento di Pentecoste - così come ce lo descrive l’autore degli Atti - si può davvero percepire, quasi fisicamente, nelle spirali circolari fatte di un blu intenso, alternate a lampi che rifulgono di un giallo accecante, che paiono voler colpire proprio il nostro sguardo di osservatori.
Pentecoste - Acrilico e stucco su tela-Ph_Fulvio Mandrini
Il fuoco spirituale che discende e infiamma l’umanità degli apostoli, si concreta invece in rosse pennellate di colore sul giallo corporeo dei protagonisti, fiamme che danno nuova vita alla finitezza degli uomini, come fosse una seconda creazione.
Vieni Spirito Santo - Pointilisme acrilico - Ph_Fulvio Mandrini
Si può quindi ammirare la molteplicità delle genti e delle lingue riunite dalla forza dello Spirito, nella suggestiva galassia di punti di colore, distinti, tuttavia tenuti insieme dalla forza divina. I passi biblici o di antiche liturgie, accompagnano il percorso espositivo, quadro dopo quadro, opera dopo opera, creando un legame perfetto tra parole e immagini. Il tutto nella cornice della chiesa ex-parrocchiale, che è un edificio suggestivo, da poco restaurato, che è un luogo naturale per chi voglia dialogare con il proprio io più profondo.
Quadro3 Come lingue di fuoco. Acrilico e stucco su tela - Ph_Fulvio Mandrini
Personalmente trovo che il confronto con un’arte tanto potente, nata da un’interiorità così genuina e profonda, sia veramente un’esperienza da sperimentare. Dapprincipio forse, soprattutto se abituati alle forme dell’arte figurativa classica, si potrebbe provare un senso di straniamento, al cospetto stavolta di opere di arte sacra contemporanea. Ben presto però, l’incontro emozionale tra i mondi spirituali di Ferragina e di chi osserva le sue opere, ne chiarisce in modo naturale la comprensione, ponendo interrogativi e riempiendo di curiosità, spunti di riflessione e di quel senso di pienezza che deriva dalla contemplazione del bello. Una bellezza che, in virtù dello scambio spirituale costante, sta sì nei dipinti, ma che anche, di riflesso, vive anche dentro di noi.
Quadro4 Bagna ciò che è arido. Acrilico e stucco su tela - Ph_Fulvio Mandrini
Se volete regalarvi un tempo che sia solo per voi, a Pozzo d’Adda, alle porte di Milano, sabato 26 e domenica 27 maggio, potete perciò trovare quella vera e propria oasi che, nel nome dell’arte e della spiritualità, è pronta non solo a farvi delle domande, ma forse, a darvi anche delle risposte.
INGRESSO LIBERO
sabato 26 maggio: 10-12/15-18.30;
 domenica 27 maggio: 10-12.
domenica 27 maggio: 10-12.Tutte le foto di: Fulvio Mandrini
* FONTE: "MaQ": MILANO AL QUADRATO. (ripresa parziale, senza immagini).
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. -- 1948-2018. Tante impronte sulla Carta. Nella Costituzione idee cattoliche, liberali, marxiste. E tracce del fascismo (di Sabino Cassese)11 aprile 2018, di Federico La Sala
1948-2018 Un estratto del saggio di Sabino Cassese sulla «Rivista trimestrale di diritto pubblico» (Giuffrè)
Tante impronte sulla Carta
Nella Costituzione idee cattoliche, liberali, marxiste. E tracce del fascismo
di Sabino Cassese (Corriere della Sera, 10.04.2018)
Nel 1995, Massimo Severo Giannini, uno degli studiosi che prepararono la Costituzione, riassumeva così la sua valutazione della Carta costituzionale del 1948: «Splendida per la prima parte (diritti-doveri), banale per la seconda (struttura dello Stato), che in effetti è una cattiva applicazione di un modello (lo Stato parlamentare) già noto e ampiamente criticato». Da dove è stata attinta questa prima parte «splendida», quale è stata l’«officina di idee» che l’ha prodotta?
Piero Calamandrei ha fornito una chiave per individuare le fonti ideali delle norme costituzionali quando ha detto, nel 1955, che esse furono «il testamento di centomila morti, scritto con sangue di italiani nel tempo della Resistenza», ma anche «un punto di ripresa del pensiero politico-civile italiano, dove parlano le “grandi voci lontane” di Beccaria, Cavour, Pisacane, Mazzini».
La Costituzione ebbe una breve gestazione - non più di un triennio -, ma la sua maturazione ideale non fu altrettanto breve. Essa non nacque come Minerva armata dalla testa di Giove. Vi sono intessute culture, aspirazioni, esperienze, ideologie di diversa provenienza, di epoche differenti.
Di questo contenuto profondo dei principi costituzionali non posso fare qui che qualche esempio, e soltanto in forma interrogativa, avanzando ipotesi. Come arriva la diade della Costituzione termidoriana (non delle precedenti Costituzioni francesi rivoluzionarie) «diritti e doveri» negli articoli 2 e 4, nonché nel titolo della parte prima della Costituzione italiana? Non bisogna riconoscere dietro alla formula del secondo comma dell’articolo 3, quello sull’eguaglianza in senso sostanziale, la critica marxista della eguaglianza meramente formale affermata dalle Costituzioni borghesi e il successo che solo pochi anni prima, nel 1942, aveva avuto anche in Italia il «piano Beveridge» con la sua libertà dal bisogno? Come spiegare la circostanza che dei 1357 lemmi della Costituzione uno di quelli che hanno il maggior numero di occorrenze è «ordinamento», senza capire che «così dalla prima commissione la grande ombra di Santi Romano si estendeva all’Assemblea, come se il piccolo libro fosse stato scritto a favore dei Patti Lateranensi», come notato nel suo solito stile immaginifico da La Pira nel suo intervento sull’articolo 7?
 Ed è possibile ignorare la lunga storia del cattolicesimo italiano e del suo rifiuto dello Stato (la «questione romana»), che si intreccia con l’idea romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici o ispira le norme dove si afferma, prima che lo Stato garantisca i diritti o promuova le autonomie, che questi vadano riconosciuti, e quindi, preesistono allo Stato, consolidando quindi il pensiero della corrente antipositivistica (perché lo Stato viene dopo le persone, le «formazioni sociali» e gli ordinamenti originari non statali)?
Ed è possibile ignorare la lunga storia del cattolicesimo italiano e del suo rifiuto dello Stato (la «questione romana»), che si intreccia con l’idea romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici o ispira le norme dove si afferma, prima che lo Stato garantisca i diritti o promuova le autonomie, che questi vadano riconosciuti, e quindi, preesistono allo Stato, consolidando quindi il pensiero della corrente antipositivistica (perché lo Stato viene dopo le persone, le «formazioni sociali» e gli ordinamenti originari non statali)?
 Si possono comprendere le norme costituzionali sul patrimonio storico e artistico e sulla scuola ignorando l’elaborazione, in periodo fascista, a opera di Giuseppe Bottai, di Santi Romano, di Mario Grisolia, della legislazione sulle cose d’arte e della «carta della scuola», quindi senza riconoscere che la Costituzione antifascista ha raccolto anche l’eredità del fascismo? Infine, come intendere la portata dei programmi economici per indirizzare a fini sociali l’impresa privata, senza considerare una duplice esperienza, quella della pianificazione economica sovietica e quella del New Deal rooseveltiano?
Si possono comprendere le norme costituzionali sul patrimonio storico e artistico e sulla scuola ignorando l’elaborazione, in periodo fascista, a opera di Giuseppe Bottai, di Santi Romano, di Mario Grisolia, della legislazione sulle cose d’arte e della «carta della scuola», quindi senza riconoscere che la Costituzione antifascista ha raccolto anche l’eredità del fascismo? Infine, come intendere la portata dei programmi economici per indirizzare a fini sociali l’impresa privata, senza considerare una duplice esperienza, quella della pianificazione economica sovietica e quella del New Deal rooseveltiano?Nel melting pot costituente, furono raccolte, messe insieme, ordinate queste diverse idee, culture, esperienze, e altre ancora, che si mescolavano all’esigenza di riportare libertà e rispetto per i diritti nel Paese. La Costituzione rappresentò una reazione al regime illiberale fascista, ma fu anche il precipitato di ideali di epoche diverse (risorgimentale, liberaldemocratica, fascista), Paesi diversi (specialmente quelli che si dividevano il mondo, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica), aree diverse (quella cattolica, quella socialista e comunista, quella liberale), orientamenti dottrinali opposti (quello statalistico e quello pluralistico).
Calamandrei ebbe l’intelligenza di riconoscere questo sguardo lungo della Costituzione, ma - forse prigioniero dell’idea che la Resistenza fosse un secondo Risorgimento - si fermò alla segnalazione del contributo ideale di autori lontani, Mazzini, Cavour, Cattaneo, Garibaldi, Beccaria. Nel discorso del 1955 tralasciò il contributo che proveniva da altri Paesi e da epoche più vicine, specialmente dal fascismo, un contributo che prova la lungimiranza degli autori della Costituzione, antifascisti che recuperarono l’eredità del fascismo (ma questo a sua volta aveva sviluppato ideali e proposte dell’età liberale).
Questo risultato non fu sempre positivo, come osservava Giannini, perché la seconda parte della Costituzione (o, meglio, quella relativa alla forma di governo) sembrò dimenticare proprio la lezione del passato, come alcuni costituenti dissero ai loro colleghi, ricordando che anche dalle debolezze del sistema parlamentare liberale era scaturito il fascismo. Ciò avrebbe richiesto un sistema di stabilizzazione dei governi, pure auspicato da molti (e anzi accettato in linea di principio dalla ampia maggioranza che votò l’ordine del giorno Perassi), secondo il quale il sistema parlamentare doveva avere «dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e a evitare degenerazioni del parlamentarismo».
Come osservava Paolo Ungari molti anni or sono, «l’intera vicenda della cultura giuridica italiana fra le due guerre dovrebbe essere attentamente ripercorsa, e non solo al livello delle discussioni universitarie, per rendersi conto del patrimonio di idee e di tecniche degli uomini che sedettero nelle varie commissioni di studio del periodo intermedio, dalla commissione Forti a quella sulla “riorganizzazione dello Stato”, nonché alla Consulta e alla Costituente stessa».
-
> Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e -- Il destino ambiguo del Concordato. Nella Costituzione senza esserlo (di Roberto Finzi).30 marzo 2018, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ... *
Diritto
Nel saggio di Daniele Menozzi (Carocci) la storia di come la Carta regolò i rapporti tra Stato e Chiesa
Nella Costituzione senza esserlo. Il destino ambiguo del Concordato
I tessitori. Dossetti e Togliatti con il liberale Lucifero trovarono la soluzione sancita nell’articolo 7
di Roberto Finzi (Corriere della Sera, 30.03.2018)
Non c’è dubbio che tra i «principi fondamentali» che reggono la nostra Repubblica racchiusi nei primi dodici articoli della Carta del 1948 (cui Carocci dedica una serie diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati) il più controverso sia stato (in parte continui a essere) l’articolo 7 o meglio, e soprattutto, il primo asserto del suo secondo comma. Se, al di là delle sfumature, ogni forza politica e ogni cittadino, poteva ammettere che «lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» perplessità e opposizioni nascevano e continuarono dalla affermazione che seguiva: «I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi», firmati, come si sa, da Benito Mussolini e dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri l’11 febbraio 1929, regnante Achille Ratti, Papa Pio XI. Sanavano la «questione romana» apertasi con la presa di Roma. Con accordi e norme complicate tra cui due particolarmente odiose per un Paese che - dopo un decennio di guerre e la doppia occupazione nazista e alleata - si era scrollato di dosso la dittatura anche attraverso la Resistenza e stava lavorando non solo al ritorno delle civili libertà ma a una democrazia nuova, repubblicana come aveva decretato il voto del 2 giugno 1946.
Si trattava dell’asserto che quella cattolica era la religione «di Stato» e, per la sua pervasività, dell’attribuzione degli effetti civili al matrimonio religioso. Con il paradosso che chi riteneva il matrimonio un sacramento poteva, per le norme del diritto canonico, ottenerne la nullità, riconosciuta poi dallo Stato e chi invece aveva del matrimonio una concezione puramente civile era destinato a essere legato a vita, indissolubilmente, non per diretta conseguenza dei Patti, ma per la coincidenza nella visione della famiglia tra Chiesa e fascismo. Nel quadro per di più di un diritto di famiglia in cui era sancita una netta subordinazione della donna.
Nella sua ricostruzione del formarsi del dettame costituzionale e poi dei suoi effetti nella vita democratica italiana ( Art.7. Costituzione italiana ), Daniele Menozzi non nega le conseguenze negative del permanere di quelle norme specie nel quindicennio successivo alla emanazione della Carta Costituzionale. Ci offre però una chiave di lettura della formazione e del senso della norma più articolata, che affonda le sue radici nella complessità del problema cattolico nella storia dell’Italia unita e soprattutto a quel punto della vicenda del nostro Paese.
La Chiesa, lo dimostreranno le successive elezioni del 18 aprile 1948, aveva ancora un forte ascendente sulla popolazione ed era una Chiesa che, seppure - si vedrà di lì a poco - intimamente percorsa da interne pulsioni verso il nuovo, era ancora fortemente contraria al mondo moderno e alle sue forme politiche. In particolare a quelle di matrice socialista e comunista. Ora, si trattava, in sostanza - spiega Menozzi con precisione e acribia filologica - di attirare, per così dire, la Chiesa verso la accettazione piena di quella democrazia che si andava delineando nel lavoro della Costituente, cedendo in via formale alle sue richieste anche se nell’immediato contraddittorie con quella visione.
Protagonista di questa operazione complicata e sottile fu in primis Giuseppe Dossetti che univa alla sua profonda fede cristiana una visione non ierocratica della Chiesa, la competenza giuridica del canonista di vaglia, cristalline convinzioni democratiche, saldi legami con le altre culture politiche formatisi nella Resistenza. Dossetti trovò una sponda in Palmiro Togliatti, a lungo, e tutt’oggi, accusato di avere, in qualche modo permesso un inquinamento della Costituzione con il riconoscimento nel suo testo dei famigerati Patti Lateranensi.
L’atteggiamento del leader del Pci derivava dal convincimento che nella Repubblica dovessero riconoscersi per davvero tutti gli italiani e pure, dice Menozzi, da considerazioni più immediatamente politiche. Mentre stava costruendo il «partito nuovo» guardava alla possibilità di una adesione al Pci di cattolici. Così temuta dalla Chiesa pacelliana che nel 1949 il Papa scomunicherà i comunisti.
Io aggiungerei due aspetti. Togliatti era ben consapevole di quanto Milovan Gilas nelle sue Conversazioni con Stalin ricorda avergli detto il dittatore sovietico: «Questa guerra (...) è diversa da tutte quelle del passato; chiunque occupa un territorio gli impone anche il suo sistema sociale». E infine la lotta per l’egemonia all’interno della sinistra. In quel campo i socialisti, allora sotto la sigla Psiup, erano ancora, seppure non di molto, maggioritari rispetto al Pci.
Per ben intendere la vicenda al quadro manca un tassello. Decisivo. Si tratta della seconda parte del secondo comma dell’articolo 7 che recita: «Le modificazioni dei Patti (Lateranensi), accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». In tal modo si eliminava una delle più forti obiezioni all’inserimento dei Patti in Costituzione. Per tale via infatti non venivano «costituzionalizzati» ché la loro modifica poteva avvenire per legge ordinaria. L’artefice di questo accorgimento essenziale fu Roberto Lucifero, liberale e monarchico.
Così l’articolo, nota Menozzi, «appariva formulato con il concorso di tre diverse famiglie politiche: la democristiana, la comunista e la liberale».
La «non costituzionalizzazione» dei Patti - in un modo profondamente cambiato all’interno e soprattutto all’esterno della Chiesa - sarà uno degli elementi che permetterà all’Italia l’adozione formale, prima sul terreno parlamentare e quindi - con i referendum del 1974 e del 1981 - attraverso la conferma popolare di decisive riforme come il divorzio e l’interruzione volontaria di gravidanza. E del nuovo diritto di famiglia.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
 LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
 CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e la testimonianza di venti cristiani danesi
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
Federico La Sala
- TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. -- "Croce e l’ansia di un’altra città". Tra Croce e Marx. Quale terza via?3 luglio 2017, di Federico La Sala
- VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e la testimonianza di venti cristiani danesi (ricerca scientifica)
Tra Croce e Marx. Quale terza via?
di Michele Martelli *
Molti gli articoli su giornali e settimanali in occasione dell’anniversario dell’assassinio per mano fascista di Carlo Rosselli e suo fratello Nello a Parigi nel 1937. E in tanti (Eugenio Scalfari in primis) hanno (ri)scoperto l’imperituro valore del liberalsocialismo, o liberalismo sociale, o sinistra liberale che dir si voglia, e, si può aggiungere, destra socialista, o socialdemocrazia, o liberaldemocrazia.
Che proprio la stessa cosa non sono, mi pare, dato che il significato è diverso, a seconda che si metta l’accento sul sostantivo (liberalismo, socialismo e democrazia, mi pare, non sono sinonimi) o sull’aggettivo (liberale non è uguale a sociale o a democratico). O che se ne ricostruisca le specifiche origini storiche, l’evoluzione e il valore ideologico.
«Un pasticcio», sentenziava Benedetto Croce, da respingere, perché sintomo di confusione di idee e di intellettualismo astratto. Giudizio che, sicuramente troppo severo e ingeneroso, si riferiva in particolare al liberalsocialismo italiano, una variegata corrente di pensiero filosofico-politico antifascista nata negli anni Trenta, e confluita poi nel Partito d’Azione (1942-1947). Gli esponenti di tale corrente furono infatti tra gli attori principali della lotta partigiana e della costruzione dell’Italia repubblicana: la loro teoria, quindi, non era slegata dalla prassi. Da una prassi coerentemente antifascista.
D’altronde, mentre Croce godeva, certo meritatamente, dell’aureola di «guida morale dell’antifascismo», Carlo Rosselli, autore del famoso opuscolo Socialismo liberale (1929), era però tra gli organizzatori della resistenza antifranchista in Spagna e da Radio Barcellona diffondeva la parola d’ordine: «Oggi in Spagna, domani in Italia!». Anche per questo fu barbaramente trucidato dai sicari fascisti.
 All’antifascismo partigiano apparterranno poi, come si sa, i più noti intellettuali e filosofi liberalsocialisti italiani, tra cui Piero Calamandrei, Guido Calogero, Norberto Bobbio, Guido de Ruggero, Aldo Capitini, a cui diversi altri se ne potrebbero aggiungere. Né va dimenticato che Ferruccio Parri, membro azionista del CLN, sarà il primo Presidente del Consiglio (21 giugno-10 dicembre 1945) dell’Italia liberata. E che la Costituzione italiana del 1948 non sarebbe stata quella che è, una delle migliori al mondo, senza l’apporto decisivo degli esponenti del liberalsocialismo e dell’azionismo.
All’antifascismo partigiano apparterranno poi, come si sa, i più noti intellettuali e filosofi liberalsocialisti italiani, tra cui Piero Calamandrei, Guido Calogero, Norberto Bobbio, Guido de Ruggero, Aldo Capitini, a cui diversi altri se ne potrebbero aggiungere. Né va dimenticato che Ferruccio Parri, membro azionista del CLN, sarà il primo Presidente del Consiglio (21 giugno-10 dicembre 1945) dell’Italia liberata. E che la Costituzione italiana del 1948 non sarebbe stata quella che è, una delle migliori al mondo, senza l’apporto decisivo degli esponenti del liberalsocialismo e dell’azionismo.Questa temperie culturale, politica e filosofica viene scandagliata a fondo dal recente libro di Francesco Postorino, Croce e l’ansia di un’altra città, Milano, Mimesis, 2017. Il titolo può servire da bussola al lettore nella complessa problematica del volume, in cui il giovane e valente autore, dopo aver esposto, nella Prima parte, la sintesi del pensiero filosofico-politico di Croce, delle sue aporie e contraddizioni interne, ricostruisce con passione e intelligenza critica, nella Seconda e Terza parte, la fitta trama di relazioni di incontro-scontro tra Croce e gli intellettuali di cui sopra.
Comune era il riferimento ideale al valore insopprimibile del liberalismo. Ma notevoli le differenze. Per Croce il liberalismo era un concetto metapolitico, che, pur incarnandosi nella storia, era, in un certo senso, sovrastorico, e nulla aveva a che fare con la prassi partitica e la contingenza degli eventi: in fondo, un altro nome della sua «religione della libertà», della libertà assoluta dello Spirito e delle sue forme (arte, filosofia, economica e morale). Ipostatizzando una presunta «storia ideale eterna dello Spirito», Croce tuttavia finiva di fatto, senza volerlo, col rovesciare contraddittoriamente la Libertà in Necessità.
Due le conseguenze logiche. O tutto ciò che è accaduto e accade è opera dello Spirito, e allora nulla poteva e può accadere di diverso da ciò che è accaduto e accade; in tal caso il determinismo, seppur spirituale, regnerebbe sovrano, non la «Dea-Libertà». Oppure non tutto è opera dello Spirito, ma solo l’eterno e l’ideale, da distinguere dal contingente e dal particolare. Ma poiché il contingente e il particolare esistono, seppur in forma debole, resta da sapere: 1) da dove essi derivano, se non derivano dallo Spirito?; 2) poiché lo Spirito, fino a prova contraria, non parla né opera in prima persona, chi è il suo portavoce o sacerdote, a chi umanamente è da attribuire quel sacro potere di distinzione tra eterno e contingente? Non resterebbe che la strana ipotesi che quel sacerdote, dio sa con quale diritto, sia Croce medesimo: non a caso Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere lo chiama «una specie di papa laico» della cultura italiana e mondiale. E la parola del papa, come ogni credente sa, è infallibile.
Si spiegherebbe così perché, per esempio, il conservatore Croce abbia prima appoggiato l’ascesa del fascismo in chiave filoliberale e anticomunista, votando da senatore la fiducia al governo Mussolini anche dopo il delitto Matteotti, e poi l’abbia definito banalmente una «parentesi» nella storia d’Italia. E il nazismo? Un’altra parentesi? Di questo passo, la storia reale non sarebbe, in gran parte, che un succedersi ininterrotto di parentesi. Una storia parentetica.
 Una sorta, diciamo così, di vacanza permanente dello Spirito. Con quali orribili conseguenze per milioni di poveri mortali, forse poco importa. Del resto, non sarà un risibile ducetto col moschetto e un anonimo imbianchino con la svastica ad arrestare l’inarrestabile marcia dello Spirito. E l’Urss? Il regno satanico dell’Orrore. Ma la fede nello Spirito non vacilla: cristianamente, portae inferi non praevalebunt! Il fatto è che, nonostante i continui e sofferti ripensamenti, Croce non mise mai in discussione i presupposti speculativi del suo pensiero.
Una sorta, diciamo così, di vacanza permanente dello Spirito. Con quali orribili conseguenze per milioni di poveri mortali, forse poco importa. Del resto, non sarà un risibile ducetto col moschetto e un anonimo imbianchino con la svastica ad arrestare l’inarrestabile marcia dello Spirito. E l’Urss? Il regno satanico dell’Orrore. Ma la fede nello Spirito non vacilla: cristianamente, portae inferi non praevalebunt! Il fatto è che, nonostante i continui e sofferti ripensamenti, Croce non mise mai in discussione i presupposti speculativi del suo pensiero.All’assolutismo e al conservatorismo del «papa laico» gli intellettuali liberalsocialisti italiani, crociani o non crociani, eretici e dissidenti, si opporranno, in modi diversi, con idee filosofiche, giuridiche e politiche diverse, in un dibattito ricco e sfaccettato, come Postorino documenta nei vari capitoli dedicati al confronto tra la filosofia di Croce e le teorie di Calamandrei (umanesimo giuridico e principio di equità), Calogero (dialogica dell’«io», del «tu», e del «lui» che è un «tu»), de Ruggero (dialettica neoilluministica di ragione e storia), Bobbio (teoria procedurale della liberaldemocrazia) e Capitini (nonviolenza e omnicrazia).
Tutti accomunati dalla ricerca di una «terza via», caratterizzata, come Postorino a più riprese ribadisce, dalla tensione tra fatti e valori, essere (Sein) e dover essere (Sollen). Per sfuggire alle dure critiche mosse dal realismo conservatore crociano agli ideali liberalsocialisti (sulla scia delle critiche, ben più efficaci, di Hegel a Kant), occorrerebbe però una filosofia universalistica dei valori e del Sollen. Ma il problema è: «Si può fare?», per usare una frase oggi consueta. Ossia, come evitare di cadere in un nuovo assolutismo e dogmatismo? Oppure, per dirlo in positivo, come costruire, se «Dio è morto», un relativismo critico e al tempo stesso non nichilistico, ma propositivo e progettuale?
Un’ultima annotazione. Oggi ancor più di ieri, dato il trionfo globale del neoliberismo, il vertiginoso aumento delle disuguaglianze sociali e il fallimento delle «terze vie» più o meno clintoniane e blairiane (da noi tradotto, o non è molto, nel «terzismo» dalemian-bersaniano, rovesciatosi poi, per eterogenesi dei fini, nei disastrosi programmi neoliberisti e anticostituzionali del renzismo), a me sembra che «l’ansia di un’altra città» non possa prescindere dal misurarsi con Marx, con la sua teoria del Capitale e della lotta di classe (da assumere non come dogma, ma come strumento di ricerca, fallibile e rivedibile).
Croce l’aveva fatto nel lontano 1900, ma per sancire illusoriamente «la morte» definitiva «del marxismo teorico» (oggi, dopo più di un secolo, più vivo che mai nelle analisi di sociologi politici ed economisti di fama mondiale»). «Né con Marx né contro Marx», aveva dichiarato Bobbio: ma basta essere neutrali? Tutti gli altri liberali di cui sopra avevano sposato il socialismo senza Marx.
 Probabilmente non sapevano dell’inaudita «svolta» filomarxista del loro capostipite, Carlo Rosselli, resosi conto, a quanto pare, nell’ultimo periodo della sua vita, che un «socialismo liberale» senza o contro Marx, a fronte della brutalità del capitalismo reale (rappresentato attualmente dal neoliberismo selvaggio di matrice angloamericana e dall’Ordoliberalismus austeritario di matrice germanica), rischia purtroppo di essere inane, monco o utopico.
Probabilmente non sapevano dell’inaudita «svolta» filomarxista del loro capostipite, Carlo Rosselli, resosi conto, a quanto pare, nell’ultimo periodo della sua vita, che un «socialismo liberale» senza o contro Marx, a fronte della brutalità del capitalismo reale (rappresentato attualmente dal neoliberismo selvaggio di matrice angloamericana e dall’Ordoliberalismus austeritario di matrice germanica), rischia purtroppo di essere inane, monco o utopico. -
> BENEDETTO CROCE E IL TRAMONTO DELL’EPOCA MODERNA - Perché Croce piace all’estero ma non è profeta in patria (di Roberto Esposito)22 settembre 2016, di Federico La Sala
TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE:
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
Perché Croce piace all’estero ma non è profeta in patria
A Napoli un convegno sulla sua grande fortuna internazionale conferma la necessità di riscoprirne il valore anche qui in Italia
di Roberto Esposito (la Repubblica, 22.09.2016)
La figura di Benedetto Croce ha spesso diviso i pareri, ponendo più di un interrogativo sul suo posto all’interno della filosofia moderna. Qualcuno, con qualche eccesso, si è spinto a parlare di un mistero di nome Croce. Come conciliare, ci si chiede, un profilo teoretico non troppo netto, più da grande intellettuale che da filosofo vero e proprio, con il suo crescente successo internazionale? Perché su quest’ultimo non vi sono dubbi. Basta scorrere il programma del Convegno di Napoli in programma oggi e domani presso l’Istituto di studi storici - organizzato dalla Fondazione che porta il suo nome, inaugurato questa mattina dal presidente Sergio Mattarella, e intitolato appunto La diffusione internazionale dell’opera di Benedetto Croce - per averne conferma.
Dall’Inghilterra alla Germania, dagli Usa al Canada, dalla Cina al Giappone, l’opera di Croce è oggetto di un interesse che non ha uguali, forse con l’eccezione di Gramsci, nel panorama italiano del ’900. Né si tratta di una scoperta recente. Il suo Breviario di estetica elabora una serie di lezioni tenute nel 1912 al Rice Institute di Huston. Come Aesthetica in nuce è lo sviluppo della voce Estetica scritta per l’Encyclopaedia Britannica, con Bohr e Einstein.
A cosa addebitare tale travolgente successo per un autore così lontano dai canoni della filosofia contemporanea - per intenderci, da Husserl e Heidegger, Wittgenstein e Bergson, Sartre e Adorno?
La risposta va cercata in una duplice direzione, come dimostrano due vaste sillogi appena pubblicate, Croce e Gentile. La cultura italiana e l’Europa, a cura di Michele Ciliberto per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, e Lessico crociano. Un breviario filosofico- politico per il futuro, a cura di Rosalia Peluso per La Scuola di Pitagora.
Intanto Croce strinse una serie di relazioni con i maggiori intellettuali del tempo, da Sorel a Vossler, a Collingwood, che diffusero la sua opera in Europa. Stimata da personaggi del calibro di Weber, Meinecke, Dewey, Ortega e Zambrano.
Già al centro del dibattito europeo sul marxismo e la sua crisi, la sua figura crebbe durante la prima guerra mondiale, quando rifiutò ogni atteggiamento grettamente nazionalistico. E poi, ancora di più, quando assunse il ruolo di capo dell’opposizione morale al fascismo. Ma anche dopo la seconda guerra, egli si situa allo stesso livello di grandi autori liberali quali Aron, Popper, Berlin, come ricorda Corrado Ocone nel recente Il liberalismo del ‘ 900. Da Croce a Berlin (Rubettino).
E allora? Da dove nasce quest’aria di sufficienza nei suoi confronti? Da un lato dal rovesciamento speculare del provincialismo patriottico che certamente ha caratterizzato il Ventennio italiano in una sorta di pregiudizio antitaliano che ha portato alla liquidazione della nostra cultura filosofica primonovecentesca, catalogata come neo-idealismo. Dall’altro dalla marcata eterogeneità del lessico concettuale crociano rispetto alle scuole filosofiche più in voga - fenomenologica, esistenzialista, analitica. Alcuni dei problemi sono comuni, ma il linguaggio, la prospettiva, la tonalità di Croce sono molto diversi.
Ma - ecco il punto - è sicuro che tale diversità spinga il filosofo italiano all’indietro? Dipende naturalmente da cosa s’intende per filosofia. Se le si assegna una connotazione logica, analitica o metafisica, con un alto tasso di gergo specialistico. O se la si considera affacciata sul “fuori”, a contatto con la politica, la storia, la vita - come è del resto tipico dell’intero pensiero italiano.
Quando Croce scrive, in polemica con “i filosofi puri” che «la filosofia ha sempre l’origine sua nel moto della vita» e che essa «non può risolvere che i problemi che la vita le propone», intende rompere lo steccato che spesso rinchiude il sapere filosofico entro confini autoreferenziali.
Certo, Croce non avvertì che l’epoca moderna volgeva rapidamente al tramonto. Cercò ancora in essa le chiavi per arrestarne la deriva. E questo non può che allontanarlo da noi, ormai irrimediabilmente postmoderni. Ma, ben lontano dall’abito distaccato e curiale che gli è stato cucito addosso, egli colse con intensità, e talvolta disperazione, i drammi del proprio tempo, cercando, fino all’ultimo, di fronteggiarli.
Benedetto Croce «globale»: un convegno a Napoli poi il seminario in Giappone *
Dopo il convegno che si tiene oggi e domani a Napoli presso l’Istituto italiano per gli studi storici, sarà ancora più difficile bollare l’idealismo di Benedetto Croce (1866-1952) come un pensiero provinciale. L’incontro, organizzato dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce a 150 anni dalla nascita del filosofo, riguarda la diffusione internazionale della sua opera e vi partecipano relatori da tutto il mondo: Paesi anglosassoni, Francia, Europa orientale, America Latina, Cina, Giap-pone.
«Croce - osserva Piero Craveri, presidente della Fondazione - aveva intessuto una fitta rete europea di rapporti, i cui riflessi si avvertivano anche in Asia: la prima traduzione in cinese della sua Estetica è del 1937». E ora a Pechino l’interesse è rifiorito: dal 2000 in poi sono state pubblicate sette opere di Croce.
Il convegno di Napoli, che si apre oggi alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella con una relazione di Giuseppe Galasso, è stato preceduto in maggio da un appuntamento tenuto a Mosca e sarà seguito (il 10 ottobre) da un incontro a Kyoto . «Tanta attenzione - commenta Craveri - deriva dal fatto che Croce è un antidoto alla barbarie. Dinanzi a fondamentalismi, nazionalismi, populismi, c’è bisogno di riscoprire la sua religione della libertà».
* Corriere della Sera, 22.09.2016
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. --- IL PROBLEMA CROCE. A centocinquant’anni dalla nascita di Croce, e ci troviamo dinanzi a un anniversario quanto mai scomodo.9 giugno 2016, di Federico La Sala
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"!
 VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
Forse Croce non è tutto da dimenticaredi Federico Vercellone (La Stampa, 09.06.2016)
Ricorrono i centocinquant’anni dalla nascita di Croce, e ci troviamo dinanzi a un anniversario quanto mai scomodo. Croce costituisce un grande rimosso della cultura italiana.
Non a caso il libro di Paolo D’Angelo, massimo specialista di Croce oggi in Italia, comparso da Quodlibet, s’intitola Il problema Croce. Abbiamo a che fare con il nume che ha dominato la cultura italiana per decenni, che fatica ora a profilarsi nella nostra memoria culturale come quel grande olimpico classico che fu invece in vita.
Trascorso il tempo dell’epica lotta tra crociani e anti-crociani, lasciati dietro di noi i venti di una polemica che segnò in profondità e per decenni la cultura filosofica ed estetica, ora si fa fatica a fare i conti in modo maturo con l’opera di Croce.
E’ significativo per esempio che si siano dedicate almeno tre importanti biografie a Gentile, mentre a Croce nessuna. Il suo sistema appare obsoleto e arretrato il suo atteggiamento culturale anche in forza del polemico atteggiamento nei confronti di discipline come la sociologia e la psicoanalisi.
Alla base della ricezione attuale di Croce resta poi in fondo l’ Estetica del 1902, un’opera che sembra profilarsi come impari rispetto a quelle precedenti e coeve provenienti dalla grande tradizione continentale. Si dimentica a questo proposito, e non è poco, che l’estetica in Italia prima di Croce era ben poca cosa mentre la sua opera ebbe un immediato respiro internazionale. E’ ben vero: nell’Estetica Croce liquida, con un quasi oltraggioso colpo di spugna, tutti le grandi categorie che avevano pervaso la tradizione.
A fronte del dominio assoluto della bellezza da lui sostenuta, venivano messi da parte il comico, il sublime, il patetico, il tragico, l’umoristico, e poi la partizione delle arti e i loro principi specifici. E il critico, privato dei ferri del mestiere, sembrava di colpo indotto ad affidarsi alla sola intuizione per esercitare il proprio mestiere. Nondimeno, guardando all’arte contemporanea, Croce sembra avere anche attualmente qualche buona ragione da mettere in campo. Sono davvero utili oggi quelle distinzioni sovratemporali che mancano infine la realtà concreta e variegata dell’opera d’arte?
Onore dunque al grande umanista retrò che ebbe comunque lampi geniali che ci consentono di avvicinare il presente dell’arte. E poi all’antifascista che seppe dialogare con i vertici della cultura europea in tempi quanto mai difficili, e resistere, da grande e onesto aristocratico, al conformismo della società italiana dell’epoca che permane purtroppo come una nostra inquietante eredità.
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"!
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce --- Croce e il cristianesimo. Il voto sul Concordato (di Sergio Romano).1 marzo 2016, di Federico La Sala
Croce e il cristianesimo. Il voto sul Concordato
risponde Sergio Romano (Corriere della Sera, 01.03.2016)
.***Sono rimasto sorpreso nel leggere che Benedetto Croce non aveva un buon rapporto con la cultura cattolica. Mi chiedo se fosse proprio anticlericale o propugnasse semplicemente la separazione tra Chiesa e Stato. Non mi pare che il Concordato segnasse necessariamente una sottomissione alla Chiesa, per cui l’avversione che Croce manifestò non mi pare giustificata.
 Se l’aveva accettato Mussolini, di cui si ricorda la sfida a Dio di fulminarlo entro cinque minuti, c’è da supporre che il Concordato fosse stato una intesa doverosa. Vorrebbe esprimere la sua opinione?
Se l’aveva accettato Mussolini, di cui si ricorda la sfida a Dio di fulminarlo entro cinque minuti, c’è da supporre che il Concordato fosse stato una intesa doverosa. Vorrebbe esprimere la sua opinione?
 Abelardo Ignoti
Abelardo IgnotiCaro Ignoti,
In una saggio intitolato «Perché non possiamo non dirci cristiani» apparso su La Critica nel 1942, Benedetto Croce scrisse: «Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta: così grande, così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi (...). Tutte le altre rivoluzioni, tutte le maggiori scoperte che segnano epoche nella storia umana, non sostengono il suo confronto, parendo rispetto a lei particolari e limitate».
 Non era una conversione. Quando parlava di «rivoluzione compiuta dalla umanità», Croce escludeva implicitamente interventi ultraterreni e verità rivelate. Benché scritto nel pieno della Seconda guerra mondiale, il saggio fece molto baccano e fu oggetto di diverse interpretazioni. Ma non indusse la Chiesa Romana a modificare il suo giudizio su un filosofo di cui le opere erano state messe all’Indice sin dal 29 giugno 1934.
Non era una conversione. Quando parlava di «rivoluzione compiuta dalla umanità», Croce escludeva implicitamente interventi ultraterreni e verità rivelate. Benché scritto nel pieno della Seconda guerra mondiale, il saggio fece molto baccano e fu oggetto di diverse interpretazioni. Ma non indusse la Chiesa Romana a modificare il suo giudizio su un filosofo di cui le opere erano state messe all’Indice sin dal 29 giugno 1934.Quanto al Concordato, caro Ignoti, Croce non poteva approvare che lo Stato facesse alla Chiesa concessioni destinate a trasformare l’Italia in una specie di condominio. Non gli piaceva, per fare qualche esempio, la creazione di un Ordinariato militare per l’assistenza spirituale delle Forze armate, l’insegnamento religioso impartito nelle scuole medie, l’impegno a non impiegare in un servizio pubblico «sacerdoti apostati o irretiti da censura». Non gli piaceva che il sacerdote, per la celebrazione del matrimonio concordatario, divenisse ufficiale di stato civile e che il Presidente del Consiglio del Regno d’Italia avesse firmato con la Santa Sede due documenti (il Trattato del Laterano e il Concordato) che cominciavano con le parole «In nome della Santissima Trinità».
 Al Senato, quando fu messo ai voti un documento che «plaudiva alla felice soluzione della questione romana», il senatore Croce dette voto contrario insieme a Luigi Albertini, Alberto Bergamini, Emanuele Paternò, Francesco Ruffini e Tito Sinibaldi. Prima di votare, aveva pronunciato un discorso in cui aveva tirato una implicita stoccata a Mussolini con queste parole: -«Accanto e di fronte agli uomini che stimano Parigi valer bene un messa» vi sono quelli «per i quali l’ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi perché è affare di coscienza».
Al Senato, quando fu messo ai voti un documento che «plaudiva alla felice soluzione della questione romana», il senatore Croce dette voto contrario insieme a Luigi Albertini, Alberto Bergamini, Emanuele Paternò, Francesco Ruffini e Tito Sinibaldi. Prima di votare, aveva pronunciato un discorso in cui aveva tirato una implicita stoccata a Mussolini con queste parole: -«Accanto e di fronte agli uomini che stimano Parigi valer bene un messa» vi sono quelli «per i quali l’ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi perché è affare di coscienza». -
> VENI, CREATOR SPIRITUS.Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e -- La religione di Gentile (di Giuseppe Bedeschi).31 gennaio 2016, di Federico La Sala
Tra spirito e pensieroLa religione di Gentile
di Giuseppe Bedeschi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 31.01.2016)
- Giovanni Gentile, Discorsi di religione, a cura di Paolo Bettineschi, Orthotes Editrice, Nocera, pagg. 176, ?€ 16,00
Nel 1935 Giovanni Gentile tenne una conferenza all’Università di Praga, che poi pubblicò sul «Leonardo» col titolo«Il carattere religioso dell’idealismo italiano» (con questa espressione, “idealismo italiano”, egli intendeva la propria filosofia, il cosiddetto “attualismo”, data la rottura drammatica e insanabile intervenuta fra lui e Croce). In tale conferenza Gentile sosteneva che la forza del proprio idealismo stava nel suo carattere religioso, che tante avversioni, ma anche tanti entusiasmi, aveva suscitato.
Carattere religioso perché? Perché, spiegava il filosofo siciliano, la religione entra in tutti i pensieri degli uomini, laddove ogni arte o scienza particolare si contenta di una sfera determinata di interessi; allo stesso modo «la filosofia [idealistica] partecipa di questo carattere totalitario e perciò vitale o etico della religione».
È vero, diceva Gentile, che la filosofia accentua il motivo della ragione e della libertà, ossia dell’infinità dell’umana natura in quanto realtà pensante, autocoscienza e persona; ma non perciò nega il limite e la necessità in cui questa personalità si trova, di superare se stessa; anzi fa consistere in ciò l’essenza della realtà spirituale, nel trascendere se stessa e attingere nella realtà trascendente - nella sua realtà trascendente - la realtà.
Perciò, aggiungeva Gentile, l’idealismo italiano contemporaneo non solo non credeva di lasciare inappagata nessuna reale esigenza religiosa dello spirito, ma riconosceva nel Cristianesimo la concezione filosofica più alta e più adeguata tra le forme storiche della religiosità. E non solo.
In una celebre conferenza del 1943 («La mia religione») Gentile affermerà di essere non soltanto cristiano, ma anche cattolico. «Ripeto dunque la mia professione di fede, piaccia o dispiaccia a chi mi sta a sentire: io sono cristiano. Sono cristiano perché credo nella religione dello spirito. Ma voglio subito aggiungere, a scanso di equivoci: io sono cattolico».
Cristiano, perché per la religione cristiana Dio è spirito, ma è spirito in quanto l’uomo è spirito, e Dio e uomo nella realtà dello spirito sono due e sono uno, sicché l’uomo è veramente uomo soltanto nella sua unità con Dio. Cattolico, perché la religione, come ogni attività spirituale, è universale, propria di un soggetto che si espande all’infinito: comunità illimitata, nella quale il mio Dio è Dio se è Dio di tutti.
A questa concezione, Paolo Bettineschi (che ha curato una bella edizione dei Discorsi di religione di Gentile, con un ampio saggio introduttivo, per i tipi di Orthotes) obietta che, «piuttosto che avvicinare i due poli del divino e dell’umano - stringendoli in buona unità e rendendoli solidali - l’attualismo abbatte la verità della distinzione che passa tra uomo e Dio, e quando parla di unità dei due, intende in effetti la loro identità, il loro essere una sola realtà, non già il loro stare insieme che sarebbe il loro vero abbracciarsi». Obiezione fondata, mi pare, da un punto di vista logico. E tuttavia non si dovrebbe dimenticare, da un punto di vista storico, che - come osservò un eminente studioso cattolico, Adriano Bausola - la carica di religiosità dell’attualismo fu un fattore di attrazione per molti, e preparò la strada ad alcuni giovani pensatori, destinati a diventare tra i maggiori esponenti dello “spiritualismo cristiano”, per approdare poi al cattolicesimo.
Ed è proprio in riferimento a questi temi che si misura tutta la distanza fra Gentile e Croce, e si colgono i motivi profondi della loro rottura. Nella Storia d’Italia dal 1871 al 1918 Croce definì l’attualismo come un «nuovo irrazionalismo», «un misto di vecchia speculazione teologica e di decadentismo, tra lo stil dei moderni e il sermon prisco». Perciò, affermava Croce, egli ne prese subito le distanze, nonostante il rapporto di stretta collaborazione che lo aveva unito precedentemente a Gentile, il cui “idealismo attuale” si sarebbe sempre più apertamente svelato (sono parole del filosofo napoletano) «come un complesso di equivoche generalità e un non limpido consigliere pratico».
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. ---" La memoria, la vita, i valori. Itinerari crocian". L’importanza di fare i conti con Croce (di U. Curi)6 novembre 2015, di Federico La Sala
L’importanza di fare i conti con Crocedi Umberto Curi (Corriere della Sera, 06.11.2015)
Con il titolo Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, nel 1907, compariva presso la casa editrice Laterza un’opera destinata a costituirsi come punto di riferimento obbligato. Autore era Benedetto Croce. La formula impiegata dal pensatore idealista - «ciò che è vivo e ciò che è morto» - era destinata ad essere imitata o parafrasata più volte, perché configurava un «metodo» di analisi estremamente incisivo.
Nella lettura critica di qualunque filosofo (e dunque non solo di Hegel), non si trattava di limitarsi a ricostruirne l’articolazione concettuale. Ciò di cui si sottolineava l’esigenza era la formulazione di un giudizio, teso a cogliere quanto vi fosse ancora di attuale e intramontabile, e quanto vi fosse, invece, di irrimediabilmente caduco. Un vaglio severo ed esigente, quindi, lontano da ogni atteggiamento diplomatico e da ogni servilismo accademico.
Si potrebbe impiegare la stessa fortunata formula per compendiare in estrema sintesi il «taglio» della monumentale opera di Giuseppe Galasso, La memoria, la vita, i valori. Itinerari crociani (a cura di Emma Giammattei, Istituto italiano per gli studi storici, Il Mulino, pp. 551, e 60). A Croce, nel corso degli ultimi cinquant’anni, Galasso aveva già dedicato un gran numero di saggi. Ma nel testo ora pubblicato, pur essendo programmaticamente escluso ogni intento di delineazione complessiva e unitaria della filosofia crociana, Galasso sembra essere attratto dalla prospettiva di individuare, una volta per tutte, «ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Croce», procedendo dunque anche oltre gli importanti risultati raggiunti mediante i lavori precedenti.
Attraverso le tre parole indicate nel titolo, vengono raccolti e ordinati contributi originariamente comparsi in sedi e anni diversi, ricondotti dall’intelligente lavoro della curatrice ad alcuni assi tematici fondamentali, dalla storiografia alla politica, dall’etica all’estetica. Ne risulta un quadro generale mosso e variegato, dal quale balza fuori una figura irriducibile agli schemi tuttora prevalenti.
A Croce è infatti accaduto qualcosa di simile - fatte le debite differenze - alla sorte toccata a un autore da lui assai valorizzato, Karl Marx. Dopo aver dominato in maniera incontrastata la cultura italiana (e non solo filosofica) per oltre mezzo secolo, ed essere stato il «maestro», sia pure in forma indiretta, di legioni di intellettuali, come il pensatore di Treviri, travolto dal crollo del comunismo, così Croce nel secondo Dopoguerra è stato frettolosamente archiviato, liquidando la dialettica dei distinti, originale riformulazione della dialettica hegeliana, con l’etichetta sarcastica della «filosofia delle quattro parolette».
Nella grande maggioranza dei casi, questo passaggio non ha corrisposto a un capovolgimento dell’impostazione critica, ma semplicemente a una sua riconferma: dalla dogmatica soggezione all’autorità di un protagonista inattaccabile, si è transitati a una liquidazione sommaria, non meno aprioristica del consenso precedentemente espresso. Mentre ciò che ancora è utile e per certi aspetti necessario fare è instaurare un atteggiamento opposto, quale è quello che ci pare di cogliere nell’opera di Galasso: ritornare sulle pagine crociane restando al di fuori di ogni prospettiva apologetica, come di ogni attitudine unilateralmente demolitrice.
Cercando, insomma, con obbiettività e rigore, di individuare davvero quel non poco e non marginale che è ancora «vivo», senza avere ritegno a denunciare insieme ciò che appare irrimediabilmente «morto». Dobbiamo essere grati a Galasso per averci offerto una guida preziosa per inoltrarci in un’esplorazione che si preannuncia potenzialmente ricca di importanti scoperte.
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. --- La memoria di Benedetto Croce. Colloquio con Marta Herling, a capo dell’Istituto italiano di studi storici (di Stefania Miccolis)11 marzo 2013, di Federico La Sala
La memoria di Benedetto Croce
Colloquio con Marta Herling, a capo dell’Istituto italiano di studi storici
La nipote del filosofo e figlia dello scrittore polacco Gustaw è la custode di un patrimonio gigantesco in un luogo complesso come Napoli «Una metropoli dura ma dove la cultura può risultare come un antidoto»
di Stefania Miccolis (l’Unità, 10.03.2013)
PALAZZO FILOMARINO? I NAPOLETANI DI SPACCANAPOLI NON SANNO DOVE SI TROVA, MA SE CHIEDI LORO PALAZZO CROCE NON ESITANO CON QUELLA LORO CADENZA MUSICATA a indicarti quel possente grandioso e bellissimo palazzo, con l’ampio atrio ad archi nel quale visse il filosofo Benedetto Croce dal 1911 fino alla sua morte e nel quale oggi oltre alla Fondazione a lui dedicata si trova l’Istituto italiano per gli studi storici fondato proprio da Croce nel 1946.
Entrare nella casa che contiene ancora intatto l’archivio e la biblioteca del filosofo e camminare per i lunghi corridoi e le sale laterali piene di luce e ricoperte di libri, fa sentire tutto il peso della cultura e della tradizione italiana sulle spalle, e quell’orgoglio di identità nazionale che è forse l’unico valore che ci tiene ancora uniti in un Paese politicamente martoriato e culturalmente ferito.
Marta Herling, la nipote di Benedetto Croce, ma anche la figlia dello scrittore polacco Gustaw Herling, è il segretario generale dell’Istituto italiano di studi storici ed è erede di un grande patrimonio intellettuale. Dice: «Il confronto con questi due cognomi non era semplice, ma la cosa più importante è stato instaurare un dialogo, nel senso di continuità, su un piano che era un piano possibile, sia con mio nonno che con mio padre. Il caso vuole che una delle prime case in cui viene accolto Gustaw Herling durante la guerra - dopo l’esperienza nel gulag sovietico sia proprio quella di Croce, villa Tritone a Sorrento. E l’incontro fra i due segna anche l’incontro con la figlia del filosofo, Lidia Croce, una donna dall’intelligenza viva, tutt’ora irrinunciabile consigliera della Fondazione. «Una storia in un certo senso simbolica».
Marta Herling ha scelto di dedicarsi all’Istituto, creato e fondato (grazie soprattutto all’apporto economico della Banca Commerciale Italiana e al direttore Raffaele Mattioli) con una visione per l’avvenire: «In qualche modo un lascito alle giovani generazioni, un lascito al Paese negli anni del dopoguerra, una istituzione che ha avuto poi una importanza straordinaria». Istituzione che ha rischiato grosso per la politica dei tagli più di una volta. Ma resta ancora stabilmente a galla riconosciuto nella sua importanza e nel suo valore da molti, dal presidente Napolitano in primis che anche l’anno scorso ha fatto visita a palazzo Filomarino.
«Una grande gioia», ricorda Marta Herling, una donna che nella vita ha superato numerose sfide. Una è stata quella di cercare un dialogo col padre «tanto che ho a un certo punto deciso di studiare e imparare il polacco perché era uno strumento importante per entrare in contatto con lui, col suo mondo, le sue radici e naturalmente la sua opera». Ora l’archivio di Gustaw Herling si trova nella Fondazione Croce, insieme a quelli delle figlie Alda, Elena, Silvia e della moglie del filosofo, Adele Rossi.
Bisogna distinguere le due istituzioni che hanno due vocazioni differenti, ma profondamente congiunte: la Fondazione biblioteca Benedetto Croce nata dopo la morte del filosofo grazie alla nonna Adele e alle quattro figlie, con lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio bibliotecaarchivio nella dimora di Croce, e l’Istituto italiano per gli studi storici con la funzione diversa di formazione e di ricerca, per giovani laureati e dottori di ricerca.
CARATTERE FAMILIARE
La Fondazione ha un carattere familiare; composta dalla famiglia segue le edizioni delle opere di Croce. Alda Croce ha sempre vissuto a Palazzo Filomarino; garante della continuità, ha tenuto il legame della famiglia all’interno dell’Istituto, ha curato la biblioteca e l’archivio del padre ed è stata il punto di congiunzione, il motore delle due istituzioni che entrambe hanno l’impronta dell’eredità di Croce ma in modo differente: «Una più legata al patrimonio, l’altra con una trasmissione al mondo esterno attraverso l’attività di alta formazione e di ricerca».
Alla fine degli anni ‘90 sono iniziati i progetti di informatizzazione per conservare e tutelare i documenti, oltre a renderli più facilmente accessibili. Si è iniziato col fondo imponente dei carteggi di Benedetto Croce «si valutano più o meno centomila documenti spiega già ordinato in vita da Croce, per anno e per corrispondenti, col suo collaboratore Giovanni Castellano».
Marta Herling racconta: «I documenti vengono schedati analiticamente, riprodotti in formato digitale con un programma che consente poi chiavi di ricerca; adesso c’è la possibilità di consultare un inventario informatico dal 1888 al 1928». Accanto a tale impegno, sin dagli anni ‘60 è stata avviata l’edizione dei carteggi: «Ne sono usciti circa 25 volumi; a seguirli con attenzione e a collaborare all’edizione di alcuni di essi vi era lo studioso Stefano Miccolis e dopo la sua scomparsa non è stato semplice continuare con la stessa scrupolosità».
L’informatizzazione e inventariazione riguarda anche altri fondi dell’archivio e della biblioteca, come per esempio la serie della miscellanea degli scritti su Croce, raccolti da lui stesso: «Raccoglieva, selezionava e annotava tutto ciò che veniva pubblicato su di lui e sulla sua opera: riviste, giornali, molti materiali che è difficile reperire altrove»
L’Istituto di studi storici ha una sua biblioteca che è cresciuta nel corso degli anni: all’inizio è nata col nucleo della biblioteca di Adolfo Omodeo e Federico Chabod , poi è aumentata fino agli attuali 130.000 volumi (donazione più consistente quella di Benedetto Nicolini), con un’importante collezione di riviste soprattutto straniere. È consultabile e aperta agli studiosi, agli studenti, ai laureandi e ai dottorandi che fanno riferimento soprattutto alle università napoletane.
Ogni anno ci sono circa quattordici borsisti che «si stabiliscono a Napoli per i sei mesi della borsa, vivono questa esperienza significativa e importante nell’Istituto: hanno la possibilità di seguire corsi e seminari di studiosi insigni, maestri, di avere rapporti con loro per le proprie ricerche, con un dialogo e uno scambio continuo».
Ci sono poi iniziative alle quali è stato dato il sostegno dell’Istituto: «Di recente le scuole storiche di Napoli hanno costituito un’associazione con l’intento di valorizzare i propri patrimoni, e abbiamo voluto dare la nostra collaborazione ed essere un punto di riferimento per questo progetto, anche per creare un contatto maggiore con il mondo della scuola e dei docenti», «Tenere vivi questi luoghi cotinua Marta Herling è un compito molto bello, ma non semplice in una città dalla realtà molto dura; preservare queste istituzioni con il loro patrimonio, la loro storia, i loro legami a livello nazionale e a livello internazionale, è impegnativo.
Questo cuore di Napoli, questo centro antico, è punto di riferimento di studiosi italiani e stranieri, di giovani borsisti che provengono da esperienze e università diverse, da ambiti disciplinari che vanno dalla storia, alla filosofia, alla letteratura. C’è un’impronta di grande apertura, e l’Istituto ha preso una responsabilità in questa direzione umanistica». «Sono patrimoni e tradizioni fondanti della nostra identità e nonostante le difficoltà, c’è qualcosa di molto forte che fa sperare».
Continuano ad esserci personalità e giovani che credono, che si impegnano e che vogliono tutelare e preservare il patrimonio culturale: «È segno che tali istituzioni possono andare avanti sia con la presenza familiare, che è importante, sia con apporti esterni, come è sempre stato nella compagine dell’Istituto e nella struttura organizzativa».
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. --- La rivincita di Benedetto Croce. Le cinque ragioni per rileggere il filosofo (di Giuseppe Galasso)20 novembre 2012, di Federico La Sala
La rivincita di Croce
Le cinque ragioni per rileggere il filosofo
La libertà come forza motrice nella storia del genere umano
 1952-2012 Lontano dalla metafisica e dal relativismo
1952-2012 Lontano dalla metafisica e dal relativismo
 Un grande maestro a sessant’anni dalla scomparsa
Un grande maestro a sessant’anni dalla scomparsadi Giuseppe Galasso (Corriere La Lettura, 18.11.2012)
Che cosa davvero intendiamo per «attualità» di un pensiero o di un pensatore come Benedetto Croce? «Una questione di attualità, un libro di attualità, palpitante di attualità? Fa un po’ ridere!»: lo diceva Alfredo Panzini, e non solo per un disdegnoso purismo verso il nostro tempo, il nostro sentire e pensare di oggi. Era anche un’esortazione a non identificare l’attualità con la cronaca, col rincorrersi, sempre più frenetico, di quel che ci scorre davanti e che viviamo.
Il problema non è, però, così semplice per le più o meno grandi figure del passato, che vissero nella scia dei loro problemi e interessi, urgenze e bisogni. È molto contraddittorio che agli storici, da un lato, si chieda di non peccare di anacronismo, ossia di non alterare aspetti e uomini del passato rivestendoli dei panni propri di altri tempi; e che, dall’altro lato, li si lodi se sembrano portare il passato e i suoi uomini nel nostro tempo e farne dei nostri contemporanei.
In realtà, a ben vedere, l’attualità che attribuiamo al passato non è quella di un passato che non passa, o una qualità che si ritrovi solo in alcune sue espressioni e non in altre. L’attualità al passato la diamo noi, interrogando ciò che ne resta coi nostri occhi di oggi e ponendo ad esso altre e nuove domande o riformulando quelle già fatte; e sono anche nostre le risposte a tali domande. Non è il passato che viene a noi, siamo noi che lo evochiamo, mossi dai nostri problemi di oggi, e lo facciamo parlare con lingue a noi familiari. Senza alcun arbitrio, però, poiché lo storico deve procedere secondo le norme di una rigorosa filologia, sicché, divenendo parte del presente, il passato non cessi né di essere passato, né di essere diverso dal presente, anche se ne è una condizione di base.
Ecco, in ciò, una prima ragione di «attualità» di Croce. È sua, infatti, una limpida, geniale esposizione del principio da lui definito della «contemporaneità della Storia». E da ciò deriva pure un’altra ragione di sua «attualità», per l’affermazione che la realtà, tutta la realtà in ognuno e in tutti i suoi aspetti, non è «nient’altro che Storia». La storicità è, così, la categoria totalizzante ed esaustiva del reale. La stessa natura non è che Storia solidificata in certe forme; e anche il pensiero è Storia, è la vicenda perenne e dinamica, quale che ne sia il ritmo, della coscienza riflessa dell’uomo, sempre proiettiva, ossia che si spinge in avanti, anche quando sembra il contrario.
La verità muta allora col tempo? Sì e no. Ogni verità è figlia del suo tempo, ma, se è verità, è insieme figlia di ogni tempo. Uno storicismo integrale, dunque, che esclude ogni considerazione extrastorica, ogni riferimento metafisico, ma che in Croce non configura alcun relativismo. La distinzione fra storicismo e relativismo è un cardine del suo pensiero.
La verità si costruisce nel tempo, ma trascende il tempo. Non è semplice eliminazione del falso, mera «falsificazione», operazione negativa che taglia via via i rami secchi del pensiero, bensì un’operazione altamente positiva, che sfronda il passato, lo supera, ma anche lo conserva e lo incrementa nel sempre mutevole presente, con una «verificazione» che comprende ma annulla in sé il momento della «falsificazione». Ossia, in altri termini, il relativismo è l’apparenza di questo processo (ogni tempo ha le sue verità); la progressiva costruzione del grande patrimonio intellettuale e morale dell’umanità ne è, invece, la sostanza.
In questo patrimonio ciò che trascende il proprio tempo diventa «classico», ossia un riferimento per il futuro, che secondo le sue esigenze può in ogni momento evocarlo e riproporselo. In questo senso Croce è un classico, appartiene, cioè, al grande album delle voci durature del passato. Egli, peraltro, pur affermando la Storia e la storicità come unico senso e valore della realtà e del pensiero, è ben lontano dal credere che la Storia e la storicità, ossia la Storia (sono le sue parole) «come pensiero e come azione», siano un tutto indifferenziato.
Il «principio della distinzione» è un altro caposaldo crociano, degno di speciale attenzione per un mondo che oggi è appena (e non tutto) uscito da un’epoca di oppressivi e sanguinari totalitarismi. Croce accetta in pieno il principio hegeliano della dialettica, per cui la Storia, cioè la vita, è strutturalmente fatta di ininterrotte contrapposizioni, che nel suo cammino si sciolgono via via in più alte sintesi. Non accetta, però, la tesi hegeliana di una marcia a termine fisso verso una sintesi totale e finale prefigurata dalla struttura stessa della realtà.
Per lui la realtà è sempre aperta, e gli esiti di quella dialettica sono quali possono essere e si riesce a farli essere nel difficile e sempre faticoso cammino della Storia. Un cammino che, per di più, procede per molte vie, anche se interconnesse: quelle della fantasia, regno dell’arte, e della logica, regno del sapere, e, in parallelo, quelle della volontà individuale, regno dell’utile particolare (o, com’egli dice, dell’economico), e della volontà che si fa universale, regno della morale nella sua integrità e pienezza.
Ciascuna di queste vie o forme è autonoma e valida di per sé ma, data la loro coessenziale partecipazione alla vita del tutto, la realtà procede alternandole e integrandole o superandole in una più alta ragione. Ciascun percorso ha, insomma, la sua legittimità e il suo diritto a farsi valere, ma la vita del tutto non può fermarsi per sempre nell’uno o nell’altro, ed esige e impone che ciascuna forma si affermi nella sua autonomia e nel suo valore, ma non blocchi il procedere della vita e ceda, anzi, il passo alle esigenze del tutto.
Sembra un meccanismo complicato e anche un po’ anarchico, ma non è così. Si tratta solo di una unità del tutto fatta di profonde articolazioni interne e non fossilizzata in nessuna di esse, anzi volta sempre sia a sollecitarle che a superarle, non secondo un calendario prefissato, ma seguendo il ritmo libero e creativo delle sue imprevedibili potenzialità.
Abbiamo detto che Croce teorizzò quattro di queste forme (il bello, il vero, l’utile, l’etico), per cui si ironizzò sulla sua «filosofia delle quattro parole». Ma non è qui la forza della sua riflessione al riguardo, bensì in quella logica della distinzione che non nega l’unità e le sue ragioni ma non le rende esclusive e monopolizzanti.
È in base a tutto ciò che si colgono meglio altre due ragioni per ricordare Croce. Una è relativa alla natura dell’arte (poesia, arti visive, musica e quant’altre ve ne siano), fondata sulla sua profonda liricità (ossia pura intuizione e rappresentazione estetica del sentire e patire) che ci trasmette l’immediata, commossa e piena percezione del bello, ci fa distinguere l’opera creativa della fantasia (con cui si identifica la poesia) da quella dell’immaginazione (che dà luogo a una grande varietà di espressioni, altre da quella poetica) e ci dà un’idea della poesia di incomparabile e perenne specificità di senso e di valore.
L’altra è relativa all’idea che la libertà è la forza motrice della Storia, sempre attiva, anche quando ne appare espulsa o assente. E ciò non per un vuoto ottimismo. È di Croce una drammatica visione delle forze primigenie che animano la vitalità dell’uomo e la sua volontà di dominio e di potenza, così come delle opposte debolezze, per cui solo una vigile e profonda disciplina morale può dominare e volgere al meglio tutto ciò.
Quindi Croce poteva sia difendere sino in fondo l’autonomia dell’arte nel suo valore estetico da ogni interferenza sensoriale, psicologistica, strutturale, tecnicistica o di altro ordine materiale o esterno; sia sostenere un rapporto fra politica ed etica, che non disconosceva la sostanza dura e materiale della politica, anzi la difendeva, ma la vedeva e la voleva eticamente proiettata verso fini e valori generali, conformi alle ragioni della libertà, che non è legata ad alcun particolare ordine economico o sociale, perché vale di per sé e, come tale, opera quale «libertà liberatrice».
Sono alcune (non le sole) lezioni «attuali» di un classico, che trovò nella grande crisi europea del Novecento la spinta a una riflessione per cui poté, fra l’altro, prevedere la finale vittoria delle libertà sui totalitarismi allora al vertice dei loro trionfi. Un classico di grande eco ai suoi tempi, e non solo in Italia, ma poi più volte dichiarato estinto per ogni verso, ma vivo invece della presenza propria appunto dei classici, non sempre rumorosa, ma sempre attiva per vie e modi non prevedibili.
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. --- Perché non «è possibile convertire Croce» (Fulvio Tessitore, La ricerca delo storicismo)..20 novembre 2012, di Federico La Sala
Cristiano ma senza redenzione finale
di Gaetano Pecora (Corriere La Lettura, 18.11.2012)
Ogni grande autore viene interpretato in mille maniere diverse. Non c’è da prenderne scandalo: è il ritmo della conversazione umana. Quando però superano certi limiti, le interpretazioni si mutano in capricci esegetici, snodati e fantasiosi. È accaduto per Benedetto Croce quando, arpionatolo al saggio Perché non possiamo non dirci cristiani, a viva forza lo si è tirato dentro il circolo di quella particolarissima coloritura del cristianesimo che è il cattolicesimo.
Siano benvenute, perciò, le pagine assai acute (e puntute) con cui Fulvio Tessitore, nel libro La ricerca dello storicismo (Il Mulino, pp. 703, 75), spiega perché non «è possibile convertire Croce». Cristiano sì; ma cattolico no, mai. Cristiano, Croce lo fu davvero; ma suppergiù come un napoletano si sente anche italiano, come un fatto culturale dunque; e meglio ancora come ciascuno di noi eredita il patrimonio dai suoi maggiori; «eredità - sono parole di Croce - che non si può rifiutare, si deve accrescere e correggere anche per accrescerla, ma col metodo stesso col quale è stata trovata, cioè col metodo antidogmatico e critico».
C’è qualcuno che in queste parole sente gorgogliare gli umori della sapienza cattolica? Si aggiunga che il cattolico non esclude che l’uomo possa redimersi dal male e salvarsi. Solo che la salvezza non è di questo mondo, che Adamo precipitò in un mare di dolori (o cattivi piaceri). La qual cosa, nota Tessitore, si urta due volte con la concezione crociana.
 La prima è che la prospettiva ultramondana esula dagli orizzonti del suo pensiero. Quel che a Croce interessa sapere è se l’uomo possa salvarsi in questo mondo. Qui, non altrove. Quaggiù, non lassù.
La prima è che la prospettiva ultramondana esula dagli orizzonti del suo pensiero. Quel che a Croce interessa sapere è se l’uomo possa salvarsi in questo mondo. Qui, non altrove. Quaggiù, non lassù.
 La seconda è che la salvezza cattolica rimanda al Paradiso, cioè a uno stato perfetto che, proprio perché perfetto, è tetragono ai mutamenti e come fermo in un eterno presente.
La seconda è che la salvezza cattolica rimanda al Paradiso, cioè a uno stato perfetto che, proprio perché perfetto, è tetragono ai mutamenti e come fermo in un eterno presente.Nella concezione di Croce, invece, non c’è la redenzione finale; e non c’è perché per lui la Storia non conosce mete ultime, traguardi estremi, tappe finali, dove a uomini appagati sia dato riposare sulle loro fatiche. «Altro riposo - scrisse - non è concesso all’uomo se non nella lotta e per la lotta». Donde la preoccupazione che non si «tolga all’uomo l’umana sua facoltà di errare e di peccare, senza la quale non si può neppure fare il bene, il bene come ciascuno lo sente e sa di poter fare».
Tutto questo, beninteso, nel presupposto che siano gli uomini in carne e ossa a far tesoro dei loro errori, con i loro slanci e le loro chiusure, le loro passioni e le loro miserie. Precisamente quegli uomini che, talora, sbiadiscono nello «Spirito universale» di Croce e che a giusta ragione Tessitore traguarda con ciglio contratto come l’inciampo che devia per strade torte il corso, altrimenti umanissimo, dei suoi pensieri. Umanissimo proprio nel senso che non oltrepassa gli umani e appunto perciò si tiene stretto «alla virtù che immane in noi».
-
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. ---- Per riprendere a crescere serve lo spirito dello sviluppo (di Mauro Magatti).23 novembre 2011, di Federico La Sala
Per riprendere a crescere serve lo spirito dello sviluppo
di Mauro Magatti (Avvenire, 23 novembre 2011)
L a storia è sempre sorprendente. Lunghe e tormentate fasi gestatorie generano poi cambiamenti improvvisi. Spesso irreversibili. Così accade, per l’ennesima volta, in Italia in questi giorni, dove l’intero sistema politico, impantanato nelle proprie alchimie, si è ritrovato in qualche modo ’commissariato’ nel giro di 48 ore. Se saprà uscire dal pantano, la politica dimostrerà che non è così. Ma per intanto e soprattutto è il nuovo governo, composto da ’tecnici’, a tenere la scena. Un governo al quale si chiedono misure capaci di portarci fuori dall’occhio del ciclone. Cioè al riparo dalla speculazione, in modo che il vero valore del Paese - ben superiore a quello che ’i mercati’ hanno decretato in queste settimane - torni in auge. E tuttavia, non ci può illudere che la questione finisca qui.
Il Paese, infatti, ha bisogno di ristabilire non solo la propria economia, ma anche le condizioni stesse della propria convivenza, sociale e politica. Si potrebbe dire così: in quella che è stata chiamata Seconda Repubblica, il sistema politico nel suo insieme è stato il mediatore di un ’equilibrio di marginalità’: raggiunto il benessere e lo status di potenza economica, è come se l’Italia avesse smesso di pensare al suo futuro. Come se avesse smesso di interrogarsi sul proprio ruolo nel mondo e nella storia. Il debito pubblico è stato il galleggiante di tale ’equilibrio di marginalità’.
L’insostenibilità di tale modello ha cominciato ad affiorate con la nascita dell’euro. Come sappiamo, sono dieci anni che il Paese ha smesso di crescere. Il che è come dire che l’Italia non è stata capace di fare quel salto che le nuove condizioni richiedevano. E si è invece accartocciata su se stessa, facendo esplodere la conflittualità verbale, le chiusure corporative, le paure isteriche.
Chiudendo, così, la porta del futuro alle nuove generazioni. A poco a poco, la barca ha cominciato a imbarcare acqua. E oggi, sotto l’impulso delle autorità monetarie europee, siamo costretti a intervenire sulle falle che si sono aperte. L’urgenza dell’intervento è innegabile.
Ma mentre questo intervento si svolgerà è ugualmente necessario lavorare per ritracciare la rotta della nave che verrà riparata. E su questo punto occorre essere decisi: al di là degli interventi necessari, l’Italia potrà uscire dall’equilibrio di marginalità in cui è caduta solo a condizione di ritrovare uno spirito. Contrariamente a quanto pensa il neo-materialismo contemporaneo, lo sviluppo o è spirituale o non è.
Per chiarire di che cosa si tratta, vale la pena ricordare la radice del termine ’spirito’: spas-spus, che significa soffiare, esalare, alitare. In italiano - appunto - spirare. Il vento, infatti, spira. Per questo, lo spirito è strettamente associato alla parola speranza, che viene anch’essa dalla medesima radice nel senso di a-spirare e di spingere verso. Dunque, la speranza - come atto spirituale - indica la capacità dell’essere umano di desiderare qualche cosa di buono, di bello, di vero. Qualche cosa di qualitativamente differente dall’esistente. La speranza è esattamente l’eccedenza che troppo manca all’Italia di oggi, che per questo rischia di non avere futuro. La crisi italiana viene da lontano.
L’inadeguatezza ’tecnica’, che questo governo è chiamato ad affrontare, deriva prima di tutto e fondamentalmente da uno smarrimento spirituale. L’Italia ha oggi urgentemente bisogno del farmaco tecnico. Ma nessuno sviluppo potrà darsi se non tornerà a soffiare uno spirito. Cioè una speranza, un’energia, un desiderio.
-
> VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. --- Evangelo e Resistenza: Giustizia e Gratuità ("Charitas"). La memoria e la lezione di don Luisito Bianchi (di Paolo Viana).28 aprile 2009, di Federico La Sala
 il fatto
il fatto Nel racconto di chi visse la lotta contro i nazi-fascisti una rilettura delle manifestazioni attuali «Dopo il 25 aprile c’è stata soltanto politica Allora festeggiarono anche coloro che non avevano partecipato, adesso servirebbe un diverso stile di accoglienza dell’altro»
Nel racconto di chi visse la lotta contro i nazi-fascisti una rilettura delle manifestazioni attuali «Dopo il 25 aprile c’è stata soltanto politica Allora festeggiarono anche coloro che non avevano partecipato, adesso servirebbe un diverso stile di accoglienza dell’altro»LA LIBERAZIONE 64 ANNI DOPO
 «La Resistenza scelta di vita Implica vera conversione»
«La Resistenza scelta di vita Implica vera conversione»
 Don Luisito Bianchi: giustizia e gratuità, questo va celebrato oggi
Don Luisito Bianchi: giustizia e gratuità, questo va celebrato oggi Parla il sacerdote che fu spettatore delle vicende della lotta partigiana nel Nord Italia e ne ha lasciato una vivida e accorata narrazione nei suoi libri «L’esempio di quei giovani che rischiavano la propria vita per la libertà degli altri mi fece fare il passo decisivo verso la mia vocazione religiosa»
Parla il sacerdote che fu spettatore delle vicende della lotta partigiana nel Nord Italia e ne ha lasciato una vivida e accorata narrazione nei suoi libri «L’esempio di quei giovani che rischiavano la propria vita per la libertà degli altri mi fece fare il passo decisivo verso la mia vocazione religiosa»DI PAOLO VIANA (Avvenire, 25.04.2009).
Se lo ricorda bene Stalino, che era salito in montagna con i partigiani per poter guardare ancora negli occhi suo figlio: « Alla fine della guerra è tornato a fare lo stradino » . Il Rondine, invece, nei boschi di Bobbio ci è rimasto: « Ha difeso il Piero, che era il dottore e suo amico: la pallottola ha colpito lui ». Rileggiamo con don Luisito Bianchi La messa dell’uomo disarmato, il racconto degli anni più caldi della lotta partigiana, narrati da un prete che ha fatto della gratuità il suo stile di vita e che oggi, a 82 anni, vive nel monastero di Viboldone, alle porte di Milano, immerso nei ricordi. A dire il vero. lui li chiama « memoria » , perché quelli sbiadiscono, mentre la memoria si può attualizzare, con un pizzico di fede.
Don Luisito, prete operaio e partigiano nel cuore di fede ne ha tanta e infatti continua a credere « in un mondo diverso » , ben sapendo in quale stia vivendo. Anzi, proprio per questo, ci dice, lui continua ad aspettarlo.
Il sottotitolo del suo libro è «Un romanzo sulla Resistenza». Ammetterà che è un genere strano per un prete.
Non più di tanto, se si considera che fu proprio la Resistenza a forgiarmi, a farmi prendere la decisione di fare il prete. La chiamata era già avvenuta, certamente, ma vivevo anche un profondo travaglio e l’esempio di chi rischiava la propria vita per la libertà degli altri mi fece fare il passo verso la gratuità.
Cosa c’entra la gratuità con un periodo di odi, stragi e vendette?
I ragazzi che sceglievano la lotta partigiana erano poco più vecchi di me, mi parlavano di un mondo di giustizia, molti di loro erano persone semplici, che non facevano questa scelta, mettendo a repentaglio la vita e gli affetti, con un obiettivo personale ma perché rispondevano al desiderio di cambiare la società italiana. Quel che mi colpiva di più era la freschezza di questa testimonianza, la sua gratuità, scevra da ogni odio, da ogni rancore.
Ne ho conosciuti tanti che sono partiti perché quella era la scelta giusta e che non sono tornati. Me li porto dentro, come porto con me la memoria del 26 luglio del ’ 43, quando le strade di Vescovato, il mio paese, nel Cremonese, si riempirono di gente incredula per la caduta del fascismo e si credeva veramente di essere entrati in una nuova civiltà. Durò poco. L’ 8 settembre fu uno choc.
E il 25 aprile?
La festa chiassosa dei partigiani dell’ultima ora, quelli che la guerra sulle montagne non l’avevano fatta perché non sapevano neanche sparare. Per mesi, migliaia di persone avevano messo in gioco se stessi per realizzare un ideale di giustizia sociale e di pace che quel giorno si spense. Paradossalmente, nel giorno della Liberazione fu chiaro che le grandi speranze della Resistenza non si erano realizzate.
Eppure lei ha continuato a crederci, al punto di improntare tutta la sua vita sacerdotale a questi ideali, giusto?
La Resistenza fu l’avvenimento di cui dovevo fare memoria. Aver conosciuto quei ragazzi e le loro speranze non poteva passarmi addosso e infatti iniziai a scrivere, capendo che fare memoria con gli scritti e con la testimonianza significava attualizzare quel sogno che non si sarebbe compiuto. Ecco perché ho sempre celebrato la Resistenza e il 25 aprile e continuo a farlo.
Cosa significa ’ fare memoria’ della Resistenza?
Gesù Cristo ci dice ’ fate questo in memoria di me’ e in quel momento il corpo e il sangue di Dio irrompono nella vita. In altro modo, fare memoria di un fatto storico, per quanto incompiuto, significa attualizzare il messaggio di chi ha rischiato la vita per realizzarlo, non riuscendoci.
Cosa dice quel messaggio?
La vera Resistenza è quella al potere, ad ogni potere. Non è Resistenza quella che abbatte un potere per instaurarne un altro.
In altre parole...
In altre parole, la Resistenza finisce il 25 aprile, in tutti i sensi. Dopo quella data c’è solo la politica.
Quest’anno tutta la politica italiana si ritrova a festeggiare la Resistenza. Cosa ne pensa?
Non so con quali motivazioni i diversi leader dei partiti si accingano a festeggiare il 25 aprile. La Resistenza è una scelta di vita, implica una conversione alla gratuità e deve avvenire ogni giorno, non solo oggi. Il cristiano non ha esitazioni a schierarsi dalla parte dei poveri e della giustizia, contro la violenza, ieri come oggi. Non ha esitazioni a scegliere la gratuità, la Charis, la Grazia evangelica, che gratuitamente ci è concessa dal Signore. Ne ho visti tanti di cattolici che sceglievano la lotta partigiana con questo spirito. Se i politici che festeggiano il 25 aprile si convertono a un diverso stile di accoglienza dell’altro e di gratuità nella vita allora hanno adottato veramente gli ideali della Resistenza. Altrimenti...
-
>Evangelo e Resistenza: Giustizia e Gratuità ("Charitas"). ---- Don Luisito Bianchi, prete e scrittore operaio (di Roberto Carnero), che lavorava per gli ultimi (di Remo Bassini).8 gennaio 2012, di Federico La Sala
Don Luisito Bianchi, prete e scrittore operaio
di Roberto Carnero (Il Sole 24 Ore, 8 gennaio 2012)
Con la scomparsa di don Luisito Bianchi, avvenuta il 5 gennaio, abbiamo perso non solo uno scrittore, uno dei più originali degli ultimi decenni, ma anche il testimone scomodo di un radicalismo evangelico profetico e mai accomodante. Nella sua vita Luisito Bianchi ha fatto l’insegnante, il traduttore, l’operaio, il benzinaio, l’inserviente in ospedale. Nato a Vescovato, in provincia di Cremona, nel 1927, sacerdote cattolico dal 1950, il grande pubblico l’ha conosciuto a partire dal 2003, quando Sironi editore ripubblicò La messa dell’uomo disarmato, un ampio, suggestivo romanzo sulla Resistenza, uscito per la prima volta nel 1989 in un’edizione autoprodotta. Di quel periodo, l’autore non offriva soltanto una lettura storiografica. C’era una dimensione filosofica e religiosa (una religione civile, oltre che trascendente) che faceva della Resistenza una categoria quasi esistenziale.
Nel 2005 sempre Sironi manda in libreria una nuova edizione di un suo libro del 1972, dal titolo Come un atomo sulla bilancia, il racconto, alternato alla riflessione, dell’esperienza vissuta da don Luisito, a cavallo tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, come prete operaio. In occasione dell’uscita di quel libro, lo incontrai presso l’abbazia trecentesca di Viboldone (una manciata di chilometri da Milano), dove da alcuni anni prestava la funzione di cappellano presso la comunità delle suore benedettine. Parlammo della sua vita, del suo amore per la scrittura, della sua idea di Chiesa. Parlava lentamente, a voce bassa, di tanto in tanto socchiudendo gli occhi. Ma le sue parole erano molto precise.
Don Luisito non risparmiava le critiche ai modi con cui l’istituzione ecclesiastica ha organizzato la propria vita. Tuttavia ci teneva a ribadire il suo amore per la Chiesa: «Amo questa Chiesa perché è lei che mi ha trasmesso Cristo. Ed è nella Chiesa che ho sentito parlare di un Dio che sceglie di perdere ogni potere, preferendo la povertà. Di fronte a certi atteggiamenti della Chiesa mi viene da chiedermi: è possibile che si cerchi il potere per affermare la parola di colui che ha rifiutato il potere?».
Uno dei concetti su cui insisteva maggiormente era quello della "gratuità". Nel 1968 si chiedeva: «Come posso restare coerente nell’annunciare la gratuità del Vangelo, se in cambio, proprio per la mia funzione di prete, ricevo del denaro?». È da questa riflessione che scaturì in lui la decisione di diventare operaio. Così entrò in fabbrica (alla Montecatini di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria), per condividere tutto con i colleghi: salario, turni di lavoro, amicizie. Per tre anni registrale sue giornate in alcuni taccuini. Nel 2008 pubblica da Sironi I miei amici. Diari (1968- 1970), in cui rievoca quell’esperienza. Il suo ultimo libro, uscito due anni fa sempre presso Sironi, si intitola Le quattro stagioni di un vecchio lunario. Quasi un testamento spirituale, incentrato su una sorta di ritorno alle origini: una ricostruzione dell’infanzia e della giovinezza, alle radici della propria vocazione di uomo e di scrittore.
Don Luisito, che lavorava per gli ultimi
di Remo Bassini (il Fatto Quotidiano, 7 gennaio 2012)
Quando Gesù si è fatto uccidere in croce non l’ha fatto in cambio di uno stipendio” diceva spesso, con voce flebile ma ferma, don Luisito Bianchi , cappellano di Viboldone, prete scomodo, scrittore, morto giovedì scorso a Melegnano (Milano). Aveva 84 anni. Era un prete che predicava bene - la gratuità come essenza del vivere cristiano - e razzolava bene, tant’è che ha sempre rifiutato lo stipendio “da prete”. La Chiesa istituzione lo ha sopportato: con una smorfia di disprezzo, ignorandolo.
Non c’erano mai preti, o se c’erano, erano preti isolati come lui, quando presentava i suoi libri. Quando diceva “se fossi Papa brucerei il Vaticano , affinché rifulga la luce di Cristo. E donerei ai poveri, a chi soffre, agli zingari, ai perseguitati”, la Chiesa istituzione faceva finta di niente. Anche perché, si sapeva, don Luisito, mite e timido, rifuggiva telecamere e notorietà. La sua vita da prete l’ha vissuta ascoltando gli insegnamenti del Vangelo. Dietro le quinte, insomma, tra gli ultimi.
ORDINATO sacerdote nel 1950, negli anni Sessanta, dopo un’esperienza romana alla Pastorale del lavoro, si domanda: “Cosa ho imparato? Io, veramente, che so del lavoro?”. A trent’anni decide così di andare a lavorare in fabbrica, alla Montecatini di Spinetta Marengo (Alessandria), esperienza che racconterà in alcuni suoi libri e che lo segnerà per sempre: rifiuterà infatti l’etichetta di prete operaio. In fabbrica, spiegherà don Luisito, un prete non serve, perché le virtù teologali, Fede, Speranza e Carità, sono già parte del lavoro duro, da operaio. Se un intellettuale si sente a corto di argomenti, dirà anche, vada in fabbrica: lì, il terreno è fertile.
NEL 2003, don Luisito diventa noto nell’ambiente editoriale. La piccola casa editrice Sironi pubblica La messa dell’uomo disarmato ed è subito un successo: di vendite e critiche. Tanti gridano al capolavoro. Un libro sulla resistenza, ma anche sulla gratuità: dei partigiani che morirono per un’idea, per la libertà, solo per quella.
I proventi del libro, comunque, don Luisito li dona ai missionari: a lui, che vive tra Vescovato, suo paese natale, e Viboldone, dove è cappellano, bastano 600 euro di pensione, frutto dei contributi versati come operaio, inserviente, benzinaio, insegnante. Era un mite, ma insieme all’amore per il prossimo insegnava la ribellione.
“Uno schiavo ai tempi di Gesù - ha scritto don Luisito - veniva colpito al volto dal suo padrone con il dorso della mano, perché quest’ultimo non avesse a sporcarsi le mani. La guancia colpita era dunque la guancia destra. Porgere l’altra guancia, cioè la sinistra, a quel tempo significava costringere il padrone a colpire col palmo della mano e, quindi, a sporcarsi le mani, cosa che un padrone non avrebbe mai fatto. Quindi il voltare il viso dall’altra parte per porgere la guancia opposta era un modo per impedire al padrone di colpire ancora, era un modo per interrompere il sistema, per costringere il potente a fermarsi”. Sussurrava, ma aveva una grande voce, don Luisito Bianchi...
-
> Evangelo e Resistenza: Giustizia e Gratuità ("Charitas"). ---- In ricordo di don Luisito Bianchi (di Mario Arnoldi)3 febbraio 2012, di Federico La Sala
In ricordo di don Luisito Bianchi
di Mario Arnoldi
in "Tempi di fraternità" n. 2 del febbraio 2012
Luisito Bianchi è mancato il 5 gennaio scorso, la vigilia dell’Epifania. Era nato a Vescovato, Cremona, nel 1927 e ordinato sacerdote nel 1950. Laureato in scienze politiche a Milano, dapprima era stato insegnante al Seminario vescovile, poi missionario in Belgio, quindi Assistente delle Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) a Roma, incarico che gli ha permesso di prendere i primi contatti con gli operai e di costatare che l’istituzione Chiesa non realizza una presenza adeguata nel mondo. Finalmente, dopo tante riflessioni e contatti, sceglie la vita di prete operaio ed è assunto nella fabbrica Montecatini di Spinetta Marengo presso Alessandria, dove rimane per tre anni dal ’68 al ’71.
Ogni giorno, quando i turni di lavoro lo permettono, Luisito frequenta la messa vespertina presso la parrocchia del quartiere più povero della città, insieme all’altro prete operaio, Giovanni Carpené, che pure proveniva dal Belgio e col quale condivide l’abitazione. Là ho conosciuto Luisito e Giovanni e con loro si è stabilita un’amicizia feconda. Io ero più giovane e ascoltavo le loro parole e la loro esperienza come un insegnamento particolarmente ricco. La mia amicizia con i due preti operai ha poi preso vie parallele e autonome.
Luisito, dopo i tre anni in fabbrica, si riavvicina alla sua Vescovato, continuando per qualche tempo a lavorare come aiuto benzinaio e come infermiere; poi si ferma all’abbazia di Viboldone, a sud-est di Milano, dove vive la seconda fase della sua vita come cappellano, nella riflessione, nella scrittura narrativa poetica e nella frequentazione di amici delle varie tappe della sua esistenza. che tanto hanno ricevuto da lui, e che, insieme con le Suore Benedettine, costituiscono la sua famiglia umana e spirituale. All’abbazia Luisito compie quasi una revisione e interpretazione delle tante esperienze compiute.
Sono stato a volte a trovarlo e sempre mi ha accolto con amicizia sincera. Mi ascoltava e le sue parole erano di comprensione, di conforto e illuminanti. Luisito Bianchi vive la sua vita non come un susseguirsi di avvenimenti giustapposti, sia pure significativi, ma come la manifestazione quotidiana di un flusso continuo che chiama "gratuità", una variazione significativa della grazia, della misericordia e del dono di Dio verso l’uomo e la donna, l’umanità, la Chiesa. E in questo flusso di gratuità di Dio siamo tutti chiamati a inserirci, donandoci a nostra volta verso tutto quanto ci circonda. "Avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date" (Matteo 10,8). "La gratuità (nella vita) e nel ministero - dice in un suo scritto
 è un tema da infinite variazioni, almeno una per ogni giorno, perché ogni giorno si presenta con
un nuovo cesto di doni sconosciuti da svuotare, un canone all’infinito".
è un tema da infinite variazioni, almeno una per ogni giorno, perché ogni giorno si presenta con
un nuovo cesto di doni sconosciuti da svuotare, un canone all’infinito".Testimoniano questa ricerca, o meglio questa sua impostazione di vita, i suoi libri sul lavoro Sfilacciature di fabbrica, 1970, riedizione 2002 e Come un atomo sulla bilancia, Morcelliana, Brescia, 1972, riediz. Sironi, Milano 2005, storia di tre anni di fabbrica. Luisito pensa che il lavoro di fabbrica per un prete sia un mezzo di sostentamento per non cadere nel commercio dei sacramenti e degli strumenti di fede. Il romanzo che lo ha reso celebre raggiungendo il grande pubblico è La Messa dell ’uomo disarmato, 1989, riediz. Sironi, Milano 2003, in cui narra e intende la resistenza partigiana come la Parola e la gratuità che si sono fatte storia. E ancora i testi in cui affronta direttamente il nucleo del tema come Dialogo sulla gratuità, Morcelliana, Brescia, 1975, riediz. Gribaudi, Milano, 2004. Tanti altri scritti, ed anche piccole perle di musica, che egli a volte componeva per diletto, narrano il diffondersi delle infinite variazioni della gratuità.
All’abbazia di Viboldone sabato scorso, giorno successivo all’Epifania, ho partecipato alla liturgia di addio a Luisito. Sono stato coinvolto dalla grande partecipazione, composta e commossa, di amici ed estimatori, di tanti preti concelebranti e del vescovo di Cremona che presiedeva. Due momenti mi hanno colpito particolarmente. All’inizio della liturgia il prete operaio Giovanni Carpené ha depositato sulla bara la tuta blu di lavoro di Luisito, come lui stesso aveva chiesto fosse fatto. Il gesto ha suscitato grande emozione. E poi l’omelia del celebrante ha ricordato la gratuità motivoconduttore della sua vita. Non è vero, ha affermato, riprendendo un detto di Luisito, che l’Epifania, cioè la manifestazione della gratuità divina, tutte le feste porta via, la vita infatti è costellata di epifanie, sino all’ultima, quando si incontra Dio, la fonte di ogni gratuità.
-
-