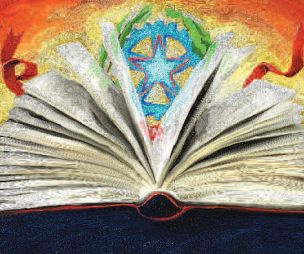
COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI - di Piero Calamandrei. La Costituzione italiana: SALVIAMOLA! - selezione a cura del prof. Federico La Sala
lunedì 20 novembre 2006.Il 26 gennaio 1955 ad iniziativa di un gruppo di studenti universitari e medi, fu organizzato a Milano, nel salone degli affreschi della Società Umanitaria, un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana, inviando insigni cultori del diritto ad illustrare, in modo accessibile a tutti, i principi morali e giuridici che stanno a fondamenta della nostra vita sociale.
Il corso è stato inaugurato e concluso da Piero Calamandrei e, non senza viva commozione, Egli ritorna tra noi con la sua eloquenza nobile e pur semplice, con dottrina profonda, scientificamente serena e civilmente incitatrice.
La parola del maestro indimenticabile suona, ancora oggi, come un altissimo richiamo all’impegno scientifico e morale di tutti i giovani che si apprestano ad una sempre rinnovata battaglia di civiltà, di progresso e di libertà.
Ecco la parte sostanziale di ciò che Egli disse introducendo il corso e precisando i fondamenti storici della Nostra Costituzione.
"L’art.34 dice: “i capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” E se non hanno mezzi! Allora nella nostra Costituzione c’è un articolo, che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo; non impegnativo per noi che siamo al desinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi.
Dice così: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
E’ compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’articolo primo “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza con il proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica.
Una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della Società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la Società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinnanzi!
E’ stato detto giustamente che le Costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli delle Costituzioni, c’è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime.
Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai diritti di libertà voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate, riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute: quindi polemica nella parte dei diritti dell’uomo e del cittadino, contro il passato.
Ma c’è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la Società presente. Perché quando l’articolo 3 vi dice “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana” riconosce, con questo, che questi ostacoli oggi ci sono, di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo, contro l’ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare, attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani.
Ma non è una Costituzione immobile, che abbia fissato, un punto fermo. E’ una Costituzione che apre le vie verso l’avvenire, non voglio dire rivoluzionaria, perché rivoluzione nel linguaggio comune s’intende qualche cosa che sovverte violentemente; ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa Società, in cui può accadere che, anche quando ci sono le libertà giuridiche e politiche, siano rese inutili, dalle disuguaglianze economiche e dalla impossibilità, per molti cittadini, di essere persone e di accorgersi c he dentro di loro c’è una fiamma spirituale che, se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anch’essa contribuire al progresso della Società. Quindi polemica contro il presente, in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente.
Però vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.
Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità; per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica, indifferentismo, che è, non qui per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghi strati, in larghe categorie di giovani, un po’ una malattia dei giovani. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica. E io quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina, che qualcheduno di voi conoscerà di quei due emigranti, due contadini che traversavano l’oceano, su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte e si accorgeva che c’era una gran burrasca, con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora uno di questi contadini, impaurito, domanda a un marinaio “ ma siamo in pericolo?” e questo dice “secondo me, se continua questo mare, tra mezz’ora il bastimento affonda.” Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno, dice: “Beppe, Beppe, Beppe”,....“che c’è!” ... “Se continua questo mare, tra mezz’ora, il bastimento affonda” e quello dice ”che me ne importa, non è mica mio!” Questo è l’ indifferentismo alla politica.
E’ così bello e così comodo. La libertà c’è, si vive in regime di libertà, ci sono altre cose da fare che interessarsi di politica. E lo so anch’io. Il mondo è così bello. E vero! Ci sono tante belle cose da vedere, da godere oltre che ad occuparsi di politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però, la libertà è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro, di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno, che sulla libertà bisogna vigilare,vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.
La Costituzione, vedete, è l’affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma l’affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va affondo, va affondo per tutti questo bastimento. E’ la Carta della propria libertà. La Carta per ciascuno di noi della propria dignità d’uomo.
Io mi ricordo le prime elezioni, dopo la caduta del fascismo, il 6 giugno del 1946; questo popolo che da venticinque anni non aveva goduto delle libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare, dopo un periodo di orrori, di caos: la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi, andò a votare.
Io ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui. Queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni. Disciplinata e lieta. Perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità, questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare, questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, della nostra patria, della nostra terra; disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese.
Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questo è uno delle gioie della vita, rendersi conto che ognuno di noi, nel mondo, non è solo! Che siamo in più, che siamo parte di un tutto, tutto nei limiti dell’Italia e nel mondo.
Ora vedete, io ho poco altro da dirvi, in questa Costituzione di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli. E a sapere intendere dietro questi articoli, ci si sentono delle voci lontane.
Quando io leggo: nell’articolo 2 “L’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale” o quando leggo nell’articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli”, “la patria italiana in mezzo alle altre patrie” ma questo è Mazzini!Questa è la voce di Mazzini. O quando io leggo nell’articolo 8: “Tutte le confessioni religiose, sono ugualmente libere davanti alla legge” ma questo è Cavour! O quando io leggo nell’articolo 5 ”La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” ma questo è Cattaneo! O quando nell’articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate “L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, l’esercito di popolo, e questo è Garibaldi! O quando leggo all’art. 27 “Non è ammessa la pena di morte” ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria!!
Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione!! Dietro ogni articolo di questa Costituzione o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una Carta morta: no, non è una Carta morta. Questo è un testamento, un testamento di centomila morti.
Se voi volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: "andate lì, o giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione".
 (20 novembre 2006)
(20 novembre 2006)
- Piero Calamandrei: l’arringa pronunciata in difesa di Danilo Dolci (FiloDiritto, 19.03.2022).
Sul tema, nel sito, si cfr.:

- QUESTIONE DI DIGNITA’ UMANA, POLITICA E INTELLETTUALE. PERCHE’ DOBBIAMO DIRCI CRISTIANI E CRISTIANE, MA MAI "CATTOLICI" E "CATTOLICHE". E NON CONFONDERE DA MENTITORI LE PAROLE!!!
 La Costituzione e la Repubblica che è in noi
La Costituzione e la Repubblica che è in noi
 IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI
FLS
|
LE 21 DONNE DELLA COSTITUENTE |
Forum
-
>LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI --- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E COSTITUZIONE. Una nota a margine del testo di «Piero Calamandrei e la “separazione delle carriere” in magistratura» ([Riccardo Radi,26 gennaio 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, COSTITUZIONE ("LOGOS"), E PARTITI ("LOGO"), OGGI...
- Una nota a margine del testo di «Piero Calamandrei e la “separazione delle carriere” in magistratura» (Riccardo Radi,"TERZULTIMA FERMATA", 26 gennaio 2025 ).
CHI LO SA, LO SA; CHI NON LO SA, NON LO SA, MA ORMAI LO SANNO TUTTI E TUTTE. CHE OGGI SI STIA PERDENDO DEFINITIVAMENTE LA DISTINZIONE TRA LA #VEGLIA E IL #SONNO, TRA LA #LEGGE #FONDAMENTALE (le "regole del gioco" nel #campo e del campo di tutta la società ) E I "LOGO" (i "marchi", i "nomi", i "simboli" dei vari Partiti, delle varie Aziende, delle varie Lobbies atee e devote), dovrebbe preoccupare prima di tutto e soprattutto filologi e filologhe, oltre che filosofi e filosofe!
Il problema del "ripescaggio" geologico dal fondo del #pozzo in cui è caduto lo #spirito della Legge è un nodo antropologico e teologico-politico di lunga durata: "essere, o non essere" (#Shakespeare, "#Amleto"). E’ ancora il tempo della discussione sul tema della "dotta ignoranza" (1440) e sull’autenticità della cosiddetta "Donazione di Costantino" (1440).
ANTROPOLOGIA E #STORIA. CON IL SUO "ELOGIO DEI GIUDICI scritto da un avvocato" (1959), Piero Calamandrei mette chiaramente il #ditonellapiaga ("Quid est veritas?") e sollecita a non addormentarsi, come già la "memoria" di #Eraclito di #Efeso (e #Immanuel #Kant di Koenisberg, l’attuale #Kaliningrad): "Bisogna dunque seguire ciò è comune. Ma pur essendo questo lógos comune, la maggior parte degli uomini vive come se avesse un propria e particolare saggezza" (fr. 2).
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE --- Il discorso della senatrice a vita Liliana Segre a Palazzo Madama la seduta per il voto del presidente del Senato dea Repubblica.14 ottobre 2022, di Federico La Sala
Il discorso della senatrice a vita Liliana Segre
L’apertura della seduta a Palazzo Madama per il voto del presidente
di Redazione Ansa*
***
Ecco il testo del discorso della senatrice a vita Liliana Segre che ha aperto a Palazzo Madama la seduta per il voto del presidente
Colleghe Senatrici, Colleghi Senatori,
rivolgo il più caloroso saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a quest’Aula. Con rispetto, rivolgo il mio pensiero a Papa Francesco.
Certa di interpretare i sentimenti di tutta l’Assemblea, desidero indirizzare al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, che non ha potuto presiedere la seduta odierna, i più fervidi auguri e la speranza di vederlo ritornare presto ristabilito in Senato.
Il Presidente Napolitano mi incarica di condividere con voi queste sue parole: “Desidero esprimere a tutte le senatrici ed i senatori, di vecchia e nuova nomina, i migliori auguri di buon lavoro, al servizio esclusivo del nostro Paese e dell’istituzione parlamentare ai quali ho dedicato larga parte della mia vita”.
Rivolgo ovviamente anch’io un saluto particolarmente caloroso a tutte le nuove Colleghe e a tutti i nuovi Colleghi, che immagino sopraffatti dal pensiero della responsabilità che li attende e dalla austera solennità di quest’aula, così come fu per me quando vi entrai per la prima volta in punta di piedi.
Come da consuetudine vorrei però anche esprimere alcune brevi considerazioni personali.
Incombe su tutti noi in queste settimane l’atmosfera agghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, terrore...una follia senza fine.
Mi unisco alle parole puntuali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “la pace è urgente e necessaria. La via per ricostruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino”.
Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva.
In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della Marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica.
Ed il valore simbolico di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre; ed è impossibile per me non provare una sorta di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato!
Il Senato della diciannovesima legislatura è un’istituzione profondamente rinnovata, non solo negli equilibri politici e nelle persone degli eletti, non solo perché per la prima volta hanno potuto votare anche per questa Camera i giovani dai 18 ai 25 anni, ma soprattutto perché per la prima volta gli eletti sono ridotti a 200.
L’appartenenza ad un così rarefatto consesso non può che accrescere in tutti noi la consapevolezza che il Paese ci guarda, che grandi sono le nostre responsabilità ma al tempo stesso grandi le opportunità di dare l’esempio.
Dare l’esempio non vuol dire solo fare il nostro semplice dovere, cioè adempiere al nostro ufficio con “disciplina e onore”, impegnarsi per servire le istituzioni e non per servirsi di esse.
Potremmo anche concederci il piacere di lasciare fuori da questa assemblea la politica urlata, che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione dal voto, interpretando invece una politica “alta” e nobile, che senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti, dia prova di rispetto per gli avversari, si apra sinceramente all’ascolto, si esprima con gentilezza, perfino con mitezza.
Le elezioni del 25 settembre hanno visto, come è giusto che sia, una vivace competizione tra i diversi schieramenti che hanno presentato al Paese programmi alternativi e visioni spesso contrapposte. E il popolo ha deciso.
È l’essenza della democrazia.
La maggioranza uscita dalle urne ha il diritto-dovere di governare; le minoranze hanno il compito altrettanto fondamentale di fare opposizione. Comune a tutti deve essere l’imperativo di preservare le Istituzioni della Repubblica, che sono di tutti, che non sono proprietà di nessuno, che devono operare nell’interesse del Paese, che devono garantire tutte le parti.
Le grandi democrazie mature dimostrano di essere tali se, al di sopra delle divisioni partitiche e dell’esercizio dei diversi ruoli, sanno ritrovarsi unite in un nucleo essenziale di valori condivisi, di istituzioni rispettate, di emblemi riconosciuti.
In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l’unità del nostro popolo è la Costituzione Repubblicana, che come disse Piero Calamandrei non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà; una lotta che non inizia nel settembre del 1943 ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti.
Il popolo italiano ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla sua Costituzione, l’ha sempre sentita amica.
In ogni occasione in cui sono stati interpellati, i cittadini hanno sempre scelto di difenderla, perché da essa si sono sentiti difesi.
E anche quando il Parlamento non ha saputo rispondere alla richiesta di intervenire su normative non conformi ai principi costituzionali - e purtroppo questo è accaduto spesso - la nostra Carta fondamentale ha consentito comunque alla Corte Costituzionale ed alla magistratura di svolgere un prezioso lavoro di applicazione giurisprudenziale, facendo sempre evolvere il diritto.
Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata (come essa stessa prevede all’art. 138), ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione - peraltro con risultati modesti e talora peggiorativi - fossero state invece impiegate per attuarla, il nostro sarebbe un Paese più giusto e anche più felice.
Il pensiero corre inevitabilmente all’art. 3, nel quale i padri e le madri costituenti non si accontentarono di bandire quelle discriminazioni basate su “sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”, che erano state l’essenza dell’ancien regime.
Essi vollero anche lasciare un compito perpetuo alla “Repubblica”: “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Non è poesia e non è utopia: è la stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo programmi diversi per seguirla: rimuovere quegli ostacoli !
Le grandi nazioni, poi, dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria.
Perché non dovrebbe essere così anche per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date “divisive”, anziché con autentico spirito repubblicano, il 25 Aprile festa della Liberazione, il 1° Maggio festa del lavoro, il 2 Giugno festa della Repubblica?
Anche su questo tema della piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell’esempio, di gesti nuovi e magari inattesi.
Altro terreno sul quale è auspicabile il superamento degli steccati e l’assunzione di una comune responsabilità è quello della lotta contro la diffusione del linguaggio dell’odio, contro l’imbarbarimento del dibattito pubblico, contro la violenza dei pregiudizi e delle discriminazioni.
Permettetemi di ricordare un precedente virtuoso: nella passata legislatura i lavori della “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza” si sono conclusi con l’approvazione all’unanimità di un documento di indirizzo. Segno di una consapevolezza e di una volontà trasversali agli schieramenti politici, che è essenziale permangano.
Concludo con due auspici.
Mi auguro che la nuova legislatura veda un impegno concorde di tutti i membri di questa assemblea per tenere alto il prestigio del Senato, tutelare in modo sostanziale le sue prerogative, riaffermare nei fatti e non a parole la centralità del Parlamento.
Da molto tempo viene lamentata da più parti una deriva, una mortificazione del ruolo del potere legislativo a causa dell’abuso della decretazione d’urgenza e del ricorso al voto di fiducia. E le gravi emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni non potevano che aggravare la tendenza.
Nella mia ingenuità di madre di famiglia, ma anche secondo un mio fermo convincimento, credo che occorra interrompere la lunga serie di errori del passato e per questo basterebbe che la maggioranza si ricordasse degli abusi che denunciava da parte dei governi quando era minoranza, e che le minoranze si ricordassero degli eccessi che imputavano alle opposizioni quando erano loro a governare.
Una sana e leale collaborazione istituzionale, senza nulla togliere alla fisiologica distinzione dei ruoli, consentirebbe di riportare la gran parte della produzione legislativa nel suo alveo naturale, garantendo al tempo stesso tempi certi per le votazioni.
Auspico, infine, che tutto il Parlamento, con unità di intenti, sappia mettere in campo in collaborazione col Governo un impegno straordinario e urgentissimo per rispondere al grido di dolore che giunge da tante famiglie e da tante imprese che si dibattono sotto i colpi dell’inflazione e dell’eccezionale impennata dei costi dell’energia, che vedono un futuro nero, che temono che diseguaglianze e ingiustizie si dilatino ulteriormente anziché ridursi. In questo senso avremo sempre al nostro fianco l’Unione Europea con i suoi valori e la concreta solidarietà di cui si è mostrata capace negli ultimi anni di grave crisi sanitaria e sociale.
Non c’è un momento da perdere: dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo, prima che la paura e la rabbia possano raggiungere i livelli di guardia e tracimare.
Senatrici e Senatori, cari Colleghi, buon lavoro!
* Fonte: ANSA, 13 ottobre 2022 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI --- Bibbia civile e magistero antropologico: la Costituzione e la logica dei "Due Soli" (Dante 2021).2 luglio 2021, di Federico La Sala
#COSTITUZIONE
#BIBBIA CIVILE E #MAGISTERO ANTROPOLOGICO:
#COME NASCONO I BAMBINI?
#Divina Commedia:
#Dante2021.
se #Maria è #madre e #maestra.. #Giuseppe non è #padre e #maestro?!
Per un’altra #fenomenologiadellospirito:
IO, dall’#AMORE di #Due IO.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI - --- Dante, simbolo dell’Italia molto prima della sua unità (di Andrea Riccardi).15 luglio 2019, di Federico La Sala
L’intervento
Dante, simbolo dell’Italia molto prima della sua unità
Il presidente della Società Dante Alighieri sostiene l’iniziativa di una Giornata dedicata al poeta della «Commedia». Il Dantedì sarà una festa per gli italiani e chi ama l’Italia
di ANDREA RICCARDI *
- [Foto] Il volto di Dante di Riccardo Guasco nell’ambito della mostra «idDante» (a Ravenna nel 2016, progetto Bonobolabo di Marco Miccoli, curatrice Maria Vittoria Baravelli)
La proposta di dedicare a Dante una giornata celebrativa, avanzata da Paolo Di Stefano sul «Corriere della Sera», incontra l’interesse di tanti. Dante dà nome alla Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da Giosue Carducci per difendere l’identità degli emigrati nel mondo. La Società lavora in questo senso da 130 anni e conta oggi circa 400 comitati e tante scuole ovunque. La sua missione resta l’insegnamento dell’italiano non solo agli emigrati e ai loro figli, ma anche a chi è attratto dalla lingua e dal vivere all’italiana.
- [Foto] Lo storico Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri
Abbiamo sempre festeggiato la Giornata di Dante in tutti i nostri comitati il 29 maggio, scegliendo questa tra le possibili date di nascita del poeta, uno degli ultimi giorni del mese indicato nel commentario di Boccaccio. Questi afferma che Dante morì dopo aver passato il cinquantaseiesimo anno «dal preterito maggio». Ma la data non è importante. Quel che conta è l’esperienza positiva di una giornata dedicata al Sommo Poeta da parte della nostra Società lungo gli anni.
Sono quindi d’accordo sul Dantedì. Infatti Dante è un simbolo del «mondo italiano», molto prima dell’unità politica del Paese, che però si proietta verso il futuro e rappresenta un giacimento di poesia, umanità e mondo spirituale, ancora in parte da esplorare. È simbolo, in qualche modo, di «preveggenza», di un rapporto positivo tra passato e futuro: il poeta immagina la redenzione del Purgatorio, dando forma letteraria alla speranza di poter «rimediare» agli errori e ai limiti, in un modo che pochi decenni prima non esisteva. Dante ha fondato la visione di un’umanità più giusta e positiva. È una visione «italiana» in senso profondo. Del resto si celebrano le identità culturali associate alla grande poesia di autori come Cervantes o Shakespeare.
- [Foto] Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, che sostiene il Dantedì e ha preso parte a un incontro sul tema, in Sala Buzzati a Milano organizzato dalla Fondazione Corriere
Dante è con Shakespeare nel cosiddetto «canone poetico occidentale». Molti lo conoscono. Tuttavia bisogna conoscerlo sempre meglio, perché la ricchezza letteraria della sua opera non si esaurisce e non si sintetizza. È come una Bibbia, che va letta e riletta: allora si scoprono messaggi e significati nuovi. Insegna una lettura che è un metodo per fare cultura, anche per i non specialisti. Lo si vede nel Paradiso, summa delle conoscenze concluse nel simbolo della rosa candida, che è un raffinato esempio di come insegnamenti alti e complessi possano essere incastonati in un testo poetico e letterario. La rosa, simbolo caro a poeti e mistici, è il fiore del mese di maggio, quando celebriamo la Giornata di Dante.
- [Foto] Paolo Di Stefano, scrittore e giornalista, dal quale è nata l’idea del Dantedì
Qualunque sarà la data prescelta, la proposta di un Dantedì non deve cadere nel vuoto. La giornata sarà significativa non solo per la Dante Alighieri, da cinque generazioni impegnata nella salvaguardia della cultura italiana nel mondo. Sarà soprattutto una «festa» per gli italiani e per quanti guardano con simpatia al «mondo italiano» in tutto il suo spessore. Questo mondo vive anche fuori dalla penisola. Abbiamo dato come titolo al nostro prossimo congresso di Buenos Aires, che raccoglie italiani e amici dell’italiano: Italia, Argentina, mondo: l’italiano ci unisce. La nostra lingua non è egemonica, non s’impone ma attrae: unisce i tanti «pezzi d’Italia», come diceva il manifesto fondatore della nostra Società, guardando agli italiani e ai simpatizzanti per l’Italia nel mondo.
Dante non è solo il simbolo dell’Italia. È voce mondiale e patrimonio dell’umanità. L’Italia (e forse l’Europa) non sarebbero quel che sono nella cultura e nel seguir «virtute e canoscenza», se non ci fosse stato Dante, il quale non è solo, come molti credono, la sintesi del Medioevo, ma è l’anticipatore dell’umanesimo ancora prima di Petrarca, grazie al colloquio fertile con i classici, nonché il profeta del futuro con una visione moderna dell’esistenza e in una simbiosi di vita e arte, mai così intensa prima né dopo di lui. Per questo il Dantedì rappresenta, in questo sconfinato mondo globale dei nostri tempi, una salda radice e un’apertura al futuro.
L’Emilia-Romagna appoggio al progetto e l’evento a Ravenna al festival Dante2021
La regione Emilia-Romagna sostiene la mobilitazione per il Dantedì. In una risoluzione il consigliere Gianni Bessi (Partito Democratico) impegna la giunta «ad attivarsi presso il governo e il parlamento affinché si istituisca, tramite percorsi legislativi e normativi, anche formalmente la giornata del Dantedì». Al progetto di una Giornata mondiale per Dante è dedicato un evento del festival Dante2021 a Ravenna il prossimo 13 settembre. Con lo scrittore e giornalista Paolo Di Stefano, che in un articolo del 24 aprile sul «Corriere» aveva lanciato il Dantedì, intervengono il sindaco della città Michele de Pascale, Carlo Ossola (presidente del Comitato nazionale per i 700 anni dalla morte di Dante), Francesco Sabatini (presidente onorario dell’Accademia della Crusca), Wafaa El Beih (direttrice del dipartimento di Italianistica dell’Università di Helwan-Il Cairo), i traduttori René de Ceccatty e José María Micó e il tedesco Harro Stammerjohann, socio straniero della Crusca.
* Corriere della Sera, 15.07.2019 (ripresa parzale - senza immagini).
-
>LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI - Galante Garrone e Calamandrei: il senso della Costituzione (di Furio Colombo).3 settembre 2018, di Federico La Sala
Galante Garrone e Calamandrei: il senso della Costituzione
La storia intellettuale e morale di un uomo d’altri tempi, padre della Carta
di Furio Colombo (Il Fatto, 03.09.2018)
L’autore è Alessandro Galante Garrone, un nome che ha fatto da guida e da riferimento a tanti adolescenti torinesi dell’immediato dopoguerra, sul senso e il valore di essere antifacisti. Il libro è dedicato a Calamandrei (Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della nostra storia, Effepi Libri), il personaggio che - dopo avere partecipato alla scrittura della Costituzione - si è impegnato a guidare un’Italia nuova e pulita lungo un percorso nobile di solidarietà fraterna, un Paese senza odio e senza confini, dopo una guerra che ha attraversato le terre desolate della morte a milioni e del deliberato e bene organizzato sterminio di popoli.
Né Galante Garrone né Calamandrei si fidavano dello slancio spontaneo verso il bene di coloro che erano sopravvissuti a una guerra di stragi.
Galante Garrone ha preso subito la bandiera della democrazia, dimostrando che niente vive senza l’impegno (il dovere) e la partecipazione di ciascuno cittadino. Calamandrei ha spinto sulla scena ancora disadorna dell’Italia povera e incerta di allora, i diritti delle persone, i diritti della Costituzione, i diritti umani, i diritti civili che, in seguito, i partiti, con l’unica clamorosa eccezione di Marco Panella, di Emma Bonino, del Partito Radicale, avrebbero tralasciato come se fossero solo l’ornamento, non la materia prima della democrazia.
Ma l’imbarazzo deve essere grande, per chi prende in mano ora questo libro (che è una ristampa da un’Italia lontana) e lo confronti con l’Italia che stiamo vivendo adesso, dove i diritti umani di rom, migranti e poveri vengono non solo trascurati ma deliberatamente e fisicamente offesi perchè i più deboli non contano.
Governare con le false promesse, in un castello di illusioni e invenzioni, ha portato a precipitare in un triste retro-cortile senza cultura, senza storia, senza solidarietà, senza alcun interesse per sentimenti e diritti, dove conta solo il compiacimento del proprio personale potere.
Questo libro arriva dal passato in un tempo in cui si usa lo slogan “prima gli italiani”, che farebbe inorridire chiunque ha combattuto per la libertà, e ha scritto e insegnato la Costituzione italiana. Perciò Galante Garrone e Calamandrei servono oggi all’Italia come le navi ong e la Guardia costiera italiana servono a salvare migranti, benchè l’ordine di questa repubblica sia di voltare le spalle.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. - APPELLO. LA SCUOLA ITALIANA ha bisogno di formare ragazze e ragazzi (...) Fermiamo la trasformazione della scuola in impresa.9 maggio 2018, di Federico La Sala
Scuola
Fermiamo la trasformazione della scuola in impresa
Appello. La scuola ha bisogno di un arricchimento dei programmi disciplinari, di una loro più avanzata e originale cooperazione, di nuovi rapporti tra docenti e alunni. Forze politiche, cittadini e intellettuali dicano un no definitivo a questi ciechi legislatori, che vogliono la scuola come un gigantesco apprendistato senza anima e senza futuro
La scuola italiana ha bisogno di maggiori risorse per rendere sicuri gli edifici che ospitano i nostri ragazzi, servizi più avanzati, per recuperare l’evasione che consegna tanti giovani alla marginalità, talora alla criminalità. La scuola italiana ha bisogno di un arricchimento dei programmi disciplinari, di una loro più avanzata e originale cooperazione, di nuovi rapporti tra docenti e alunni, nuove modalità di insegnamento, in grado di trasformare la classe in una comunità di studio e dialogo.
LA SCUOLA ITALIANA ha bisogno di formare ragazze e ragazzi emotivamente e psicologicamente equilibrati, culturalmente ricchi, consapevoli dei problemi del Pianeta, muniti di sguardo critico sulla società oggi inghiottita entro una bolla pubblicitaria. Ma chi decide il destino della nostra scuola è sordo a questi bisogni irrinunciabili del presente e del futuro. Impone ai nostri ragazzi- ad esempio con l’alternanza scuola-lavoro - un apprendistato per un lavoro che non troveranno, competenze per mansioni che saranno rese obsolete dall’innovazione tecnologica incessante.
EBBENE, dal prossimo giugno maestri e docenti della scuola elementare e media dovranno certificare le competenze dei loro allievi, utilizzando i nuovi modelli nazionali predisposti dal Ministero dell’istruzione. Per i ragazzini delle medie, la scheda di certificazione conterrà una parte dedicata a 8 «competenze europee» redatta dai loro insegnanti e una parte a cura dell’INVALSI.
 Per i bambini delle elementari, la scheda di certificazione riferita alle otto competenze europee, riguarda anche quella denominata «spirito di iniziativa e imprenditorialità», che in Italia è diventata semplicemente «spirito di iniziativa», pur mantenendo in nota il riferimento originario all’entrepreneurship, l’imprenditorialità. I consigli di classe delle varie scuole del Paese dovranno adoperarsi per «testare» la capacità di «realizzare progetti», essere «proattivi» in grado di «assumersi rischi», «assumersi le proprie responsabilità» fin da piccoli.
Per i bambini delle elementari, la scheda di certificazione riferita alle otto competenze europee, riguarda anche quella denominata «spirito di iniziativa e imprenditorialità», che in Italia è diventata semplicemente «spirito di iniziativa», pur mantenendo in nota il riferimento originario all’entrepreneurship, l’imprenditorialità. I consigli di classe delle varie scuole del Paese dovranno adoperarsi per «testare» la capacità di «realizzare progetti», essere «proattivi» in grado di «assumersi rischi», «assumersi le proprie responsabilità» fin da piccoli.
 Si stenta a credere, ma è proprio così: le istituzioni europee chiedono agli insegnanti di fare violenza ai nostri bambini, di plasmarli in una fase delicatissima della loro formazione emotiva e spirituale, incitandoli alla competizione, alla realizzazione di cose, all’intraprendenza «rischiosa».
Si stenta a credere, ma è proprio così: le istituzioni europee chiedono agli insegnanti di fare violenza ai nostri bambini, di plasmarli in una fase delicatissima della loro formazione emotiva e spirituale, incitandoli alla competizione, alla realizzazione di cose, all’intraprendenza «rischiosa».
 Verrebbe da ridere di fronte all’enormità di tale pretesa. Ma essa fa parte ormai di una gabbia fittissima di imperativi a cui è sottoposta la scuola, diventata luogo di ubbidienza di comandi ministeriali.
Verrebbe da ridere di fronte all’enormità di tale pretesa. Ma essa fa parte ormai di una gabbia fittissima di imperativi a cui è sottoposta la scuola, diventata luogo di ubbidienza di comandi ministeriali.DOPO ANNI di ciarle sull’autonomia, sulle libertà di scelta, su tutte le chimere della letteratura neoliberistica, appare evidente che la scuola è assoggettata a un progetto di centralismo neototalitario. Una pianificazione dall’alto mirata a sottrarre libertà agli insegnanti, obbligandoli a compiti subordinati ai miopi interessi del capitalismo attuale. Passo dopo passo, la scuola cessa di essere il progetto educativo di una comunità nazionale per diventare il luogo dove si riproduce un solo tipo di individuo, l’uomo economico ossessionato da finalità produttive. Chiediamo a tutte le forze politiche, agli intellettuali, ai cittadini italiani ed europei di dire un no definitivo a questi ciechi legislatori, che vogliono trasformare la scuola in un gigantesco apprendistato senza anima e senza futuro.
- Anna Angelucci, Rossella Latempa, Piero Bevilacqua, Alberto Asor Rosa, Salvatore Settis, Ilaria Agostini, Serge Latouche (Università Paris-Sud), Enzo Scandurra, Tomaso Montanari, Paolo Favilli,Tonino Perna, Ignazio Masulli, Lina Scalisi, John Dickie(Universiity College, London), Carlos J. Hernando Sanchez (Universidad de Valladolid), Adolfo Carrasco Martinez ((Universidad de Valladolid), Francesco Benigno, Francesco Vigliarolo (Università di Buones Aires)Tiziana Drago, José Antonio Guillen Berrendero (Università Rey Juan Carlos, Madrid), Manfredi Merluzzi, Elisa Novi Chavarria, Lavinia Gazzé, Cinzia Recca , Carlo Bitossi, Stefania de Vincentis ,Giorgio Inglese, Marta Petrusewicz, Giorgio Nebbia, Luigi Vavalà, Cristina Lavinio, Armando Vitale, Lucinia Speciale, Giuseppe Aragno, Alberto Ziparo, Francesco Santopolo, Battista Sangineto, Piero Caprari, Giuseppe Saponaro, Franco Toscani, Franco Novelli, Velio Abati, Carla Maria Amici, Gregorio De Paola, Laura Marchetti, Francesco Trane, Fabio Bentivoglio, Franco Blandi, Amalia Collisani, Rossano Pazzagli, Ugo M. Olivieri, Giovanni Carosotti, Francesco Cioffi, Lidia Decandia, Andrea Battinelli, Alessandro Bianchi, Dario Bevilacqua, Robert Lumley, (University College London) Rafael J.Gallé Cejudo (Universidad de Càdiz), Massimo Baldacci, Luisa Marchini, Carlo Freccero.,Francesco Sylos Labini, Donatelo Santarone, Joseph John Viscomi (Center for European and Mediterranean Studies New York University)Piotr Laskowski (Istituto di scienze sociali, Università di Varsavia) Roberto Budini Gattai, Alfonso Gabardella.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. - Smuraglia partigiano del diritto. La Costituzione come stella polare (di Corrado Stajano)5 maggio 2018, di Federico La Sala
Antifascismo
Il presidente emerito dell’Anpi conversa con Francesco Campobello
Smuraglia partigiano del diritto. La Costituzione come stella polare
di Corrado Stajano (Corriere della Sera, 05.05.2018)
«Erano momenti grandiosi, di immensa, comune felicità». Si lascia andare, nel ricordo di quel lontano aprile, Carlo Smuraglia, illustre giurista, senatore per più legislature, avvocato in processi che hanno lasciato il segno, in difesa delle vittime, dei poveri, degli offesi, uomo della Repubblica democratica e antifascista.
Partigiano e poi soldato nel Corpo italiano di liberazione, racconta la festa indimenticata, la commozione di quando, con il suo plotone, entrava nei paesi e nelle città riconquistate ai nazisti lungo l’Adriatico, fino a Venezia, dove furono proprio i soldati della divisione Cremona, di cui faceva parte, a piantare il tricolore sul campanile di San Marco: «Venivamo accolti con fiori e con doni di cibo. Io ero tra quelli che entravano per primi perché, essendo diventato marconista, la radio sulle spalle con cui trasmettevo gli ordini del nostro sottotenente, stavo sempre al suo fianco alla guida del plotone. Eravamo i primi due e si scherzava sul fatto che entrando per primo il tenente, era lui a ricevere gli abbracci e i baci delle ragazze e a me, che venivo subito dopo, venivano riservati quelli delle donne più anziane».
Carlo Smuraglia, con Francesco Campobello, assegnista di ricerca di Storia del diritto all’Università di Torino, è l’autore di questo piccolo-grande libro, Con la Costituzione nel cuore. Conversazioni su storia, memoria e politica, pubblicato dalle Edizioni del Gruppo Abele.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 era stato istintivo per lui scegliere la parte della libertà: aveva vent’anni ed era studente di Giurisprudenza alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Le discussioni tra i compagni cresciuti negli anni del fascismo, con in testa generiche idee politiche, non avevano fine, ma il dissolversi dello Stato, l’esercito a brandelli, la fuga del re, la mortale tenaglia dell’occupazione nazista, risvegliarono lo spirito di ribellione.
Contribuirono nel profondo gli echi del discorso, giunti alla Normale, di Concetto Marchesi, rettore all’Università di Padova, che invitava gli studenti a battersi.
Una lunga vita, quella di Smuraglia, tra l’università, la politica, le istituzioni. Professore ordinario di Diritto del lavoro - e non doveva esser facile diventarlo per un comunista negli anni Cinquanta - con una bibliografia ricca, di alto livello, da La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro pubblicato da Feltrinelli nel 1958, a La Sicurezza del lavoro e la sua tutela penale (Giuffré, 1967), al Diritto penale del lavoro (Cedam, 1980) alle innumerevoli pubblicazioni sullo statuto dei lavoratori, fino all’oggi in nome dei diritti dei cittadini e contro le diseguaglianze che umiliano il nostro infelice Paese.
Al Consiglio superiore della magistratura, poi, dal 1986 al 1990. Sarebbe dovuto diventare vicepresidente, ma «per scongiurare questa eventualità», dice Smuraglia nel libro, «Francesco Cossiga decise di votare, rompendo la tradizione secondo la quale il presidente della Repubblica, in tali occasioni, non vota». Al Csm fu tra quelli, sconfitti, che votarono per la nomina di Giovanni Falcone a capo dell’Ufficio istruzione di Palermo, una scelta che forse avrebbe salvato la vita al giudice. Fu eletto invece un magistrato che distrusse il pool di Palermo autore della sentenza-ordinanza del maxiprocesso del 1986.
L’avvocatura. Ai suoi inizi il giovane Smuraglia difese i partigiani perseguitati negli anni della Guerra fredda e gli operai comunisti chiusi nei reparti confino delle fabbriche e poi via via Piazza Fontana - fu uno dei protagonisti nel processo sulla morte in Questura, a Milano, di Giuseppe Pinelli -, vinse il processo sulla diossina di Seveso, fu parte civile nel doloroso processo sul sequestro di Cristina Mazzotti, uccisa nel 1975 dalla ’ndrangheta legata alla criminalità del Nord. Senza dimenticare il processo per lo scandalo Lockheed del 1978 davanti alla Corte costituzionale, eletto dal Parlamento commissario d’accusa, con Alberto Dall’Ora e Marcello Gallo, contro i ministri Gui e Tanassi.
Il Senato, poi. Smuraglia fu presidente della Commissione lavoro per sette anni, dalla XIII legislatura in avanti, e fece quel che poteva per la tutela dei diritti.
È un fautore del dialogo, Smuraglia. Un realista, non un estremista, sempre preoccupato delle conseguenze di quel che si sta facendo.
È un uomo rigoroso: «Non si può difendere bene un imputato se non si è convinti delle sue ragioni», dice, «Non si può vendere la coscienza per una parcella».
La Costituzione, per Smuraglia, è la stella polare, «regola la nostra vita, la convivenza quotidiana, la vita delle istituzioni».
Fu criticato quando l’Anpi, l’Associazione dei partigiani, di cui era allora presidente, si schierò per il No al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. La politicizzazione dell’ Anpi era l’accusa. È giusto far politica, replicava Smuraglia, se significa opporsi allo stravolgimento della somma Carta quando la riforma «tocca la libertà di voto e la sovranità popolare». In quell’occasione incontrò in un dibattito televisivo Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio davanti al professore, rigido ma sereno, sembrava uno scolaro balbettante e impreparato. Tante volte sconfitto, non quella volta, Carlo Smuraglia non rinuncia mai. Non si è mai arreso, il lume della speranza per lui non si spegne.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. -- Grazie alla nostra Costituzione (70 anni fa) siamo entrati nell’età dei diritti e gli articoli 2 e 3 della Carta sono lì a dimostrarlo, il passaporto per il futuro (Liliana Segre).5 maggio 2018, di Federico La Sala
Una commissione contro il razzismo
di Liliana Segre (la Repubblica, 05.05.2018)
Cari ragazzi e ragazze della Nuova Europa, ci sono molti modi per impegnarsi, efficacemente, nella materia, enorme e delicata, della discriminazione, ed io non cerco scorciatoie. Per dirla con parole antiche (Giambattista Vico) i rischi di una deriva autoritaria sono sempre dietro l’angolo. Lui, l’autore dei corsi e ricorsi storici, aveva visto lungo. Arrivo subito al punto consegnando a voi, che siete su un’isola, un “messaggio in bottiglia”: il mio primo atto parlamentare.
Intendo infatti depositare nei prossimi giorni un disegno di legge che istituirà una Commissione parlamentare d’indirizzo e controllo sui fenomeni dell’intolleranza, razzismo, e istigazione all’odio sociale. Si tratta di raccogliere un invito del Consiglio d’Europa a tutti i paesi membri, ed il nostro Paese sarebbe il primo a produrre soluzioni e azioni efficaci per contrastare il cosiddetto hate speech.
Questo primo passo affianca la mozione che delibera, anche in questa legislatura ( la mia firma segue quella della collega Emma Bonino) la costituzione di una Commissione per la tutela e l’affermazione dei diritti umani. C’è poi il terzo anello del discorso, l’argomento che più mi sta a cuore e che coltivo con antica attitudine: l’insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado della storia del ‘900. In una recentissima intervista, la presidentessa dell’Anpi, Carla Nespolo, ha insistito sullo stesso punto: «La storia va insegnata ai ragazzi e alle ragazze perché raramente a scuola si arriva a studiare il Novecento e in particolare la seconda guerra mondiale. Ma soprattutto non si studia che cosa ha significato per interi popoli europei vivere sotto il giogo nazista e riconquistare poi la propria libertà». Ora che le carte sono in tavola rivolgo a voi un invito molto speciale.
Un appello per una rifondazione dell’Europa, minacciata da “autoritarismi e divisioni” che segnalano l’emergere di una sorta di “nuova guerra civile europea”.
Il vento che attraversa l’Europa non è inarrestabile. Riprendete in mano le carte che ci orientano, che sono poche ma buone: in quelle righe sono scolpiti i più alti principi della convivenza civile, spetta a voi battervi perché trovino applicazione: grazie alla nostra Costituzione (70 anni fa) siamo entrati nell’età dei diritti e gli articoli 2 e 3 della Carta sono lì a dimostrarlo, il passaporto per il futuro.
La carta europea dei diritti fondamentali (che ha lo stesso valore dei trattati) è l’elevazione a potenza europea di questi principi, intrisi di libertà ed eguaglianza che abbiamo, orgogliosamente, contribuito a esportare.
Se vogliamo impastare i numeri con la memoria direi che siamo passati, in un solo “interminabile” decennio, dalla difesa della razza (1938) alla difesa dei diritti (1948). Il futuro deve essere orientato diversamente nel solco dei diritti inalienabili ecco perché, concedetemi la citazione, a cinquant’anni dal suo assassinio, Martin Luther King diceva che occorre piantare il melo anche sotto le bombe. È questo il momento giusto!
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI -- 1948-2018. Nella Costituzione idee cattoliche, liberali, marxiste. E tracce del fascismo (di Sabino Cassese).11 aprile 2018, di Federico La Sala
1948-2018 Un estratto del saggio di Sabino Cassese sulla «Rivista trimestrale di diritto pubblico» (Giuffrè)
Tante impronte sulla Carta
Nella Costituzione idee cattoliche, liberali, marxiste. E tracce del fascismo
di Sabino Cassese (Corriere della Sera, 10.04.2018)
Nel 1995, Massimo Severo Giannini, uno degli studiosi che prepararono la Costituzione, riassumeva così la sua valutazione della Carta costituzionale del 1948: «Splendida per la prima parte (diritti-doveri), banale per la seconda (struttura dello Stato), che in effetti è una cattiva applicazione di un modello (lo Stato parlamentare) già noto e ampiamente criticato». Da dove è stata attinta questa prima parte «splendida», quale è stata l’«officina di idee» che l’ha prodotta?
Piero Calamandrei ha fornito una chiave per individuare le fonti ideali delle norme costituzionali quando ha detto, nel 1955, che esse furono «il testamento di centomila morti, scritto con sangue di italiani nel tempo della Resistenza», ma anche «un punto di ripresa del pensiero politico-civile italiano, dove parlano le “grandi voci lontane” di Beccaria, Cavour, Pisacane, Mazzini».
La Costituzione ebbe una breve gestazione - non più di un triennio -, ma la sua maturazione ideale non fu altrettanto breve. Essa non nacque come Minerva armata dalla testa di Giove. Vi sono intessute culture, aspirazioni, esperienze, ideologie di diversa provenienza, di epoche differenti.
Di questo contenuto profondo dei principi costituzionali non posso fare qui che qualche esempio, e soltanto in forma interrogativa, avanzando ipotesi. Come arriva la diade della Costituzione termidoriana (non delle precedenti Costituzioni francesi rivoluzionarie) «diritti e doveri» negli articoli 2 e 4, nonché nel titolo della parte prima della Costituzione italiana? Non bisogna riconoscere dietro alla formula del secondo comma dell’articolo 3, quello sull’eguaglianza in senso sostanziale, la critica marxista della eguaglianza meramente formale affermata dalle Costituzioni borghesi e il successo che solo pochi anni prima, nel 1942, aveva avuto anche in Italia il «piano Beveridge» con la sua libertà dal bisogno? Come spiegare la circostanza che dei 1357 lemmi della Costituzione uno di quelli che hanno il maggior numero di occorrenze è «ordinamento», senza capire che «così dalla prima commissione la grande ombra di Santi Romano si estendeva all’Assemblea, come se il piccolo libro fosse stato scritto a favore dei Patti Lateranensi», come notato nel suo solito stile immaginifico da La Pira nel suo intervento sull’articolo 7?
 Ed è possibile ignorare la lunga storia del cattolicesimo italiano e del suo rifiuto dello Stato (la «questione romana»), che si intreccia con l’idea romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici o ispira le norme dove si afferma, prima che lo Stato garantisca i diritti o promuova le autonomie, che questi vadano riconosciuti, e quindi, preesistono allo Stato, consolidando quindi il pensiero della corrente antipositivistica (perché lo Stato viene dopo le persone, le «formazioni sociali» e gli ordinamenti originari non statali)?
Ed è possibile ignorare la lunga storia del cattolicesimo italiano e del suo rifiuto dello Stato (la «questione romana»), che si intreccia con l’idea romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici o ispira le norme dove si afferma, prima che lo Stato garantisca i diritti o promuova le autonomie, che questi vadano riconosciuti, e quindi, preesistono allo Stato, consolidando quindi il pensiero della corrente antipositivistica (perché lo Stato viene dopo le persone, le «formazioni sociali» e gli ordinamenti originari non statali)?
 Si possono comprendere le norme costituzionali sul patrimonio storico e artistico e sulla scuola ignorando l’elaborazione, in periodo fascista, a opera di Giuseppe Bottai, di Santi Romano, di Mario Grisolia, della legislazione sulle cose d’arte e della «carta della scuola», quindi senza riconoscere che la Costituzione antifascista ha raccolto anche l’eredità del fascismo? Infine, come intendere la portata dei programmi economici per indirizzare a fini sociali l’impresa privata, senza considerare una duplice esperienza, quella della pianificazione economica sovietica e quella del New Deal rooseveltiano?
Si possono comprendere le norme costituzionali sul patrimonio storico e artistico e sulla scuola ignorando l’elaborazione, in periodo fascista, a opera di Giuseppe Bottai, di Santi Romano, di Mario Grisolia, della legislazione sulle cose d’arte e della «carta della scuola», quindi senza riconoscere che la Costituzione antifascista ha raccolto anche l’eredità del fascismo? Infine, come intendere la portata dei programmi economici per indirizzare a fini sociali l’impresa privata, senza considerare una duplice esperienza, quella della pianificazione economica sovietica e quella del New Deal rooseveltiano?Nel melting pot costituente, furono raccolte, messe insieme, ordinate queste diverse idee, culture, esperienze, e altre ancora, che si mescolavano all’esigenza di riportare libertà e rispetto per i diritti nel Paese. La Costituzione rappresentò una reazione al regime illiberale fascista, ma fu anche il precipitato di ideali di epoche diverse (risorgimentale, liberaldemocratica, fascista), Paesi diversi (specialmente quelli che si dividevano il mondo, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica), aree diverse (quella cattolica, quella socialista e comunista, quella liberale), orientamenti dottrinali opposti (quello statalistico e quello pluralistico).
Calamandrei ebbe l’intelligenza di riconoscere questo sguardo lungo della Costituzione, ma - forse prigioniero dell’idea che la Resistenza fosse un secondo Risorgimento - si fermò alla segnalazione del contributo ideale di autori lontani, Mazzini, Cavour, Cattaneo, Garibaldi, Beccaria. Nel discorso del 1955 tralasciò il contributo che proveniva da altri Paesi e da epoche più vicine, specialmente dal fascismo, un contributo che prova la lungimiranza degli autori della Costituzione, antifascisti che recuperarono l’eredità del fascismo (ma questo a sua volta aveva sviluppato ideali e proposte dell’età liberale).
Questo risultato non fu sempre positivo, come osservava Giannini, perché la seconda parte della Costituzione (o, meglio, quella relativa alla forma di governo) sembrò dimenticare proprio la lezione del passato, come alcuni costituenti dissero ai loro colleghi, ricordando che anche dalle debolezze del sistema parlamentare liberale era scaturito il fascismo. Ciò avrebbe richiesto un sistema di stabilizzazione dei governi, pure auspicato da molti (e anzi accettato in linea di principio dalla ampia maggioranza che votò l’ordine del giorno Perassi), secondo il quale il sistema parlamentare doveva avere «dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e a evitare degenerazioni del parlamentarismo».
Come osservava Paolo Ungari molti anni or sono, «l’intera vicenda della cultura giuridica italiana fra le due guerre dovrebbe essere attentamente ripercorsa, e non solo al livello delle discussioni universitarie, per rendersi conto del patrimonio di idee e di tecniche degli uomini che sedettero nelle varie commissioni di studio del periodo intermedio, dalla commissione Forti a quella sulla “riorganizzazione dello Stato”, nonché alla Consulta e alla Costituente stessa».
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI --- LA BUONA NOVELLA E LA COSTITUZIONE. Note.31 dicembre 2015, di Federico La Sala
LA TERRA, LA BUONA NOVELLA, E LA COSTITUZIONE - LA LEGGE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI...
- I suoi discepoli dissero, "Quando ci apparirai, e quando tornerai a visitarci?"
 Gesù disse, "Quando vi spoglierete senza vergognarvi, e metterete i vostri abiti sotto i piedi come bambini e li distruggerete, allora vedrete il figlio di Chi vive e non avrete timore." (Ev-angelo di Tommaso, 37)
Gesù disse, "Quando vi spoglierete senza vergognarvi, e metterete i vostri abiti sotto i piedi come bambini e li distruggerete, allora vedrete il figlio di Chi vive e non avrete timore." (Ev-angelo di Tommaso, 37)
- I suoi discepoli dissero, "Quando ci apparirai, e quando tornerai a visitarci?"
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- Perché mi dimetterò da italiano se verrà stravolta la Costituzione (di Maurizio Viroli)28 febbraio 2015, di Federico La Sala
CittadinanzaPerché mi dimetterò da italiano se verrà stravolta la Costituzione
di Maurizio Viroli (il Fatto, 28.02.2015)
Provo a rispondere alle molte persone che hanno commentato su vari social networks l’articolo Non una riforma ma una revisione: il colpetto di Stato incostituzionale apparso sul Fatto Quotidiano del 20 febbraio. I gentili lettori e lettrici hanno concentrato le loro osservazioni soprattutto sulla conclusione: “Il capo dello Stato, quando riceverà la riforma dovrebbe rifiutarsi di firmarla. La Corte costituzionale dovrebbe abrogarla senza alcuna esitazione. Non si verificherà né l’una né l’altra ipotesi. Resta il referendum per il quale conviene cominciare a organizzarci fin d’ora, anche contro i partiti politici, come del resto abbiamo fatto nel 2006. Se poi la riforma passerà, e avremo un bel Senato di nominati, prenderò in serio esame di rinunciare alla cittadinanza italiana. Non credo che riuscirei a sopportare la vergogna di essere cittadino di una Repubblica che offende così apertamente la sua Costituzione”.
Chiarisco subito che non ho elementi certi per affermare che il capo dello Stato firmerà la riforma e che la Corte non la dichiarerà incostituzionale. La mia è soltanto una supposizione. Se il capo dello Stato avesse serie perplessità, le avrebbe manifestate in via riservata a Renzi e quest’ultimo avrebbe agito in tutt’altro modo. Stesso discorso per la Corte costituzionale.
LE MAGGIORI critiche vertono tuttavia sulla mia affermazione che rinuncerei alla cittadinanza italiana se venisse approvata la riforma renziana della Costituzione. Non è un motivo serio, hanno rilevato alcuni: gli antifascisti degli Anni 30 non lo hanno fatto, non si vede perché il sottoscritto, che gode di tutte le libertà, dovrebbe accedere a un simile passo.
Rispondo che per me la Costituzione è l’anima della Repubblica, ne definisce i principi fondativi, raccoglie l’eredità morale e politica della più alta esperienza di emancipazione politica della storia italiana, indica la via da seguire per vivere in Italia con dignità di cittadini. Una volta devastata, e per me la riforma renziana è una devastazione attuata in aperta violazione delle norme costituzionali, la Repubblica cambierà forma, non sarà più quella alla quale mi sento leale e quindi mi sentirò in diritto di rinunciare a essere cittadino.
Ma la motivazione fondamentale del mio gesto sarebbe l’incapacità di sopportare il senso di vergogna e di disgusto per una patria che lascia violare così la propria Costituzione senza un sussulto di dignità civile.
Ma insomma, com’è possibile accettare che la Costituzione sia riformata con il sostegno attivo di un delinquente? E come è possibile non vedere i pericoli che si annidano dietro il potere enorme del capo della maggioranza? Anche in passato, noi italiani, abbiamo avuto molti motivi per vergognarci, ma questa volta il metodo seguito e il contenuto della riforma sono il segno di una tale arroganza da autorizzare anche la protesta più radicale, beninteso, sempre entro i limiti della vita civile.
Il suo atto, mi hanno scritto, “non servirebbe a nulla”. Servirebbe, rispondo, a non sentirmi sottoposto a una casta arrogante e corrotta. E forse servirebbe come gesto di sdegno, a stimolare una resistenza civile. Riconosco tuttavia che molti lo interpreterebbero come una rinuncia all’impegno, anzi, una fuga di fronte alla sconfitta. Gli antifascisti che tanto ammiro non si sono mai arresi. “Lei può rinunciare alla cittadinanza italiana perché è già cittadino americano e vive all’estero; per la maggior parte di noi rinunciare alla cittadinanza è impossibile”. Verissimo, e se deciderò di non rinunciarvi, nonostante la riforma, sarà soprattutto perché voglio continuare a impegnarmi a fianco dei tanti italiani che non possono o non vogliono andarsene.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. --- Quando Calamandrei consacrò il nuovo inizio dell’Italia antifascista (di Corrado Stajano )11 ottobre 2013, di Federico La Sala
Domani la manifestazione a Roma per la difesa e per l’attuazione della Costituzione
Quando Calamandrei consacrò il nuovo inizio dell’Italia antifascista
di Corrado Stajano (Corriere della Sera, 11.10.2013)
La Costituzione, un traguardo storico da tutelare Nel famoso discorso che Piero Calamandrei fece nella seduta dell’Assemblea costituente del 4 marzo 1947 c’è, nel finale, un passo severo e insieme commosso che fa riflettere amaramente se si confronta quel passato al nostro presente: «Io mi domando, onorevoli colleghi, come i nostri posteri tra cento anni giudicheranno questa nostra Assemblea costituente: se la sentiranno alta e solenne (...). Io credo di sì: credo che i nostri posteri sentiranno più di noi, tra un secolo, che da questa nostra Costituente è nata veramente una nuova storia: e si immagineranno, come sempre avviene, che con l’andar dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda». Presa a modello nel mondo civile per il suo respiro, il suo coraggio nella tutela dei diritti dei cittadini, la Costituzione non ha avuto una sorte fortunata. La storia non si è «trasfigurata nella leggenda», come sognò il grande giurista. La Carta della Repubblica, il suo Vangelo, ha avuto e seguita invece ad avere nemici implacabili che allora come oggi, soprattutto in questi ultimi vent’anni, seguitano a considerarla «la nemica», un inciampo, un ostacolo da rimuovere, una legge arcaica ritenuta responsabile della mancata modernizzazione del Paese.
Le Edizioni di Storia e Letteratura hanno pubblicato in un aureo libretto quel discorso di Calamandrei, Chiarezza nella Costituzione (pp. 67, e 9), con un’appassionata introduzione di Carlo Azeglio Ciampi che fa rivivere lo spirito della giovinezza, la fiducia e le speranze di allora, nonostante le inaudite difficoltà dell’«Italia, sfiancata da anni di totalitarismo e di isolamento culturale. (...) Avvertivamo l’impegno e la responsabilità di contribuire con le nostre idee e con il nostro lavoro a restituire dignità all’Italia e a noi stessi».
Le speranze caddero presto. La guerra fredda e l’eterna compromissione nazionale impedirono una rottura radicale col passato. Gli anni 50-60, il periodo del centrismo democristiano, non furono per nulla da rimpiangere, come invece ha sostenuto nel suo discorso in occasione della fiducia al Senato il presidente del Consiglio Enrico Letta. L’epurazione fu una burletta, i fascisti, «i fantasmi della vergogna», come li definì Calamandrei in una sua celebre epigrafe, tornarono a dettar legge in posti di responsabilità, la discriminazione nei confronti della sinistra fu ferrea, gli operai comunisti e socialisti furono isolati nei reparti-confino delle grandi fabbriche, il centrosinistra originario, anni dopo, andò a gambe all’aria alla svelta, i tentati colpi di Stato, come quello del generale De Lorenzo, nel 1964, inquinarono ogni fervore.
Calamandrei - morì nel 1956 - fu profondamente deluso. Definì l’amata Costituzione L’incompiuta , dalla famosa Sinfonia in si minore di Schubert. In effetti istituti fondamentali previsti nella somma Carta tardarono decenni: la Corte costituzionale fu istituita nel 1955, il Consiglio superiore della magistratura nel 1958, le Regioni nel 1970, i codici sono mantelli di Arlecchino, corretti via via da interventi parziali, con l’eccezione del Codice di procedura penale rifatto nel 1988.
Il revisionismo degli anni 90 è diventato la carta vincente di una certa cultura politica del berlusconismo. Scrive Ciampi nella sua introduzione di aver giudicato con ammirazione i propositi dei costituenti di far sì che la Carta avesse come fondamento gli ideali e i valori comuni: «Mi riferisco proprio a quelle stesse soluzioni che oggi una saggistica e una storiografia mediocre pretendono di “rivedere” abbassandole a compromessi, frutto di opportunismo e di scambi inconfessabili». Bisogna tener conto che i costituenti del 1947 erano di livello intellettuale e politico assai alto: Luigi Einaudi, De Gasperi, Moro, Togliatti, Terracini, Dossetti, La Pira, Concetto Marchesi, Di Vittorio, Giorgio Amendola, Antonio Giolitti.
Come dimenticare la famosa costituente della baita di Lorenzago, nel Cadore, dove Roberto Calderoli, Francesco D’Onofrio, Domenico Nania e Andrea Pastore compilarono in 5 giorni (20-25 agosto 2003) 56 articoli della seconda parte della Costituzione che stravolgeva proprio quello spirito unitario del 1947? Furono puniti dagli elettori - esiste anche un’altra Italia - che al referendum del 25-26 giugno 2006 bocciò col 61,32 per cento dei voti quel dissennato progetto di legge costituzionale. Ma anche adesso, in un momento di grave crisi finanziaria, era davvero necessario dar vita a comitati e comitatini, più o meno lottizzati, per proporre riforme costituzionali? Non è sufficiente, per un governo di transizione, preoccuparsi di riformare la grottesca legge elettorale e tentare di risolvere i problemi economici e sociali?
Provoca sussulti rileggere quel testo di Calamandrei del 1947. Spiega, come un buon maestro, spiritoso, tra l’altro, chiaro, le sue idee di Stato e di società, il lavoro, la legalità, i partiti, l’articolo 7, la tutela delle minoranze: «La Costituzione deve essere presbite, deve veder lontano, non essere miope». Dobbiamo fare, disse citando Dante: «come quei che va di notte, / che porta il lume dietro e sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte». Una Costituzione non deve illuminare la strada soltanto ai presenti ma anche a coloro che vengono dopo, i posteri. Fedeli, infedeli?
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. --- COSTITUZIONE E FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE: BOLOGNA-REFERENDUM.21 maggio 2013, di Federico La Sala
 COSTITUZIONE E SCUOLA PUBBLICA: REFERENDUM CONSULTIVO. Alle urne questo 26 maggio i cittadini e le cittadine di Bologna voteranno per difendere la scuola pubblica e la Costituzione. Ogni altra interpretazione è pretestuosa e fallace.
COSTITUZIONE E SCUOLA PUBBLICA: REFERENDUM CONSULTIVO. Alle urne questo 26 maggio i cittadini e le cittadine di Bologna voteranno per difendere la scuola pubblica e la Costituzione. Ogni altra interpretazione è pretestuosa e fallace.
 BOLOGNA-REFERENDUM. COSTITUZIONE E FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE. Materiali: note di Stefano Rodotà, Emiliano Liuzzi, Francesca Coin
BOLOGNA-REFERENDUM. COSTITUZIONE E FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE. Materiali: note di Stefano Rodotà, Emiliano Liuzzi, Francesca Coin
 FRANCESCO GUCCINI. “Entrare nella scuola pubblica è il primo passo di ogni individuo che voglia imparare l’alterità e la condivisione. Ed è il primo passo di ogni essere umano per diventare uomo, per diventare donna”.
FRANCESCO GUCCINI. “Entrare nella scuola pubblica è il primo passo di ogni individuo che voglia imparare l’alterità e la condivisione. Ed è il primo passo di ogni essere umano per diventare uomo, per diventare donna”.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. --- «Questa è la cosa bella dell’animo democratico: pensare da bambino per ridisegnare le cose» (Teresa Mattei)..25 marzo 2013, di Federico La Sala
La buona politica della Costituzione
di Salvatore Settis (la Repubblica, 25 marzo 2013)
NON sfugga un confronto, questo: nell’Agenda Monti, programma elettorale di un presidente del Consiglio in carica, la parola “Costituzione” non c’è mai. Viceversa, nel suo discorso di insediamento come presidente della Camera, Laura Boldrini ha insistito sui «valori della Costituzione repubblicana» e sulla dignità delle istituzioni della Repubblica, ricordando con parole vibranti che «in quest’aula sono stati scritti i diritti universali della nostra Costituzione, la più bella del mondo».
Analogamente, il presidente del Senato Piero Grasso ha esordito richiamando due volte la Costituente e «quella che ancora oggi è considerata una delle Carte costituzionali più belle e più moderne del mondo». Il silenzio di Monti è coerente con l’ordine dei valori prevalso nella scorsa legislatura (compresa la sua fase “tecnica”): il “volere dei mercati” al culmine, la Costituzione sospesa, in attesa di tempi migliori. Basta questa differenza a misurare le straordinarie potenzialità di una nuova stagione politica, in cui l’impersonale, anti-politico anzi anti-democratico diktatdei mercati deve fare i conti con l’orizzonte dei diritti civili disegnato dalla Costituzione: sovranità popolare, diritto al lavoro, alla salute, a un sano ambiente, alla cultura, alla giustizia sociale.
Sarebbe un delitto farsi sfuggire un’occasione che non si ripeterà: questo il senso dei due appelli, quello promosso da Barbara Spinelli e quello lanciato da Michele Serra, che in pochi giorni hanno superato le 200.000 firme (li ho firmati anch’io). Questo, e non la cieca fiducia in questo o in quel partito, non l’ubbidienza a ordini di scuderia. Non l’arroganza di intellettuali che si sentono maestri, ma la voce di cittadini che fuori da ogni coro esprimono una preoccupazione e una speranza.
Perciò chi si è rallegrato che all’elezione del presidente del Senato abbiano contribuito voti del Movimento Cinque Stelle dovrà rallegrarsi altrettanto se, in altre circostanze, parlamentari del Pd violeranno la disciplina di partito per votare giusti provvedimenti proposti da quel Movimento. Dopo una campagna elettorale condotta sbandierando nomi, alleanze, schieramenti assai più che progetti e contenuti, è ora di rovesciare il tavolo dei giochi. Identificare contenuti, indicare traguardi, cercare consensi nel Paese e (dunque) nel Parlamento. Passare dalle chiacchiere ai fatti, cambiare subito il Paese sapendo quel che si vuole e quel che si fa.
Perciò l’art. 67 della Costituzione, secondo cui «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato» è oggi più che mai prezioso. Beppe Grillo non vorrà certo copiare Berlusconi attaccando la Costituzione ogni volta che non gli fa comodo. Senatori e deputati sanno bene, giacché lo sanno tutti i cittadini, quale è il paradosso che stiamo vivendo: il loro (anzi il nostro) è un Parlamento di nominati, non di eletti, eppure segna il più profondo rinnovamento che mai si sia visto in Italia, il più massiccio approdo in quelle aule di non-professionisti della politica. Essi possono essere tentati da una rigida disciplina di partito in cui qualcun altro pensi per loro, ma dovrebbero mirare assai più in alto. Pieno rispetto della legalità costituzionale (incluso l’art. 67) e piena libertà di coscienza sono i presupposti necessari per ridisegnare la mappa delle priorità politiche di questo Paese. Nessun prezzo è troppo alto, se il fine è il bene comune.
Gravi problemi incombono: la debolezza dello Stato centrale, in questo momento di ardue scadenze istituzionali, favorirà la marcia verso la formazione de facto di una “macroregione del Nord” capeggiata da Maroni, ridando fiato alla Lega in crisi e al suo mai sopito secessionismo, a spese dell’unità nazionale (art. 5 Cost.). Regioni svantaggiate e “generazioni perdute” verranno sacrificate senza pietà, immolandole non si sa più se alle ragioni “globali” dei mercati o a miopi alleanze (o nonalleanze) politiche. Cadranno nel nulla obiettivi oggi a portata di mano: «più giustizia sociale, più etica» (Grasso), «strumenti a chi ha perso il lavoro o non lo ha mai trovato» (Boldrini). Per non dire di una legge elettorale non iniqua, della riduzione dei costi della politica, di un forte argine, pur così tardivo, al conflitto di interessi, di un vero argine alla corruzione.
Per l’Italia e per l’Europa, questo e non il prossimo Parlamento deve fare il massimo sforzo per diventare «la casa della buona politica » (Boldrini) vincendo le logiche di un partitismo di maniera che gli elettori hanno bocciato, e facendo dell’inesperienza dei neo-eletti un punto di forza, lo strumento di un nuovo sguardo sulle istituzioni e sui problemi del Paese.
Dovrebbero esser scritte a caratteri cubitali, all’ingresso della Camera e del Senato (e domani a Palazzo Chigi e al Quirinale) le parole di Teresa Mattei (la più giovane dei membri della Costituente, morta a 92 anni qualche giorno fa) nella sua ultima intervista: «Questa è la cosa bella dell’animo democratico: pensare da bambino per ridisegnare le cose».
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. --- Calamandrei, le idee di un «costruttore di ponti» (di Arrigo Colombo)11 marzo 2013, di Federico La Sala
Calamandrei, le idee di un «costruttore di ponti»
di Arturo Colombo (Corriere della Sera, 11.03.2013)
- Il libro: Paolo Bagnoli, «Piero Calamandrei: l’uomo del ponte», edizioni Fuorionda, pagine 99, 12
Oggigiorno di Piero Calamandrei si parla troppo poco; quindi, va dato merito a Paolo Bagnoli di aver elaborato questo saggio, breve ma efficace, dal titolo Piero Calamandrei: l’uomo del ponte (Fuorionda), dove il riferimento al ponte non serve solo a richiamare la rivista «Il Ponte», che Calamandrei fondò nell’aprile del 1945 e della quale fu direttore fino al 1956, anno della sua scomparsa.
L’espressione «uomo del ponte» vuole indicare soprattutto un elemento caratterizzante della sua forma mentis, che vale a spiegare il costante rifiuto di ogni esclusivismo e settarismo, e la ricerca, invece, di quello spirito di collaborazione, che sempre contraddistinse Calamandrei nei diversi campi in cui operava, ogni volta lasciando il segno. Infatti fu un giurista, un docente universitario, un politico e anche un raffinato umanista: il suo libro del 1942, Inventario della casa di campagna, è lì a dimostrarlo.
Ma soprattutto l’apporto di Calamandrei fu decisivo negli anni dell’Assemblea Costituente, dove diede un apporto fondamentale nella difesa tanto del principio di libertà, «non come garanzia di isolamento egoistico, ma come garanzia di espansione sociale», quanto nel definire il ruolo della giustizia, connesso all’organizzazione del potere giudiziario e all’autogoverno della magistratura. Così da poter sostenere - sono parole di Calamandrei - che «le norme di una Costituzione democratica, come è quella della Repubblica italiana, possono avere un’efficacia educativa e quasi, si direbbe, pedagogica, che può servire di stimolo e di guida alle forze politiche».
Per la verità, mai come adesso si moltiplicano le critiche verso più di un aspetto di questa nostra Carta costituzionale. Eppure, rileggere non poche delle tesi di Calamandrei ci aiuta a costruire il profilo, mai intollerante o settario, di questa «coscienza inquieta»; ma soprattutto ci permette di intendere che solo attraverso «l’intervento correttore dello Stato» (purtroppo, così spesso latitante nel nostro Paese) riusciremo a rendere operante - Calamandrei lo scriveva fin dall’agosto del 1945 - una «democrazia vitale in cui la giustizia sociale, piuttosto che come ideale separato ed assoluto, sia concepita come premessa necessaria e come graduale arricchimento della libertà individuale».
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA.6 novembre 2012, di Federico La Sala
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. --- IL GOVERNO DI "IMPEGNO NAZIONALE" E LA "DEMOCRAZIA SOSPESA". UNA VERGOGNA DI LUNGA DURATA E IL DIFFICILISSIMO TENTATIVO DI MONTI.18 novembre 2011, di Federico La Sala
 STORIA D’ITALIA, 1994-2011: LA COSTITUZIONE, LE REGOLE DEL GIOCO, E IL "MENTITORE" ISTITUZIONALIZZATO ... CHE GIOCA DA "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" CON IL LOGO - PARTITO DI "FORZA ITALIA" E DI "POPOLO DELLA LIBERTA’"!!!
STORIA D’ITALIA, 1994-2011: LA COSTITUZIONE, LE REGOLE DEL GIOCO, E IL "MENTITORE" ISTITUZIONALIZZATO ... CHE GIOCA DA "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" CON IL LOGO - PARTITO DI "FORZA ITALIA" E DI "POPOLO DELLA LIBERTA’"!!! (...) I margini di successo sono tanto più ridotti, come ha rilevato il Presidente della Repubblica, dopo anni di contrapposizione e di scontri nella politica nazionale" (...)
(...) I margini di successo sono tanto più ridotti, come ha rilevato il Presidente della Repubblica, dopo anni di contrapposizione e di scontri nella politica nazionale" (...) -
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. --- CITTADINI E CITTADINE DI UNA DEMOCRAZIA "REALE"!5 giugno 2011, di Federico La Sala
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. --- Prima lezione di democrazia. Dalle regole alla partecipazione cosa vuol dire essere cittadini (di Gherardo Colombo).19 settembre 2011, di Federico La Sala
 Prima lezione di democrazia
Prima lezione di democrazia
 Dalle regole alla partecipazione cosa vuol dire essere cittadini
Dalle regole alla partecipazione cosa vuol dire essere cittadini
 Nel suo saggio l’ex magistrato spiega l’importanza dell’impegno. Altrimenti i governi diventano oligarchie
Nel suo saggio l’ex magistrato spiega l’importanza dell’impegno. Altrimenti i governi diventano oligarchie
 Le funzioni non si esauriscono nell’esercitare o meno il proprio diritto di voto
Le funzioni non si esauriscono nell’esercitare o meno il proprio diritto di votodi Gherardo Colombo (la Repubblica, 19.09.2011)
La democrazia presuppone una precisa considerazione degli esseri umani e delle caratteristiche delle relazioni che tra loro intercorrono. La democrazia non è uno strumento compatibile con gli atteggiamenti infantili, e se non si tiene conto della fatica che la crescita personale comporta per superare tali atteggiamenti non si può arrivare a capirla (...).
Il popolo governa agendo. E siccome il popolo non esiste se non esistono le persone che lo compongono, il popolo governa se agiscono le persone di cui è costituito. Si è considerata la forma, si è vista la sostanza. Si è tratteggiato, cioè, lo schema di regole e di contenuti che servono perché possa funzionare la democrazia. Tutto questo, però, ancora non basta: crea i presupposti perché il popolo governi, ma affinché si realizzi la democrazia è necessario che il popolo, nell’ambito delle regole, effettivamente governi. Una citazione aiuta a comprendere meglio la questione.
L’articolo 1 della Costituzione italiana afferma nel primo paragrafo che «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». L’espressione è interpretata storicamente attribuendo alla parola «lavoro» il significato corrente di attività produttiva. Il lavoro quindi fonda la Repubblica democratica perché è lo strumento attraverso il quale la persona si realizza, è il mezzo per l’emancipazione personale e per la promozione della società. Una lettura in chiave diversa aiuterebbe a capire cosa intendo: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro in quanto i cittadini lavorano, e cioè si impegnano, perché sia una Repubblica e una democrazia. È necessario che i cittadini agiscano per compiere la democrazia, perché questa possa attuarsi. In caso contrario, e cioè se tutti loro, o gran parte di loro, rimanessero inerti, evidentemente non governerebbero, e la democrazia si trasformerebbe necessariamente in monarchia o in oligarchia (perché governerebbero soltanto gli attivi, che potrebbero essere ipoteticamente soltanto uno o estremamente pochi). La trasformazione si verificherebbe di fatto, senza necessità di cambiare nemmeno una legge.
Così come la monarchia si trasformerebbe in oligarchia se il sovrano assoluto si disinteressasse completamente di svolgere le sue funzioni e gli subentrasse, di fatto, la corte. Allo stesso modo governerebbe, per esempio, il solo presidente del Consiglio dei ministri, se tutti i ministri e il Parlamento tralasciassero in concreto (pur conservandole apparentemente) le loro funzioni e il popolo si limitasse a esprimere con indifferenza il proprio voto alle scadenze elettorali, o magari a omettere, per una parte consistente dei suoi membri, persino quello. Non si tratta, però, soltanto di questioni di remissività da parte delle istituzioni nei confronti di una sola o di poche persone, che assumerebbero così il potere spettante ad altre sedi; non si tratta soltanto dell’esercitare o meno il diritto di voto. Il problema riguarda più in generale l’abdicazione del popolo a governare.
Per comprendere come il comportamento delle persone che compongono il popolo incida sull’attuazione della democrazia si può paragonare la società a una famiglia. Le persone che compongono la famiglia compiono di continuo azioni che riguardano se stesse individualmente e azioni che riguardano la famiglia nel suo complesso. Azioni generalmente programmate, dall’ora del risveglio passando per le varie faccende quotidiane fino al momento di coricarsi.
La programmazione individuale riguardante le proprie sfere di competenza incide non soltanto sulla vita di chi l’ha fatta, ma anche su quella degli altri: alzarsi alle dieci e arrivare regolarmente tardi al lavoro comporta il rischio di essere licenziato, presentarsi sempre tardi a scuola quello di non essere promosso, e il licenziamento e la bocciatura si rifletterebbero sull’intera famiglia. Altri aspetti organizzativi riguardano la famiglia nel suo complesso: fare la spesa, riordinare la casa, decidere gli acquisti e i viaggi, e così via. Dalla programmazione complessiva e dalla attuazione della programmazione risulta la qualità della vita del la famiglia, e cioè dei suoi membri.
Nella famiglia patriarcale la programmazione, anche delle sfere più personali, era riservata al padre (il monarca), che poteva delegare (magari tacitamente e per tradizione) le parti più ripetitive e meno qualificanti alla moglie, spettando per tutto il resto a questa e ai figli il compito di eseguire, cioè di comportarsi secondo le disposizioni ricevute. Ora, in una famiglia attuale gli indirizzi sono decisi concordemente dai coniugi: il Codice civile italiano, articolo 144, stabilisce che «I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare»; ma anche i figli partecipano alle decisioni che li riguardano, quando siano abbastanza grandi per farlo. Salvo che uno dei coniugi (o i figli, per quel che compete loro) si disinteressi, lasci fare, non partecipi, nel qual caso gli indirizzi, le decisioni sono presi dall’unica persona che si impegna a farlo. È questa persona che decide cosa comperare facendo la spesa, dove andare in vacanza e così via, e gli altri si adeguano. Non decidono, ma subiscono la decisione altrui.
Quel che succede in famiglia succede nella società: nella democrazia le regole prevedono la possibilità di contribuire all’indirizzo della vita propria e di quella della collettività, ma se la possibilità non è usata, se manca cioè l’impegno, la democrazia svanisce. Non sono sufficienti le regole, perché le regole consentono di partecipare al governo: se manca l’impegno, la partecipazione, il governo va ad altri.
© 2011 Bollati Boringhieri Editore
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. --- EDUCAZIONE ITALIANA. “Lo Stato siamo noi”, raccolta di scritti e discorsi di Piero Calamandrei (di Silvia Truzzi)..6 novembre 2011, di Federico La Sala
Calamandrei, educazione italiana
di Silvia Truzzi (il Fatto, 5.11.2011)
A chi si domanda perché riprendere in mano gli scritti dei vecchi, dei morti - invece che tenerli come santini in improbabili pantheon - sarà utile dare più di un’occhiata a “Lo Stato siamo noi” (Chiarelletere; 7 euro, 136 pagine) raccolta di scritti e discorsi di Piero Calamandrei. Giurista, azionista, padre costituente: perché Calamandrei oggi lo spiega Giovanni De Luna nella sua introduzione al volumetto, a proposito della fascistizzazione degli italiani. “Si era trattato, diceva Calamandrei, di un arido ventennio di diseducazione, passato sulle menti come una carestia morale’. Bisognava impedire che gli elementi essenziali di questa carestia transitassero intatti nella nuova Italia repubblicana”. Dice qualcosa? “Le macerie lasciate dal fascismo sono state quelle che ci hanno obbligato a riedeficare lo spazio pubblico con una religione civile”, spiega ancora De Luna. E tutti i comandamenti sono nella Costituzione. “La Carta è una cosa bellissima, però vive nella mente e nel cuore delle persone. Si deve incarnare nella concretezza di movimenti collettivi. Non è una conquista data una volta per tutte: va rinnovata in continuazione, attraverso la partecipazione politica”. Ma per sentirsi partecipi dello spazio pubblico della cittadinanza c’è bisogno di valori. Ci si domanda se alla bufera delle cricche, del potere e dell’individualismo, qualche forma di etica sia sopravvissuta. “Quello che è accaduto con la Seconda Repubblica”, conclude De Luna, “è stata una desertificazione dello spazio pubblico. Gli unici elementi di continuità sono stati gli interessi. Come se quella italiana fosse una sorta di cittadinanza bancomat. Una carta per accedere a beni, ricchezze, consumi, merci”. Bisogna ripartire. E bisogna ripartire da un’idea di democrazia che non è se non è inclusiva.
NEL LIBRO C’È un celebre discorso fatto da Calamandrei ai giovani. Parte dall’articolo 34 e dice: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nel-l’art. primo - «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» - corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale”.
Il testo è del 1955 eppure sembra scritto per i ragazzi della generazione mille euro che chiedono il diritto di essere, pienamente e non precariamente, persone. L’istruzione, il lavoro, l’uguaglianza sostanziale: ecco come avrete un’esistenza degna. Tutti: Calamandrei non dimentica mai gli ultimi. Come nel discorso in difesa - è proprio il testo di un’arringa difensiva pronunciata davanti al Tribunale di Palermo nel ’56 - di Danilo Dolci, accusato di manifestazione sediziosa e turbamento dell’ordine pubblico. Dolci aveva (addirittura) incitato al digiuno una comunità di pescatori, rimasti senza pesci nelle reti a causa del contrabbando. Digiunare vuol dire disturbare l’ordine pubblico. Ma l’ordine pubblico di chi? chiede Calamandrei ai giudici. E risponde: “L’ordine pubblico di chi ha da mangiare. Non bisogna disturbare con spettacoli di miseria e di fame la mensa imbandita di chi mangia bene”. Chissà che avrebbe detto dei “respingimenti”. Naturalmente nelle parole di questo libro ci sono anche il regime e la guerra civile. Quella frase diventata così famosa - “ora e sempre Resistenza” - è l’ultimo verso di un’epigrafe datata 4 dicembre 1952, scritta da Calamandrei per una lapide collocata nell’atrio del palazzo comunale di Cuneo, in protesta per la liberazione di Albert Kesselring, comandante delle forze di occupazione tedesche in Italia, condannato all’ergastolo nel 1947 ma liberato nel 1952 per “gravi” condizioni di salute. E ci sono anche i morti.
IN UN DISCORSO all’Assemblea Costituente, l’avvocato che elogiava i magistrati fa una domanda sui cittadini di domani: “Mi chiedo come i nostri posteri giudicheranno questa nostra Assemblea costituente. Se la sentiranno alta e solenne come noi sentiamo oggi alta e solenne la Costituente romana, dove un secolo fa sedeva e parlava Giuseppe Mazzini. Io credo di sì: credo che i nostri posteri sentiranno più di noi (...) che in questa nostra Assemblea, seduti su questi scranni non siamo stati noi, uomini effimeri di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all’Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la parte più dura e più difficile; quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore. Non dobbiamo tradirli”. Siamo in tempo?
-
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- la lezione di don Loreno Milani. Lettera aperta al Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano dei “ragazzi di Barbiana” (Francesco Gesualdi, Adele Corradi, Nevio Santini, Fabio Fabbiani, Guido Carotti, Mileno Fabbiani, Nello Baglioni, Franco Buti, Silvano Salimbeni, Enrico Zagli, Edoardo Martinelli, Aldo Bozzolini).13 aprile 2011, di Federico La Sala
Lettera aperta al Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano
dei “ragazzi di Barbiana”
dell’11 aprile 2011
Signor Presidente,
lei non può certo conoscere i nostri nomi: siamo dei cittadini fra tanti di quell’unità nazionale che lei rappresenta.
Ma, signor Presidente, siamo anche dei "ragazzi di Barbiana". Benché nonni ci portiamo dietro il privilegio e la responsabilità di essere cresciuti in quella singolare scuola, creata da don Lorenzo Milani, che si poneva lo scopo di fare di noi dei "cittadini sovrani".
Alcuni di noi hanno anche avuto l’ulteriore privilegio di partecipare alla scrittura di quella Lettera a una professoressa che da 44 anni mette in discussione la scuola italiana e scuote tante coscienze non soltanto fra gli addetti ai lavori.
Il degrado morale e politico che sta investendo l’Italia ci riporta indietro nel tempo, al giorno in cui un amico, salito a Barbiana, ci portò il comunicato dei cappellani militari che denigrava gli obiettori di coscienza. Trovandolo falso e offensivo, don Milani, priore e maestro, decise di rispondere per insegnarci come si reagisce di fronte al sopruso.
Più tardi, nella Lettera ai giudici, giunse a dire che il diritto - dovere alla partecipazione deve sapersi spingere fino alla disobbedienza: “In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo d’amare la legge è d’obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando avallano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate”.
Questo invito riecheggia nelle nostre orecchie, perché stiamo assistendo ad un uso costante della legge per difendere l’interesse di pochi, addirittura di uno solo, contro l’interesse di tutti. Ci riferiamo all’attuale Presidente del Consiglio che in nome dei propri guai giudiziari punta a demolire la magistratura e non si fa scrupolo a buttare alle ortiche migliaia di processi pur di evitare i suoi.
In una democrazia sana, l’interesse di una sola persona, per quanto investita di responsabilità pubblica, non potrebbe mai prevalere sull’interesse collettivo e tutte le sue velleità si infrangerebbero contro il muro di rettitudine contrapposto dalle istituzioni dello stato che non cederebbero a compromesso.
Ma l’Italia non è più un paese integro: il Presidente del Consiglio controlla la stragrande maggioranza dei mezzi radiofonici e televisivi, sia pubblici che privati, e li usa come portavoce personale contro la magistratura. Ma soprattutto con varie riforme ha trasformato il Parlamento in un fortino occupato da cortigiani pronti a fare di tutto per salvaguardare la sua impunità.
Quando l’istituzione principe della rappresentanza popolare si trasforma in ufficio a difesa del Presidente del Consiglio siamo già molto avanti nel processo di decomposizione della democrazia e tutti abbiamo l’obbligo di fare qualcosa per arrestarne l’avanzata. Come cittadini che possono esercitare solo il potere del voto, sentiamo di non poter fare molto di più che gridare il nostro sdegno ogni volta che assistiamo a uno strappo.
Per questo ci rivolgiamo a lei, che è il custode supremo della Costituzione e della dignità del nostro paese, per chiederle di dire in un suo messaggio, come la Costituzione le consente, chiare parole di condanna per lo stato di fatto che si è venuto a creare.
Ma soprattutto le chiediamo di fare trionfare la sostanza sopra la forma, facendo obiezione di coscienza ogni volta che è chiamato a promulgare leggi che insultano nei fatti lo spirito della Costituzione. Lungo la storia altri re e altri presidenti si sono trovati di fronte alla difficile scelta: privilegiare gli obblighi di procedura formale oppure difendere valori sostanziali. E quando hanno scelto la prima via si sono resi complici di dittature, guerre, ingiustizie, repressioni, discriminazioni.
Il rischio che oggi corriamo è lo strangolamento della democrazia, con gli strumenti stessi della democrazia. Un lento declino verso l’autoritarismo che al colmo dell’insulto si definisce democratico: questa è l’eredità che rischiamo di lasciare ai nostri figli.
Solo lo spirito milaniano potrà salvarci, chiedendo ad ognuno di assumersi le proprie responsabilità anche a costo di infrangere una regola quando il suo rispetto formale porta a offendere nella sostanza i diritti di tutti. Signor Presidente, lasci che lo spirito di don Milani interpelli anche lei.
Nel ringraziarla per averci ascoltati, le porgiamo i più cordiali saluti
Francesco Gesualdi, Adele Corradi, Nevio Santini, Fabio Fabbiani, Guido Carotti, Mileno Fabbiani, Nello Baglioni, Franco Buti, Silvano Salimbeni, Enrico Zagli, Edoardo Martinelli, Aldo Bozzolini
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO". LA LEZIONE DI GRAMSCI E L’ITALIA FERITA DI OGGI.11 aprile 2011, di Federico La Sala
ANTONIO GRAMSCI (1924). "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo":
***
L’ITALIA FERITA E SCONCERTATA. DOPO CHE IL SUO PAPA HA BENEDETTO E GUIDATO L’ATTACCO, BRUNO FORTE SI CHIEDE "COME CURARE L’ALBERO MALATO DELLA POLITICA". Una nota di premessa sull’inizio dell’offensiva e le sue "riflessioni sui nostri tempi", oggi
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani.8 aprile 2011, di Federico La Sala
Cliccare sul rosso, per leggere l’articolo:
 SCIENZA, FEDE, E "SIDEREUS NUNCIUS": "VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), GALILEO HA VINTO NON SOLO SUL PIANO SCIENTIFICO, MA ANCHE TEOLOGICO E POLITICO!!! COSI’ PER KANT ....
SCIENZA, FEDE, E "SIDEREUS NUNCIUS": "VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), GALILEO HA VINTO NON SOLO SUL PIANO SCIENTIFICO, MA ANCHE TEOLOGICO E POLITICO!!! COSI’ PER KANT ....
 L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani
(...) L’omissis più macroscopico è però un altro. Si tratta di un nome studiato anche in sede di letteratura italiana. Parliamo, è scontato dirlo, di Galileo, colui che scrisse in italiano quanto fino ad allora era riservato al latino. Per una Chiesa non ipocrita sarebbe stato il primo nome da citare, anche al fine di confutare, attraverso la sincerità, l’uso strumentale fattone da altri. Ciò vale anche per Savonarola e Giordano Bruno (...)
L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani
(...) L’omissis più macroscopico è però un altro. Si tratta di un nome studiato anche in sede di letteratura italiana. Parliamo, è scontato dirlo, di Galileo, colui che scrisse in italiano quanto fino ad allora era riservato al latino. Per una Chiesa non ipocrita sarebbe stato il primo nome da citare, anche al fine di confutare, attraverso la sincerità, l’uso strumentale fattone da altri. Ciò vale anche per Savonarola e Giordano Bruno (...) -
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- "Uniti supereremo ogni difficoltà". Gli auguri di Napolitano all’Italia. Accompagnato dalla signora Clio, il capo dello Stato ha aggiunto: "Se fossimo rimasti divisi in otto stati come eravamo nel 1860 saremmo stati spazzati via dalla storia".16 marzo 2011, di Federico La Sala
"Uniti supereremo ogni difficoltà". Gli auguri di Napolitano all’Italia
Roma - (Ign) - Il presidente della Repubblica nel suo intervento alla manifestazione per la ’notte tricolore’ nella piazza antistante il Quirinale: oggi "festeggiamo il meglio della nostra storia. E sottolinea: "Ognuno deve ricordare che è parte di qualcosa di più grande, la nostra nazione, la nostra Patria e la nostra Italia
Accompagnato dalla signora Clio, il capo dello Stato ha aggiunto: "Se fossimo rimasti divisi in otto stati come eravamo nel 1860 saremmo stati spazzati via dalla storia".
Per Napolitano oggi "festeggiamo il meglio della nostra storia. Perché abbiamo avuto momenti brutti, commesso errori, abbiamo vissuto pagine drammatiche ma abbiamo fatto tante cose grandi e importanti, grazie all’unità siamo diventati un Paese moderno". "Eravamo già in ritardo allora di fronte alla Spagna, alla Francia, all’Inghilterra che erano già dei grandi stati nazionali e stava per diventarlo anche la Germania. Per fortuna - ha detto ancora - eravamo in ritardo ma non abbiamo atteso ulteriormente. Sono state schiere di nostri patrioti che hanno combattuto e dato la vita e scritto pagine eroiche che noi dobbiamo avere l’orgoglio di ricordare e rivendicare. Perché solo così possiamo anche guardare con fiducia al futuro e alle prove che ci attendono".
"Ne abbiamo passate tante, passeremo anche quelle che avremo di fronte, in un mondo forse più difficile. Però l’importante è che ricordiamo sempre che" anche se "ognuno ha i suoi problemi, i suoi interessi e le sue idee e discutiamo e battagliamo ognuno deve ricordare che è parte di qualcosa di più grande, la nostra nazione, la nostra Patria e la nostra Italia. E se saremo uniti sapremo superare tutte le difficoltà che ci attendono. Auguri a tutti gli italiani"
* ADNKRONOS. ultimo aggiornamento: 16 marzo, ore 22:18:
 http://www.adnkronos.com/IGN/Speciali/Unita_DItalia/Uniti-supereremo-ogni-difficolta-Gli-auguri-di-Napolitano-allItalia_311798162589.html
http://www.adnkronos.com/IGN/Speciali/Unita_DItalia/Uniti-supereremo-ogni-difficolta-Gli-auguri-di-Napolitano-allItalia_311798162589.html-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- una cerimonia seria e festosa, in cui le ragazze e i ragazzi che nel corso dell’anno precedente hanno raggiunto la maggiore età giurassero lealtà alla Costituzione. E sarebbe giusto che questo rito di passaggio, consapevolmente vissuto, diventasse l’atto necessario per il pieno esercizio dei diritti politici (di Alberto Mario Banti - Fratelli d’Italia?).)17 marzo 2011, di Federico La Sala
FRATELLI d’Italia?
di Alberto Mario Banti (il manifesto, 17 marzo 2011)
Il 17 marzo ispira sentimenti patriottici. E invita a interrogarsi su cosa sia la patria, e, nello specifico, che cosa sia la patria italiana. Una risposta potrebbe essere questa: ubi bene, ibi patria: dove stai bene, quella è la tua patria. Il detto latino è piaciuto a Voltaire, che non aveva una grande opinione del patriottismo esclusivo. E infatti osservava: «È triste che spesso, per essere un buon patriota, si sia il nemico del resto degli uomini». E come correttivo a questa negativa valutazione, invitava ad alti pensieri: «Chi volesse che la sua patria non fosse mai né più grande né più piccola, né più ricca né più povera, sarebbe cittadino del mondo».
Dinamiche primarie
Molti anni dopo, in ben altro contesto, lo scrittore inglese E. M. Forster ha detto: «Se fossi posto davanti alla scelta se tradire il mio paese o tradire un amico, spero di avere il fegato di tradire il mio paese». Amorale? Anti-etico? George Steiner, che cita quella frase in un articolo per il «New Yorker», non la pensa così, e spiega perché: «Non c’è niente di più brutalmente assurdo della propensione degli esseri umani a distruggersi l’un l’altro o a massacrarsi sotto l’effetto del puerile incantesimo di una bandiera. La cittadinanza è un accordo bilaterale che è o dovrebbe essere sempre sottoposto a un esame critico. Dubito che l’animale uomo possa sopravvivere se non impara a fare a meno di frontiere e passaporti, se non riesce a capire che siamo tutti ospiti l’uno dell’altro, come lo siamo di questa terra ferita e avvelenata».
Visioni utopistiche? Forse. Il fatto è che, comunque sia, i nazionalismi ottocenteschi le hanno cancellate o rese impossibili, rovesciando il principio contenuto nel detto latino che piaceva a Voltaire, che per i nazionalisti funziona così: ubi patria, ibi bene: dov’è la tua patria, lì stai bene. Ma dov’è la patria di una persona? Per il nazionalismo ottocentesco l’appartenenza nazionale, e il necessario sentimento patriottico che ne deriva, scaturisce dal nascere: è sulla base di questa dinamica primaria che l’ideologia nazionale attribuisce la cittadinanza. È cittadino di uno Stato nazione chi è figlio di nazionali; o chi nasce sul territorio patrio. Ius sanguinis; e ius soli. Cioè «diritto di sangue» e «diritto di suolo». Questi sono i due dispositivi giuridici fondamentali. Ai quali altri si aggiungono, ma solo in forma sussidiaria. Il nesso tra nazione e cittadinanza, così formulato, attrae anche il concetto di patria. E così patria, con tutte le locuzioni che si trascina con sé («amare la patria», «morire per la patria», «tradire la patria») diventa un termine che indica il rapporto che un individuo ha e deve avere con la propria comunità nazionale e con le istituzioni che la rappresentano. In questa forma il patriottismo diventa inscindibile dal nazionalismo. E la relazione affettiva che il termine patria implica nei confronti della propria comunità si dispone su una catena che funziona in questo modo: si nasce dentro una nazione; si è tenuti ad amare quella nazione e le sue istituzioni in modo esclusivo; si è tenuti, dunque, a un sentimento patriottico che non ammette deroghe. Right or wrong, my country.
Il sentimento d’amore per la propria patria deriva dunque, per il nazionalismo, da un fondamentale automatismo etero-diretto: il nascere. Che, com’è chiaro, è un evento che non comporta scelta: non si sceglie né da chi nascere, né dove nascere.
Può sembrare strano, ma questa concezione automaticamente naturalistica, intimamente biopolitica, imposta dal nazionalismo ottocentesco, e condivisa dal nazional-patriottismo risorgimentale, presiede ancora oggi all’attribuzione della cittadinanza della Repubblica italiana.
Il fallimento della scuola
Secondo la legge che disciplina il conferimento della cittadinanza italiana, si è automaticamente nazionali se si è figli di nazionali; o se si nasce sul suolo patrio da genitori ignoti o apolidi. Tutti gli altri meccanismi per diventare italiani prevedono procedure più complesse e, in qualche caso, anche irte di ostacoli.
Come che sia, gli italiani per «diritto di sangue» o per «diritto di suolo» dispongono automaticamente della piena cittadinanza italiana sin dalla nascita. Dopodiché, chi possiede questapiena cittadinanza, al raggiungimento della maggiore età acquisisce anche i pieni diritti civili e politici in forma altrettanto automatica. Non c’è bisogno che sia consapevole di quali sono i suoi diritti. Né c’è bisogno che sappia quali sono i valori o i meccanismi fondamentali che regolano la vita pubblica.
Basta essere italiano e, una volta maggiorenne, si ottiene una piena cittadinanza politica. Che - a pensarci bene - è un meccanismo abbastanza impressionante nella sua stranezza. Sarebbe come se a un certo punto si dicesse: siccome un giovane è figlio di nazionali, al raggiungimento della maggiore età diamogli la patente di guida automaticamente, senza chiedergli neanche mezz’ora di scuola guida o uno straccio di esame di verifica. Se lo merita, no? È figlio di nazionali! Anzi, facciamo di più: se uno è figlio di nazionali, diamogli anche la maturità, senza nemmeno un giorno di scuola. Se lo merita, no? È figlio di nazionali! Anzi, vogliamo essere veramente generosi? E allora diamogli anche una laurea in medicina e chirurgia senza chiedergli neanche un giorno di università, e poi mandiamolo su un tavolo operatorio ad operare il primo paziente che passa: se lo merita, no? È figlio di nazionali!
Sarebbe assurdo, non è vero? E però, se giustamente chiediamo conoscenze, competenze, verifiche per cose anche banali - come la licenza di guida -, o per cose ben più complesse - come un diploma abilitante -, perché non chiediamo a tutti i cittadini una seria e rigorosa conoscenza dei valori e delle norme che regolano la vita collettiva?
Ricorrenze durature
La scuola è sempre stata tristemente fallimentare in questo compito: né l’educazione civica, né l’educazione alla cittadinanza, né altre denominazioni della stessa materia, sono mai state prese sul serio; e meno per colpa dei professori che dell’evidente scarso rilievo che a questo tipo di conoscenza è sempre stato attribuito dalle élite di governo.
Il testo che raccoglie i valori fondamentali e le regole essenziali che disciplinano la vita pubblica è la Costituzione. I diritti politici che adesso si acquisiscono automaticamente sono enunciati lì. Quello è il patto fondamentale che ci fa italiani. Non importa che uno sia di lingua e cultura italiana, di lingua e cultura francese, di lingua e cultura tedesca: se vive nei confini della Repubblica italiana trova lì le sue garanzie, lì i suoi diritti. Lì, in un testo molto bello, scritto da un’assemblea eletta liberamente a suffragio universale. Un testo che dal 1948 a oggi ha garantito la libertà di tutti, qualunque fosse il credo politico individuale.
È un testo che festeggiamo implicitamente il 25 aprile e il 2 giugno, ricorrenze festive che giustamente non durano per un anno soltanto come il 17 marzo, perché ricordano la vera origine della nostra Repubblica. È nel rispetto e nella lealtà a quel testo che potremmo riconquistare un nuovo patriottismo, che non sia quello inquinato dall’ideologia nazionalista. È il patriottismo costituzionale, sul quale più volte Jürgen Habermas ha riflettuto.
Ma come può alimentarsi concretamente un patriottismo costituzionale? Per rendere vivo quel sentimento politico è necessario considerare che la Costituzione è in effetti il patto collettivo che ci tiene insieme. E in quanto patto collettivo dovrebbe essere non solo conosciuto, ma anche sottoscritto da tutti i cittadini.
Adesso non è così. Solo alcune categorie di individui sono chiamate a giurare lealtà alla Costituzione: le alte cariche dello Stato; i militari; e gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana. E perché tutti gli altri no? Perché gli italiani e le italiane per «diritto di sangue» o per «diritto di suolo» no?
La festa del 2 giugno
È difficile che un sano sentimento di italianità possa scaturire dalla primitiva automaticità del «diritto di sangue» o del «diritto di suolo». Com’è difficile che un sano patriottismo possa scaturire dal revival di dubbie o controverse memorie storiche. E invece un’italianità non nazionalista e un caldo patriottismo costituzionale potrebbero ricevere nuova energia se li si facesse derivare da un consapevole rito di passaggio, un rito che trasformasse un giovane in un cittadino perfettamente consapevole dei suoi diritti e dei valori fondamentali che lo legano a tutti gli altri.
Un rito che, per esempio, festeggiasse il 2 giugno in ogni comune con una cerimonia seria e festosa, in cui le ragazze e i ragazzi che nel corso dell’anno precedente hanno raggiunto la maggiore età giurassero lealtà alla Costituzione. E sarebbe giusto che questo rito di passaggio, consapevolmente vissuto, diventasse l’atto necessario per il pieno esercizio dei diritti politici.
Fantasie? Quasi sicuramente sì. Eppure son convinto che sarebbe un rituale bellissimo; son convinto che tutti prenderebbero con impegno e serietà la cosa; e che così il garrire delle bandiere e il risuonare di inni non evocherebbe più vacue e inquietanti immagini di lontani eventi bellici, ma una realtà attuale e cara: la tavola dei valori su cui concordiamo e che disciplina la nostra vita in comune.
-
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI ---- La rivoluzione promessa? Possiamo ancora farla. Tutti noi (di Gianfranco Pasquino).16 marzo 2011, di Federico La Sala
La rivoluzione promessa? Possiamo ancora farla. Tutti noi
Quella che segue è una parte dell’introduzione di Gianfranco Pasquino al libro «La rivoluzione promessa. Lettura della Costituzione italiana» (Bruno Mondadori) , da giovedì in libreria
di Gianfranco Pasquino (l’Unità, 15.03.2011)
Le Costituzioni moderne sono soprattutto carte che codificano le libertà; sanciscono diritti e doveri dei cittadini; delineano i rapporti fra cittadini e le istituzioni; specificano la divisione dei poteri e i limiti del loro esercizio a opera di ciascuna istituzione e di coloro che vi sono preposti. Oggi, possiamo affermare con sicurezza che le Costituzioni danno forma a un sistema politico, e potremmo aggiungere che dove non c’è una Costituzione non esiste, pur con la luminosa eccezione della Gran Bretagna, democrazia. Tutti i sistemi politici che si sono affacciati alla democrazia, negli ultimi trent’anni alcune decine, si sono dati Costituzioni il cui elemento centrale è rappresentato dal riconoscimento e dalla garanzia dei diritti dei cittadini. Molto spesso i rispettivi costituenti hanno approfittato della possibilità, qualche volta una vera e propria necessità, di scrivere la Carta costituzionale per delineare anche il tipo di sistema politico, sociale ed economico da loro preferito. Nessuna Costituzione contemporanea potrebbe oggi fare a meno di offrire spazio al mercato e alla concorrenza economica. Né potrebbe tralasciare di regolamentare tutto quello che attiene all’istruzione, al lavoro, alla salute dei suoi cittadini.
Tra il 1946 e il 1948 i costituenti italiani ebbero la grande opportunità di collaborare alla stesura della prima vera e propria Carta costituzionale della Repubblica democratica italiana. Da uno dei più autorevoli di loro, per statura intellettuale e conoscenza del diritto, Piero Calamandrei, vennero contributi significativi, ma anche forti critiche al testo approvato. In particolare, Calamandrei, giurista positivista, manifestò forte contrarietà alle norme programmatiche, quelle che indicano quanto deve essere fatto, che, per l’appunto, delineano un programma. Quando, pochi anni dopo la promulgazione, Calamandrei si trovò a fare un bilancio, ancorché preliminare, della Costituzione italiana, affermò con una frase memorabile che era una«rivoluzione promessa in cambio di una rivoluzione mancata».
Negli articoli della Costituzione, addirittura nel suo impianto complessivo, stava un disegno di trasformazione dei rapporti politici, sociali ed economici che, almeno in parte, rifletteva le grandi e nobili aspirazioni della Resistenza, ovvero la «rivoluzione mancata».
Quella di Calamandrei non era soltanto una frase a effetto. Purtroppo la fase di applicazione della Costituzione non si è mantenuta fedele alle sue promesse e alle norme programmatiche. La storia della Repubblica italiana spiega il perché delle inadempienze, ma non può giustificarle, anche se la guerra fredda (1946-1989) sicuramente non facilitò scelte che la Costituzione suggeriva e incoraggiava. In seguito, lo strapotere dei partiti, ovvero la partitocrazia, tutt’altro che un fenomeno inevitabile e meno che mai insito nella Costituzione italiana, provocò non poche inadempienze e distorsioni costituzionali.
Da più di tre decenni, ormai, l’attenzione si è spostata e si è concentrata sulle istituzioni e sulla loro riforma, spesso addirittura esclusivamente sul sistema elettorale, nella ricerca spasmodica della formula che convenga maggiormente a partiti che si sono alquanto indeboliti, ma che rimangono gli attori politici dominanti. È probabile che i costituenti, non soltanto Calamandrei, guarderebbero preoccupati, se non addirittura inorriditi, alle proposte particolaristiche di cambiamento delle regole e delle istituzioni. Preoccupazione e orrore non deriverebbero affatto da una loro difesa a oltranza, come fanno alcuni politici, giuristi e intellettuali italiani, di tutto il testo costituzionale quasi fosse un oggetto sacro. Al contrario, pochi di loro riterrebbero la Costituzione immodificabile poiché le modalità delle eventuali modifiche sono chiaramente indicate e regolate. I costituenti non meritano l’appellativo di «conservatori istituzionali». Si chiederebbero, però, se la classe politica italiana ha davvero operato per tradurre la rivoluzione promessa in quelle riforme politiche, sociali ed economiche che renderebbero migliore l’Italia.
La lettura del testo costituzionale, effettuata senza interferenze politicizzate e senza paraocchi ideologici, consente di cogliere in molti articoli le potenzialità tuttora vive di una trasformazione profonda dell’Italia, anche grazie al suo inserimento, previsto in maniera lungimirante, negli organismi europei e nelle istituzioni internazionali.
Credo che sia doveroso sottolineare che i problemi politici, sociali, economici e istituzionali italiani non hanno nessuna radice negli articoli della Costituzione, anche se alcuni articoli sono, senza dubbio, da rinfrescare e da ritoccare, talvolta anche da riscrivere. Ma la rivoluzione promessa è ancora tutta davanti a noi, perseguibile e conseguibile. La Repubblica alla quale i costituenti hanno affidato il compito ambiziosissimo ed esigentissimo di rimuovere gli ostacoli che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale» siamo noi, cittadini e detentori di cariche politiche a tutti i livelli. La responsabilità maggiore è sempre quella di chi ha più potere politico, ma qualsiasi rivoluzione, anche pacifica, da effettuarsi attuando le norme programmatiche, ha bisogno diunampio sostegno popolare e di una convinta partecipazione di cittadini informati. Sono entrambi elementi che una buona conoscenza della Costituzione è in grado di costruire e potenziare. Era la speranza dei costituenti italiani. È rimasta tale.
 Tutti i diritti riservati © 2011, Pearson Italia, Milano - Torino. Prima edizione: marzo 2011
Tutti i diritti riservati © 2011, Pearson Italia, Milano - Torino. Prima edizione: marzo 2011-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE ---- Le parole (sbagliate) della politica20 febbraio 2017, di Federico La Sala
- LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IMPARARE A CONTARE! "Realismo Metafisica Modernità" - oggi.
Le parole (sbagliate) della politica
di Gianfranco Pasquino (Il Mulino, 17 febbraio 2017)
«La» proporzionale non esiste. Da più di cento anni esistono molte leggi elettorali definibili «proporzionali» che si distinguono per tre aspetti: per la dimensione delle circoscrizioni (piccole se vi si eleggono meno di 10 parlamentari, medie e grandi a seconda del numero di parlamentari loro assegnati); per l’esistenza o meno di soglie, percentuali o di altro tipo, di accesso al Parlamento; per la formula di traduzione dei voti in seggi (D’Hondt, Hare, Saint Lagüe, che avvantaggiano/svantaggiano i partiti). Sia il Porcellum sia l’Italicum sono leggi elettorali proporzionali, corrette o, a seconda del punto di vista, distorte da un premio di maggioranza.
Dunque, abbandonare l’Italicum non significa di per sé «tornare» alla proporzionale perché nella «cattiva» proporzionale con l’Italicum c’eravamo già, alla grande. Poi, dipende da quale proporzionale il Parlamento vorrà/saprà scrivere. Meglio sarebbe che gli anti-proporzionalisti, il cui punto di convergenza sembra essere, senza alcuna fantasia, il premio di maggioranza, si esprimessero in maniera coerentemente maggioritaria (first past the post inglese, voto alternativo australiano, doppio turno francese) e dicessero alto e forte che i collegi uninominali consentono una migliore selezione del ceto parlamentare.
In nessuna delle democrazie attualmente esistenti, meno che mai in quelle parlamentari, è aperto il surrealissimo dibattito su rappresentatività e governabilità. In tutte la rappresentatività è vista come la premessa essenziale della governabilità. Persino laddove i sistemi elettorali sono maggioritari, applicati in collegi uninominali, la rappresentatività è assicurata dall’imperativo per il candidato vittorioso in ciascun collegio di rappresentare non soltanto gli elettori che lo hanno votato, ma anche quelli che non l’hanno votato. Alcuni di questi elettori potrebbero votarlo la volta successiva se avrà ben rappresentato il collegio tutto.
L’elezione del segretario di un partito non è mai una primaria. L’ho già detto, ripetuto e scritto (Le parole della politica, Il Mulino, 2010). Le primarie che, secondo gli apologeti, si troverebbero nel Dna del Partito democratico, servono esclusivamente a fare scegliere a iscritti, elettori, simpatizzanti di un partito le candidature alle cariche pubbliche monocratiche: sindaco, governatore della regione, presidente del Consiglio.
 L’elezione del segretario del Pd che, con filtri e vagli, può giungere persino a essere decisa dall’Assemblea nazionale non è affatto una primaria. Inoltre, congresso del Partito ed elezione del nuovo segretario hanno scadenze proprie che non debbono tenere e non hanno tenuto conto delle occasioni elettorali. Per di più, sono disponibili le fattispecie di almeno due importanti elezioni del segretario del Pd: quella di Walter Veltroni nel 2007 e quella di Pierluigi Bersani nel 2009. In entrambe le occasioni nessuno dei dirigenti, militanti, iscritti, simpatizzanti, pure se era ampiamente usata la terminologia sbagliata, credeva di stare incoronando il candidato alla carica di presidente del Consiglio (anche se la cavalcata di Veltroni, inconsciamente/subconsciamente, terminò con la sua inevitabile candidatura grazie alla caduta del governo Prodi). Che «primarie» suoni pomposamente bene è un fatto (in parte positivo per le primarie correttamente intese), ma il suo uso per l’elezione del segretario del Pd rimane fuorviante e sbagliato.
L’elezione del segretario del Pd che, con filtri e vagli, può giungere persino a essere decisa dall’Assemblea nazionale non è affatto una primaria. Inoltre, congresso del Partito ed elezione del nuovo segretario hanno scadenze proprie che non debbono tenere e non hanno tenuto conto delle occasioni elettorali. Per di più, sono disponibili le fattispecie di almeno due importanti elezioni del segretario del Pd: quella di Walter Veltroni nel 2007 e quella di Pierluigi Bersani nel 2009. In entrambe le occasioni nessuno dei dirigenti, militanti, iscritti, simpatizzanti, pure se era ampiamente usata la terminologia sbagliata, credeva di stare incoronando il candidato alla carica di presidente del Consiglio (anche se la cavalcata di Veltroni, inconsciamente/subconsciamente, terminò con la sua inevitabile candidatura grazie alla caduta del governo Prodi). Che «primarie» suoni pomposamente bene è un fatto (in parte positivo per le primarie correttamente intese), ma il suo uso per l’elezione del segretario del Pd rimane fuorviante e sbagliato.Altrove - come negli Stati Uniti, dove non esiste affatto una legge federale che le regolamenti, ma ciascun partito in ciascuno Stato decide a suo piacimento requisiti e regole - attraverso le primarie si designano i candidati alla Camera dei rappresentanti e al Senato, al governo degli Stati, alla presidenza. Sono facoltative, dunque, cosicché ogniqualvolta c’è un unico candidato, rappresentante, senatore, governatore, senza sfidante non si terrà alcuna elezione primaria. Sono anche criticate perché esposte a manipolazioni di molti generi e perché, qualche volta, sono divisive. Rimangono un efficacissimo strumento di mobilitazione, partecipazione, comunicazione e influenza dei cittadini-elettori.
C’è un Paese nel quale sembra non s’insegnino più i congiuntivi e, con grande dolore dei professori, neppure se ne faccia accorto uso. Potrebbero quei professori inquietarsi anche per il cattivo ed erroneo uso di alcune parole chiave della politica e delle istituzioni? Tanto usare le parole sbagliate quanto manipolarle produce confusione che, certo, non giova né alla politica né alla cultura politica.
- LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. --- IMPARARE A CONTARE! "Realismo Metafisica Modernità" - oggi.
-
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- Scuola pubblica e Costituzione Due valori sacri (di Marco Rossi Doria)13 marzo 2011, di Federico La Sala
Scuola pubblica e Costituzione Due valori sacri
di Marco Rossi Doria (l’Unità, 11 marzo 2011)
Andiamo nelle piazze per difendere la Costituzione e la scuola pubblica. Perché pensiamo che l’Italia, che noi tutti, non ne possiamo fare proprio a meno. E non ne possiamo fare a meno perché sono due cose che hanno la rara qualità di essere, ad un tempo, vitali e sacre. Vitali perché consentono a un organismo complessissimo - quale è la società - di regolarsi e di continuare a vivere nel tempo, generazione dopo generazione. Sacre perché contengono le qualità simboliche che permettono di tenere insieme una comunità fatta di milioni di persone diverse secondo un diritto che è uguale.
La nostra Carta sa mettere insieme, in modo chiaro, non solo i diritti e i doveri ma «quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi» - come scriveva Piero Calamandrei. In questi anni abbiamo vissuto e stiamo vivendo un tempo Grave non perché si è pensato o si pensi di cambiare questa o quella parte della Costituzione, cosa del tutto prevista dalla Carta stessa. E normale col passare del tempo. Se fatta per concorde adesione. Il tempo grave che viviamo è dato dal fatto che si stanno continuamente attaccando proprio “quegli organi” - e il delicato equilibrio tra di essi - «attraverso i quali la politica si trasforma in diritto». Questo non deve accadere. E siamo qui per impedirlo. Perciò: non si tratta di una battaglia di parte né di conservazione. È una battaglia per tutti, anche per quelli che oggi non lo vogliono capire. Ed è una battaglia che permette di continuare a cambiare. Perché c’è la certezza del come farlo, delle condizioni entro le quali le trasformazioni non diventano distruzioni, non minacciano la casa comune.
La nostra scuola ogni mattina mette insieme i mondi interiori di ogni bambino e ragazzo che sta crescendo con quello di ciascun altro e, al contempo, con l’universo mondo, le sue leggi, la sua storia, i suoi problemi e i molti alfabeti che servono a leggerlo. È in questa doppia funzione - mettere insieme persone diverse e apprendere - che vi è vitalità e sacralità.
La scuola è chiamata ad assolvere a questo suo compito in modi nuovi. E deve trasformarsi proprio perché sono mutate e stanno mutando sia le condizioni dello stare insieme tra diversi sia il mondo sia gli strumenti attraverso i quali lo si guarda e lo si può capire, salvaguardare e cambiare. Il tempo grave che stiamo vivendo è dato dal fatto che si metta in discussione la scuola nel suo carattere pubblico e protetto - e, dunque, altro da casa - nel quale ci si confronta tra diversi ed uguali mentre si sta crescendo e si sta imparando a stare al mondo e a conoscerlo. Anche per la scuola questa non è una battaglia di parte né di conservazione. È per tutti e per ciascuno. Ed è per consentire che la scuola, salvaguardata, possa cambiare.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- COSTITUZIONE E SCUOLA DELLA REPUBBLICA: CHI INSEGNA A CHI, CHE COSA?24 febbraio 2011, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI, CHE COSA?
Una dichiarazione di indipendenza e un appello
2001*
PER IL DIALOGO E LA PACE TRA LE GENERAZIONI E I POPOLI: Apriarno gli occhi, saniarno le ferite dei bambíni (deí ragazzi) e delle bambine (delle ragazze), dentro di noí e fuori di noí...Riannodiamo i fili della nostra rnemoria e della nostra dignità di esseri umani. Fermiamo la strage...
Linee per un Piano di Offerta Formativa della SCUOLA dell’AUTONOMIA, DEMOCRATICA E REPUBBLICANA.
***
CHI siamo noi in realtà? Qual è íl fondamento della nostra vita? Quali saperi? Quale formazione?
SCUOLA, STATO, E CHIESA: CHI INSEGNA A CHI, CHE COSA?!
 IL "DIO" DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI...
IL "DIO" DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI...
 E IL "DIO" ZOPPO E CIECO DELLA GERARCHIA DELLA
CHIESA CATTOLICA, EDIPICO-ROMANA.
E IL "DIO" ZOPPO E CIECO DELLA GERARCHIA DELLA
CHIESA CATTOLICA, EDIPICO-ROMANA. Alla LUCE, e a difesa, DELLA NOSTRA DIGNITA
DI CITTADINI
SOVRANI E DI CITTADINE SOVRANE E
Alla LUCE, e a difesa, DELLA NOSTRA DIGNITA
DI CITTADINI
SOVRANI E DI CITTADINE SOVRANE E
 DI LAVORATORI
E LAVORATRICI DELLA SCUOLA PUBBLICA (campo
di RELAZIONE educativa, che basa il suo PROGETTO e la sua
AZIONE sulla RELAZIONE FONDANTE - il patto costituzionale
DI LAVORATORI
E LAVORATRICI DELLA SCUOLA PUBBLICA (campo
di RELAZIONE educativa, che basa il suo PROGETTO e la sua
AZIONE sulla RELAZIONE FONDANTE - il patto costituzionale
 sia la vita personale di tutti e di tutte sia la vita politica di
tutta la nostra società),
sia la vita personale di tutti e di tutte sia la vita politica di
tutta la nostra società), Per PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA (PERSONALE,
STORlCO-CULTURALE) E
Per PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA (PERSONALE,
STORlCO-CULTURALE) E
 L’ESERCIZIO DELLA SOVRANITA’ DEMOCRATICA
L’ESERCIZIO DELLA SOVRANITA’ DEMOCRATICA
 RISPETTO A SE STESSI E A SE
STESSE, RISPETTO AGLI ALTRI E ALLE ALTRE, E RISPETTO
ALLE ISTITUZIONI
RISPETTO A SE STESSI E A SE
STESSE, RISPETTO AGLI ALTRI E ALLE ALTRE, E RISPETTO
ALLE ISTITUZIONI
 ("Avere il coraggo di dire ai nostri giovani
che sono tutti sovrani": don Lorenzo Milani; "Per rispondere
ai requisiti sottesi alla libertà repubblicana una persona deve essere
un uomo o una donna indipendente e questo presuppone che essi
non abbiano un padrone o dominus, che li tenga sotto il suo potere,
in relazione ad alcun aspetto della loro vita. [...] La libertà richiede
una sorta di immunità da interferenze che diano la possibilità di
[...] tenere la propria testa alta, poter guardare gli altri dritto negli
occhi e rapportarsi con chiunque senza timore o deferenza": Philippe
Pettit)
("Avere il coraggo di dire ai nostri giovani
che sono tutti sovrani": don Lorenzo Milani; "Per rispondere
ai requisiti sottesi alla libertà repubblicana una persona deve essere
un uomo o una donna indipendente e questo presuppone che essi
non abbiano un padrone o dominus, che li tenga sotto il suo potere,
in relazione ad alcun aspetto della loro vita. [...] La libertà richiede
una sorta di immunità da interferenze che diano la possibilità di
[...] tenere la propria testa alta, poter guardare gli altri dritto negli
occhi e rapportarsi con chiunque senza timore o deferenza": Philippe
Pettit) e un LAVORO DI RETTIFICAZIONE E DI ORIENTAMENTO
CULTURALE, CIVILE, POLITICO e religioso (art.7 della Costituzione
e Concordato),
e un LAVORO DI RETTIFICAZIONE E DI ORIENTAMENTO
CULTURALE, CIVILE, POLITICO e religioso (art.7 della Costituzione
e Concordato),
 per evitare di ricadere nella tentazione
dell’accecante e pestifera IDEOLOGIA deII’INFALLIBILITA e
deII’ANTISEMITISMO (cfr. la beatificazione di PIO IX) e di un
ECUMENISMO furbo e prepotente, intollerante e fondamentalista
(cfr. il documento Dominus Jesus di Ratzinger, le dichiarazioni anti-
islamiche di Biffi, e il rinvio sine die dell’incontro fissato per il
3.10.2000 tra ebrei e cattolici) e di perdere la nostra lucidità e sovranita
politica,
per evitare di ricadere nella tentazione
dell’accecante e pestifera IDEOLOGIA deII’INFALLIBILITA e
deII’ANTISEMITISMO (cfr. la beatificazione di PIO IX) e di un
ECUMENISMO furbo e prepotente, intollerante e fondamentalista
(cfr. il documento Dominus Jesus di Ratzinger, le dichiarazioni anti-
islamiche di Biffi, e il rinvio sine die dell’incontro fissato per il
3.10.2000 tra ebrei e cattolici) e di perdere la nostra lucidità e sovranita
politica, e per INSTAURARE un vero RAPPORTO DIALOGICO e DEMOCRATICO,
tra ESSERI UMANI, POPOLI e CULTURE, non
solo d’Italia, ma dell’Europa e del Pianeta TERRA (e di tutto
I’universo, cfr. Giordano Bruno),
e per INSTAURARE un vero RAPPORTO DIALOGICO e DEMOCRATICO,
tra ESSERI UMANI, POPOLI e CULTURE, non
solo d’Italia, ma dell’Europa e del Pianeta TERRA (e di tutto
I’universo, cfr. Giordano Bruno), IO, cittadino italiano,figlío di Due IO, dell’UNiOne di due esseri
umani sovrani, un uomoj ’Giuseppe’, e una donna:’Maria’ (e, in
quanto tale, ’cristiano’ - ricordiamoci di Benedetto Croce; non cattolico
edipico-romano! - ricordiamoci, anche e soprattutto, di Sigmund
Freud),
IO, cittadino italiano,figlío di Due IO, dell’UNiOne di due esseri
umani sovrani, un uomoj ’Giuseppe’, e una donna:’Maria’ (e, in
quanto tale, ’cristiano’ - ricordiamoci di Benedetto Croce; non cattolico
edipico-romano! - ricordiamoci, anche e soprattutto, di Sigmund
Freud), ESPRIMO tutta la mia SOLIDARIETA a tutti i cittadini e a tutte
le cittadine della Comunità EBRAICA e a tutti i cittadini e a tutte lecittadine della comunità ISLAMICA della REPUBBLICA DEMOCRATICA
ITALIANA,
ESPRIMO tutta la mia SOLIDARIETA a tutti i cittadini e a tutte
le cittadine della Comunità EBRAICA e a tutti i cittadini e a tutte lecittadine della comunità ISLAMICA della REPUBBLICA DEMOCRATICA
ITALIANA, e
e PROPONGO
di riprendere e rilanciare (in molteplici forme e iniziative) la riflessione
e la discussione sul PATTO di ALLEANZA con il qúale tutti i
nostri padri (nonni...) e tutte le nostre madri (nonne...) hanno dato
vita a quell’UNO, che è il Testo della COSTITUZIONE, e il ’vecchio’
invito dell’Assemblea costituente (come don Lorenzo Milani
ci sollecitava nella sUa Lettera ai giudici, cfr. L’obbedienza non è più
una virtù) a "rendere consapevoli le nuove generazioni delle raggiunte
conquiste morali e sociali" e a riattivare la memoria
dell’origine dell’uno, che noi stessi e noi stesse siamo e che ci costituisce
PROPONGO
di riprendere e rilanciare (in molteplici forme e iniziative) la riflessione
e la discussione sul PATTO di ALLEANZA con il qúale tutti i
nostri padri (nonni...) e tutte le nostre madri (nonne...) hanno dato
vita a quell’UNO, che è il Testo della COSTITUZIONE, e il ’vecchio’
invito dell’Assemblea costituente (come don Lorenzo Milani
ci sollecitava nella sUa Lettera ai giudici, cfr. L’obbedienza non è più
una virtù) a "rendere consapevoli le nuove generazioni delle raggiunte
conquiste morali e sociali" e a riattivare la memoria
dell’origine dell’uno, che noi stessi e noi stesse siamo e che ci costituisce
 in quanto esseri umani e cittadini - sovraní, sla rispetto a
noi stessi e a noi stesse sia rispetto agli altri e alle altre, e sui piano
personale e sul piano politico,
in quanto esseri umani e cittadini - sovraní, sla rispetto a
noi stessi e a noi stesse sia rispetto agli altri e alle altre, e sui piano
personale e sul piano politico, e di RAFFORZARE E VALoRIZZARE, in TUTTA la sua fondamentale
e specifica portata, IL RUOLo e LA FUNZIONE deila
SCUOLA DELLA nostra REPUBBLICA DEMOCRATICA.
e di RAFFORZARE E VALoRIZZARE, in TUTTA la sua fondamentale
e specifica portata, IL RUOLo e LA FUNZIONE deila
SCUOLA DELLA nostra REPUBBLICA DEMOCRATICA.P.S.
NESSuNO E’ STRANIERO SULLA TERRA
 "A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno
consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Per lo più questa
convinzione giace in fondo agli animi come una infezione laiente,
si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine
di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il
dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo*,
"A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno
consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Per lo più questa
convinzione giace in fondo agli animi come una infezione laiente,
si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine
di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il
dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo*,
 allora, al termine della catena, sta il lager.
allora, al termine della catena, sta il lager.
 Esso è il prodotto di una
concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa
coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano"
Esso è il prodotto di una
concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa
coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano"*
 "Tutti gli stranieri sono nemici.
"Tutti gli stranieri sono nemici.
 I nemici devono essere soppressi.
I nemici devono essere soppressi.
 Tutti gli stranieri devono essere soppressi".
Tutti gli stranieri devono essere soppressi". Primo Levi, Se questo è un uomo, Prefazione, Torino, Einaudi,
1973, pp. I 3-14.
Primo Levi, Se questo è un uomo, Prefazione, Torino, Einaudi,
1973, pp. I 3-14. Andiamo alla radice dei problemi. Perfezioniamo la conoscenza
di noi stessi e di noi stesse. Riattiviamo la memoria dell’Unita,
apriamo e riequilibriamo il campo della nosha, personale e collettiva,
coscienza umana e politica.
Andiamo alla radice dei problemi. Perfezioniamo la conoscenza
di noi stessi e di noi stesse. Riattiviamo la memoria dell’Unita,
apriamo e riequilibriamo il campo della nosha, personale e collettiva,
coscienza umana e politica. Sigmund Freud aveva colto chiaramente la tragica confusione in
cui la Chiesa cattolico-romana si era cacciata (cfr. L’uomo Mosè e
la religione monoteistica): "scaturito da una religione del padre, il
cristianesimo divenne una religione del figlio. Non sfuggì alla fatalità
di doversi sbarazzare del padre" ... Giuseppe (gettato per la seconda
volta nel pozzo) e di dover teorizzare, per il figlio, il ’matrimonio’
con la madre e, nello stesso tempo,la sua trasformazione in
’donna’ e ’sposa’ del Padre e Spirito Santo, che ’generano’ il figlio!
Sigmund Freud aveva colto chiaramente la tragica confusione in
cui la Chiesa cattolico-romana si era cacciata (cfr. L’uomo Mosè e
la religione monoteistica): "scaturito da una religione del padre, il
cristianesimo divenne una religione del figlio. Non sfuggì alla fatalità
di doversi sbarazzare del padre" ... Giuseppe (gettato per la seconda
volta nel pozzo) e di dover teorizzare, per il figlio, il ’matrimonio’
con la madre e, nello stesso tempo,la sua trasformazione in
’donna’ e ’sposa’ del Padre e Spirito Santo, che ’generano’ il figlio!Karol Wojtyla, nonostante tutto il suo coraggio e tutta la sua sapienza, fa finta di niente e, nonostante il ’muro’ sia crollato e lo ’spettacolo’ sia finito, continua a fare l’attore e a interpretare il ruolo di Edipo, Re e Papa.
QUIS UT DEUS? Nessuno può occupare il posto dell’UNO. Non è meglio deporre le ’armi’ della cecità e della follia e, insieme e in pace, cercare di guarire le ferite nostre e della nostra Terra?
"GUARIAMO LA NOSTRA TERRA": è il motto della "Commissione per la verità e la riconciliazione" voluta da Nelson Mandela (nel 1995 e presieduta da Desmond Tutu). In segno di attiva solidarietà, raccogliamo il Suo invito...
 "La realtà è una passione. La cosa più cara" (Fulvio Papi). Cerchiamo
di liberare ii nostro cielo dalle vecchie idee. Benché diversi,
i suoi problemi sono anche i nostri, e i nostri sono anche i suoi...
"La realtà è una passione. La cosa più cara" (Fulvio Papi). Cerchiamo
di liberare ii nostro cielo dalle vecchie idee. Benché diversi,
i suoi problemi sono anche i nostri, e i nostri sono anche i suoi...
 E le ombre, se si allungano su tutta la Terra, nascondono la luce e portano il buio, da lui come da noi... "nell’attuale momento focale
della storia - come scriveva e sottolineava con forza Enzo Paci già
nel 1954 (cfr. E. Paci, Tempo e relazione, Milano, Il Saggiatore,
1965 - Il ed., p. 184) - la massima permanenza possibile della libertà
democratica coincide con la massina metamorfosí verso un
più giusto equilibrio sociale, non solo per un popolo ma per tutti i
popoli del mondo".
E le ombre, se si allungano su tutta la Terra, nascondono la luce e portano il buio, da lui come da noi... "nell’attuale momento focale
della storia - come scriveva e sottolineava con forza Enzo Paci già
nel 1954 (cfr. E. Paci, Tempo e relazione, Milano, Il Saggiatore,
1965 - Il ed., p. 184) - la massima permanenza possibile della libertà
democratica coincide con la massina metamorfosí verso un
più giusto equilibrio sociale, non solo per un popolo ma per tutti i
popoli del mondo".* Cfr. Federico La Sala, L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide. Considerazioni attuali sulla fine della preistoria ..., Edizioni Ripostes, Roma-Salerno, Febbraio 2001, pp. 49-53.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---ITALIANI, DI COSTITUZIONE. E’ il titolo che l’Anpi ha dato alla sua seconda festa nazionale che apre oggi ad Ancona per chiudersi domenica 27. Lavoro, pace, democrazia: di questo si parlerà (di Alessandra Longo)..24 giugno 2010, di Federico La Sala
Italiani, di costituzione
di Alessandra Longo (la Repubblica, 24.06.2010)
Italiani, di Costituzione. E’ il titolo che l’Anpi ha dato alla sua seconda festa nazionale che apre oggi ad Ancona per chiudersi domenica 27. Lavoro, pace, democrazia: di questo si parlerà. I partigiani, dopo anni di solitudine, anche amara, si ritrovano dentro la corrente dei tanti che ci tengono ancora alla Costituzione, oggi sottoposta a continui attacchi. Non un raduno di ex. «E’ una sfida al presente», dice l’attore Marco Paolini. Da Ancona, l’appello è per un «no forte, responsabile, massiccio, a chi intende cancellare la democrazia dal Paese». Un nuovo sito, il blog, forum, spettacoli, il tentativo di rinnovarsi per lasciare il testimone ai giovani: è la missione dell’Anpi 2010, fedele alla lezione della decima brigata Rocco: «Abbiamo imparato a non essere mai indifferenti».
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. ---- CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. .... E DI SPIEGARE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AL CITTADINO SILVIO BERLUSCONI LE RAGIONI DELL’ "ODIO POLITICO" CHE "LO FA SOFFRIRE".14 dicembre 2009, di Federico La Sala
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI - di Piero Calamandrei. ----parte dell’introduzione di Gustavo Zagrebelsky a un testo inedito di una conferenza che Piero Calamandrei pronunciò nel gennaio del 1940.17 settembre 2008, di Federico La Sala
Anticipazioni / La prefazione di Zagrebelsky a una conferenza inedita del grande giurista
Piero Calamandrei. Se la legge è uguale per tutti
di Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 17.09.2008)
Anticipiamo parte dell’introduzione di Gustavo Zagrebelsky a un testo inedito di una conferenza che Piero Calamandrei pronunciò nel gennaio del 1940 e che ora viene raccolto in un volume intitolato Fede nel diritto (a cura di Silvia Calamandrei, Laterza, pagg. 148, euro 12)
La conferenza (di Calamandrei, n.d.r.) è un’apologia della legalità. La legalità non è solo un elemento della forma mentis del giurista, o di quel tipo di giurista (legalitario, appunto) nel quale Calamandrei si riconosceva. È per lui un elemento morale, che corrisponde esso stesso a un’idea di giustizia: nella legge e nel suo rigoroso rispetto sta la giustizia dei giuristi, giudici, avvocati, studiosi del diritto. E non perché egli creda in un legislatore-giusto, che è tale perché e in quanto da lui promanino leggi giuste, come possono ritenere i giusnaturalisti di ogni specie; e nemmeno perché creda in un giusto-legislatore, dal quale, per qualche qualità sua propria, provengano leggi giuste per definizione, come ritengono i gius-positivisti ideologici; ma perché crede che la legge in se stessa, in quanto cosa diversa dall’ordine particolare o dalla decisione caso per caso, contenga un elemento morale di importanza tale da sopravanzare addirittura l’ingiustizia eventuale del suo contenuto.
Questo elemento morale risiede nella forma-legge in quanto tale, cioè nella forma generale e astratta in forza della quale si esprime, poiché questa è la "forma logica" della solidarietà e della reciprocità tra gli esseri umani, su cui soltanto società e civiltà possono edificarsi. I toni attraverso i quali è tratteggiata questa concezione della legge, tipicamente razionalista, sono particolarmente appassionati: la legge generale e astratta «significa che il diritto non è fatto per me o per te, ma per tutti gli uomini che vengano domani a trovarsi nella stessa condizione in cui io mi trovo. Questa è la grande virtù civilizzatrice e educatrice del diritto, del diritto anche se inteso come pura forma, indipendentemente dalla bontà del suo contenuto: che esso non può essere pensato se non in forma di correlazione reciproca; che esso non può essere affermato in me senza esser affermato contemporaneamente in tutti i miei simili; che esso non può essere offeso nel mio simile senza offendere me, senza offendere tutti coloro che potranno essere domani i soggetti dello stesso diritto, le vittime della stessa offesa. Nel principio della legalità c’è il riconoscimento della uguale dignità morale di tutti gli uomini, nell’osservanza individuale della legge c’è la garanzia della pace e della libertà di ognuno. Attraverso l’astrattezza della legge, della legge fatta non per un solo caso ma per tutti i casi simili, è dato a tutti noi sentire nella sorte altrui la nostra stessa sorte». «Indipendentemente dalla bontà del suo contenuto», «anche quando il contenuto della legge gli fa orrore».
Queste proposizioni non possono non colpire profondamente, sia per l’immagine ch’esse rendono del giurista e della giurisprudenza, sia per il carattere assolutorio del servizio che i giuristi prestino all’arbitrio che si manifesta in legge: il servizio allo "Stato di delitto" (per usare la formula di Gustav Radbruch) che si fa schermo delle forme dello Stato di diritto. Il giurista come puro esecutore della forza messa in forma di legge? Non è questa una concezione servile del "giurista, giudice o sapiens", che riduce il coetus doctorum a "una sorta di congregazione di evirati"?, ha domandato polemicamente. Tutto questo sembra scandaloso ? si può aggiungere ?, soprattutto in un’epoca nella quale la legge aveva dimostrato tutta intera la sua disponibilità a qualunque avventura, nelle mani di despoti e perfino di criminali comuni, impadronitisi del potere. In Italia, non si trattava solo delle leggi che avevano istituzionalizzato l’arbitrio poliziesco e la vocazione autoritaria del fascismo (per esempio, il codice penale del ’31, o il Testo Unico delle leggi di p.s. del ?34). Si trattava, niente di meno, delle leggi razziali del ?38, sulle quali non una parola è spesa nella conferenza: leggi che paiono dunque essere tacitamente comprese, nella sua argomentazione, tra quelle cui si deve "culto a ogni costo" e ossequio, sia pure, eventualmente "sconsolato", un ossequio dovuto, da parte dei giuristi consapevoli del compito che è loro proprio, come atto di "freddo e meditato eroismo". Queste espressioni, che sono state intese come manifestazione di piaggeria verso il regime, non si leggono oggi senza scandalo.
Ma è proprio così? Il silenzio tenuto in proposito si può spiegare certo col clima d’intimidazione poliziesca del tempo. Ma non è questo il punto che qui interessa. Interessa piuttosto sottolineare che nella nozione "formale" di legge, cui Calamandrei si riferiva, non potevano rientrare leggi come quelle razziali, leggi discriminatici per antonomasia, con riguardo alle quali non si sarebbe certo potuto parlare di reciprocità, capacità di valere oggi per uno e domani per l’altro, solidarietà in una sorte comune, virtù educatrice e civilizzatrice: caratteristiche proprie della legge generale e astratta cui Calamandrei si riferiva, che sono invece puntualmente contraddette da atti in forma di legge aventi lo scopo di spaccare la comunità di diritto, espellendone una parte. Chi potrebbe parlare, per quelle leggi, di reciprocità, valenza generale, solidarietà, eccetera?
L’elogio della legalità non era dunque riferito alla pura e semplice forma del potere che si fosse espresso nel rispetto delle vigenti procedure per la produzione di atti d’imperio, chiamati leggi. Era rivolta a quella legalità che esige una determinata struttura della prescrizione: la generalità e l’astrattezza, alle quali soltanto si possono riferire virtù come la reciprocità, la solidarietà, ecc., del tutto estranee alle misure che creano discriminazioni. Queste ultime, dunque, a ben leggere, non sono da comprendere nell’elogio alla legalità, anche se assumono l’aspetto esteriore della legge. (...) «La scienza giuridica deve mirare soltanto a "sapere qual è il diritto", non a crearlo; solo in quanto il giurista abbia coscienza di questo suo limite e non tenti di sovrapporsi al dato positivo che trova dinanzi a sé, l’opera sua è benefica per il diritto. Io mi immagino il giurista come un osservatore umile e attento».
La certezza del diritto è il valore che primariamente è in gioco, un valore strettamente intrecciato alla sicurezza del singolo, affinché possa «vivere in laboriosa pace la certezza dei suoi doveri, e con essa la sicurezza che intorno al suo focolare e intorno alla sua coscienza la legge ha innalzato un sicuro recinto dentro il quale è intangibile, nei limiti della legge, la sua libertà». Anche a questo proposito, sarebbe facile osservare che queste parole possono sembrare addirittura beffarde, se riferite a leggi che legittimano l’arbitrio. Delle leggi dei regimi autoritari o, peggio ancora, totalitari, tutto si può dire, ma non che esse valgano a protezione della sicurezza delle persone. Ma la preoccupazione di Calamandrei, risultante con evidenza dalla conferenza e da numerosi passi di altri scritti coevi, era la difesa, se non contro l’autoritarismo o il totalitarismo, almeno contro l’arbitrarietà del potere.
Era un’ultima e minima linea difensiva, contro quello che in altri tempi si sarebbe detto il dispotismo, cioè il potere capriccioso, imprevedibile, casuale. Così, si spiega l’attaccamento alla legge e, per converso, la polemica contro quello che viene definito il "diritto libero", considerato il regno dell’arbitrio. (?)
Il "diritto libero" cui Calamandrei si riferisce è un movimento che "libera" la giurisprudenza dall’osservanza stretta della legge, ma allo scopo di sottoporla a una devastante soggezione, la soggezione alle minaccianti pressioni ideologiche e politiche dell’epoca. Gli esempi ch’egli porta, tratti dall’esperienza sovietica e nazista, non sono quelli che ci si aspetterebbe siano forniti da regimi politici e sociali in disfacimento, ma sono quelli di regimi che si sono affermati con durezza e integrità totalitaria. Se non ci si rendesse conto di questo punto, il "chiodo fisso" di Calamandrei ? l’incubo del diritto libero - resterebbe incomprensibile. Forse ci si avvicina al vero, osservando che il "diritto libero" che veniva offrendosi all’attenzione degli studiosi negli anni di Calamandrei era tutt’altro che "libero": era un diritto fortemente ideologizzato, era un diritto che si alimentava direttamente nella "legalità socialista" o nel Volksgeist nazista e nei loro "valori". L’attuazione di tali valori, una volta posta come compito dei giudici, avrebbe travolto ogni limite e legittimato ogni azione, perché di fronte ai valori "che devono valere" in maniera assoluta come fini, ogni mezzo è autorizzato. (?)
Ritorniamo, per un momento, alla "politica razziale", lo scoglio che la conferenza, nell’elogio della legalità, evita accuratamente. Certo, abbiamo difficoltà a vedere differenze di abiezione tra la persecuzione e lo sterminio pianificati per legge, da un lato, o, dall’altro, lasciati all’attivismo dei pogrom, delle azioni "spontanee" della "notte dei cristalli", delle direttive di partito e dei suoi funzionari, assunte fuori di ogni procedura legale in un raduno di gerarchi (la "conferenza di Wannsee", ad esempio), diramate illegalmente e in segreto (come avvenne in Germania e poi, dopo l’8 settembre, da noi, nella Repubblica sociale) ed eseguite con zelo creativo anche se, talora, con improvvisazioni controproducenti. Anzi, sotto certi aspetti, la procedura "legale" ci appare ancor più ributtante perché apparentemente "oggettiva", apparentemente "non coinvolgente" le responsabilità personali, apparentemente più "pulita". Sotto altri aspetti, però, pubblicizzando e burocratizzando le procedure, almeno si evitava di mettere direttamente in movimento il fanatismo ideologico e l’odio razziale che lo Stato etico diffonde nella società, facendo di ogni suo membro un organo o una vittima. Lo Stato, per quanto criminale, evitava almeno di trasformarsi in orda. La difesa della legalità aveva questo estremo significato. Calamandrei, per la sua concezione della legalità, probabilmente non avrebbe rifiutato la famosa immagine di Eraclito delle leggi come le "mura della città".
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI - di Piero Calamandrei. La Costituzione italiana: SALVIAMOLA! - selezione a cura del prof. Federico La Sala1 maggio 2007, di Federico La Sala
I fratelli Rosselli, genesi di un delitto impunito A settant’anni dall’uccisione di Carlo e Nello Rosselli, Mimmo Franzinelli rievoca, in un saggio appena uscito per Mondadori, l’attività antifascista dei due fratelli e i processi che portarono alla scandalosa assoluzione di esecutori e mandanti
di SILVIA CALAMANDREI (il manifesto, 29.04.2007)
Carlo Rosselli fece in tempo il 22 maggio a commemorare dall’esilio di Parigi la morte in carcere di Antonio Gramsci, prima di essere assassinato insieme al fratello Nello il 9 giugno del 1937 a Bagnoles-de-l’Orne. C’è un presagio nelle sue parole: «L’ideale, lo si serve e non ce ne si serve. E, se necessario, si muore, con la semplicità di un Gramsci, piuttosto che continuare a vivere perdendo la ragione di vita».
A settant’anni di distanza, Mimmo Franzinelli, con Il delitto Rosselli, (Mondadori 2007, pp. 291, euro 18,50) ricostruisce la genesi di questo assassinio nel contesto italiano e francese e i processi che seguirono, lasciando impuniti i mandanti italiani e la maggior parte degli esecutori della Cagoule, un gruppo paramilitare della destra filofascista francese. La sinergia tra le mire di colpo di stato in Francia e la volontà di Mussolini di eliminare avversari politici sempre più attivi nella propaganda contro il regime (soprattutto dopo la sconfitta dei legionari fascisti a Guadalajara ad opera delle Brigate internazionali) verrà oscurata nei meandri giudiziari del dopoguerra, fino alla clamorosa sentenza di assoluzione dei mandanti da parte della Corte d’appello di Perugia nell’ottobre 1949, stigmatizzata da Gaetano Salvemini e Piero Calamandrei.
Particolarmente interessante nella ricerca di Franzinelli la ricostruzione del Preludio ad un delitto, con la descrizione dell’«attivismo irrefrenabile» di Carlo Rosselli nel suo esilio, dopo che approdò a Parigi nel 1929 in seguito alla clamorosa evasione dal confino di Lipari. Insieme al liberale Tarchiani e al federalista Lussu, Rosselli fondò il movimento «Giustizia e libertà» e sul settimanale di GL condusse una incessante propaganda antifascista che acquistò maggiore incidenza con la guerra d’Africa, quando fu elaborato un progetto di propaganda tra i soldati e di denuncia delle bombe all’iprite, e soprattutto con la guerra di Spagna.
Risale all’agosto del 1936 l’organizzazione dell’intervento armato in Spagna da parte di Carlo Rosselli, che individuò nella guerra civile «la guerra di tutto l’antifascismo » (mentre i comunisti ancora esitavano a internazionalizzare il conflitto) e capeggiò con l’anarchico Berneri e il repubblicano Angeloni la Prima colonna italiana delle Brigate internazionali in Catalogna. Fu sua la parola d’ordine Oggi in Spagna, domani in Italia, lanciata da Radio Barcellona. Ferito in combattimento e con una flebite alla gamba, rientrò a Parigi per curarsi, adoperandosi tuttavia per riunire tutti gli antifascisti in un’unica colonna e organizzare la controinformazione sulla sconfitta dei fascisti italiani comandati da Roatta a Guadalajara.
Grande impatto propagandistico ebbe in particolare l’analisi delle missive ai familiari dei legionari italiani, che Carlo commentò su «Giustizia e libertà» in marzo, suscitando le preoccupazioni di Mussolini e Ciano: l’auspicio di una Guadalajara in terra italiana, accanto alle fotografie dei prigionieri, accelerò i contatti tra il controspionaggio militare italiano e gli esponenti della Cagoule, la formazione paramilitare filofascista francese, con l’obiettivo di eliminare Rosselli.
La constatazione di Rosselli sulla fine della «accademia dell’esilio » («l’emigrazione italiana - scrisse - torna ad essere fatto vivo e presente nella storia italiana») intensificò l’attività delle spie e dei poliziotti che gli erano alle costole: i carteggi documentano i preparativi dell’assassinio, che fu auspicato dal ministro degli esteri Ciano, coordinato dal suo segretario particolare Anfuso e messo in opera dal Servizio informazioni militari capeggiato prima dal generale Roatta e poi da Angioi, mentre i contatti con il gruppo operativo francese erano tenuti da Emanuele e Navale. A parte Ciano, fucilato a Salò, tutti costoro sarebbero riusciti a farla franca nel dopoguerra, profittando delle revisioni successive delle sentenze e delle amnistie, nonostante momenti di ammissione delle responsabilità nel delitto.
I due ultimi capitoli del saggio di Franzinelli, Francia: un processo tardivo e Italia: crimine senza mandanti proseguono l’accurata analisi già svolta in L’amnistia di Togliatti sulla memoria corta del dopoguerra e la mancata punizione dei crimini fascisti. Da segnalare come nell’estate 1944, mentre l’Alto commissariato per la punizione dei delitti fascisti stava indagando sui delitti commessi all’estero, l’ex ufficiale dei servizi Santo Emanuele riuscì addirittura a riciclarsi nell’ufficio del Commissariato all’epurazione diretto da Scoccimarro. Da parte sua, il maggiore Navale, assunto da Valletta tra i sorveglianti Fiat, ne ricevette encomi per contributi alla lotta antinazista, guadagnandosi così uno sconto di pena al momento della condanna per l’omicidio premeditato dei Rosselli, inflitta dalla Corte d’assise di Roma nel giugno 1947 (pena già ridotta rispetto alla condanna del primo processo del 1945, di fronte all’Alta Corte di giustizia, in cui la famiglia Rosselli era rappresentata dagli avvocati Calamandrei, Battaglia e Comandini). La sentenza dell’Alta Corte (fucilazione per Anfuso, ergastolo per Emanuele, Navale e Roatta) si andrà stemperando nei passaggi successivi e grazie all’amnistia del 1946, fino all’inaudita sentenza di Perugia in cui gli imputati vengono assolti per il dubbio, sia pur «tenue », che il delitto fosse frutto di «un’attività parallela» maturata «nel torbido mondo del fuoriuscitismo internazionale», «all’insaputa » degli imputati, che si sarebbero dunque arrogati «il merito» dell’uccisione per vanteria e desiderio di carriera.
Nel commentare la motivazione della sentenza sul «Ponte» (Giustizia suicida, febbraio 1950), Piero Calamandrei si chiedeva se l’estensore non avesse a bella posta redatto una motivazione abnorme per favorirne l’impugnazione. Invocando la sua fede nella magistratura, interpretò la motivazione come «una estrema forma di protesta, una specie di Sos lanciato da un magistrato di coscienza, che grida: "Attenzione, attenzione! In Italia la giustizia politica funziona così! Attenzione! Anche quando i delitti dei fascisti sono pienamente provati, i giudici coscienziosi sono costretti, contro la loro coscienza, ad assolverli"...».
Se di Sos si trattava, non fu comunque raccolto in quell’Italia del 1950 in cui si sparava sugli operai: nello stesso numero del «Ponte» Calamandrei intitolava il suo editoriale Pena di morte preventiva, a commento dell’eccidio di Modena.
Un ricordo sul «Ponte»
Quelle passeggiate domenicali con Nello
Nel primo numero del «Ponte» dell’aprile 1945 fu pubblicato un ritratto di Carlo e Nello Rosselli di Pietro Annigoni insieme a un «Ricordo di Nello» firmato da Piero Calamandrei. Nei ponti lanciati per ricostruire la nuova Italia democratica i Rosselli sono un punto di riferimento essenziale ed è Nello, rimasto in Italia mentre Carlo si era rifugiato all’estero, che Calamandrei ricorda nelle passeggiate domenicali compiute insieme ad altri amici antifascisti negli anni Trenta. È Nello che vuole fare emergere accanto alla figura eroica di Carlo, anche nell’arringa al processo di fronte all’Alta Corte: quel Nello cui «era toccato il compito più oscuro ma altrettanto virile di combattere il fascismo vivendoci in mezzo, di esperimentare il clima della servitù, di sopportare senza scoraggiarsi i contatti disgustosi... pur di non abbandonare la patria dolorante e di rimanere giorno per giorno a contatto col suo popolo oppresso».
Carlo e Nello assassinati durante una gita a Alençon, da cui spediscono una cartolina di auguri al piccolo Giovanni firmata «Zio Nello e Babbo», rimandano nella memoria di Piero a quelle passeggiate domenicali, «in cerca della libertà perduta». «Ogni domenica una meta nuova: uno qualunque di quei vecchi paesi della campagna toscana, ognuno dei quali ha una sua fisionomia inconfondibile come un volto vivo. Tutti, senza dircelo, portavamo con noi in quelle gite la segreta malinconia di chi, andando a far visita ad una persona cara, pensa che forse è quella l’ultima volta che la vedrà e non riesce a scacciare il funesto presentimento. "La guerra viene, la guerra verrà..." ammoniva Carlo da lontano. C’era già su quelle colline ridenti un presagio di distruzione. Ma Nello era con noi in quelle gite: e bastava la sua presenza, di lui così biondo e ridente, a diffondere su tutti noi più vecchi di lui un alone luminoso di serenità e fiducia».
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI - di Piero Calamandrei. La Costituzione italiana: SALVIAMOLA! - selezione a cura del prof. Federico La Sala25 aprile 2007, di Federico La Sala
L’Italia incompatibile
di Furio Colombo *
Giorni come il 25 aprile tracciano linee di confine, demarcazioni nette fra un prima e un dopo, fra un destino e un altro destino, un’Italia e un’altra Italia. Non resta che sperare che niente di questa data diventi cerimonia e abitudine e che ci sia sempre chi la spiega nelle scuole ai più giovani con pazienza e chiarezza.
Non c’è niente in questa frase che condanni irreversibilmente qualcuno, vita, scelte, idee, sentimenti, o che stabilisca (troppo tardi, comunque) una lista di reietti. Niente che non rispetti i morti. Quanto ai vivi, gli esseri umani cambiano in meglio o in peggio e si trasformano tutto il tempo come la natura, il paesaggio, la storia. Dipende dal momento in cui si scatta la fotografia il rapporto col tempo, passato e futuro.
Ma date come il 25 aprile non spostano di un millimetro il senso di ciò che è avvenuto e che ha salvato tutti, persecutori e perseguitati, anzi ha salvato - con il suo impetuoso sbocco nella libertà - sopratutto i persecutori che sarebbero stati costretti a continuare nella loro triste missione, ondata di morti dopo ondata di morti.
Per questo chiunque, la sera del 22 aprile, si sia incontrato con il programma «RT, Rotocalco televisivo, Speciale Resistenza e resistenze», di Enzo Biagi, su Raitre, ha un debito in più verso il vecchio maestro che non rinuncia. E dopo cinque anni di esilio riprende con gli italiani, tra montagne di spazzatura e di vergogna, il discorso di libertà esattamente dal punto in cui lo avevano forzato a interrompere.
Come ricorderete Enzo Biagi è il primo, nella lista di alcuni protagonisti della televisione italiana (tra cui Michele Santoro, Daniele Luttazzi) licenziati personalmente con un potere che non aveva - ma che alla Rai, tramite personale subalterno, è diventato immediatamente esecutivo - dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Molti di noi hanno frequentemente citato con scandalo la motivazione di quel licenziamento: «attività criminosa». Con queste parole Silvio Berlusconi che - ci viene detto - non è nemico ma solo avversario, intendeva descrivere ogni attività di opposizione. E a molti di noi è sembrato naturale definire “regime” la situazione politica in cui un governante vuole e può mettere a tacere chi non lo esalta.
Ora, cambiato il tempo, il governo - e, un pochino anche il Paese e la Rai - Enzo Biagi ritorna. E con la sua trasmissione dedicata alla Resistenza, nel senso originale del 25 Aprile e nel senso perenne del non piegarsi solo perché qualcuno è più ricco e potente e ti può anche mettere al bando, racconta con la sua implacabile pacatezza che esiste una Italia incompatibile con l’Italia libera e democratica evocata da quel giorno e descritta nei dettagli dalla Costituzione. E che non è questione di sentimenti (inimicizia o gentile confronto) ma di nessun punto di corrispondenza fra un’Italia e l’altra. Dice che non bastano né le lacune della memoria né la potenza dei media (tuttora in prevalenza orientati a non offendere un grande editore che può comprare tutto, e può comprare molti) a oscurare l’incompatibilità di un’Italia con l’altra.
Credo che possa essere utile confrontare il sommario della trasmissione con cui Biagi torna in Tv con l’articolo di fondo de Il Giornale (autore Massimo Teodori) dello stesso giorno. Quell’articolo celebra la buona accoglienza riservata a Berlusconi nei due congressi fondanti del nascente PD, ma poi elenca le tappe, che per l’autore sono esecrabili, della “delegittimazione di Berlusconi”. L’Italia di Biagi si apre con Roberto Saviano e la piovra della camorra con cui non si può convivere, si chiude con Tina Anselmi, mai dimenticata investigatrice della P2, passa attraverso la Resistenza come guerra partigiana e lotta al fascismo.
Ci fa riascoltare la voce limpida di Primo Levi che descrive con la famosa chiarezza come si distrugge un essere umano. Ascolta Vittorio Foa da giovane: si poteva non resistere?
E colloca al centro il magistrato Gherardo Colombo, verso cui molti italiani si considerano debitori (come verso tutto il Pool di Mani pulite) per la coraggiosa, tenace, difficilissima difesa della reputazione dell’Italia, mentre stava per essere ricoperta da un blob di corruzione tra i più vasti e più estesi al mondo.
Dunque, lo stesso giorno in cui è andata in onda la trasmissione-manifesto di Enzo Biagi, Massimo Teodori ha scritto: «La storia (della delegittimazione e demonizzazione del “nemico” politico, Ndr) cominciò dal colle più alto con Oscar Luigi Scalfaro che distorse i poteri presidenziali contro il premier». Come è noto «li distorse» per impedire che il plurinquisito Previti, ora condannato in via definitiva, diventasse ministro della Giustizia, evitando dunque un grave insulto alla Repubblica e all’immagine dell’Italia nel mondo. L’articolo di Teodori continua: «La storia proseguì con l’accanimento giudiziario in sintonia con l’ala giustizialista dei post-comunisti». Si capisce l’intento.
“Accanimento giudiziario” deve diventare il titolo di un capitolo della storia italiana, quello dei processi a Silvio Berlusconi. L’autore evidentemente conta sul fatto che a poco a poco smetteremo di insistere nel raccontare ciò che è avvenuto davvero e finiremo per dire che, sì, quelle gravissime imputazioni non erano che vaneggiamenti di giudici comunisti. L’affermazione viene dalla casa che non ha esitato a dire e a ripetere che «bisogna essere mentalmente tarati per fare i giudici».
Ma l’autore del fondo de Il Giornale implacabile continua:
«Infine i girotondi espressero, ai limiti del grottesco, quell’animus giacobino tanto gradito ai piani alti della politica illiberale e della gauche caviar, la cui nobile aspirazione era vedere in manette il parvenu della politica».
Poiché i girotondi sono mobilitazione spontanea, diventa interessante l’evocazione dei «piani alti della politica illiberale» che vuol dire: è illiberale chi invoca «la legge uguale per tutti» e denuncia le leggi ad personam che la rendono «legge di uno solo». La frase è affetta da palese assurdità fattuale, logica e storica. Ma Teodori ha un punto di forza su cui poggiare la sua costruzione orwelliana del “ministero della verità”. Dice infatti in conclusione: «Se il Partito Democratico servirà a tenere a freno le pulsioni antidemocratiche tanto radicate nei politici di sinistra (ovvero l’ostinazione a ripetere : “la legge è uguale per tutti”, Ndr) sarà un passo avanti per l’Italia civile e liberale». Sembra chiaro che qui si sta accennando all’Italia di Previti, Dell’Utri, Cuffaro, dei beneficiari di condono continuo, degli evasori lodati perché «a un certo punto diventa legittimo frodare il fisco», degli scrupolosi autori dei falsi in bilancio, di personaggi come il sindaco An di Trieste che ha sempre rifiutato di recarsi alla risiera di San Sabba dove fascisti e nazisti massacravano gli ebrei.
Del resto il capo di tutta questa gente mai si è fatto trovare - lui che è dappertutto - ad una celebrazione del 25 aprile durante i cinque anni del suo celebrato governo costellato di canzoni e di allegre passeggiate a Villa Certosa. L’Italia di Tina Anselmi, di Oscar Luigi Scalfaro, di Gherardo Colombo, dei girotondi ne ha fatto a meno.
Come si vede la questione - che è giusto ripetere nel giorno della Resistenza incoraggiati dal libero ritorno in video di Enzo Biagi - non è di buona educazione (anche se è bene mostrare buona educazione quando Silvio Berlusconi si presenta al congresso di un partito che ha appena finito di considerare autore di «delitti, morte e miseria»). È una questione di incompatibilità. L’Italia della Liberazione e della Costituzione è incompatibile con l’Italia della illegalità che ha cercato, senza successo, di cancellare il 25 aprile e metà della Costituzione italiana nata dal 25 aprile. La scelta fra queste due Italie è una decisione drammatica che tocca agli elettori. A noi spetta il compito di rendere chiara l’alternativa.
* l’Unità, Pubblicato il: 25.04.07, Modificato il: 25.04.07 alle ore 8.40
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI - di Piero Calamandrei. La Costituzione italiana: SALVIAMOLA! - selezione a cura del prof. Federico La Sala26 aprile 2007, di Federico La Sala
Perché è viva la Resistenza
di Enzo Collotti (il manifesto, 25.04.2007)
Che cosa resta del 25 aprile? Domandarselo è più che legittimo, nel frastuono e nella confusione della vita politica italiana in cui la fretta dei politici di cambiare pelle concede poco spazio alla riflessione sulle modalità dei cambiamenti e sul loro rapporto con le costanti della nostra storia che sono le linee guida dalle quali non si può derogare senza smentire le origini stesse della Repubblica.
E’ chiaro che a oltre sessant’anni da quel 25 aprile del 1945 non è riproducibile l’intensità con la quale la mia generazione ha vissuto il giorno della liberazione, dopo la lunga attesa dei giorni dell’occupazione nazista e dell’oppressione della Repubblica sociale nutrita non solo dalla Resistenza ma anche dalle aspettative per il futuro. Il ricambio delle generazioni comporta anche una diversa sensibilità nello sguardo con il quale si percepiscono i fatti storici costitutivi del nostro patto civile di collettività e non possiamo impedire che le nuove generazioni rivivessero con la distanza di oltre mezzo secolo, e quindi con un distacco non solo temporale, i momenti fondativi della Repubblica democratica.
E’ altrettanto inevitabile che oggi, salvo rarissime eccezioni, il personale politico proveniente per esperienza diretta dalla Resistenza sia di fatto scomparso dalla scena pubblica, mentre anche la maggior parte degli indicatori ci significano (a cominciare dalla scuola), che la stessa memoria familiare appartiene ormai a un passato irrevocabilmente superato. Mai come in un frangente di questa natura si deve avere coscienza che la sopravvivenza di quelli che chiamiamo i valori della Resistenza è affidata alla persistenza e alla continuità della memoria, che non è un prodotto spontaneo della somma delle memorie individuali ma un processo collettivo, sollecitato da una pluralità di soggetti, istituzionali e non.
Nel primo cinquantennio repubblicano i partiti politici - nati dall’esperienza dei comitati di liberazione - furono tra i soggetti collettivi naturali strumenti di trasmissione di quella tradizione, insieme a una pluralità di enti della vita associativa che concorrevano a compenetrare la società di quei valori e ideali. La lacerazione di quel tessuto politico e associativo, in questa infinita transizione italiana, ha disperso un patrimonio politico-culturale che fa fatica a ricostituirsi e identificare le sedi stesse del suo insediamento sociale. I partiti politici anche nelle nuove configurazioni, la scuola, l’associazionismo rimangono le sedi privilegiate per custodire e alimentare questa memoria, in una prospettiva ormai di lunga durata ma anche come risvolto di una prassi operativa, nella misura in cui sono valori della Resistenza i vincoli pratici e le regole che devono governare la nostra convivenza e ispirano la nostra direzione di marcia. Soltanto se continuiamo a essere consapevoli di quanto è stata aspra la lotta per sottrarci alla dittatura fascista e nazista, per restituirci le libertà democratiche e consentirci l’elaborazione della Costituzione, restituiremo alla Resistenza il significato di un evento storicamente motivato nel suo naturale contesto temporale e epocale e ridaremo ai valori della Resistenza con la loro materiale evidenza il senso della loro attualità e della loro permanente necessità.
Il 25 aprile rimane un fatto fortemente simbolico, uno di quei punti fermi dei quali ogni collettività ha bisogno come punto di riferimento, ma non è principalmente sui miti e sui riti che si deve alimentare la memoria della Resistenza. Essa sarà viva se gli indirizzi politici saranno improntati a quei valori essenziali per i quali in Italia e in Europa migliaia di uomini e donne hanno sacrificato la loro esistenza per rivendicare la propria autonoma responsabilità e il diritto di partecipazione, il rispetto della dignità dell’uomo, l’aspirazione alla giustizia sociale e all’eguaglianza, l’utopia di una Europa pacifica e pacifista. Una tavola di valori che si trova scritta nelle Lettere dei condannati a morte della Resistenza, italiana e europea, il libro che vorremmo fosse letto dalle generazioni più giovani.
-
> COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI ED ITALIANE. LA LEZIONE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI - di Piero Calamandrei. --- per quanto profonde e salde siano le radici della Costituzione repubblicana, "non sembra corrispondere ad esse - osservò Scoppola - un diffuso patriottismo repubblicano e costituzionale come coscienza di cittadinanza". E’ davvero stringente la sintonia tra queste parole e l’allarme pronunciato da Giorgio Napolitano, in occasione del 2 giugno, sui rischi di una deriva opportunistica, fino all’egoismo più palese, da cui il Paese sembra essere attraversato (di Sergio Zavoli).8 giugno 2008, di Federico La Sala
Contro la diseducazione civile
di Sergio Zavoli *
Celebrare la ricorrenza della nascita della Repubblica ha significato rinnovare, non simbolicamente, il ricordo di un evento cui Piero Calamandrei conferì, nell’ambito della nostra storia, il «primato della straordinarietà». Non solo per ciò che recise e inaugurò nella vita del Paese, ma anche per il modo in cui si ebbe il grande salto storico da cui nacque una Repubblica sorta dal libero voto dei cittadini, deciso, predisposto e svoltosi con un re ancora sul trono. Dopo la catastrofe del conflitto mondiale e della guerra civile risorgeva la Nazione e si compiva l’ideale del risorgimento democratico d’ispirazione mazziniana.
Fu Nenni - repubblicano, nella sua giovinezza - a proporre che la scelta tra monarchia e repubblica fosse contemporanea all’elezione dell’Assemblea costituente; ebbe in ciò l’appoggio di Togliatti e la proposta prevalse su quella di De Gasperi, il quale avrebbe prima voluto il voto per la Costituente e poi il referendum - che pure aveva indicato e sostenuto - per non accentuare il dissidio interno alla DC sul grande plebiscito istituzionale, che vedrà una campagna serrata, martellante, emotiva, venata di acrimonia e radicalismo.
In tutte le regioni del Sud la repubblica venne sconfitta, ma i voti di minoranza contribuirono a formare una maggioranza di due milioni di suffragi che decise il referendum: l’Italia era repubblicana, anche con il voto dei ceti progressisti meridionali, dei contadini di Carlo Levi, dei cafoni di Ignazio Silone.
Così, alla "Conferenza della pace" di Parigi, davanti al consesso dei vincitori, nel discorso rimasto famoso per l’esordio "Sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me", De Gasperi potrà aggiungere: "ma sento anche la responsabilità e il diritto di parlare come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica, la quale armonizza in sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, la concezione universalistica del Cristianesimo e le speranze internazionaliste dei lavoratori".
Quel 2 giugno, nello stesso giorno in cui nasceva la Repubblica, rinasceva il Parlamento.
La scelta tra repubblica presidenziale e parlamentare, dibattuta a lungo nel comitato ristretto dei Settantacinque e nell’Assemblea plenaria, non aveva un esito scontato. Il modello presidenziale contava su pochi, ma agguerriti sostenitori, tra cui Calamandrei. Pesava, in ogni caso, la tragica esperienza della Repubblica di Weimar e quella dell’Italia del primo dopoguerra, esempi di un parlamentarismo debole e inconcludente, schermo troppo fragile da opporre a nazismo e fascismo. Einaudi proporrà all’Assemblea di prendere in esame i poteri che, in una lunga evoluzione, aveva via via assunto il primo ministro inglese, seppure sottoposto allo stretto controllo del Parlamento. Richiamo, per cenni, quelle dispute volendo rimarcare l’esame approfondito, lo scrupolo, il ricorso alla storia e alla dottrina, l’apertura senza pregiudizi con cui la Costituente, in diciotto mesi, svolse il suo compito. Quei temi, in particolare il cosiddetto "premierato forte", ai giorni nostri li ritroveremo al centro del dibattito politico.
Ancora vivi - anzi, di una inquietante attualità - sono i grandi temi legati a quanto la Costituzione afferma nell’articolo 3: "E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Norma programmatica, unica tra tutte le Costituzioni dell’epoca (dove si incontrano il pensiero sociale cattolico e quello socialista) fondamento della legislazione sui diritti civili dell’ultimo trentennio e oggi nuovamente sotto attacco, ma via via più condivisi, al punto d’essere difesi superando le divisioni e gli schieramenti tradizionali. Il Parlamento della Repubblica ha una laboriosa storia di risvegli ideali; e, in concreto, di sempre rinnovate inclusioni, cioè di aperture alle forze emergenti della politica e della società civile nel mutare, e nel maturare, dei tempi. La straordinaria ricchezza costituita dalla pluralità di idee, di cultura, di progetti ispirati dalla ritornata democrazia, a veder bene non è andata dispersa.
La Carta costituzionale imprimerà a un Paese minacciato dalla disunione un forte "sostrato unitario", come l’ha definito Napolitano. Quanto profondo e solido sia quel radicamento nella storia della Repubblica e della Costituzione è stato il tema di un intervento del compianto Pietro Scoppola alla Fondazione della Camera. Dalla sua analisi riprendo il passo in cui lo storico ha fatto proprio un giudizio di Dossetti, per il quale "il fiore pungente della Costituzione - come lo chiamò - germoglia dalla tragedia della seconda guerra mondiale e dalle durissime prove della Resistenza". E tuttavia, per quanto profonde e salde siano le radici della Costituzione repubblicana, "non sembra corrispondere ad esse - osservò Scoppola - un diffuso patriottismo repubblicano e costituzionale come coscienza di cittadinanza". E’ davvero stringente la sintonia tra queste parole e l’allarme pronunciato da Giorgio Napolitano, in occasione del 2 giugno, sui rischi di una deriva opportunistica, fino all’egoismo più palese, da cui il Paese sembra essere attraversato. C’è dunque ancora bisogno di educazione civica; non in forme stereotipate, ma nuove e coinvolgenti. La scuola dovrebbe fare di più, e così il sistema mediatico.
A tali necessità rispondeva quella che, in altre circostanze, chiamammo l’instancabile pedagogia di Ciampi, in cui la riscoperta dell’italianità si legava all’idea di una comunità non solo storicamente, ma anche socialmente, civilmente e culturalmente solidale, nel rispetto della virtù repubblicana come la vedeva Montesquieu: amore per la cosa pubblica, che presuppone disponibilità a mettere in comune, tutti, qualcosa di sé, anzi "il meglio di sé". E Scalfaro non ha mai cessato di perorare con tutte le sue energie, in ogni modo e circostanza, l’insegnamento della Costituzione, "la più solida, equa ed efficace delle pedagogie civili".
L’educazione alla cittadinanza, come è chiamata dagli studiosi di scienze politiche, è tutt’altro che un tema minore. Nella Carta fondamentale dell’ordinamento repubblicano è chiaramente definito un diritto decisivo per la democrazia: quello di manifestare liberamente il proprio pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". La premessa e la garanzia più efficaci di questo diritto stanno nella pluralità delle voci; eppure ha continuato a circolare una domanda destinata a suscitare una preoccupazione non bigotta, né bizzarra: se cioè stesse entrando in crisi l’assunto democratico secondo cui società libera, pluralità di idee e d’informazione, concorso alla vita pubblica in tutte le sue forme civili, sono tutt’uno, cioè spirito di cittadinanza, lo stesso al quale ci ha ricondotto Napolitano con accenti così risoluti da indurre una serie di osservazioni, analisi e giudizi. Ed è questo il motivo per cui - trascorso il 2 giugno, e avendo appreso che solo il 30-35% degli italiani conosce il significato della ricorrenza - sono riandato all’esperienza maturata sul campo a proposito dell’uso che noi, i cosiddetti comunicatori, abbiamo fatto e facciamo della nostra storia nazionale. Imparare la democrazia, esortava Gustavo Zagrebelsky dalle pagine di un libro assai profetico. Bisogna salvare i giovani dalla malattia strisciante, persino inconsapevole, della diseducazione civile. Per prime, vanno rianimate tutte le grandi fonti del senso, del significato, a cominciare dalla famiglia, dalla scuola e dai mass-media, per evitare che i loro ruoli, raccolti e fatti suoi dalla televisione, finiscano per essere interpretati - su basi generaliste, direbbe un massmediologo - dall’onnivora e fatalmente superficiale supplenza di ogni altra designata agenzia.
Sotto questo aspetto credo sia lecito definire vacillante il mito della televisione che "mostra le cose come stanno". Non è più un mistero per nessuno che tutto il ricreato dalla TV diviene l’immagine di una realtà più vera del vero. E qui, nel rappresentare quanto va direttamente riferito allo stato reale del Paese, cioè al progressivo scollegarsi dell’interesse individuale da quello comune, si coglie il primo indebolimento dell’identità nazionale - civile, culturale, etica - e una crescente cessione alla logica del sentire privato di ciò che dovremmo saper cogliere come segni di una diffusa e critica consapevolezza civica. Se la Tv non è soltanto il mezzo più idoneo a rappresentarci il mondo, ma anche a formare il nostro giudizio sul mondo, l’ineludibile requisito di uno strumento di tanta potenza e responsabilità dovrebbe essere quello di svolgere il suo compito fondandolo su contributi di carattere etico. Inventiva, spettacolo, gradevolezza, svago - non ne verrebbero a soffrire. Anche la gara per la conquista dell’audience andrebbe pensata e perseguita richiamandosi a quel principio: passi per un giornale, che ciascuno si sceglie perché corrisponde alla propria cultura, mentalità, ideologia, ma irrompere nelle case attraverso l’etere - specie se si è servizio pubblico - chiama in causa il rapporto fiduciario che uno strumento di tanto potere deve garantire alla res publica, cioè in nome di un bene generale. Mi sono soffermato sulla TV - anche quella di proprietà privata ha responsabilità pubbliche - per la sua posizione dominante nel sistema dei media, ma l’esigenza di pluralità e il richiamo all’etica vale per il giornalismo e per qualunque altra modalità comunicativa: è dall’intero sistema che può venire l’apporto più efficace alla formazione di una società di cittadini consapevoli dei loro diritti e capaci di esercitarli. Specie in un’epoca di crescenti risorse mediatiche, dovute all’universo elettronico; cui non può sfuggire l’elaborazione e la messa in valore di pulsioni, proposte e travisamenti che sono raramente l’opera dello storico, il quale si propone di accertare la verità anche sottoponendo a nuovo esame la versione degli eventi accettata fino ad allora, e dandone una sua responsabile lettura. Molto revisionismo deteriore ha le sue origini in una cattiva informazione, una pedagogia interessata, una politica ideologica, in definitiva una cultura in cui si insinua e agisce una parziale o manomessa costruzione della realtà che può portare a lente, striscianti, suggestive amnesie di ogni genere; non escluse quelle, di non facile decifrazione, che includono principi etici, valori morali, dignità culturali. Ogni ridondanza, malizia e faziosità andrebbero banditi: quel che serve è una pacata, lucida e condivisa volontà di pace civile e sociale, fatta di lavoro, di equità, di sicurezza. È ciò che dobbiamo allo stesso atto fondativo di questa democrazia e di questa Repubblica. Cioè a noi, persone e cittadini, singoli e comunità, tenuti insieme, indivisi, da una storia che è di ciascuno e di tutti. In cui quanto va salvato, contro la vischiosità del pregiudizio, è compito di strumenti specialmente vocati a farci capire che cosa dover intendere per res publica, la quale non è mai interessata alle pronunce solenni, scolpite nel marmo, ma al principio secondo cui conoscere e condividere - pur nelle diverse, legittime identità - è la prima possibilità di difendersi e crescere. Insieme. Penso alla lucidità di De Rita nel considerare la lectio umana e civile, sociale ed etica, venuta dal Colle in un giorno che invitava a parlarci, l’un l’altro, avendo davanti agli occhi lo stesso Paese, tentato dalla trasgressione quotidiana come segno di una micro-deriva della dignità civica e del rispetto interiore; e ciò mentre - osserva De Rita - "una società che esalta l’individualismo, e ha rotto con le vecchie appartenenze, non riesce a crearne di nuove". Se non quelle spaesate, aggressive, ribelliste, violente che aggregano i senza bussola, imbarbariti dalla solitudine e dall’egotismo, alle soglie di quella che il presidente Napolitano ha chiamato "regressione civile".
* l’Unità, Pubblicato il: 08.06.08, Modificato il: 08.06.08 alle ore 13.47
-
-
