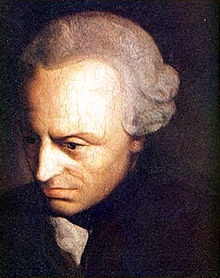
ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. Alcune note - di Federico La Sala
- [...] La prima volta che Eichmann mostrò di rendersi vagamente conto che il suo caso era un po’ diverso da quello del soldato che esegue ordini criminosi per natura e per intenti, fu durante l’istruttoria, quando improvvisamente dichiarò con gran foga di aver sempre vissuto secondo i principî dell’etica kantiana, e in particolare conformemente a una definizione kantiana del dovere.
 L’affermazione era veramente enorme, e anche incomprensibile, poiché l’etica di Kant si fonda soprattutto sulla facoltà di giudizio dell’uomo, facoltà che esclude la cieca obbedienza. Il giudice istruttore non approfondì l’argomento, ma il giudice Raveh, vuoi per curiosità, vuoi perché indignato che Eichmann avesse osato tirare in ballo il nome di Kant a proposito dei suoi misfatti, decise di chiedere chiarimenti all’imputato. E con sorpresa di tutti Eichmann se ne uscì con una definizione più o meno esatta dell’imperativo categorico: “Quando ho parlato di Kant, intendevo dire che il principio della mia volontà deve essere sempre tale da poter divenire il principio di leggi generali” [...]
L’affermazione era veramente enorme, e anche incomprensibile, poiché l’etica di Kant si fonda soprattutto sulla facoltà di giudizio dell’uomo, facoltà che esclude la cieca obbedienza. Il giudice istruttore non approfondì l’argomento, ma il giudice Raveh, vuoi per curiosità, vuoi perché indignato che Eichmann avesse osato tirare in ballo il nome di Kant a proposito dei suoi misfatti, decise di chiedere chiarimenti all’imputato. E con sorpresa di tutti Eichmann se ne uscì con una definizione più o meno esatta dell’imperativo categorico: “Quando ho parlato di Kant, intendevo dire che il principio della mia volontà deve essere sempre tale da poter divenire il principio di leggi generali” [...]
Premessa
KANT E L’USCITA DALLO STATO DEL FARAONE, DALLO STATO DI MINORITA’.
Uscire dall’Egitto non è un giochino né una passeggiata. Mettersi sulla strada della liberazione significa attraversare il deserto, affrontare una “discesa all’Averno”! Come sa e insegna Kant, per uscire dallo stato di minorità, occorre “il coraggio di servirsi del proprio intelletto senza esser guidati da un altro”. E la cosa è difficile sia dal lato del coraggio sia dal lato del servirsi del proprio intelletto: è “difficile per ogni singolo uomo districarsi dalla minorità che per lui è diventata una seconda natura. E’ giunto perfino ad amarla”. Inoltre, a “far sì che la stragrande maggioranza degli uomini (e con essi tutto il bel sesso) ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltreché difficile, anche molto pericoloso, provvedono già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l’alta sorveglianza sopra costoro”(I. Kant, Risposta alla domanda: che cosa è l’illuminismo, 1783).
Pensare è interpretare. La critica è un esame e un giudizio (I. Kant, “I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica”, 1766), per decidere in che direzione andare! Quale Legge seguire come criterio? La Legge del Faraone o la Legge di Mosè - del “Super-Io” o dell’“Oltre-Io”?
Restare in Egitto è restare minorenni per sempre. Pensare da sé, orientarsi nel pensiero, non è facile: “significa cercare in se stessi (vale a dire nella propria ragione) il criterio supremo della verità”, significa “chiedere a se stessi, in tutto ciò che si deve accogliere, se si ritiene fattibile che il fondamento in base a cui lo si accoglie, o anche la regola che consegue a quel che si accoglie, vengano elevati a principio universale dell’uso della nostra ragione. Ognuno può fare su stesso questo esperimento, e vedrà che in quest’esame la superstizione e l’esaltazione ben presto si dilegueranno, anche se egli stesso non avesse le cognizioni necessarie a confutare entrambe con argomenti oggettivi. Egli infatti si serve esclusivamente della massima dell’autoconservazione della ragione”(I. Kant, Che cosa significa orientarsi nel pensiero, 1786).
Questo esame comporta un “esame di noi stessi, il quale richiede che si scruti l’abisso del cuore sino nelle sue profondità più nascoste (...) che egli cominci a sbarazzarsi di ogni ostacolo interno (creato dalla cattiva volontà che si annida in lui), e che s’affatichi poi a sviluppare in sé le innate disposizioni di una buona volontà, che non possono mai andare interamente perdute. Soltanto la discesa all’Averno della conoscenza di noi stessi apre la via che innalza all’apoteosi” (I. Kant, La metafisica dei costumi, 1797 - Laterza, Bari 1983, p. 302).
1. GERUSALEMME, 1961: KANT, ADOLF EICHMANN, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI HEIDEGGER. L’ABBAGLIO DI HANNAH ARENDT PRIMA E DI EMIL L. FACKENHEIM DOPO.
- 1933: L’ORA DELLA DECISIONE PER HEIDEGGER. A fine gennaio del 1933, Adolf Hitler giunge al potere. Nello stesso anno, Martin Heidegger diventa rettore dell’Università di Friburgo ed esprime pieno ed inequivocabile appoggio al regime nazista, con il suo famoso discorso su “L’autoaffermazione dell’università tedesca”. Per Heidegger non c’è alcun dubbio che Hitler sia il Messia del popolo tedesco, come ripeterà in uno scritto sul giornale degli studenti dell’Università, il 3 novembre del 1933: “Il Fuhrer stesso e lui soltanto è la realtà tedesca e la sua legge, oggi e da oggi in poi. Rendetevene conto sempre di più: da ora ogni cosa richiede decisione, e ogni azione responsabilità”. La notte scende sulla Germania, e su tutta l’Europa: in un’intervista del 1966, Heidegger, pur mai pentendosi dei suoi trascorsi nazionalsocialisti, dichiarerà che “Solo un Dio ci può salvare”.(Cfr. Federico La Sala, Sigmund Freud e la Legge dell’"Uno" ... "L’Uomo Mosè e la religione smonoteistica" Un’indicazione per una rilettura).
A. ADOLF EICHMANN CHIARISCE COME E’ DIVENUTO “ADOLF EICHMANN”, MA HANNAH ARENDT TESTIMONIA CONTRO SE STESSA E BANALIZZA: “IO PENSO VERAMENTE CHE EICHMANN FOSSE UN PAGLIACCIO”(H. ARENDT, Che cosa resta? Resta la lingua materna. Conversazione di Hannah Arendt con Gunther Gaus, 1964 - in "Aut Aut", 239-240, 1990)
“La conferenza di Wannsee, ovvero Ponzio Pilato”. Nel capitolo settimo di “La banalità del male” (Feltrinelli, Milano 2007) Hannah Arendt affronta “il discorso sulla coscienza” di Adolf Eichmann. Seguendo il filo delle sue dichiarazioni, ella scrive che il vero e proprio punto di svolta della sua vita,“il momento cruciale”, avvenne “nel gennaio del 1942, quando ebbe luogo la conferenza che i nazisti usarono chiamare dei segretari di Stato, ma che oggi è più nota con nome di Conferenza di Wannsee, dal sobborgo di Berlino in cui fu convocata da Himmler” (p. 120):
“(...) quella giornata fu indimenticabile per Eichmann. Benché egli avesse fatto del suo meglio per contribuire alla soluzione finale, fino ad allora aveva sempre nutrito qualche dubbio su “una soluzione cosí violenta e cruenta”. Ora questi dubbi furono fugati. “Qui, a questa conferenza, avevano parlato i personaggi piú illustri, i papi del Terzo Reich”. Ora egli vide con i propri occhi e udí con le proprie orecchie che non soltanto Hitler, non soltanto Heydrich o la “sfinge” Muller, non soltanto le SS o il partito, ma i piú qualificati esponenti dei buoni vecchi servizi civili si disputavano l’onore di dirigere questa “crudele” operazione. “In quel momento mi sentii una specie di Ponzio Pilato, mi sentii libero da ogni colpa”. Chi era lui, Eichmann, per ergersi a giudice? Chi era lui per permettersi di “avere idee proprie”? Orbene: egli non fu né il primo né l’ultimo ad essere rovinato dalla modestia.
Così la sua attività prese un nuovo indirizzo, divenendo ben presto un lavoro spicciolo, di tutti i giorni. Se prima egli era stato un esperto in “emigrazione forzata”, ora diventò un esperto di “evacuazione forzata”. In un paese dopo l’altro gli ebrei dovettero farsi schedare, furono costretti a portare il distintivo giallo per essere riconoscibili a prima vista, furono rastrellati e deportati e i vari convogli vennero spediti a questo o a quel campo di sterminio dell’Europa orientale, a seconda del “posto” disponibile in quel dato momento” (p. 122 - c.vi miei, fls).
“I doveri di un cittadino ligio alla legge” - dell’Imperatore-Dio. Nel capitolo ottavo, il resoconto prosegue, e così inizia:
“Eichmann ebbe dunque molte occasioni di sentirsi come Ponzio Pilato, e col passare dei mesi e degli anni non ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose, questa era la nuova regola, e qualunque cosa facesse, a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge. Alla polizia e alla Corte disse e ripeté di aver fatto il suo dovere, di avere obbedito non soltanto a ordini, ma anche alla legge.
Eichmann aveva la vaga sensazione che questa fosse una distinzione importante, ma né la difesa né i giudici cercarono di sviscerare tale punto. Oltre ad aver fatto quello che a suo giudizio era il dovere di un cittadino ligio alla legge, egli aveva anche agito in base a ordini - preoccupandosi sempre di essere“coperto” -, e perciò ora si smarrì completamente e finì con l’insistere alternativamente sui pregi e sui difetti dell’obbedienza cieca, ossia dell’“obbedienza cadaverica”, Kadauergehorsam, come la chiamava lui.
La prima volta che Eichmann mostrò di rendersi vagamente conto che il suo caso era un po’ diverso da quello del soldato che esegue ordini criminosi per natura e per intenti, fu durante l’istruttoria, quando improvvisamente dichiarò con gran foga di aver sempre vissuto secondo i principî dell’etica kantiana, e in particolare conformemente a una definizione kantiana del dovere.
L’affermazione era veramente enorme, e anche incomprensibile, poiché l’etica di Kant si fonda soprattutto sulla facoltà di giudizio dell’uomo, facoltà che esclude la cieca obbedienza. Il giudice istruttore non approfondì l’argomento, ma il giudice Raveh, vuoi per curiosità, vuoi perché indignato che Eichmann avesse osato tirare in ballo il nome di Kant a proposito dei suoi misfatti, decise di chiedere chiarimenti all’imputato. E con sorpresa di tutti Eichmann se ne uscì con una definizione più o meno esatta dell’imperativo categorico: “Quando ho parlato di Kant, intendevo dire che il principio della mia volontà deve essere sempre tale da poter divenire il principio di leggi generali” (il che non vale, per esempio, nel caso del furto o dell’omicidio, poiché il ladro e l’omicida non possono desiderare di vivere sotto un sistema giuridico che dia agli altri il diritto di derubarli o di assassinarli).
Rispondendo ad altre domande, Eichmann rivelò di aver letto la Critica della ragion pratica di Kant, e quindi procedette a spiegare che quando era stato incaricato di attuare la soluzione finale aveva smesso di vivere secondo i principî kantiani, e che ne aveva avuto coscienza, e che si era consolato pensando che non era più “padrone delle proprie azioni”, che non poteva far nulla per “cambiare le cose”.
Alla Corte non disse però che in questo periodo “di crimini legalizzati dallo Stato” - così ora lo chiamava - non solo aveva abbandonato la formula kantiana in quanto non più applicabile, ma l’aveva distorta facendola divenire: “agisci come se il principio delle tue azioni fosse quello stesso del legislatore o della legge del tuo paese”, ovvero, come suonava la definizione che dell’“imperativo categorico nel Terzo Reich” aveva dato Hans Frank e che lui probabilmente conosceva: “agisci in una maniera che il Fuhrer, se conoscesse le tue azioni, approverebbe” (Die Technik des Staates, 1942, pp. 15-16).
Certo, Kant non si era mai sognato di dire una cosa simile; al contrario, per lui ogni uomo diveniva un legislatore nel momento stesso in cui cominciava ad agire: usando la “ragion pratica” ciascuno trova i principî che potrebbero e dovrebbero essere i principî della legge. Ma è anche vero che l’inconsapevole distorsione di Eichmann era in armonia con quella che lo stesso Eichmann chiamava la teoria di Kant “ad uso privato della povera gente”. In questa versione ad uso privato, tutto ciò che restava dello spirito kantiano era che l’uomo deve fare qualcosa di più che obbedire alla legge, deve andare al di là della semplice obbedienza e identificare la propria volontà col principio che sta dietro la legge - la fonte da cui la legge è scaturita. Nella filosofia di Kant fonte era la ragion pratica; questa, per Eichmann, era la volontà del Fuhrer.
Buona parte della spaventosa precisione con cui fu attuata la soluzione finale (una precisione che l’osservatore comune considera tipicamente tedesca o comunque caratteristica del perfetto burocrate) si può appunto ricondurre alla strana idea, effettivamente molto diffusa in Germania, che essere ligi alla legge non significa semplicemente obbedire,ma anche agire come se si fosse il legislatore che ha stilato la legge a cui si obbedisce. Da qui la convinzione che occorra fare di più di ciò che impone il dovere.
Qualunque ruolo abbia avuto Kant nella formazione della mentalità dell’ “uomo qualunque” in Germania, non c’è il minimo dubbio che in una cosa Eichmann seguì realmente i precetti kantiani: una legge è una legge e non ci possono essere eccezioni. A Gerusalemme egli ammise di aver fatto un’eccezione in due casi, nel periodo in cui “ottanta milioni di tedeschi” avevano ciascuno “il suo bravo ebreo”, aveva aiutato una cugina mezza ebrea e una coppia di ebrei viennesi, cedendo alle raccomandazioni di suo “zio”.
Questa incoerenza era ancora un ricordo spiacevole, per lui, e così durante l’interrogatorio dichiarò, quasi per scusarsi, di aver “confessato le sue colpe” ai superiori. Agli occhi dei giudici questa ostinazione lo condannò più di tante altre cose meno incomprensibili, ma ai suoi occhi era proprio questa durezza che lo giustificava, così come un tempo era valsa a tacitare quel poco di coscienza che ancora poteva avere. Niente eccezioni: questa era la prova che lui aveva sempre agito contro le proprie “inclinazioni”, fossero esse ispirate dal sentimento o dall’interesse; questa era la prova che lui aveva fatto sempre il proprio “dovere” (...)" (pp142.144).
B.COME L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DIVENTA L’IMPERATIVO CATEGORICO DI EICHMANN?
Emil L. Fackenheim, nel suo lavoro “Tiqqun. Riparare il mondo”, Medusa Edizioni, Milano, 2010) scrive: “Quando un ebreo pensa a Hitler, ricorda il Faraone, Amalek, Haman: quest’ultimo forse è quello che si avvicina di più al dittatore tedesco. Il Faraone aveva reso schiavi gli Israeliti. Amalek attaccava i più deboli. Ma fu Haman che pianificò di uccidere tutti gli ebrei” (p. 25). Al centro della sua riflessione filosofica e teologica - a partire dal nostro presente storico, dopo Auschwitz e dopo la nascita dello Stato di Israele - è proprio lo sforzo di negare al Faraone, a Hitler, la vittoria postuma.
Ma, se questo è il problema e l’obiettivo, è decisamente grave che un ‘architetto’, che va alla ricerca di nuovi “fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah”, metta fuori campo il contributo di Freud e, in particolare, il suo ultimo lavoro:“L’uomo Mosè e la religione monoteistica” (1938). E dice di una più generale e sintomatica assenza di controllo critico sul suo intero percorso e sulla sua proposta di ‘costruzione’. Non essendo stato giusto con Freud, non lo è stato nemmeno con Kant, il filosofo dell’”uscita dallo stato di minorità” (o, se si vuole, dall’Egitto). E così anche con Mosè - e con se stesso!
Pur essendo fermamente convinto che “solo tenendo saldamenti fermi nel contempo “è” e “non dover essere”, il pensiero può guadagnare una sopravvivenza autentica”, che “il pensiero cioè deve assumere la forma della resistenza”, e, ancora, che “il pensiero resistente deve puntare oltre la sfera totale del pensiero, a una resitenza che non sia solo nel “mero” pensiero, ma in un’azione pubblica, in una vita in carne e ossa” (op.cit., p.208), alla fine, finisce anch’egli nel cadere nella trappola della “dottrina - largamente citata, largamente diffusa, largamente accettata della banalità del male” (op.cit., p. 206).
In una “Lezione pronunciata l’11 aprile 1993 presso l’Università Martin Luther di Halle-Wittenberg”, dal titolo “Auschwitz come sfida alla filosofia e alla teologia”, Fackenheim dice e scrive: “L’anno è il 1961. Il famigerato omicida di massa Adolph Eichmann (...) catturato dagli agenti israeliani e tratto da Buenos Aires in Israele, è (...) sotto processo a Gerusalemme. Il processo si stava protraendo di molto. A un certo punto i giudici chiedono conto all’accusato delle sue convinzioni personali, e questi menziona l’etica di Kant. I giudici devono aver sobbalzato (...) Tutti e tre erano tedeschi di origine, e in quanto tali dovevano avere una certa dimestichezza con Kant. Uno di essi, Yitzhak Rawe, non riuscì a trattenersi: Potrebbe Eichmann spiegare la filosofia morale di Kant? E con sorpresa di tutti, l’accusato diede una sintesi confusa ma in qualche modo adeguato. L’uomo che probabilmente passerà alla storia come il più grande organizzatore di omicidi di massa, conosceva, credeva e talvolta metteva in pratica pezzi dell’insegnamento di Immanuel Kant, il più grande filosofo tedesco” (cfr. Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah, Milano, Medusa, 2010, , p. 290).
Fackenheim resta abbagliato. Comprende - e condivide con Hannah Arendt (op. cit., p. 300, nota 3) - che “Per Eichmann «Legge» in fin dei conti significava una sola cosa Fuhrerbefehl [ordine del Fuhrer], chiaro netto, inequivocabile. Che avesse letto o no il libro di Hans Frank, imputato nel processo di Norimberga, La tecnica dello Stato, egli obbedì a quella nuova, originale versione dell’Imperativo Categorico promossa dall’autorevole pensatore: «Agisci in modo tale che il Fuhrer, se conoscesse la tua azione, approverebbe»”(op. cit., p. 291). Ma - come Hannah Arendt - non riesce a capire, e il suo precetto di “negare al Faraone la vittoria postuma” diventa solo un ennesimo ‘precetto’.
Tuttavia, se il nodo non sciolto sta come una montagna su tutto il suo lavoro, ha il merito di aver ri-proposto la domanda decisiva: “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (op. cit., p. 293). E non è poco!
Federico La Sala (10.11.2011)
Sul tema, per ulteriori approfondimenti, si cfr.:
KANT, UN ALTRO KANT. LA LEZIONE DI MICHEL FOUCAULT E LA SORPRESA DI JURGEN HABERMAS.
Forum
-
> FARE CHIAREZZA --- ISRAELE - PALESTINA: USCIRE DALL’ORBITA DEL «MITO POTENTISSIMO» DELL’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE-TERRA E «ABITARE DA STRANIERI UNA TERRA-SPOSA» (di Donatella Di Cesare).26 maggio 2021, di Federico La Sala
ISRAELE - PALESTINA /SENZA FINE
ABITARE DA STRANIERI UNA TERRA-SPOSA
Tra Israele e Palestina l’idea dei due popoli e due stati non regge più
Chi conosce i territori sa bene che sono strettamente intrecciati e che sotto ogni aspetto una divisione netta, oltre a essere irrealistica, sarebbe artificiosa e alla fin fine nociva. Quasi una resa. Per questo serve immaginare un laboratorio politico nuovo
di Donatella Di Cesare (L’Espresso, 25.05.2021)
«Quelli sono occupanti! E gli altri sono occupati». Più esplicitamente: «Quel paese è frutto di occupazione!». Oppure con il nuovo motto: «Basta con l’esproprio etnico!». Sono solo alcuni esempi di slogan che circolano ovunque, dal web alle piazze, e che rilanciano una vecchia, vecchissima accusa (quasi immemoriale): Israele non dovrebbe essere lì dov’è. Non ci sarebbe quasi altro da aggiungere.
Il «peccato originale» che avrebbe segnato la nascita di Israele sarebbe quello di aver scalzato un popolo che c’era prima, indigeno, nativo, insomma autoctono. Alla fin fine non si tratta neppure tanto di limiti e confini, di linea verde e territori contestati. Dietro calcolo e contabilità, a cui spesso si fermano statisti e politologi, si nascondono questioni ben più profonde che di solito vengono aggirate. Forse perché non riguardano solo Israele e Palestina, ma investono tutti noi, le nostre frontiere, gli stati nazionali in cui siamo inseriti, il nostro abitare e il rapporto con gli altri.
 Perciò occorre forse una prospettiva nuova, un modo diverso a cui guardare quel terribile conflitto che non per caso ci turba e ci coinvolge tutti con un’ondata di emozioni talvolta irrefrenabili, al punto da rendere impossibile una riflessione. E se nella tragedia si nascondesse invece una chance? Se Israele e Palestina fossero il laboratorio politico della globalizzazione?
Perciò occorre forse una prospettiva nuova, un modo diverso a cui guardare quel terribile conflitto che non per caso ci turba e ci coinvolge tutti con un’ondata di emozioni talvolta irrefrenabili, al punto da rendere impossibile una riflessione. E se nella tragedia si nascondesse invece una chance? Se Israele e Palestina fossero il laboratorio politico della globalizzazione?Forse bisognerebbe chiedersi anzitutto che cosa significa «occupare». Questo verbo, che è il punto dirimente, non sembra solo legato alla frontiera e al fronteggiarsi. Rinvia anche al possesso originario, alla mitologia dell’origine, a cui non si sottraggono neppure i palestinesi quando rivendicano di essere i primi abitanti. La battaglia delle cartine è arrivata anche su facebook. Colori e bandiere diversi si avvicendano per quello stretto lembo di terra che va dal Giordano al Mediterraneo. E di nuovo: lo scontro non è tanto sulla geografia, quanto sulla storia. Chi c’era prima? I palestinesi che sono stati poi scalzati. Sono loro gli abitanti originari, gli autoctoni. Quelli che sono arrivati dopo - gli ebrei, gli israeliani - sono occupanti, colonialisti, ecc. Ma i nomi contengono anche una testimonianza storica. L’etimologia di «palestinese» va ricondotta a liflosh, ovvero filisteo, cioè invasore, e si riferisce a un popolo venuto dal mare. Dopo aver raso al suolo Gerusalemme i romani chiamarono Palestina la terra di Israele per sottolineare la rottura rappresentata dall’Impero e cancellare anche nel nome il ricordo del popolo ebraico. I palestinesi di oggi, discendenti in gran parte dall’immigrazione araba intorno al 1930, sono andati costruendo una identità nazionale nel confronto-scontro con Israele rivendicando radicamento e possesso originario.
Sono allora gli ebrei i veri autoctoni? No - e lo dice il nome. Perché ivrì, cioè venuto da altrove, non può essere del luogo. Abramo, il primo emigrante, segue l’ingiunzione: «va, vattene!». E così lascia tutto per andare a vivere da straniero in una terra non sua, promessa. Insomma, quelli che credono di essere venuti prima sono invece sempre venuti dopo.
 Chi sono allora gli abitanti originari, gli autoctoni, di questa terra, e di ogni terra? Ma forse sbagliata è proprio la domanda: nessun popolo può dimostrare di essere autoctono.
Chi sono allora gli abitanti originari, gli autoctoni, di questa terra, e di ogni terra? Ma forse sbagliata è proprio la domanda: nessun popolo può dimostrare di essere autoctono.Eppure, questo mito potentissimo alimenta ancora oggi la politica degli stati nazionali. Basti pensare alla guerra contro i migranti. È l’idea della terra-madre che, mettendo fuori gioco le donne, genera direttamente i suoi figli, tutti maschi e tutti cittadini, perché nati proprio lì, in quella zolla di terra, nel suolo stesso della città. Perciò sono i proprietari esclusivi, i figli legittimi, ben nati, in grado di respingere gli altri, i bastardi e gli stranieri. Questo avviene nell’Atene patria del sé, modello fulgido di pura, presunta autoctonia. Ma l’esempio - lo sappiamo - può vantare una tradizione secolare che nulla ha interrotto, nemmeno l’hitlerismo, la forma più esasperata dello ius soli. E oggi quel mito continua ad affermarsi tra radici inestirpabili e malattia identitaria, che ovunque rischiano di ridurre la democrazia a etnocrazia, una forma politica dove valgono non i diritti del popolo, ma quelli della stessa etnia. Si può puntare l’indice solo su Israele, parlando di stato etnico e magari usando una parola grave come «apartheid»? Oppure non si dovrebbe guardare anzitutto a quel che avviene nei paesi europei, anzitutto in Italia, dove la cittadinanza è basata ancora sul sangue e sul suolo?
Chi conosce i territori israeliani e palestinesi sa bene che sono strettamente intrecciati e che sotto ogni aspetto una divisione netta, oltre a essere irrealistica, sarebbe artificiosa e alla fin fine nociva. Quasi una resa. E infatti sono sempre più le voci critiche che negli ultimi anni si sono levate contro la «soluzione dei due stati», giudicata una fantasia che dimentica la storia e ignora il contesto politico. D’altronde ovunque, sotto la spinta della globalizzazione, lo stato perde sovranità e i confini diventano un limite. In tale scenario quello tra Israele e Palestina è il conflitto tra uno stato post-nazionale e uno stato proto-nazionale. Sta qui in gran parte l’insolubilità.
 Le due parti non si incontrano anche perché si trovano in fasi diverse della propria storia. Israele ha compiuto la «liberazione nazionale» e in molti ambiti (dallo high tech all’informatica) oltrepassa continuamente i referenti statuali. Resta allora la questione dello Stato palestinese. Al di là delle divisioni interne, si può essere sicuri che la fondazione di un nuovo stato sarebbe criterio di equità e favorirebbe la pace? La logica degli stati nazionali, che ancora nel secolo scorso poteva essere considerata la via dell’emancipazione, da tempo mostra tutte le proprie pecche, dall’aggressività nazionalistica alla costruzione di identità artificiali. Le «patrie» che gli stati nazionali hanno costruito per i propri popoli si sono rivelate trappole senza uscita.
Le due parti non si incontrano anche perché si trovano in fasi diverse della propria storia. Israele ha compiuto la «liberazione nazionale» e in molti ambiti (dallo high tech all’informatica) oltrepassa continuamente i referenti statuali. Resta allora la questione dello Stato palestinese. Al di là delle divisioni interne, si può essere sicuri che la fondazione di un nuovo stato sarebbe criterio di equità e favorirebbe la pace? La logica degli stati nazionali, che ancora nel secolo scorso poteva essere considerata la via dell’emancipazione, da tempo mostra tutte le proprie pecche, dall’aggressività nazionalistica alla costruzione di identità artificiali. Le «patrie» che gli stati nazionali hanno costruito per i propri popoli si sono rivelate trappole senza uscita.Puntare a una comune cittadinanza deterritorializzata e denazionalizzata sarebbe invece la strada insieme più concreta, ma anche più lungimirante. Si tratta peraltro di un esperimento che viene praticato anche in altre parti del mondo, dove gli stati gomito a gomito impediscono la convivenza, oppure in alcune grandi città nelle quali è molto alto il numero degli immigrati (esemplare è il caso di New Haven che ha concesso stato civile e diritti politici). Tutto questo non potrebbe in nessun modo lasciare immutato lo stato di Israele che, anzi, proprio perciò, dovrebbe andare al di là dello stato.
Non avrebbe dovuto essere questo il suo compito? Mentre è accusato di occupare una terra non sua, mostrare la possibilità di un altro abitare? Era questo il senso della promessa, una promessa certo non dettata dalla Shoah, dei cui esiti atroci Israele ha dovuto semmai farsi carico. Eppure, ancora oggi Israele è inquisito nel suo essere: si contesta quel ritorno, negando la continuità della presenza su quella terra, e dunque la storia stessa del popolo ebraico. Capita che lo facciano subdolamente esimi storici che su youtube ironizzano sull’antico regno di Israele. Come se questo fosse il punto.
Ma che dire degli sfratti a Sheikh Jarrah? Soprattutto per ciò di cui sono simbolo? E tutta la miope e belligerante politica di espansione della destra che in questi ultimi anni ha provocato enormi e inutili tensioni? Si può ormai parlare di una tragicità del sionismo politico che sulla scia della normalizzazione ha inscritto Israele nella modernità al prezzo di un nazionalismo esasperato e una simbiosi con la terra. Proprio il popolo che dovrebbe mostrare la possibilità di un altro abitare, non nel solco del radicamento, bensì nella separazione. Questo vuol dire kadosh, santo, separato. Terra in cui si risiede come stranieri, venuti da fuori, come ospiti che non possono non concedere ospitalità.
 Non una terra-madre, bensì una terra-sposa. Impossibile dimenticare l’estraneità, sacralizzando idolatricamente la terra. D’altronde in ebraico gher, straniero, è connesso con ghur, abitare. Si può e si deve abitare da stranieri. Nessun mito di autoctonia.
Non una terra-madre, bensì una terra-sposa. Impossibile dimenticare l’estraneità, sacralizzando idolatricamente la terra. D’altronde in ebraico gher, straniero, è connesso con ghur, abitare. Si può e si deve abitare da stranieri. Nessun mito di autoctonia.Abitare e coabitare sono verbi oggi politicamente decisivi e vanno al di là di vecchie categorie politiche che non rispondono più allo scenario attuale e all’ordine statocentrico. Si capisce che il conflitto tra Israele e Palestina abbia ripercussioni ovunque. Già solo perché viene tacitamente scossa la sovrana autocoscienza delle nazioni che vantano radici e possesso territoriali. Israele è una effrazione nel dimorare della Palestina e i palestinesi, i più prossimi, sono quasi delegati degli altri popoli, che d’un tratto si trovano faccia a faccia con il vuoto statuale e nazionale di cui Israele è memoria. In tal senso, guardando oltre il quadro bellico, è quello il laboratorio politico dove due popoli, loro malgrado, sono costretti a inaugurare nuove forme di coabitazione che saranno forse modello per gli altri.
-
> ISRAELE: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. --- INTERVISTA A ZEEV STERNHELL. In ricordo (di Redazione "Il Mulino").23 giugno 2020, di Federico La Sala
In ricordo di Zeev Sternhell
di Redazione "Il Mulino" *
- Riproponiamo l’intervista di Mario Snajder a Zeev Sternhell, lo storico e scienziato della politica israeliano scomparso oggi [21 giugno 2020].
La maggior parte dei tuoi studi si è concentrata sul fascismo. Come mai ti sei interessato a questo argomento, e qual è stata la spinta iniziale ?
Mentre stavo compiendo i miei studi di Master scoprii i testi di Maurice Barrès, lavori che all’epoca erano praticamente dimenticati. Cominciai a leggerli e trovai riflessioni che mi colpirono profondamente. La prima fu quella che Barrès definì «il senso del relativo», vale a dire il rifiuto di norme universali, di tutta la tradizione occidentale dell’Illuminismo : una visione che conduce ad una guerra totale contro Kant e l’imperativo categorico. Tutto ciò emerge nel suo più importante romanzo politico, Les Déracinés (1897), nel quale egli esprime in maniera compiuta la sua visione del nazionalismo e della nazionalità, quella «della terra e dei morti». Quando uno lo legge si rende conto che non c’è alcuna differenza tra questa visione e quella del «Blut und Boden» (sangue e suolo). Studiando quindi le argomentazioni con le quali la destra radicale ha condotto la propria guerra contro il relativismo morale e Kant - che insieme a Jean-Jacques Rousseau è il principale rappresentante dell’Illuminismo - capii che lì, in quelle argomentazioni, c’era l’inizio di una risposta alle domande che mi stavo facendo io stesso : e cioè, perché tutto ciò accadeva in Francia ? Se fossi stato in Germania non mi avrebbe sorpreso, e se fossi stato in Italia avrei detto : beh, il fascismo... Ma perché in Francia ? Perché in una società identificata con i principi della rivoluzione del 1879 ?
 Questi interrogativi rappresentano l’inizio della mia ricerca : stimolato da tutto ciò scrissi il libro su Barrès, Maurice Barrès et le nationalisme français (1972) derivato dalla mia tesi di dottorato. Questo saggio aprì un lungo percorso di ricerca. Il mio secondo libro, dedicato destra rivoluzionaria, è intitolato La droite revolutionaire (1885-1914), ma con un sottotitolo significativo, Les origines françaises du fascisme (1978). Infatti non intendevo parlare delle origini del fascismo francese, bensì delle origini francesi del fascismo. Per la prima volta si metteva l’accento sulle fonti intellettuali francesi del fascismo, e questo fu considerato molto originale. Questo lavoro, affiancato da quello precedente su Barrès, allargò il mio orizzonte e mi portò ad affrontare non solo elementi ideologici ma anche sociali e politici. In quel momento ero già convinto che l’origine del fascismo dovesse essere ricercata in Francia.
Questi interrogativi rappresentano l’inizio della mia ricerca : stimolato da tutto ciò scrissi il libro su Barrès, Maurice Barrès et le nationalisme français (1972) derivato dalla mia tesi di dottorato. Questo saggio aprì un lungo percorso di ricerca. Il mio secondo libro, dedicato destra rivoluzionaria, è intitolato La droite revolutionaire (1885-1914), ma con un sottotitolo significativo, Les origines françaises du fascisme (1978). Infatti non intendevo parlare delle origini del fascismo francese, bensì delle origini francesi del fascismo. Per la prima volta si metteva l’accento sulle fonti intellettuali francesi del fascismo, e questo fu considerato molto originale. Questo lavoro, affiancato da quello precedente su Barrès, allargò il mio orizzonte e mi portò ad affrontare non solo elementi ideologici ma anche sociali e politici. In quel momento ero già convinto che l’origine del fascismo dovesse essere ricercata in Francia.
 L’Italia venne dopo. Studiando la destra radicale e poi il boulangismo capii che in quella fase - gli anni Ottanta del XIX secolo - si manifestava la prima crisi del liberalismo, e ciò avveniva nella più avanzata società liberale dell’Europa, la Francia. Il boulangismo fu un fenomeno affascinante perché conteneva tutti gli elementi fondamentali dell’estrema destra : il nazionalismo radicale e organicista, l’antisemitismo, l’esaltazione del leader. Tutta l’animosità contro l’ordine liberale e borghese espressa dalla destra radicale, così come dalla sinistra radicale non-marxista, si presenta in una forma ancora embrionale in quegli anni. Tuttavia emerge in maniera evidente che la destra non deve essere di necessità conservatrice, ma può essere anche rivoluzionaria.
L’Italia venne dopo. Studiando la destra radicale e poi il boulangismo capii che in quella fase - gli anni Ottanta del XIX secolo - si manifestava la prima crisi del liberalismo, e ciò avveniva nella più avanzata società liberale dell’Europa, la Francia. Il boulangismo fu un fenomeno affascinante perché conteneva tutti gli elementi fondamentali dell’estrema destra : il nazionalismo radicale e organicista, l’antisemitismo, l’esaltazione del leader. Tutta l’animosità contro l’ordine liberale e borghese espressa dalla destra radicale, così come dalla sinistra radicale non-marxista, si presenta in una forma ancora embrionale in quegli anni. Tuttavia emerge in maniera evidente che la destra non deve essere di necessità conservatrice, ma può essere anche rivoluzionaria.Così si arriva al fascismo del XX secolo?
Sì. Tutto ciò converge nel mio terzo libro La naissance de l’ideologie fasciste (1989) al quale hanno contribuito Maia Asheri e Mario Sznajder. Ma l’impianto concettuale è una prosecuzione, o piuttosto un esame più approfondito, di quanto era stato già elaborato nei precedenti lavori. Siamo arrivati a rintracciare il momento della nascita dell’ideologia fascista seguendone lo sviluppo lungo tutto il XIX secolo. In particolare abbiamo messo in luce il colpo di genio di questa ideologia : la separazione tra la struttura economica del liberalismo e i suoi contenuti morali e intellettuali. Il sindacalismo rivoluzionario di George Sorel catturò la mia attenzione fin da quando ero studente tanto che scrissi un paper su Sorel e Tocqueville per il corso di Jacob Talmon, l’autore del fondamentale studio sul totalitarismo. Nel XIX secolo la divaricazione tra liberalismo e democrazia si era considerevolmente ridotta e verso il 1880 si era praticamente chiusa. Fu in quel momento che Sorel e i sindacalisti rivoluzionari compresero che le due dimensioni potevano essere separate, accettando l’una e rigettando l’altra. Questa fu l’impostazione originale e geniale del fascismo.
 L’ideologia fascista è nata da un’ideologia anti-razionalista, anti-materialista, anti-marxista e da un nazionalismo radicale preesistente. Tutti i fondamenti del nazionalismo organico, cioè il culto dei morti e la venerazione della tradizione, esistevano già nella destra radicale francese, e anche in Ernest Renan. Di Renan si ricorda spesso la sua immagine della nazione come «plebiscito quotidiano» ma per Renan la nazione è un’entità organica.
L’ideologia fascista è nata da un’ideologia anti-razionalista, anti-materialista, anti-marxista e da un nazionalismo radicale preesistente. Tutti i fondamenti del nazionalismo organico, cioè il culto dei morti e la venerazione della tradizione, esistevano già nella destra radicale francese, e anche in Ernest Renan. Di Renan si ricorda spesso la sua immagine della nazione come «plebiscito quotidiano» ma per Renan la nazione è un’entità organica.
 Quest’idea esisteva già in Johann Gottfried Herder. Quindi l’idea che la nazione fosse un organismo vivente non è un’invenzione italiana in quanto era già presente in una tradizione che va da Herder a Renan ; e Barrès la confeziona in una versione moderna che poi gli italiani adottano perché fa parte della loro stessa cultura. Quindi il nazionalismo storico, radicale e organico, unito alla venerazione degli antenati seppelliti nel proprio suolo e al richiamo al «Blut und Boden» (sangue e terra), da un lato, e la revisione anti-razionale e antimaterialista del marxismo avviata da Sorel, dall’altro, accomunati entrambi dall’idea che la violenza sia uno strumento necessario per il cambiamento dell’ordine sociale, diventano i principali ingredienti del fascismo. I sindacalisti rivoluzionari soreliani rifiutavano l’ordine esistente e volevano cambiarlo con la forza e la violenza. Se questa forza rivoluzionaria non può più essere fatta da una classe - il proletariato - può essere condotta da tutte le classi e dalla nazione intera. Questa è la situazione alla vigilia della prima guerra mondiale.
Quest’idea esisteva già in Johann Gottfried Herder. Quindi l’idea che la nazione fosse un organismo vivente non è un’invenzione italiana in quanto era già presente in una tradizione che va da Herder a Renan ; e Barrès la confeziona in una versione moderna che poi gli italiani adottano perché fa parte della loro stessa cultura. Quindi il nazionalismo storico, radicale e organico, unito alla venerazione degli antenati seppelliti nel proprio suolo e al richiamo al «Blut und Boden» (sangue e terra), da un lato, e la revisione anti-razionale e antimaterialista del marxismo avviata da Sorel, dall’altro, accomunati entrambi dall’idea che la violenza sia uno strumento necessario per il cambiamento dell’ordine sociale, diventano i principali ingredienti del fascismo. I sindacalisti rivoluzionari soreliani rifiutavano l’ordine esistente e volevano cambiarlo con la forza e la violenza. Se questa forza rivoluzionaria non può più essere fatta da una classe - il proletariato - può essere condotta da tutte le classi e dalla nazione intera. Questa è la situazione alla vigilia della prima guerra mondiale.C’è allora un rapporto diretto tra la prima guerra mondiale e il fascismo?
Mussolini durante la guerra integrò tutti gli elementi nazionalisti dandogli forza politica. Ne La naissance de l’ideologie fasciste dimostriamo come questa ideologia esistesse già prima della prima guerra mondiale. E quindi il fascismo non è una conseguenza diretta della grande guerra. La nostra interpretazione non è condivisa da vari studiosi ; anche George Mosse, che pure ha attribuito molta importanza alla prima guerra mondiale, non concorda con la nostra impostazione e cioè che il fascismo esisteva, nella sua essenza, già prima della grande guerra.
 Il conflitto rese possibile il passaggio dal regno delle idee all’azione politica concreta. Inoltre, a nostro avviso, il fascismo non è un fenomeno limitato al periodo tra le due guerre e non è certo finito dopo il 1945. Non c’è alcun valido motivo « metodologico » per sostenere che l’ideologia del fascismo si sia esaurita con l’esecuzione di Mussolini o con il suicidio di Hitler. Infine il fascismo può essere considerato il miglior prisma per studiare l’evoluzione della politica europea nel XX secolo, molto meglio del nazismo. Il fascismo fu una guerra contro la modernità razionalista universalista e contro il diritto naturale e i diritti umani : in una parola contro l’Illuminismo. Il nazismo fu invece una guerra contro l’umanità.
Il conflitto rese possibile il passaggio dal regno delle idee all’azione politica concreta. Inoltre, a nostro avviso, il fascismo non è un fenomeno limitato al periodo tra le due guerre e non è certo finito dopo il 1945. Non c’è alcun valido motivo « metodologico » per sostenere che l’ideologia del fascismo si sia esaurita con l’esecuzione di Mussolini o con il suicidio di Hitler. Infine il fascismo può essere considerato il miglior prisma per studiare l’evoluzione della politica europea nel XX secolo, molto meglio del nazismo. Il fascismo fu una guerra contro la modernità razionalista universalista e contro il diritto naturale e i diritti umani : in una parola contro l’Illuminismo. Il nazismo fu invece una guerra contro l’umanità.In che misura l’antisemitismo ha indirizzato il tuo interesse verso lo studio del fascismo?
Quando incominciai le mie ricerche non immaginavo quanto fosse forte l’antisemitismo nella Francia del 1880 e nemmeno quanto lo fosse nel periodo tra le due guerre. In particolare mi chiesi perché le leggi razziali francesi promulgate nell’estate del 1940 fossero più rigide di quelle italiane e addirittura delle leggi naziste di Norimberga. Il destino degli ebrei costituisce una cartina di tornasole per comprendere questa posizione. Vale a dire, la rivoluzione francese rese liberi sia gli ebrei che gli schiavi neri sulla base dei principi della Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, principi che si fondavano sui diritti umani e che stabilivano che la nazione era composta da tutte le persone che vivevano in un determinato territorio ed erano governati da un solo governo.
 E questo era tutto. Non c’era nulla che riguardasse la storia o la religione. Il principio era politico e giuridico, e si basava sul valore dell’uguaglianza. Quindi, dato che il regime di Vichy rigettava i principi della rivoluzione francese e di conseguenza l’Illuminismo, l’eliminazione delle leggi di emancipazione degli ebrei costituivano il passaggio più significativo. Del resto, sin dalla fine dell’Ottocento l’antisemitismo incominciò ad essere usato come un’arma politica contro l’Illuminismo. Questa è la ragione per cui mi sono interessato alle vicende degli ebrei e all’antisemitismo. C’è comunque una differenza tra fascismo e nazismo su questo punto. Nel fascismo l’antisemitismo è uno strumento per una battaglia anti-illuminista, nel nazismo è un obiettivo in sé stesso. Il fascismo può usare antisemitismo a diverse gradazioni e consentire che anche gli ebrei siano fascisti, mentre non era immaginabile che anche un ebreo potesse essere nazista.
E questo era tutto. Non c’era nulla che riguardasse la storia o la religione. Il principio era politico e giuridico, e si basava sul valore dell’uguaglianza. Quindi, dato che il regime di Vichy rigettava i principi della rivoluzione francese e di conseguenza l’Illuminismo, l’eliminazione delle leggi di emancipazione degli ebrei costituivano il passaggio più significativo. Del resto, sin dalla fine dell’Ottocento l’antisemitismo incominciò ad essere usato come un’arma politica contro l’Illuminismo. Questa è la ragione per cui mi sono interessato alle vicende degli ebrei e all’antisemitismo. C’è comunque una differenza tra fascismo e nazismo su questo punto. Nel fascismo l’antisemitismo è uno strumento per una battaglia anti-illuminista, nel nazismo è un obiettivo in sé stesso. Il fascismo può usare antisemitismo a diverse gradazioni e consentire che anche gli ebrei siano fascisti, mentre non era immaginabile che anche un ebreo potesse essere nazista.E veniamo ora al tuo libro più discusso, «Ni droite, ni gauche. L’idéologie fasciste en France», del 1983
Questo lavoro prosegue la linea di ricerca de La droite révolutionaire. È soprattutto un lavoro di storia delle idee e di quanto le élite intellettuali influenzarono l’opinione pubblica e la politica francesi. La sua pubblicazione ha suscitato grande scalpore e parecchie polemiche in Francia. Credo che questo sia addebitabile a tre aspetti. Il primo è che dimostrava ancora più chiaramente che nei lavori precedenti che il fascismo non è una imitazione del fascismo italiano bensì è un prodotto originale francese. In secondo luogo mostra la profondità e la presa del fascismo nella società francese e soprattutto nella sua élite intellettuale. In terzo luogo sottolinea il ruolo del regime di Vichy. Questi tre fattori crearono molto sconcerto in Francia, soprattutto la questione di Vichy. Il regime di Vichy non era conservatore bensì rivoluzionario e fascista, tant’è che ruppe con centocinquant’anni di storia francese. All’epoca fu difficile per i francesi accettare queste interpretazioni di Vichy anche se poi divenne chiaro che era una questione generazionale in quanto gli intellettuali di una generazione più giovane sostennero sostanzialmente questa interpretazione e inaugurarono un nuovo filone di ricerca sul tema.
Tutto quanto abbiamo discusso fin qui conduce al tuo ultimo lavoro, quello dedicato all’anti-Illuminismo, «Les anti-Lumières. Du XVIII siècle à la guerre froide» (2006). Come si connette con i tuoi lavori precedenti? E come sei arrivato a quest’opera?
Immagina uno che salendo una scala, gradualmente allarga il proprio orizzonte. In questi - orami lunghi - anni di studio mi sono imbattuto in tutta una serie di opposizioni all’illuminismo. Leggendo Barrès scoprii che in un suo romanzo, Les déracinés, descrive, con un riferimento biografico, come un insegnante sradichi i propri studenti dalla loro cultura originaria e dal loro ancoraggio alla terra trasformandoli, appunto, in déracinés. L’insegnante era professore di filosofia ed era un kantiano: insegnava l’«imperativo categorico» del filosofo di Könisberg che per Barrès rappresentava la «grande calamità» della cultura francese.
 Ma ancora prima di Barrès, nel mio libro sottolineo come la più solida costruzione filosofico alternativa all’Illuminismo viene da Herder. Nel suo primo pamphlet, pubblicato nel 1774, ci sono tutti gli argomenti che saranno sviluppati in seguito : l’alternativa al razionalismo alla concezione giuridico-politica della nazione, al concetto kantiano dell’autonomia dell’individuo. Solo alcuni anni più tardi, dopo che Herder pubblica il suo grande libro Idee per la filosofia della storia dell’umanità (1774-1791), Kant reagisce scrivendo una risposta ferocemente critica del lavoro di Herder. Questo scontro può essere interpretato come l’inizio del conflitto tra la tradizione razionalista kantiana-rousseouiana e la « seconda modernità », quella anti-razionalista.
Ma ancora prima di Barrès, nel mio libro sottolineo come la più solida costruzione filosofico alternativa all’Illuminismo viene da Herder. Nel suo primo pamphlet, pubblicato nel 1774, ci sono tutti gli argomenti che saranno sviluppati in seguito : l’alternativa al razionalismo alla concezione giuridico-politica della nazione, al concetto kantiano dell’autonomia dell’individuo. Solo alcuni anni più tardi, dopo che Herder pubblica il suo grande libro Idee per la filosofia della storia dell’umanità (1774-1791), Kant reagisce scrivendo una risposta ferocemente critica del lavoro di Herder. Questo scontro può essere interpretato come l’inizio del conflitto tra la tradizione razionalista kantiana-rousseouiana e la « seconda modernità », quella anti-razionalista.
 Ho utilizzato questa chiave interpretativa per analizzare tutta la storia europea dell’Ottocento e del Novecento. Sono partito da Herder perché lo considero il vero capostipite di questa tradizione e perché il filosofo tedesco ha influenzato in maniera «insospettabile» molti anti-illuministi da Jules Michelet a Edgard Quinet a, persino, Isaiah Berlin. In particolare mi sono concentrato nel rintracciare la sua influenza e i rapporti incrociati tra i vari autori nel tempo per scoprire quanto delle iniziali critiche anti-illuministe venissero poi riprese e rilanciate nel corso degli ultimi due secoli.
Ho utilizzato questa chiave interpretativa per analizzare tutta la storia europea dell’Ottocento e del Novecento. Sono partito da Herder perché lo considero il vero capostipite di questa tradizione e perché il filosofo tedesco ha influenzato in maniera «insospettabile» molti anti-illuministi da Jules Michelet a Edgard Quinet a, persino, Isaiah Berlin. In particolare mi sono concentrato nel rintracciare la sua influenza e i rapporti incrociati tra i vari autori nel tempo per scoprire quanto delle iniziali critiche anti-illuministe venissero poi riprese e rilanciate nel corso degli ultimi due secoli.- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> ISRAELE: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. --- INTERVISTA A ZEEV STERNHELL. In ricordo (di Redazione "Il Mulino").23 giugno 2020, di Federico La Sala
- CONTINUAZIONE E FINE DEL POST PRECEDENTE
In ricordo di Zeev Sternhell di Redazione "Il Mulino" *
-*** Riproponiamo l’intervista di Mario Snajder a Zeev Sternhell, lo storico e scienziato della politica israeliano scomparso oggi [21 giugno 2020].
[...]
Di recente hai scritto un importante lavoro sulla nascita dello Stato israeliano «Nascita d’Israele. Miti, storia, contraddizioni». Come è nato? E come si collega con gli altri tuoi lavori?
Qui c’è un aspetto autobiografico. Quando giunsi in Israele, nel 1951, sentivo sempre parlare di socialismo israeliano. Ma non capivo di che socialismo si trattasse. Non capivo il concetto di comunità di lavoro. Quando andavo a scuola vedevo i contadini della comunità di Magdiel (una delle prime quattro comunità di lavoro ebraiche, moshavot, fondate nel 1924) che andavano a lavorare molto presto alla mattina. Poi, oltre ai contadini proprietari, c’erano anche dei lavoratori salariati che lavoravano altrettanto duramente ma non erano considerati sullo stesso piano. Io non capivo la differenza tra questi due gruppi. Per me erano entrambi dei coloni lavoratori. Il punto è che il kibbutz originariamente era stato concepito anche come un’entità politica dove realizzare gli ideali socialisti. Infatti, quando dopo la guerra arrivarono nuove ondate di immigrati, nei kibbutz si discuteva sull’importanza del lavoro indipendente e autonomo, senza assumere forza lavoro dall’esterno. Eppure, al di là della fedeltà al principio teorico-ideologico socialista del non-sfruttamento c’era la necessità di dar lavoro ai nuovi arrivati. Inoltre, il lavoro è un grande fattore di integrazione.
Nel mio lavoro, che copre il periodo dal 1905 - inizio della seconda immigrazione sionista - al 1948 - fondazione dello Stato di Israele - analizzo le vicende della Confederazione del lavoro, l’Histadrut (che dispone di un immenso archivio, degno di una grande organizzazione burocratica qual era) e poi del partito laburista, il Mapai. Entrambi parlavano di socialismo : ma che tipo di socialismo avevano in mente ? Il socialismo era nel kibbutz, che voleva essere una società socialista esemplare. Ma fuori, la società non era diversa da quella borghese ; in più, era anche povera.
Il mio interrogativo centrale si rivolgeva al rapporto tra socialismo e nazionalismo. Da un lato volevano costruire una società ebraica che eventualmente avrebbe potuto costituirsi come Stato, e dall’altro volevano costruire una società giusta, egualitaria e democratica. Ma non riuscirono a mantenere un equilibrio tra i principi del nazionalismo che sono particolari e quelli del socialismo che sono universali. La costruzione dello Stato e la conquista dell’indipendenza si scontrarono con i principi del socialismo. Aaron David Gordon, il pensatore sionista e protosocialista di inizio secolo, diede un significato classico della nazione seguendo l’impostazione organicista e nazionalista. Per Gordon è la nazione che crea l’individuo, la cultura e il linguaggio. Intervenendo dal proprio kibbutz, Degania, il primo ad essere fondato, Gordon sosteneva che i lavoratori ebrei vogliono unirsi con gli ebrei borghesi, e non con i lavoratori di un altro Paese. Non pensava di modificare l’ordine sociale esistente. Non c’era alcuna intenzione di rompere con il capitalismo. La lotta di classe non era prevista mentre, al contrario, la cooperazione tra le classi era considerata necessaria per la costruzione della nazione. E infatti, negli anni Venti e Trenta si stringe un’alleanza tra il partito socialista e la borghesia. I sindacati non lottano per un mutamento sociale e, in sostanza, accettano il capitalismo mentre la borghesia « rinuncia » a esercitare direttamente il potere politico lasciando spazio ai laburisti. Ad esempio, Ben Gurion fin dall’inizio degli anni Trenta cerca di eliminare le scuole operaie gestite dall’Histadrut (ci riuscirà completamente solo negli anni Cinquanta quando verrà creato un sistema educativo statale). I sostenitori del progetto « nuova educazione », tutti giovani immigrati dall’Unione Sovietica, volevano scardinare l’impostazione esistente e creare una educazione libera che forgiasse bambini autonomi e consapevoli. Costoro vennero però emarginati e indirizzati in kibbutz dove potevano mettere in atto i loro esperimenti.
Ma che interpretazione dai del kibbutz?
Pensiamo a duecento giovani donne e uomini che sbarcano da una nave a Jaffa o ad Haifa e si disperdono nel Paese. Duecento persone come queste quando fondano un kibbutz e prendono possesso della terra diventano un vero e proprio corpo combattente. Il kibbutz diviene una postazione militare. Moltiplichiamo questi duecento per dieci, quindici o venti e si ha il controllo della Galilea, della Valle del Giordano, e di altre aree strategiche. In realtà il kibbutz fu uno strumento per la conquista del territorio e per la nascita del Paese ; non fu uno strumento per il cambiamento dell’ordine sociale. L’unico tentativo per riprodurre il kibbutz fu quello del «battaglione del lavoro» - Gdud Ha’Avoda - che però venne presto eliminato da Ben Gurion il quale voleva mantenere il ruolo centrale dell’Histadrut.
 Un altro progetto egualitario fallì quasi subito. Negli anni Trenta, quando la situazione economica migliorò, venne introdotto il salario famigliare per finanziare soprattutto le spese mediche e di istruzione. Quest’idea egualitaria venne però abolita poco dopo la nascita di Israele. E questo comportò anche l’abbandono di ogni ipotesi di modifica del sistema capitalistico. Allo stesso tempo si rinunciò anche all’idea di una cooperazione tra i lavoratori arabi e quelli ebrei. Questo problema creava una forte conflittualità tra i vecchi insediamenti ebraici in Galilea che impiegavano forza lavoro araba e quelli nuovi, della quarta immigrazione, che impiegavano solo manodopera ebraica. I leader sindacali rinunciarono presto all’egualitarismo perché questo confliggeva con gli interessi nazionali. Il socialismo era concepito per favorire la costruzione dello Stato e della nazione. Il sindacato si identificava con i lavoratori ebraici della terra di Israele e quindi la collaborazione con gli arabi era praticamente inconcepibile. Del resto, nel 1922, lo stesso Ben Gurion disse che erano arrivati in Palestina non per organizzare qualcuno ma per conquistare la terra. Tutto era indirizzato all’obiettivo fondamentale, la costruzione dello Stato e della nazione.
Un altro progetto egualitario fallì quasi subito. Negli anni Trenta, quando la situazione economica migliorò, venne introdotto il salario famigliare per finanziare soprattutto le spese mediche e di istruzione. Quest’idea egualitaria venne però abolita poco dopo la nascita di Israele. E questo comportò anche l’abbandono di ogni ipotesi di modifica del sistema capitalistico. Allo stesso tempo si rinunciò anche all’idea di una cooperazione tra i lavoratori arabi e quelli ebrei. Questo problema creava una forte conflittualità tra i vecchi insediamenti ebraici in Galilea che impiegavano forza lavoro araba e quelli nuovi, della quarta immigrazione, che impiegavano solo manodopera ebraica. I leader sindacali rinunciarono presto all’egualitarismo perché questo confliggeva con gli interessi nazionali. Il socialismo era concepito per favorire la costruzione dello Stato e della nazione. Il sindacato si identificava con i lavoratori ebraici della terra di Israele e quindi la collaborazione con gli arabi era praticamente inconcepibile. Del resto, nel 1922, lo stesso Ben Gurion disse che erano arrivati in Palestina non per organizzare qualcuno ma per conquistare la terra. Tutto era indirizzato all’obiettivo fondamentale, la costruzione dello Stato e della nazione.Come vedi il futuro dello Stato di Israele?
Nella mia opinione l’acquisizione e occupazione delle terre fino al 1948 fu legittima in quanto necessaria : era una questione di sopravvivenza. Gli ebrei avevano bisogno di un pezzo di terra in cui andare a vivere. Del resto nessuno li voleva. Dopo la seconda guerra mondiale c’erano trecentomila rifugiati ebrei che non sapevano dove andare. Per questo non ho mai avuto nessun dubbio sulla legittimità del sionismo fino alla nascita dello Stato di Israele ; per questo penso che tutto quello che è stato fatto fino al 1949 fosse giusto, nonostante la Nakbah e l’espulsione degli arabi-palestinesi : era un’esigenza vitale.
 Ma allo stesso tempo credo che tutto quello che è stato fatto dopo il 1967 non sia stato né legittimo né giusto perché non riguardava alcun interesse vitale. Tra il 1949 e il 1967 fu chiaro che tutti gli obiettivi del sionismo potevano essere raggiunti all’interno dei confini di allora (la « Linea Verde »). In precedenza, invece, vi era stata una situazione di guerra più o meno continua tra ebrei e arabi.
Ma allo stesso tempo credo che tutto quello che è stato fatto dopo il 1967 non sia stato né legittimo né giusto perché non riguardava alcun interesse vitale. Tra il 1949 e il 1967 fu chiaro che tutti gli obiettivi del sionismo potevano essere raggiunti all’interno dei confini di allora (la « Linea Verde »). In precedenza, invece, vi era stata una situazione di guerra più o meno continua tra ebrei e arabi.
 Gli insediamenti impiantatisi al di là della Linea Verde dopo il 1967 sono la più grande catastrofe nella storia del sionismo perché hanno creato una situazione coloniale. Hanno creato proprio quella situazione che il sionismo voleva evitare. In un certo senso la divisione tra lavoratori arabi ed ebrei lastricava la strada verso il colonialismo, e questo fu chiaro dopo il 1967. Pur tenendo conto di tutti i disagi inflitti agli arabi-palestinesi il sionismo salvò più di mezzo milione di ebrei che, se non avessero abbandonato l’Europa, non sarebbero sopravvissuti. Il sionismo però, a mio avviso, si fonda sui diritti naturali dei popoli all’autodeterminazione e all’autogoverno. Ne consegue che questi diritti sono anche propri dei palestinesi. Per questo il sionismo ha diritto di esistere solo se riconosce i diritti dei palestinesi.
Gli insediamenti impiantatisi al di là della Linea Verde dopo il 1967 sono la più grande catastrofe nella storia del sionismo perché hanno creato una situazione coloniale. Hanno creato proprio quella situazione che il sionismo voleva evitare. In un certo senso la divisione tra lavoratori arabi ed ebrei lastricava la strada verso il colonialismo, e questo fu chiaro dopo il 1967. Pur tenendo conto di tutti i disagi inflitti agli arabi-palestinesi il sionismo salvò più di mezzo milione di ebrei che, se non avessero abbandonato l’Europa, non sarebbero sopravvissuti. Il sionismo però, a mio avviso, si fonda sui diritti naturali dei popoli all’autodeterminazione e all’autogoverno. Ne consegue che questi diritti sono anche propri dei palestinesi. Per questo il sionismo ha diritto di esistere solo se riconosce i diritti dei palestinesi.
 Chi vuole precludere ai palestinesi l’esercizio di tali diritti non può rivendicarli per sé stesso soltanto. Tutto ciò deve essere messo in pratica e richiede una visione liberale della nazione che non siè mai realizzata praticamente da nessuna parte. I diritti nazionali sono un’estensione dei diritti individuali e per questo sono universali : i diritti degli israeliani non sono differenti da quelli dei palestinesi.
Chi vuole precludere ai palestinesi l’esercizio di tali diritti non può rivendicarli per sé stesso soltanto. Tutto ciò deve essere messo in pratica e richiede una visione liberale della nazione che non siè mai realizzata praticamente da nessuna parte. I diritti nazionali sono un’estensione dei diritti individuali e per questo sono universali : i diritti degli israeliani non sono differenti da quelli dei palestinesi.
 Per questa ragione gli insediamenti devono fermarsi e l’unica soluzione logica sia per gli ebrei che per gli arabi è quella di due Paesi per due popoli. L’ipotesi di un unico Stato non solo porta all’eliminazione dello Stato ebraico ma apre la strada a conflitti sanguinosi per generazioni. Due Paesi, fianco a fianco, fondati su uguali diritti per entrambi i popoli, questa è la strada giusta e necessaria : ogni altra scelta condurrebbe o al colonialismo o alla eliminazione di Israele in uno Stato binazionale.
Per questa ragione gli insediamenti devono fermarsi e l’unica soluzione logica sia per gli ebrei che per gli arabi è quella di due Paesi per due popoli. L’ipotesi di un unico Stato non solo porta all’eliminazione dello Stato ebraico ma apre la strada a conflitti sanguinosi per generazioni. Due Paesi, fianco a fianco, fondati su uguali diritti per entrambi i popoli, questa è la strada giusta e necessaria : ogni altra scelta condurrebbe o al colonialismo o alla eliminazione di Israele in uno Stato binazionale.*[Da "il Mulino", n. 1/10, Doi : 10.1402/31091, Copyright © 2010 by Società editrice il Mulino, Bologna: qui è possibile scaricare il pdf, completo dell’introduzione]
-
> RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. --- «Le tre fughe di Hannah Arendt» di Krim Krimstein (di Alessandro Dal Lago).21 gennaio 2020, di Federico La Sala
HANNAH ARENDT E MARTIN HEIDEGGER: VITA E FILOSOFIA. IL PROBLEMA DELLA NASCITA... *
Arendt, sempre al di là del dove, e ora stretta in una striscia
Questioni tedesche/Graphic. Dall’infanzia prussiana, all’università con Strauss, Löwith, Marcuse, Lévinas, alla bohème berlinese, all’esilio parigino, a N.Y. «Le tre fughe di Hannah Arendt» di Krim Krimstein, da Guanda
di Alessandro Dal Lago (il manifesto, Alias Domenica, 13.10.2019)
Nell’opinione comune, i filosofi sono gente reclusa in studi foderati di libri e priva, in sostanza, di biografia e accessi al mondo. Fu Hannah Arendt, per esempio a citare una frase di Heidegger su Aristotele, secondo cui lo stagirita «visse, lavorò e morì». L’immagine del filosofo come essere estraneo alla vita e alla realtà è stata formata nell’Ottocento da un libretto divertente e maligno di Thomas de Quincey, Gli ultimi giorni di Immanuel Kant, in cui il gran saggio è mostrato come un vecchio un po’ rimbambito che vaga per le vie di Königsberg e si sbrodola a tavola.
In realtà, un buon numero di pensatori ebbe una vita turbolenta e attiva. Pitagora esaltava le pratiche sportive e Platone, oltre che essere esperto di lotta, tentò a più riprese di influenzare il governo di Siracusa, per essere infine venduto come schiavo dal vendicativo tiranno Dionisio il vecchio, con cui era entrato in conflitto. Quanto a Cartesio, si sa che prima di chiudersi in una capanna a meditare sul cogito era stato soldato nella guerra dei trent’anni. E non parliamo di Leibniz, matematico, diplomatico ed esperto di miniere, o di Voltaire che corrispondeva con i principi di tutta Europa e interveniva pubblicamente contro la tortura e la pena di morte.
La rinuncia alla filosofia
È forse pensando alla leggenda grigia dei filosofi maldestri e appartati che il cartoonist Krim Krimstein ha dedicato una storia a fumetti o graphic novel a Hannah Arendt, la filosofa che meno corrisponde all’immagine del pensiero solitario ed estraneo al mondo. In Le tre fughe di Hannah Arendt. La tirannia della verità (traduzione di Antonella Bisogno, Guanda, pp. 233, e 20,00) Krimstein realizza il singolare tentativo di fondere la biografia di Arendt con il suo pensiero. L’aspetto più interessante in questa vicenda è l’estraneità di Arendt alla filosofia in senso stretto. Come si legge nel prologo («Umano troppo umano. Introduzione a una vita»): «Come mai questa persona, probabilmente la più grande filosofa del ventesimo secolo, ha rinunciato alla filosofia, e, nonostante questo, il suo pensiero rimane per l’umanità una via praticabile per progredire?».
La domanda rimane senza risposta, nel romanzo a fumetti, e non poteva essere diversamente. Dagli anni Ottanta in poi, la critica, in centinaia di libri e saggi, si è sbizzarrita sulla questione, cercando la soluzione nel tormentato romance di Arendt con Heidegger, il filosofo che cedette al nazismo, nell’incapacità della filosofia contemporanea di pensare la politica e, spiegazione che mi sembra la più ragionevole, in una personalità poliedrica, che cercava la spiegazione dei problemi che la assillavano nella filosofia, certamente, ma anche nella teoria politica, nella storia, nella letteratura e nella poesia. Più che rinunciare alla filosofia, come certamente la stessa Arendt ha affermato, si può dire che la nostra filosofa si sentiva stretta nella galleria soffocante di pensatori accademici, che pure aveva frequentato e variamente apprezzato, da Husserl a Jaspers e allo stesso Heidegger.
Krimstein riversa in immagini la storia di questo personaggio eccentrico, sempre al di là di dove si cerca di fissarla: ebrea, ma affascinata dal pensiero cristiano, allieva dei tre massimi pensatori di area tedesca, ma soprattutto affine al cugino acquisito Walter Benjamin, l’irregolare per eccellenza, attratta dalla dimensione della politica, ma impossibile da classificare in uno schieramento (anarchica e per certi versi tradizionalista, aristocratica e profondamente democratica, sionista in gioventù e critica di Israele e così via).
Tutta questa complessità, d’altronde era giù iscritta nella biografia, che la vede intellettuale a Berlino e studentessa di filosofia a Marburg, perseguitata dai nazisti e fuggiasca in Francia, esule negli Stati Uniti, accademica onorata e infine rigettata dagli intellettuali ebrei e ignorata dagli amici per avere scritto in modo non convenzionale e assai penetrante del processo a Eichmann nel 1961.
Pensatrice fuggiasca per definizione, può Arendt essere inquadrata in modo appropriato da un romanzo a fumetti? Come può il suo pensiero paradossale, ovvero la supremazia dell’azione rispetto al pensiero, che appare nelle sue opere fondamentali (Vita activa e La vita della mente), essere tradotto in vignette?
 Krimstein sceglie di privilegiare la biografia rispetto alla teoria, come è inevitabile. E così ci scorrono davanti le immagini dell’infanzia in Prussia, dell’università - in cui frequentò compagni destinati a diventare famosi (Leo Strauss, Karl Löwith, Herbert Marcuse, Emmanuel Lévinas), della bohème berlinese, dell’esilio parigino, della vita intellettuale di New York e infine della solitudine che precedette la morte. Ecco allora che, attraverso la vita di questa filosofa per certi versi inafferrabile, un pezzo di Novecento, con le sue tragedie immani e le sue illusioni scorre davanti agli occhi (si spera) di gente giovane, curiosa e insoddisfatta delle categorie e dei pregiudizi dell’opinione corrente.
Krimstein sceglie di privilegiare la biografia rispetto alla teoria, come è inevitabile. E così ci scorrono davanti le immagini dell’infanzia in Prussia, dell’università - in cui frequentò compagni destinati a diventare famosi (Leo Strauss, Karl Löwith, Herbert Marcuse, Emmanuel Lévinas), della bohème berlinese, dell’esilio parigino, della vita intellettuale di New York e infine della solitudine che precedette la morte. Ecco allora che, attraverso la vita di questa filosofa per certi versi inafferrabile, un pezzo di Novecento, con le sue tragedie immani e le sue illusioni scorre davanti agli occhi (si spera) di gente giovane, curiosa e insoddisfatta delle categorie e dei pregiudizi dell’opinione corrente.Tra le lenzuola di Heidegger
Resta, nell’operazione di Krimstein, qualcosa che probabilmente Arendt non avrebbe troppo apprezzato, e cioè il rilievo eccessivo attribuito alla sua vita intima e sentimentale. Se c’è un aspetto sul quale Arendt rompe con quasi tutta la filosofia del Novecento è la sua critica radicale dell’interiorità. In Vita activa, appare quasi un gesto di disprezzo nei confronti di una certa filosofia, che pretende di chiudersi nella contemplazione della vita soggettiva e dell’anima, invece che del mondo. In questo Arendt si distacca radicalmente dalla fenomenologia e dal suo amato Agostino (Noli foras ire! In interiore homine habitat veritas). Forse Krimstein avrebbe dovuto rammentarlo mentre si accingeva a disegnare Arendt e Heidegger che si scambiano effusioni a letto discettando di morte e verità...
Ma non dovremmo fargliene una colpa. A un periodo di critica, giusta o sbagliata, aspra o apologetica, del pensiero di Arendt è seguita una serie di libri che, in nome della verità biografica, si soffermano sulla sua relazione con Heidegger, ai limiti del gossip filosofico. È mettendo da parte questo genere letterario francamente scadente che il discorso su Arendt può ripartire.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"LA VITA DELLA MENTE. Conclusioni" (H. ARENDT): AUGUSTO, LA SIBILLA TIBURTINA, E LA "MADONNA DI FOLIGNO"
"NICODEMO O DELLA NASCITA": LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI).
VITA E FILOSOFIA: METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PIER ALDO ROVATTI INCONTRA ELVIO FACHINELLI.
Federico La Sala
-
> FARE CHIAREZZA --- Fania Oz: «L’ascolto cambia il mondo». Parla la storica israeliana: «Oggi la solidarietà è ancora viva, ma l’Europa ha il dovere di impedire che siano messi in discussione i valori fondamentali». Intervista.22 maggio 2019, di Federico La Sala
LA MEMORIA NELLE PAROLE. PER AMOS OZ.... *
Intervista.Fania Oz: «L’ascolto cambia il mondo»
Parla la storica israeliana: «Oggi la solidarietà è ancora viva, ma l’Europa ha il dovere di impedire che siano messi in discussione i valori fondamentali»
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, mercoledì 22 maggio 2019)
- [Foto] Fania Oz-Salzberger
- La memoria e il possibile è il tema della terza edizione di “Mens-a”, l’evento sui temi dell’ospitalità e del cosmopolitismo che da qui a settembre toccherà Modena, Vignola, Parma e Ravenna.
 Si parte giovedì 24 maggio alle 20,30 dall’Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni 5), con la serata dal titolo “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”, durante la quale l’intervento di Fania Oz-Salzberger si intreccerà con le letture di Alessio Vassallo da Una storia d’amore e di tenebra, capolavoro riconosciuto del grande scrittore israeliano scomparso nei mesi scorsi: la moderazione è affidata all’ebraista Sarah Kaminski.
Si parte giovedì 24 maggio alle 20,30 dall’Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni 5), con la serata dal titolo “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”, durante la quale l’intervento di Fania Oz-Salzberger si intreccerà con le letture di Alessio Vassallo da Una storia d’amore e di tenebra, capolavoro riconosciuto del grande scrittore israeliano scomparso nei mesi scorsi: la moderazione è affidata all’ebraista Sarah Kaminski.
 Tra venerdì e sabato si susseguiranno, sempre a Bologna, gli incontri con monsignor Erio Castellucci, con Benianimo de’ Liguori Caino della Fondazione Olivetti, con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con i filosofi Francesca De Vecchi, Rocco Ronchi e Sergio Givone, con lo psichiatra Eugenio Borgna, con lo studioso di estetica Pietro Montani e con numerosi altri ospiti. Per infomazioni www.mens-a.it.
Tra venerdì e sabato si susseguiranno, sempre a Bologna, gli incontri con monsignor Erio Castellucci, con Benianimo de’ Liguori Caino della Fondazione Olivetti, con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con i filosofi Francesca De Vecchi, Rocco Ronchi e Sergio Givone, con lo psichiatra Eugenio Borgna, con lo studioso di estetica Pietro Montani e con numerosi altri ospiti. Per infomazioni www.mens-a.it.
Fania Oz-Salzberger non ha dubbi: «Le parole possono peggiorare o migliorare il mondo - dice - ma ascoltare gli altri, ascoltarli veramente, può soltanto migliorarlo». È il suo modo di reinterpretare l’eredità ricevuta dal padre, il grande romanziere israeliano Amos Oz, morto a Tel Aviv negli ultimi giorni del 2018. Insieme, alcuni anni fa, avevano scritto un libro illuminante, Gli ebrei e le parole, edito in Italia da Feltrinelli. Ed è proprio sul legame strettissimo fra memoria, linguaggio e destino che la studiosa, docente di Storia delle idee all’Università di Haifa, si soffermerà domani a Bologna durante la lezione inaugurale di Mens-a, l’evento internazionale sul pensiero ospitale e il cosmopolitismo in calendario fino a sabato. «Ma c’è un’altra parola che aggiungerei alla lista», osserva Fania Oz-Salzberger.
Quale?
Verità. Mentre lavoravamo al libro, mio padre e io ci interrogavamo spesso sul suo significato. In che senso, mettiamo, un racconto biblico va considerato “vero”? Abramo e Sara potrebbero anche non essere esistiti, eppure la loro storia ha cambiato il mondo. Anche la verità letteraria non si basa sui fatti: Amleto non è una figura storica, ma attraverso di lui Shakespeare continua a svelarci qualcosa che si annida nella profondità della natura e dell’esperienza umana. “I fatti possono essere i peggiori nemici della verità”, ha dichiarato mio padre. Un racconto d’invenzione riesce a toccarci in maniera molto più autentica e decisiva rispetto alle notizie del telegiornale.
Scopriamo qual è il nostro destino?
Ecco, questo è un termine sul quale ci siamo subito intesi, mio padre e io. Essendo ebrei secolarizzati, siamo sempre stati persuasi che la storia sia un prodotto dell’azione umana e delle circostanze esteriori. Quanto alla memoria, la questione è più complessa: quella personale non coincide con quella storica ed entrambe differiscono da quella letteraria. Tutte insieme, però, cambiano il mondo. I ricordi di mio padre sulla madre, il modo in cui ebrei e palestinesi ricostruiscono il proprio passato, le nostre reminiscenze di lettori ( Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, nella fattispecie, influenzò molto mio padre): ciascuno di questi elementi modifica la relazione che intratteniamo con la famiglia, la tradizione, l’amore, il lutto. Entrano in gioco materiali mentali diversi, un po’ come accade con gli strumenti e i codici simbolici delle varie arti: pittura, musica, scrittura.
Qui entra in scena il linguaggio?
Ogni grande scrittore si nutre della propria lingua madre, che nel caso di mio padre era l’ebraico. Lo amava, ci giocava. In quanto storica, non posso permettermi un atteggiamento così disinvolto, ma ho comunque la facoltà di interrogare la lingua e approfondirne la comprensione. L’ebreo moderno, in questo senso, è stata la più importante startup linguistica del Novecento. Nessun’altra lingua ha avuto uno sviluppo altrettanto rapido, nessun’altra è riuscita a partire dal nulla fino a superare la soglia di dieci milioni di parlanti.
Come è potuto accadere? Grazie alla combinazione di due fattori irripetibili: l’alto livello di alfabetizzazione, specie maschile, e il permanere di una forte tradizione testuale. Ancora adesso, la Bibbia rappresenta una miniera inesauribile di espressioni, e così il Talmud, la poesia ebraica medievale, la letteratura profana. L’ebraico è una delle lingue più vive di oggi e il successo di molti autori contemporanei lo dimostra in modo eloquente.
Ma questo non contrasta con il ritorno del pregiudizio antisemita?
Mio padre amava ripetere che Hitler e Stalin, pur senza volerlo, ci hanno vaccinati contro l’odio razziale e il genocidio, ma che dopo settant’anni l’effetto del trattamento sta cominciando a svanire. L’affievolirsi della memoria risveglia i demoni e l’antisemitismo, come sappiamo, è uno tra i più feroci. Gli ebrei sono minacciati da destra e da sinistra. Da una parte li si identifica in blocco con lo Stato di Israele, giungendo a negare il loro diritto all’esistenza. Dall’altra, si torna ad accusarli di complotti globali e malefatte universali. Ci sono musulmani che si proclamano antisemiti e antisemiti che sono anche islamofobi. La discriminazione non si sposa bene con la logica.
Come si dovrebbe reagire?
Lo dico con chiarezza: è l’ora che l’Europa si prenda le sue responsabilità. A essersi rimessi in marcia, infatti, sono proprio i demoni della storia europea. Decine di migliaia di ebrei stanno lasciano la Francia, la Gran Bretagna e diversi Paesi dell’Est. Questa volta, per fortuna, hanno un posto in cui rifugiarsi, un luogo in cui sentirsi a casa. Ma un’Europa senza ebrei sarebbe ancora Europa?
Che cosa pensa dell’ondata populista?
Il filosofo Isaiah Berlin, che è stato mio maestro a Oxford, distingueva sempre tra nazionalità e nazionalismo. La prima va tranquillamente a braccetto con la democrazia, che il secondo invece non sopporta proprio. I nazionalisti amano l’ethnos, la componente etnica, e disprezzano il demos, perché la declinazione moderna del demos, ossia della cittadinanza nel suo complesso, prevede la compresenza di gruppi etnici tra loro differenti. Vogliono convincerci che nell’era del web la democrazia sia ormai fuori moda e che i social network diano una spinta al populismo, diffondendo l’odio in modo molto più rapido e capillare di quanto accada con l’amore e la solidarietà. Anche mio padre la pensava così. In questo, tra di noi, c’era una certa incomprensione generazionale. Al contrario di lui, io mi servo di internet, interagisco sulle piattaforme sociali e credo fermamente che il populismo vada combattuto dall’interno, contrastando con estrema durezza ogni incitamento all’odio presente in rete. Non abbiamo scelta: internet è una realtà irreversibile, è la piazza nella quale siamo chiamati a esprimerci, è il nostro campo di battaglia.
Anche la solidarietà è a rischio?
Lasci che le parli un po’ dell’impegno dei miei studenti a Lesbo, in Grecia. In questo momento, questo gruppo di giovani israeliani, sia ebrei che arabi, è la più efficace tra le organizzazioni non governative che operano con i rifugiati siriani raccolti sull’isola. Sono molto fiera di loro. Insieme con milioni di altre brave persone attive in tutto il mondo, dimostrano che ancora oggi amore e compassione sono più vivi e vitali che mai. Il problema è che troppo spesso il loro lavoro non viene percepito, perché è meno facile da twittare rispetto al razzismo e su Instagram risulta meno attraente di un’ereditiera viziata. Ma non possiamo dimenticare che l’attuale crisi dei migranti in Europa non deriva solo dal razzismo, ma anche da decisioni politiche inadeguate. Per accogliere milioni di persone non è sufficiente spendere qualche bella parola e neppure un bel mucchio di soldi. Occorre un serio lavoro sul campo, specie nella sensibilizzazione dei nuovi arrivati e degli abitanti di ciascun Paese, che devono essere messi in grado di capire quali valori vadano preservati e quali criteri di giustizia economico-sociale vadano rispettati. Si tratta di una transizione enorme, che purtroppo la maggioranza dei Paesi europei non ha saputo governare, accontentandosi di discorsi zuccherosi e di proclami solenni.
A che cosa si riferisce?
Trovo inaccettabile che, in nome del rispetto tra le culture, il ruolo della donna possa essere sminuito. E questo vale anche per le aggressioni agli ebrei, vale per la svalutazione dei valori fondamentali di convivenza. Se l’Europa vuole restare fedele a se stessa, deve liberarsi di queste ambiguità.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Palestina, Israele e la rinascita della lingua ebraica....
- ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA]
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. -- Anatomia di una scelta ingiusta. Così Israele spezza l’uguaglianza (di David Grossman).3 agosto 2018, di Federico La Sala
Anatomia di una scelta ingiusta
Così Israele spezza l’uguaglianza
di David Grossman (la Repubblica, 03.08.2018)
Il potenziale di divisione e di distruzione contenuto nella legge che proclama Israele stato-nazione del popolo ebraico salta talmente all’occhio che l’ostinazione del Primo ministro a non introdurre nessun emendamento alla suddetta legge risveglia il sospetto che vi sia un’intenzione nascosta: quella di voler mantenere aperta la ferita dei rapporti tra Stato e minoranza araba. Una ferita infiammata e minacciosa. Da cosa potrebbe derivare l’intenzione di Netanyahu? Perché il governo e chi lo guida vorrebbero una cosa simile? Possiamo solo immaginarlo. Forse perché una minoranza con una ferita aperta è più vulnerabile e più facile a manipolazioni, a essere sobillata, intimidita, divisa. Forse perché è più propensa a subire una politica di "divide et impera".
È così che si mantiene aperta una ferita: di colpo, con una legge inutile, con la quale Netanyahu e il suo governo hanno fatto mancare la terra sotto ai piedi a un quinto della popolazione. E ancora una volta: perché? Perché possono. Perché sono sicuri che nessuna forza abbia il potere di fermarli.
Perché vogliono che i cittadini arabi di Israele vivano in un costante senso di insicurezza esistenziale. Di incertezza sul futuro. Vogliono che ricordino sempre, in ogni momento, che dipendono dalla buona - o dalla cattiva - volontà del governo. Che la loro presenza qui è condizionata, e in qualsiasi momento potrebbero diventare una presenza invisibile.
E questa legge dice chiaramente un’altra cosa: il Primo ministro israeliano ha deciso di non mettere fine all’occupazione e allo stato di apartheid nei territori palestinesi, bensì il contrario: ha deciso di rinsaldarlo e di spostarlo entro i confini di Israele. In altre parole, questa legge è essenzialmente una rinuncia alla possibilità di porre fine al conflitto con i palestinesi. E per quanto riguarda la "retrocessione" dello status della lingua araba da "ufficiale" a "speciale" decretato dalla legge: un idioma è un mondo intero, una coscienza, un’identità, una cultura. È un canovaccio infinito che tocca i vasi capillari dell’esistenza. Un uomo - un politico - deve avere un’arroganza e una sfrontatezza incredibili per ferire e umiliare, anche soltanto in maniera formale (come si sono giustificati i legislatori) l’idioma di un altro popolo. L’ebraico e l’arabo sono lingue sorelle che si sono intrecciate nel corso della storia.
Milioni di ebrei israeliani hanno succhiato l’arabo col latte materno. Non ci sono parole sufficienti nella lingua ebraica per protestare e strepitare contro lo schiaffo inflitto alla sorella.
Per centinaia e migliaia di anni il popolo ebraico è stato una minoranza nei paesi in cui ha vissuto e questa esperienza ha plasmato la sua identità e ha acuito la sua sensibilità morale.
Ora siamo noi la maggioranza nel nostro Paese e questa è un enorme responsabilità, una grande sfida politica e sociale ma soprattutto umana che ci impone di capire che il comportamento nei confronti di una minoranza è una delle più grandi prove di democrazia. Questa settimana il governo israeliano ha fallito questa prova e il suo fallimento ha sollevato echi in tutto il mondo. In quel mondo che noi accusiamo ripetutamente di discriminare la minoranza ebraica che in esso vive. Sarebbe quindi deplorevole se la locale comunità drusa si accontentasse di ricevere un "compenso" economico o di altro tipo per l’offesa subita dalla legge che riconosce Israele come Stato della nazione ebraica. La situazione che si è creata in seguito alla giustificata ondata di proteste di questa comunità potrebbe essere l’inizio di un processo molto più ampio, con i drusi in prima linea nella lotta per l’uguaglianza di tutte le minoranze musulmane e cristiane in Israele. Il consenso - almeno per il momento - dei leader drusi ad accettare la proposta di Netanyahu di un compenso, dimostra che probabilmente anni di discriminazione e di promesse vuote hanno fatto dimenticare loro il vero sapore di una completa uguaglianza.
Nella torbida realtà israeliana sarebbe bene ricordare che l’uguaglianza non è una specie di "premio" assegnato ai cittadini per i servigi resi al Paese, e nemmeno per aver sacrificato la propria vita. Anche gli ultra-ortodossi che si rifiutano di arruolarsi nell’esercito sono cittadini con pari diritti.
L’uguaglianza è il punto di partenza della cittadinanza, non un suo prodotto. È il terreno su cui la cittadinanza cresce. È anche ciò che permette una rispettosa libertà - la libertà di essere diverso, dissimile dagli altri, eppure uguale, con gli stessi diritti.
Ritengo che le ultime leggi approvate dall’attuale governo siano in buona parte il risultato di un modo distorto di pensare prodotto da cinque decenni di occupazione e di un senso di superiorità etnico creatosi dopo avere sguazzato con entusiasmo in un qualche "noi" farisaico e nazionalista che vuole "buttar fuori di casa" tutto ciò che non ci appartiene - un altro popolo, un’altra religione, una diversa tendenza sessuale.
Ma forse questa legge in realtà ci fa un grosso favore perché mostra a tutti noi, di destra e di sinistra, senza illusioni e senza auto-inganni, a che punto siamo arrivati, dove è precipitato Israele. Forse questa legge darà finalmente una scossa a chi, tra noi, si preoccupa per il proprio Paese, per il suo spirito, la sua umanità, i suoi valori ebraici, democratici e umani.
Non ho dubbi che molte persone, di destra, di sinistra e di centro, oneste e disincantate, siano consapevoli che questa legge è un atto di barbarie e un tradimento dello Stato nei confronti dei suoi cittadini. Netanyahu, come al solito, lo descrive come uno scontro tra destra e sinistra. Ma è uno scontro molto più profondo e fatidico. È una lotta tra chi è disperato e chi invece ancora spera. Tra chi si è arreso alla tentazione del nazionalismo razzista e chi continua a opporvisi e a mantenere nel cuore un’immagine, un’idea, una speranza di come potrebbero essere le cose in un paese normale.
 Traduzione di Alessandra Shomroni
Traduzione di Alessandra Shomroni -
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. -- Gaza (2018). «Un massacro per dire ai palestinesi: la vostra è una resistenza impossibile»19 maggio 2018, di Federico La Sala
Richard Falk: «Un massacro per dire ai palestinesi: la vostra è una resistenza impossibile»
Gaza. Intervista al giurista ed ex relatore speciale delle Nazioni unite: «Tel Aviv vuole convincere il mondo che non esista una soluzione. Ma i popoli ora sanno che la resistenza popolare può supplire all’inferiorità militare: dalla loro parte hanno la superiorità morale e un fine più alto, l’autodeterminazione»
- [Foto] Palestinesi perquisite dall’esercito israeliano nel primo giorno di Ramadan
di Chiara Cruciati (il manifesto, 19.05.2018)
La brutalità della risposta israeliana alla Marcia del Ritorno palestinese di Gaza ha generato uno sdegno che non si vedeva da tempo. Centinaia di manifestazioni in tutto il mondo e inusuali condanne da parte di molti governi. La Lega Araba si è risvegliata dal torpore e chiesto un’indagine internazionale; il Consiglio per i diritti umani dell’Onu ha votato per il lancio di un’inchiesta.
Ne abbiamo discusso con Richard Falk, professore emerito di diritto internazionale alla Princeton University e dal 2008 al 2014 relatore speciale per le Nazioni unite sulla questione palestinese.
In un suo articolo, scritto dopo la strage di Gaza di lunedì scorso, parla di un «nuovo livello di degradazione morale, politica e legale» israeliana. Un “salto di qualità” nell’uso della forza?
Siamo di fronte a un nuovo livello di quella che chiamo alienazione morale, visibile nella normalizzazione dell’uccisione a sangue freddo di manifestanti disarmati, senza nemmeno tentare di usare metodi alternativi per la messa in sicurezza dei confini. Quello di Gaza ha i contorni di un massacro calcolato, confermato dalle dichiarazioni della leadership israeliana. Parte dello sviluppo di questa alienazione morale è la luce verde data dalla presidenza Trump: qualsiasi cosa Israele voglia fare, può farlo. Sono due le dimensioni del massacro: la motivazione interna israeliana nell’affrontare la questione palestinese e la tolleranza esterna.
- [Foto] Richard Falk
Dice massacro calcolato: qual è l’obiettivo politico?
Le ragioni ufficiali, Hamas e la sicurezza dei confini, non sono quelle reali. Quello che Israele vuol fare è convincere i palestinesi di essere impegnati in una resistenza impossibile. E mandare un messaggio all’Iran e agli altri avversari nella regione: Israele non ha limiti nell’uso della forza, questa sarà la reazione verso chiunque.
La legalità internazionale esiste ancora?
Le regole ci sono, quel che manca è la volontà politica di applicarle. Oggi prevalgono i fattori geopolitici. La questione palestinese è l’esempio più ovvio di questo «veto geopolitico», che annulla qualsiasi sforzo di far rispettare la legalità internazionale e di prendere misure nel caso di violazioni. A ciò si aggiunge un altro elemento: Israele sta provando a far passare l’idea che i palestinesi hanno perso la battaglia della soluzione politica e che dunque non c’è ragione di usare strumenti politici per proteggerli dalle politiche israeliane. Israele vuole convincere il mondo che questo tipo di lotta non abbia più significato e valore. La conseguenza è visibile: il veto geopolitico protegge Israele e lega le mani all’Onu, incapace di offrire protezione. Così si indebolisce l’intero sistema.
È dunque esercizio futile pensare a procedimenti legali per i crimini commessi da Israele?
Il diritto penale internazionale è sempre stato un sistema imperfetto perché non si applica agli Stati che godono di un certo livello di impunità. Dopo la seconda guerra mondiale, i tribunali di Norimberga e Tokyo giudicarono solo i crimini commessi dagli sconfitti, non quelli commessi dai vincitori, penso alle atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Quei crimini non furono perseguiti, ma «legalizzati»: l’atomica si è tradotta nella proliferazione di armi nucleari. La struttura del diritto penale internazionale si basa su un doppio standard che si esprime sul piano istituzionale nel potere di veto riconosciuto ai vincitori della guerra, veto che li esenta dall’obbligo di rispondere delle proprie azioni e che si estende ai paesi amici.
Possiamo chiederci da cosa derivi l’impunità israeliana attuale: da una parte dai paesi arabi preoccupati da quella che percepiscono come la minaccia iraniana e che li spinge a normalizzare i rapporti con Israele; dall’altra dall’amministrazione Usa che sta ringraziando i sostenitori interni della campagna di Trump. Su questi altari si sacrifica la visione degli ebrei liberali che vogliono una soluzione politica.
Lei ha spesso parlato di regime di apartheid, nei Territori Occupati ma anche dentro Israele. Un sistema unico: il palestinese è discriminato ovunque si trovi (che risieda nei Territori o sia cittadino israeliano), l’israeliano gode di privilegi ovunque esso viva, a Tel Aviv come in una colonia.
Il cuore del conflitto non è la terra, ma i popoli. L’intera idea di uno Stato ebraico implica lo svuotamento della Palestina storica dai non ebrei. Ma a differenza del Sudafrica, Israele intende anche porsi come democrazia. L’apartheid israeliana, dunque, non passa per la negazione della cittadinanza ai palestinesi che vivono nel territorio dello Stato, ma in una serie di leggi che distinguono tra chi è ebreo e chi non lo è, dal diritto al ritorno fino alla proprietà della terra. A ciò si aggiunge l’elemento della frammentazione del popolo palestinese: l’apartheid passa per la divisione dei palestinesi in territori separati e dunque in diversi status giuridici.
Vede all’orizzonte un cambiamento positivo?
L’ultimo secolo ha dimostrato che l’impossibile a volte è possibile. Penso alla fine dell’apartheid in Sudafrica o più recentemente alle primavere arabe. Lì a prevalere non sono state le parti più forti ma quelle deboli. Dopo l’epoca coloniale una delle trasformazioni a cui abbiamo assistito è la ridefinizione dei rapporti di forza: non sempre la forza militare vince su quella politica. Pensate al Vietnam. I popoli hanno imparato che la resistenza popolare può supplire all’inferiorità militare perché dalla loro parte hanno la superiorità morale e la capacità di elaborare le perdite per un fine più alto, l’autodeterminazione.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA -- «Tacciano le armi in Medio Oriente». Dopo la strage di Gaza. L’appello urgente contro la violenza in Palestina di un gruppo di personalità della cultura italiana.16 maggio 2018, di Federico La Sala
L’appello: «Tacciano le armi in Medio Oriente» *
Dopo la strage di Gaza. L’appello urgente contro la violenza in Palestina di un gruppo di personalità della cultura italiana . «Israele oggi assomiglia più a una fortezza che non a una casa», ha detto David Grossman aprendo, tre settimane fa, una cerimonia congiunta di commemorazione delle vittime del conflitto, israeliane e palestinesi, a Tel Aviv, in ebraico e in arabo.
In queste ore a Gaza sangue si aggiunge su sangue. Condividiamo il dolore delle vittime palestinesi. Noi sottoscritti, sostenitori del diritto di Israele ad esistere come stato entro confini legittimi, sicuri e riconosciuti, e ugualmente di quello dei palestinesi ad uno stato indipendente, guardiamo con estrema preoccupazione alle prime conseguenze, letali per le prospettive della pace, dello spostamento dell’ambasciata americana a Gerusalemme da parte dell’amministrazione Trump.
Non possiamo tacere di fronte all’uso sproporzionato della forza da parte di Israele. L’uso di armi da fuoco contro civili è ammissibile soltanto se detti civili partecipano direttamente ad azioni ostili, non se varcano o cercano di superare la frontiera con Israele. Vi sono mezzi non letali per contenere e disperdere proteste anche di massa.
Condanniamo la retorica fondamentalista di Hamas che non abbandona il rifiuto di Israele né desiste da una guerra di guerriglia che espone la gente di Gaza alla rappresaglia di Israele.
Chiediamo, soprattutto, che tacciano le armi e si cerchino ora e per il futuro, da parte di tutti, le vie politiche del dialogo, della conoscenza reciproca e della pace in tutta la regione.
- Hanno aderito tra gli altri
- Ruth Ben Ghiat, Edith Bruck, Donatella Calabi, Francesca Calabi, David Calef, Bruno Contini, Roberto Della Seta, Donatella Di Cesare, Anna Foa, Carlo Ginzburg, Lisa Ginzburg, Siegmund Ginsberg, Agostino Giovagnoli, Wlodek Goldkorn, Giorgio Gomel, Helena Janeczek, Gad Lerner, Simon Levis Sullam, Laura Mincer, Paolo Pezzino, Alessandro Portelli, Adriano Prosperi, Gigi Riva, Michele Sarfatti, Roberto Saviano, Bruno Segre, Maria Stone, Susanna Terracina, Alessandro Treves, Nadia Urbinati
 Per adesioni: taccianoarmiMO@gmail.com
Per adesioni: taccianoarmiMO@gmail.com -
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. -- Nakba, la catastrofe infinita (di Tommaso Di Francesco).16 maggio 2018, di Federico La Sala
Nakba, la catastrofe infinita
di Tommaso Di Francesco (il manifesto, 16.05.2018
I settant’anni dello Stato d’Israele sono anche i settant’anni della Nakba, la «Catastrofe» del popolo palestinese, la cacciata nel 1948 di centinaia di migliaia di palestinesi (da 700mila a un milione) in una operazione di preordinata pulizia etnica che li ha trasformati nel popolo profugho dei campi. A confermare laa doppiezza strabica degli eventi nel rapporto di causa ed effetto, è arrivato lo spostamento dell’ambasciata Usa a Gerusalemme, la festa della «grande riunificazione» di Netanyahu; proprio mentre la promessa elettorale mantenuta di Trump provocava la rivolta e la strage di 60 giovani nel tiro al piccione a Gaza. Secondo i versi del poeta palestinese Mahmud Darwish: «Prigionieri di questo tempo indolente!/ non trovammo ultimo sembiante, altro che il nostro sangue».
Invece sulla descrizione in atto del massacro si esercitano gli «stregoni della notizia»: così abbiamo letto di «ordini dalle moschee di andare correndo contro i proiettili», di «scontri», di «battaglia» e «guerriglia». Avremmo dunque dovuto vedere cecchini, carri armati e cacciabombardieri palestinesi fronteggiare cecchini, tank e jet israeliani, con assalti di uomini armati. Niente di tutto questo è avvenuto e avviene. Invece, nella più completa impunità, la prepotenza dell’esercito israeliano sta schiacciando una protesta armata di sassi, fionde e copertoni incendiati. Per Netanyahu poi si tratterebbe di «azioni terroristiche».
Ma la verità è che un popolo oppresso che manifesta contro un’occupazione militare ricorda solo la nostra Liberazione e il diritto dei palestinesi sancito da ben tre risoluzioni dell’Onu (una del 1948 proprio sul «diritto al ritorno»). Sì, la festa triste di un popolo, guidato da Netanyahu e dal nuovo «re d’Israele» Trump, vive della catastrofe di un altro popolo. Che si allunga all’infinito con la proclamazione di Gerusalemme «unica e storica capitale indivisibile di Israele». Altro che due Stati per due popoli: nemmeno due capitali. Intanto per lo Stato d’Israele il «diritto al ritorno» è costitutivo della natura esclusiva di Stato ebraico.
Ai palestinesi al contrario è permesso solo di vivere a milioni nei campi profughi di un Medio Oriente stravolto dalle guerre occidentali e come migranti nei propri territori occupati (Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est); di sopravvivere alla fame nel ghetto della Striscia di Gaza.
 Questa è la condizione palestinese, con il muro di Sharon che ruba terre alla Palestina e taglia in due famiglie e comunità; posti di blocco che sospendono nell’attesa le vite umane; lo sradicamento di colture agricole e le fonti d’acqua sequestrate; le uccisioni quotidiane; e una miriade di insediamenti colonici ebraici che hanno ormai cancellato la continuità territoriale dello Stato di Palestina.
Questa è la condizione palestinese, con il muro di Sharon che ruba terre alla Palestina e taglia in due famiglie e comunità; posti di blocco che sospendono nell’attesa le vite umane; lo sradicamento di colture agricole e le fonti d’acqua sequestrate; le uccisioni quotidiane; e una miriade di insediamenti colonici ebraici che hanno ormai cancellato la continuità territoriale dello Stato di Palestina.
 Dopo tante chiacchiere di Obama che nel 2009 dal Cairo dichiarava: «Sento il dolore dei palestinesi senza terra e senza Stato». E dopo i voltafaccia dell’Ue che si barcamena sull’equidistanza impossibile e tace, mentre ogni governo occidentale fa affari in armi e tecnologia, e con patti militari - come l’Italia - con Israele, che è da settant’anni in guerra e che occupa terre di un altro popolo.
Dopo tante chiacchiere di Obama che nel 2009 dal Cairo dichiarava: «Sento il dolore dei palestinesi senza terra e senza Stato». E dopo i voltafaccia dell’Ue che si barcamena sull’equidistanza impossibile e tace, mentre ogni governo occidentale fa affari in armi e tecnologia, e con patti militari - come l’Italia - con Israele, che è da settant’anni in guerra e che occupa terre di un altro popolo.Allora o si rompe il silenzio complice e si prefigura una soluzione di pace che esca dall’ambiguità di stare al di sopra delle parti - come se Israele e Palestina avessero la stessa forza e rappresentatività, quando invece da una parte c’è lo Stato d’Israele, potente e armato fino ai denti, potenza nucleare e con l’esercito tra i più forti al mondo, mentre dall’altra lo Stato palestinese semplicemente non esiste - oppure sarà troppo tardi.
 Il nodo mai sciolto - Rabin a parte, non a caso assassinato da un integralista ebreo - da tutti i governi israeliani resta quello del diritto dei palestinesi di avere una terra e uno Stato, fermo restando il diritto eguale d’Israele. Che se però non lo riconosce per la Palestina perché dovrebbe pretenderlo per sé? I due termini ormai si sostengono a vicenda oppure insieme si cancellano. Tanto più che la demografia ormai racconta che le popolazioni arabe hanno oltrepassato la misura di quelle ebraiche.
Il nodo mai sciolto - Rabin a parte, non a caso assassinato da un integralista ebreo - da tutti i governi israeliani resta quello del diritto dei palestinesi di avere una terra e uno Stato, fermo restando il diritto eguale d’Israele. Che se però non lo riconosce per la Palestina perché dovrebbe pretenderlo per sé? I due termini ormai si sostengono a vicenda oppure insieme si cancellano. Tanto più che la demografia ormai racconta che le popolazioni arabe hanno oltrepassato la misura di quelle ebraiche.
 O si avvia una trasformazione democratica dello Stato d’Israele che decide di perdere la sua natura etnico-religiosa di «Stato ebraico», con la pretesa arrogante che i palestinesi occupati lo riconoscano come tale; oppure si conferma la dimensione acclarata di Stato di apartheid come in Sudafrica; con i territori occupati come riserve per i «nativi» nemici.
O si avvia una trasformazione democratica dello Stato d’Israele che decide di perdere la sua natura etnico-religiosa di «Stato ebraico», con la pretesa arrogante che i palestinesi occupati lo riconoscano come tale; oppure si conferma la dimensione acclarata di Stato di apartheid come in Sudafrica; con i territori occupati come riserve per i «nativi» nemici.Scriveva Franco Lattes Fortini nella sua Lettera aperta agli ebrei italiani nel maggio 1989, nella la fase più acuta della Prima intifada: «Con ogni casa che gli israeliani distruggono, con ogni vita che quotidianamente uccidono e perfino con ogni giorno di scuola che fanno perdere ai ragazzi di Palestina, va perduta una parte dell’immenso deposito di verità e di sapienza che, nella e per la cultura occidentale, è stato accumulato dalle generazioni della diaspora, dalla sventura gloriosa o nefanda dei ghetti e attraverso la ferocia delle persecuzioni antiche e recenti. Una grande donna ebrea e cristiana, Simone Weil, ha ricordato che la spada ferisce da due parti. Anche da più di due, oso aggiungere».
 Provate a rileggere la grande lezione morale di S. Yizhar (Yzhar Smilansky), il fondatore della letteratura israeliana, che in un piccolo romanzo del 1949 Khirbet Khiza - significativamente un titolo in arabo, conosciuto da noi come La rabbia del vento, che aprì un dibattito sulle basi etiche del nuovo Stato - racconta la storia di una brigata dell’esercito israeliano impegnata con la violenza a cacciare famiglie palestinesi.
Provate a rileggere la grande lezione morale di S. Yizhar (Yzhar Smilansky), il fondatore della letteratura israeliana, che in un piccolo romanzo del 1949 Khirbet Khiza - significativamente un titolo in arabo, conosciuto da noi come La rabbia del vento, che aprì un dibattito sulle basi etiche del nuovo Stato - racconta la storia di una brigata dell’esercito israeliano impegnata con la violenza a cacciare famiglie palestinesi.
 Il romanzo finisce con queste parole di dolore e rammarico: «I campi saranno seminati e mietuti e verranno compiute grandi opere. Evviva la città ebraica di Khiza! Chi penserà mai che prima qui ci fosse una certa Khirbet Khiza la cui popolazione era stata cacciata e di cui noi ci eravamo impadroniti? Eravamo venuti, avevamo sparato, bruciato, fatto esplodere, bandito ed esiliato (...) Finché le lacrime di un bambino che camminava con la madre non avessero brillato, e lei non avesse trattenuto un tacito pianto di rabbia, io non avrei potuto rassegnarmi. E quel bambino andava in esilio portando con sé il ruggito di un torto ricevuto, ed era impossibile che non ci fosse al mondo nessuno disposto a raccogliere un urlo talmente grande. Allora dissi: non abbiamo alcun diritto a mandarli via da qui!».
Il romanzo finisce con queste parole di dolore e rammarico: «I campi saranno seminati e mietuti e verranno compiute grandi opere. Evviva la città ebraica di Khiza! Chi penserà mai che prima qui ci fosse una certa Khirbet Khiza la cui popolazione era stata cacciata e di cui noi ci eravamo impadroniti? Eravamo venuti, avevamo sparato, bruciato, fatto esplodere, bandito ed esiliato (...) Finché le lacrime di un bambino che camminava con la madre non avessero brillato, e lei non avesse trattenuto un tacito pianto di rabbia, io non avrei potuto rassegnarmi. E quel bambino andava in esilio portando con sé il ruggito di un torto ricevuto, ed era impossibile che non ci fosse al mondo nessuno disposto a raccogliere un urlo talmente grande. Allora dissi: non abbiamo alcun diritto a mandarli via da qui!». -
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD - RICERCA DELLA VITA BUONA E RESPONSABILITÀ: HANS JONAS..10 febbraio 2018, di Federico La Sala
Inediti.
Hans Jonas, la ricerca della vita buona
Secondo il pensatore tedesco l’uomo si realizza in un sano pensiero filosofico, evitando gnosticismo e storture scientiste. Per non diventare «formiche tecnologiche»
di Simone Paliaga (Avvenire, venerdì 9 febbraio 2018)
- Il filosofo Hans Jonas (1903-1993)
 Hans Jonas, "Sulle cause e gli usi della filosofia e altri scritti inediti", Ets, 120 pagine, 10 euro
Hans Jonas, "Sulle cause e gli usi della filosofia e altri scritti inediti", Ets, 120 pagine, 10 euro
«Che l’immagine dell’uomo non vacilli, si offuschi e sbiadisca, che gli uomini non si riducano a formiche tecnologiche o edonisti senza anima o marionette frastornate dal nostro furibondo potere». A cosa attingere per evitare questa deriva? All’uso adeguato della filosofia che instrada verso la vita buona e all’esercizio della virtù? Sono dilemmi che hanno il sapore dell’attualità benché sollevate da Hans Jonas nel 1955. Potrebbe d’altro canto essere diversamente se «le questioni filosofiche - puntualizzava il pensatore sei anni prima - si ripropongono ad ogni nuova epoca tanto daccapo, quanto alla luce della loro intera vicenda storica antecedente?». Le citazioni provengono dalle annotazioni del filosofo appartenenti alla sua stagione canadese, dal 1949 al ’55.
A lungo conservate all’Hans Jonas Nachlass dell’università di Konstanz sono state ripescate e raccolte in anteprima mondiale da Fabio Fossa in questo libro (Sulle cause e gli usi della filosofia e altri scritti inediti, Ets, pp. 120, euro 10). Hans Jonas non è tra gli autori più conosciuti al grande pubblico eppure il suo curriculum scintilla. Dopo gli studi con Rudolf Bultmann e Martin Heidegger nella Germania degli anni Trenta, prende la via dell’esilio, lontano dall’Europa.
La sua vita però non si riduce a studio e contemplazione. Anzi l’agire ne costituisce una cifra di rilievo. Lo prova, nel corso della Seconda guerra mondiale, la scelta di arruolarsi nella Jewish Brigade, inquadrata nell’esercito britannico e operativa sul suolo italiano. I rapporti con la penisola scandiscono la vita di Jonas. Sarà proprio al rientro dall’Italia, nel 1993, dopo avere ricevuto il Premio Nonino dedicato ai maestri del nostro tempo, che il filosofo tedesco naturalizzato americano si spegnerà a New York all’età di novant’anni.
Il nome di Jonas comincia a uscire dai cenacoli dotti appena pubblica Il principio responsabilità, dove traccia un’etica all’altezza della civiltà tecnologica. Siamo, con Jonas, lontani anni luce dalle prefiche apocalittiche. La Guerra fredda imperversa (è il 1979) e molti continuano a gridare al pericolo rosso, pronto a sbarcare in Afghanistan. Pochi invece si curano dei potenziali sviluppi distruttivi della civiltà a più alto tasso tecnologico mai esistita. Eppure la riflessione sul ’Prometeo scatenato’ occhieggiava già da tempo tra le note di Jonas. Lo testimoniano gli scritti del soggiorno canadese che sono tutt’altro che una parentesi nel cammino di pensiero di Jonas. Già con il breve Introduzione alla filosofia e con Virtù e saggezza in Socrate prepararti nell’inverno del 1949 per i corsi del Dawson College della McGill University, emerge la costante attenzione all’uomo e alla vita buona, medicina per non trasformarsi in «formiche tecnologiche».
«L’uomo è il risultato delle sue azioni passate - scrive nel 1949 in Introduzione alla filosofia -. Intendo il passato culturale della stirpe, custodito nella memoria storica; e solo fintantoché questo passato è realmente ricordato l’uomo è davvero consapevole del proprio esistere presente e, di conseguenza, dell’autentico significato attuale dei propri problemi esistenziali». È questa dimensione storica che gli consente di porsi di là del dualismo tra intelletto e vita, tipico della filosofia greca. Ma la sua storicità non garantisce nulla se non un punto di partenza. Occorre, all’uomo, inseguire la vita buona e praticare la virtù, rovello dello sforzo teoretico di Jonas. Agire eticamente nel mondo storico perseguendo la virtù consente di evitare le spirali dello gnosticismo o le storture del sogno scientista che «promuove la massima realizzazione di tutti i fini desiderabili attraverso la semplice messa a disposizione dei mezzi».
Occorre ricucire lo strappo tra intelletto e vita. «L’approccio dualistico alla costituzione sostanziale dell’uomo - scrive già nel 1950 - rende conto del fatto che tanto la comprensione quanto la realizzazione del fine dell’uomo non dipendono da un processo di sviluppo spontaneo, ma dall’esercizio della virtù etica». Virtù che non può rimanere chiusa nell’autosufficienza dell’intelletto e che nello Jonas maturo assume i tratti della responsabilità nei confronti delle generazioni a venire. Responsabilità che faticherebbe a farsi largo senza la «fatica della filosofia, che deve sempre ripartire da capo, fondata com’è sulla ragione; e la ragione non è il freddo, impersonale intelletto, ma è pervasa dalla passione dell’amore o dell’onestà».
DOC.:QUELLA COTTA PER LA ARENDT DI HANS JONAS
A dieci anni dalla sua scomparsa esce la sua autobiografia
di Paola Sorge (la Repubblica, 29 luglio 2003)
La notorietà arrivò tardi per Hans Jonas: il filosofo aveva 75 anni quando «Il principio responsabilità - Un’etica per la civiltà tecnologica» - un libro che ebbe una diffusione rapida e vastissima come pochi altri nel mondo del pensiero - gli diede fama internazionale; da allora, era il 1979, il pensatore originario di Monchengladbach che aveva studiato con Husserl e Heidegger, l’ insegnante entusiasta e appassionato che faceva della filosofia qualcosa di vivo e affascinante, divenne estremamente popolare, onnipresente nei dibattiti sul futuro del mondo.
La sua intensa vita che abbraccia quasi tutto il Novecento (dal 1903 al 1993) la racconta lui stesso in maniera semplice e disarmante in un volume uscito ora in Germania (Hans Jonas: Erinnerungen, ed. Insel,pagg. 500); nulla di accademico né di costruito nelle memorie di questo grande filosofo che paiono piuttosto le confidenze di un amico che sente il bisogno di confessarsi, di rivelare con estrema franchezza non solo le tappe del suo iter intellettuale - dalla analisi della spiritualità antica a quella della tecnologia moderna fino alla preoccupazione per il futuro dell’ umanità - , ma anche le sue vicende personali, gli aspetti meno conosciuti della sua formazione e della sua carriera, i lati oscuri della sua personalità. Jonas rievoca con dovizia di particolari la sua infanzia, il rapporto con il padre, un agiato fabbricante tessile che stenta a capire le aspirazioni e le tensioni spirituali del figlio e il suo impegno per il sionismo, il tenero legame con la madre e la ferita sempre aperta per la sua tragica morte a Auschwitz; come la maggior parte dei suoi compagni di studi, Hans prova una forte attrazione per Hannah Arendt, conosciuta a Marburg nel 1924, ma lei gli confessa subito la sua relazione con Heidegger per non illuderlo e ne fa il suo confidente e amico per la vita.
La descrizione dell’ ambiente universitario di Friburgo e poi di Marburg e delle lezioni tenute dai due grandi, allora mitici maestri di Jonas, Husserl e Heidegger, è a dir poco disincantata. Il primo, fondatore della fenomenologia, riteneva che tutti i pensatori dell’ era moderna, da Descartes in poi, non erano riusciti a risolvere certi problemi della consapevolezza o della teoria della conoscenza perché non conoscevano il suo metodo, l’ unico che dava soluzioni. Tra l’ altro, si diverte a ricordare Jonas, era presente alle lezioni la moglie di Husserl che, come un cerbero, controllava che gli studenti fossero attenti e prendessero appunti.
Quanto a Heidegger, il giovane Hans ne riconosce il grande valore e la suggestione esercitata dalla sua personalità, ma non esita a dichiarare che spesso non lo capiva: il suo messaggio era cifrato, destinato a pochi iniziati e inoltre, intorno a lui, si avvertiva un’ atmosfera «malsana» dovuta agli adoratori del filosofo. «Non riuscivo a sopportare quella congrega di cultori di Heidegger dall’ atteggiamento bigotto e altezzoso» - osserva Jonas ricordando i seminari frequentati a Marburgo dal 1924 - «essi credevano di possedere la verità rivelata: quella non era filosofia ma qualcosa di settario, quasi una nuova fede...».
Queste prime, sgradevoli impressioni saranno poi rafforzate dal celebre discorso tenuto da Heidegger nel ’33 in favore di Hitler e dal suo vergognoso comportamento nei riguardi di Husserl. In realtà per il giovane studente pieno di ideali, che credeva che la filosofia dovesse proteggere l’uomo da errori, migliorarlo e nobilitarlo, l’inaspettata adesione del grande filosofo al nazismo non significa solo il crollo di un idolo, ma anche il fallimento catastrofico della filosofia stessa, «la bancarotta del pensiero filosofico».
Dopo la guerra Hans Jonas si distaccherà definitivamente dalla filosofia dell’ esistenzialismo contrapponendole la «filosofia della vita»; a differenza della Arendt, non perdonerà mai colui che ritiene il più profondo pensatore del suo tempo, anche se accetterà di incontrarlo brevemente nel 1969, in occasione del suo ottantesimo compleanno. «Ma tra noi ci fu solo uno scambio di ricordi del tempo di Marburg», nota Jonas.
Dopo la notizia dell’ avvento di Hitler al potere appresa durante un’ allegra festa in maschera, Hans si rifugia a Gerusalemme, partecipa alla seconda guerra mondiale arruolandosi nell’ esercito inglese, combatte in Italia, a Taranto, a Forlì, a Udine, e rimane piacevolmente sorpreso nel constatare che la popolazione protegge e nasconde gli ebrei in barba alle leggi razziali.
Quando nel ’45 torna in Germania e vede le città tedesche rase al suolo - città fantasma che sembravano paesaggi lunari, piene di crateri e di rovine - , prova una gioia incontenibile per la vendetta che si è compiuta: «E’ qualcosa che non vorrei mai più provare», confessa Jonas, « ma che non voglio tacere». E, senza remore aggiunge che per molti anni quello è stato per lui il momento di più intensa felicità. «Oggi non lo potrei più dire «, nota il filosofo « perché nella mia vita ho vissuto momenti ben più felici».
A New York, dove dal 1955 ha la cattedra di filosofia, ritrova Hannah Arendt e frequenta la sua cerchia di amici a Manhattan fino a quando la pubblicazione degli articoli della scrittrice sul processo di Eichmann a Gerusalemme lo sconvolge profondamente: Jonas non crede ai suoi occhi, non riesce a capacitarsi delle dure critiche mosse dalla Arendt agli stessi ebrei, del tono tagliente e sarcastico da lei usato nei loro confronti, della sua posizione antisionista. Lo scontro fra i due amici di un tempo è inevitabile: Hans rimprovera a Hannah - che non ha mai letto la Bibbia - la sua ignoranza sulla religione e sulla storia ebraica antica, tenta inutilmente di farla desistere dalle sue posizioni, si rifiuta infine di vederla. Solo dopo due anni riprenderà i contatti con la donna da lui stesso definita «un genio dell’ amicizia».
- Il filosofo Hans Jonas (1903-1993)
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. -- “Gerusalemme capitale di Israele”. L’ultimo azzardo di Trump.2 dicembre 2017, di Federico La Sala
Diplomazia
L’ultimo azzardo di Trump
“Gerusalemme capitale di Israele” *
Washington Donald Trump si prepara a infiammare il Medio Oriente: secondo diverse fonti di stampa, il presidente americano, terrà mercoledì un discorso in cui riconoscerà Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha fatto sapere un funzionario della Casa Bianca.
L’annuncio potrebbe rovesciare decenni di politica americana: per i palestinesi infatti Gerusalemme Est deve diventare la capitale del loro Stato e non può quindi essere riconosciuta come parte della capitale israeliana.
Oggi la città è di fatto divisa in due: dal 1967, dopo l’annessione da parte di Israele della parte orientale della città che era sotto sovranità giordana, c’è un Est, abitato da circa 200mila palestinesi e un Ovest, dove vivono oltre mezzo milione di israeliani.
Sul tema di Gerusalemme si sono arenati molti dei tentativi di pace degli ultimi decenni.
L’ultima polemica sul tema ha toccato anche l’Italia. «Il Giro d’Italia tenta di compiacere Israele presentando Gerusalemme come una città unificata sotto sovranità israeliana » , ha detto l’esponente dell’Olp Hanan Ashrawi dopo che gli organizzatori della corsa, in seguito alle proteste dei ministri israeliani dello Sport e del Turismo hanno cambiato il comunicato in cui si diceva che il Giro sarebbe partito da Gerusalemme Ovest. Tolto, ” Ovest” è rimasto soltanto Gerusalemme. Tutti contenti, o quasi.
* la Repubblica, 02.12.2107
STORIA E MEMORIA:ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA
-
> ISRAELE. RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. -- RIDAMMI VITA. Dai Salmi di Davide a una visione etica contemporanea.Un lavoro di Stella Bolaffi Benuzzi (di Bruno Quaranta).26 settembre 2017, di Federico La Sala
Cercando Dio tra psicanalisi ed ebraismo
di Bruno Quaranta (La Stampa, 26.09.2017)
Era solito ricordare Karl Barth che l’unico problema ecumenico è il rapporto con gli ebrei. Se non è impostato correttamente, non si possono risolvere i problemi tra i cristiani. Una convinzione, quella del teologo e pastore svizzero, anche di Carlo Mario Martini, fra gli interlocutori, con il rabbino Laras, di Stella Bolaffi Benuzzi, psicologa e psiconalista freudiana, un’infanzia mai dimenticata «tra leggi razziali e lotta partigiana», come spiega il sottotitolo della sua autobiografia La balma delle streghe.
Ridammi vita (Salomone Belforte & C., pp. 241, €20), la nuova opera di Stella Bolaffi Benuzzi, è un excursus (dai Salmi di Davide a una visione etica contemporanea) memore della tesi di laurea discussa con Augusto Guzzo.
L’epigrafe ideale di questo dialogo ebraico-cristiano è scolpita sulla tomba di Carlo Mario Martini, nel Duomo di Milano, Salmo 119: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino».
Stella Bolaffi Benuzzi è, della Parola, un’ostinata custode e testimone, interpretando la vita come un «libro delle interrogazioni», mai appagata, sempre incardinata nell’inquietudine biblica: «A che punto è la notte?».
La psicoanalisi non mira forse - come Stella Bolaffi Benuzzi rammenta (e come sa Papa Bergoglio, a suo tempo paziente di un’analista ebrea) - «a estrarre il paziente dallo Shèol, cioè dal vallone biblico dei defunti, dal suo oscuro mondo interno e riportarlo alla luce, all’amore per la vita»?
«I Salmisti ci hanno trasmesso l’impegno ad ascoltare la voce della coscienza per poter perseguire la serietà etica nella vita», spiega Stella Bolaffi Benuzzi. Una verità che respira nei documenti conciliari: «La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio».
La coscienza, la voce giudicante della coscienza, il Super Ego freudiano in lotta con l’istintuale Es...
«La coscienza costretta a ritornare sempre più spesso al suo Signore per ritrovarsi»: è nel solco del «maggiore» Augusto Guzzo che Stella Bolaffi Benuzzi tesse il suo filo.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA -- Theodor Herzl, il sogno diventato start-up (di Lea Luzzati).25 agosto 2017, di Federico La Sala
EBRAISMO E DEMOCRAZIA. PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO... *
Theodor Herzl, il sogno diventato start-up
Nell’agosto 1897 si riunì a Basilea il Primo Congresso Sionista. Ispirandosi al Risorgimento italiano, il suo animatore guardava alle radici bibliche per forgiare l’ebreo nuovo, non più disposto a subire violenze e disprezzo
di Lea Luzzati (La Stampa, 25.08.2017)
«Se lo volete non sarà un sogno» è la frase che ne disegna la storia: una proposizione ipotetica che in principio aveva tutti i connotati dell’utopia assurda, ma che a poco a poco prese corpo, sostanza, realtà. «Se lo volete non sarà un sogno», disse Theodor Herzl in occasione del Primo Congresso Sionista, 120 anni fa, nella quieta Basilea, e lo ripeté sino alla fine della sua breve vita.
Nato a Budapest in una famiglia ebraica assimilata e profondamente acculturata, il fondatore del movimento risorgimentale ebraico si ritrovò giovane corrispondente per la Neue Freie Presse a Parigi, nella tempesta dell’infame processo Dreyfus che, se condannò il povero e fedele ufficiale francese all’esilio, regalò invece a lui una disincantata folgorazione: l’antisemitismo è inguaribile e si radica anche nelle società evolute, a dispetto dei Lumi e dei diritti civili quasi universalmente riconosciuti. Per gli ebrei l’unica soluzione di sopravvivenza e dignità è la conquista di una «completezza» nazionale e di una autonomia politica. Il ritorno a una patria. I figli d’Israele dovevano diventare «un popolo come gli altri», riavere tutto ciò che definisce una nazione: terra, bandiera, autodeterminazione.
A questo obiettivo Herzl dedicò il resto della propria vita - ma morì a soli 44 anni, nel 1904, senza fare in tempo a vedere nella Shoah la più drammatica conferma del suo pessimismo e nella nascita dello Stato d’Israele, dove dal 1950 riposano le sue spoglie, la realizzazione di quello che non rimase un sogno.
Tempi di pogrom
Cento e venti anni fa a Basilea il movimento sionista si riunì con l’obiettivo di dare una autonomia politica e civile al popolo ebraico disperso ai quattro angoli del mondo e vittima in quegli anni di sfoghi di violenza e persecuzioni: i pogrom che imperversavano nell’impero zarista mietevano vittime e costringevano alla fuga migliaia di anime.
Come bene esempla il titolo del libro di Herzl che teorizza seppure in forma narrativa la nascita del futuro Stato - Altneuland, «nuova vecchia terra» - il sionismo guardava al passato remoto, tornava alle radici bibliche della storia, a quando gli israeliti avevano un regno sulla propria terra. Ma per contro aveva come obiettivo quello di forgiare un ebreo nuovo, non più disposto a chinare la testa passivamente davanti alla catena di avversità, odio e disprezzo che avevano segnato gli ultimi duemila anni. Un ebreo nuovo capace di riprendere - in primo luogo fisicamente con il lavoro manuale - il contatto con la terra.
E in fondo tutta la storia del sionismo, che prende il nome da una collina di Gerusalemme, Sion, evocata con nostalgia dagli esuli della prima Diaspora deportati in Babilonia, è un cammino sul filo in equilibrio tra passato e futuro.
Da Theodor Herzl, che aveva nel Risorgimento italiano il suo primo e fondamentale modello politico, a David Ben Gurion, padre della patria che sempre propugnò il cammino verso Sud, verso il deserto del Negev dove secondo lui stavano il futuro del popolo e le risorse materiali e mentali per edificare la storia, tutta l’epopea del sionismo è segnata sia da un richiamo alle radici lontane sia dalla ricerca di un futuro libero, aperto.
Il Primo Congresso Sionista, tenutosi a Basilea dal 29 al 31 agosto 1897, avvia un processo interno ebraico: si creano organizzazioni, si definiscono i lineamenti di una educazione alla rinascita nazionale. Theodor Herzl e gli altri esponenti del movimento si dedicano a una fervida attività politica e diplomatica in cerca di un focolare nazionale per i figli d’Israele. Il sionismo è dunque un insieme di iniziative politiche, culturali ed economiche volte alla rinascita nazionale per il popolo ebraico. È anche e forse soprattutto un insieme di ideali intrinseco all’ebraismo, cui la modernità può dar voce. Nulla di artificiale, anzi: è l’autentico spirito dell’ebraismo che si confronta con la storia.
Lo Stato d’Israele
Cinquant’anni esatti dopo il Primo Congresso Sionista, il 29 novembre 1947, le Nazioni Unite approvano a maggioranza una risoluzione che prevede la creazione di due Stati «palestinesi»: uno ebraico e uno arabo. Nella Palestina sotto mandato britannico c’era infatti da generazioni una società ebraica strutturata, attiva, consapevole: uno Stato di fatto, dotato di istituzioni politiche, sistema educativo, servizi.
Nel maggio del 1948 nasce lo Stato d’Israele. Da allora esso vive il conflitto. Ma ancora una volta, al di là delle questione politiche e fermo restando il diritto dei palestinesi arabi a un’autonomia nazionale, la storia ebraica si è caricata del solito «sovratesto» distorto per colpa del quale «sionismo» è diventato una parolaccia, la definizione di un’ideologia del male, sinonimo di razzismo, come è detto nella risoluzione Onu 3379 del novembre 1975.
Un ideale ancora vivo
Se è vero che dal 1897 in poi, e anche prima, il movimento sionista ha conosciuto diverse espressioni, lo è altrettanto l’evidenza che col razzismo non c’entra per nulla. Da Martin Buber a Zeev Jabotinsky, da Rav Kook a Abraham Yehoshua - e con loro tantissimi intellettuali e uomini di politica - in tutte queste voci il sionismo si configura come un ideale di «normalizzazione» ebraica capace di conservare quel portato umanistico che si trova espresso nella Bibbia e in tutta la tradizione d’Israele.
Lo Stato ebraico esiste da quasi 70 anni, è una realtà costruita su un ideale. Eppure, malgrado abbia raggiunto il suo scopo, l’ideale sionista è ancora vivo. Non solo nel guidare le recenti immigrazioni di ebrei (dalla Russia, dalla Francia, dall’India), non solo nella memoria di quei fondatori sparsi per il Paese (come ad esempio il nucleo italiano di molti kibbutzim storici, da Netzer Sereni a Ruchama), ma anche nel suo essere la più autentica declinazione dell’ebraismo contemporaneo. Nel quotidiano confronto, non sempre liscio ma sempre costruttivo, tra Diaspora e realtà nazionale israeliana. Nel paradosso che fa oggi di questo paese dalle radici ancestrali in cui si parla la stessa lingua dei Profeti e dei Patriarchi la «start-up nation» proiettata verso le più avveniristiche tecnologie. Nel suo essere parte dello scacchiere politico e culturale del presente, con le sue energie intellettuali, con la sua spinta di vita.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
No al SUPERMAN...ismo israeliano
 Il sionismo non è l’ebraismo!!! Lettera a ISRAELE - di Moni Ovadia
Il sionismo non è l’ebraismo!!! Lettera a ISRAELE - di Moni OvadiaFREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
-
> ISRAELE... FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. --- «La vittoria maledetta». Decostruito il mito di Israele (di Massimiliano De Villa)3 luglio 2017, di Federico La Sala
Decostruito il mito di Israele
Guerra dei sei giorni. Sulla base di inedite fonti d’archivio ancora sotto segreto, Ahron Bregman mostra le tappe successive dell’occupazione, nei suoi effetti sui popoli dei Territori: «La vittoria maledetta», da Einaudi
di Massimiliano De Villa (il manifesto, 02.07.2017)
Il mattino del 14 maggio 1967, il primo ministro israeliano Levi Eshkol sta osservando, dalla terrazza del suo ufficio, la sfilata del Giorno dell’Indipendenza quando il generale Yitzhak Rabin gli riporta movimenti sospetti di reparti egiziani che, attraversato il Canale di Suez, sono sbarcati nel Sinai. È solo l’inizio: nel giro di tre settimane, l’Egitto ordina ai caschi blu delle Nazioni Unite di ritirarsi dalla penisola sinaitica, schiera sette divisioni militari lungo il confine con Israele, chiude gli stretti di Tiran, importantissimo passaggio per le navi israeliane, e sigla un accordo di difesa con la Giordania.
Lo schieramento di forze egiziane turba un equilibrio già assai fragile: dalla crisi di Suez del 1956, del resto, il presidente egiziano Nasser, leader popolare di un panarabismo montante, non ha mai smesso di parlare della distruzione di Israele e, nei mesi precedenti il giugno 1967, la sua propaganda anti-israeliana si è fatta più virulenta. I nemici sionisti - va ripetendo Nasser con retorica pettoruta, mentre gli altri capi di stato arabi gli fanno variamente eco - devono essere cancellati e ributtati in mare. Per gli israeliani, spaventati dal riproporsi di recenti spettri, la chiusura degli stretti è il casus belli: di qui l’attacco, improvviso e rapidissimo.
Nel giro di sei giorni, dal 5 al 10 giugno 1967, le Forze di difesa israeliane sbaragliano tre fronti, l’egiziano, il giordano e il siriano, irrompendo nei territori arabi e occupando il deserto del Sinai, la Striscia di Gaza, le alture del Golan e la Cisgiordania, compresa la parte orientale della città di Gerusalemme. Per Israele, questa guerra che, con la velocità del fulmine, ne triplica il territorio è una vittoria straordinaria. Un’ondata di fervore messianico dilaga nel paese, gli osservanti parlano di miracolo, i laici non nascondono l’emozione. La terra di Israele è stata restituita ai suoi antichi abitanti, questa è la voce che corre dal deserto del Negev al Mare di Galilea, mentre il mondo sbalordisce alla rapidità e alla potenza dell’apparato militare israeliano. Le operazioni belliche si chiudono in pochi giorni e si apre, in parallelo, la questione, insieme spinosa e delicatissima, dei Territori occupati e degli insediamenti israeliani. Un’occupazione - dicono gli osservatori esterni - che durerà poco e che invece, tolto il Sinai e, solo da qualche anno, la Striscia di Gaza, entra oggi nel suo cinquantesimo anno.
Sono molti i libri che, negli anni e nei mesi scorsi, hanno ripercorso, interpretato, indagato la Guerra dei Sei Giorni nel suo cinquantesimo anniversario. Tra le analisi più acute, quella di Ahron Bregman, inS La vittoria maledetta, Storia di Israele e dei Territori occupati (Einaudi, traduzione di Maria Lorenza Chiesara, pp. 340, euro 33,00).
Già il titolo rivela il taglio del saggio: quella che da Israele era stata vissuta come una benedizione, il compiersi dell’antica promessa fatta da Dio ai padri e il suggello trionfale dell’impresa sionista, mostrerà, nel giro di poco, il suo vero volto, mutando in modo definitivo la fisionomia medio-orientale e trasformando Israele, agli occhi dell’Occidente, da vittima della storia a paese occupante.
Il saggio di Bregman, israeliano emigrato a Londra durante la prima intifada per esplicito dissenso politico e ora professore di storia militare al King’s College, ha inizio inquadrando il problema da un punto di vista giuridico: quella di Israele nei confronti dei territori conquistati nel 1967 è de iure un’occupazione, condotta in aperta violazione della Convenzione dell’Aja, stipulata a inizio Novecento, e della più tarda e più famosa Convenzione di Ginevra del 1949.
Sulla base di inedite fonti d’archivio israeliane, in parte ancora coperte dal segreto, Bregman dimostra, con coerenza aristotelica e senza mai rinunciare a una narrazione brillante, le tappe successive dell’occupazione nei suoi effetti sulla popolazione dei Territori: la creazione di governi militari israeliani, l’uso dell’esercito per soggiogare gli occupati, la raffica di decreti d’urgenza e di ordinanze militari, l’avvio di una vertiginosa macchina burocratica che disciplinerà, di lì in avanti, ogni centimetro di vita pubblica, dall’accesso agli impieghi all’accesso alla rete idrica e all’elettricità, con estenuanti trafile per ottenere, nel migliore dei casi, un permesso o una licenza. Poi le restrizioni sugli spostamenti, i lunghissimi controlli alle frontiere, gli espropri coatti, la pulizia etnica dei territori conquistati, la distruzione di antichissimi villaggi arabi con i trasferimenti forzati dei loro abitanti in Giordania o in Siria, la costruzione, sul medesimo terreno, di basi militari e insediamenti ebraici, e l’invio di coloni israeliani, spesso ebrei ortodossi, a ripopolarli.
Nella ricostruzione storica, il resoconto cede spesso il passo alle memorie e alle testimonianze di prima mano degli occupati, facendo vibrare la corda del vissuto personale senza inficiare la sobrietà dell’analisi e rivelando anzi alcuni angoli ciechi sui quali non era stata fatta sufficiente luce.
Saldamente ancorato a un criterio cronologico, Bregman passa in rassegna le pratiche e i metodi dell’occupazione israeliana, suddividendo l’esposizione in tre parti: il primo decennio di occupazione - con una sezione per ogni territorio occupato a stagliare, di ognuno, la particolare fisionomia - il secondo decennio che culmina con la prima intifada e, infine, gli ultimi vent’anni con il procedere a singhiozzo degli accordi di pace, l’assassinio di Yitzhak Rabin, la passeggiata di Ariel Sharon sulla spianata delle Moschee e l’innesco della seconda intifada fino alla roadmap della pace e al disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza.
Il fuoco principale della ricostruzione storica, l’occupazione israeliana dei Territori, non impedisce all’autore di seguire altri fili, dalla resistenza palestinese alla guerriglia armata, agli attacchi terroristici contro Israele, dalla leadership di Arafat ai successi elettorali di Hamas.
Di decennio in decennio, con i passi accorti e precisi dell’indagine storiografica, Bregman decostruisce, nelle sue pagine, il mito, diffuso dagli israeliani all’indomani della Guerra dei Sei Giorni, dell’occupazione illuminata. Mai - sostennero infatti fin da subito gli israeliani - un popolo che, come il loro, aveva vissuto sulla pelle la spaventosa esperienza della persecuzione avrebbe replicato il trattamento su altri.
 Eppure - Bregman lo sottolinea fin dalle prime pagine traendo conclusioni amare - «un’occupazione illuminata è una contraddizione in termini, come quella di un triangolo quadrilatero. Nessuna occupazione può essere illuminata.
Eppure - Bregman lo sottolinea fin dalle prime pagine traendo conclusioni amare - «un’occupazione illuminata è una contraddizione in termini, come quella di un triangolo quadrilatero. Nessuna occupazione può essere illuminata.
 I rapporti tra occupante e occupato sono sempre basati su paura e violenza, umiliazione e dolore, sofferenza e oppressione; in quanto sistema di padroni e schiavi, l’occupazione non può che essere un’esperienza negativa per l’occupato. Che Israele - una nazione piena di vita e istruita, terribilmente consapevole dei mali della storia - abbia imboccato la strada dell’occupazione militare è di per sé abbastanza stupefacente».
I rapporti tra occupante e occupato sono sempre basati su paura e violenza, umiliazione e dolore, sofferenza e oppressione; in quanto sistema di padroni e schiavi, l’occupazione non può che essere un’esperienza negativa per l’occupato. Che Israele - una nazione piena di vita e istruita, terribilmente consapevole dei mali della storia - abbia imboccato la strada dell’occupazione militare è di per sé abbastanza stupefacente». -
> FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. -- LA VERITA’ DEL MALE. Eichmann prima di Gerusalemme (Bettina Stangneth).14 giugno 2017, di Federico La Sala
- ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD.
Eichmann smascherato
Di banale non ha nulla
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 11 Giugno 20179)
- Bettina Stangneth, La verità del male. Eichmann prima di Gerusalemme, Luiss University Press
- iL VERO VOLTO. Dalle «Carte argentine», appunti dell’alto ufficiale delle SS, risulta che era un fanatico ed era rimasto attivo anche in esilio
Si dice Eichmann e si pensa al male nella sua versione novecentesca. Ma che genere di male? Hannah Arendt ci ha spinto a parlare di «banalità del male». Questa formula aveva per lei un significato filosofico preciso. In veste di giornalista Arendt aveva seguito per il periodico «The New Yorker» il processo contro l’ex tenente colonnello delle SS Adolf Eichmann.
Nel maggio del 1963 uscì il suo libro Eichmann a Gerusalemme. Il sottotitolo A Report on the Banality of Evil era destinato a suscitare accese polemiche. Un sinonimo di banalità potrebbe essere stupidità, o «assenza di pensiero», sconsideratezza. Eichmann non era la bestia degli abissi; non aveva nulla di demoniaco, né di profondo o addirittura abissale. A guardarlo da vicino era un piatto e grigio impiegato, una rotella all’interno di un ingranaggio che, anche senza di lui, avrebbe comunque funzionato. Per questa scandalosa banalità Eichmann appariva agli occhi della filosofa il prototipo del burocrate, incapace di «mettersi nei panni degli altri», al quale si poteva imputare l’unica colpa di non aver «pensato» e non aver agito, sottraendosi ai suoi compiti, con la «disobbedienza civile».
Arendt ha avuto il merito di rompere il silenzio sullo sterminio con una riflessione originale. Ma l’impressione che resta, dopo aver letto attentamente il suo libro, è che il ritratto di Eichmann abbia qualcosa di artificioso e sia perciò poco convincente. A spiegare il perché è il prezioso lavoro della storica e filosofa tedesca Bettina Stangneth, La verità del male, pubblicato finalmente in italiano da Luiss University Press.
Il volume imponente, che si legge però con facilità - anche perché ha quasi le caratteristiche di un giallo - è la raccolta meticolosa di prove, testimonianze, documenti inediti, soprattutto le cosiddette Carte argentine, da cui emerge un Eichmann ben diverso da quello descritto da Arendt.
Si capisce perché il libro di Stangneth sia stato un successo sia in Germania, sia soprattutto in America. Ha scritto Steven Aschheim, professore emerito della Università Ebraica e storico della cultura: «Non sarà più possibile in futuro occuparsi del “fenomeno Eichmann” e delle sue implicazioni politiche senza confrontarsi con La verità del male».
Vale la pena ricordare che il titolo del libro in tedesco è Eichmann prima di Gerusalemme (diventato il sottotitolo nell’edizione italiana). Esplicito è dunque il rinvio ad Arendt, verso la quale Stangneth riconosce il suo debito. Ma il suo interesse si concentra sulla figura del gerarca nazista prima di Gerusalemme, cioè nel periodo che va dal 1945 fino al 23 maggio 1960, quando il premier israeliano David Ben Gurion annunciò al mondo che l’architetto della Shoah era stato catturato dagli agenti del Mossad in Argentina e che sarebbe stato presto processato.
Grazie a numerosi appoggi e complicità, Eichmann si era infatti imbarcato a Genova, con il falso nome di Ricardo Klement, ed era riuscito a raggiungere l’Argentina nel luglio del 1950. Aveva cominciato allora una nuova vita grazie alla sua capacità di reinventarsi, senza per questo venir mai meno alla fede nazionalsocialista. Come d’altronde i molti nazisti che avevano trovato rifugio in Sudamerica.
Le Carte argentine sono gli appunti di Eichmann in esilio, nonché i dialoghi e le interviste protocollati, da cui fra l’altro viene fuori l’impressionante rete di rapporti che intratteneva un po’ ovunque nel mondo. Il primo risultato della ricerca di Stangneth è la decostruzione di un mito: quello dell’ex nazista isolato, che cerca di nascondersi, nel tentativo di dimenticare ed essere dimenticato. Nulla di tutto ciò.
La sua vita sociale in Argentina mostra che il grande esperto della «questione ebraica», l’amico del Gran Mufti, il boia che considerava la Shoah il suo «capolavoro», non solo non aveva mai rivisto le sue convinzioni politiche, ma si preparava semmai a realizzarle sotto nuovi cieli e in altre terre.
Bettina Stangneth, nata e cresciuta nella Repubblica federale tedesca, riflette criticamente sul ruolo giocato in quegli anni dalla Germania. Il «fenomeno Eichmann» non si limitava solo all’Argentina. Che il principale stratega e testimone di quei crimini contro l’umanità, che pesavano sul popolo tedesco, fosse ancora in vita, costituiva certo un ostacolo che rendeva difficile, se non impossibile, una rielaborazione del passato.
Eichmann era talmente sicuro di sé che si era persino spinto a scrivere una lettera aperta al cancelliere Konrad Adenauer. Quasi a voler suggellare quella continuità, che molti congetturavano, tra il vecchio regime e la nuova repubblica. E Stangneth denuncia il rifiuto delle autorità tedesche che ancor oggi custodiscono gli atti su Eichmann, preclusi al pubblico con la scusa che potrebbero provocare turbamento. Né isolato, né pentito - ma neppure un burocrate.
Arendt è caduta nella trappola ben congegnata dallo stesso Eichmann che, una volta catturato, scelse intenzionalmente la maschera dell’inetto impiegato, del grigio funzionario. Lui che era considerato più intelligente e astuto di ogni altro, lui che aveva concepito e guidato lo sterminio. Sperava di aver salva la vita attraverso quell’abile manipolazione. Non ci riuscì. Ma ottenne almeno di passare alla storia come esponente di un male banale. È tempo di conoscere la sua storia e il male che ha consapevolmente compiuto.
- ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. -- "Eichmann prima di Gerusalemme. La vita non verificata di un assassino di massa" (Bettina Stangneth).11 giugno 2017, di Federico La Sala
Eichmann era un cinico nazista, non la "banalità del Male"di Mario Avagliano *
Adolf Eichmann, ovvero il Male non banale. A 51 anni dalla pubblicazione del libro di Hannah Arendt Eichmann in Jerusalem, proposto in Italia da Feltrinelli con il titolo La banalità del male, una nuova ricerca demolisce le tesi della studiosa tedesca naturalizzata americana, che nel 1961 seguì per la rivista New Yorker le 121 udienze del processo in Israele a uno dei principali responsabili della macchina della soluzione finale, condannato a morte e impiccato l’anno dopo.
E capovolge la rappresentazione del criminale di guerra nazista fatta dalla Arendt come «un esangue burocrate» che si limitava ad eseguire gli ordini e ad obbedire alle leggi.
A firmare il saggio, uscito questa settimana negli Stati Uniti per i tipi di Alfred A. Knopf e già recensito con grande rilievo dal New York Times, è una filosofa tedesca che vive ad Amburgo, Bettina Stangneth, che ha lavorato attorno alla figura di Eichmann per oltre un decennio, scavando a fondo sulla sua storia. Ne è venuto fuori un libro provocatoriamente intitolato Eichmann prima di Gerusalemme. La vita non verificata di un assassino di massa, già pubblicato con scalpore in Germania.
Se ascoltando Eichmann a Gerusalemme, la Arendt rimase impressionata dalla sua «incapacità di pensare», invece analizzando l’Eichmann capo della sezione ebraica della Gestapo, e poi in clandestinità in Sudamerica, la Stangneth vede all’opera un abile manipolatore della verità, tutt’altro che un “funzionario d’ordine” o «un piccolo ingranaggio dell’enorme macchina di annientamento di Hitler», come si autodefinì nel corso del suo processo. Adolf fu un carrierista rampante e ambizioso e un nazista fanatico e cinico, che agì con incondizionato impegno per difendere la purezza del sangue tedesco dalla “contaminazione ebraica”.
In passato già vari ricercatori avevano seriamente messo in discussione le conclusioni della Arendt. Ma con questo libro la Stangneth le "frantuma" definitivamente, come ha dichiarato Deborah E. Lipstadt, storica alla Emory University e autrice di un libro sul processo Eichmann. La Stangneth sostiene che la Arendt, morta nel 1975, fu ingannata dalla performance quasi teatrale di Eichmann al processo. E aggiunge che forse «per capire uno come Eichmann, è necessario sedersi e pensare con lui. E questo è il lavoro di un filosofo».
LA RICERCA
La filosofa tedesca ha però lavorato come uno storico, rovistando in ben 30 archivi internazionali e consultando migliaia di documenti, come le oltre 1.300 pagine di memorie manoscritte, note e trascrizioni di interviste segrete rilasciate da Eichmann nel 1957 a Willem Sassen, un giornalista olandese ex nazista residente a Buenos Aires.
Un libro che rivela tanti dettagli inediti, come la lettera aperta scritta nel 1956 da Eichmann al cancelliere tedesco occidentale, Konrad Adenauer, per proporre di tornare in patria per essere processato e informare i giovani su ciò che era realmente accaduto sotto Hitler (conservata negli archivi di stato tedeschi), oppure la riluttanza dei funzionari dell’intelligence della Germania Ovest - che sapevano dove si trovava Eichmann già nel 1952 - ad assicurare lui e altri ex gerarchi nazisti alla giustizia. Ma il cuore del libro è il ritratto di Eichmann “esule” in Argentina, dove venne scovato e arrestato dagli agenti segreti del Mossad.
All’apparenza era diventato un placido allevatore di conigli, con il nome di Ricardo Klement. In realtà l’ex gerarca nazista aveva conservato l’arroganza di un tempo e non era niente affatto pentito, tanto da spiegare la sua “attività” con una tirata che a leggerla lascia inorriditi. «Se 10,3 milioni di questi nemici fossero stati uccisi - disse degli ebrei - allora avremmo adempiuto il nostro dovere».
Altrettanto interessante è la descrizione del cerchio magico di ex nazisti e simpatizzanti nazisti che lo circondava in Sudamerica. Personaggi che formavano una sorta di perverso club del libro, che s’incontrava quasi ogni settimana a casa di Willem Sassen per lavorare nell’ombra contro la narrazione pubblica emergente della Shoah, discutendo animatamente su ogni libro o articolo che usciva sull’argomento. Con l’obiettivo di fornire materiale per un libro che avrebbe raffigurato l’Olocausto come una esagerazione ebraica, «la menzogna dei sei milioni» di morti.
Eichmann, il boia nazista chiese la grazia a Gerusalemme
di Mario Avagliano *
Fino all’ultimo momento il criminale nazista Adolf Eichmann provò a negare le sue responsabilità nella Shoah, affermando di essere stato un «semplice strumento» di Adolf Hitler. È quanto risulta dalla lettera manoscritta dello stesso Eichmann, datata 29 maggio 1962, che oggi, in occasione della Giornata della Memoria, il presidente israeliano Reuven Rivlin ha deciso per la prima volta di rendere pubblica. Una missiva di quattro pagine, indirizzata all’allora presidente d’Israele Yitzhak Ben-Zvi, di cui già si conosceva l’esistenza (ne aveva parlato tra gli altri Hannah Arendt nel suo libro La banalità del male), ma non il contenuto.
Nella lettera Eichmann sosteneva che il tribunale israeliano avesse esagerato il suo ruolo nell’organizzazione della logistica della «soluzione finale», vale a dire nello sterminio degli ebrei. «Bisogna distinguere i responsabili dalle persone che come me sono state semplici strumenti nelle loro mani», scrisse l’ex ufficiale delle SS. «Io non ero un responsabile e non mi sento quindi colpevole» (...) «pertanto non ritengo giusto il giudizio della corte e vi chiedo, signor presidente, di esercitare il vostro diritto a concedermi la grazia, così che la condanna a morte non venga eseguita».
In realtà il funzionario tedesco, classe 1906, era stato uno dei protagonisti della persecuzione degli ebrei in Europa. Già all’età di ventotto anni venne incaricato dalla Gestapo di occuparsi della questione ebraica. Segretario della conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942 che decise la «soluzione finale», curò in prima persona il meticoloso piano dei trasporti ferroviari di deportazione degli ebrei, contribuendo al perfetto funzionamento della macchina di morte nei lager di Auschwitz e della Polonia orientale (Belzec, Sobibor, Treblinka).
Nel 1945 Eichmann, al pari di altri gerarchi nazisti, riuscì a far perdere le proprie tracce, imbarcandosi nel 1950 a Genova per l’Argentina, con un passaporto falso intestato a Ricardo Klement. Il funzionario nazista lavorava in uno stabilimento della Mercedes a Buenos Aires quando venne individuato dagli agenti del Mossad, i servizi segreti israeliani. Rapito l’11 maggio 1960, fu trasportato a bordo di un aereo in Israele, dove venne processato e condannato a morte nel 1961.
La lettera - insieme a quella con cui Ben-Zvi respinse la richiesta di grazia - è stata esposta nella residenza dell’attuale presidente israeliano Reuven Rivlin, nell’ambito di una mostra inaugurata ieri e dedicata al celebre processo del 1961, che riaccese l’attenzione sulla Shoah, mandato in onda in diretta tv mondiale e svoltosi presso il Beit Haam, la Casa del Popolo di Gerusalemme.
Proprio in questi giorni è uscito in numerose sale cinematografiche italiane, come evento speciale per la Giornata della Memoria, The Eichmann Show, film di produzione britannica, diretto da Paul Andrew Williams, che ripercorre tutte le tappe produttive della diretta televisiva delle 121 udienze del processo, narrando fra l’altro, grazie a videocamere nascoste, le reazioni di Eichmann di fronte alle testimonianze dei sopravvissuti.
Eichmann venne impiccato poco prima di mezzanotte del 31 maggio 1962 in una prigione a Ramia. Come prescriveva il verdetto, il suo cadavere venne cremato e le sue ceneri disperse da una motovedetta israeliana nel Mediterraneo, al di fuori delle acque territoriali d’Israele.
Il suo processo venne seguito per la rivista New Yorker da Hannah Arendt, che lo descrisse come «un esangue burocrate» che si limitava ad eseguire gli ordini e ad obbedire alle leggi. Una tesi poi messa in discussione da vari studiosi e che è stata di recente demolita da un saggio della filosofa tedesca Bettina Stangneth, intitolato Eichmann prima di Gerusalemme. La vita non verificata di un assassino di massa, che lo ha identificato come un carrierista rampante e ambizioso e un nazista fanatico e cinico, che agì con incondizionato impegno per difendere la purezza del sangue tedesco dalla «contaminazione ebraica».
*
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO. RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD --- NEL NOME DI MOSE’ (di Roberto Saviano).7 maggio 2017, di Federico La Sala
- «Superman è senza dubbio ebreo!». Oltre-uomo o..... Superuomo (Nietzsche)? Il lato inquietante di una storia. Una nota di Elena Loewenthal
Nel nome di Mosé
È un prete, vive in Svizzera e lo chiamano così. Ogni giorno divide le acque per i rifugiati. Salvando vite. E invitandoci a restare umani
- Padre Mussie Zerai
Ascoltare parole e approfondire. Non lasciarle macinare dal vortice. Nella trama delle parole scelte c’è l’interpretazione del mondo stesso. Quando il vicepresidente della Camera ha usato la parola “taxi” riferita alle imbarcazioni che salvano vite, ha descritto con una parola che sa di comodità una situazione di disperazione.
Poi ha cercato di recuperare distinguendo tra «ong buone e ong cattive». E poi la frase di rito, facile da dire e facile da applaudire: «Che la magistratura faccia il suo corso», pietra tombale su ogni ragionamento. Lo scopo è stato raggiunto e le ong diventano “complici” di malviventi difficilmente identificabili (un capro espiatorio serve e da qualche parte va trovato). Le espressioni da cui vengono accompagnate ormai sono: «improvvisamente proliferate», «finanziate da chi ha interesse a destabilizzare l’Europa» e a usarle è chi sa che non sono proliferate all’improvviso e che sono altri i fattori che destabilizzano l’Europa. Ad esempio la crisi economica, che non è scaturita dall’arrivo di migranti. Ma quanto è più facile dire: state male perché siete invasi, piuttosto che: continuate a stare male perché il nuovo che avanza è uguale al vecchio. Dietro le polemiche sulle ong nessuna volontà di fare chiarezza, ma solo razzismo, quello acchiappavoti e quello di chi ha completamente abdicato al ragionamento.
Vi racconto la storia di un uomo che dal 2003 salva vite. È un prete cattolico di origini eritree che oggi vive in Svizzera. Si chiama Mussie Zerai: Mosé lo chiamano i migranti, perché in qualche modo divide le acque per far arrivare i naufraghi sulla terraferma. Nel 2003 Gabriele Del Grande gli chiese di tradurre le testimonianze di alcuni rifugiati eritrei che erano in un centro di detenzione in Libia dopo aver tentato di migrare verso l’Europa.
Padre Zerai rimase scioccato dalle storie dei suoi connazionali che gli raccontarono la vita in quella prigione, tanto che prese l’impegno di denunciare la situazione e lasciò il suo numero di cellulare ai prigionieri. Nei giorni che seguirono quell’incontro iniziò a ricevere telefonate da migranti che erano in mezzo al mare, che chiedevano aiuto. Come era possibile che chiamassero lui? Semplice. Qualcuno aveva inciso il suo numero su una parete del carcere in Libia con sotto scritto: «In caso di emergenza chiamate questo numero». Lo aveva letto una donna, che se l’era trascritto sulle mani e dalle mani lo aveva trascritto sui legni di un barcone durante il suo viaggio dalla Libia verso Lampedusa.
I migranti, in genere, scrivono il numero dei familiari sui vestiti, in modo che si sappia a chi restituire la salma in caso finisse male, lei invece aveva scritto il numero di Padre Mosé, perché fosse visibile in caso di emergenza. Da quel giorno il cellulare di Padre Zerai non ha più smesso di squillare. A chiamarlo sono indifferentemente cattolici, musulmani, ortodossi, a cui è stato detto che Padre Zerai è capace di far comparire una scialuppa di salvataggio in mezzo al mare. Succede questo: quando le cose si mettono male in mare, chiamano padre Mosé e lui cerca di organizzarne il salvataggio, comunicando alla Guardia Costiera italiana più informazioni possibili per andare a prestare soccorso. Secondo le autorità italiane il cellulare di Padre Zerai ha permesso di salvare finora almeno 5 mila vita umane.
E poi c’è Nawal Soufi, chiamata la vedetta del Mediterraneo. Nawal Soufi è nata in Marocco, vive a Catania ed è diventata un punto di riferimento per chi fugge verso l’Italia. «Tutti hanno il mio numero, ne ho salvati a migliaia», dice. Il suo contatto passa tra chi fugge dalla guerra tentando l’approdo sulle coste europee. I profughi l’hanno soprannominata Lady SOS perché la chiamano dai barconi in difficoltà per dare le loro coordinate prima di affondare. E lei lancia l’allarme telefonando alla Guardia Costiera con un cellulare vecchio di 10 anni «perché almeno la batteria dura 4 giorni e posso essere sempre reperibile». Presta gratis questo servizio da oltre due anni ed è stata anche denunciata per aver facilitato l’immigrazione illegale (per la Bossi-Fini la solidarietà è un crimine). Nawal è in Italia da quando aveva un mese, studia Scienze Politiche e parla perfettamente italiano, la sua storia l’ha raccontata Daniele Bella nel libro “Nawal, l’angelo dei profughi”.
Immagino Padre Zerai e Nawal Soufi chiedere al telefono: «Mi scusi, non sarà mica uno scafista, perché nel caso sa che le dico, potete pure morire tutti».
Saviano: “Mosè per me era un amico immaginario, un alleato, un supereroe”
di Gisella Ruccia *
“Non ho mai visto Mosè come una una severa figura, la più importante dell’ebraismo, ma l’ho visto quasi come un alleato, una di quelle figure a cui parlare come un amico immaginario“. Sono le parole di Roberto Saviano ai microfoni di “Sorgente di vita”, il programma di Rai Due curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dedicato alla cultura ebraica.
Lo scrittore, che ha aperto quest’anno il Festival internazionale della letteratura e cultura ebraica di Roma, racconta il suo amore e la sua ammirazione per l’ebraismo. “La cultura ebraica non mi ha semplicemente attratto, ma formato” - afferma - “Gli scrittori ebrei mi hanno insegnato a non disperare, a cercare sempre una via d’uscita”.
E rivela: “I racconti biblici di mio nonno per me sono stati fondamentali. Quando ero bambino, Mosè era davvero un supereroe. Accanto a Batman, Superman, Spiderman, l’Uomo Tigre, c’era Mosè. Lui era il balbuziente che guida un intero popolo, sbaglia di continuo, viene punito sempre per il minimo errore”. Saviano aggiunge: “Ci penso spesso a Mosè e penso spesso a me bambino che guardava a Mosè come qualcuno che, anche se sbagliava, sapeva che poteva farcela e poteva farcela a trovare un senso alle cose”
di Gisella Ruccia
* The Huffington, 31 luglio 2013 (ripresa parziale - con video).
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. -- La perversione del senso del 25 aprile (di Moni Ovadia).23 aprile 2017, di Federico La Sala
La perversione del senso del 25 aprile
Polemiche. Le bandiere palestinesi al corteo? Un vulnus inaccettabile per il presidente della comunità ebraica romana Pacifici e per qualche ultrà del sionismo più isterico. Ma screditando le ragioni di chi lotta per una Palestina libera si sovverte il significato della Resistenza
di Moni Ovadia (il manifesto, 11.04.2015/23.04.2017)
Nel corso della mia vita e da che ho l’età della ragione, ho cercato di partecipare, anno dopo anno a ogni manifestazione del 25 aprile.
Un paio di anni fa, percorrendo il corteo alla ricerca della mia collocazione sotto le bandiere dell’Anpi, mi imbattei nel gruppo che rappresentava i combattenti della “brigata ebraica”, aggregata nel corso della seconda guerra mondiale alle truppe alleate del generale Alexander e impegnata nel conflitto contro le forze nazifasciste. Qualcuno dei componenti di quel drappello mi riconobbe e mi salutò cordialmente, ma uno di loro mi rivolse un invito sgradevole, mi disse: «Vieni qui con la tua gente». Io con un gesto gli feci capire che andavo più avanti a cercare le bandiere dell’Anpi che il 25 aprile è «la mia gente» perché io sono iscritto all’Anpi con il titolo di antifascista. Lui per tutta risposta mi apostrofò con queste parole: «Sì, sì, vai con i tuoi amici palestinesi».
Il tono sprezzante con cui pronunciò la parola palestinesi sottintendeva chiaramente «con i nemici del tuo popolo». Io gli risposi dandogli istintivamente del coglione e affrettai il passo lasciando che la sua risposta, sicuramente becera si disperdesse nell’allegro vociare dei manifestanti.
Questo episodio, apparentemente innocuo, mi fece scontrare con una realtà assai triste che si è insediata nelle comunità ebraiche.
I grandi valori universali dell’ebraismo sono stati progressivamente accantonati a favore di un nazionalismo israeliano acritico ed estremo. Un nazionalismo che identifica stato con governo.
Naturalmente non tutti gli ebrei delle comunità hanno imboccato questa deriva sciovinista, ma la parte maggioritaria, quella che alle elezioni conquista sempre il “governo” comunitario, fa dell’identificazione di ebrei e Israele il punto più qualificante del proprio programma al quale dedica la prevalenza delle sue energie.
Io ritengo inaccettabile questa ideologia nazionalista, in primis come essere umano perché il nazionalismo devasta il valore integro e universale della persona, poi come ebreo, perché nessun altro flagello ha provocato tanti lutti agli ebrei e alle minoranze in generale e da ultimo perché, come insegna il lascito morale di Vittorio Arrigoni, io non riconosco altra patria che non sia quella dei diseredati e dei giusti di tutta la terra.
L’ideologia nazionalista israeliana negli ultimi giorni ha fatto maturare uno dei suoi frutti tossici: la decisione presa dalla comunità ebraica di Roma, per il tramite del suo presidente Riccardo Pacifici, di non partecipare al corteo e alla manifestazione del prossimo 25 aprile. La ragione ufficiale è che nel corteo sfileranno bandiere palestinesi, vulnus inaccettabile per il presidente Pacifici, in quanto nel tempo della seconda guerra mondiale, il gran muftì di Gerusalemme Amin al Husseini, massima autorità religiosa sunnita in terra di Palestina fu alleato di Hitler, favorì la formazione di corpi paramilitari musulmani a fianco della Germania nazista e fu fiero oppositore dell’instaurazione di uno stato Ebraico nel territorio del mandato britannico. Mentre la brigata ebraica combatteva con gli alleati contro i nazifascisti. Tutto vero, ma il muftì nel 1948 venne destituito e arrestato: oggi vedendo una bandiera palestinese a chi viene in mente il gran muftì di allora? Praticamente a nessuno, se si eccettua qualche ultrà del sionismo più isterico o qualche fanatico modello Isis.
Oggi la bandiera palestinese parla a tutti i democratici di un popolo colonizzato, occupato, che subisce continue e incessanti vessazioni, che chiede di essere riconosciuto nella sua identità nazionale, che si batte per esistere contro la politica repressiva del governo di uno stato armato fino ai denti che lo opprime e gli nega i diritti più elementari ed essenziali. Un governo che lo umilia escogitando uno stillicidio di violenze psicologiche e fisiche e pseudo legali per rendere esausta e irrilevante la sua stessa esistenza.
Quella bandiera ha pieno diritto di sfilare il 25 aprile - com’è accaduto per decenni e senza polemica alcuna - e glielo garantisce il fatto di essere la bandiera di un popolo che chiede di essere riconosciuto, un popolo che lotta contro l’apartheid, contro l’oppressione, per liberarsi da un occupante, da una colonizzazione delle proprie legittime terre, legittime secondo la legalità internazionale, un popolo che vuole uscire di prigione o da una gabbia per garantire futuro ai propri figli e dignità alle proprie donne e ai propri vecchi, un popolo la cui gente muore combattendo armi alla mano contro i fanatici del sedicente Califfato islamico nel campo profughi di Yarmouk, nella martoriata Damasco.
E degli ebrei che si vogliono rappresentanti di quella brigata ebraica che combatté contro la barbarie nazifascista hanno problemi ad essere un corteo con quella bandiera? Allora siamo alla perversione del senso ultimo della Resistenza.
La verità è che quella del gran muftì di allora è solo un pretesto capzioso e strumentale. Il vero scopo del presidente Pacifici e di coloro che lo seguono - e addolora sapere che l’Aned condivide questa scelta -, è quello di servire pedissequamente la politica di Netanyahu, che consiste nello screditare chiunque sostenga le sacrosante rivendicazioni del popolo palestinese.
Per dare forza a questa propaganda è dunque necessario staccare la memoria della persecuzione antisemita dalle altre persecuzioni del nazifascismo e soprattutto dalla Resistenza espressa dalle forze della sinistra. È necessario discriminare fra vittima e vittima israelianizzando la Shoah e cortocircuitando la differenza fra ebreo d’Israele ed ebreo della Diaspora per proporre l’idea di un solo popolo non più tale per il suo legame libero e dialettico con la Torah, il Talmud e il pensiero ebraico, bensì un popolo tribalmente legato da una terra, da un governo e dalla forza militare.
Se come temo, questo è lo scopo ultimo dell’abbandono del fronte antifascista con il pretesto che accoglie la bandiera palestinese, la scelta non potrà che portare lacerazioni e sciagure, come è vocazione di ogni nazionalismo che non riconosce più il valore dell’altro, del tu, dello straniero come figura costitutiva dell’etica monoteista ma vede solo nemici da sottomettere con la forza.
-
> ISRAELE: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. --- Cesare Lombroso sionista riluttante (di Emanuele D’Antonio)11 novembre 2016, di Federico La Sala
Padre della antropologia criminale Cesare Lombroso (Verona 1835 - Torino 1909) era alla fine dell’Ottocento uno degli scienziati più noti a livello internazionale
Cesare Lombroso sionista riluttante
Nel 1898 Theodor Herzl tentò di conquistare lo scienziato alla causa del nazionalismo ebraico: lo rivela un carteggio
di Emanuele D’Antonio (La Stampa, 11.11.2016)
Nell’estate del 1898 Theodor Herzl, il fondatore del sionismo politico, tentò di conquistare Cesare Lombroso alla causa del nazionalismo ebraico. L’episodio, documentato da alcuni carteggi inediti conservati presso il Museo Lombroso di Torino e i Central Zionist Archives di Gerusalemme, riporta alla luce una pagina poco nota di storia dell’ebraismo nella turbolenta fin-de-siècle europea. Il sionismo si era costituito in soggetto politico al Congresso di Basilea del 1897, nel nome dell’autodifesa dall’antisemitismo e della preservazione dell’identità ebraica dalla «assimilazione».
Il nuovo movimento spaccò l’ebraismo europeo, suscitando entusiasmi ma anche ostilità. L’ideologia dell’emancipazione, egemonica nelle Comunità, ne criticava il carattere «antimoderno», pericoloso per le conquiste seguite all’affrancamento dal ghetto. È dunque in un contesto di forte conflittualità interna che, alla vigilia del secondo Congresso di Basilea, si inscrive l’abboccamento di Herzl a Lombroso. Il veronese, docente di Psichiatria a Torino e padre dell’antropologia criminale, non era solo una celebrità internazionale della scienza e della cultura ma anche uno dei più noti intellettuali ebrei dell’epoca. La sua adesione avrebbe prodotto gran clamore, offrendo nuova legittimazione al movimento sionista.
Ebreo «assimilazionista»
Che il compito fosse malagevole, Herzl doveva ben saperlo. Lombroso aveva già detto la sua alla vigilia dello scoppio dell’affaire Dreyfus, nella monografia su L’antisemitismo e le scienze moderne (1894). Lo scienziato aveva allestito un’autorevole difesa dell’emancipazione respingendo, in nome del sapere socio-antropologico, la sfida dei movimenti antisemiti di massa. L’antisemitismo gli appariva uno strumento di propaganda nazionalista, che mobilitava atavici odi etno-religiosi. L’ideale della nazione ariana era fuorviante e regressivo: il métissage aborrito dagli antisemiti era da secoli realtà e fonte di sviluppo delle società europee. Gli ebrei erano una popolazione «più aria che semita», protesa all’integrazione nel corpo nazionale e, dove emancipati, alfieri del progresso comune.
Il discorso lombrosiano si faceva ferocemente critico, trattando di alcuni usi ebraici, a suo dire, residuali e anacronistici. Lombroso, ribadita la bontà dell’emancipazione, dava voce alla sua identità di ebreo «assimilazionista»: l’umanità era chiamata a superare le appartenenze tradizionali, raccogliendosi in una nuova solidarietà universale. Il sionismo, in questo quadro, non poteva trovare alcuno spazio.
Il viennese Nathan Birnbaum, importante figura della fase pre-herzliana, lo aveva interpellato al riguardo. Lombroso gli riservò una cocente delusione: il suo progetto era un’utopia antistorica e irrealizzabile. La Palestina era «un deserto» poco attraente per gli ebrei d’Europa, legati da vivissimo amore alle loro patrie. I «pochi fanatici» disponibili a migrarvi, russi e romeni incolti, non erano in grado di portare avanti ambiziosi progetti di colonizzazione agraria. Il precedente era ben poco incoraggiante.
«Troppo vecchio...»
Nel luglio 1898 Herzl gli inviò fiducioso una propria brochure. Lo scienziato, benché non ne fosse molto impressionato, formulò un giudizio positivo grazie alla mediazione della rete familiare e amicale: il tessuto connettivo lo crearono la figlia Gina e il Kulturkritiker Max Nordau, intimo di Lombroso e braccio destro di Herzl. La Welt, organo ufficiale del sionismo, annunciò la sua «conversione», sollecitata dai «figli» e giunta dopo «un lungo dibattito» familiare.
A questo punto Herzl alzò il livello delle richieste, invitandolo nel novero dei suoi opinionisti: «Io credo che [Lombroso]», scriveva alla figlia Gina il 13 luglio, «potrebbe riscontrare più il genio che la follia della razza ebraica in questo movimento [che] abbraccia i figli - e le figlie! - della nostra nazione». Il 29 luglio, la Welt pubblicò in prima pagina il lombrosiano Der Zionismus in Italien und anderswo. Lo scienziato, fatta ammenda del precedente giudizio, legittimava il sionismo quale risorsa per risollevare dall’oppressione le masse ebraiche dell’Europa orientale. La sua testimonianza alimentò la speranza della leadership sionista di riuscire a coinvolgerlo nell’attività del movimento. Alla metà di agosto Lombroso fu acclamato delegato del circolo di Braila, in Romania, all’imminente Congresso di Basilea. Il mandato gli fu comunicato separatamente da Herzl e Nordau. «La nostra causa, che voi stesso giudicate grande», gli scriveva il leader sionista il 19 agosto, «trarrebbe il massimo vantaggio dalla vostra presenza e dall’autorità del vostro nome».
Lombroso non era convinto, né riusciva a concepire il sionismo diversamente da una pratica filantropica. Nordau, ben consapevole, lo invitò a ponderare l’accettazione: «Vi si attaccherà certo in Italia, e voi non avrete altra ricompensa della soddisfazione di coscienza». Il dovere di un buon ebreo, anche alieno a «una parte attiva», era quello di rivendicarsi tale: «Voi apportate una grande forza morale al sionismo, dichiarandovi simpatico ai suoi obiettivi».
Poco dopo Lombroso comunicò a Herzl il rifiuto del mandato: «Troppo vecchio di mente e corpo, non però [...] di spirito, la prego di dire ai suoi amici che se io fossi più giovane [...] sarei uno dei più ardenti partigiani del sionismo». Il messaggio, letto all’assise congressuale, avrebbe scatenato un’ovazione fra i delegati.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- "La legge del sangue" (Johann Chapoutot). La «cultura» della purezza razziale (di Emilio Gentile)16 ottobre 2016, di Federico La Sala
- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo). HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Nazismo
La «cultura» della purezza razziale
La concezione che portò allo sterminio di massa fu attuata non solo da Hitler e dal partito, ma da una foltissima schiera di dotti giuristi, scienziati, medici, teologi e giornalisti
di Emilio Gentile (Il Sole-24 Ore, Domenica, 16.10.2016)
- Johann Chapoutot, La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti , Einaudi, Torino, pagg. 472, € 32
Nel 1945, diciotto medici tedeschi di un ospedale pediatrico furono processati dal tribunale di Amburgo, su iniziativa delle truppe di occupazione britanniche, perché accusati di aver assassinato con iniezioni letali cinquantasei bambini malati. Il direttore dell’ospedale respinse l’accusa di «crimine contro l’umanità» perché tale crimine, disse agli inquirenti britannici, «non può essere commesso che contro uomini, mentre gli esseri viventi di cui dovevamo occuparci non possono essere qualificati come “esseri umani”». Cinque anni dopo, i giudici assolsero gli imputati affermando di «aver creduto alla legalità dei loro atti».
Inizia con questo episodio un’ampia indagine dello storico francese Johann Chapoutot sul modo di pensare e di agire dei nazisti, ricostruito con una folta documentazione di oltre milleduecento libri e articoli pubblicati durante il regime nazista negli ambiti più vari, dai testi ideologici alla letteratura pedagogica, dal diritto alla medicina, dalla biologia alla filosofia, dall’antropologia alla storia e alla geografia, con l’aggiunta di una cinquantina di film prodotti dal Terzo Reich. Dall’indagine, suddivisa per temi, emerge un’elaborata e coerente concezione nazista del mondo, che fu messa in pratica durante i dodici anni del dominio hitleriano. Il nazismo attuò così una rivoluzione culturale oltre che politica, per istituire un diritto, una morale, un’etica e una religione esclusivamente tedesche, fondate sulla superiorità biologica della razza germanica, e per inculcare nel popolo tedesco l’imperativo categorico di preservare la purezza del sangue, che era l’essenza della sua superiorità su tutte le altre razze.
Milioni di tedeschi si convinsero che per preservare l’integrità e la salvezza della razza germanica, era necessario eliminare con la sterilizzazione o l’eutanasia le persone afflitte da mali ereditari; impedire la contaminazione biologica con altre razze; invadere i Paesi dell’Europa orientale per conquistare spazio vitale alla razza germanica e sottomettere gli slavi come schiavi.
E soprattutto si convinsero della necessità inevitabile di una spietata guerra razziale contro gli ebrei, fino alla loro totale eliminazione, perché da seimila anni l’ebreo era il nemico naturale del popolo tedesco, un pericolo mortale per la sua purezza e la sua integrità, come il bacillo della tubercolosi per un corpo sano e vigoroso.
Per molti decenni dopo la fine del regime hitleriano, la concezione nazista del mondo è stata considerata dagli storici una paccottiglia di farneticanti elucubrazioni, esibite da folli criminali per adornare con arcaici miti una sfrenata libidine di potere, che alla fine si sfogò con una barbarica guerra di conquista e con il sadico sterminio organizzato di oltre cinque milioni di ebrei. La follia, la barbarie, il sadismo apparivano motivi sufficienti per spiegare storicamente la criminalità del nazismo, alimentata anche dall’avidità di un capitalismo imperialista che per due volte nell’arco di trent’anni aveva tentato di dare l’assalto al potere mondiale provocando due guerre mondiali.
Comune a queste interpretazioni, osserva Chapoutot, era la «disumanizzazione dei protagonisti del crimine nazista», ma in tal modo, aggiunge, «facendo di loro dei soggetti estranei alla nostra comune umanità, noi ci esoneriamo da ogni riflessione sull’uomo, l’Europa, la modernità, l’Occidente, insomma su tutti i luoghi che i criminali nazisti abitano, dei quali partecipano, e che noi abbiamo in comune con loro», confortandoci al pensiero che «l’idea secondo la quale noi potremmo condividere qualcosa con gli autori di tesi e crimini così mostruosi ci ripugna».
Pur se legittima, tale ripugnanza ci induce però a eludere questioni fondamentali della nostra storia e del nostro tempo, perché le idee della concezione nazista del mondo erano solo in minima parte originaria produzione dei nazisti: «Né il razzismo, né il colonialismo, né l’antisemitismo, né il darwinismo sociale o l’eugenismo sono nati tra il Reno e Memel». Inoltre «la Shoah avrebbe provocato un numero molto minore di vittime se non ci fosse stato lo zelante concorso di poliziotti e di gendarmi francesi e ungheresi», insieme a «innumerevoli nazionalisti baltici, volontari ucraini, antisemiti polacchi, alti funzionari e uomini politici pervasi da volontà di collaborazione». Come lo furono, in Italia, politici, funzionari e intellettuali fascisti.
Vi erano tuttavia movimenti culturali tedeschi che fin dall’Ottocento avevano diffuso con convinzione le idee sopra citate, e la loro presenza favorì il successo della concezione nazista, che dopo il 1933 fu messa in pratica con ossessiva tenacia non solo da Hitler e dal partito nazista, ma da una foltissima schiera di dotti giuristi, scienziati, medici, teologi, ideologi e giornalisti, con l’ausilio del cinema di finzione e del cinema documentario. Milioni di tedeschi, sia persone di elevata cultura sia gente comune, si convinsero che gli ebrei tramavano da seimila anni per distruggere il popolo tedesco, inquinandolo con incroci di sangue e con idee disgregatrici, come il cristianesimo, il diritto romano, l’individualismo, l’universalismo, l’umanitarismo, il liberalismo, il socialismo, il bolscevismo. Queste idee minavano le virtù, la morale, l’etica, le tradizioni e l’integrità della comunità germanica.
Fu la concezione nazista del mondo, diffusa con martellante, capillare, pervasiva propaganda quotidiana, a trasformare milioni di uomini e donne, non predestinati alla follia né al crimine, in zelanti esecutori della persecuzione e dello sterminio. Ogni tentazione alla pietà fu anestetizzata con l’invocazione della necessità di agire con mezzi spietati per annientare i nemici della razza germanica che da seimila anni tramavano per annientarla.
Conoscere il modo di pensare e di agire dei nazisti considerandoli uomini cresciuti e vissuti in contesti particolari, con un proprio universo di significati e di valori, è il compito proprio dello storico, afferma Chapoutot. Ciò non attenua affatto la mostruosità delle idee e dei crimini nazisti: anzi, rende ancora più consapevoli della sua gravità, perché nulla esclude che tale mostruosità possa ripetersi, con altre idee e in altri contesti, nell’azione di altri uomini convinti che essa sia necessaria per salvare la propria comunità.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---Mein Kampf in edicola, scherzare con il fuoco. Non è un libro normale, è un inno allo sterminio.15 giugno 2016, di Federico La Sala
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
Mein Kampf in edicola, scherzare con il fuoco
L’iniziativa de Il Giornale. La scelta di Sallusti non offende solo la sensibilità degli ebrei, come si sente dire da più parti, ma il buonsenso di tutte le persone civili. Al di la della illeggibilità di un testo infarcito delle farneticazioni di un tribuno da operetta che sfruttava il disorientamento di un popolo, ciò che impressiona oggi è l’ingenuità della sua riproposizione come se in esso si trovasse anche l’antidoto ai veleni di cui esso stesso è portatore.
di Enzo Collotti (il manifesto, 14.06.2016)
La trovata de Il Giornale di distribuire il Mein Kampf per aumentare le vendite è semplicemente indecente. Non si capisce se è una trovata spregiudicata o se vuole essere un ammiccamento morboso ad uso di un pubblico sicuramente non avvezzo a bocconi così forti.
Certo non è una lettura neutrale, e il proposito di farne l’introduzione ad una serie di pubblicazioni sul nazismo non rende l’idea meno perversa. Essa sfrutta l’appeal che continua ad avere il Führer in virtù dell’attrazione del mostro ma senza fornire gli strumenti per neutralizzarlo.
È un po’ scherzare con il fuoco, come se in un frangente in cui tornano virulenti populismi e razzismi nelle più diverse matrici ci fosse ancora bisogno di normalizzare l’orrore offrendolo in pasto agli ignari lettori fuori dal contesto in cui il Führer lo concepì e a distanza di quasi un secolo dalla sua originaria pubblicazione.
Un anacronismo, si direbbe, se non fosse che c’è ancora qualcuno che pensa a pulizie etniche, a muri di separazione, a gerarchie di razza, ad egoistici esclusivismi e che potrebbe trovare in un simile oggetto incoraggiamento e argomenti.
Al di la della illeggibilità di un testo infarcito delle farneticazioni di un tribuno da operetta che sfruttava il disorientamento di un popolo uscito dalla sconfitta, dalla catastrofe economica e dalla demoralizzazione e che prometteva con freddo calcolo l’assassinio di milioni di esseri umani, ciò che impressiona oggi è l’ingenuità della sua riproposizione come se in esso si trovasse anche l’antidoto ai veleni di cui esso stesso è portatore.
Il fatto singolare è che mentre in Germania, come cercheremo di spiegare in altra sede, si procede con cautela a ristampare con un’edizione «critica», corredata da un autorevole e anche troppo pignolesco commento di accompagnamento, il testo incriminato, in Italia senza troppi complimenti lo si distribuisce quasi gratuitamente e senza troppo curarsi della sua correttezza non dico filologica ma neppure logica.
Si tratti di una consapevole provocazione o di una operazione mirata e sicuramente male architettata, l’iniziativa de Il Giornale non offende solo la sensibilità degli ebrei, come si sente dire da più parti, ma il buonsenso di tutte le persone civili che sono messe a confronto con uno dei capolavori del pensiero perverso senza essere necessariamente preparati a svelenirne il contenuto.
Sarebbe vano invocare censure, dovremmo contare solo sulle capacità di ciascuno di esercitare la propria censura interna e di avere una cultura e un’educazione storica e politica superiori a quella dei media che insieme al buon senso insidiano la buona fede e la curiosità dello sprovveduto lettore attratto dall’apparente novità nel singolare quanto orrido messaggio.
Mein Kampf
Non è un libro normale, è un inno allo sterminio
di Donatella Di Cesare (Corriere Sera, 14.06.2016)
Hitler non si addice alle edicole. La scelta di «regalare» Mein Kampf come allegato deve essere condannata con grande fermezza da una società civile. Quali che siano i motivi reconditi che possono aver spinto il Giornale a diffondere il libro di Hitler, si tratta di una scelta gravissima, irragionevole e ingiustificabile.
Questo fatto - come ha dichiarato Efraim Zuroff, direttore del Centro Wiesenthal di Gerusalemme - è «senza precedenti». Non stupisce che la stampa internazionale abbia dato rilievo alla notizia. Dalla Frankfurter Allgemeine a Die Welt e al Washington Post , per citare solo alcune testate, lo sconcerto è unanime. E ci si chiede come mai, nell’Italia di oggi, Hitler possa tornare a essere popolare.
Il «regalo» è giunto sabato scorso - per gli ebrei alla vigilia di Shavuot, la festa in cui si ricorda il dono della Torah, il Libro dei libri. Triste coincidenza, dunque, che nelle edicole di un Paese europeo, coinvolto nello sterminio, girasse la «Bibbia del nazismo». Né si può sorvolare su una coincidenza inquietante: solo pochi giorni fa è stata finalmente approvata la legge contro il negazionismo.
Vuoi per richiamo morboso, vuoi per banale interesse, nelle edicole l’allegato è esaurito. Questa sarebbe una operazione culturale? Distribuire il secondo volume del testo di Hitler, intitolato La mia battaglia , nella vecchia edizione Bompiani del 1937? Non è una edizione critica: non ci sono né note, né commenti. Non può farne le veci la breve e discutibile introduzione di Francesco Perfetti, il quale sembra ignorare il successo ottenuto, persino nel mondo accademico tedesco, dall’«antisemitismo della ragione» propugnato da Hitler. L’edizione critica, pubblicata in Germania nel gennaio del 2016, è costituita da due volumi di 2.000 pagine e corredata da ben 3.500 note.
Ma arriviamo al punto. I campioni dell’ultraliberalismo hanno gridato alla censura e si sono appellati alla necessità di leggere Hitler come «documento storico». Qui è bene chiarire: Mein Kampf non è un libro come un altro. Non può essere paragonato ad altri libri antisemiti che hanno propagato e propagano ancor oggi le teorie del complotto. Mein Kampf è il libro che contiene il primo progetto di sterminio planetario del popolo ebraico.
Chi lo ha letto lo sa. E sa giudicare la gravità incommensurabile di quelle pagine che preludono all’annientamento. Per Hitler gli ebrei sono gli «stranieri», che cancellano i confini - quelli geografici e quelli tra i popoli. Distruggono gli altri per dominare il mondo; la loro «vittoria» sarebbe «la ghirlanda funeraria dell’umanità», decreterebbe la fine del cosmo. Il pericolo maggiore viene indicato nella possibile fondazione di uno «Stato ebraico». Perché non ci deve essere luogo alcuno, per gli ebrei, nel mondo. Di qui l’annientamento.
Dare allora queste pagine da leggere senza una guida critica? Certo che occorre conoscere Mein Kampf . E chi responsabilmente si occupa della Shoah lo legge e lo fa leggere. Non era necessario che il Giornale degradasse la cultura italiana per avvertirci che il male si deve conoscere. Noi il male non lo dimentichiamo. Ma siamo convinti che uno studio critico, come quello che d’altronde già si compie in molte università e scuole italiane, sia la strada giusta per conoscere il passato e per guardare con più consapevolezza al futuro.
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. --- Leggere il Mein Kampf apre gli occhi (di Carlo Rovelli)14 giugno 2016, di Federico La Sala
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
Perché SILeggere il Mein Kampf apre gli occhi
Il volume è utile per capire che il centro delle emozioni dell’estrema destra non è essere forti, ma la paura di essere deboli. Il senso di inferiorità spinge a voler dominare gli altri anche attraverso il terrore
di Carlo Rovelli (Corriere della Sera, 14.06.2016)
Il Giornale propone in edicola copie del libro di Hitler, Mein Kampf. Ci sono ragioni per essere offesi o disgustati da questa scelta, e Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, lo dico apertamente, non è persona che mi piace. Eppure mi sono trovato d’accordo con lui quando, forse un po’ goffamente, ha provato a difendere la sua provocazione dicendo che per combattere un male bisogna conoscerlo.
Ho letto Mein Kampf qualche tempo fa, e effettivamente mi ha insegnato delle cose: cose che non mi aspettavo. Provo a riassumerle. Il nazismo è stato un feroce scatenarsi di aggressività. Dalla notte dei lunghi coltelli alla disperata difesa di Berlino, ha cavalcato la violenza estrema. La giustificazione ideologica immediata per la brutalità e la violenza era la superiorità della razza e della civiltà germanica, l’esaltazione della forza, la lettura del mondo in termini di scontro invece che di collaborazione, il disprezzo per chiunque fosse debole.
Questo pensavo, prima di leggere Mein Kampf. Il libro di Hitler è stato una sorpresa perché mostra cosa c’è alla sorgente di tutto questo: la paura. Per me è stata una specie di rivelazione, che mi ha d’un tratto fatto comprendere qualcosa della mentalità della destra, per me da sempre difficile da cogliere. Una sorgente centrale delle emozioni che danno forza alla destra, e all’estrema destra sopratutto, non è il sentimento di essere forti: è la paura di essere deboli.
In Mein Kampf, questa paura, questo senso di inferiorità, questo senso del pericolo incombente, sono espliciti. Il motivo per cui bisogna dominare gli altri è il terrore che altrimenti ne saremo dominati. Il motivo per cui preferiamo combattere che collaborare è che siamo spaventati dalla forza degli altri. Il motivo per cui bisogna chiudersi in un’identità, un gruppo, un Volk, è per costruire una banda più forte delle altre bande ed esserne protetti in un mondo di lupi. Hitler dipinge un mondo selvaggio in cui il nemico è ovunque, il pericolo è ovunque, e l’unica disperata speranza per non soccombere è raggrupparsi in un gruppo e prevalere.
Il risultato di questa paura è stata la devastazione dell’Europa, e una guerra con un bilancio totale di 70 milioni di morti. Cosa ci insegna questo? Penso che quello che ci insegna è che ciò da cui bisogna difendersi per evitare le catastrofi non sono gli altri: sono le nostre paure degli altri. Sono queste che sono devastanti. È la paura reciproca che rende gli altri disumani e scatena l’inferno. La Germania umiliata e offesa dall’esito della prima guerra mondiale, spaventata dalla forza della Francia e della Russia, è stata una Germania che si è autodistrutta; la Germania che, imparata la lezione sulla sua pelle, si è ricostruita come centro di collaborazione e di resistenza alla guerra è una Germania che è fiorita. A me questo insegnamento suona attuale. Forse ora nel mondo la paura reciproca sta aumentando, non lo so, ma a me sembra che noi siamo i primi ad alimentarla. Chi si sente debole ha paura, diffida degli altri, difende se stesso e si arrocca nel suo gruppo, nella sua pretesa identità. Chi è forte non ha paura, non si mette in conflitto, collabora, contribuisce a costruire un mondo migliore anche per gli altri. Pochi libri svelano questa intima logica della violenza come Mein Kampf.
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- L’altra vita di Otto Skorzeny. Nuovi dettagli sull’ex ufficiale nazista che liberò Mussolini dal Gran Sasso (di Paolo Salom)29 marzo 2016, di Federico La Sala
L’altra vita del capitano Otto Skorzeny
«Diventò un killer del Mossad»
La vera storia dell’SS del Duce
Nuovi dettagli sull’ex ufficiale nazista che liberò Mussolini dal Gran Sasso e dopo la guerra aiutò Israele
di Paolo Salom (Corriere della Sera, 29.03.2016)
«Abbiamo stretto un patto con il diavolo». Questo il pensiero degli agenti del Mossad che nei primi mesi del 1962 riuscirono a «persuadere» Otto Skorzeny - l’ex ufficiale delle SS che liberò Mussolini dal Gran Sasso - a diventare non solo un preziosissimo informatore per il servizio di intelligence del neonato Stato ebraico ma, addirittura, un killer capace di eliminare gli scienziati tedeschi che allora si erano messi al servizio del Paese considerato il nemico numero uno di Israele: l’Egitto. I particolari di come sia avvenuto un simile incontro - una spy story degna di Hollywood - sono raccontati dall’americano The Jewish Forward e dall’israeliano Haaretz . Non è la prima volta che l’episodio viene alla luce. Tanto che persino Benny Morris lo ha citato nel suo saggio «Mossad» (Rizzoli, 2003), ma senza riuscire a rivelare il ruolo di assassino di Skorzeny che gli autori del lungo e dettagliato articolo, Dan Raviv e Yossi Melman, hanno potuto riscontrare grazie alle loro fonti nel segretissimo «Istituto».
Antefatto. Otto Skorzeny, allora 35enne capitano delle SS, nell’estate del 1943 fu incaricato personalmente da Hitler, di cui sarebbe diventato un pupillo, di liberare il Duce, imprigionato a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, per ordine di Badoglio. L’operazione Quercia ebbe luogo il 12 settembre: l’ufficiale nazista scese con una formazione di alianti sull’altipiano. Con lui cento paracadutisti che non trovarono reazione tra gli italiani. Mussolini era libero, pronto a iniziare la tragica epopea della Repubblica sociale; Skorzeny, da quel momento, un eroe e non più capitano: ma tenente colonnello. Le vicende della guerra lo portarono ovunque in Europa. Fu poi processato dagli americani ma riuscì a fuggire, aiutato da complici, e a rifugiarsi in Spagna.
La nuova storia comincia da una notizia di cronaca. L’11 settembre 1962, Heinz Krug, scienziato tedesco che durante la guerra aveva lavorato al programma missilistico nazista nella base di Peenemünde, sparisce senza lasciare traccia. Un giornale israeliano spiega - ma è un depistaggio - che Krug è stato rapito dagli egiziani per «impedirgli contatti con Israele». La verità, emerge ora, è ben diversa. Krug era stato sì rapito. Ma non dagli egiziani: è Skorzeny l’uomo chiave di questa vicenda. Scortato da tre «guardie del corpo» (in realtà agenti del Mossad tra i quali un giovane Yitzhak Shamir, futuro premier di Israele, e un altro, Zvi «Peter» Malkin, membro della squadra che aveva catturato Eichmann in Argentina), Skorzeny porta Krug in una foresta e lo uccide senza esitare un secondo. Lo scienziato si era messo al servizio del programma missilistico egiziano e per questo era diventato un pericolo esistenziale per lo Stato ebraico.
La soluzione, per un’intuizione dell’allora capo del Mossad, Isser Harel, era arrivata proprio grazie all’arruolamento di Skorzeny, avvicinato nel suo buen retiro di Madrid al principio del 1962 da Yosef «Joe» Raanan, il «terzo uomo» del gruppo. A momenti l’operazione era fallita: l’uomo aveva capito che i due giovani erano spie israeliane. «Siete venuti per uccidermi - gridò Skorzeny, il viso ancora affascinante solcato da una vecchia cicatrice, un revolver spianato e pronto a sparare -. Siete del Mossad». La risposta, tranquilla e incisiva, in pochi minuti raddrizzò la situazione: «È vero, siamo del Mossad - confessò l’uomo - ma non siamo venuti per ucciderti, se avessimo voluto farlo, saresti morto da settimane».
Poi l’incredibile offerta: aiutare lo Stato ebraico nella lotta per la sua sopravvivenza. Skorzeny godeva di una fama intatta nei circoli degli ex nazisti. Poteva avvicinare chiunque tra i molti scienziati che si erano messi (per soldi e non solo) a disposizione degli egiziani desiderosi di sviluppare un programma missilistico capace di regalare al Cairo la supremazia strategica sull’odiato vicino. Il punto era: perché mai Skorzeny avrebbe dovuto mettersi al servizio degli israeliani? Non per avidità: «Sono abbastanza ricco, non ho bisogno di denaro», chiarì subito. Ma un accordo poteva essere trovato: «Voglio che Simon Wiesenthal tolga il mio nome dalla sua maledetta lista!».
Skorzeny temeva di fare la fine di Eichmann. Dunque accettò l’offerta e da quel momento fu uno dei più validi collaboratori dei servizi israeliani. Si recò più volte in Egitto, portando indietro la lista di tutti i principali scienziati (tedeschi) all’opera per costruire il missile capace di colpire Israele. Addirittura, inviò lui stesso un pacco bomba che uccise cinque egiziani in una base segreta. E poi, il rapimento e l’omicidio di Kurt Heinz.
Un giorno, Otto Skorzeny fu persino invitato, sotto falsa identità, in Israele e i suoi ospiti lo portarono in visita allo Yad Vashem, il museo dell’Olocausto di Gerusalemme. Skorzeny durante tutta la visita fu silenzioso e mostrò rispetto. Ma fu riconosciuto da un ex deportato: «È un nazista!». Uno degli accompagnatori rispose tranquillo: «Si sbaglia, è un mio parente: anche lui ha sofferto durante la Shoah». Il lavoro - molto fruttuoso - proseguì per anni. Nessuno ha mai capito fino in fondo perché lui abbia accettato: sensi di colpa? Paura di essere ucciso? Il Mossad, dal canto suo, continuò l’opera di intimidazione ed eliminazione dei nemici dello Stato ebraico: come per gli organizzatori dell’attentato a Monaco 1972. Con ogni mezzo. Anche stringendo, se necessario, patti con il diavolo. O falsificando le carte: Wiesenthal non accettò mai di cancellare dalla sua lista il nome di Skorzeny. Così all’ex ufficiale fu consegnata una lettera realizzata a Tel Aviv con la firma (riprodotta) del cacciatore di nazisti: tanto bastò a donargli sonni tranquilli.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- «Non credere ma capire»: «È questo lo spirito dell’ebraismo» (Bernard-Henri Levy).3 febbraio 2016, di Federico La Sala
- Palestina, Israele e la rinascita della lingua ebraica....
- ELIEZER BEN-YEHUDA.
- Per il dialogo e uno stato bi-nazionale ....
- ISRAELE E PALESTINA. LA PROFEZIA DI HANNAH ARENDT.
- PENSARE UN ALTRO ABRAMO: GUARIRE LA NOSTRA TERRA. Una lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla),di Federico La Sala
- (...) Ciò che è successo in Sudafrica. Può succedere anche a Gerusalemme... Se l’ho persuasa, e ritiene che nelle cose dette ci sia un granellino di verità, agisca, agisca subito (...)
il nuovo libro
La sfida di Lévy, parlare ai nemici
«È questo lo spirito dell’ebraismo»
Dall’Ucraina al Bangladesh, dal Ruanda alla Libia, il filosofo francese spiega perché ha sempre messo alla prova sul campo la sua visione morale
- «Non credere ma capire, la missione degli ebrei»
- Leggi l’estratto *
di STEFANO MONTEFIORI, corrispondente a Parigi (Corriere della Sera, 02.02.2016)
«In questo libro difendo l’umanesimo contro il comunitarismo. Sostengo che l’essere ebrei è rivolgersi agli altri uomini e mai restare chiusi in se stessi. Difendo una concezione aperta del giudaismo», dice al «Corriere» Bernard-Henri Lévy, alla vigilia dell’uscita in Francia del suo nuovo saggio L’esprit du judaïsme (Grasset). È un’opera filosofica e politica, un manifesto e un racconto personale. Sono 438 pagine che spiegano come sia stato inevitabile, per l’uomo che ha avuto la fortuna di conoscere Emmanuel Lévinas e diventarne allievo, sporcarsi le mani con la realtà. Difendere Israele, a partire dalla guerra dei Sei giorni fino a oggi. E accanto a questo, provare a modificare gli eventi e rifiutarsi di assistere all’orrore. Pensare, scrivere e agire, dal Bangladesh all’Ucraina, dal Darfur al Ruanda, dal Kurdistan alla Libia: cause teoricamente lontane, sentite come una chiamata individuale alla quale sarebbe stato illogico e ignobile resistere.
«Il personaggio centrale del mio volume è il profeta Giona, l’unico che non parla ai suoi, ma che si rivolge al popolo più lontano, il più ostile. Ed è questo il suo dovere. Il libro di Giona è il mio libro preferito all’interno dell’Antico Testamento. Quello che nei viaggi ho portato sempre con me». Giona predica agli abitanti di Ninive, la capitale corrotta dei nemici, gli Assiri, sui quali sta per abbattersi la punizione divina. Giona parla ai nemici, e li salva. Oggi Ninive è Mosul, cuore dell’Isis in Iraq. «Sono stato a Ninive - scrive Lévy - non una ma molte volte. E ho passato una parte non trascurabile della mia vita ad agire in favore di popoli che non erano i miei, la cui sorte avrebbe potuto essermi indifferente e che erano talvolta, in potenza o in atto, i nemici di chi io sono».
Oggi Ninive è anche la Libia. Nel 2011 Lévy si è impegnato di persona per convincere l’allora presidente francese Nicolas Sarkozy a intervenire in favore dei ribelli, per evitare il bagno di sangue promesso da Gheddafi. I raid aerei dell’Occidente fermarono i carri armati che stavano per compiere un massacro a Bengasi, Gheddafi è stato ucciso, ma le speranze di una primavera libica sono andate tradite, il Paese è in preda all’espansione dello Stato islamico. Molti si indignano perché l’Occidente non è intervenuto in Siria e non ha salvato i siriani dalla furia di Assad, ma allo stesso tempo si rimpiange Gheddafi e la sua funzione stabilizzatrice. Si è pentito, Lévy, di avere aiutato i ribelli libici?
«No, non ho cambiato opinione su quel che ho fatto in Libia e quel che continuerò a fare per tutta la mia vita - risponde -. Lo scontro tra democratici e fondamentalisti, tra moderati e integralisti è la battaglia della nostra epoca. Bisogna fare tutto il possibile per appoggiare coloro che, con molto coraggio, si battono all’interno dell’Islam contro la sua versione mortifera». Lévy crede nell’universalità dei diritti dell’uomo: è il suo spirito del giudaismo. «Niente di quel che ho fatto l’avrei fatto - dice -, se non fossi stato ebreo».
*
Non credere ma capire
la missione degli ebrei
- Un estratto dal nuovo libro del filosofo francese Bernard-Henri Lévy
- «L’Esprit du Judaïsme» in uscita giovedì 4 febbraio per l’editore Grasset
di BERNARD-HENRI LÉVY (Corriere della Sera, 3 febbraio 2016 )
Uno dei miei figli, cui faccio leggere qualche pagina di questo libro e che si meraviglia del mio modo di evocare, evitare, senza però invocarlo mai veramente, il nome del divino, mi pone la domanda che forse si porranno altri lettori: credi in Dio? A una domanda così diretta, rispondo altrettanto direttamente che non è lì il problema e che, in ogni caso, non si pone in quei termini.
Infatti, se tutto quello che ho scritto finora è, se non vero, almeno sensato, se il genio di Rashi, di Maimonide o di Giona somiglia a ciò che asserisco, se il Talmud è proprio quel getto di scintille che continuano a sfavillare fra coloro che hanno mantenuto il gusto di accostarsi alla parola di Mosè accantonata e riattivata a colpi di enigmi, di paradossi, di parole limpide o ingannevoli, di sensi costruiti o decostruiti, di enunciati ben articolati o bruscamente aberranti, allora tutto questo significa che gli Ebrei sono venuti al mondo meno per credere che per studiare; non per adorare, ma per comprendere; e significa che il più alto compito al quale li convocano i libri santi non è di ardere d’amore, né di estasiarsi davanti all’infinito, ma di sapere e di insegnare.
Ricordo i testi di Levinas che accompagnarono i miei primi passi e che insistevano sulla grande ostilità del pensiero ebraico al mistero, al sacro, alla mistica della presenza, alla religiosità. Ricordo i suoi ammonimenti, ripresi da Blanchot, contro il grande errore che sarebbe dare ai nostri doveri verso Dio la precedenza sugli obblighi verso gli altri, al punto di vista sull’etica, all’indiscrezione nei confronti del divino la precedenza sulla sollecitudine verso il prossimo. (...)
Maimonide parla di veridicità, non di convinzione religiosa. Dice o, piuttosto, sotto-intende che la conoscenza, e la conoscenza solamente, di questo presupposto è il primo dei comandamenti. Senza retorica, senza parola di scongiuro, magica o mistica, insiste che l’edificio dei mondi riposa su un sapere originario, un pensiero, un da’at, mai su una fede iniziale. (...)
E tutti i testi ebraici che conosco lo dicono e lo ripetono: l’uomo non può vedere e vivere; stare nello spazio e nel tempo significa condannare se stessi a non vedere colui che è fuori da questo spazio e da questo tempo; se lo si vedesse, se si rivelasse in un vero vedere, ecco che io stesso non sarei più né in questo spazio né in questo tempo.
Ma soprattutto, mai e poi mai si tratta di crederci. Mai, da nessuna parte, è pronunciato il «credo in unum Deum» richiesto da coloro ai quali si domanda se «credono in Dio». La verità è che tutta questa storia del credere riguarda un’altra storia, molto bella, intensamente intrecciata nei cuori e negli affetti: è la storia della «fede che salva» dei paolini. Ma non è la storia di chi insiste nel dirsi ebreo...
Il «credo quia absurdum», per esempio, la rinuncia a entrare nel mistero della tomba aperta il giorno di Pasqua che fa così bella la cieca preghiera di Agostino o di Claudel: nulla è più contrario alla non meno grande bellezza della volontà di capire che è al centro del giudaismo. (...)
Sono lontano, molto lontano dall’essere all’altezza del nome ebreo e del mio nome. Ma questo io so e ripeto un’ultima volta: non viene chiesto all’Ebreo, dal più istruito al più ignorante, dal più grande (che è anche il più piccolo) al più piccolo (che è anche il più grande) di «credere in Dio». Il riferirsi a Dio come credenza è il punto di inizio, l’atto di nascita della religione, voglio dire del cristianesimo: ma per l’Ebreo può essere un errore; infatti l’abbandonarsi al cuore, il ricorrere alla fede dei semplici in nome dell’impossibilità del sapere, è un modo di differire l’intellezione che è ciò per cui, ancora un volta, l’Ebreo è giunto.
E non significa offendere i cristiani, tutti i cristiani, quelli della comunione come quelli dell’amore per il debole, i cristiani della confessione come quelli del cuore, se ricordiamo che la loro teologia, nata da una relazione geniale e al tempo stesso tragica al testo ebraico e al suo uso non è il punto di partenza di tutti gli atteggiamenti umani e che ne resta uno, quello ebraico, che si ostina a dire questo: ciò che si sa, lo si sa; ciò che si sa e si conosce, non è necessario crederlo; e se lo si crede, significa che si è rinunciato a conoscerlo, che si è voluto guadagnare tempo, tentare un azzardo che abolisca non il caso, ma la necessità di ostinarsi nel pensiero: e questa impresa, questo salto al quale Pascal ha dato la carica esistenziale, emotiva, intellettuale più grande che si possa immaginare, questo salto che fece di lui un genio prodigioso e infelice, all’ebreo si chiede soprattutto di non compierlo. (traduzione di Daniela Maggioni)
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA -- Heidegger: i «Quaderni neri 1938/1939». Nota di Donatella Di Cesare (di D. Di Cesare)31 gennaio 2016, di Federico La Sala
L’Occidente tedesco di Heidegger lasciava sempre fuori gli ebrei
Tradotto da Bompiani il secondo volume dei «Quaderni neri», con i taccuini scritti tra il 1938 e il 1939. Una visione della civiltà occidentale che mette al centro la Germania
di DONATELLA DI CESARE (Corriere della Sera, 29.01.2016)
È uscito in questi giorni, nell’eccellente traduzione di Alessandra Iadicicco, il secondo volume dei Quaderni neri di Martin Heidegger (Bompiani) in cui sono comprese le Riflessioni che vanno dal 1938 al 1939. Alle quasi 700 pagine del primo volume si aggiungono così altre 584 pagine: una sfida per i lettori italiani, ma anche un monito. Perché sarebbe doveroso affrontare il testo in modo critico, prima di emettere giudizi sbrigativi o di lasciarsi andare a facili scoop.
L’ultimo è quello lanciato dal giornalista tedesco Thomas Vašek, e ripreso da Angelo Bolaffi («la Repubblica», 4 gennaio), secondo cui Heidegger non sarebbe che un epigono di Julius Evola e del suo razzismo. La prova flagrante sarebbe un fantomatico foglietto, di poche righe e di oscura provenienza, che potrebbe, tutt’al più, essere un appunto. Per i tedeschi un bel modo, certo, per scaricare sugli altri responsabilità proprie. Sì, perché il nazismo non è stato il fascismo. E soprattutto perché l’antisemitismo metafisico di Heidegger non è riducibile al razzismo tradizionale. D’altra parte l’aggettivo «metafisico» non mitiga l’antisemitismo, bensì ne indica la gravità abissale. L’antisemitismo metafisico di Heidegger ha una provenienza teologica, una intenzione politica, un rango filosofico.
Se deleteri sono, per un serio dibatto, i vuoti scoop, esiziali sono gli interventi dei «negazionisti» dell’ultima ora, quelli che pretenderebbero di cancellare con una spugna i passi antisemiti. Come se Heidegger non parlasse di Verjudung o di Weltjudentum, cioè di «ebraizzazione» e di «ebraismo mondiale» - termini non neutri, né casuali. Nei Quaderni neri vengono mosse, d’altronde, accuse precise: privi di suolo, di fondo, di fondamento, gli ebrei sono gli sradicati agenti dell’accelerazione, della tecnicizzazione del pianeta, della desertificazione della terra. Ma soprattutto gli ebrei sono la figura della fine che si ripete, impedendo al popolo tedesco di risalire al mattino dell’Occidente.
Proprio l’Occidente è uno dei grandi temi del secondo volume dei Quaderni neri. Il tedesco Abendland rende bene ciò che l’etimologia suggerisce: l’Occidente è la «terra della sera», il Paese dove sembra che il sole vada declinando. Dalla prospettiva dei greci - s’intende. Sono allora le coste dell’Esperia, dell’Italia odierna, quelle dove il sole pare quasi inabissarsi nel mare. Ma non si deve fraintendere: per Heidegger l’Occidente non è un luogo geografico, né un sistema di valori, bensì un’epoca nella storia del mondo. E gli esperii sono quelli venuti tardi e dopo - rispetto ai greci. L’inizio dell’Occidente è greco. Non è possibile, perciò, alcuna meditazione sul mondo occidentale senza un confronto con quel primo inizio greco. Il che poi vuol dire riprendere il filo della «filosofia» che costituisce la trama segreta della storia occidentale.
Sebbene l’Occidente sembrasse sprofondare nel nulla del nichilismo europeo, non si trattava di un tramonto, Untergang - secondo la famosa profezia di Spengler - bensì di un passaggio, Übergang. Il buio di quell’epoca, al termine degli anni Trenta, è considerato da Heidegger non come l’oscurità della fine, ma come lo spegnersi dell’ultimo lume della sera che avrebbe permesso di scorgere l’albore del mattino. Non si poteva, certo, resuscitare il primo inizio greco; ma si doveva attraversare sino in fondo la lunga notte dell’Essere, per risalire, oltre la metafisica, quella perversa malattia dell’Occidente, a un «altro inizio». La Terra della Sera avrebbe dovuto risvegliarsi a una nuova, dorata alba, scoprirsi Terra del Mattino.
Chi avrebbe potuto scorgere il passaggio, là dove tutti vedevano un crollo ineluttabile? Chi poteva seguire la strada della fine, per imboccare il sentiero dell’inizio? Solo i tedeschi. Il destino dell’Occidente, la sua «salvezza» era nelle loro mani. I tedeschi avrebbero dovuto essere gli Übergehenden, «coloro che passano oltre», che aprono un varco anche per gli altri popoli europei. Ecco il loro compito.
«Tutto il «sangue», tutta la «razza», ogni «carattere nazionale» è inutile, e solo un decorso cieco, se non vibra già in un azzardo dell’Essere». Più volte Heidegger si chiede: «Dove sono finiti i tedeschi?». La decisione a cui li richiama è filosofica: tra il sonno dell’uomo occidentale, immerso negli enti, e il risveglio all’Essere.
Ma non per questo i termini sono meno gravi. Nell’epoca della fine il rischio non sarebbe solo la vittoria della metafisica ma anche, per quel legame di complicità che li lega, la vittoria dell’ebraismo. Vincerebbe allora «la più grande assenza di suolo che, a nulla vincolata, tutto quanto si asservisce (l’ebraismo)». Già nel 1938, all’indomani della Notte dei cristalli, Heidegger parla di «battaglia», e non esita a individuare nell’Ebreo il nemico metafisico che impedisce ai tedeschi l’accesso all’altro inizio. Il tratto greco-tedesco lascia fuori gli ebrei, l’asse dell’Essere li esclude. Per loro - questo è il verdetto - non c’è spazio nella topografia dell’Occidente.
-
> ISRAELE --- Pronto il “Rahav” (“Nettuno”). La Germania, dove sono costruiti i sommergibili israeliani, contribuisce a creare un arsenale atomico galleggiante in Medio Oriente di cui nessuno parla.21 dicembre 2015
Pronto il “Rahav”, cresce sui mari la potenza nucleare israeliana
Israele. La Germania, dove sono costruiti i sommergibili israeliani, contribuisce a creare un arsenale atomico galleggiante in Medio Oriente di cui nessuno parla.
di Michele Giorgio (il manifesto, 20.12.2015)
GERUSALEMME Mentre il Congresso discute il rinnovo, sicuro, del finanziamento annuale statunitense di tre miliardi di dollari, in gran parte ad uso militare, destinato a Israele, il portavoce delle Forze Armate dello Stato ebraico ha diffuso le foto del sottomarino “Rahav” (“Nettuno”, in ebraico) che lascia il porto tedesco di Kiel diretto ad Haifa.
Il “Rahav” è l’ultimo dei sommergibili di classe Dolphin II, di fabbricazione tedesca, ad entrare in servizio e, nel silenzio internazionale, accrescerà ulteriormente le capacità atomiche di Israele che non ha mai firmato il Trattato di non proliferazione nucleare e continua a mantenere segreto il suo arsenale atomico costituito, secondo alcuni esperti internazionali, da 100 forse 200 bombe.
Costruito nei cantieri Howaldtswerke-Deutsche Werft, con un costo di 2 miliardi di dollari sostenuto dalla Germania (nel quadro dei risarcimenti tedeschi per l’Olocausto), il “Rahav” non è a propulsione atomica ma, come altri due dei quattro sommergibili israeliani costruiti in Germania già in servizio, è in grado di trasportare missili con testate nucleari nei mari del Medio Oriente e nell’Oceano Indiano. Se gli Stati Uniti sono garanti della superiorità bellica di Israele nei confronti degli altri Paesi della regione, la Germania di Angela Merkel da anni contribuisce alla costituzione di una flotta di sottomarini israeliani dotati anche di armi non convenzionali.
Grazie all’aiuto di Berlino, Israele può tenere sotto il tiro dei suoi missili Popeye con una gittata di 1500 km e armati con atomiche fino a 200 chilogrammi non solo il “nemico” Iran, la Siria, tutti gli altri Paesi arabi e parte dell’Asia centrale. Tre anni fa, la rivista tedesca Der Speigel, in un servizio di 12 pagine intitolato “L’Operazione Sansone”, scrisse che i missili israeliani con testata nucleare possono essere lanciati dai sommergibili grazie a un sistema idraulico speciale di ultima generazione. «Utilizzando la tecnologia tedesca, Israele ha creato un arsenale nucleare galleggiante in Medio Oriente», aggiunse il giornale.
Angela Merkel ha sempre negato che i sottomarini consegnati a Israele siano in grado di trasportare testate nucleari. In realtà, spiegava Der Spiegel, il governo tedesco è consapevole della capacità nucleare dei sommergibili però accetta di guardare da un’altra parte in nome della “sicurezza di Israele”.
Nella visione strategica israeliana, ha scritto Ronen Bergman, analista militare per il quotidiano di Tel Aviv Yedioth Ahronot, il “Rahav” e gli altri sottomarini garantirebbero a Israele la capacità del “secondo colpo”, ossia la possibilità di rispondere con le atomiche ai nemici anche dopo aver subito un attacco nucleare. Altri esperti, non israeliani, sostengono che i sommergibili hanno il compito di affermare la superiorità militare e la potenza nucleare dello Stato ebraico nella regione, quindi di rappresentare un potere di deterrenza, o, secondo un altro punto di vista, una costante minaccia non dichiarata davanti alle coste degli avversari. È perciò strategica la capacità che il “Rahav”, il suo predecessore “Tanin” e il sesto sommergibile israeliano ora in costruzione in Germania, hanno di rimanere in immersione anche per 18 giorni consecutivi.
Sarebbe l’Eritrea, secondo il centro ricerche strategiche Stratfor, a fornire una base navale strategica, nell’arcipelago di Dahlak, ai sottomarini di Israele che si alternano nella missione di tenere sotto tiro l’Iran e nel controllo delle navi di Tehran che entrano nel Mar Rosso. Allo stesso tempo l’Eritrea assicura un porto, ad Assab, anche alla Marina militare iraniana, ottenendo dai due Paesi avversari armi e aiuti finanziari.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- In Germania, un’edizione critica del libro-manifesto di Hitler. Settant’anni dopo siamo pronti a leggere il "Mein Kampf"?16 dicembre 2015, di Federico La Sala
- KANT, IL “MOSE’ DELLA NAZIONE TEDESCA” E LE ORIGINI DEL-
 L’ “IMPERATIVO CATEGORICO” DI HEIDEGGER E DI EICHMANN.
L’ “IMPERATIVO CATEGORICO” DI HEIDEGGER E DI EICHMANN.
Settant’anni dopo siamo pronti a leggere il Mein Kampf?
Mentre in Germania gli storici preparano la prima edizione critica al libro-manifesto di Hitler è dedicato il nuovo numero di Origami
- In francese, finlandese e danese. Per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale, il libro-manifesto di Adolf Hitler sarà pubblicato in Germania nel prossimo gennaio in un’edizione critica curata da Christian Hartmann per l’Institut für Zeitgeschichte
di Umberto Gentiloni (La Stampa, 16.12.2015)
Si può vietare la pubblicazione di un libro per tutelare valori e consuetudini? E chi ha il potere di deciderlo e di controllarne la diffusione? Possiamo ancora porre vincoli e barriere nel tempo della rete quando tutto è rintracciabile, alla portata di un motore di ricerca? Interrogativi che sembrerebbero futili se il libro in questione non fosse il concentrato del pensiero e della piattaforma politica di Adolf Hitler. Il Mein Kampf (a cui è dedicato il nuovo numero di Origami da domani in edicola, mentre in Germania gli storici preparano la prima edizione critica) è un oggetto che incute timore, il suo impatto va ben al di là di pagine sconclusionate ricche di propaganda nazista disarticolata e confusa.
Sappiamo che ha avuto un peso nella costruzione di una terribile realtà politica, ha contribuito a rafforzarne lo spessore e la capacità attrattiva, ha avuto una storia e un itinerario editoriale simile alla traiettoria del regime di cui ambiva a cantare le lodi e narrare le gesta.
Hitler lo scrive mentre è in prigione a Lansberg, recluso in quella che con sprezzo definirà «un’università a spese dello Stato». Sembra che altri detenuti gli suggerirono di iniziare a scrivere le sue memorie per tentare di contenere i suoi monologhi logorroici, porre un freno a quel fiume incessante e insensato di parole. Vane illusioni. Hitler leggeva o meglio recitava ad alta voce i brani che riusciva a mettere sulla carta. Il titolo provvisorio suona come un manifesto d’intenti: «Quattro anni e mezzo di lotta contro menzogne, stupidità e codardia», poi la scelta definitiva mentre detta pensieri sparsi al suo autista Emil Maurice.
Errori e ripetizioni
Il primo volume - esce nel luglio 1925 - tiene l’impronta autobiografica in uno strano connubio tra sfondoni e riferimenti di vario genere conclusi dal ridondante richiamo al programma del partito. La seconda parte viene concepita dopo la scarcerazione - pubblicata nel ’26 - ed è incentrata sui caratteri della proposta politica emergente: ideologia di riferimento, propaganda come necessità strategica, richiami alla centralità della politica estera o meglio della proiezione internazionale del suo disegno aggressivo.
I biografi di Hitler da tempo hanno ricostruito che in molti misero le mani sul manoscritto per renderlo leggibile e presentabile, depurandolo tra l’altro da errori grammaticali e ripetizioni ricorrenti. L’autore stesso non mancò di ridimensionarne la natura fino a condurla a un insieme di articoli o contributi sporadici. E tuttavia quelle pagine contribuirono a incendiare l’Europa negli anni tra le due guerre.
Bestseller per forza
L’esordio fu tutt’altro che un successo. La casa editrice del partito (Franz Eher-Verlag) lo mise in circolazione con un prezzo impegnativo, 12 marchi. Nel 1929 il primo volume aveva venduto 23 mila copie, mentre il secondo aveva raggiunto le 13 mila. Un punto di partenza che s’intreccia con il percorso dei successi del partito, con l’ampliamento dei consensi e dei potenziali sostenitori. Tra il 1930 e il 1932 le copie diventano 80 mila. Con la presa del potere, l’anno successivo viene superato il milione e mezzo di copie.
Una marcia inarrestabile: dal 1936 viene predisposta la versione braille per i non vedenti e ogni coppia di sposi riceve in dono un volume in versione rilegata. Nel tornante conclusivo della Seconda guerra mondiale le tirature e le vendite avevano superato i 10 milioni, senza contare la diffusione all’estero grazie alle 16 lingue in cui venne tradotto. Un potente strumento di diffusione e soprattutto di identificazione collettiva nel pensiero (per quanto caotico e delirante) di un uomo solo che al comando avrebbe risollevato le sorti della Germania tracciando un nuovo cammino per il genere umano.
Il nucleo delle idee portanti è noto: la razza come chiave di lettura delle stratificazioni sociali, lo spazio vitale orizzonte e frontiera di ogni conquista necessaria, la violenza del più forte esercizio di identità rinnovate, la dittatura come approdo di un progetto di trasformazione. Il significato del libro nel dibattito tra gli studiosi ha oscillato tra due estremi: una piattaforma ideologica che contiene le premesse dell’ascesa successiva o al contrario uno scritto marginale che non merita particolari attenzioni.
Le ragioni della storia
Ecco le origini delle paure, i timori che la pubblicazione di un testo del genere possa offrire spunti a chi è in cerca di legittimazioni o pericolose scorciatoie. Ma attenzione, il tema non è certo quello di riaprire dopo decenni un confronto di merito sul nazismo, né può essere confuso con le prerogative della libertà di espressione, del pluralismo delle idee.
Un’edizione critica di duemila pagine, con 3.700 note, dopo tre anni di lavoro nel quadro di un prestigioso istituto storico (quello di Monaco di Baviera) si basa sulla scelta di contestualizzare storicamente: distruggere il mito e le sue tracce rafforzando le ragioni della storia quindi la sfida e gli strumenti per una consapevole comprensione del passato. Non è poco.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- Hitler, un figlio dell’occidente. Intervista allo storico Giorgio Galli (di Oreste Pivetta)17 dicembre 2015, di Federico La Sala
Hitler, un figlio dell’occidente
- 70 anni fa il fututo Fuhrer diventava cancelliere del Reich. Aveva già programmato tutto in "Mein Kampf".
- Lo storico Giorgio Galli ha curato la ristampa del libro per Kaos: "Razzismo e antisemitismo non erano sue invezioni".
di Oreste Pivetta *
Settant’anni fa Adolf Hitler diventava cancelliere dei Reich. Era la mattina del 30 gennaio quando il presidente Paul Hindenburg gli affidò l’incarico. Hitler poteva contare su una coalizione di destra, ma quarantotto ore dopo l’investitura ottenne da Hindenburg lo scioglimento del parlamento. A febbraio il nuovo governo decretò la sospensione della libertà di stampa e i nazisti scatenarono un’ondata di violenze contro gli oppositori politici. Soprattutto i nazisti misero in moto la formidabile macchina della propaganda, diretta da Goebbels, mentre per decreto legge (a fine febbraio) venivano sospese le libertà costituzionali e proibito l’attivismo politico delle sinistre. Il giorno prima, il 27 febbraio, era stato dato alle fiamme il Reichstag. Dell’incendio fu accusato un cittadino olandese di presunte simpatie comuniste, Marinus van der Lubbe.
Cominciava così la più tragica avventura del nostro secolo, alla fine la guerra, le deportazioni, lo sterminio. Le idee che ispirarono tutto questo, stanno in un libro, Mein Kampf, che Hitler aveva dettato al suo segretario Rudolf Hess nell’anno di prigionia, nel carcere di Landsberg, tra l’11 novembre 1923 e il 20 dicembre 1924. Hitler era stato condannato per alto tradimento per il tentato putsh di Monaco, il putsh della birreria. Mein Kampf, scritto in forma prolissa e contorta, fu rivisto e corretto (anche dagli errori grammaticali) da un prete che era diventato giornalista antisemita, Bernhard Stempfle, e da Josef Czerny, di origine cèca, giornalista e poeta ugualmente antisemita. Il titolo era di Max Amman, che stava in carcere con Hitler ed era il direttore commerciale della casa editrice del partito nazionalsocialista.
Il libro ebbe all’inizio scarsa fortuna. Alla fine della guerra, al crollo del nazismo ne erano state vendute dieci milioni di copie. Veniva regalato ad ogni coppia di neo-sposi. In Italia fu Bompiani a pubblicare nel 1934 il secondo volume, quello dichiaratamente teorico, che si intitolava Il movimento nazional socialista. Il primo volume (Resoconto), più autobiografico, apparve sempre con Bompiani nel 1938. L’editore Kaos ristampa ora entrambi i volumi, a cura di Giorgio Galli, che ha scritto anche un’ampia introduzione (con una postfazione di Gianfranco Maris, presidente dell’Aned, associazione nazionale ex deportati).
Professor Galli, la prima domanda nasce dal disagio: il disagio, persino materiale di fronte a un oggetto come un libro, di chi ha sempre visto in «Mein Kampf» uno dei simboli della barbarie nazista. Un libro respinto dalla nostra coscienza. Perchè ristamparlo?
«Intanto perchè in una società aperta non dovrebbero esistere tabù. Poi perchè Mein Kampf non è mai scomparso: ne sono circolati estratti in una chiara logica apologetica e si sa che una cosa proibita esercita sempre una certa attrazione. Questa riedizione ha un dunque un senso: non accettare i tabù e offrire un testo storicamente collocato, un testo che può illuminare la figura di Hitler, che tante ambiguità, tante rimozioni e persino le censure possono avvolgere di un fascino sinistro... Proprio sere fa in un programma televisivo, padre Amorth, il prete esorcista del Vaticano, trattava Hitler al pari di un indemoniato. L’oscurità può sedurre: una indagine ha catalogato centocinquanta siti internet ispirati ad una sorta di mito hitleriano».
L’idea della follia è anche un’idea di alterità. Leggendo invece «Mein Kampf» si dovrebbe capire quanto Hitler viva invece nel solco della cultura del suo tempo?
«Mein Kampf è stato sempre giudicato un prodotto abbastanza singolare, sorprendente, quasi un incidente nei percorsi della storia politica occidentale. Non è vero. Hitler raccoglie idee che vengono da lontano. Mi rifaccio alle tesi di Poliakov e di Mosse. Il razzismo e l’antisemitismo non sono invenzioni di Hitler».
Raul Hilberg, nella «Distruzione degli ebrei d’Europa» (Einaudi), presenta addirittura le tavole comparative tra diritto canonico e misure naziste: dal divieto dei matrimoni misti (Sinodo di Elvira del 306) alla legge per la difesa del sangue e dell’onorabilità tedesca (15 settembre 1935), dalla proibizione per gli ebrei a rivestire cariche pubbliche (Sinodo di Clermont del 535) alla legge sulla riorganizzazione delle professioni burocratiche pubbliche (7 aprile 1933). Il distintivo di riconoscimento fu inventato dal Concilio Lateranense nel 1215. Scrive Hilberg: i nazisti non hanno rinnegato il passato, hanno costruito sulle vecchie fondamenta...
«Nel testo hitleriano il razzismo antigiudaico è l’approdo di una concezione razziale che affonda nella cultura occidentale. Hitler per esempio utilizza il francese Joseph-Arthur Gobineau e il suo Saggio sull’ineguaglianza delle razze. Ne ricava l’esecrazione per il "meticciato", che avrebbe portato alla degenerazione dell’umanità. Nel Mein Kampf si ritrovano le teorie eugenetiche dello psicologo inglese Francis Galton...».
Erano tutte letture di Hitler?
«Non letture dirette, ma non credo che la cultura di Hitler si limitasse a pochi opuscoli antisemiti. Conosceva Nietzsche e Schopenhauer. Ipotizzo che conoscesse anche Weber: nella concezione che Hitler manifesta del "capo carismatico", che dev’essere confermato dal successo e che è forte di una tradizione, vi è affinità con il pensiero del sociologo. Tra i dirigenti nazisti era popolare Gobineau».
La storiografia revisionista, che come scrive uno studioso che lei cita, Enzo Traverso, tende a espellere i crimini nazisti dalla traiettoria del mondo occidentale, spiegandoli come una reazione alla rivoluzione russa...
«Non fu l’antibolscevismo a indurre Hitler all’invasione dell’Unione Sovietica. L’operazione Barbarossa non fu il risultato di una contrapposizione ideologica, ma di una pretesa di "spazio vitale". Lo si legge appunto nel Mein Kampf: "Chiudiamo finalmente la politica coloniale e commerciale dell’anteguerra... quando oggi parliamo di nuovo territorio in Europa, dobbiamo pensare in primo luogo alla Russia o agli Stati marginali a essa soggetti. Sembra che il destino stesso ci voglia indicare queste regioni: consegnando la Russia al bolscevismo, rapì al popolo russo quel ceto di intellettuali che finora ne addusse e garantì l’esistenza statale...".
Come si spiega invece la simpatia per l’Inghilterra. Anche qui fa testo il «Mein Kampf», a proposito di Inghilterra e Italia: «La più grande Potenza mondiale e un giovane Stato nazionale offrirebbero ben altri elementi per una lotta in Europa, rispetto ai putridi cadaveri di Stati ai quali la Germania si alleò nell’ultima guerra».
«Sullo sfondo c’è sempre la missione della razza ariana. Secondo i nazisti da una parte della Manica stavano gli ariani di mare, dall’altra gli ariani di terra».
«Mein Kampf» definisce anche il ruolo dello stato. Che cosa rappresenta per Hitler lo stato?
«Lo stato è uno strumento. Scrive: "Lo stato non rappresenta un fine, ma un mezzo. Esso è la premessa della formazione di una civiltà umana superiore, ma non è la causa di questa...". Hitler ribalta le conclusioni di Gobineau: il meticciato non è irreversibile, l’ariano resiste, lo stato è solo il mezzo per invertire la tendenza alla degenerazione, da qui la politica eugenetica dedotta da Galton, teorizzata nel Mein Kampf, attuata dal Terzo Reich. Nella concezione hitleriana lo Stato non è dunque un oggetto di culto, ma uno strumento al servizio di una razza che si edifica in nazione e costruisce una civiltà».
Altro tema fondamentale del «Mein Kampf» è quello relativo alla concezione della classe politica...
«Di Weber appunto è l’idea del capo carismatico investito di una missione, attorno al quale si forma il primo nucleo dei fedeli e che deve essere confermato dal successo, "la inequivocabile prova del successo visibile, il quale, in fin dei conti darà sempre l’ultima conferma della giustezza di un’azione". I profeti disarmati non contano».
Siamo ancora nella tradizione occidentale?
«Tutti i politici anche i più moderati coltivano l’idea di essere investiti da una missione, coltivano la convinzione di avere un compito di pubblica utilità. Questo Weber lo coglie con lucidità. La storia politica dell’Occidente è costruita da personaggi di questo genere, da Cronwell a Napoleone. Hitler ha aggiunto la dimensione divina: capo politico e sacerdote del nuovo rito. Le sue oceaniche assemblee erano quasi cerimonie liturgiche: la massa dei sottoposti nel buio, la tribuna nella luce, il capo che arriva al culmine della rappresentazione. Non cita ovviamente una religione: Hitler si appella agli dei o a una provvidenza che non è mai la provvidenza cristiana... Hitler scrive: "Noi ci rivolgiamo a quelli che adorano non il denaro, ma altri Dei, ai quali votano la loro esistenza"».
«Mein Kampf» dunque sintesi della futura politica hitleriana. Singolare che non faccia cenno alle fonti...
«Mein Kampf esprime un progetto compiuto. Gli atti successivi sono rintracciabili in quelle pagine. Il nazismo si affermò sulla base di un disegno preciso e chiuso, al contrario del fascismo che procedette in modo molto più empirico. L’unica teorizzazione del fascismo sta in quella voce dell’enciclopedia Treccani scritta da Gentile e rivista da Mussolini... Per quanto riguarda le fonti, tacendole Hitler rivendicava l’originalità del proprio pensiero».
Non fu solo un progetto però ad assicurare il successo del nazismo... un movimento che fino al 1928 non aveva che il tre per cento dei voti dopo cinque anni andava al potere.
«Non fu l’ideologia ed anche questo smentisce i revisionisti. Furono sei milioni di disoccupati, con i quali il comunismo non aveva nulla a che fare. La crisi tedesca stava tutta all’interno del sistema liberal democratico. La classe politica della repubblica di Weimar si era mostrata incapace, non solo divisa. La soluzione venne da una medicina keynesiana, come quella adottata negli Stati Uniti, proposta a Hitler da Hjalmar Schacht, il presidente della Banca tedesca: investimenti pubblici per rilanciare l’economia. Il bello è che Schacht aveva presentato lo stesso piano al governo di Weimar, che l’aveva respinto. Fu il primo successo di Hitler: la disoccupazione di massa cancellata. Il "miracolo economico" consentì la seconda performance di Hitler: il riarmo. Nel 1933 la Germania aveva un esercito di centomila uomini, male armati, senza aerei. Nel 1938 la Germania era la prima potenza militare europea».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- Hitler, un figlio dell’occidente - Mein Kampf, in edizione critica: così cade in Germania l’ultimo tabù (di Angelo Bolaffi).17 dicembre 2015, di Federico La Sala
Mein Kampf così cade in Germania l’ultimo tabù
Comparirà un’edizione critica che evidenzia l’uso strumentale di luoghi comuni e falsità
A 70 anni dalla morte di Hitler scadono i diritti del manifesto del Terzo Reich detenuti dalla Baviera. Non fu mai pubblicato, ora cambia tutto
di Angelo Bolaffi (la Repubblica, 17.12.2015)
IL prossimo gennaio uscirà nelle librerie tedesche l’edizione storico-critica del “Mein Kampf” di Adolf Hitler: cade così in Germania anche l’ultimo tabù. Ma la decisione presa dall’Institut für Zeitgeschichte di Monaco molto difficile e controversa è anche saggia e lungimirante. Il 31 dicembre di quest’anno, infatti, trascorsi settant’anni dalla morte del Führer e novant’anni dalla prima edizione scadranno i diritti d’autore del Manifesto ideologico del III Reich.
Nel ‘45 dopo la capitolazione tedesca gli Alleati avevano assegnato per competenza al Land della Baviera, che ne vietò la riedizione, la custodia dei diritti del “Mein Kampf”. E questo per due ragioni: Monaco era stata la città culla del movimento nazista e in essa Hitler aveva scelto di avere la sua residenza e continuò a mantenerla anche dopo essere stato nominato a Berlino Cancelliere del Reich. E poi perché a Monaco nel 1925 per i tipi dell’editore Franz Eher legato al movimento nazista, era apparso con il titolo Una resa dei conti il primo volume dell’opera. Hitler l’aveva scritto durante la sua detenzione nel carcere di Landsberg mentre scontava la condanna (per la verità molto mite) dopo il fallito putsch del Novembre del 1923. A questo primo volume di carattere prevalentemente autobiografico contenente le descrizioni degli anni dell’infanzia e della gioventù nella nativa Braunau, di quelli bohèmien vissuti in miseria a Vienna e delle traumatiche esperienze nella Prima guerra mondiale, fece seguito, tra la fine del 1926 e l’inizio del 1927, sempre per lo stesso editore, il secondo intitolato Il Movimento nazionalsocialista: quello più propriamente programmatico.
Benché Hitler fosse allora uno dei tanti esponenti dell’estrema destra nazionalista che odiava Weimar, la democrazia e gli ebrei nel segno della rinascita della “vera Germania” ed era noto solo come acceso comiziante e pittore fallito, Mein Kampf fu subito un best seller. E questo nonostante le feroci stroncature dei critici: un libro «noioso, confuso, scritto male e fumoso» lo definì Andreas Andernach nel saggio del 1932 intitolato Hitler ohne Maske. E un altro recensore parlò di «un guazzabuglio di frasi costruite male oppure sbagliate dal punto di vista grammaticale che non ha alcun valore intellettuale ».
Ma i recensori e con loro quasi tutta la classe politica e intellettuale della Germania weimariana si sbagliarono clamorosamente. Commisero un gravissimo errore di sottovalutazione sulla pericolosità del personaggio («la storia di Hitler» secondo il grande studioso Karl Dieter Bracher «è una ben nota storia di sottovalutazione»). E soprattutto non colsero la luciferina determinazione e la radicalità programmatica dello scritto: «nella storia raramente o forse mai un dittatore» così lo storico Eberhard Jäckel «ha con tanta precisione messo per iscritto prima di arrivare al potere quello che poi ha veramente fatto».
Della prima edizione del Mein Kampf vennero tirate e vendute 10mila copie che diventarono più di 200mila alla fine del gennaio del 1933 quando i nazisti andarono al potere. Tra il 1933 e il 1945 del Mein Kampf fu pubblicata una serie infinita di edizioni. Di quella in versione popolare veniva regalata una copia agli sposi all’atto delle nozze. Quella di lusso in pelle bianca e incisioni d’oro era destinata ai Gauleiter e agli altri gerarchi del regime.
Quando il III Reich fu sconfitto e per la Germania fu ”l’ora zero” del Mein Kampf risultarono venduti oltre 12 milioni di esemplari che avevano fruttato a Hitler 15 milioni di Reichsmark. 8 dei quali vennero scoperti in una banca e poi confiscati dagli Alleati. Ovviamente nonostante il divieto di pubblicazione in vigore in Germania, il Mein Kampf ha continuato negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale a essere reperibile e letto.
Nell’area di lingua tedesca era possibile acquistare nelle librerie d’antiquariato una delle copie di cui dopo la fine della guerra ci si era volentieri sbarazzati. Nel mondo circolavano edizioni in molte lingue. In Francia le Novelles Editions Latines sin dal 1934 avevano in catalogo una versione non autorizzata della quale ogni anno sono state e ancora vengono vendute alcune centinaia di copie. In India ne circolano addirittura diverse versioni. L’editore americano Random House si è sin dagli anni Trenta assicurato i diritti per l’edizione inglese devolvendo per la verità in beneficienza i proventi delle vendite. Perfino in Israele circola sia pure in forma molto limitata e a fini di studio una versione ebraica del Mein Kampf. Oggi poi da internet è possibile scaricare il testo tradotto in quasi tutte le lingue del mondo.
E allora qual è il problema? È esattamente quello a cui si intende dar risposta con questa edizione critica del Mein Kampf. Intanto dimostrare che una solida democrazia consapevole della propria forza non ha e non deve avere paura di un libro, neppure del Mein Kampf, se sa criticamente discuterne. Questa pubblicazione, inoltre, vuole essere un ennesimo contributo alla rielaborazione in Germania di un «passato che non deve e non può passare». La risposta alle sfide del presente nel segno dell’illuminismo e della difesa dei valori liberal-democratici dell’Occidente. Un ulteriore capitolo, dunque, di grande significato simbolico, di quella “resa dei conti” con la propria storia che costituisce il vero segreto della odierna forza “egemonica” della Germania post- tedesca.
Come? Decostruendo criticamente il testo hitleriano (l’edizione consta di due volumi di 2000 pagine, oltre il doppio dell’originale, corredate da ben 3700 note e commenti) per metterne in luce le falsità ideologiche, le mezze verità, le genealogie razziste di un social darwinismo allora molto in voga e di un niccianesimo pervertito e caricaturale, l’uso demagogicamente strumentale di luoghi comuni come il cosiddetto “spazio vitale”. O l’utilizzo a scopi manipolatori di vere e proprie menzogne. Prima fra tutte quella dei cosiddetti Protocolli di Sion.
Ma il senso forse più rilevante di questa che è stata una vera e propria impresa editoriale costata anni di lavoro e di ricerca ad un team di storici non è, si badi bene, solo quello, pur nobile, di un archeologico ristabilimento della verità. Ma di offrire uno strumento utilizzabile anche pedagogicamente e per questo capace di avere conseguenze politiche nel presente. Infatti l’arrivo in Germania di centinaia di migliaia di profughi provenienti dal mondo arabo (ma il discorso vale per tutta l’Europa) da una realtà culturale in cui in nome della cosiddetta lotta contro il “nemico sionista” la propaganda antisemita, compresa anche la lettura di testi nazisti, è componente fondamentale dell’ideologia dominante e, purtroppo, anche della formazione delle giovani generazioni, potrebbe avere un impatto culturale e politico dalle conseguenze imprevedibili. Soprattutto in Germania un paese in cui la coscienza storica della catastrofe della Shoà rappresenta, per usare le parole di Joschka Fischer, il fondamento della costituzione spirituale della nazione.
Questa pubblicazione, non a caso fortemente appoggiata dalla comunità ebraica tedesca preoccupata dalla possibile rinascita di un “senso comune antisemita”, vuole essere, dunque, uno strumento pratico, una fonte di informazioni e di argomenti di cui potranno servirsi coloro che avranno il difficile compito di favorire non solo dal punto di vista materiale ma anche da quello spirituale e culturale l’integrazione nella società tedesca dei nuovi “ospiti” provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo.
Inoltre potrà e dovrà funzionare da antidoto anche nei confronti del razzismo neonazista che usando strumentalmente l’argomento della difesa dell’identità tedesca sta cercando, soprattutto in alcune realtà della ex Germania Orientale, di organizzarsi nel segno della xenofobia.
Certo, come ha scritto Sven Felix Kellerhoff, un autore che per anni ha studiato il testo hitleriano, quella del Mein Kampf è «una lettura che fa male, mostruosa, molto ma molto perturbante». E tuttavia ha concluso «fare luce » perché questo significa illuminismo «è sempre meglio che tacere o nascondere».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- “Lui è tornato”: così tra letteratura e cinema rivive in Germania la figura di Hitler (di Angelo Bolaffi)7 maggio 2016, di Federico La Sala
Libri e film
il ritorno del grande dittatore
Non solo “Mein Kampf”: così tra letteratura e cinema rivive in Germania la figura di Hitler
Un’ossessione che si manifesta in chiave critica e a volte comica
Ma che fa i conti con un passato mai risolto
di Angelo Bolaffi (la Repubblica, 06.05.2016)
“Lui è tornato”: e lui è Adolf Hitler. Non è solo il titolo provocatorio e grottesco di un bestseller letterario diventato commedia cinematografica, ma un fatto: la rinnovata attenzione per la figura del dittatore nazista. All’inizio di quest’anno, come si ricorderà, a cura dell’Istituto tedesco per la storia contemporanea è apparsa tra mille polemiche e non pochi dubbi l’edizione scientifica del Mein Kampf andata esaurita in pochissimi giorni.
 E nelle scorse settimane sempre in Germania è stata pubblicata una monumentale ricerca sulla vita di Hitler: Das Itinerar, questo il titolo dell’opera in quattro volumi di ben 2.432 pagine scritta da Harald Sandner, ricostruisce passo dopo passo tutti gli episodi documentabili della sua biografia (compresi anche quelli più curiosi e sconosciuti, come la richiesta presentata all’ambasciata italiana di un autografo di Mussolini) dalla nascita nel 1889 a Braunau, allora Austria- Ungheria, fino al 30 aprile del 1945, giorno in cui si suicidò nel suo bunker di Berlino.
E nelle scorse settimane sempre in Germania è stata pubblicata una monumentale ricerca sulla vita di Hitler: Das Itinerar, questo il titolo dell’opera in quattro volumi di ben 2.432 pagine scritta da Harald Sandner, ricostruisce passo dopo passo tutti gli episodi documentabili della sua biografia (compresi anche quelli più curiosi e sconosciuti, come la richiesta presentata all’ambasciata italiana di un autografo di Mussolini) dalla nascita nel 1889 a Braunau, allora Austria- Ungheria, fino al 30 aprile del 1945, giorno in cui si suicidò nel suo bunker di Berlino.Inevitabilmente questo ritorno di interesse per la persona di Hitler ha sollevato molti interrogativi legati al timore che possa nascondere una più o meno consapevole “banalizzazione del male”. Una specie di inflazione della sua figura che, soprattutto sulle nuove generazioni, potrebbe avere come conseguenza una “normalizzazione” e relativizzazione della condanna del nazismo.
Certo, in una Germania com’è quella di oggi, profondamente lacerata e messa in ansia dal fenomeno migratorio e di fronte, sia pure in settori (ancora) minoritari, all’emergere di pulsioni identitarie e idiosincrasie xenofobe, la cautela è d’obbligo. E tuttavia questa rinnovata presenza mediatica di Hitler non è affatto espressione di revisionismo storico. Né, come nel film Lui è tornato di David Wnendt, l’idea tra il comico e l’assurdo per altro filmicamente molto efficace di far ricomparire Hitler nella odierna Berlino capitale della Germania riunificata, rappresenta un’allarmante rottura di un tabù.
Intanto perché c’è un precedente illustre: il film realizzato nel 1940 da Charlie Chaplin intitolato Il grande dittatore nel quale il monologo di Hitler nella scena del mappamondo è non solo un’icona cinematografica ma anche la denuncia politicamente lungimirante (in quell’anno era ancora in vigore il Patto tra Unione Sovietica di Stalin e Hitler) del pericolo planetario rappresentato dalla dittatura nazista.
 E poi: non è forse vero che un approccio ironico e il ricorso al linguaggio della satira possono favorire grazie alla funzione maieutica del sorriso la resa dei conti di un individuo o di un popolo col proprio passato? Infatti, a differenza di quanto accaduto in altri paesi (ad esempio in Austria e Giappone ma anche nella Russia di Putin che rivendica l’eredità del comunismo di Stalin) la Germania ha cercato (e continuamente cerca) di fare i conti col proprio passato.
E poi: non è forse vero che un approccio ironico e il ricorso al linguaggio della satira possono favorire grazie alla funzione maieutica del sorriso la resa dei conti di un individuo o di un popolo col proprio passato? Infatti, a differenza di quanto accaduto in altri paesi (ad esempio in Austria e Giappone ma anche nella Russia di Putin che rivendica l’eredità del comunismo di Stalin) la Germania ha cercato (e continuamente cerca) di fare i conti col proprio passato.Negli anni dell’immediato dopoguerra, fino alla metà degli anni Sessanta, dominante nell’opinione pubblica tedesca era stato il “principio di rimozione” fondato su una vera e propria connivenza, spazzata via dalla rivolta studentesca del ’67-’68. Una congiura omertosa raccontata dal recente film di Lars Kraume intitolato Lo Stato contro Fritz Bauer (lo stesso tema, anche se da una diversa angolatura, era stato affrontato in precedenza da Giulio Ricciarelli nel suo Il labirinto del silenzio): dirigente del movimento socialista ed ebreo, Fritz Bauer era stato costretto a emigrare. Alla fine della guerra, come Theodor Adorno, Max Horkheimer, Ernst Fraenkel o Richard Löwenthal, fu uno di quei “generosi remigranti”, come li ha definiti Jürgen Habermas, che decisero di tornare in Germania. Diventato procuratore del tribunale a Francoforte, nonostante l’isolamento e il sospetto che lo circondavano e lo portarono poi al suicidio, gettò le basi per la ricostruzione di un sistema giuridico democratico e aiutò il Mossad a individuare e arrestare Adolf Eichmann.
Per sempre all’ombra di Hitler?
Il titolo di una importante raccolta di saggi pubblicata qualche anno fa dallo studioso Heinrich August Winkler solleva un interrogativo che forse ci aiuta a capire l’odierna, ossessiva presenza della figura di Hitler. La Germania e la coscienza europea sono condannate infatti, per un tempo ancora imprevedibile, a confrontarsi con quella “frattura della civiltà” (così lo storico ebreo tedesco Dan Diner) che è stato il nazismo, i cui delitti ancora attendono - nonostante le decine di migliaia di pagine scritte sul tema - di essere ricostruiti in tutta la loro terrificante dimensione.
 Ne è conferma KL: A History of the Nazi Concentration Camps, la monumentale indagine sul sistema nazista dei campi, oltre duemila pagine frutto di una ricerca durata dieci anni, dello storico tedesco (residente in Inghilterra) Nikolaus Wachsmann, apparsa l’anno scorso in inglese e proprio in questi giorni in Germania. Una discesa agli inferi in cui la documentazione raccolta è costituita per gran parte dalle testimonianze fino ad oggi sconosciute delle vittime. Prende le mosse dal campo di Dachau, nei pressi di Monaco di Baviera, messo in funzione in modo ancora provvisorio e artigianale dopo la vittoria elettorale di Hitler nelle elezioni del 5 marzo 1933, per rinchiudervi gli oppositori politici, e si conclude sempre a Dachau con l’arrivo degli americani alla fine di aprile del 1945.
Ne è conferma KL: A History of the Nazi Concentration Camps, la monumentale indagine sul sistema nazista dei campi, oltre duemila pagine frutto di una ricerca durata dieci anni, dello storico tedesco (residente in Inghilterra) Nikolaus Wachsmann, apparsa l’anno scorso in inglese e proprio in questi giorni in Germania. Una discesa agli inferi in cui la documentazione raccolta è costituita per gran parte dalle testimonianze fino ad oggi sconosciute delle vittime. Prende le mosse dal campo di Dachau, nei pressi di Monaco di Baviera, messo in funzione in modo ancora provvisorio e artigianale dopo la vittoria elettorale di Hitler nelle elezioni del 5 marzo 1933, per rinchiudervi gli oppositori politici, e si conclude sempre a Dachau con l’arrivo degli americani alla fine di aprile del 1945.Nel mezzo, il capitolo più buio della storia tedesca. Un capitolo che più viene studiato ed esaminato più ci appare incomprensibile: «Nonostante ci siano migliaia di letture possibili», il nazismo - ha affermato l’ex Cancelliere Helmut Schmidt - «è inspiegabile. Ed è proprio questo che mi opprime nel profondo dell’animo». Dunque Adolf Hitler nonostante il passare dei decenni resta un vero e proprio mistero, come genialmente intuito da Salvador Dalí che nel 1939 intitolò El enigma de Hitler un suo piccolo quadro oggi esposto al museo madrileno Reina Sofia.
-
- KANT, IL “MOSE’ DELLA NAZIONE TEDESCA” E LE ORIGINI DEL-
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- GERUSALEMME. «Una nuova Muraglia di Difesa contro i palestinesi» (di Michele Giorgio)24 novembre 2015, di Federico La Sala
«Una nuova Muraglia di Difesa contro i palestinesi»
Israele/Territori occupati. I ministri della destra radicale e i coloni invocano una operazione militare in Cisgiordania ampia e distruttiva come quella del 2002 per piegare i palestinesi e per impedire che sia preso in considerazione un nuovo ritiro unilaterale di Israele.
di Michele Giorgio (il manifesto, 24.11.2015)
GERUSALEMME Una nuova “Muraglia di Difesa 2″. Ad invocare una seconda vasta operazione militare come quella del 2002, all’interno dei centri abitati palestinesi, in particolare nel sud della Cisgiordania, sono i coloni, i ministri della destra più estrema e anche qualche esponente del centrosinistra, in risposta all’intensificarsi degli attacchi individuali compiuti da palestinesi, spesso appena adolescenti. La nuova fiammata dell’Intifada di Gerusalemme registrata in questi ultimi giorni dice che le misure punitive adottate dal governo israeliano non fermano la nuova rivolta palestinese contro l’occupazione. E a poco serviranno, si prevede, gli ulteriori provvedimenti annunciati ieri da Benyamin Netanyahu: saranno negati i permessi di lavoro in Israele per i congiunti degli attentatori e gli autoveicoli palestinesi saranno perquisiti prima del loro ingresso nelle maggiori strade della Cisgiordania dove circolano anche gli automezzi dei coloni. Il primo ministro ha anche dato il via libera a raid dell’Esercito in villaggi e città palestinesi. La soluzione però è politica, non repressiva, ma il governo in carica continua ad escluderla, per salvaguardare la colonizzazione, capitolo centrale del suo programma.
Negli ultimi giorni sono morti quattro israeliani in attacchi quasi sempre all’arma bianca. Ieri e domenica, in particolare, sono stati uccisi un soldato, Zvi Mizrachi, 19 anni, a una stazione di rifornimento sulla superstrada 443, e domenica una giovane, Hadar Buchris, 21 anni, nei pressi delle colonie di Etzion. Il palestinese, responsabile dell’uccisione del militare è stato ucciso sul posto dagli spari di altri soldati. Si chiamava Jamal Taha, di Qutna (Ramallah) ed aveva appena 16 anni. Giovanissime sono anche le due cugine del campo profughi di Qalandiya, Hadeel Awad, 16 anni, e Norhan Awad, 14 anni, che ieri, nella zona del mercato ebraico di Mahane Yehuda, hanno accoltellato un palestinese 70enne di Betlemme evidentamente scambiato per un israeliano. La prima è stata uccisa da agenti di polizia. La seconda è stata ferita.
«Non c’è alternativa a una nuova operazione Muraglia di Difesa. Nel 2002 siamo andati nelle città e nei villaggi palestinesi e li abbiamo ripuliti. Poi il terrore è sceso del 80%», ha esortato il ministro Naftali Bennett, leader di Casa ebraica (il partito dei coloni). A distanza di 13 anni nessun adulto palestinese ha dimenticato “Muraglia di Difesa”, quando, nel pieno della seconda Intifada, il primo ministro Ariel Sharon ordinò di rioccupare le città autonome palestinesi lasciate dall’esercito israeliano nel biennio 1994-95, dopo la firma degli accordi di Oslo. Gli uccisi, non pochi dei quali durante combattimenti, furono diverse centinaia, quasi tutti palestinesi. I carri armati Merkava israeliani si lasciarono dietro una scia di morti, feriti e distruzioni immense evacuando, dopo settimane, Ramallah, Nablus e Betlemme. A Jenin fu distrutto in buona parte il campo profughi da dove, secondo l’intelligence israeliana, partivano i kamikaze palestinesi.
Per Bennett una nuova “Muraglia di difesa” serve anche ad impedire che Netanyahu prenda in considerazione l’eventualità di un “Ridispiegamento 2″, ossia di un ritiro unilaterale di Israele (da porzioni, ovviamente) della Cisgiordania sull’esempio di quanto fece nel 2005 Ariel Sharon che evacuò da Gaza soldati e coloni. Il premier in pubblico ha sempre escluso questa opzione ma sembra avere avuto un ripensamento. Bennett, con una metafora piuttosto forte, criticata anche a destra, sostiene di aver «sparato un proiettile in mezzo agli occhi» di Netanyahu. Dice di aver bloccato l’intenzione, espressa due settimane fa dal premier al Center for American Progress di Washington, di poter valutare una nuova mossa unilaterale di Israele. «Intorno a questa ipotesi si è fatto molto rumore ma la verità è che Netanyahu non ha alcuna volontà di compiere un passo del genere», ha detto al manifesto Shlomo Brom, un analista dell’Istituto per la sicurezza nazionale di Tel Aviv (Inss). «Una buona fetta di israeliani - ha aggiunto Brom - si rende conto che non si può continuare con l’occupazione (dei Territori) e che occorre separarci dai palestinesi. Tuttavia i vertici della politica e il governo si oppongono al ritiro. Forse sul lungo periodo Netanyahu e i suoi ministri capiranno che non è possibile andare avanti su questa strada, oggi però vanno nella direzione opposta».
-
> ISRAELE E IL NODO NON SCIOLTO -- "HEIDEGGER, NO GLOBAL". La disputa d’amore tra Heidegger e Arendt, una chiave indispensabile per comprendere (di Donatella Di Cesare)8 novembre 2015, di Federico La Sala
Heidegger no globalIl vero bersaglio del filosofo tedesco è l’orizzonte del liberalismo planetario
di Donatella Di Cesare (La Lettura - Corriere della Sera, 08.11.2015)
Qual è il filosofo che nell’ultimo anno è stato continuamente presente nei media di tutto il mondo? Martin Heidegger - non c’è dubbio. È tornato, con i Quaderni neri, per riprendersi la scena, mostrando - come ha osservato il massmediologo tedesco Gernot Böhme - «uno spiccato senso per la comunicazione pubblica». La sua messa in scena postuma è innegabile. Quasi che, pur rifuggendo le luci della ribalta, abbia voluto far implodere un sistema, basato sulla presunta trasparenza, rinviandolo alla dimensione rimossa del «segreto».
Il rapporto tra filosofia e pubblicità è uno dei grandi temi trattati nei Quaderni neri. Sarebbe però sbagliato mettere l’accento solo sulla critica all’informazione; ne verrebbe fuori l’immagine di un filosofo retrivo e provinciale. Al contrario, Heidegger è il primo filosofo ad aver riconosciuto l’esigenza della pubblicità, e ad aver tentato di trovare un posto stabile nell’ininterrotta attualità delle news. È insomma il primo filosofo a considerare la globalizzazione attraverso il prisma dei media. L’informazione planetaria - scrive - è ciò che oggi è più «degno di essere pensato». Perciò delinea una fenomenologia del giornalista in cui vede il «moderno storico», il «letterato» della pubblicità, che attraverso il «culto organizzato del semplice», ha la forza di far passare per «reale» quel che rende pubblico. Di fronte al giornalista, nelle cui mani è affidata la democrazia, il filosofo non avrebbe più nulla da dire.
Che ne è allora della filosofia, della sua complessità, nell’epoca in cui il giornalismo è il «fenomeno essenziale» dello spazio pubblico? Sebbene appaia indifeso e antiquato, il filosofo non ha esaurito il suo compito. Purché, però, sia capace di confrontarsi con il potente dispositivo della pubblicità. È quel che fa Heidegger, decidendo in vita la pubblicazione postuma dei quaderni rimasti a lungo «secretati». La forza del filosofo è il «segreto». Così ricorda a chi crede nell’evidenza e nella trasparenza che resta sempre ancora un fondo di verità da svelare.
Con un sorprendente colpo di scena Heidegger ha interrotto il lavoro del lutto, esibendo il suo segreto, senza però davvero rivelarlo, ha incrinato una identità che sembrava definita. Che cosa si nasconde dietro il nome «Heidegger»? Quanti Heidegger ci sono? E chi può dire che Heidegger non torni di nuovo, nel futuro, come promette in una pagina degli ultimi quaderni? Infrangendo le leggi dell’archivio, forzando la preclusione degli eredi, Heidegger è tornato alla ribalta con il segreto del suo lascito.
Nel dibattito intorno ai Quaderni neri, di cui è stata protagonista indiscussa «la Lettura», si pongono allora due grandi questioni. La prima ruota intorno al lascito del filosofo, alla sua eredità. La seconda riguarda invece il futuro di Heidegger e della sua filosofia.
Che cosa vuol dire ereditare? È necessario rimanere fedeli, secondo il principio genealogico? Oppure è possibile rifiutare un’eredità, tanto più se è non solo inattesa, ma anche inquietante?
Dopo il trauma dei passi antisemiti contenuti nei Quaderni neri, che ha colpito il mondo della filosofia, una parte degli «eredi» di Heidegger, di coloro che riconoscono il debito verso il filosofo, ha reagito con veemenza nostalgica. Questi «risentiti orfani di Heidegger» rappresentano un modo di ereditare reazionario. Ripiegati su di sé, vedono negli altri eredi dei «traditori». Immersi nel sonno dogmatico della assiomatica heideggeriana, di cui si considerano gli unici depositari, non desiderano altro che restare nel crepuscolo funebre che accompagna il Grande Padre perduto.
Il recente dibattito ha fatto però emergere anche un’altra figura, inconsueta nella filosofia: quella del rottamatore che si presenta nell’agorà non per dialogare, bensì per fare piazza pulita. L’incapacità di dialogare investe anche il modo di intendere l’eredità. I rottamatori della filosofia non vogliono essere eredi; si ergono piuttosto a giudici di un passato che condannano alla demolizione.
Ereditare non vuol dire né conservare né, d’altra parte, gettare via tutto. Sia gli orfani risentiti che gli infaticabili rottamatori considerano il lascito del filosofo come se si trattasse di una proprietà, di un bene qualsiasi. Ma l’eredità non è mai statica; e chiede di essere tramandata.
La filosofia è una questione di «famiglia»; altrimenti non sarebbe profondamente storica. Questo non vuol dire, però, che la famiglia abbia la proprietà del filosofo e dei suoi testi. L’eredità di un filosofo è un patrimonio tanto più ricco quanto più è condiviso. Heidegger appartiene, e non appartiene, a coloro che lo hanno letto, che lo leggeranno, che saranno in accordo o in disaccordo.
Prima ancora di accettare o rifiutare, di avere o non avere, siamo eredi e, anzi, siamo in quanto ereditiamo. L’eredità permea la nostra esistenza. Né mera passività né presunta autonomia: l’eredità è una ingiunzione a cui si risponde per un verso accogliendo quel che ci precede, per l’altro reinterpretandolo. È indispensabile una lettura critica. Ereditare - come ha chiarito forse meglio di ogni altro Jacques Derrida - vuol dire essere a un tempo fedeli e infedeli.
Ma nell’eredità di Heidegger, più che i figli, hanno un ruolo decisivo le figlie - le prime donne filosofe, che sono figlie necessariamente ribelli, chiamate a contestare la linea patriarcale della filosofia. Ha un posto a sé Hannah Arendt.
Che cosa avrebbe detto Arendt leggendo le pagine dei Quaderni neri? Quelle in cui Heidegger tenta di definire l’Ebreo, parla dell’«ebraismo mondiale», e imputa agli ebrei una «assenza di mondo»? Non possiamo saperlo.
Avviene però qui quasi un gioco di specchi: la disputa d’amore tra Heidegger e Arendt diventa una chiave indispensabile per comprendere la riflessione sulla figura dell’Ebreo nei Quaderni neri, mentre questi ultimi gettano luce su quel rapporto.
Hannah - il nome ebraico che vuol dire «grazia» - è l’evento che spezza l’ordo amoris di Heidegger. Ma è anche la chance mancata, l’attimo fuggito, l’asilo rifiutato perché troppo inquietante e estraneo. Dopo di lei l’amore di Heidegger resterà spaesato, prigioniero nel regno della possibilità. La relazione dura solo pochi mesi. Heidegger sceglie il ritiro, la meditazione sull’Essere. Abbandona Hannah, aggira l’incontro, lascia che la sua figura svanisca, rifugge da quel che lei è concretamente. Così, in seguito, l’ebraismo può ritornare, come uno spettro, aggravato da un peso metafisico. E l’ombra dell’ebreo può proiettare l’ Ebreo figurale , accusato dell’abbandono dell’Essere.
Molti sono, oltre all’antisemitismo, i nuovi temi all’ordine del giorno dopo i Quaderni neri. Occorrerà, in particolare, riscrivere il capitolo sulla politica.
In un suo saggio recente Peter Sloterdijk sostiene che sia indispensabile oggi parlare di una «politica» di Heidegger, una politica radicale, percorsa da un «accento leniniano», da una tonalità apocalittica e dall’aspirazione a essere avanguardia.
Sloterdijk situa Heidegger, insieme a Dostoevskij, nello schieramento dell’antiglobalizzazione che critica lo stile di vita occidentale e punta l’indice contro il mondo della felicità appagata dal grande magazzino. Sloterdijk annovera Heidegger tra i « compagnons de route del comunismo». L’antiglobalizzazione avrebbe potuto portarlo «nel campo della sinistra».
Accanto a un concetto inedito e articolato di «rivoluzione», vista come «evento», la grande novità dei Quaderni neri è la riflessione di Heidegger sul comunismo. Le virgolette, usate con rigore, distinguono il comunismo storicamente realizzato, legato per lo più alla figura di Lenin, dal «comunismo» che resta invece una possibilità non ancora realizzata, il nome filosofico di quel comune e comunitario soggiornare umano nella pólis , che potrà esserci solo quando la politica non sarà più solo amministrazione burocratica.
«Potere dei soviet più elettrificazione»: il comunismo sovietico non ha parlato di «comunità». E ha assecondato il nichilismo tecno-planetario - per una via diversa da quella del liberalismo. Il rimprovero non potrebbe essere più grave. Perché il vero bersaglio di Heidegger è quella ideologia del progresso che ha la sua espressione più potente nel liberalismo. Dopo averlo ricondotto al «pragmatismo», alla dottrina per cui è vero ciò che è «utile», Heidegger lo designa con il nome di «americanismo» considerandone la provenienza geopolitica. E scrive: «Non prima del 2300, all’incirca, potrà esserci di nuovo Storia. Allora l’americanismo si sarà esaurito nel tedio del suo vuoto. Fino a quel momento l’uomo continuerà a compiere insospettati pro-gressi nel nulla, senza riconoscere lo spazio di questa sua corsa, e cioè senza superarlo».
Heidegger non considera il liberalismo come orizzonte ultimo e lo lega alla fine della modernità, mentre nel comunismo, non ancora realizzato, vede il polo filosoficamente opposto. La critica alla « rivoluzione occidentale » di Marx e di Lenin, «non abbastanza rivoluzionaria», si coniuga con una idea di globalizzazione a cui sembra affidato il futuro del filosofo, la sua possibilità di incidere nel XXI secolo.
Heidegger non ha mai trovato la via dell’esodo e il modo di giungere alla metropoli. I suoi sentieri si interrompono prima; ogni movimento, necessariamente planetario, gli appare ridondante. Perciò resta nell’intimità, in qual margine dove, da rivoluzionario liturgico, custodisce la presenza nascosta di un incombente stato di eccezione promesso a un mondo non redento. Rifiuta la visione urbana della politica, l’incontro delle opinioni nel mercato, lo scambio nell’assemblea popolare - o parlamentare. Il luogo da cui parla è extra-parlamentare, oltre-parlamentare. In questo senso la sua politica è una poetica dell’emergenza.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO --- Benjamin Netanyahu non è un negazionista, ma un politico che manipola la storia.23 ottobre 2015, di Federico La Sala
Benjamin Netanyahu non è un negazionista, ma un politico che manipola la storia
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 23.10.2015)
La storia si manipola quando si strumentalizzano intenzionalmente momenti, aspetti, passaggi problematici della vicenda storica - a fini politici.
In questo caso, il premier israeliano ha attribuito al Gran Muftì di Gerusalemme Amin al Husseini la responsabilità d’aver convinto Hitler a sterminare gli ebrei anziché procedere al loro trasferimento fuori dalla Germania.
Netanyahu fa questa affermazione in un momento di estrema conflittualità tra ebrei e palestinesi, mettendo insieme tre elementi: l’esistenza negli ambienti nazisti di una alternativa allo sterminio; la presunta indecisione di Hitler su come intendere e attuare la «soluzione finale» e il filonazismo e l’antisemitismo radicale del Muftì.
E’ opportuno fare chiarezza su questi punti per ristabilire la verità nella sua complessità, anche a beneficio di una politica che deve agire oggi con memoria vigile in un contesto molto diverso.
Un punto però è fuori discussione. Lo ha espresso con chiarezza il portavoce della cancelliera Angela Merkel: «Noi tedeschi conosciamo molto bene la storia della pazzia razzista criminale dei nazionasocialisti che ha condotto alla catastrofe di civiltà della Shoah. Non vedo alcuna ragione per cambiare in qualche modo il quadro storico. Conosciamo la responsabilità originaria tedesca per questo crimine contro l’umanità».
Anche Netanyahu la pensa così, ma nel suo discorso dà rilievo ad un dettaglio che implicitamente modifica il quadro storico: l’esistenza di un progetto diverso per colpire gli ebrei. Un progetto che sarebbe stato scartato per intervento del Muftì di Gerusalemme.
Qui Netanyahu fa confusione. Esisteva in effetti un’ipotesi alternativa allo sterminio con il trasferimento degli ebrei in Madagascar. Al ministero degli Esteri e anche in alcuni uffici d’emigrazione delle Ss si parlava di trasportare milioni di ebrei in quell’isola. Ma non c’era alcun progetto di fattibilità. Non si può escludere che fosse un’opera di disinformazione. Ma ottenne successo, dal momento che molti tedeschi ne erano convinti - anche quando vedevano intere famiglie ebree caricate sui vagoni ferroviari.
Ma è altrettanto certo che il colloquio tra il Muftì e Hitler cui si riferisce Netanyahu ha avuto luogo - 28 novembre 1941 - quando l’operazione che aveva di mira lo sterminio era già iniziata. Abbiamo testimonianze dirette di gerarchi e ufficiali in contatto con Hitler. Il 31 luglio 1941 Goering diede esplicitamente ordine al capo del Servizio di Sicurezza Reinhard Heydrich di «procedere alla soluzione finale del problema ebraico».
L’espressione «soluzione finale» è diventata per noi un termine-chiave inequivoco, ma non possiamo ignorare la sua ambiguità letterale. Qui si apre il capitolo del linguaggio dissimulatore e ingannatore che è parte essenziale della comunicazione nazista. Sono innumerevoli le parole apparentemente tecniche o neutre (emigrazione, pulizia, trattamento speciale, cambiamento di residenza) che nascondevano brutali realtà criminali.
Tornando all’incontro tra Hitler e il Muftì, questi (secondo Netanyahu ) avrebbe detto «Se cacciate via gli ebrei, verranno tutti in Palestina». «Allora che cosa devo fare di loro?» - avrebbe chiesto Hitler. «Bruciateli» - fu la risposta. Secondo il premier israeliano, il Muftì avrebbe anche accusato gli ebrei di voler distruggere la moschea sul Monte del Tempio.
Inutile dire come quest’ultima osservazione da parte del premier israeliano accentui ancora più esplicitamente il nesso che vuole proporre come autoevidente tra quegli eventi passati e il presente. Innescando un corto-circuito inaccettabile e pericoloso. La drammatica situazione di oggi in Israele richiede una intelligenza storica e politica ben più matura.
Netanyahu non ha capito il significato di Auschwitz
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, 23.10.2015)
In un momento così grave per il proprio Paese un leader politico dovrebbe anzitutto pesare le parole. E dovrebbe guardarsi dal fare un uso strumentale della storia a fini politici. Non solo Israele, ma tutto il mondo ebraico della diaspora, è oggi costernato e non potrà facilmente dimenticare l’intervento di Netanyahu che parlando al XXXVI Congresso sionista di Gerusalemme ha di fatto ridotto e sminuito le responsabilità di Adolf Hitler, fin quasi alla negazione.
Non si tratta solo di un falso storico. Al-Husseini, il Gran Muftì, è stato un seguace, non certo l’ispiratore del Führer - come emerge con chiarezza dall’intervista sul Corriere della Sera di Dino Messina allo storico Mauro Canali.
Agghiaccianti sono le parole di Netanyahu per almeno due motivi. Il primo riguarda il crimine della Shoah. Le ricerche condotte negli ultimi anni mostrano che sin dall’inizio i nazisti non pensavano a una espulsione miravano invece allo sterminio degli ebrei d’Europa. Temevano la «nazione ebraica». Basterebbe leggere Mein Kampf. Ma c’è di più: ormai è sempre più chiaro che il nazismo hitleriano è stato il primo rimodellamento biopolitico del pianeta. Sta qui la sua peculiarità - anche rispetto ad altri genocidi. In questo progetto politico non era previsto più nessun luogo per gli ebrei. Con le sue parole Netanyahu mostra di non aver compreso, o di non voler comprendere, che cosa ha significato Auschwitz. E non basterà chiedere scusa ai sopravvissuti, ai parenti delle vittime, e a tutti gli ebrei costernati oggi dopo questa patetica, importuna e deplorevole boutade del premier.
Il secondo motivo riguarda l’abuso della Shoah in un discorso pubblico per acquisire consensi. È forse proprio questo che offende e irrita di più. Perché ci si poteva attendere da altri un disinvolto e bieco cinismo, che pure ogni giorno si tenta di contrastare. Non certo dal primo ministro dello Stato di Israele.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO -- Lo storico Kellerhoff ritiene «totalmente prive di ogni fondamento storico» le argomentazioni di Netanyahu22 ottobre 2015, di Federico La Sala
Lo storico del nazismo Kellerhoff:
“Le prime fantasie di sterminio vennero al Führer già nel 1919”
“Antisemitismo ossessivo”
Il “Mein Kampf” sarà ristampato a gennaio: “Ecco le sue bugie”
di Tonia Mastrobuoni (La Stampa, 22.10.2015)
- Il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, è stato deciso: "Non c’è nessun motivo per cambiare la storia". E ha continuato: "Conosciamo bene l’origine dei fatti ed è giusto che la responsabilità sia sulle spalle dei tedeschi".
All’inizio degli anni Venti, Adolf Hitler era ospite fisso dei salotti di Monaco, dove i ricchi borghesi si divertivano ad ascoltare l’eccentrico austriaco abbaiare i suoi proclami antisemiti. Quando l’attenzione scemava, il tribuno di Braunau schioccava il suo frustino sugli stivali da cavallerizzo, per costringere famiglie come i Bechstein - quelli dei pianoforti - a non perdersi neanche una sillaba delle sue tirate contro gli ebrei «parassiti». I monacensi facoltosi adoravano quello strano politicante che indossava lisi completi blu e che da lì a poco avrebbe organizzato l’inquietante putsch nella capitale bavarese. E il suo odio viscerale, ossessivo per gli ebrei non li disturbava: «l’antisemitismo era molto diffuso, nella borghesia tedesca, ma anche in quella francese o austriaca, in quegli anni» ricorda Sven Felix Kellerhoff.
Un odio antico
Nel 1919, sottolinea lo storico e giornalista tedesco, Hitler aveva già espresso in una lettera ad un soldato, Adolf Gemlich, il suo odio malato contro gli ebrei, evocando pogrom, discriminazioni per legge, allontanamenti. «Le fantasie da sterminio - argomenta Kellerhoff - sono già evidenti in quella lettera, ma anche in “Mein Kampf”», il delirante manifesto scritto in carcere nel 1924 e venduto 12 milioni di copie prima della fine della Seconda guerra mondiale. Kellerhoff ritiene «totalmente prive di ogni fondamento storico» le argomentazioni del premier israeliano Netanyahu: Hitler «sognava già di sterminare gli ebrei quando il Muftì di Gerusalemme non era neanche lì». L’antisemitismo ossessivo e la teoria dello spazio vitale per i tedeschi sono i due cardini del libro del Fuehrer, argomenta l’esperto di storia del nazismo.
Kellerhoff ha appena dato alle stampe un documentatissimo libro sulla bibbia dei nazisti: «“Mein Kampf”. Die Karriere eines deutschen Buches» (Klett-Cotta), alla vigilia di un evento storico. A gennaio dell’anno prossimo sarà pubblicata in Germania la prima edizione commentata del manifesto di Hitler, dopo ben 70 anni. Il libro non è mai stato vietato, ricorda l’autore: ne è stata proibita la ristampa, dopo la guerra (i diritti appartengono al Land Baviera). «Un errore clamoroso - per Kellerhoff - perché ha alimentato miti e leggende false». In quasi 800 pagine il Fuehrer ha condensato un’opera «intellettualmente misera, piena di errori grammaticali, stilisticamente obbrobriosa, che pullula di insulti, falsi autobiografici - su cui sono inciampati persino biografi del calibro di Joachim Fest - e assurdità storiche». Kellerhoff ha le idee chiare sull’origine dell’antisemitismo di Hitler, ma smaschera il teorico del Terzo Reich anche su aspetti biografici assolutamente grotteschi.
Manie di grandezza
La frenesia agiografica dei nazisti ha distorto molti aspetti della vita di Hitler, cercando di confermare i deliri di «Mein Kampf». Kellerhoff ne elenca molti. Il primo è quello della giovinezza povera e disagiata a Vienna e Monaco. È vero che nella capitale asburgica Hitler visse momenti terribili, alla vigilia della Grande guerra, di fame e pernottamenti negli alberghi dei poveri. Anni in cui fu aiutato economicamente, peraltro, da alcuni amici ebrei. Ma la verità è che riusciva ogni mese a spendersi la pensione da orfano e i soldi della famiglia in un battibaleno. Un bamboccione, più che un bohèmien.
Nessun eroismo
Anche i racconti epici delle battaglie combattute nell’esercito tedesco durante la Grande guerra sono da ridimensionare. Il «battesimo di fuoco» di Hitler avvenne effettivamente nelle Fiandre. «Mein Kampf» non lascia spazio alla fantasia: pallottole che fischiano intorno alle orecchie del giovane Fuehrer, botti assordanti, un corpo a corpo micidiale e la battaglia che culmina in un coro che si leva dalle prime file, intona «Deutschland, Deutschland ueber alles», contagiando tutto il battaglione.
Fantasie, secondo la ricostruzione storica: di fronte all’avanzata micidiale dei francesi, molti commilitoni si buttarono a terra fingendosi morti, il comandante gridò tre volte invano «all’attacco». E Hitler? A giudicare dalle cronache, al suo solito posto: nelle retrovie. E fu la costanza - non l’eroismo - mostrata in quelle retrovie che gli valse poi la Croce di ferro. Medaglia di cui il Fuehrer parlò sempre con timidezza. Strano, si dirà. Ma il motivo è ovvio. Il luogotenente che aveva insistito per conferire una medaglia al merito al giovane Hitler, Hugo Gutmann, era ebreo.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- Ebrei a Destra un labirinto. Nessi impensabili a livello ideologico ci fu chi ipotizzò un patto con Hitler (di Paolo Mieli)17 febbraio 2015, di Federico La Sala
Ebrei a Destra un labirinto
Nessi impensabili a livello ideologico ci fu chi ipotizzò un patto con Hitler
di Paolo Mieli (Corriere della Sera, 17.02.2015)
Da qualche anno il rapporto tra il mondo ebraico e la destra politica europea è finito all’attenzione degli storici. Nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale, eccezion fatta per qualche studioso americano, in pochi avevano approfondito questa relazione, soprattutto perché, indagando su di essa, si sarebbe dovuto indagare su nessi che coinvolgevano il fascismo e, perfino, il nazismo. Di destra ed ebrei si era cominciato a parlare nella seconda metà degli anni Settanta, ai tempi della vittoria in Israele di Menachem Begin con il Likud.
Fu in quel momento (1977) che venne «riscoperta» la figura del leader del revisionismo sionista Vladimir Ze’ev Jabotinsky. Ed è alle personalità, peraltro tra loro assai diverse, di questa particolarissima sensibilità per la destra del mondo israelitico che è dedicato l’interessante libro di Vincenzo Pinto, In nome della Patria. Ebrei e cultura di destra nel Novecento , di imminente pubblicazione per Le Lettere. Fin qui, scrive Pinto, la cultura di sinistra ha finito per rileggere la storia degli ebrei sotto la categoria della persecuzione antisemita («geneticamente» di destra). Le figure conservatrici del mondo ebraico «sono state relegate ai margini della storia», come ingenui rappresentanti di un’utopia, «quella di essere parte integrante del proprio Paese ospitante, di poter realizzare il sogno della diversità senza l’assimilazione».
C’è stato, però, dell’altro. L’ebreo di destra, scrive Pinto, è culturalmente «figlio legittimo della tradizione ma figlio “adottivo” della modernità tecnologica e spirituale». La «destra ebraica», ha osservato lo studioso israeliano Ezra Mendelsohn, è molto più difficile da definire rispetto alla sinistra; se i partiti ebraici progressisti erano orgogliosi di affermare la loro «simpatia ideologica per la sinistra generale europea», i loro oppositori «erano alquanto restii ad ammettere qualsiasi affinità con la “destra generale europea” che, nel periodo interbellico, era spesso sinonimo di fascismo (e, naturalmente, di antisemitismo)». Ciò nonostante, prosegue Mendelsohn, se definiamo la destra come «la formazione di un campo politico fieramente opposto al socialismo» nonché «conservatore nella sua idea di come dovrebbe organizzarsi la società ebraica», allora diventa possibile identificare una destra israelitica già nella stagione tra le due guerre mondiali.
La caratteristica unificante, nel corso degli anni Venti e Trenta, era «l’enfasi tenace sull’assoluta necessità dell’unità ebraica e, di conseguenza, la profonda ostilità verso tutti i movimenti politici che predicavano l’idea di guerra di classe o persino la divisione di classe nel mondo ebraico». Uno dei termini preferiti nel dizionario politico della destra secolare, ricorda Mendelsohn, era quello di monismo ( hadnes in ebraico; una bandiera), «che implicava la supremazia dell’unità nazionale, valore tradizionale ebraico, sulla divisione sociale». La sinistra definì assai pericolosa questa enfasi sull’«unicità» ebraica. Così la destra israelitica fu subito criticata per aver «importato nel mondo israelitico pericolose idee “straniere” che ponevano falsamente un ebreo contro l’altro e perciò facevano il gioco del nemico comune: l’antisemitismo».
Pinto bolla come «discutibili» queste tesi. Ma riconosce a Mendelsohn il merito di aver impostato correttamente la questione. Rimproverandogli, però, di aver teso a «liquidare la destra ebraica moderna (non sionista) come irrilevante nella diatriba tra secolarismi e religiosi», e di aver dimenticato «che, lungo tutto il Novecento, vi furono non pochi ebrei di destra sostenitori di altre forme di nazionalismo conservatore».
Grande protagonista di questo libro è il già citato Jabotinsky, definito da Pinto «il re senza corona». Nato a Odessa nel 1880, giornalista, agitatore politico, scrittore, ufficiale dell’esercito, e perfino assicuratore, ha segnato «in maniera indelebile il discorso politico sionista e israeliano nei primi decenni del Novecento» ed è considerato «una delle personalità ebraiche più affascinanti ma, al contempo, contraddittorie del secolo passato». Fu il primo a teorizzare, durante un pogrom nel 1903, l’autodifesa ebraica. Autodifesa che Jabotinsky avrebbe esportato a Gerusalemme all’inizio degli anni Venti. È stato il padre, si è detto, del «revisionismo sionista», ma morì di un attacco cardiaco a New York nell’agosto del 1940 prima di conoscere il volto atroce della Shoah, ma anche prima di aver potuto vedere realizzato il sogno di uno Stato di Israele .
Figura ben diversa è quella del banchiere ebreo torinese Ettore Ovazza, considerato da Pinto «un personaggio quasi romanzesco per la sua ingenua e fideistica adesione al fascismo» o, piuttosto, «un personaggio tragico, accecato dal proprio amor patrio a tal punto da non scorgere il nodo del destino sempre più stretto intorno al collo proprio e dei propri cari». Ovazza - al quale si è già dedicato Alexander Stille nel libro Uno su mille (Mondadori) - rimarrà fascista fino alla fine, accettando la legislazione antiebraica, respingendo l’opportunità di emigrare e trovando una tragica morte, per mano delle SS il 9 ottobre del 1943, nei pressi del confine svizzero. Il suo amore per il fascismo mussoliniano può anche essere letto, secondo Pinto, «come un tentativo di trovare una dimensione estetica nuova e alternativa al sentimentalismo borghese, chiuso in se stesso, incapace di riunire armonicamente spirito e materia». Anche se la visione spirituale dell’ebraismo e del fascismo di Ovazza «si è scontrata con una visione e una realtà materiali che avevano preso il sopravvento»; dappertutto ormai in Europa «si considerava l’ebreo come il materialista per eccellenza, come il distruttore dell’idillio e di tutte le barriere, non come il difensore di un ideale di giustizia messianica o come parte integrante della civiltà occidentale» .
Un caso più complicato è quello di Isaac Kadmi-Cohen (1892-1944) , ebreo polacco, che mise radici in Francia. «Ebreo di sinistra nello scacchiere politico francese, ma di destra in quello sionista internazionale», scrive di lui Pinto, Kadmi-Cohen «ha cercato disperatamente di mutare le sorti del suo popolo e di salvarlo dalla tempesta antisemita» battendosi per la nascita di uno Stato mediorientale che fosse «la casa di tutti i popoli semiti». Kadmi-Cohen concepisce un semitismo come modo di essere alternativo all’arianesimo, e il suo progetto pansemita è alternativo allo «spirito del ghetto». Di più. Per lui «la vera minaccia dell’Occidente non è la barbarie comunista oppure l’Oriente vicino ed estremo... e non è nemmeno più una questione di contrapposizione interna al continente». Il vero nemico è rappresentato dall’America (cioè gli Stati Uniti) e, più in particolare, da quel materialismo di cui è emblema una semplice banconota: il dollaro». L’identificazione del «nemico americano» produce un ambizioso progetto di federazione degli Stati europei, la cui prima tappa dovrebbe essere nella costituzione di un asse politico tra Parigi e Berlino, «che ponga fine ai vecchi conflitti».
Tale progetto va in frantumi tra il 1939 e il 1940 con l’invasione nazista della Polonia e lo scoppio della Seconda guerra mondiale. E, quando le croci uncinate invadono la Francia, Kadmi-Cohen punta addirittura ad una trattativa con il governo di Vichy per una «espulsione di massa» che favorisca la creazione di uno Stato ebraico e che salvi gli ebrei dal genocidio hitleriano. Ai suoi occhi il nazismo non rappresentava una maledizione politica o religiosa, bensì «una possibilità per porre fine all’apolidismo diasporico». Teorie che non gli eviteranno una morte atroce nel campo di sterminio di Gleiwitz. Ma che gli varranno l’imbarazzante stima di antisemiti come il visconte Léon de Poncins o di negazionisti come Paul Rassinier. Ma la sua storia in un certo senso non finisce con la morte a Gleiwitz.
Suo figlio Jean-François Steiner (dal cognome del patrigno, anche lui ebreo) pubblica nel 1966 un romanzo a tesi intitolato Treblinka (pubblicato in Italia da Mondadori). Treblinka narra la storia della rivolta ebraica nel Lager nazista «cercando da un lato di mettere in evidenza i meccanismi psicologici, tecnologici e morali utilizzati dai carnefici (i “tecnici”) per piegare la volontà delle vittime e dall’altro lato mostrando le profonde contraddizioni insite nel popolo ebraico e, in particolare, il dilemma tra salvezza fisica e salvezza morale». Secondo Pinto, all’autore premeva «dimostrare che la retorica martirologica della resistenza non rappresentava che una prosecuzione del vecchio “spirito del ghetto” tanto criticato dal padre». Voleva altresì porre domande assai scomode sulla «scarsa resistenza ebraica alla deportazione» e persino sulla «collaborazione delle classi dirigenti» israelitiche con i persecutori del loro popolo.
Una storia a sé è quella del lituano Joseph G. Klausner (1874-1958), prozio di Amos Oz, che di lui ha scritto in Una storia di amore e di tenebra (Feltrinelli). La sua opera «ha rappresentato la realizzazione di una particolare sintesi fra la cultura umanistica occidentale e la tradizione ebraica orientale», là dove Klausner provò a recuperare «le migliori aspirazioni libertarie dei suoi correligionari illuministi occidentali (tedeschi, in particolar modo)», per innestarle sull’albero «sano» della tradizione religiosa orientale.
Più imbarazzante il caso di Abba Achimeir o Gaissinovic (1897-1962), «lettore e interprete» di Oswald Spengler, ammiratore di Benito Mussolini che definì come l’autentico erede di Mazzini e di Garibaldi, oltreché estimatore del generale polacco Józef Pilsudski. Restano celebri le sue «cronache di un fascista» scritte nel 1928 sul giornale revisionista «Doar Hayom». Nel ’29 fonda, con il poeta Uri Zvi Greenberg e lo scrittore Yehoshua Yevin, l’associazione segreta «Brit Ha’Birionim» (Patto dei briganti), ispirata agli zeloti d’epoca romana nell’intento di combattere gli inglesi, gli arabi, ma anche gli «ebrei moderati o disfattisti». Nel 1933 Achimeir fu arrestato con l’accusa di istigazione all’assassinio di Chaim Arlosoroff, esponente di punta del sionismo in Palestina, ritenuto uno dei principali artefici di un accordo commerciale con la Germania nazista.
Ancora più complicato il caso del tedesco Hans-Joachim Schoeps (1909-1980), che nel 1930, in uno scritto dal titolo «Gioventù e nazionalsocialismo», fu in grado di prefigurare la vittoria nazista e nel 1932 venne all’attenzione - in parte benevola - del celeberrimo studioso di misticismo ebraico Gershom Scholem. Negli anni tra il 1933 e il 1934, Schoeps diede vita ad un bollettino, «Der Vortrupp», sorretto da un’omonima casa editrice, vagheggiò un incontro tra ebraismo e nazismo e cercò di costituire un fronte ebraico in grado di ottenere il riconoscimento da parte del governo hitleriano. Tutto era basato su un progetto di «epurazione» interna dell’ebraismo tedesco. Tale progetto, ricorda Pinto, «fu espresso in un memoriale che conteneva l’idea di creare una corporazione ebraica che separasse gli elementi ebraici insani (i sionisti e gli ebrei orientali) da quelli sani (gli ebrei coscienziosamente tedeschi)».
I nazisti non lo seguirono su questa strada, già nel ’35 esclusero gli ebrei dall’esercito e dalla marina e sciolsero tutte le associazioni ebraiche. Nel ’38 Schoeps riparò in Svezia, i suoi morirono nei campi di concentramento e lui poté tornare solo nel 1946 in Germania, dove insegnò all’università e approfondì il nesso tra ebraismo e prussianesimo che gli stava a cuore fin dai tempi della gioventù. Schoeps, scrive Pinto, non rinnegò mai il proprio passato politico (le proprie simpatie per la «rivoluzione conservatrice»), tanto da pubblicare nel 1970 la raccolta di scritti Bereit für Deutschland (Pronti per la Germania) come risposta alle accuse di esser stato un «nazista ebreo». Tenne sempre a distinguere, prosegue Pinto, il suo particolare conservatorismo prussiano dal nazismo, esito di una «rivoluzione popolare» e razziale dettata dall’ hybris umana moderna. Il legame fra prussianesimo ed ebraismo «aveva radici storico-religiose, non razziali, l’eroica ostinazione prussiana contro l’auto-disgregazione aveva sconfitto l’infinità del paesaggio pianeggiante (a differenza della melanconia russa), come gli ebrei avevano fatto verso il deserto attraverso la parola del loro Signore sovrano».
Jabotinsky è stato il leader della destra sionista negli anni che precedettero la costituzione dello Stato di Israele. Ovazza è stato uno dei maggiori rappresentanti della destra ebraica antisionista nell’Italia fascista. Kadmi-Cohen è stato il paladino di un semitismo ultra-rivoluzionario nella Francia della Seconda Repubblica. Klausner ha alimentato una visione organicistica della nazione ebraica tra la Russia tardo-zarista e la Palestina mandataria. Gaissinovic ha sostenuto una visione rivoluzionaria del sionismo. Schoeps ha pensato fosse possibile una rifondazione dialettica dell’ebreo tedesco durante il nazismo. Tutti questi personaggi, scrive Pinto, hanno creduto in una visione militante della cultura: lo spirito non deve «emancipare» gli ebrei dal giogo del capitalismo, ma renderli «partecipi consapevoli della modernità» .
Il loro comune avversario avrebbe dovuto essere l’Illuminismo, l’idea che l’ebraismo fosse semplicemente una «morale» universalizzabile e non più una religione nazionale, che gli ebrei fossero uomini come tutti gli altri. Liberalismo e comunismo erano ritenuti due facce della stessa medaglia: la distruzione dei legami spirituali e comunitari degli individui e la loro sottomissione ad una presunta etica universalistica e utilitaristica. L’antisemitismo era visto come l’altra faccia della modernità, come l’esito di logiche puramente materiali e della (fallita) assimilazione degli ebrei ai popoli ospitanti. Le loro furono esperienze tra loro molto diverse, ma che testimoniano una complessità di nessi in qualche caso imprevedibili. Addirittura insospettabili.
Quei personaggi che lottarono per il risveglio del loro popolo *
Esce domani in libreria il volume di Vincenzo Pinto In nome della Patria. Ebrei e cultura di destra nel Novecento , edito da Le Lettere (pagine 200, e 16,50) nella collana Biblioteca di «Nuova Storia Contemporanea» diretta da Francesco Perfetti. Uno su mille (Mondadori, 1991) è il titolo del saggio in cui Alexander Stille si è occupato anche del banchiere ebreo italiano Ettore Ovazza, un fervente fascista che venne ucciso dalle SS nell’ottobre del 1943. S’intitola Treblinka (traduzione di Luisa d’Alessandro e Giovanni Mariotti, Mondadori, 1967) il libro dedicato da Jean-François Steiner alla rivolta avvenuta nell’omonimo campo di sterminio. Lo scrittore israeliano Amos Oz parla del suo prozio Joseph G. Klausner, esponente della destra ebraica, nel romanzo Una storia di amore e di tenebra (traduzione di Elena Loewenthal, Feltrinelli, 2003)
* Corriere della Sera, 17.02.2015
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. --- BIBI Netanyahu ci ricorda che l’ottusità ... (di Michele Serra - L’amaca).17 febbraio 2015, di Federico La Sala
L’amaca
di Michele Serra (la Repubblica, 17.02.2015)
BIBI Netanyahu ci ricorda che l’ottusità è, nella storia umana, un fattore purtroppo notevole. Come ha spiegato benissimo, e con condivisibile animosità, Gad Lerner su questo giornale, invitare gli ebrei europei ad abbandonare i loro paesi per trovare rifugio in Israele equivale a concedere all’antisemitismo e al terrorismo una patente di invincibilità: come se la sola cosa da fare fosse scappare a gambe levate. E come se le comunità nazionali delle quali quegli ebrei, a milioni, fanno parte a pieno titolo da molte generazioni fossero così imbelli e impreparate da non essere in grado di proteggere i propri cittadini.
Di peggio c’è solo da aggiungere che il pensiero di Nethanyau racchiude, alla massima potenza, la perniciosa idea che ognuno di noi sia ciò che è solo in conseguenza della religione e/o dell’etnia; mentre essere francesi o inglesi o italiani o danesi o europei è uno status che, anche formalmente, non deriva in alcun modo da religione o etnia.
Qualcuno spieghi a Bibi che gli ebrei francesi e gli ebrei danesi sono francesi ebrei e danesi ebrei: e non è la stessa cosa. Il patto sociale, nelle democrazie moderne, non è tra correligionari, è tra concittadini. Un mondo organizzato alla maniera di Netanyahu prevede tutti gli ebrei in Israele, tutti gli islamici in Arabia e tutti i cristiani a Roma? E gli atei? Tutti a Las Vegas?
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. --- Le responsabilità della filosofia (di C. Augias)17 febbraio 2015, di Federico La Sala
Le responsabilità della filosofia
risponde Corrado Augias (la Repubblica, 17.02.2015)
Caro Augias,
 si vorrebbe che i grandi filosofi fossero anche uomini di grande livello, non sempre è così, dell’adesione al nazismo di Heidegger si sapeva, e tuttavia, passando per la fenomenologia di Husserl a cui Essere e tempo è dedicato, e agli sviluppi successivi dell’Esistenzialismo di cui Heidegger è un fabbricatore, non si può non prendere ciò che di nuovo e di spessore ci sia nella sua filosofia. Anche Furtwangler è stato nazista, ma resta un grande direttore d’orchestra. Forse bisogna separare, in alcuni (o molti?) casi, l’uomo dall’opera, Andrea Emo, grande metafisico, poco conosciuto è stato fascista, e tuttavia leggere (grazie a Cacciari) i suoi quaderni di metafisica, è necessario, per chi ami la filosofia, che se non aiuta a vivere a volte è sicuramente una consolazione (vedi Boezio). Gli uomini sono complessi, figuriamoci i filosofi, questo certo non giustifica certe scelte ma dobbiamo essere giusti, qualcuno lo ha detto che Heidegger è stato un grande filosofo e un piccolissimo uomo, quindi lasciamo perdere l’uomo...
Gianfranco Coci
si vorrebbe che i grandi filosofi fossero anche uomini di grande livello, non sempre è così, dell’adesione al nazismo di Heidegger si sapeva, e tuttavia, passando per la fenomenologia di Husserl a cui Essere e tempo è dedicato, e agli sviluppi successivi dell’Esistenzialismo di cui Heidegger è un fabbricatore, non si può non prendere ciò che di nuovo e di spessore ci sia nella sua filosofia. Anche Furtwangler è stato nazista, ma resta un grande direttore d’orchestra. Forse bisogna separare, in alcuni (o molti?) casi, l’uomo dall’opera, Andrea Emo, grande metafisico, poco conosciuto è stato fascista, e tuttavia leggere (grazie a Cacciari) i suoi quaderni di metafisica, è necessario, per chi ami la filosofia, che se non aiuta a vivere a volte è sicuramente una consolazione (vedi Boezio). Gli uomini sono complessi, figuriamoci i filosofi, questo certo non giustifica certe scelte ma dobbiamo essere giusti, qualcuno lo ha detto che Heidegger è stato un grande filosofo e un piccolissimo uomo, quindi lasciamo perdere l’uomo...
Gianfranco CociIl signor Coci si riferisce alla recente scoperta di un quaderno nero del filosofo Heidegger da cui si ricava che egli era al corrente delle atrocità commesse nei campi di sterminio ma non per questo cambiò idea. La domanda se bisogna ancora una volta separare l’uomo dalla sua opera è più che legittima.
Ho chiesto un parere alla studiosa Donatella Di Cesare, autrice del recente saggio Heidegger e gli ebrei (Bollati Boringhieri). Mi ha cortesemente inviato la risposta che trascrivo:
 “Il pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale? L’antisemitismo metafisico, emerso nei Quaderni neri, muta profondamente la visione che abbiamo di Heidegger. E ora viene meno anche il suo silenzio sullo sterminio. Sarebbe comodo continuare a leggerlo, facendo finta di nulla, oppure gettare alle ortiche la sua opera. Il nazismo non è stato una ‘follia’, ma un progetto di rimodellamento biopolitico del pianeta. Gli ebrei non avrebbero più dovuto avere posto nel mondo.
“Il pensiero più elevato si è prestato all’orrore più abissale? L’antisemitismo metafisico, emerso nei Quaderni neri, muta profondamente la visione che abbiamo di Heidegger. E ora viene meno anche il suo silenzio sullo sterminio. Sarebbe comodo continuare a leggerlo, facendo finta di nulla, oppure gettare alle ortiche la sua opera. Il nazismo non è stato una ‘follia’, ma un progetto di rimodellamento biopolitico del pianeta. Gli ebrei non avrebbero più dovuto avere posto nel mondo.
 Heidegger non è isolato; proviene da una lunga tradizione di odio verso il popolo ebraico.
Heidegger non è isolato; proviene da una lunga tradizione di odio verso il popolo ebraico.
 Se Kant auspica una ‘eutanasia dell’ebraismo’, se Hegel esclude gli ebrei dalla storia della salvezza, non ci deve sorprendere che Heidegger definisca la Shoah l’autoannientamento degli ebrei. Certo, ben diverse sono le responsabilità che si assume così negli anni Trenta e Quaranta.
Se Kant auspica una ‘eutanasia dell’ebraismo’, se Hegel esclude gli ebrei dalla storia della salvezza, non ci deve sorprendere che Heidegger definisca la Shoah l’autoannientamento degli ebrei. Certo, ben diverse sono le responsabilità che si assume così negli anni Trenta e Quaranta.
 Prendere alla lettera le metafore dei filosofi è stato il lavoro dei boia. Ma l’accusa metafisica di tanti filosofi che hanno condannato gli ebrei al non-essere, al nulla, ha avuto esiti devastanti. Credo che sia venuto il momento - con Heidegger e oltre Heidegger - di interrogarsi sulle responsabilità della filosofia verso lo sterminio”.
Prendere alla lettera le metafore dei filosofi è stato il lavoro dei boia. Ma l’accusa metafisica di tanti filosofi che hanno condannato gli ebrei al non-essere, al nulla, ha avuto esiti devastanti. Credo che sia venuto il momento - con Heidegger e oltre Heidegger - di interrogarsi sulle responsabilità della filosofia verso lo sterminio”. -
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO --- Dagli atti del processo Eichmann tradotte le pagine relative alle vittime più giovani (di Elena Loewenthal - La Shoah dei bambini)1 dicembre 2014, di Federico La Sala
La Shoah dei bambini
Inghiottiti nei forni crematori, sfracellati contro i muri, centrati a colpi di pistola. Dagli atti del processo Eichmann tradotte le pagine relative alle vittime più giovani
di Elena Loewenthal (La Stampa, 01.12.2014)
Che la memoria sia un valore e ricordare un dovere è cosa ormai assodata. Un dogma che non si discute, valido in assoluto. Ma non sempre è stato così, neppure a proposito di quella memoria divenuta tale per antonomasia, tanto da siglare una giornata apposita. La Shoah non è sempre stata l’oggetto di una commemorazione pubblica, non è sempre stata il simbolo del dovere morale di ricordare, per evitare che succeda di nuovo. Anzi.
Negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, di imperativo ne era in vigore un altro, di segno opposto: lasciarsi tutto alle spalle. Tornare a vivere. E per poterlo fare, per potersi svegliare ogni mattina e prendere sonno ogni sera senza lo sgomento di quel passato prossimo, sembrava necessario dimenticare. Quanto meno, tacere. Israele era allora il Paese con il più alto tasso di incubi notturni e urla dal sonno profondo. Ma i sopravvissuti tacevano, di giorno. Un po’ per continuare a sopravvivere, per non farsi distruggere dalla disperazione. Un po’ per l’indecifrabile vergogna di esserci ancora, mentre tutti gli altri erano morti.
Poi ci fu un evento cruciale, senza il quale la memoria non sarebbe diventata quello che è oggi. Nel 1960 Adolf Eichmann, la mente della Soluzione finale, viene individuato e catturato dagli israeliani in Sud America, dove conduce una vita perfettamente tranquilla. L’anno successivo s’inizia a Gerusalemme il suo processo, in una sala costruita all’uopo. Centinaia di sopravvissuti prendono posto sul banco dei testimoni, sotto gli sguardi della corte e dell’impassibile imputato. Centinaia di giornalisti di tutto il mondo seguono le udienze. Molte sono trasmesse per radio. In Israele e nel mondo intero si ascoltano per la prima volta, da quelle vive ma straziate voci, i racconti della Shoah. In quei mesi, la memoria diventa qualcosa di diverso da ciò che era prima. Parole, sguardi, silenzi. Anche il tonfo del corpo svenuto di Yechiel De Nur, che ha voluto testimoniare con il nome di Ka-Tzetnik (abbreviazione di «prigioniero del campo di concentramento») seguito dal numero che ha tatuato sul braccio, e non ce l’ha fatta.
Livio Crescenzi, archeologo e traduttore di letteratura americana, sta da molti anni lavorando alla traduzione italiana di quel documento indispensabile che sono gli atti del processo.
Inspiegabilmente, nella mole financo ridondante di letteratura intorno alla Shoah di cui dispone e in cui ancora si profonde la nostra editoria, mancava questo tassello fondamentale. Forse perché si tratta di un lavoro immenso e minuzioso, che esige passione e commozione nel senso più alto del termine, il desiderio cioè di sentire e inevitabilmente soffrire, lavorando su quelle parole. Più che mai quando il tema sono i bambini della Shoah, come in questo secondo volume degli atti, pubblicato come il precedente dal benemerito editore Mattioli 1885 con il titolo Un fiore mi chiama (pp. 207, € 21,90) e una prefazione di Ernesto Galli della Loggia.
Sono pagine terribili. Non c’è altro modo per definirle. È una lettura che mette a dura prova, che ti provoca continuamente, che ti invita a ogni pagina a chiudere il libro, sbatterlo contro il primo muro, urlare che non è possibile. Eppure è così. Crescenzi ha metodicamente raggruppato le testimonianze per luoghi, momenti. Udienza per udienza. A partire dal ghetto di Varsavia dove più si era piccini più probabilità - per quanto scarsa - c’era di riuscire a contrabbandare un tozzo di pane di qua dal muro, sfuggendo alla sorveglianza. C’è la tacca su un altro muro, quello del dottor Mengele: sopra significava passare dai suoi esperimenti, sotto voleva dire essere troppo piccoli di statura, e finire immediatamente nelle camere a gas.
C’è un’infinità intollerabile di neonati strappati alle braccia delle madri e sbattuti per terra per fracassargli il cranio. Ridendo. C’è quel bambino rimasto un anno nascosto in cantina con la consegna del silenzio, che a distanza di tanto tempo ancora sussurrava invece di parlare, per paura. C’è anche il sedicenne che Eichmann uccise perché aveva rubato due ciliegie dal suo albero. Era in una squadra di lavori forzati al servizio «domestico» e fu probabilmente l’unico caso in cui la bestia nazista ammazzò qualcuno direttamente, con le proprie mani. Il suo avvocato difensore si accanisce contro questa testimonianza, perché tutta la sua strategia è basata sul paradosso di un capo d’accusa fondato sulla responsabilità di più di sei milioni di morti, e nessun (o quasi nessun) omicidio compiuto in prima persona.
Eichmann venne giustiziato il 31 maggio 1962 perché ritenuto colpevole di crimini contro l’umanità, nella piena consapevolezza che la pena, per quanto capitale, non era commisurata all’immensità della colpa. Momento cruciale della storia di tutti noi, chiave di volta del nostro approccio alla memoria, il processo Eichmann è anche, forse soprattutto, la resa di ogni possibile giustizia di fronte a un milione e mezzo di bambini inghiottiti dal fumo dei forni crematori, sfracellati contro il muro, centrati da un colpo di pistola, sepolti dentro una fossa comune.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---e del il suo assistente Otto von Bolschwing (di Massimo Gaggi - Cia, la guerra sporca e quei mille nazisti arruolati contro i sovietici).28 ottobre 2014, di Federico La Sala
 La storia
La storia
 Cia, la guerra sporca e quei mille nazisti arruolati contro i sovietici
Cia, la guerra sporca e quei mille nazisti arruolati contro i sovietici
 Per i vertici dell’intelligence ogni mezzo era lecito per contrastare Mosca.
Per i vertici dell’intelligence ogni mezzo era lecito per contrastare Mosca.
 Nel 1980 l’Fbi si rifiutò di fornire informazioni su 16 nazisti che vivevano negli Usa
Nel 1980 l’Fbi si rifiutò di fornire informazioni su 16 nazisti che vivevano negli Usadi Massimo Gaggi *
Quando nel 1960 agenti israeliani catturarono in Argentina Adolf Eichmann, il regista della «soluzione finale» studiata dai nazisti per gli ebrei, il suo assistente Otto von Bolschwing, reclutato già da anni dai servizi segreti americani che ben sapevano del suo passato nelle SS, andò a chiedere protezione, temendo di essere anche lui scoperto e processato. La Cia, che a suo tempo lo aveva assunto in Europa come spia impegnata a contrastare la diffusione del comunismo e l’influenza del blocco sovietico, e che nel 1954 lo aveva addirittura fatto trasferire a New York con tutta la famiglia come segno di riconoscenza per la sua fedeltà, lo coprì in tutti i modi possibili.
Benché responsabile di crimini di guerra e autore anche di scritti politici nazisti e manuali su come terrorizzare gli ebrei, l’ex braccio destro di Eichmann non fu mai chiamato in causa nel processo e visse da uomo libero per altri 20 anni. Fino a quando la magistratura scoprì le sue malefatte e lo processò. Nel 1981 von Bolschwing dovette rinunciare alla cittadinanza Usa, ma non scontò grandi pene, dato che morì pochi mesi dopo.
Il suo non è stato un caso isolato: per decenni si è parlato di criminali nazisti usati dagli Stati Uniti come spie contro i russi. Nel 1980 l’Fbi arrivò a rifiutarsi di fornire al ministero della Giustizia informazioni su 16 nazisti che vivevano negli Usa: tutti informatori della polizia federale. Quindici anni dopo un avvocato che lavorava per la Cia fece pressioni sui procuratori federali perché smettessero di perseguire un nazista implicato nel massacro di decine di migliaia di ebrei.
Ma è solo ora, con la desecretazione di molti documenti ormai vecchi di più di 50 anni, che il New York Times è riuscito a ricostruire quasi per intero il ricorso dell’intelligence a un esercito di personaggi che avevano combattuto per il Terzo Reich. Una contabilità impressionante: nel Dopoguerra l’America reclutò quasi mille nazisti, utilizzandoli nella battaglia contro il comunismo e contro l’Urss. Un confronto che allora l’America temeva di perdere.
Per questo due arcigni combattenti - il capo dell’Fbi Edgar Hoover e quello della Cia, Allen Dulles - decisero di accantonare ogni remora morale: era più importante disporre di agenti capaci e determinati da usare contro Mosca che punire questi nazisti per i crimini contro gli ebrei commessi qualche decennio prima.
Un’altra storia imbarazzante per l’intelligence Usa, anche se stavolta si tratta di vicende ormai remote: nessuno dei criminali nazisti protetti dai servizi segreti di Washington è ancora in vita. Una brutta pagina della storia americana le cui ragioni vanno ricercate nell’angoscia e nella paranoia degli anni della Guerra fredda. Hoover in persona approvò il reclutamento di informatori con un passato nelle SS sostenendo che la meticolosità e l’anticomunismo viscerale di questi «nazisti moderati» erano armi preziose per disporre della quali l’America poteva fare qualche sacrificio sul piano etico.
Un ragionamento cinico che, a parte ogni considerazione giuridica e morale, risultò poco fondato anche sul piano pratico: ben pochi dei mille nazisti reclutati si rivelarono agenti efficaci e fedeli. I documenti ora pubblicati rivelano che molti di loro erano degli inetti, inguaribili bugiardi o, peggio, agenti doppi al servizio anche del Cremlino.
L’imbarazzo della Cia è tutto nell’ostinato rifiuto di commentare il caso: difficile giustificare il tentativo di sottrarre ai tribunali i responsabili di crimini orrendi. Il New York Times racconta che nel 1994, quando il ministero della Giustizia si preparava a processare Aleksandras Lileikis, un capo della Gestapo responsabile del massacro di 60 mila ebrei lituani, la Cia cercò di difendere la sua ormai ex spia reclutata nel 1952 con uno stipendio di 1.700 dollari l’anno più due cartoni di sigarette al mese. I giudici tennero duro e alla fine si giunse ad un compromesso: la magistratura avrebbe rinunciato a condannare Lileikis solo se nel processo fossero venute fuori questioni tali da mettere in pericolo la sicurezza nazionale Usa. Non successe e il criminale nazista finì in galera.
-
>Germania. Manifestazione contro l’antisemitismo. Merkel a Berlino: «Gli ebrei sono parte dell’identità tedesca» (di Paolo Lepri)15 settembre 2014, di Federico La Sala
Merkel a Berlino: «Gli ebrei sono parte dell’identità tedesca»
Manifestazione contro l’antisemitismo
di Paolo Lepri (Corriere della Sera, 15.09.2014)
BERLINO - In Germania non c’è spazio per l’antisemitismo, «una minaccia per la libertà di tutti». È stato un «no» molto netto, che ha radici profonde nella memoria del passato e si proietta in un futuro da vivere nel segno della tolleranza, quello che Angela Merkel ha pronunciato ieri.
«Mai più odio contro gli ebrei», era la parola d’ordine della grande manifestazione svoltasi alla Porta di Brandeburgo e sono rimasti pochi dubbi sulla volontà del governo di combattere con forza il risorgere di un fenomeno vecchio e nuovo, alimentato in questi ultimi mesi dalle proteste anti-israeliane organizzate da settori della comunità islamica. «L’ebraismo è parte della nostra identità», ha detto la cancelliera. Quindi, «chiunque colpisce chi indossa una kippah colpisce tutti noi, chi distrugge una tomba distrugge la nostra cultura, chi attacca una sinagoga attacca le basi della nostra società libera». Stroncare tutto questo «è un dovere civico, un obbligo dello Stato».
Il discorso della cancelleria, più volte interrotto da applausi, è iniziato proprio con un omaggio agli ebrei che vivono in Germania (è l’unica comunità aumentata di dimensioni in un Paese europeo) e che hanno fatto una scelta impensabile qualche decennio fa. «Sono oltre centomila: si tratta di un miracolo - ha detto - e di un regalo che ci riempie di gratitudine». Proprio per questo è «uno scandalo» che oggi non si sentano più sicuri. È «inaccettabile», ha proseguito, che gli ebrei vengano minacciati e aggrediti e che le manifestazioni filo-palestinesi si trasformino in esibizioni di odio, abusando del diritto alla libera espressione che è una caratteristica di una società aperta. La Germania, invece, è «la loro casa». Lo è diventata, è stato il ragionamento di Angela Merkel, «perché abbiamo sempre tramandato da generazione a generazione la memoria e la conoscenza di quel capitolo terribile della nostra storia che è stato l’Olocausto».
L’allarme della comunità israelitica in Germania ha trovato così risposta. Ieri se ne è fatto nuovamente interprete il presidente del consiglio centrale degli ebrei tedeschi, Dieter Graumann, che ha denunciato il clima di intimidazione sempre più minaccioso e il fatto che «slogan antisemiti così violenti non risuonavano nelle strade delle nostre città da molti decenni». Le sue parole erano state precedute da quelle del rabbino Daniel Alter che aveva denunciato lo stato di «forte angoscia» di un numero sempre crescente di persone, molte delle quali «stanno pensando di tornare in Israele», e aveva ricordato un sondaggio secondo cui il venticinque per cento dei tedeschi avrebbe sentimenti antisemiti latenti. Una cifra, questa, che raddoppia nella comunità islamica.
Nel giugno e luglio di quest’anno gli atti di antisemitismo sono stati 159, tra cui l’incendio di una sinagoga a Wuppertal e l’aggressione a un uomo che indossava una kippah a Berlino. Slogan violenti sono stati gridati in decine di manifestazioni e la scritta «Hamas, ebrei al gas» è stata tracciata a pochi metri della sinagoga berlinese di Orianeburger Strasse.
È probabile che il governo tedesco, impegnato nel sostenere campagne per promuovere la convivenza, prenda nuove iniziative nella prevenzione dell’estremismo anti-ebraico. In ogni caso, come ha riconosciuto Graumann, da Berlino è arrivato «un segnale importante». E una dimostrazione di unità, si potrebbe aggiungere, perché alla manifestazione (alla quale hanno partecipato il presidente Joachim Gauck e i ministri più importanti della grande coalizione) hanno aderito tutti i partiti, anche la Linke e i Verdi, le due forze di opposizione rappresentate in Parlamento.
Non è un caso che, parlando con il Corriere , il leader storico degli ambientalisti, l’ex ministro degli Esteri Joschka Fischer, abbia elogiato il discorso della cancelliera perché «combattere l’antisemitismo è un dovere, soprattutto per noi». «Anche se il pericolo è forse maggiore in Europa che non in Germania», ha aggiunto. Intanto, però, i tedeschi hanno dato l’esempio.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO --- Eichmann prima di Gerusalemme. La vita non verificata di un assassino di massa. La filosofa tedesca Bettina Stangneth ribalta la tesi di Hannah Arendt4 settembre 2014, di Federico La Sala
Eichmann era un cinico nazista, non «la banalità del Male»
La filosofa tedesca Bettina Stangneth nel suo libro ribalta la tesi di Hannah Arendt che definiva l’SS un burocrate
di Mario Avagliano (Il Messaggero, 04.09.2014)
RIVELAZIONI
Adolf Eichmann, ovvero il Male non banale. A 51 anni dalla pubblicazione del libro di Hannah Arendt Eichmann in Jerusalem, proposto in Italia da Feltrinelli con il titolo La banalità del male, una nuova ricerca demolisce le tesi della studiosa tedesca naturalizzata americana, che nel 1961 seguì per la rivista New Yorker le 121 udienze del processo in Israele a uno dei principali responsabili della macchina della soluzione finale, condannato a morte e impiccato l’anno dopo. E capovolge la rappresentazione del criminale di guerra nazista fatta dalla Arendt come «un esangue burocrate» che si limitava ad eseguire gli ordini e ad obbedire alle leggi.
A firmare il saggio, uscito questa settimana negli Stati Uniti per i tipi di Alfred A. Knopf e già recensito con grande rilievo dal New York Times, è una filosofa tedesca che vive ad Amburgo, Bettina Stangneth, che ha lavorato attorno alla figura di Eichmann per oltre un decennio, scavando a fondo sulla sua storia. Ne è venuto fuori un libro provocatoriamente intitolato Eichmann prima di Gerusalemme. La vita non verificata di un assassino di massa, già pubblicato con scalpore in Germania.
Se ascoltando Eichmann a Gerusalemme, la Arendt rimase impressionata dalla sua «incapacità di pensare», invece analizzando l’Eichmann capo della sezione ebraica della Gestapo, e poi in clandestinità in Sudamerica, la Stangneth vede all’opera un abile manipolatore della verità, tutt’altro che un “funzionario d’ordine” o «un piccolo ingranaggio dell’enorme macchina di annientamento di Hitler», come si autodefinì nel corso del suo processo. Adolf fu un carrierista rampante e ambizioso e un nazista fanatico e cinico, che agì con incondizionato impegno per difendere la purezza del sangue tedesco dalla “contaminazione ebraica”.
In passato già vari ricercatori avevano seriamente messo in discussione le conclusioni della Arendt. Ma con questo libro la Stangneth le "frantuma" definitivamente, come ha dichiarato Deborah E. Lipstadt, storica alla Emory University e autrice di un libro sul processo Eichmann. La Stangneth sostiene che la Arendt, morta nel 1975, fu ingannata dalla performance quasi teatrale di Eichmann al processo. E aggiunge che forse «per capire uno come Eichmann, è necessario sedersi e pensare con lui. E questo è il lavoro di un filosofo».
LA RICERCA
La filosofa tedesca ha però lavorato come uno storico, rovistando in ben 30 archivi internazionali e consultando migliaia di documenti, come le oltre 1.300 pagine di memorie manoscritte, note e trascrizioni di interviste segrete rilasciate da Eichmann nel 1957 a Willem Sassen, un giornalista olandese ex nazista residente a Buenos Aires.
Un libro che rivela tanti dettagli inediti, come la lettera aperta scritta nel 1956 da Eichmann al cancelliere tedesco occidentale, Konrad Adenauer, per proporre di tornare in patria per essere processato e informare i giovani su ciò che era realmente accaduto sotto Hitler (conservata negli archivi di stato tedeschi), oppure la riluttanza dei funzionari dell’intelligence della Germania Ovest che sapevano dove si trovava Eichmann già nel 1952 - ad assicurare lui e altri ex gerarchi nazisti alla giustizia.
Ma il cuore del libro è il ritratto di Eichmann “esule” in Argentina, dove venne scovato e arrestato dagli agenti segreti del Mossad. All’apparenza era diventato un placido allevatore di conigli, con il nome di Ricardo Klement. In realtà l’ex gerarca nazista aveva conservato l’arroganza di un tempo e non era niente affatto pentito, tanto da spiegare la sua “attività” con una tirata che a leggerla lascia inorriditi. «Se 10,3 milioni di questi nemici fossero stati uccisi disse degli ebrei allora avremmo adempiuto il nostro dovere».
Altrettanto interessante è la descrizione del cerchio magico di ex nazisti e simpatizzanti nazisti che lo circondava in Sudamerica. Personaggi che formavano una sorta di perverso club del libro, che s’incontrava quasi ogni settimana a casa di Willem Sassen per lavorare nell’ombra contro la narrazione pubblica emergente della Shoah, discutendo animatamente su ogni libro o articolo che usciva sull’argomento. Con l’obiettivo di fornire materiale per un libro che avrebbe raffigurato l’Olocausto come una esagerazione ebraica, «la menzogna dei sei milioni» di morti.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO -- ISRAELE E "LA TERRA PROMESSA". Il lato inquietante di una storia.30 luglio 2014, di Federico La Sala
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO --- Se Israele vuole l’eredità di quell’ebraismo ridotto in cenere, deve assumerne la piena eredità morale (di Moni Ovadia)30 luglio 2014, di Federico La Sala
Se Israele vuole l’eredità di quell’ebraismo ridotto in cenere, deve assumerne la piena eredità morale
di Moni Ovadia (Peace Reporter, 08.09.2006) *
Yad Vashem è il museo dell’Olocausto di Gerusalemme, il sacrario della Shoà, ma per gli israeliani è ben altro che questo. Quel luogo è per molti aspetti, il topos del senso stesso dell’esistenza di Israele come stato ebraico.
Ogni cittadino, ogni fanciullo, ogni soldato, si reca in pellegrinaggio in quel luogo per assumere il pieno statuto identitario di ebreo israeliano. Ogni persona, dal semplice turista o viaggiatore, al più illustre politico in visita in Israele, quale che sia la ragione della sua presenza, sa che ha il dovere di rendere omaggio alle vittime dello sterminio nazista recandosi a Yad Vashem. Con quel solenne pellegrinaggio, il visitatore riconosce il suggello con cui lo stato d’Israele assume su di sé un’intera eredità. Per un grandissimo numero di ebrei che si riconoscono nelle istituzioni ufficiali, Israele diviene acriticamente e senza mediazioni, passato, presente e futuro. Per essi la diaspora perde significato in sé per divenire appendice di un ritorno in pectore anche se procrastinato sine die. Di fatto, essi si sentono israeliani in standby.
Le recenti drammatiche vicende mediorientali, richiedono una rimessa in questione di questi assetti israelo-ebraici e delle dinamiche psicologico-culturali che vi sottostanno. Il movimento sionista ha avuto fra i suoi obbiettivi primari quello di normalizzare gli ebrei, collocandoli in una terra con la quale avevano un’antico legame e facendone un popolo come gli altri. Quando il primo ebreo fu arrestato per furto e messo in prigione nella neonata entità statuale ebraica, il padre fondatore e primo capo del governo, David Ben Gurion, esultò: ”Siamo un paese normale!”.
Mai affermazione fu più rovinosamente scentrata. Israele è tutto fuorché un paese “normale”. La sua collocazione geografica è in Medio Oriente ma in questo momento la sua vocazione è occidentale. Per certi aspetti potrebbe essere uno stato degli Stati Uniti, anche se più di metà della sua popolazione viene da stati arabi e il 17% di essa è arabo-palestinese. La sua politica, in grande misura coincide con quella delle amministrazioni americane.
E’ stato fondato da scampati alle persecuzioni antisemite zariste e degli stati autoritari centro-orientali e da sopravvissuti alla Shoà, ha piena dunque titolarità a quella eredità, ma gli ebrei sterminati dai nazisti erano quanto c’è di più lontano da quello che è oggi l’ebreo israeliano. Quelli parlavano lo yiddish ed erano a proprio agio in molte altre lingue, vivevano a cavallo dei confini, erano cosmopoliti, ubiqui, inquieti, refrattari alle logiche militari, poco interessati, quando non ostili ai nazionalismi, erano smunti, fragili, dediti allo studio, alle professioni liberali, intellettuali, al piccolo o grande commercio, appartenevano alla categoria dei paria perseguitati emarginati, erano dalla parte degli sconfitti.
L’israeliano delle nuove generazioni si esprime in ebraico moderno, una lingua costruita desantificando l’ebraico biblico e piegandolo alle esigenze di una nazione e la sua seconda lingua è l’inglese. L’israeliano sta con i vincitori, è forte, determinato, orgogliosamente nazionale, militarmente molto preparato, capace di essere agricoltore e soldato quanto intellettuale e tecnico, ma anche taxista, ingegnere, negoziante o impiegato, operaio e persino occupante e poliziotto di un altro popolo, cosa inconcepibile per un ebreo della diaspora che subì lo sterminio.
Oggi, che nuovamente un leader fanatico di un paese islamico chiede la cancellazione dello stato sionista dalla carta geografica, in Israele e nella diaspora, si evoca il legame con la Shoà in modo univoco e schematico quasi a volere stabilire un parallelo inaccettabile con il ghetto di Varsavia.
Ma ancorché Israele viva in stato di grande difficoltà e subisca il terrorismo e l’aggressione di Hezbollah sulla carne della propria gente, pensare di rappresentare la tragica eredità dello sterminio solo con un modello rigido per giustificare l’uso indiscriminato della propria soverchia forza militare e radere al suolo intere città provocando quasi esclusivamente morti civili, è scambiare etica per propaganda.
Se Israele vuole assumere l’eredità di quell’ebraismo ridotto in cenere, deve assumerne la piena eredità morale, cessare di vessare ed imprigionare un altro popolo, diventare più piccolo, molto più democratico, abbandonare la mistica della potenza, diventare leader del processo di pace ed assumere la funzione di ponte fra occidente e medio oriente.
* Segnalato da don Aldo Antonelli
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- Nessuno vuole davvero fermare Israele (di Alessandro Dal Lago)26 luglio 2014, di Federico La Sala
Nessuno vuole davvero fermare Israele
di ALESSANDRO DAL LAGO (il manifesto, 25 Luglio 2014)
La striscia di Gaza è martirizzata da tredici anni, dall’inizio della seconda Intifada. Periodicamente Israele, in risposta ai lanci di razzi, al rapimento di un soldato o all’uccisione di giovani coloni, scatena offensive (dai nomi fantasiosi o truci, come “arcobaleno” o “piombo fuso” ecc.) dal cielo, dal mare e a terra.
Dall’inizio del millennio, sono morti circa 6.400 palestinesi e poco più di 1000 israeliani, senza dimenticare le centinaia di palestinesi vittime della guerra civile tra Hamas e Anp. Ogni volta, gli strateghi israeliani giurano che il conflitto in corso sarà l’ultimo, ma chiunque nel mondo sa che si tratta di una favola. Anche se la striscia di Gaza - una fascia costiera abitata da una popolazione pari a quella della Liguria, ma con una superficie quindici volte più piccola - fosse completamente ridotta in macerie, qualche razzo potrebbe essere ancora sparato e quindi il conflitto riprenderebbe...
Per comprendere il senso di una guerra apparentemente infinita, basta confrontare le carte della Palestina nel 1946 e oggi. Se allora gli insediamenti dei coloni ebrei erano una manciata, soprattutto nel nord, oggi è esattamente il contrario: una spruzzata di insediamenti palestinesi circondati da Israele e dai suoi coloni, con la striscia di Gaza isolata a sud-ovest. Non ci vuole molta fantasia per comprendere che la strategia di Israele, in nome di una sicurezza assoluta di cui non potrà mai godere, è quella di cacciare più palestinesi possibile, con le infiltrazioni dei coloni in Cisgiordania e con le azioni militari a Gaza.
Rapporti pubblicati da Human Rights Watch, agenzie Onu e Amnesty International mostrano ormai, senza possibilità di dubbio, che lo sradicamento dei palestinesi è perseguito con l’espulsione dalla terre coltivabili, l’interruzione periodica dell’energia elettrica e il blocco delle risorse idriche. D’altronde che l’esercito considerato il più “professionale” al mondo rada al suolo scuole gestite dall’Onu e uccida soprattutto civili la dice lunga sulla vera strategia di Israele verso i palestinesi.
Mai come oggi, i palestinesi di Gaza sono stati così soli. Hamas non gode della protezione dell’Egitto, come ai tempi di Morsi, né della simpatia dei sauditi e di quasi tutti gli stati arabi. Né riceve vera solidarietà da parte di Abu Mazen. E, ovviamente, in quanto organizzazione ufficialmente definita “terrorista”, è avversata da Stati Uniti ed Europa. Ma tutto questo non spiega, né tanto meno giustifica, il silenzio ipocrita dei governi occidentali e tanto meno della cosiddetta opinione pubblica indipendente sulle stragi di Gaza.
Lasciamo stare il nostro Presidente del consiglio e l’ineffabile ministro Mogherini, la cui ascesa spiega perfettamente il ruolo trascurabile della politica estera nella cultura governativa italiana. Ma che dire dell’incredibile squilibrio politico e morale nella valutazione ufficiale del conflitto?
Basti pensare che un B.-H. Lévy, l’eroe della fasulla rivoluzione libica e il mestatore di Siria, da noi passa come un profeta della pace e della giustizia. Che centinaia o migliaia di imbecilli, in Europa o altrove, trasformino il conflitto tra palestinesi e stato d’Israele in una crociata antisemita non può essere usato come un alibi per chiudere gli occhi davanti alle stragi di bambini e di civili. In questo quadro, la palma dell’ipocrisia va al governo americano, e in particolare a Obama, che pure aveva illuso il mondo all’inizio del suo primo mandato.
La banale verità è che la differenza tra democratici e repubblicani in materia di Palestina è semplicemente di stile. Brutalmente filo-israeliani quelli della banda Bush, preoccupati un po’ più delle forme della repressione gli obamiani, come dimostrano i famosi fuori-onda di Kerry.
Ma nessuno ha veramente intenzione di fermare Israele, oggi o mai. La solitudine dei palestinesi è la vergogna del mondo, dell’occidente come dei padroni del petrolio. Per non parlare di un’Europa inetta e imbelle.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- Palestina, il partito del grande silenzio (di Angelo d’Orsi)24 luglio 2014, di Federico La Sala
Palestina, il partito del grande silenzio
di ANGELO D’ORSI (il manifesto, 23 luglio 2013)
Ho trascorso la settimana in Spagna, a Malaga, a una Scuola estiva della Cattedra Unesco di quella Università. Il tema della sezione a cui ho partecipato come relatore era “L’impegno degli intellettuali”. Seguivo, naturalmente, la notizie sempre più angosciose provenienti dalla terra martire di Palestina, constatando l’assoluta “distrazione” del ceto politico, rispetto a quei fatti di sconvolgente gravità, e il totale disinteresse, salvo pochissime eccezioni, del “mondo della cultura”.
Ricordo altre stagioni, come l’invasione del Libano e la guerra contro Hezbollah, del luglio 2006, o il bombardamento di Gaza del dicembre 2008-gennaio 2009: stagioni in cui fiorirono appelli, e la mobilitazione di professori, giornalisti, letterati, scienziati,artisti fu vivace e intensa. Si denunciavano le responsabilità di Israele, la sua proterva volontà di schiacciare i palestinesi, invece di riconoscer loro il diritto non solo a una patria, ma alla vita. Oggi, silenzio. La macchina schiacciasassi di Matteo Renzi , nel suo micidiale combinato disposto con Giorgio Napolitano, si sta rivelando un efficacissimo apparato egemonico.
L’intellettualità “democratica”, facente capo per il 90% al Pd, appare allineata e coperta. I grandi giornali, a cominciare dal “quotidiano progressista” di De Benedetti, sempre in prima linea a sostenere le nuove guerre, dal Golfo alla Jugoslavia, appaiono organismi perfettamente oliati di sostegno al governo da un canto, e di adeguamento alla politica estera decisa da un pugno di signori e signore tra Washington, Londra, Bruxelles e Berlino (Parigi, caro Hollande, ne prenda atto, non conta un fico). Della radiotelevisione non vale neppure la pena parlare; come per l’Ucraina, ora, nella ennesima micidiale aggressione israeliana a Gaza, si sono raggiunti vertici non di disinformazione, ma di semplice rovesciamento della verità. La categoria del “rovescismo”, che mi vanto di aver creato, per la storiografia iper-revisionista, va ormai estesa ai media.
E devo constatare che mai in passato si erano raggiunti simili livelli: dove sono le zone franche? Fa impressione sfogliare la balbettante Unità, che un tempo non lontano, con tutti i suoi limiti, accanto a Liberazione (defunta) e al manifesto (che resiste!), era una delle poche voci critiche nel deprimente panorama all’insegna del più esangue conformismo.
Sulle pagine del manifesto (15 luglio) Manlio Dinucci ha spiegato bene le ragioni reali del “conflitto” in corso, e non ci tornerò. Qui mi preme piuttosto evidenziare, con sgomento, che il “silenzio degli intellettuali” che qualche anno fa Alberto Asor Rosa denunciava, deplorandolo fortemente, è divenuto non soltanto una condizione di fatto, ma una posizione “teorica” che, accanto a quella dell’equidistanza, sta trovando i suoi alfieri. Appunto, rientrando dalla mia settimana spagnola, di intense discussioni sulla necessità di impegnarsi, a cominciare dal mondo universitario, cado dalle nuvole leggendo lacerti di pensiero che configurano la nascita di una sorta di “Partito del silenzio”.
Il silenzio non viene soltanto praticato, sia «perché dovrei espormi?», sia perché la pressione della lobby sionista è fortissima e induce a tacere se proprio non vuoi esprimere la tua gioiosa adesione alla “necessità” degli israeliani “di difendersi”. Il silenzio, oggi, a quanto pare, è divenuto una divisa, una bandiera, e una ideologia.
Quei pochi che parlano, che osano aprire bocca, premettono il riconoscimento delle ragioni di Israele e condannano in primo luogo rapimento e uccisione dei tre ragazzi ebrei, poi uccisi (si tralascia di dire che si tratta di tre giovani coloni, ossia occupanti, con la violenza dell’esercito, terra palestinese), e il lancio di razzi Kassam contro le città del Sud di Israele, e cercano poi di cavarsela con un colpo al cerchio e una alla botte. Ma attenzione, se il colpo alla botte israeliana appare troppo sonoro, ecco che si scatena l’inferno, non di fuoco come su Gaza, ma di parole.
Molto praticato il genere “commenti” agli articoli on line, per esempio: sono tutti uguali, anche se variamente dosati nel tasso di violenza verbale. Mentre un gran lavorio di informazione al contrario, di diretta provenienza da fonti israeliane, viene dispiegato dagli innumerevoli piccoli dispensatori di verità nostrani. Per esempio un pur prudente articolo di Claudio Magris sul Corriere della Sera (17 luglio) che si permetteva di accennare alle ragioni dei palestinesi, ha ricevuto la sua buona dose di ingiurie. Non c’è che dire, il sistema funziona. E finisce per indurre al silenzio, o quanto meno alla prudenza. Che è l’altro nome del silenzio.
Ma non è questo silenzio, il silenzio del ricatto, che mi preoccupa di più. È, invece, il silenzio della scelta. Il silenzio teorizzato come terza via, tra coloro che incondizionatamente sono con Israele, e gli altri, quelli che sostengono la causa palestinese. Il silenzio come rispetto del dolore, o come via della ragionevolezza: contro gli opposti estremismi. Esemplare in tal senso Roberto Saviano, che, quasi commettendo autogol, cita Euromaidan per denunciare il tardivo schierarsi anche italiano dalla parte giusta, che per lui, ovviamente, è quella dei golpisti nazisti diKiev. E ora, a suo dire, occorre schierarsi non con gli uni né con gli altri, ma «dalla parte della pace»: i “terroristi” di Hamas sono indicati come il primo nemico della pace, ovviamente.
È la linea (solita) di Adriano Sofri (la Repubblica, 17 luglio), altro guerriero democratico, che ripartisce torti e ragioni, equiparando i razzi di Hamas alle bombe israeliane, e invoca implicitamente silenzio, discrezione, rispetto: mette sullo stesso piano tutti. Tutte le vittime innocenti. Ma si può confondere la pietà umana, doverosa, col giudizio politico? Si può trasformare l’opinione in saggezza?
Sul medesimo giornale, Michele Serra sostiene che occorre tacere, che si devono abbassare la voce e gli occhi, davanti alla “tragedia” della guerra, lo stesso termine usato da Magris. Ma quale tragedia? Qui abbiamo la politica, e la politica ha degli attori, dei responsabili: come in passato la divisione tra vittime e carnefici è netta ed evidente (so che qualche anima bella mi accuserà di semplificare: la cosa è più complessa, non si può dividere così nettamente, ciascuna delle due parti ha un pezzo di responsabilità e via di seguito). Serra scrive: «Evidentemente il ‘ciclo dell’indignazione’ è un meccanismo logoro».
Dal ceto intellettuale mi aspetto assai più che l’indignazione, mi aspetto una rivolta morale: tutti, se non in perfetta malafede, oggi sanno quanta verità ci sono nelle parole di Primo Levi: «Quello che non potrò mai perdonare ai nazisti è di averci fatto diventare come loro».
Quanto bisogno avremo di sentire la sua voce risuonare, pacata e ferma, scandendo le parole, a voce bassa, ma chiarissima: «La tragedia è di vedere oggi le vittime diventate carnefici». E se questo era evidente a lui negli anni Ottanta del Novecento, cosa potrebbe mai dire oggi, davanti a quei corpi straziati di bimbi, alla vita cancellata in tutta la Striscia di Gaza, davanti a quelle macerie che occupano, quartiere dopo quartiere, isolato dopo isolato, di ora in ora, lo spazio affollato di case e persone?
Se non denunciamo le menzogne dei media, le complicità dei governi occidentali, con quello di Tel Aviv, in particolare l’oscena serie di accordi (militari, innanzi tutto) dell’Italia con Israele... Se ci consegniamo al silenzio, oggi, davanti a una ingiustizia così grave,così palese, così drammatica, quando parleremo? Insomma, non intendo tacere, e ricorrendo proprio alle parole di quel grande uomo, gridare: «Se non ora, quando?».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO... FARE CHIAREZZA --- L’unica, la sola, la sempiterna vittima (di Moni Ovadia)21 luglio 2014, di Federico La Sala
L’unica, la sola, la sempiterna vittima
di Moni Ovadia (Pagina Ufficiale) *
L’Unità _ Voce d’Autore del 19 luglio 2014
I cittadini dello Stato d’Israele in questi giorni sono vittime di una pioggia di missili che provengono dalla striscia di Gaza e vivono l’angoscia degli allarmi che li costringono a correre nei rifugi antiaerei per evitare di essere colpiti. Fortunatamente, l’efficacia dei missili lanciati dall’ala militare di Hamas o di altri gruppi jihadisti o islamisti è molto limitata. Cionondimeno vivere sotto la minaccia di quelle armi ancorché poco efficienti non cancella la condizione di vittima e men che meno il sentimento di essere tale.
I sostenitori delle ragioni di Israele sempre e comunque, senza se e senza ma, oggi come ieri, proclamano tuttavia che Israele sia vittima in ogni circostanza e qualsiasi cosa faccia, qualunque sia la politica praticata dal suo governo. Non vedono altro, non vogliono che la loro fede sia neppure sottoposta al vaglio di disamine critiche.
Per esempio, Gaza dopo l’evacuazione dei coloni ad opera di Ariel Sharon è stata ridotta ad una gabbia sigillata, il suo territorio, le sue acque territoriali, i suoi confini, il suo spazio aereo sono sotto il controllo dell’esercito israeliano, le risorse idriche, l’energia elettrica è sotto il controllo delle autorità israeliane, i movimenti dei cittadini, persino la loro identità sono sottoposte al controllo di Israele, il flusso delle merci e di quali merci lo decidono sempre gli organi di controllo dello stato di Israele, la popolazione palestinese gazawi vive in una condizione infernale, sottoposta allo stillicidio di un assedio permanente, il numero delle sue vittime civili e innocenti dei ripetuti conflitti con l’assediante è pauroso...chi è la vittima? Israele.
Il popolo palestinese vive da quasi cinquant’anni sotto occupazione, le sue terre legittime secondo il diritto internazionale vengono espropriate, colonizzate, le sue topografie esistenziali vengono stravolte a favore dell’occupante, le sue case demolite o alienate, i diritti di proprietà negati per mezzo di leggi speciali, le colonie si espandono in continuazione, i suoi confini sono unilateralmente ridisegnati dall’occupante che non avendo una legge costituzionale non ha né dichiarato né definito i suoi confini.
La popolazione palestinese subisce continue vessazioni come centinaia di migliaia di detenzioni amministrative senza processo ad opera dell’occupante che è potentissimo, la quarta potenza militare al mondo...
Chi è la vittima? Gli israeliani. Ora, sarebbe un errore considerare ironicamente questo sentire vittimistico di un vastissimo numero ebrei in Israele e nella diaspora. Esso è alimentato dal formidabile propellente della immane tragedia della shoà.
Lo sterminio degli ebrei è mille volte rivissuto, rimetabolizzato senza fine, usato strumentalmente da politici cinici ed accolto dalla vile comunità internazionale occidentale come lavacro di un ignobile complesso di colpa espiato con impudicizia colonialista sulle spalle dei palestinesi a cui viene negata dignità e identità.
Per questa ragione i governanti dell’occidente non chiamano quelli israeliani al rispetto della legalità internazionale. Ma, sia chiaro, se il drammatico e micidiale circuito della vittimizzazione psicopatologica e insieme strumentale non viene superato con un grande progetto politico culturale promosso dalle istituzioni internazionali, non ci sarà mai pace.
*
https://www.facebook.com/MoniOvadiaPaginaUfficiale/posts/675809779174274?fref=nf
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- UNA VITTORIA POSTUMA. Israele e l’orrore dei ragazzi assassini (di Gad Lerner)8 luglio 2014, di Federico La Sala
Israele e l’orrore dei ragazzi assassini
A ISRAELE, per fortuna, non basta consolarsi additando la barbarie praticata dal nemico per trovare giustificazione alla barbarie perpetrata dai suoi figli. La ricerca di alibi morali, o magari di attenuanti, cede il posto a un profondo turbamento interiore.
di Gad Lerner (la Repubblica, 08.07.2014)
OGGI Israele deve guardarli in faccia, questi suoi figli che per vendetta hanno afferrato un coetaneo palestinese di 16 anni, Mohammad Abu Khdeir, e lo hanno bruciato vivo in un bosco di Gerusalemme. Li guarda in faccia e li riconosce perché gli sono ben noti, familiari. Magari finora se ne vergognava un po’, ma liquidava la loro esuberanza come teppismo generazionale proletario.
Sono i ragazzi di stadio della curva scalmanata del Beitar, organizzati come ultràs in un raggruppamento dal nome sefardita, “La Familia”, scelto in contrapposizione linguistica all’élite tradizionalmente ashkenazita dello Stato. Anche il premier Netanyahu tifa per il Beitar, il che naturalmente non significa nulla, se non che il sabato sugli spalti udiva spesso lo slogan “morte agli arabi” rivolto contro i calciatori arabo-israeliani; così come udiva le irrisioni blasfemedella fede musulmana.
Di fronte al baratro della perdizione e del disonore, Netanyahu agisce da politico responsabile di uno Stato di diritto. Parla di «atto ripugnante», telefona le sue condoglianze al padre di Mohammad, assicura che «nella società israeliana non c’è spazio per gli assassini, ebrei o arabi». Lo avevano preceduto, con parole nobilissime, i genitori in lutto per la morte di Eyal, Gilad e Naftali. Loro certamente si sono immedesimati nella sofferenza di una famiglia che non possono sentire nemica. Ma per poter sperare che l’orrore degli adolescenti ammazzati a casaccio rimanga un episodio circoscritto, sarà inevitabile un’autocoscienza collettiva delle società che tanto odio hanno generato. E qui viene il difficile.
Estrema e degenere, ma è la filiazione di una storia importante la vendetta che si è consumata all’alba di mercoledì 2 luglio in un bosco di Gerusalemme. Ha rilevato i codici di un fascismo-razzismo che pensavamo rinchiuso negli stadi di calcio, proprio come, vent’anni fa, le belve della guerra etnica dell’ex Jugoslavia si forgiarono nelle tifoserie organizzate.
Naturalmente il fascismo-razzismo in Israele ha altri luoghi d’aggregazione. La componente ultràs ne rappresenta solo un orpello simbolico, tipico del linguaggio giovanile universale. Non a caso, però, il suo retroterra culturale porta lo stesso nome della squadra di calcio giallo-nera di Gerusalemme. Beitar è il movimento del cosiddetto “sionismo revisionista” fondato nel 1923 da Zeev Jabotinsky, in contrapposizione al sionismo ufficiale accusato di sinistrismo filo-socialista e di eccessiva moderazione. Dal Beitar nascerà il Likud, cioè l’attuale destra israeliana, oggi affiancata (e insidiata) da nuovi movimenti messianici e etnicisti.
In forma laica o religiosa, l’ideologia postulata da costoro snatura il significato biblico di terra promessa. Per la precisione, idolatrano la terra e ne rivendicano la proprietà. L’esatto contrario di quanto è scritto nel Levitico 25-23: “...Mia è la terra, perché voi siete forestieri e residenti provvisori presso di Me”. Un Dio che si è fatto annunciare da patriarchi ebrei senza fissa dimora, eternamente stranieri anche nella terra promessa, viene strumentalizzato come fonte del diritto in base a cui negare legittimità alla residenza dei palestinesi.
Questo naturalmente non basta a spiegare la predicazione dell’odio trasformatasi in azione violenta già prima che il delitto di Hebron sollecitasse pulsioni di vendetta. L’organizzazione “Price Tag” votata a seminare il terrore fra i palestinesi con centinaia di agguati ai civili e alle loro proprietà è attiva da qualche anno, senza che le forze di sicurezza israeliane agissero efficacemente per smantellarla. A legittimarla non è stato solo il fanatismo religioso, ma anche l’affermarsi di una diversa forma di razzismo: l’islamofobia. L’idea, cioè, che gli arabi, ormai quasi tutti musulmani, per loro stessa natura siano inaffidabili e irriducibili. Solo la forza può tenerli a bada, non intendono altro linguaggio. Poco importa chiedersi le ragioni del loro agire, tanto meno intenerirsi per la loro sofferenza. Bisogna solo combatterli. Allontanarli a meno che accettino di sottomettersi.
Va rilevato come questi argomenti riavvicinino la componente ebraica che li propugna alle destre europee che nel frattempo, dopo la Shoah, hanno per lo più ripudiato il loro tradizionale antisemitismo. Anzi, di Israele ammirano proprio l’inflessibilità con cui esercita il suo diritto alla sicurezza e disconosce l’interlocutore palestinese.
“Beitar puro per sempre”, avevano scritto su uno striscione gli ultràs di “La Familia” l’anno scorso, quando la loro squadra voleva ingaggiare due calciatori musulmani. La ebbero vinta, in un paese in cui la stessa nozione di purezza razziale dovrebbe far correre tuttora brividi lungo la schiena. Si tratta di quel medesimo gusto per la violazione di un tabù che spinge molti politici della destra israeliana a accusare di nazismo gli avversari. Ma che ha suscitato enorme scalpore quando è stato lo scrittore Amos Oz a paragonare ai “neonazisti europei” gli estremisti che aggrediscono gli arabi o imbrattano di scritte odiose chiese e moschee.
C’è chi sostiene amaramente che la ricomparsa di Hitler nel dibattito pubblico, sia pure come estrema provocazione, rappresenti una sua vittoria postuma. Anche quando (succede spesso) sono gli oltranzisti ebrei a definire nazisti Hamas o gli Hezbollah. Temo invece che si tratti di qualcosa di più semplice e feroce al tempo stesso, nascosto chissà dove nella natura umana: l’odio inebriante che può sospingere un ragazzo a cospargere di benzina un suo coetaneo e dargli fuoco, pensando di trarre sollievo dall’annientamento di un corpo indifeso eletto a simbolo del nemico.
Il grande storico del fascismo e del pensiero reazionario Zeev Sternhell, vincitore del premio Israele, ha denunciato un cambiamento verificatosi addirittura nella “psicologia della nazione”. La stessa idea di pace si è deformata fino a concepirla possibile solo quando gli arabi accettino il proprio status di inferiorità. I ragazzi ebrei assassini dello stadio di Gerusalemme ne sono una terribile espressione.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- UNA VITTORIA POSTUMA. Vattimo: “Israele? Nazisti puri, forse peggio di Hitler” (di Gisella Ruccia)17 luglio 2014, di Federico La Sala
 Vattimo: “Israele? Nazisti puri, forse peggio di Hitler”.
Vattimo: “Israele? Nazisti puri, forse peggio di Hitler”.
 E volano insulti con Parenzo
E volano insulti con Parenzodi Gisella Ruccia (il Fatto quotidiano, 16.07.2014)*
“Israele vuole distruggere definitivamente i palestinesi, è una guerra di puro sterminio. Sono nazisti puri e forse un po’ peggio di Hitler perché hanno anche l’appoggio delle grandi democrazie occidentali“. Sono le parole pronunciate da Gianni Vattimo, ex parlamentare europeo, ai microfoni de “La Zanzara”, su Radio24.
“Andrei a Gaza” - afferma Vattimo - “a combattere a fianco di Hamas, direi che è il momento di fare le Brigate Internazionali come in Spagna, perché Israele è un regime fascista che sta distruggendo un popolo intero. In Spagna non era niente in confronto a questo. Questo è un genocidio in atto, nazista, razzista, colonialista, imperialista e ci vuole una resistenza“.
E aggiunge: “Ma siamo quattro gatti, perché tutta l’informazione, compresa la stampa italiana, piange sul fatto che c’è una pioggia di missili su Israele, però Hamas quanti morti ha fatto? Nessuno. I poveretti non hanno armi, sono dei miserabili tenuti in schiavitù, come tutta la Palestina. Hanno dei razzetti per bambini, e voglio promuovere una sottoscrizione mondiale per permettere ai palestinesi di comprare delle vere armi e non delle armi giocattolo. Cominciamo a distruggere il nucleare israeliano, Israele è lo stato canaglia che ha il nucleare“.
Alla domanda di Cruciani se sparerebbe conttro gli israeliani, l’ex europarlamentare risponde: “Io sono un non violento, però contro quelli che bombardano ospedali, cliniche private e bambini sparerei, ma non ne sono capace”.
E aggiunge: “Gli ebrei italiani dalla parte di Israele sono gli ex fascisti, che adesso sono dalla parte dell’America. La comunità ebraica italiana è rappresentata da quell’ossimoro che è Pacifici, ma ci sono molti ebrei d’accordo con me. Li c’è uno stato nazista che cerca di sopprimere un altro popolo. E io ce l’ho con lo stato di Israele, non con gli ebrei“
 di Gisella Ruccia
di Gisella Ruccia*
 http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/07/16/vattimo-israele-nazisti-puri-forse-peggio-di-hitler-e-volano-insulti-con-parenzo/288906/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/07/16/vattimo-israele-nazisti-puri-forse-peggio-di-hitler-e-volano-insulti-con-parenzo/288906/
-
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. Alcune note - di Federico La Sala13 maggio 2014, di Federico La Sala
Il processo Eichmann divise Israele e gli ebrei americani
Le critiche a Ben Gurion dagli Usa, la sua aspra replica
di Paolo Mieli (Corriere della Sera, 13.05.2014)
Lo sterminatore davanti ai giudici Esce oggi in libreria il saggio di Deborah E. Lipstadt Il processo Eichmann (traduzione di Maria Lorenza Chiesara, Einaudi, pagine 183, e 27). Tra i testi riguardanti la vicenda del criminale nazista: Isser Harel, La casa di via Garibaldi (Castelvecchi, 2012); Sergio Minerbi, La belva in gabbia (Lindau, 2012); Hannah Arendt, La banalità del male (Feltrinelli, 2001); Peter Malkin, Harry Stein, Nelle mie mani (Sperling & Kupfer, 1991).
Il pomeriggio del 23 maggio 1960, mentre alla Knesset era in corso un dibattito sul bilancio, David Ben Gurion chiese la parola e annunciò che era stato catturato Adolf Eichmann, definendolo «uno dei più grandi criminali di guerra nazisti». «È già in Israele in stato d’arresto», aggiunse, «e sarà tra breve processato». Pronunciate queste parole, il primo ministro lasciò l’aula, che restò attonita per qualche secondo e poi fu travolta da un’onda inimmaginabile di commozione. «Mai come quel giorno, dai tempi della Dichiarazione di indipendenza, gli israeliani avevano provato un senso di unità nazionale così profondo», ha scritto Tom Segev nel libro Il settimo milione (Mondadori). L’indomani, un quotidiano laico, «Maariv», titolò così: «Il Potente Iddio, a cui spetta la vendetta, è apparso».
È da questo istante che prende le mosse uno straordinario e coraggioso libro di Deborah E. Lipstadt, Il processo Eichmann , che esce oggi da Einaudi. La Lipstadt è una studiosa assai nota per essere stata sottoposta a sua volta, nel 2000, in Gran Bretagna, ad un procedimento giudiziario per un’azione legale intentata a lei e alla sua casa editrice, la Penguin, da David Irving. Quell’Irving che era stato a sua volta accusato dalla Lipstadt di aver dolosamente negato l’esistenza delle camere a gas e lo sterminio sistematico degli ebrei ai tempi di Hitler. Il dibattimento ebbe ampia risonanza e quando si concluse - con una sentenza di trecento pagine che assolveva la studiosa - il «Daily Telegraph» scrisse: «Questo processo è stato per il nuovo secolo quel che il processo di Norimberga o il processo Eichmann furono per le generazioni precedenti». Di qui l’autrice si è sentita in dovere di tornare sul caso Eichmann.
Il criminale nazista era già stato catturato dagli Alleati alla fine della guerra senza però che se ne conoscesse l’identità; era poi fuggito in una zona remota della Germania dove aveva lavorato - sempre sotto falso nome - in un’azienda di legname. Sarebbe poi riuscito ad espatriare all’inizio degli anni Cinquanta, per scomparire una decina di anni, e poi essere ritrovato in Argentina nel 1960, rapito dal Mossad, portato in Israele dove, dopo un processo, sarebbe stato mandato a morte nel 1961. Nel ricostruire questa storia, la Lipstadt si è concentrata su alcune questioni di dettaglio, degne di interesse.
L’autrice sostiene che il «cacciatore di nazisti» Simon Wiesenthal, che avrebbe poi rivendicato una parte decisiva nella cattura di Eichmann, ebbe invece un ruolo marginale nella vicenda. Anzi, una sua lettera del 23 settembre 1959 (sei mesi prima dell’arresto del criminale) all’ambasciatore israeliano a Vienna suggeriva che egli si trovasse ancora nel Nord della Germania.
Il merito di aver scoperto che Eichmann viveva in una povera casa (senza elettricità, né acqua corrente) di via Garibaldi alla periferia di Buenos Aires, va a Lothar Hermann, un tedesco quasi cieco, ebreo a metà, trasferitosi in Argentina nel 1939 dopo essere riuscito a uscire da un campo di concentramento dove era recluso. Una sua figlia adolescente, Sylvia, aveva iniziato a frequentare un giovane che diceva di chiamarsi Klaus Eichmann. Proprio così: il padre, in fuga dalla Germania, aveva cambiato nome e cognome (quello nuovo era Ricardo Klement), ma il figlio aveva tenuto quelli veri. La notizia per vie traverse era giunta al capo dei servizi segreti israeliani, Isser Harel, che l’aveva presa sottogamba, anche perché Tuvia Friedman, un altro cacciatore di nazisti, sosteneva di avere le prove che Eichmann si trovasse in Kuwait. E la «rivelazione» di Friedman era finita addirittura sui giornali, mettendo a rischio la successiva operazione di Buenos Aires.
Poi però Harel (che ha raccontato questa storia in La casa di via Garibaldi , pubblicato da Castelvecchi) si convinse della bontà dell’informazione di Hermann, spedì in loco un commando che, ottenuto il via libera da Ben Gurion, catturò Eichmann la sera dell’11 maggio, per strada. Secondo uno degli uomini che lo bloccarono, Peter Malkin (lo scrive in Nelle mie mani , pubblicato da Sperling&Kupfer), Eichmann quella sera si lasciò sfuggire «il grido primitivo di un animale intrappolato», provò a dire di essere Ricardo Klement, ma, poco dopo, ammise la sua vera identità. Durante il volo che lo avrebbe portato a Tel Aviv, un agente del Mossad offrì ad Eichmann una sigaretta, ma un capo meccanico presente sull’aereo, orfano di genitori uccisi dai nazisti, si mise a piangere e protestò contro quel gesto: «Lei a lui dà le sigarette, lui a noi ha dato il gas».
Israele comunicò al mondo che la cattura di Eichmann era opera di alcuni «volontari» e si scusò (tramite il ministro degli Esteri, Golda Meir) per la violazione della sovranità del Paese latinoamericano. Il presidente argentino Arturo Frondizi si arrabbiò per quel rapimento. E diede incarico al suo rappresentante alle Nazioni Unite, Mario Amadeo (ammiratore dichiarato di Francisco Franco e di Benito Mussolini), di chiedere l’immediata restituzione di Eichmann.
Gli Stati Uniti sulle prime appoggiarono la richiesta di Frondizi, ma, in vista della campagna elettorale, il vicepresidente Richard Nixon, in procinto di candidarsi contro John Kennedy, nel timore di perdere l’appoggio della comunità ebraica, ordinò all’ambasciatore Henry Cabot Lodge di definire le scuse della Meir un «atto sufficiente di riparazione». I giornali americani, invece, si scatenarono contro Israele. Il «New York Times», il «Washington Post», il «New York Post» scrissero che lo Stato ebraico aveva adottato «la legge della giungla», dando prova di un «grande disprezzo delle norme internazionali», che il processo sarebbe stato «inquinato dall’illegalità» e inficiato dallo «spirito di vendetta». I quotidiani tedeschi furono invece molto più prudenti, anche perché il cancelliere Konrad Adenauer - che pure era circondato da ex nazisti (o, forse, proprio per questo) - aveva da tempo avviato una politica molto generosa nei confronti di Israele, atta a scoraggiare i sentimenti antitedeschi dei superstiti della Shoah. Per non dar adito ad equivoci, la Germania rifiutò di pagare le spese processuali per la difesa di Eichmann (le pagò Israele).
Durissime furono, invece, le reazioni degli ebrei antisionisti come il rabbino Elmer Berger. Il celebre psicologo Erich Fromm qualificò il tutto come un «atto di illegalità del genere esatto di cui gli stessi nazisti si erano resi colpevoli». Anche esponenti di primo piano dell’American Jewish Committee polemizzarono apertamente con Ben Gurion, accusandolo di volersi erigere a rappresentante dell’intero popolo ebraico. Essi chiesero esplicitamente di consegnare Eichmann alla Germania e di evitare di tenere il processo in Israele. Suggerivano inoltre agli israeliani di «smorzare i toni sulle sofferenze degli ebrei durante la soluzione finale» così da non «dare la stura a nuove manifestazioni antisemite». Parole che oggi difficilmente potrebbero essere pronunciate da un ebreo (e anche da un non ebreo). Ben Gurion rispose con durezza che l’ebraismo americano stava «perdendo ogni significato» e che soltanto un cieco poteva non vedere quanto fosse prossima la sua «estinzione». Queste loro prese di posizioni - proseguiva Ben Gurion - dimostravano che gli ebrei statunitensi si disponevano a ricevere «il bacio della morte», che avrebbe suggellato il loro «lento declino nell’abisso dell’assimilazione».
In Israele il caso Eichmann andò a incrociare un processo che aveva diviso il Paese negli anni precedenti, quello a Israel Kasztner. Kasztner era un ebreo ungherese, che nel 1944 aveva negoziato proprio con Eichmann una cessione di autocarri in cambio della vita di un consistente numero di ebrei. L’operazione «sangue in cambio di merci» (così fu definita) aveva consentito la messa in salvo di 1.700 persone e altre ancora avevano evitato di finire ad Auschwitz a seguito di quella trattativa. Dopo la guerra, Kasztner era espatriato in Israele dove aveva militato nel Mapai, divenendo portavoce del governo. Ma un altro ebreo immigrato in Palestina dall’Ungheria, Malchiel Gruenwald, si era messo a far circolare ciclostilati nei quali Kasztner veniva accusato di aver favorito i propri familiari e altri ebrei ricchi, nonché di essere stato per tutti gli altri (cinquecentomila) finiti nei Lager una sorta di «assassinio vicario» dei nazisti. Il governo aveva fatto causa a Gruenwald, ma il suo avvocato, Shmuel Tamir, era riuscito a capovolgere i termini del procedimento giudiziario, trasformandolo in un processo agli ebrei che avevano in qualche modo «collaborato» con i nazisti.
Il dibattimento, rievoca Lipstadt, fece venire allo scoperto «una percezione da tempo diffusa in Israele secondo cui i sopravvissuti all’Olocausto avevano fatto qualcosa di disdicevole per salvarsi la vita». Il giudice, Benjamin Halevi, condivise pressoché apertamente le tesi di Tamir, assolse Gruenwald e disse, nei modi più chiari, che Kasztner, negoziando con Eichmann, aveva «venduto l’anima al diavolo». Poco tempo dopo Kasztner era stato ucciso davanti alla porta di casa, a Tel Aviv. E non aveva potuto sapere della successiva sentenza della Corte suprema che avrebbe capovolto le decisioni di Halevi, condannando il suo accusatore
Adesso, proprio quando, come ha scritto Sergio Minerbi nel libro La belva in gabbia (Lindau), in Israele «si era diffuso il desiderio di sbarazzarsi dell’amarezza» per il caso Kasztner, con un colpo di scena, proprio al giudice Halevi, diventato nel frattempo presidente del tribunale distrettuale di Gerusalemme, sarebbe spettato di presiedere il processo ad Adolf Eichmann. Halevi pretendeva di far valere questo diritto, in molti si erano schierati dalla sua parte e avevano sostenuto che non era lecito «adattare» le leggi di uno Stato alle circostanze.
Altrettanti, però, fecero rilevare come non ci si dovesse «nascondere dietro i formalismi» e che la politica dovesse operare delle scelte. Tra questi ultimi, Ben Gurion. La Knesset fece propri questi dubbi e varò un’apposita legge, con la quale disponeva che il nuovo dibattimento dovesse essere guidato da un magistrato appartenente all’Alta Corte di giustizia (fu scelto Moshe Landau). Per i due giudici che avrebbero affiancato Landau, si restò alle disposizioni di sempre, che assegnavano il diritto di scelta ad Halevi. Il quale fece due nomi: il proprio e quello di Yitzhak Raveh. Tutti e tre erano ebrei tedeschi, laureati in Europa prima di emigrare in Palestina.
Il processo iniziò l’11 aprile del 1961. Elie Wiesel, lì in veste di reporter per il «Jewish Daily Forward», si disse colpito dal fatto che Eichmann non appariva «diverso dagli altri esseri umani». Cyrus Leo Sulzberger, sul «New York Times», notò che «sembrava più ebreo, secondo le definizioni convenzionali, delle due abbronzate guardie israeliane» schierate a sua protezione. Protezione davvero eccezionale. Eichmann era recluso nella prigione di Yagur: una guardia fu incaricata di sorvegliarlo, un’altra di sorvegliare la prima e una terza di occuparsi della seconda. Nessuno dei tre aveva perso parenti nell’Olocausto, né parlava tedesco. Come suo difensore fu scelto Robert Servatius, che, pur non essendo mai stato nazista, aveva già svolto il ruolo di avvocato della difesa dei collaboratori di Hitler al processo di Norimberga. Il ruolo di pubblico ministero toccò a Gideon Hausner, privo di competenza in quel campo specifico (era specializzato in diritto commerciale), ma in stretti rapporti con Ben Gurion. Nel corso della fase istruttoria, la Corte israeliana chiese un’imponente documentazione a molti Paesi: l’Unione Sovietica e la Gran Bretagna non la concessero. Servatius nella prima fase del dibattimento fu assai abile nel sollevare una serie di obiezioni procedurali, alle quali però Hausner seppe rispondere con efficacia. Una legge israeliana del 1950 e una delibera delle Nazioni Unite rendevano legale il processo.
I testimoni a favore di Eichmann, che non potevano entrare in Israele senza rischiare l’incriminazione (o peggio), avrebbero potuto deporre all’estero. I corrispondenti dei giornali americani, in principio assai critici nei confronti del processo, lodarono la pertinenza e la quantità di precedenti fatti valere da Hausner. Eichmann si difese con grande abilità raccontando che nei primi anni del regime hitleriano, quando era in Austria, aveva avuto intensi rapporti con i leader sionisti per un piano che avrebbe consentito agli ebrei di espatriare, qualora si fossero rassegnati a lasciare in «patria» i loro averi. A tal fine avrebbe anche «soggiornato» a lungo in Palestina (ma si scoprì che, dopo un giorno ad Haifa, era stato espulso dagli inglesi alla volta dell’Egitto). Hausner smontò quel racconto grazie alla testimonianza di Aharon Lindenstrauss che, per conto degli ebrei, aveva «trattato» con Eichmann, venendone apostrofato «vecchio sacco di merda». Hannah Arendt, però, liquidò l’impianto di ricostruzione di Hausner come «cattiva storiografia e retorica a buon mercato». Deborah Lipstadt - che pure prende le distanze dalla Arendt - definisce «indubbio» che Hausner abbia presentato «gran parte della storia in modo errato», e imputa all’esposizione del pubblico accusatore «superficialità storica e autocelebrazione».
Un momento assai complicato fu quello dell’interrogatorio all’eroe Moshe Bejski, che raccontò di come in Polonia 15 mila ebrei furono costretti ad assistere all’impiccagione di un bambino. Hausner gli domandò a bruciapelo: «Perché, essendo in 15 mila contro poche centinaia di guardie, non vi ribellaste passando all’attacco?». Bejski chiese di potersi sedere e rispose evocando il terrore di chi spera di aver salva la vita, ma soprattutto, ove mai scegliesse di ribellarsi, non saprebbe poi dove cercar riparo. Con quella domanda, il processo rischiava di sfuggire di mano ad Hausner e di trasformarsi in un procedimento d’accusa contro le vittime. Ma la Lipstadt sostiene che il pubblico ministero volesse «dimostrare l’ingiustizia intrinseca di questa domanda». Hausner, scrive, «era perfettamente consapevole del fatto che gli israeliani nati in Israele e che nel 1948 avevano sconfitto cinque eserciti, non capivano perché gli ebrei di numero tanto superiore rispetto ai loro aguzzini non avevano fatto lo stesso» con i nazisti. E aveva portato la questione allo scoperto proprio per far sì che comprendessero quanto eccezionali fossero stati gli episodi di rivolta, come quello del ghetto di Varsavia nella primavera del 1943.
Per dimostrare questo assunto, Hausner chiamò sul banco dei testimoni Abba Kovner, capo della Resistenza di Vilnius. Ma qui vennero a confliggere la parte politica e quella strettamente giudiziale del dibattimento. Dopo che Kovner ebbe parlato, il giudice Landau con grande irritazione richiamò Hausner, accusandolo di aver «divagato molto rispetto all’argomento di questo processo» portando quell’uomo sul banco dei testimoni. E quando Zvi Zimmerman, alleato politico di Ben Gurion, andò alla sbarra per riferire quel che di Eichmann gli avevano detto persone della Gestapo, Landau diede in escandescenze: «Il valore di questa prova è, direi, quasi nulla... Questi, di fatto, sono pettegolezzi», disse ad alta voce. Il presidente del tribunale era a tal punto spazientito che sembrò pendere dalla parte di Servatius, sia nel caso dell’interrogatorio a Leon Wells (che parlò nello specifico degli ebrei costretti a cancellare le tracce delle uccisioni in massa), sia nel caso di quello a Michael Musmanno, i quali non riuscirono a dire con precisione in che modo quel che raccontavano fosse legato alla persona di Eichmann.
Ci riuscì, invece, il decano protestante di Berlino, Heinrich Grueber, il quale raccontò di un tedesco che aveva dato una mano a degli ebrei. Però al momento di farne il nome non volle, per non mettere a repentaglio, disse, la sua incolumità. Il fatto che, nella Germania degli anni Sessanta, fosse ancora rischioso dire di aver aiutato gli ebrei provocò sconcerto. Il testimone aggiunse che stava parlando per esperienza, dal momento che, quando la stampa tedesca aveva rivelato la sua intenzione di testimoniare contro Eichmann, aveva ricevuto uno «spesso dossier» di «minacce» e «lettere di insulti».
CONTINUA - NEL POST SUCCESSIVO...
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. Alcune note - di Federico La Sala13 maggio 2014, di Federico La Sala
- CONTINUAZIONE ----
In quegli stessi giorni il processo entrò nella fase decisiva, quella in cui si esaminava il ruolo svolto da Eichmann in Ungheria nel 1944, dove aveva organizzato il «trasferimento» ad Auschwitz di 437 mila ebrei. Eichmann aveva suggerito di cominciare con quelli della Carpazia, cosicché i loro correligionari di Budapest si «tranquillizzassero» al pensiero che ad essere colpiti fossero solo gli ortodossi. Poi aveva aperto una trattativa con il negoziatore Joel Brand per «vendergli» un milione di ebrei e nello stesso tempo aveva suggerito al comandante di Auschwitz, Rudolph Höss, di «trattarne» con il gas il maggior numero possibile. Infine si era tornati sul caso Kasztner - su cui la Lipstadt ha parole di grande comprensione - e quando si era presentato a testimoniare Pinchas Freudiger, membro del consiglio ebraico ungherese, dopo che un uomo dall’aula lo aveva accusato di essere responsabile della morte della propria famiglia, il processo era precipitato nel caos. Aggravato dal fatto che il giudice Halevi (quello che aveva condannato Kasztner) chiese a uno di quei testimoni se avessero mai pensato di uccidere Eichmann. Senza ottenerne risposta. Con il che Halevi aveva raggiunto lo scopo di dimostrare che in qualche modo i dirigenti dei Consigli ebraici - tranne rare eccezioni - avevano delle «colpe» per quel che era accaduto al loro popolo.
Il 20 giugno, dieci settimane dopo l’inizio del processo, Eichmann salì sul banco degli imputati. Fu assai vago e, ad un tempo, loquace. Il giudice fu costretto più volte a interromperlo: «Non le è stata chiesta una lezione generale... Le è stata posta una domanda specifica». Ma lui decise di insistere con la sua vuota verbosità. E ottenne un risultato. Il «New York Times» scrisse che non appariva «astioso o insolente», dal momento che «si crogiolava in frasi burocratiche» e che, dunque, non «valeva la pena di odiarlo». Hausner, secondo Lipstadt, commise molti errori nell’interrogarlo. Va ad Halevi merito di averlo indotto a pronunciare la frase che lo avrebbe condannato. Fu quando Eichmann, per dimostrare di non essere stato antisemita, raccontò di aver favorito la fuga di una coppia di ebrei viennesi e, per spiegare in che modo, si lasciò sfuggire: «In ogni legge esiste qualche scappatoia». Da quel momento non poté più cavarsela dicendo che era stato soltanto ligio alle leggi del suo tempo. Per lui non c’era più scampo.
A dicembre Eichmann viene condannato a morte. Alcune autorità morali del Paese, Martin Buber, Yeshayahu Leibowitz, Gershom Sholem, chiedono che ci si fermi lì. Ben Gurion che pure aveva dato battaglia per non includere la pena di morte nel codice penale di Israele, discute della questione con Buber, ma non si fa convincere. Decisiva è la presa di posizione del poeta Uri Zvi Grinberg: «Buber può rinunciare al castigo per la morte dei suoi genitori, se sono stati assassinati da Eichmann, ma né lui né altri Buber possono chiedere un’amnistia per l’assassinio dei miei genitori». Il 31 maggio 1962 Eichmann salirà sul patibolo.
Merito di questo libro è di aver ripercorso le tappe del processo senza fermarsi ai celebri reportage di Hanna Arendt, usciti sul «New Yorker» e poi raccolti nel libro La banalità del male (Feltrinelli). Ma un capitolo è dedicato alla stessa Arendt. Un capitolo non simpatizzante: «La Arendt tra l’altro mancò dall’aula per buona parte del processo», fa notare Lipstadt, «il suo fu un abuso di fiducia nei confronti dei lettori». Si mette in risalto come la Arendt scrivesse della «commedia di parlare ebraico», descrivesse i poliziotti israeliani come «simili agli arabi», «brutali», gente che «obbedirebbe a qualsiasi ordine», imputasse ai sionisti («senza offrire alcun dato per giustificare tale accusa») di «parlare un linguaggio non del tutto diverso da quello di Eichmann», avesse parole sprezzanti per i Consigli ebraici, il cui capitolo definì «fosco, patetico e sordido». Anche se, alla fine, la Arendt fu favorevole alla pena di morte. E diede il suo contributo a far sì che, se a Norimberga al centro dell’attenzione erano stati i carnefici, adesso giungesse «l’ora delle vittime». Gli ebrei. È questa, scrive Lipstadt, l’eredità più significativa del dibattimento che si concluse nel 1962 con le ceneri di Eichmann sparse nel mare.
-
-
> IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- HANNAH ARENDT E LA NUOVA "BANALITA’ DEL MALE" (di Bruno Forte)5 gennaio 2014, di Federico La Sala
LA NUOVA "BANALITA’ DEL MALE"
di Bruno Forte (Il Sole-24 Ore, 05.01.2014) *
Esattamente cinquant’anni fa Hannah Arendt, la filosofa ebrea tedesca allieva di Martin Heidegger e di Karl Jaspers, pubblicava l’edizione definitiva del suo libro "La banalità del male", frutto del lavoro svolto a Gerusalemme come inviata del "New Yorker" per seguire lo storico processo ad Adolf Eichmann. Il criminale nazista responsabile dello sterminio di milioni di Ebrei era stato catturato l’anno prima a Buenos Aires dove aveva vissuto indisturbato per anni.
Il "reportage" della Arendt si sviluppava in una serie preziosa di considerazioni morali, che furono poi raccolte e ampliate nel libro. La tesi che emerge dalle straordinarie pagine di questo testo è per molti aspetti sconcertante: «Il guaio del caso Eichmann era che di uomini come lui ce n’erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali. Dal punto di vista delle nostre istituzioni giuridiche e dei nostri canoni etici, questa normalità è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme» (282). Il messaggio che scaturiva dal caso Eichmann, quello «che il suo lungo viaggio nella malvagità umana ci aveva insegnato», era per la Arendt «la lezione della spaventosa, indicibile e inimmaginabile banalità del male» (259).
Su questa lezione mi sembra importante ritornare perché, fatte salve le ovvie differenze fra quello che fu "il male assoluto" e quelli che sono i mali del nostro presente, non c’è dubbio che molti di essi derivino dalla mentalità del "così fan tutti", giustificata dai cattivi maestri della scena pubblica, in particolare di quella politica. Provo ad articolare questa riflessione sull’insinuante presenza della "banalità del male" su tre fronti, che convergono nel male endemico e distruttivo della corruzione: la perdita diffusa del senso del dovere; il rimando alle altrui responsabilità per scaricare le proprie; la disaffezione nei confronti del bene comune, a favore di quello personale o della propria "lobby".
Il senso del dovere è a fondamento della coscienza morale e del comportamento che ad essa si ispira. Nella sua essenza esso consiste nella disposizione ferma a compiere il bene perché è bene e a fuggire il male per l’unica ragione che è male. Applicato all’etica del lavoro questo principio comporta la cura rigorosa da mantenere nell’assolvimento dei propri compiti, a prescindere dal riconoscimento altrui e dalla ricerca pur così naturale di gratificazioni.
Fare bene ciò di cui si è incaricati - purché ovviamente non contrasti con la legge morale inscritta in ciascuno di noi, com’è riassunta nei precetti del Decalogo - vuol dire contribuire alla qualità della vita di tutti, fino a poter avvertire il senso del giusto orgoglio di aver fatto la propria parte per migliorare l’esistenza collettiva. Essere paghi del bene compiuto non è egoismo: esattamente al contrario è uno dei volti dell’amore per gli altri, che è alla base della legge morale.
Un servitore dello Stato che rimandasse colpevolmente a domani ciò che può fare oggi nel dare risposte a chi richiede i suoi servizi, specialmente nell’ambito delle necessità dello stato sociale, cadrebbe in una mancanza etica, che dovrebbe pesargli a prescindere da qualsivoglia sanzione (peraltro spesso inesistente o ignorata).
Si pensi, per fare due esempi ben noti, ai tanti casi di esasperante lentezza della giustizia o ai continui rimandi della politica nell’affrontare questioni urgenti e necessarie, come la riforma dell’attuale, pessima legge elettorale. Se questa sensibilità morale è richiesta specialmente a chi deve assolvere a un servizio pubblico, essa mi sembra sia doverosa per tutti, perché indispensabile al bene di tutti.
La perdita del senso del dovere viene per lo più giustificata dal rimando alle responsabilità altrui: se sono i capi a dare il cattivo esempio, si comprende come il meccanismo di deresponsabilizzazione si diffonda a macchia d’olio.
I cattivi maestri si possono trovare tuttavia in molti ambiti della scena pubblica: si tenga conto dell’influenza che hanno specialmente sui giovani alcuni comportamenti o stili di vita immorali di protagonisti dello spettacolo e dello sport; o si pensi alle autogiustificazioni o addirittura alla semplice negazione della responsabilità giuridica o morale che figure di rilievo della politica danno di propri comportamenti scorretti, perfino quando essi siano stati accertati e condannati a più livelli di azione giudiziaria. Questo modo di fare corrompe le scelte e le motivazioni di tanti: i corrotti diventano a loro volta corruttori, e questi si giustificano con la logica perversa del "così fan tutti".
È un veleno che dilaga facilmente: «Si comincia con una piccola bustarella, ed è come una droga», afferma Papa Francesco, stigmatizzando una prassi che porta tanti a dar da mangiare ai loro figli "pane sporco". In tal senso, la corruzione è peggio del peccato, perché erode in profondità la coscienza morale e induce a sguazzare nella "banalità del male".
La diffusione di comportamenti corrotti va poi di pari passo con la crescita della disaffezione al bene comune, che è forse oggi la malattia dell’anima più insidiosa per la nostra società: la sola logica che sembra debba giustificare le scelte diventa quella del "che me ne viene?". La preoccupazione del benessere proprio e della propria lobby prevale su ogni considerazione che finalizzi l’agire al maggior bene di tutti. Si perde così il senso dell’impresa collettiva, del sogno e della speranza di una giustizia più grande; si spegne nei cuori la passione per ciò che è possibile, da fare al servizio degli altri per la costruzione di un domani migliore per tutti.
Non sorprende in questo clima avvelenato che i giovani provino disgusto per l’impegno sociale e politico e preferiscano rintanarsi nel privato della propria ricerca di vantaggi e di sicurezze per il futuro. A questa mentalità che riduce il male a banalità si può reagire in un solo modo, ritrovando il senso della serietà della vita, del suo spessore morale, della dignità unica e irripetibile dell’esistenza personale.
L’indignazione, su cui insiste il fortunato pamphlet di Stéphane Hessel, il grande vecchio della resistenza francese, recentemente scomparso ("Indignez-vous!", Paris 2010, in traduzione italiana: "Indignatevi!", Torino 2011), può essere il primo passo, l’appello a un risveglio. Ciò di cui, però, c’è assoluto bisogno è l’impegno serio e perseverante al servizio del bene comune, vissuto nella fedeltà rigorosa e continua alle esigenze morali. La domanda di Gesù riassume l’antidoto necessario alla banalità del male: «Quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?» (Luca 9,25).
Misurarsi sulle esigenze di un giudizio assoluto non è rifugio consolatorio, ma fondamento di un’esistenza che valga la pena di essere vissuta e di una tensione etica e spirituale in grado di dare dignità e bellezza alla fatica dei giorni, rendendo serio e grande ciò che appare o si vorrebbe ridurre a semplicemente banale. Tendere a questa serietà, amarla, custodirla ed essere pronti a pagare di persona per non rinunciarvi è l’augurio migliore che si possa fare a se stessi e agli altri in questo inizio di un anno nuovo.
* Bruno Forte è arcivescovo di Chieti-Vasto
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO --- Martin Heidegger. Nei “Quaderni neri” gli appunti segreti contro gli ebrei (di Antonio Gnoli)19 dicembre 2013, di Federico La Sala
 Martin Heidegger
Martin Heidegger
 Nei “Quaderni neri” gli appunti segreti contro gli ebrei
Nei “Quaderni neri” gli appunti segreti contro gli ebrei
 Le posizioni antisemite dell’autore di “Essere e tempo” svelate dai taccuini ancora inediti
Le posizioni antisemite dell’autore di “Essere e tempo” svelate dai taccuini ancora inediti di Antonio Gnoli (la Repubblica, 18.12.2013)
di Antonio Gnoli (la Repubblica, 18.12.2013)Un migliaio di pagine. Vedranno la luce nel marzo del prossimo anno: tre quaderni, vergati da Martin Heidegger, di cui pochissimi conoscevano l’esistenza. Nel mondo degli studi filosofici, soprattutto tedesco, c’è molto sbalordimento. Il “Mago di Messkirch” (così era soprannominato dai suoi studenti) per circa quarant’anni (dall’inizio degli anni Trenta al 1975, l’anno precedente alla sua morte) tenne una sua navigazione segreta, quasi quotidiana. Immaginate quest’uomo, piccolo, taciturno, duro, sospettoso come un contadino dell’Alta Svevia che, la sera nella sua baita di Todtnauberg, dava libero sfogo ai pensieri più nascosti, e avrete una vaga idea di cosa siano questi quaderni (in tutto nove) che Klosterman (editore delle opere complete) ha deciso di pubblicare. Sono molti gli interrogativi che queste pagine suscitano.
Vado ad affrontarli con la persona giusta: Donatella Di Cesare, ordinario di Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, autrice di libri sull’etica ebraica, Gadamer e contro il negazionismo. Il prossimo mese uscirà con un testo su Israele e la filosofia (per Bollati Boringhieri) e in primavera con Heidegger e la Shoah.
Di Cesare è una singolare figura di studiosa: è membro della comunità ebraica di Roma e al tempo stesso vice presidente dell’Heidegger Gesellshaft ,la società filosofica che nel mondo raccoglie diverse centinaia di studiosi. Del resto, non aveva avuto Heidegger stesso allievi ebrei? A cominciare da Hannah Arendt e poi Karl Löwith, Leo Strauss, Emmanuel Lévinas: pensatori che hanno beneficiato, anche se in maniera contrastata, delle riflessioni del maestro.
 Ma in questi quaderni la materia che scotta non riguarda tanto, o solamente, la questione, ormai annosa, dell’adesione al nazismo, quanto quella più esplosiva del presunto antisemitismo di Heidegger.
Ma in questi quaderni la materia che scotta non riguarda tanto, o solamente, la questione, ormai annosa, dell’adesione al nazismo, quanto quella più esplosiva del presunto antisemitismo di Heidegger.«Dopo aver letto queste pagine sono rimasta sconvolta», dice la Di Cesare, mentre indica sul tavolo le bozze dei tre quaderni. «Non posso ovviamente rendere pubblico nessun estratto perché c’è l’embargo dell’editore tedesco fino alla data di pubblicazione dei tre quaderni, prevista per il 13 marzo. Ma le assicuro che il mio primo impulso è stato di dimettermi dalla carica di vice presidente».
Mentre la Di Cesare va a recuperare un suo libretto, sbircio tra quei fogli. Mi colpisce un’espressione: Weltjudentum, “ebraismo mondiale”. Richiama scenari cupi, complotti internazionali, l’anticamera del peggior antisemitismo. Davvero Heidegger se ne macchiò in modo indelebile?
«Per me quell’espressione è carica di minacce. Ed è inequivocabile sul piano del significato. È come se individuasse un nemico sugli altri: l’ebreo. Agli ebrei egli imputa la bastardizzazione del mondo e l’autoestraneazione dei popoli. Potremmo dire che, in negativo, è il primo esempio di globalizzazione. L’argomentazione heideggeriana non si sviluppa però solo su un piano politico, ma assume anche contorni filosofici».
I Quaderni neri - l’immaginazione ci spinge a vederne i risvolti più inquietanti, sebbene la dicitura sia dello stesso Heidegger che lavorava su dei taccuini dalla copertina di quel colore - sono in tutto trentatré. A quanto pare due di essi sono andati perduti. Se ne conoscono le date: uno risale al 1931-32, l’altro al 1945-46. Con ogni evidenza, appartengono a periodi cruciali della vita del filosofo e dei tedeschi. Da un lato, la Germania entra nel suo periodo nazista; dall’altro, sconfitta dalla guerra, ne esce con tutte le terribili conseguenze che sappiamo. Chi sono i responsabili?
Sarebbe stato interessante gettare un occhio sui materiali scomparsi. Vedere cosa Heidegger pensasse all’inizio e alla fine di quella storia micidiale: «Alla Klosterman sostengono che il filosofo prestò quei due quaderni e che non li riebbe mai più indietro. Hanno scritto perciò, nel loro sito, che se qualcuno ne fosse ancora in possesso è pregato di restituirli al figlio Hermann Heidegger. La cosa ha il sapore dello scherzo».
Hermann - oggi ultranovantenne, figlio sì di Heidegger, ma che la moglie Elfride ebbe con un altro - è sempre stato un custode ortodosso delle opere del padre. Si sospetta che quei due quaderni siano stati sfilati da qualche “manina santa”. Perché? «Non bisogna essere troppo svegli per intuire che lì dentro, con ogni probabilità, ci sono i pensieri più compromettenti del filosofo sulla questione ebraica».
Naturalmente qui si cammina sul ghiaccio. Ma c’è molto fermento nella Heidegger Gesellshaft che, non essendo la Spectre, si interroga oggi su quanto di male stia accadendo. Nel frattempo il ruolo che era di Hermann, in qualità di membro familiare presente nella società filosofica, è stato preso dal figlio Arnulf. Un uomo, dice la Di Cesare, generoso e di grande libertà mentale. «Grazie a lui, alcuni di noi si sono resi conto che l’edizione delle opere complete di Heidegger presenta qualche manomissione. Sono state ad esempio eliminate alcune parole. La domanda è: perché superflue o perché compromettenti? Per ora ci limitiamo a questo».
Mi chiedo chi potrebbe essere il “perverso filologo”, o meglio il censore. E il pensiero corre a Hermann Heidegger, ai suoi celebri diktat editoriali. «Non lo sappiamo », si cautela la Di Cesare.
Chiedo se dietro all’affaire non vi sia la longa manus di F. W. Von Herrmann, assistente di Heidegger, negli ultimi anni, e curatore di parecchie opere. Anche qui cautela. Ma sembra sia stato proprio Von Herrmann a impedire la pubblicazione di questi sorprendenti Quaderni neri.
C’è un dettaglio rilevante, aggiunge la Di Cesare: «Heidegger in persona ha lasciato, tra le sue volontà testamentarie, l’indicazione che i Quaderni fossero pubblicati a compimento dell’edizione delle sue opere. Hermann Heidegger non si è mai pronunciato circa l’esistenza di questo lascito. Nessuno, fino alla primavera di quest’anno, ne sapeva nulla. Sono convinta che la loro pubblicazione non sarà un danno per l’immagine del filosofo. Lì dentro ci sono moltissime cose che chiariscono il suo pensiero». Dunque non solo un polemico atto d’accusa, ma anche una vertiginosa discesa nella sua filosofia.
Spiega la Di Cesare: «Lo stile è diverso da quello che conosciamo. Di solito siamo abituati a leggere Heidegger attraverso i suoi saggi e le sue lezioni. Dentro una prosa oscura e meticolosa. Qui, in gran parte, si tratta di riflessioni che vengono svolte con un andamento aforistico, quasi di impronta nicciana. Sono considerazioni prevalentemente filosofiche ma con una continua presa di posizione su questioni attuali, anche politiche. Sono convinta che i Quaderni neri muteranno la visione che abbiamo di Heidegger».
In bene? In male? Vediamo. Tornando alla spinosissima questione dell’antisemitismo c’è da aggiungere un particolare. Heidegger, secondo la Di Cesare, non parla mai degli ebrei come razza. Riporta quell’esperienza alla sua concezione metafisica. Quindi ne fa un problema filosofico. Come va intesa questa affermazione? Si sa che Heidegger pose sullo stesso piano americanismo, bolscevismo e, da ultimo, lo stesso nazismo, come manifestazioni dell’epoca della tecnica. Anche l’ebraismo, chiedo, finisce nello stesso calderone?
Risponde la Di Cesare:«Proprio alla luce della rilettura che fa della storia dell’Essere, notiamo qui qualcosa di più radicale e diverso. In alcune pagine dei Quaderni parla di Entwurzelung, di sradicamento dell’Essere, e dice che questo “sradicamento” è imputabile agli ebrei. È un’accusa metafisica. Non c’entrano niente il sangue e la razza».
E allora? «L’idea che mi sono fatta è che accanto a una questione filosofica ci sia in Heidegger una questione teologico-politica che non va sottovalutata. In fondo, leggendo Jacob Taubes e Carl Schmitt ci si accorge che le posizioni di Heidegger non erano poi così distanti. La cosa che interessava a tutti e tre era il lato messianico dell’ebraismo».
Ma lo declinano in modi diversi, replico. «È vero, ma lo sfondo teologico-politico è il medesimo. Con questa precisazione. Quando Heidegger parla di sradicamento, in realtà sta alludendo alla forza messianica, planetaria, dell’ebraismo e reagisce come farebbe un conservatore della vecchia Europa. Ossia delineando uno scontro planetario (che del resto la guerra in qualche modo legittimava): da un lato lo sradicamento, dall’altro la Germania - che lui identificava con l’Europa - che deve rispondere con la forza del Boden ossia del radicamento al suolo, alla terra, alla dissoluzione planetaria. I passi contenuti nei Quaderni mostrano una profonda intuizione del messianismo. Heidegger capisce tutto. Stando dalla parte sbagliata».
Bisognerebbe, a questo punto, domandarsi cosa ha significato la lunga e perfino penosa reticenza da parte del filosofo nei riguardi di chi gli chiedeva una spiegazione delle mostruosità che erano accadute. Solo in un’occasione, per quel che ne so, Heidegger si pronunciò alludendo ai campi di sterminio. Parlò della «fabbricazione dei cadaveri». Poi più nulla. Salvo accorgersi che, in quelle sere passate nella sua “capanna”, i pensieri tornavano spesso su quel dramma. Quasi fosse un algido affresco dell’inferno. Dobbiamo essere indulgenti con un grande pensatore? Dobbiamo continuare a distinguere la sua filosofia dai suoi comportamenti? È su questo che i Quaderni neri oggi ci interpellano. E quel lungo silenzio - che Derrida interpretò come la scelta di un filosofo che non giudicava nessuna parola all’altezza di quella tragedia - andrebbe sciolto in una nuova consapevolezza. O quanto meno in una più evidente ragione sulle responsabilità della filosofia verso la politica.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- Lascio la Comunità ebraica, fa propaganda a Israele. Intervista a Moni Ovadia (di Silvia Truzzi)5 novembre 2013, di Federico La Sala
Lascio la Comunità ebraica, fa propaganda a Israele
intervista a Moni Ovadia
a cura di Silvia Truzzi (il Fatto Quotidiano, 5 novembre 2013)
Diceva don Primo Mazzolari che “la libertà è l’aria della religione”. Non era ebreo, come non lo era George Orwell che in appendice alla Fattoria degli animali scrive: “Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuol sentirsi dire”. L’eco di queste frasi si sente entrando nella casa di Moni Ovadia a Milano. Per dar seguito al nome pacifista, il cane Gandhi si accomoda sul divano insieme a un paio di gatti; il caffè bolle, l’attore con il capo coperto racconta la storia del festival promosso dalla comunità ebraica che si è svolto alla fine di settembre a Milano, Jewish and the city. “Qualcuno, durante una riunione tra gli organizzatori ha posto il veto alla mia presenza. E gli altri hanno ceduto”.
Perché?
Per le mie posizioni critiche nei confronti del governo Netanyahu. Le violazioni del diritto internazionale, mi riferisco all’occupazione e alla colonizzazione dei territori palestinesi, durano da oltre cinquant’anni. Ho imparato dai profeti d’Israele che bisogna essere al fianco dell’oppresso. Io esprimo opinioni, non sono depositario di nessuna verità. Penso però che questa situazione sia tossica. Per i palestinesi, che sono le vittime, ma anche per gli israeliani: non c’è niente di più degradante che fare lo sbirro a un altro popolo. Aggiungo però che io m’informo esclusivamente da fonti israeliane. Non palestinesi: gli ultrà palestinesi sono i peggiori nemici della loro causa. Apprezzo molto due giornalisti israeliani di Haaretz, Gideon Levy e Amira Hass. Quello che dico io, rispetto a quello che scrivono loro, è moderato. Bene: vivono in Israele, scrivono su un quotidiano israeliano, sono letti da cittadini israeliani e pubblicati da un editore israeliano.
È iscritto alla Comunità ebraica di Milano?
Sì, per rispetto dei miei genitori. Ma ho deciso di andarmene. Io non voglio più stare in un posto che si chiama comunità ebraica ma è l’ufficio propaganda di un governo. Sono contro quelli che vogliono “israelianizzare” l’ebraismo. Ho deciso di lasciare, come ha fatto Gad Lerner a causa della mancata presa di posizione dei vertici milanesi dopo l’uscita di Berlusconi al binario 21, nel Giorno della Memoria.
Dicono che le sue critiche a Israele nascono dal desiderio di avere consensi, successo, denaro.
Ma oggi chi è a favore della causa palestinese? La sinistra? Nemmeno più Vendola lo è! E allora dove sarebbe il grande pubblico che mi conquisto? Più ho radicalizzato le mie critiche, più il mio lavoro è diminuito, mi riferisco agli ingaggi e non al pubblico. Il teatro è per tutti, il teatrante è un cittadino e come tale ha diritto alle sue idee.
Lei non è abbastanza “carino”?
Per niente, ma non si parla di cose carine. Il comportamento della comunità internazionale nei confronti del popolo palestinese è semplicemente schifoso. Nel 2000 intervistai per il Corriere della Sera un colonnello della Golani, le teste di cuoio d’Israele. Mi disse: “Se tu hai un bazooka in mezzo ai denti e un mitragliatore tra le chiappe, ci sono almeno due modi per uscirne”. Da militare m’insegnò che se si vuole fare la pace, si riesce. Se io dicessi che il governo Netanyahu è un po’ birichino, ma non così tanto, diventerei immediatamente il più grande artista ebreo italiano. Invece offendono i miei spettacoli.
È vero che riceve minacce?
Appena scrivo qualcosa, sul mio sito arriva di tutto: minacce, insulti, parolacce. I termini sono sempre “rinnegato”, “traditore”, “nemico del popolo ebraico”. Ho criticato l’episodio del bimbo palestinese di cinque anni che aveva lanciato una pietra ed era stato portato via da undici militari israeliani. Mi hanno scritto: “Avesse potuto quella pietra arrivare sul tuo cervello marcio”. Questi sono i termini, mai risposte nel merito. Mia moglie, che gestisce la mia pagina Facebook, spesso non me li fa leggere, li cancella e basta.
Sono ebrei quelli che la insultano?
La gran parte sì.
Aver subito la discriminazione non è servito a nulla?
Si, ma paradossalmente questo ha un aspetto positivo. Significa che gli ebrei sono come tutti gli altri. Si trovano in una condizione in cui il nazionalismo è a portata di mano? Diventano i peggiori nazionalisti, malgrado la Torah condanni l’idolatria della terra. L’ebraismo è una cosa, lo Stato d’Israele un’altra. Qualcuno ha sostituito la Torah con Israele. Il buon ebreo, dunque, non è quello che segue la Torah, ma quello che sostiene Tel Aviv. I sinceri democratici - tipo La Russa - sono amici d’Israele. E non importa se fino a poco tempo fa facevano il saluto romano inneggiando a quelli che hanno sterminato la nostra gente.
Dell’affaire Vauro cosa pensa?
La vignetta su Fiamma Nirenstein prendeva in giro la disinvoltura con cui una donna, appassionatissima della causa israeliana, può sedere in Parlamento accanto a uno come Ciarrapico, che non ha mai smesso di dirsi fascista. Ha fatto benissimo Vauro a querelare chi gli dava dell’antisemita. Non solo perché ha vinto in due gradi di giudizio, ma perché l’accusa di antisemitismo è troppo grave per usarla a sproposito.
Lei cosa chiede?
Vorrei essere criticato - non calunniato o insultato - ma rispettato. Vorrei semplicemente avere il diritto di dire la mia opinione e potermi confrontare.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- Perché lascio la «mia» comunità ebraica (di Moni Ovadia)8 novembre 2013, di Federico La Sala
Perché lascio la «mia» comunità ebraica
di Moni Ovadia (il manifesto, 8 novembre 2013)
Lunedì scorso tramite un’intervista chiestami dal Fatto Quotidiano, ho dato notizia della mia decisione definitiva di uscire dalla comunità ebraica di Milano, di cui facevo parte, oramai solo virtualmente, ed esclusivamente per il rispetto dovuto alla memoria dei miei genitori. A seguito di questa intervista il manifesto mi ha invitato a riflettere e ad approfondire le ragioni e il senso del mio gesto, invito che ho accolto con estremo piacere. Premetto che io tengo molto alla mia identità di ebreo pur essendo agnostico.
Ci tengo, sia chiaro, per come la vedo e la sento io. La mia visione ovviamente non impegna nessun altro essere umano, ebreo o non ebreo che sia, se non in base a consonanze e risonanze per sua libera scelta. Sono molteplici le ragioni che mi legano a questa «appartenenza».
Una delle più importanti è lo splendore paradossale che caratterizza l’ebraismo: la fondazione dell’universalismo e dell’umanesimo monoteista - prima radice dirompente dell’umanesimo tout court - attraverso un particolarismo geniale che si esprime in una "elezione" dal basso. Il concetto di popolo eletto è uno dei più equivocati e fraintesi di tutta la storia.
Chi sono dunque gli ebrei e perché vengono eletti? Il grande rabbino Chaim Potok, direttore del Jewish Seminar di New York, nel suo «Storia degli ebrei» li descrive grosso modo così : «Erano una massa terrorizzata e piagnucolosa di asiatici sbandati. Ed erano: Israeliti discendenti di Giacobbe, Accadi, Ittiti, transfughi Egizi e molti habiru, parola di derivazione accadica che indica i briganti vagabondi a vario titolo: ribelli, sovversivi, ladri, ruffiani, contrabbandieri. Ma soprattutto gli ebrei erano schiavi e stranieri, la schiuma della terra». Il divino che incontrano si dichiara Dio dello schiavo e dello Straniero. E, inevitabilmente, legittimandosi dal basso non può che essere il Dio della fratellanza universale e dell’uguaglianza.
Non si dimentichi mai che il «comandamento più ripetuto nella Torah sarà: Amerai lo straniero! Ricordati che fosti straniero in terra d’Egitto! Io sono il Signore!» L’amore per lo straniero è fondativo dell’Ethos ebraico. Questo «mucchio selvaggio» segue un profeta balbuziente, un vecchio di ottant’anni che ha fatto per sessant’anni il pastore, mestiere da donne e da bambini. Lo segue verso la libertà e verso un’elezione dal basso che fa dell’ultimo, dell’infimo, l’eletto - avanguardia di un processo di liberazione/redenzione.
Ritroveremo la stessa prospettiva nell’ebreo Gesù: «Beati gli ultimi che saranno i primi» e nell’ebreo Marx: «La classe operaia, gli ultimi della scala sociale, con la sua lotta riscatterà l’umanità tutta dallo sfruttamento e dall’alienazione».
Il popolo di Mosé fu inoltre una minoranza. Solo il venti per cento degli ebrei intrapresero il progetto, la stragrande maggioranza preferì la dura ma rassicurante certezza della schiavitù all’aspra e difficile vertigine della libertà.
Dalla rivoluzionaria impresa di questi meticci «dalla dura cervice», scaturì un orizzonte inaudito che fu certamente anche un’istanza di fede e di religione, ma fu soprattutto una sconvolgente idea di società e di umanità fondata sulla giustizia sociale.
Lo possiamo ascoltare nelle parole infiammate del profeta Isaia. Il profeta mette la sua voce e la sua indignazione al servizio del Santo Benedetto che è il vero latore del messaggio: «Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso dei giovenchi. Il sangue di tori, di capri e di agnelli Io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i Miei Atri? Smettete di presentare offerte inutili, l’incenso è un abominio, noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto, sono per me un peso sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, Io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, Io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova».( Isaia I, cap 1 vv 11- 17). Il messaggio è inequivocabile. Il divino rifiuta la religione dei baciapile e chiede la giustizia sociale, la lotta a fianco dell’oppresso, la difesa dei diritti dei deboli. Un corto circuito della sensibilità fa sì che molti ebrei leggano e non ascoltino, guardino e non vedano. Per questo malfunzionamento delle sinapsi della giustizia, i palestinesi non vengono percepiti come oppressi, i loro diritti come sacrosanti, la loro oppressione innegabile.
Qual’è il guasto che ha creato il corto circuito. Uno smottamento del senso che ha provocato la sostituzione del fine con il mezzo. La creazione di uno Stato ebraico non è stato più pensato come un modo per dare vita ad un modello di società giusta per tutti, per se stessi e per i vicini, ma un mezzo per l’affermazione con la forza di un nazionalismo idolatrico nutrito dalla mistica della terra, sì che molti ebrei, in Israele stesso e nella diaspora, progressivamente hanno messo lo Stato d’ Israele al posto della Torah e lo Stato d’Israele, per essi, ha cessato di essere l’entità legittimata dal diritto il internazionale, nelle giuste condizioni di sicurezza, che ha il suo confine nella Green Line, ed è diventato sempre più la Grande Israele, legittimata dal fanatismo religioso e dai governi della destra più aggressiva. Essi si pretendono depositari di una ragione a priori.
Per questi ebrei, diversi dei quali alla testa delle istituzioni comunitarie, il buon ebreo deve attenersi allo slogan: un popolo, una terra, un governo, in tedesco suona: ein Folk, ein Reich, ein Land. Sinistro non è vero? Questi ebrei proclamano ad ogni piè sospinto che Israele è l’unico Stato democratico in Medio Oriente. Ma se qualcuno si azzarda a criticare con fermezza democratica la scellerata politica di estensione delle colonizzazioni, lo linciano con accuse infamanti e criminogene e lo ostracizzano come si fa nelle peggiori dittature.
Ecco perché posso con disinvoltura lasciare una comunità ebraica che si è ridotta a questo livello di indegnità, ma non posso rinunciare a battermi con tutte le mie forze per i valori più sacrali dell’ebraismo che sono poi i valori universali dell’uomo.
-
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- "L’ultimo degli ingiusti" (di Claude Lanzmann). E’ ora di assolvere l’ebreo Mulmerstein? (di Anna Foa)31 maggio 2013, di Federico La Sala
OLOCAUSTO
E’ ora di assolvere l’ebreo Mulmerstein?
di Anna Foa (Avvenire, 31 maggio 2013)
Il recente documentario di Claude Lanzmann, L’ultimo degli ingiusti, presentato al Festival di Cannes e non ancora apparso sui nostri schermi, ha autorevolmente riproposto la questione assai dibattuta del ruolo dei Consigli ebraici nella realizzazione dello sterminio nazista. Se cioè i Consigli ebraici preposti dai nazisti a gestire la vita dei ghetti abbiano avuto una funzione di collaborazione con i nazisti oppure si siano adoperati, ove più ove meno efficacemente, in modo da far sopravvivere, con l’esistenza dei ghetti, anche il maggior numero di ebrei possibile.
È noto che i sopravvissuti, che avevano spesso veduto deportare vecchi, donne e bambini in base alle selezioni gestite da questi Consigli, hanno dato generalmente un giudizio molto negativo del loro ruolo.
Chaim Rumkovski, il presidente del Consiglio del ghetto di Lódz, morto ad Auschwitz; Adam Czerniaków, presidente di quello del ghetto di Varsavia, suicidatosi nel 1942 quando non riuscì a impedire la deportazione della maggioranza degli ebrei del ghetto; Benjamin Mulmerstein, l’ultimo presidente del Consiglio ebraico di Terezin, sopravvissuto alla Shoah; tutti hanno avuto nel dopoguerra una pessima fama.
In Israele, Rudolf Kastner, accusato di «aver fatto un patto con il diavolo», cioè con Eichmann, per salvare gli ebrei ungheresi, fu prosciolto, ma dopo essere stato assassinato da un fanatico. Nel giovane Stato di Israele, l’enfasi era posta sulla resistenza armata ai nazisti, non sui tentativi necessariamente compromissori di salvare il salvabile eseguendo i loro ordini. Gli eroi erano i combattenti del ghetto di Varsavia, non coloro che avevano intavolato trattative coi tedeschi.
Mulmerstein, rabbino viennese, unico sopravvissuto dei membri del Consiglio ebraico di Terezin, fu nel dopoguerra imprigionato dai comunisti cechi, processato per collaborazionismo coi nazisti e assolto. Gershom Scholem, che basava il suo giudizio sulle informazioni ricevute dai reduci di Terezin, dichiarò che avrebbe voluto vederlo impiccato. Nel 1947 si stabilì a Roma, ma le accuse di collaborazionismo lo inseguirono qui, nonostante la sua assoluzione.
Nella postfazione scritta oggi al libro sul ghetto di Terezin, già edito nel 1961 dalla Cappelli e ora ripubblicato dall’editrice La Scuola, il figlio Wolf racconta con parole molto accorate e polemiche le vicende dell’ultimo periodo della vita del padre: «Morì nel 1989 dopo lunghe sofferenze, dovute alle esperienze vissute negli anni di "quelle tenebre" e nei successivi. L’allora rabbino capo di Roma, Elio Toaff, che gli aveva negato nel 1983 l’iscrizione alla Comunità, nel 1989 gli vietò la sepoltura nella tomba della moglie. ... Infine, chi scrive fu mortificato nel 1989 col rifiuto di recitare in Sinagoga la preghiera in ricordo del padre, perché avesse "parte del mondo futuro"». Rav Toaff motivò le sue decisioni con le informazioni negative che aveva ricevuto su di lui.
Mulmerstein fu sepolto al limite del cimitero di Prima Porta, in uno spazio che ospita ora anche le tombe di alcuni reduci della Shoah. Con il documentario di Lanzmann, basato anche su una lunga intervista da lui fatta a Mulmerstein a Roma negli anni Settanta, ci troviamo di fronte a una sua sostanziale riabilitazione.
Il libro di Mulmerstein (Terezin. Il ghetto-modello di Eichmann) è un testo di straordinario interesse, in cui l’autore descrive minuziosamente questo ghetto modello, creato vicino a Praga per imprigionarvi gli ebrei praghesi e molti ebrei tedeschi, in gran parte "prominenti", cioè personaggi che nella vita precedente erano stati autorevoli politici, artisti, studiosi, scienziati: un luogo in cui a sopravvivere erano soprattutto i vecchi e non gli uomini in grado di lavorare, al contrario di quanto successe altrove.
Mulmerstein descrive anche nei particolari l’operazione di maquillage del ghetto realizzata dai nazisti nel 1943 in occasione tanto delle visite della Croce Rossa che della realizzazione del documentario propagandistico nazista «Hitler ha regalato una città agli ebrei», i cui protagonisti furono, a film finito, tutti deportati ad Auschwitz. Sono vicende su cui oggi molto è stato scritto, ma che allora erano sconosciute alla maggior parte non solo dei lettori ma anche degli studiosi.
Interessato evidentemente a provare la sua innocenza, Mulmerstein privilegia nel suo pur lungo testo, rispetto ai tanti aspetti della vita di Terezin di cui molto si è parlato negli ultimi anni, come la vita dei bambini, la musica, l’arte, la questione della gestione del ghetto e dei rapporti con i nazisti fino alla liberazione nel maggio 1945. Proprio per questo il testo mette in luce senza filtri il terribile dilemma di fronte a cui il suo autore si è trovato di fronte: salvare il ghetto e quindi la vita di una parte dei suoi abitanti a spese dell’altra parte, oppure lasciare che tutto fosse distrutto.
Nel testo emerge anche con evidenza il conflitto interno ai nazisti fra quanti erano interessati, in vista della sconfitta, a trattare con gli Alleati usando la vita degli ebrei come ostaggio e quanti volevano la loro eliminazione totale, non ultimo Adolf Eichmann, uno dei massimi protagonisti di questa vicenda.
Ci stacchiamo da questa lettura sconvolgente senza aver sciolto il dilemma che assillò per tutto il resto della sua vita anche Mulmerstein, quello di cosa si sarebbe dovuto fare in quella situazione, ma anche facendoci l’idea che egli fece quanto riteneva meglio per salvare il ghetto e i suoi abitanti. E che in ogni caso la colpa non era di quanti tentavano di mantenere in vita il ghetto, operando scelte terribili in una situazione comunque estrema, ma di chi li aveva collocati in questa condizione, i nazisti.
Il resto appartiene alle responsabilità individuali di coloro che si fecero intermediari fra le vittime e i carnefici, che lo abbiano fatto per dovere o per altre meno nobili ragioni, quali il potere e la sopravvivenza. Mulmerstein, la cui maggior colpa è stata forse soltanto quella di essere sopravvissuto, è stato assolto dai tribunali. È forse arrivato il momento che sia assolto anche dalla storia.
Anna Foa
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO -- Arendt e Eichmann - la stupidità del male (di Gian Enrico Rusconi)28 maggio 2013, di Federico La Sala
Arendt e Eichmann la stupidità del male
Così, a confronto con Joachim Fest, la filosofa approfondì la sua analisi su uno dei maggiori responsabili della Shoah
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 28.05.2013)
«Più che della “banalità del male” si dovrebbe parlare della banalità delle conclusioni della signora Arendt. Il processo ad Eichmann fu fatto da ignoranti, voluto da Ben Gurion per giustificare la fondazione dello Stato di Israele. Hannah Arendt, che aveva seguito tutto da lontano, racconta un sacco di assurdità». Queste parole pronunciate giorni fa a Cannes, con la consueta passione, da Claude Lanzmann, autore del film Shoah, ripropongono la polemica violentissima scoppiata negli Anni 60 all’uscita dell’ormai celebre libro della filosofa ebrea, tedesca, americana Hannah Arendt, La banalità del male, appunto.
È una polemica «fuori tempo»? No. C’è infatti il rischio che la ricezione di questo libro diventi essa stessa banale (è inevitabile questo gioco di parole perché fa parte del problema). Che l’opera sia citata quasi esclusivamente per il suo titolo, ignorandone la complessità, la tortuosità e la problematicità.
Siamo quindi grati all’editore Giuntina d’avere tradotto in italiano un libro che inquadra e fa la sintesi di questa problematica ( Hannah Arendt, Joachim Fest, Eichmann o la banalità del male. Interviste, lettere, documenti, pp. 214, € 14). In esso troviamo una documentazione accurata della polemica iniziata nel marzo 1963 in America dall’Organizzazione degli ebrei emigrati dalla Germania e proseguita con moltissimi interventi tra cui quelli di personaggi di spicco come Golo Mann e Mary McCarthy.
Si è trattato di un vero e proprio processo alle intenzioni e ad alcune tesi del libro che investono non soltanto la personalità di Eichmann ma anche la corresponsabilità dei Consigli ebraici nell’organizzazione della deportazione e quindi della eliminazione degli ebrei. Hannah Arendt lo ha definito «il capitolo più fosco di tutta quella fosca storia».
In effetti è un tema terrificante e tuttora controverso, in cui guazzano anche incorreggibili antisemiti e negazionisti. Quanto a Eichmann, «altro che burocrate ottuso: era un demonio: violento, corrotto, furbissimo», prosegue oggi Lanzmann, respingendo tutti i tentativi della Arendt di darne un’immagine diversa, anche se negativa.
Già nel 1964 Golo Mann aveva riconosciuto che la Arendt aveva tracciato un ritratto a suo modo fedele di Eichmann. «Non si trattava di un mostro, di un sadico, nemmeno di un fanatico antisemita, bensì di un uomo oltremodo comune: ambizioso quanto altri, obbediente, scaltro e stupido quanto altri; rispetto alle persone più colte era animato da un misto di ammirazione e risentimento; fiutò delle opportunità per una nuova carriera bramoso di svolgere il grande compito omicida in maniera puntuale come qualsiasi altro compito gli fosse assegnato».
Dove sbaglia allora l’autrice? Il fatto che fosse un essere razionale e non un idiota, che fosse un marito tenero e un padre amorevole, nonché un amico disponibile non giustifica - scrive Golo Mann - che Eichmann venga presentato «così innocuo e bonario come lo dipinge la Arendt. Con osservazioni del genere non si risolve il problema della crudeltà e diabolicità dell’uomo».
Ecco il punto: il contrasto tra la «normalità persino bonaria dell’individuo e la mostruosità e diabolicità del suo comportamento» non può essere liquidato come «banalità del male». Questa definizione è frutto di una «saccente dialettica che genera una notte in cui i buoni non sono buoni e i cattivi non sono cattivi».
Non era certamente questa l’intenzione della Arendt. Ma per sostenere la sua tesi non usa argomenti del tipo: sì, anche l’uomo comune - immesso in un meccanismo più grande e potente di lui - si deresponsabilizza arrivando a comportarsi come un mostro. L’autrice non descrive Eichmann come un impotente automa. Analizza puntigliosamente quanto sia lucido e consenziente, accetti e si identifichi consapevolmente con la funzione che esercita perché lo fa sentire «potente» al punto che senza di essa perde la sua stessa identità. L’autrice non dice neppure che «un Eichmann alberga in noi, ciascuno di noi ha dentro di sé un Eichmann». No. La sua spiegazione è più impegnativa anche se a prima vista sconcertante: Eichmann - dice - è «stupido».
Lo spiega in una conversazione radiofonica con Joachim Fest dopo aver raccontato un episodio (ripreso da Ernst Jünger) di «normali» contadini tedeschi che trattano come esseri subumani prigionieri russi perché questi per fame rubano il cibo dei porci. Era questa «la stupidità scandalosa» che pure Eichmann condivideva in un universo di rapporti diverso. «Ed è questo che propriamente ho inteso quando parlai di banalità. In ciò non c’è nulla di abissale, cioè di demoniaco. Si tratta semplicemente della mancata volontà di immaginarsi davvero nei panni degli altri».
È facile immaginare quanto insoddisfacente suoni questa risposta, soprattutto per le vittime che si sono trovate davanti alla brutalità e al sadismo di questi «uomini comuni», «stupidi», «incarnazione della persona media».
La nostra insoddisfazione è mitigata se leggiamo e inquadriamo queste tesi, che suonano un po’ astratte, nel contesto delle conversazioni tra Hannah Arendt e Joachim Fest, che si svolgono nel periodo in cui quest’ultimo sta lavorando e pubblicando le sue biografie su Hitler e Albert Speer. È evidente che i due autori si scambiano simpateticamente riflessioni che nella diversità delle sensibilità hanno in comune l’interesse di conoscere quel mondo «borghese» o semplicemente quel «tedesco medio» che è stata la vera spina dorsale del regime nazionalsocialista. Apparentemente c’è poco in comune tra il burocrate Eichmann e il brillante architetto Speer, intimo di Hitler. Ma si intuisce lo stesso universo di seduzione e complicità che porta in grembo la nuova tipologia criminale, che la Arendt ha creduto di fissare nel concetto di «banalità del male».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO - La Arendt di fronte a Eichmann. Lo scandalo del mostro banale (di Corrado Stajano)22 maggio 2013
 La Arendt di fronte a Eichmann Lo scandalo del mostro banale
La Arendt di fronte a Eichmann Lo scandalo del mostro banale Per la filosofa il processo riguardava lui, non l’ideologia nazista
Per la filosofa il processo riguardava lui, non l’ideologia nazistadi Corrado Stajano (Corriere della Sera, 22.05.2013)
Un gran libro del Novecento, La banalità del male, di Hannah Arendt, compie quest’anno mezzo secolo e non ha perso nulla della sua forza morale e politica. Quando fu pubblicato provocò scandalo in tutto il mondo, rotture di antiche amicizie, conflitti non sopiti (insulti ancora oggi del regista Lanzmann al Festival di Cannes), ma anche un’ampia condivisione di chi si ritrovava e si ritrova in quelle idee, espressione di profonda libertà intellettuale, razionali e insieme amaramente appassionate. Negli anni diede vita ad almeno un migliaio di pubblicazioni sull’orrore della Shoah e sulle sue interpretazioni. Ha avuto insomma una funzione stimolatrice. Che continua.
Dalla casa editrice Giuntina sta ora per uscire Eichmann o la banalità del male, di Hannah Arendt e Joachim Fest, un libro intelligente che serve a fare il punto su quella questione controversa e sulla polemica che ne seguì. Il libro raccoglie la preziosa intervista andata perduta e ritrovata di recente della Arendt allo storico tedesco Joachim Fest, trasmessa nel 1964 da una radio bavarese; il carteggio inedito fra i due; lettere; documenti; la feroce stroncatura di Golo Mann; il saggio di Mary McCarthy consonante con le opinioni della filosofa tedesca; un’accurata bibliografia.
La banalità del male uscì nel 1963 in Israele, l’anno seguente in Germania e in Italia (Feltrinelli). Questo della Giuntina è un libro utile a raccogliere le idee per chi sa e a suscitare desiderio di sapere per chi non sa.
Hannah Arendt, filosofa della politica (1906-1975), ebrea tedesca, lasciò la Germania nel 1933, all’avvento del nazismo. Autrice, tra l’altro, di un’opera di grande rilievo, Le origini del totalitarismo, visse esule a Parigi e poi negli Stati Uniti, dove insegnò nelle più rinomate università.
Nel 1961 accettò, non a cuor leggero, la proposta del «New Yorker» di seguire a Gerusalemme il processo contro il criminale di guerra Adolf Eichmann, capo della sezione ebraica della Gestapo, esecutore degli ordini di Heydrich, catturato nel 1960 dal Mossad israeliano in Argentina. (Il processo finì con la condanna a morte di Eichmann impiccato nel 1962).
Che cosa provocò la polemica contro La banalità del male? La Arendt scrisse sul settimanale americano una serie di reportage, li arricchì e ne trasse poi il libro con quel titolo che offese molti. Ma, come scriverà Joachim Fest, biografo di Hitler e di Speer, in una raccolta di ritratti, Incontri da vicino e da lontano, pubblicata, come gli altri suoi libri, dalla Garzanti, la Arendt «non aveva minimamente inteso definire banale lo sterminio, né tantomeno il male in sé. Aveva semmai voluto descrivere quel male, nella sua terribile incarnazione in uno squallido personaggio».
Hannah Arendt aveva le carte in regola per scrivere quel che vide e quel che sentì: Eichmann visto da vicino non era un angelo caduto, ma un uomo meschino, mediocre, bugiardo, privo di ogni morale, un millantatore. Il suo grado nella gerarchia di comando non era elevato, tenente colonnello. Ubbidiva, felice di farlo, sofferente se gli mancavano gli ordini. Sapeva organizzare e negoziare, fu impeccabile nel far funzionare i trasporti della morte, il suo compito.
Era un «depositario dei segreti della soluzione finale», aveva visto con i propri occhi quel che bastava per conoscere bene quella terribile macchina di distruzione. Non aveva ucciso con le proprie mani, non aveva di certo il potere e l’autorità di Hitler o di Himmler. Quel che a lui interessava era la carriera e per farla era necessario che fosse il proprio gruppo a uccidere il maggior numero possibile di ebrei. L’azienda della morte.
Era un uomo comune, «normale»: «nel senso che non era un’eccezione nel contesto del Terzo Reich». Quella «normalità» di Eichmann faceva gelare il sangue alla filosofa-giornalista che aveva potuto verificarla durante le 121 udienze del processo.
Con il suo libro la Arendt ruppe ogni schema. Il procuratore generale (e il primo ministro Ben Gurion) avrebbero voluto che quello diventasse il processo al nazismo. Secondo la scrittrice, invece, il processo doveva fondarsi su quel che Eichmann aveva fatto, non su quel che gli ebrei avevano sofferto e atrocemente pagato. Era necessario che stessero fuori dal dibattimento le domande senza risposta: «Com’è potuto accadere?»; «Perché gli ebrei andavano alla morte come agnelli al macello?». E anche: «Come hanno potuto i capi ebraici contribuire allo sterminio degli ebrei?».
L’accenno alla correità dei consigli ebraici nella Shoah, per evitare mali peggiori, naturalmente, scatenò aspri risentimenti. La Arendt fu accusata di essere incapace di amore per il suo popolo, ci fu anche chi disse che aveva calunniato le vittime e scagionato la Gestapo. La verità fa male, in ogni epoca.
Nell’intervista a Fest, la Arendt difende se stessa soprattutto con ironia sull’ipocrita commedia degli intellettuali. Preferisce affrontare i temi nodali: il potere che è più forte del crimine; l’incapacità di immaginarsi nella mente degli altri; se si può essere innocenti in un regime totalitario; la tipologia degli assassini privi di un movente, «incomparabilmente più terribili di qualsiasi altro assassino»; i nazisti che non si sono per nulla pentiti; la mentalità del funzionario parossisticamente ubbidiente anche agli ordini più malvagi. «Ma in nome di Dio - esplode la Arendt -, fate che sia un altro a sporcarsi con questa faccenda! Tornate a essere uomini». Il passato irrisolto, il passato che non passa.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO --- IL MURO DEL PIANTO E LA PREGHIERA DI UOMINI E DONNE. Dietro lo scontro culturale la lotta fra due idee di Israele.11 maggio 2013, di Federico La Sala
Vincono le donne del Muro: preghiere sotto scorta
di U.D.G. (l’Unità, 11.05.2013)
Donne contro al «Muro della discordia». Diverse centinaia di donne ebree «haredi» (timorate) hanno manifestato ieri davanti al Muro del Pianto per impedire alle «Donne del Muro» di pregare come gli uomini, così come previsto da una decisione di una Corte di Gerusalemme. Secondo i media, le fedeli ortodosse che hanno risposto all’appello diffuso dai rabbini della congregazione come Ovadia Yosefa e altri hanno lanciato spazzatura e acqua contro le donne emancipate intenzionate ad avvicinarsi al Muro per pregare indossando indumenti sacri riservati dalla tradizione ai maschi. È intervenuta la polizia per dividere i due gruppi e si sono verificati alcuni scontri. I rabbini del movimento riformato, del quale fanno parte «Le Donne del Muro» hanno sostenuto che i rabbini ortodossi nonostante questi avessero chiesto una protesta senza alcuna violenza con i fatti avvenuti ieri hanno «dissacrato la santità del posto».
SFIDA LAICA
Le femministe hanno cercato di avvicinarsi al luogo più sacro dell’ebraismo: chiedono di poter pregare come gli uomini, indossando i tallit (lo scialle da preghiera), i tefillin (scatolette di cuoio legate con le cinghie, contengono versetti sacri) e di poter recitare la Torah ad alta voce (t’fila in ebraico vuol dire preghiera). Sono le quattro «T» simbolo della protesta che gli haredim leggono come una sola parola: tradimento dell’ortodossia.
Secondo il portavoce della polizia Micky Rosenfeld, mille ultraortodossi sono stati allontanati dalla manifestazione delle «Women of the Wall», che ogni mese si danno appuntamento al Kotel (Muro del Pianto o Muro occidentale) per la rituale preghiera, ma questa volta legalmente. Gli ultraortodossi hanno tentato di forzare il passaggio, alcuni insultando i poliziotti, altri attaccando le attiviste. I dimostranti hanno lanciato bottiglie d’acqua, sacchi di immondizia, sedie di plastica o uova, sia sugli agenti, che sulle donne. La polizia ha arrestato cinque ultraortodossi con l’accusa di aver creato «disordine pubblico».
Ad aprile, un tribunale ha concesso alle donne di pregare davanti al Muro e di indossare il talled, uno scialle riservato agli uomini. Circa 400 le attiviste che si sono presentate ieri: «Siamo orgogliose e felici di avere pregato in tutta libertà e in pace», ha spiegato una responsabile, ringraziando la polizia per l’aiuto.
«È un momento storico», afferma una portavoce delle Donne del Muro, Shira Pruce, aggiungendo che «la polizia ha fatto un lavoro meraviglioso proteggendo le donne per permettere loro di pregare liberamente al Muro occidentale. Questa è la giustizia». La polizia, ha riferito la portavoce, ha poi accompagnato le donne in autobus, i quali sono stati colpiti con pietre da manifestanti mentre stavano lasciando la Città vecchia di Gerusalemme.
Shmuel Rabinowitz, un rabbino che in passato aveva definito le iniziative delle donne come «una provocazione», ha cercato di allentare le tensioni. «Nessuno in Israele vuole che ci sia una disputa al Muro occidentale», ha detto in un’intervista alla radio dell’esercito.
Il Muro, il luogo più sacro dell’ebraismo, è attualmente diviso in sezioni separate per uomini e donne. Ad aprile le autorità israeliane avevano proposto di creare una nuova sezione, in cui uomini e donne potrebbero pregare insieme. La proposta dovrà essere approvata dal governo.
Dietro lo scontro culturale la lotta fra due idee di Israele
I “fondamentalisti della Torah” fuori dal governo per la prima volta da 30 anni
di Francesca Paci (La Stampa, 11.05.2013)
- Il ruolo della donna è regolato dalla «Tzanua» il concetto di modestia nei costumi
 Il gruppo delle «Donne del Muro» durante la preghiera al Muro del Pianto
Il gruppo delle «Donne del Muro» durante la preghiera al Muro del Pianto
 Si ispirano a un ebraismo «liberal» che si è sviluppano specie negli Stati Uniti
Si ispirano a un ebraismo «liberal» che si è sviluppano specie negli Stati Uniti
 Gli ortodossi sono solo il 10% ma vorrebbero imporre norme come i posti separati sui bus
Gli ortodossi sono solo il 10% ma vorrebbero imporre norme come i posti separati sui bus
Farà prima Natan Sharansky a sintonizzare le preghiere delle Women of the Wall sulle frequenze dei rabbini ultraortodossi o Tzipi Livni a rilanciare il dialogo con i palestinesi? I bookmakers israeliani puntano sulla ministra della giustizia, perché delle due mission impossible del premier Netanyahu quella assegnata al presidente dell’Agenzia ebraica tira in ballo equilibri precari assai precedenti al 1948.
La battaglia per il Muro del Pianto racconta lo scontro più ampio in corso tra la Start Up Nation proiettata verso il futuro e gli haredim, i fondamentalisti della Torah, che pur rappresentando solo il 10% della popolazione partecipano da trent’anni alle coalizioni di governo assicurandosi una buona fetta del budget tra esonero dalla leva e scuole religiose. Ma se la maggioranza degli israeliani affronta il ruolo politico di Dio al momento del voto, che quest’anno si è risolto in una disfatta per i rabbini massimalisti rimasti fuori dal gabinetto, le Women of the Wall preferiscono la prima linea, il mitico Tempio di Gerusalemme, quella porta del cielo così angusta per loro nonostante l’ebraismo sia una religione che si trasmette di madre in figlio.
La bestia nera dell’emancipazione femminile si chiama Tzanua (che in ebraico sta per modestia), un dogma più che un’auspicata virtù muliebre impresso sui cartelli intimidatori agli incroci di Mea Shearim, enclave ultraortodossa di Gerusalemme. Regola numero uno vestire di scuro, bandire i pantaloni (fascianti) e le maglie col collo a V (rivelatrici di sinuose profondità), indicare il proprio status di maritata coprendo i capelli (con cappello, foulard o parrucca) indossare calze spesse e, a voler strafare, privilegiare le scarpe chiuse. E pazienza se il lungo mare dell’iper liberale Tel Aviv pullula di bikini essenziali come neppure Copacabana: anche lì, dove coppie di militari omosessuali si abbracciano tenendo il mitra in spalla, s’è fatta spazio una spiaggia per religiosi doc con una staccionata protettiva intorno e le bagnanti rilassate nei loro austeri costumi-abiti, castigati al pari dei burqini islamici ma realizzati in sottili tessuti high tech a prova di annegamento.
Anche i rabbini più oltranzisti ammettono che alcuni divieti sono presi forse un po’ troppo alla lettera, specialmente in un paese futurista al punto che non riesce più a chiamare un taxi senza l’applicazione iPhone. L’integerrimo Moshe Feinstein per esempio, ha sempre esecrato ogni promiscuità tra i sessi (compresa la stretta di mano) facendo eccezione però per i luoghi di lavoro, i treni o l’affollatissima metropolitana di New York, situazioni limite perché considerate «contatto fisico non intenzionale».
Ciò non ha impedito che una decina di anni fa una compagnia di trasporti privata di Tel Aviv inaugurasse gli autobus con i posti separati nel sobborgo ultraortodosso di B’nai Brak mettendo il governo di fronte al fatto compiuto e le donne ribelli come la soldatessa diciottenne Doron Matalon alla stregua di una Rosa Parks israeliana costretta ad appellarsi alla Corte Suprema. Da allora si sono moltiplicate le proteste ma anche i pullman della discordia e i marciapiedi per soli uomini.
Il problema, come provano le ambizioni «ecclesiastiche» delle Women of the Wall (che vorrebbero pregare più devotamente), non è la religione di per se ma le consuetudini religiose. Soprattutto quando il brand «modestia», come qualsiasi brand identitario nell’indistinta era global, può diventare un business. «Gli autobus separati sono una grandiosa opportunità di fare soldi con gli haredim» racconta la scrittrice ebrea ortodossa Naomi Ragen, riferendo proprio la riflessione di un haredim. Basta vedere la quantità di siti che commercializzano casti abiti femminili khoser ( o quelli per single osservanti).
L’ultima parola? La sfida è donna, al Muro del Pianto come nelle cabine del Ye’elat Chen Salon, dove, in un sottoscala a dir poco nascosto, le gerosolimitane più ortodosse (e le musulmane che discretamente arrivano dalla zona araba della città) si fanno belle per il marito ma soprattutto per loro stesse.
-
> ISRAELE --- IL MURO DEL PIANTO E LA PREGHIERA. -- Libere di pregare e di apparire. Vincono le donne di Gerusalemme13 maggio 2013, di Federico La Sala
Libere di pregare e di apparire. Vincono le donne di Gerusalemme
di Davide Frattini (Corriere della Sera, 13 maggio 2013)
L’apparizione di Bar Refaeli è stata il segnale che tutti hanno potuto vedere. I manifesti con la nuova pubblicità stanno appesi sui muri di Gerusalemme da dove le donne sono state bandite per anni. Al punto che il poster per la scorsa edizione della maratona cittadina lasciava solo intravedere una partecipante (nascosta dall’uomo in primo piano). Al punto che quando non si poteva farne a meno le donne venivano disegnate piuttosto che mostrarle in fotografia.
Il cartellone con la modella israeliana è il risultato della battaglia lunga diciotto mesi di un gruppo di attiviste. Combattono - come le femministe che chiedono di pregare al Muro del pianto alla pari degli uomini - l’esclusione e la separazione negli spazi pubblici: che siano i quartieri ultraortodossi, gli autobus con le aree riservate ai maschi, le cerimonie religiose. I pullman in servizio a Gerusalemme continuano a non esibire pubblicità con la presenza di donne, ma adesso hanno garantito l’eguaglianza nell’invisibilità e hanno smesso di far apparire anche gli uomini.
Haaretz elenca i successi dei laici nella difficile convivenza con gli oltranzismi della comunità haredi . «L’esclusione femminile è il risultato di un crescente estremismo religioso - commenta Rachel Azaria, consigliere comunale, al quotidiano -. È un piccolo gruppo che prova a imporre la propria volontà a tutti gli altri: quando abbiamo cominciato a reagire la situazione è cambiata».
Alla fine di aprile un tribunale di Gerusalemme ha dato ragione alle Donne del Muro, l’organizzazione che dal 1988 combatte per poter pregare davanti alle pietre più sacre dell’ebraismo come gli uomini: vuol dire indossare i tallit (lo scialle da preghiera), i tefillin (scatolette di cuoio legate con le cinghie, contengono versetti sacri) e recitare la Torah ad alta voce ( t’fila in ebraico vuol dire preghiera). Sono le quattro «T» simbolo della protesta che i rabbini haredim leggono come una sola parola: tradimento dell’ortodossia.
Secondo il giudice, le donne non contravvengono alle «usanze locali», mentre la Corte Suprema dieci anni fa aveva preferito tutelare «la sensibilità degli altri credenti».
Venerdì scorso sono arrivate in almeno cinquecento per la cerimonia prevista il primo giorno del mese nel calendario ebraico. Questa volta sotto scorta della polizia che le ha protette invece di arrestarle: attorno migliaia di ultraortodossi che hanno insultato loro e gli agenti («nazisti» «tornatevene in Germania»), hanno tirato pietre, spazzatura e bottiglie di plastica.
Il rabbino Ovadia Yosef aveva ordinato alle studentesse delle scuole religiose di «invadere» la piazza. Una mossa che potrebbe rimpiangere: le ragazze si sono trovate di fronte a un rituale che per loro resta proibito, qualcuna si è avvicinata - come racconta su Twitter l’attivista Hallel Abramowitz, nipote adolescente della comica americana Sarah Silverman - e ha detto di aver vissuto «un momento molto significativo». Sembra avverarsi la profezia di Anat Hoffman, tra le leader del movimento: «I rabbini non sembrano capire che queste studentesse - ha detto al New York Times
 finiranno con il chiedersi "perché io no?". Una domanda molto sovversiva».
finiranno con il chiedersi "perché io no?". Una domanda molto sovversiva».Il governo di Benjamin Netanyahu sta cercando di trovare un compromesso: la controversia intacca i rapporti con gli ebrei americani, molti di loro appartengono alle congregazioni conservative e riformiste che sostengono la sfida di Women of the Wall . Nathan Sharansky, eroe della dissidenza sovietica e capo dell’Agenzia ebraica, ha presentato un piano per creare un’area dove le donne possano pregare come chiedono.
Naftali Bennett, da ministro degli Affari Religiosi, ha annunciato che proporrà nuove regole per i luoghi sacri. La paura è che il leader del partito dei coloni voglia ridimensionare la sentenza del tribunale.
Allison Kaplan Sommer gli ricorda su Haaretz le origini della sua famiglia a San Francisco e il manifesto della sinagoga (riformista) frequentata dai genitori prima di immigrare in Israele: «Abbracciare la diversità».
- Il ruolo della donna è regolato dalla «Tzanua» il concetto di modestia nei costumi
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- Hannah Arendt eroina al cinemaL’ultimo. film di Margarethe von Trotta dedicato alla filosofa si concentra sul processo a Eichmann (di Gherardo Ugolini)23 febbraio 2013, di Federico La Sala
 Hannah Arendt eroina al cinema
Hannah Arendt eroina al cinema
 L’ultimo film di Margarethe von Trotta dedicato alla filosofa si concentra sul processo a Eichmann e la nascita della «Banalità del male»
L’ultimo film di Margarethe von Trotta dedicato alla filosofa si concentra sul processo a Eichmann e la nascita della «Banalità del male» di Gherardo Ugolini (l’Unità, 23.02.2013)
di Gherardo Ugolini (l’Unità, 23.02.2013)BERLINO FA DISCUTERE «HANNAH ARENDT», L’ULTIMO FILM DI MARGARETHE VON TROTTA, DA POCO USCITO NEI CINEMA DELLA GERMANIA. La regista conclude con questa pellicola una sorta di «trilogia al femminile» su grandi donne della storia tedesca, i cui primi due capitoli erano dedicati rispettivamente a Rosa Luxemburg (film Rosa L. del 1985) e alla monaca medievale Ildegarda di Bingen (Vision del 2009). Girare un film su un filosofo ricostruendone biografia e pensiero non è per nulla facile; si rischia nella migliore delle ipotesi di produrre un documentario, e nella peggiore una fiction noiosa e inguardabile.
Margarethe Von Trotta ha evitato entrambe le cose, sfornando una pellicola fresca e ricca di tensione dalla prima all’ultima sequenza. Merito anche del soggetto, visto che Hannah ha avuto una vita quanto mai interessante, dalla giovinezza trascorsa tra Königsberg e Berlino fino all’esilio americano.
In mezzo l’approdo a Marburgo dove andò appositamente per studiare filosofia con Martin Heidegger, il legame sentimentale col grande pensatore, poi il trasferimento a Heidelberg dove si addottorò con Karl Jaspers, l’espatrio a Parigi in seguito all’avvento del nazismo e dopo l’occupazione tedesca della Francia la prigionia in un campo di raccolta e da lì la rocambolesca fuga negli Stati Uniti, dove Arendt cominciò una nuova esistenza lavorando come docente in alcune università americane.
Senza contare le polemiche suscitate dalle sue principali pubblicazioni, a partire dallo studio sulle Origini del totalitarismo del 1951 in cui tracciava un rischioso parallelismo tra dittatura nazista e staliniana.
Ebbene, Margarethe von Trotta, che sul suo personaggio si è documentata accuratamente leggendo biografie e parlando con testimoni diretti, ha scelto di concentrarsi su un solo segmento del percorso biografico di Hannah, un segmento breve ma decisivo, ovvero gli anni tra il 1960 e il 1964.
L’evento fondamentale di quel periodo, che assorbì interamente le passioni e le energie della filosofa, fu il processo contro Adolf Eichmann, l’architetto dell’Olocausto che dopo la guerra era riuscito a trovare riparo in Argentina, ma che nel 1960 fu sequestrato dal Mossad e portato in Israele. Arendt seguì da cronista il processo a Gerusalemme raccontando le sue impressioni in una serie di reportage per il giornale The New Yorker e raccogliendo poi il materiale nel pamphlet La banalità del male, destinato a diventare celebre.
Interpretata da una bravissima Barbara Sukowa, attrice prediletta della regista, la Arendt che vediamo sullo schermo fisicamente non assomiglia molto a quella storica, ma ne riproduce perfettamente lo stile comunicativo, la tempra ostinata fino a sfiorare l’arroganza, l’arrovellarsi continuo della mente, l’umorismo sottile.
La si vede protagonista, insieme col marito, il poeta Heinrich Blücher, della scena intellettual-mondana newyorkese, in particolare nei circoli dell’emigrazione ebraico-tedesca; la si vede nelle aule universitarie in cui dibatte coi suoi studenti in inglese con forte accento tedesco e con la sigaretta sempre accesa.
Se la relazione giovanile con Heidegger viene solo rievocata attraverso rapidi flashback, al centro del film c’è costantemente la questione del nazismo e del suo significato. È evidente che il processo Eichmann di cui sono anche mostrati spezzoni reali rappresentò per la filosofa una specie di resa dei conti con la storia e con la propria esistenza.
Pensava di trovarsi davanti un mostro bestiale e invece scoprì che Eichmann era un normale e grigio burocrate che aveva architettato deportazioni e massacri eseguendo gli ordini ricevuti e senza neppure pensare a quello che faceva. Non agiva per odio o per cattiveria, ma solo per obbedienza e senza domandarsi mai se ciò che faceva era bene o male.
Nacque da lì la teoria della «banalità del male», ovvero l’idea che in un contesto totalitario si verifichi nell’individuo una scissione totale tra pensiero e morale, fino al compimento di crimini atroci senza rendersene conto. Ma all’epoca quell’interpretazione non fu per nulla compresa. Anzi, Arendt si attirò veleni e inimicizie, soprattutto da parte delle comunità ebraiche, di cui pure faceva parte. Fu accusata di giustificazionismo nei confronti del nazismo, ricevette minacce pesanti e rischiò perfino di essere sospesa dall’insegnamento. Destarono scandalo in particolare le sue osservazioni sulla «passività» degli ebrei di fronte alla Shoah.
Non era facile, ma con Hannah Arend la regista di Anni di piombo e di Rosenstrasse è riuscita non solo a consegnarci un prezioso ritratto di colei che è considerata la più acuta pensatrice del secolo scorso, ma anche a toccare un nervo scoperto della storia tedesca, senza sbavature retoriche e senza ideologismi precostituiti.
-
> ISRAELE --- Palestina, la bella vittoria del paziente Abu Mazen (di Moni Ovadia) - Ultima opportunità per dare vita a due Stati sicuri e indipendenti (di Daniel Barenboim)1 dicembre 2012, di Federico La Sala
Palestina, la bella vittoria del paziente Abu Mazen
di Moni Ovadia (l’Unità, 1.12.2012)
Giovedì 29 novembre 2012 è stata e rimarrà una data memorabile nel bene (lo speriamo con tutte le nostre forze) o nel male (lo deprechiamo con tutto il cuore). Gli uomini che credono nella pace, nella giustizia e nell’eguaglianza, hanno visto sorgere il primo lucore di un’alba che era attesa da lunghissimo tempo. Il popolo palestinese ha finalmente scorto la luce in fondo al tunnel oscuro in cui era confinato da 45 anni. L’Assemblea dell’Onu, a grandissima maggioranza, ha accolto nel proprio seno come membro osservatore, la Palestina. È solo un inizio ma ha un grandissimo significato. Le piazze della Cisgiordania e di Gaza si sono riempite di folla tripudiante.
L’uomo che ha ottenuto questa luminosa vittoria per il suo popolo, il paziente Abu Mazen, ha ricevuto gli abbracci calorosi di una folla di rappresentanti delle Nazioni Unite. La sua tenacia ha avuto ragione, non si è fatto intimidire e ha incassato con determinazione, tutte le false promesse di trattativa, tutte le azioni miranti a delegittimarlo, non ha ceduto alla frustrazione, non ha aperto le porte alla tentazione della violenza e ce l’ha fatta. Anche Hamas, bon gré mal gré, sarà costretta a riconoscerlo. Le piazze palestinesi festanti, hanno rievocato simbolicamente, le piazze ricolme di ebrei «palestinesi» pervase dalla gioia che ascoltarono la proclamazione dello Stato d’Israele votata a maggioranza dall’ Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948. Per la popolazione ebraica di allora, uscita dalla Shoà, fu il coronamento di un sogno. Per i Palestinesi fu l’inizio della Nakhba, la catastrofe, la perdita di terre e case che, nel ’67, dopo la Guerra dei Sei Giorni, avrebbe conosciuto la seconda interminabile fase che perdura ancora oggi.
Ora, questa profonda lacerazione ha visto la possibilità di essere sanata. Grandi assenti a questa giornata di festa: i governanti israeliani e il Presidente degli Usa Barack Obama, incastrati in una miope solidarietà risentita senza orizzonte e senza futuro. Netanyahu e Obama fingono di non sapere che la trattativa è possibile solo fra interlocutori di pari dignità. Nel mio piccolo ho parteggiato con tutte le energie per questa prospettiva, senza risparmiare le critiche più aspre ai governi israeliani della colonizzazione e dell’occupazione e senza il minimo sconto.
Per questa ragione, proprio oggi mi sento di dire che chi si serve di stereotipi antisemiti con la pretesa di esprimere solidarietà ai palestinesi, mente. L’antisemitismo è stata una delle peggiori pestilenze che abbia attraversato l’umanità nel suo cammino, si nutre dell’humus dell’odio e del razzismo, è un pensiero criminoso che colpisce gli ebrei ma che prepara anche la catastrofe per tutti gli uomini che credono nella fratellanza, nella libertà e nella pari dignità di tutti gli esseri umani. Chi cerca di giustificarlo con l’esistenza di Israele, dimentica capziosamente che l’antisemitismo si è manifestato, nella sua forma più virulenta e genocida, quando gli ebrei non avevano terra e neppure aspiravano ad una terra nella forma di nazione moderna.
Lo ripeto, le critiche alle azioni dei governanti israeliani messe in atto contro la popolazione civile palestinese, anche le più dure e provocatorie, sono del tutto lecite e condivisibili quando suffragate da fatti e da prove ma i complottismi modello «Protocolli dei Savi di Sion» in riedizione «antisionista» comprese le identificazioni fra governo, Stato e popolo israeliano non sono altro che la versione antiisraeliana dell’antisemitismo. In Israele non vivono solo truppe militari Droni e gli elicotteri Apache, ma donne, uomini, bambini, vecchi, giovani, madri, figli, fratelli, sorelle come in Palestina pur nella drammatica differenza delle condizioni esistenziali. Ma di tutto hanno bisogno i palestinesi per trovare giustizia, fuorché degli antisemiti dichiarati o camuffati che siano.
Ultima opportunità per dare vita a due Stati sicuri e indipendenti
di Daniel Barenboim (Corriere della Sera, 1.12.2012)
Il 29 novembre è una data storica. Il 29 novembre 1947 le Nazioni Unite, con il «Piano di partizione della Palestina», stabilirono la suddivisione della regione in un territorio per gli ebrei e uno per i palestinesi. Fino a quel giorno eravamo tutti «palestinesi»: musulmani, cristiani ed ebrei.
La ripartizione del 1947 fu accolta con gioia dagli ebrei di tutto il mondo e rifiutata dal mondo arabo, che considerava la Palestina come una terra propria ed esclusiva. Seguì una guerra, cominciata il giorno dopo la dichiarazione d’indipendenza dello Stato d’Israele, il 14 maggio del 1948.
Il 29 novembre 2012, esattamente 65 anni dopo, i palestinesi hanno chiesto e ottenuto a grande maggioranza il riconoscimento dello status di «Stato osservatore» presso le Nazioni Unite. Questi sono semplicemente i fatti. Un’interpretazione potrebbe essere: hanno avuto bisogno di 65 anni per rendersi conto che Israele è divenuta una realtà innegabile e sono dunque pronti ad accettare il principio della ripartizione del territorio palestinese rifiutato nel 1947?
In questo senso diventa chiaro che la decisione presa ieri dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite deve essere un motivo di soddisfazione anche per lo Stato d’Israele. Non voglio dare lezioni di morale o di strategia politica né agli israeliani né ai palestinesi; però desidero ricordare che se questo conflitto non è stato risolto per molti anni, è forse perché né gli uni né gli altri e nemmeno il resto del mondo, ne hanno colto l’essenza profonda.
Il conflitto israelo-palestinese non è un’ostilità politica tra due Stati che si possa risolvere con mezzi diplomatici o militari: un dissidio politico tra due nazioni può riguardare problematiche relative ai confini, al controllo dell’acqua, del petrolio o casi simili. Questo è prima di tutto un conflitto umano tra due popoli che sono profondamente convinti di avere entrambi il diritto di vivere nello stesso piccolo territorio e preferibilmente in maniera esclusiva.
È ora, anche se tardi, di riconoscere il fatto che israeliani e palestinesi hanno la possibilità di vivere o insieme, o uno accanto all’altro, ma non negandosi. La decisione presa ieri da 138 Paesi è forse l’ultima opportunità per dare vita al progetto di due Stati indipendenti, sicuri, ognuno con un proprio territorio continuo e non frammentato. Forse è il destino o la giustizia del tempo che dà oggi ai palestinesi la possibilità di iniziare un processo verso l’indipendenza in maniera identica a quelli che furono gli esordi dello Stato israeliano.
È il momento giusto anche per le riconciliazioni interne, essenziali per risolvere la situazione, a partire da quella tra Hamas e Fatah, riconciliazioni necessarie per avere un’unica posizione e direzione politica.
D’altra parte è un errore pensare, come spesso accade, che sia meglio avere di fronte a sé un nemico diviso; per questo, anche per Israele è meglio che i palestinesi siano politicamente uniti. Sono altresì cosciente che i palestinesi non accetteranno mai una soluzione ideologica al conflitto, perché la loro storia è diversa e dovrebbe essere lo Stato d’Israele a cercare una soluzione pragmatica.
Credo infine che gli ebrei abbiano un diritto storico-religioso di vivere nella regione ma non in forma esclusiva. Dopo la crudeltà europea verso il popolo ebraico nel ventesimo secolo ci sarebbe la necessità di aiutarlo ora con i suoi problemi per il futuro e non solo riconoscendo le responsabilità del passato.
Sono commosso dalla quantità di nazioni che hanno votato a favore della risoluzione; mentre mi rattrista la posizione assunta dal governo israeliano, che mi sembra poco lungimirante nel non cogliere le opportunità che si offrono per un futuro migliore, e degli Stati Uniti, l’unico Paese in grado di far pesare la propria influenza. Mi riempie di felicità che l’Italia, dove trascorro diversi mesi l’anno in qualità di Direttore Musicale del Teatro alla Scala, abbia votato a favore di una speranza per tutti i popoli della regione.
-
> ISRAELE --- LA RAPPRESAGLIA. Israele "trattiene" le tasse dei palestinesi. Ue a Netanyahu: "Stop a nuovi insediamenti"2 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Israele "trattiene" le tasse dei palestinesi.
Israele "trattiene" le tasse dei palestinesi.
 Ue a Netanyahu: "Stop a nuovi insediamenti"
Ue a Netanyahu: "Stop a nuovi insediamenti"La ritorsione del governo di Tel Aviv che respinge la decisione dell’Onu sul riconoscimento dello stato palestinese. I fondi dovevano essere girati all’Anp in base agli accordi di Parigi. Il premier insiste: "Continueremo a costruire ovunque ci siano nostri interessi strategici in ballo". Mazen: "Nei prossimi giorni verranno fatti dei passi per la riunificazione di tutte le altre fazioni fazioni palestinesi" *
GERUSALEMME - Il governo israeliano all’unanimità ha respinto la risoluzione approvata dall’Onu che accredita la Palestina come Stato-non membro dell’organizzazione. In una nota ufficiale, il governo - che si è riunito oggi a Gerusalemme - sostiene che "il popolo ebraico ha un naturale, storico e legale diritto nei confronti della sua terra natale e di Gerusalemme come sua capitale. La risoluzione non servirà come base per futuri negoziati né fornisce una via per una soluzione pacifica".
La rappresaglia. Non è l’unica decisione destinata a pesare sulla tregua e in generale sui rapporti fra Israele e il governo palestinese. Per rappresaglia rispetto alla decisione dell’Assemblea generale dell’Onu, Tel Aviv infatti ha annunciato il blocco del trasferimento delle tasse raccolte da Israele per l’Autorità nazionale palestinese. Si tratta di 460 milioni di shekels (circa 92 milioni di euro), che dovevano essere trasferiti questo mese all’Anp. La risoluzione è stata approvata dalla riunione domenicale del governo israeliano, che ha inoltre precisato che non avvierà nessun negoziato sulla base del riconoscimento dei territori di Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza in un unico stato palestinese.
Ogni mese, sulla base dei Protocolli stabiliti a Parigi nel 1994, Israele trasferisce decine di milioni di euro derivanti dalle tasse destinate ai mercati palestinesi e fatte passare dai porti israeliani. Il ministro delle finanze israeliano, Yuval Steinitz, ha spiegato invece che il governo utilizzerà gli introiti della nuova tassa per pagare il debito degli stessi palestinesi con Israel Electric Corp., per le forniture di energia, ed altri organismi israeliani.
Si tratta del secondo atto di rappresaglia, dopo l’annuncio della costruzione di tremila nuove case negli insediamenti dei coloni. Su questo punto è tornato oggi il premier Benyamin Netanyahu, rincarando la dose: "Israele continuerà a costruire a Gerusalemme - ha detto il premier - e in ogni luogo della mappa degli interessi strategici dello stato di Israele". Secondo l’agenzia Ynet, Netanyahu ha anche sottolineato che "la mossa unilaterale dell’Autorità palestinese all’Onu è un’impudente violazione degli accordi firmati": "Uno stato palestinese - afferma il capo del governo - non sarà stabilito senza un connesso accordo sulla sicurezza dei cittadini israeliani e prima che l’Autorità palestinese riconosca Israele come stato del popolo ebraico e dichiari la fine del conflitto".
Mazen: "Riconciliare le fazioni palestinesi". In un clima sempre più teso, Abu Mazen ricorda quanto sia necessaria una riconciliazione nazionale. "La riconciliazione nazionale è necessaria per raggiungere la liberazione dell’occupazione israeliana", ha detto Mazen nel suo discorso alla folla davanti la Muqata. "Nei prossimi giorni - ha aggiunto - verranno fatti dei passi per la riunificazione di tutte le altre fazioni fazioni palestinesi".
Intanto l’annuncio dei nuovi insediamenti nei Territori ha provocato reazioni preoccupate da parte della comunità internazionale. Il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, ha esortato Israele a retrocedere dai suoi piani per la costruzione di 3.000 nuovi alloggi a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, in quanto rappresentano un "ostacolo alla pace". "L’Ue ha ripetutamente affermato che l’espansione degli insediamenti è illegale secondo il diritto internazionale", ha detto Ashton che ha chiesto al governo israeliano di "mostrare il suo impegno per una ripresa dei negoziati di pace non perseguendo questo progetto".
L’annuncio dei nuovi alloggi negli insediamenti è "uno schiaffo in faccia" al presidente americano Barack Obama. Lo ha detto l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert, parlando a Washington al Saban Forum, un centro di dibattito sul Medio Oriente. Olmert ha affermato che il governo americano ha dato prova di amicizia a Israele votando contro il riconoscimento della Palestina. E Israele ha mostrato la sua "gratitudine" a Obama con lo "schiaffo" dei nuovi insediamenti.
* la Repubblica, 02 dicembre 2012
-
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO ---- ONU: VOTO STORICO.La Palestina diventa Stato «osservatore» dell’Onu. Il suo rango viene elevato a quello di altri Stati, come il Vaticano e la Svizzera.29 novembre 2012, di Federico La Sala
29/11/2012
 medioriente - voto storico
medioriente - voto storico
 La Palestina diventa “Stato”
La Palestina diventa “Stato”
 All’Onu anche l’Italia dice sì
All’Onu anche l’Italia dice sì
 Ira di Israele: “Molto delusi”
Ira di Israele: “Molto delusi” Arriva il via libera alla risoluzione
Arriva il via libera alla risoluzione
 L’Ue divisa, la Germania si astiene
L’Ue divisa, la Germania si astiene
 Netanyahu frena: non cambia nulla *
Netanyahu frena: non cambia nulla *new york
La Palestina diventa Stato «osservatore» dell’Onu. Il suo rango viene elevato a quello di altri Stati, come il Vaticano e la Svizzera. Esattamente 65 anni dopo il voto sulla spartizione della Terra Santa in due Stati (era il 29 novembre del 1947, e persino un giovedì) l’Assemblea generale delle Nazioni Unite si rende dunque protagonista di un’altra giornata storica, approvando una risoluzione che il presidente dell’Anp Abu Mazen ha voluto con forza. E che i vertici dell’Autorità nazionale palestinese considerano solo un primo passo verso la nascita di un vero e proprio Stato e verso il riconoscimento della Palestina come Paese membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.
LA VITTORIA DI ABU MAZEN
Per Abu Mazen si tratta di una enorme vittoria diplomatica, che lo rafforza anche sul fronte interno e nei confronti di Hamas. Mentre il sì alla Palestina da parte dell’Assemblea Onu consegna alla storia un mondo occidentale spaccato, diviso: con gli Stati Uniti al fianco di Israele nel dire “no” al riconoscimento della Palestina come Stato “osservatore” e i Paesi europei in ordine sparso, incapaci di parlare con una sola voce e di raggiungere una posizione comune. Posizione che aveva auspicato l’Italia, a cui fino all’ultimo ha lavorato la diplomazia del nostro Paese, che alla fine ha optato a favore della risoluzione insieme a Francia, Spagna e molti altri Stati della Ue. Provocando la reazione dell’ambasciata israeliana a Roma che parla di «delusione». Altri Stati europei, come Germania e Regno Unito, hanno optato per l’astensione. Ma dietro il sì italiano, c’è la scelta di Monti per un’Unione Europea più coesa.
TENSIONE IN MEDIORIENTE
Nei Territori i palestinesi sono in festa. Quello che conta oggi è lo storico riconoscimento, votato dai due terzi della comunità internazionale. Questo nonostante il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, a poche ore dal voto sia tornato a ribadire con forza che la decisione dell’Assemblea delle Nazioni Unite «non avvicinerà la costituzione di uno Stato della Palestina. Anzi - ha sottolineato - l’allontanerà». Per gli israeliani infatti (e in questo l’appoggio di Washington è pieno) un vero e proprio Stato palestinese che viva in pace e sicurezza accanto ad Israele può scaturire solo da un negoziato che porti a un definitivo e duraturo accordo di pace. Netanyahu, quindi, assicura come il voto all’Onu di fatto non cambi nulla: «Non sarà costituito uno Stato palestinese senza il riconoscimento di Israele come Stato del popolo ebraico, senza la proclamazione della fine del conflitto e senza misure di sicurezza reali che difendano lo Stato di Israele e i suoi abitanti».
COSA CAMBIA
Da domani però qualcosa cambia. E il neo “Stato palestinese”, per esempio, avrà accesso a molti trattati e organizzazioni internazionali che finora le erano preclusi. A partire dalla Corte penale internazionale, davanti alla quale i palestinesi potrebbero decidere di portare Israele per denunciare la questione dei Territori Occupati. Questo uno dei timori più grandi degli israeliani e di molti altri Paesi, anche se i vertici dell’Anp hanno assicurato che non compiranno tale passo automaticamente: dipenderà dalla politica che Israele deciderà di portare avanti sul fronte degli insediamenti.
IL PROCESSO DI PACE
Intanto Abu Mazen guarda già alla prossima sfida, questa sì impossibile e simbolica: il sì alla Palestina Stato membro dell’Onu da parte del Consiglio di sicurezza. Una mossa già tentata dal presidente dell’Anp ma che si è inevitabilmente scontrata con il veto degli Stati Uniti. L’auspicio di tutti, però, è che dalla storica giornata al Palazzo di Vetro nasca una nuova spinta verso il dialogo. In questo senso il segretario generale dell’Onu, Ban ki-Moon ha lanciato un chiaro appello a israeliani e palestinesi: «È giunta l’ora di rianimare il processo di pace». Un processo di pace in stallo da troppo tempo.
*La Stampa, 29/11/2012
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- PALESTINA.Oggi la decisione alle Nazioni Unite... un voto simbolico che, non solo per i palestinesi, ma anche obiettivamente per gli israeliani, è un segnale di giustizia (di Bernardo Valli).29 novembre 2012, di Federico La Sala
Oggi la decisione alle Nazioni Unite
di Bernardo Valli (la Repubblica, 29 novembre 2012)
C’È MOLTO di surreale e di tragico nel rito che l’Assemblea generale dell’Onu si appresta a compiere nelle prossime ore. È scontato che una cospicua maggioranza del vasto campionario mondiale raccolto nel Palazzo di Vetro si pronunci in favore della promozione della Palestina da semplice organismo osservatore a Stato osservatore; ed è altrettanto scontato che la Palestina continui poi a essere l’entità territoriale militarmente occupata, qual è dal 1967; e che lo Stato tanto auspicato, promesso e temuto resti un miraggio.
In concreto, con i due tempi che scandiranno il rito dell’Onu, la Palestina passerà dallo strapuntino di semplice osservatore a un sedile riservato agli Stati che non lo sono sul serio. Il Vaticano, animato da altre ambizioni, se ne accontenta. Per la Palestina è una promozione piuttosto simbolica, anche se il voto dell’Assemblea generale ha in realtà un peso tutt’altro che insignificante, sul piano politico e morale. A dargli valore sono anche le promesse mancate. Quante volte è stato auspicato, annunciatoùuno Stato palestinese?
In questo senso il voto è una prima, timida riparazione. Denuncia l’incapacità di ieri e di oggi di chi conta nel mondo. Basta osservare come ci si è dati da fare nelle ultime ore per impedirlo. Ed è evidente l’angoscia dei paesi europei, il cui voto farà la differenza nella qualità del risultato. La loro scelta riguarda la giustizia, non solo la politica.
Surreale è senz’ altro la procedura e tragico il risultato se li si mette a confronto con le aspirazioni degli abitanti di quella Terra troppo santa e troppo contesa. Nell’autunno di un anno fa, Abu Mazen, presidente dell’Autorità palestinese, aveva chiesto che il suo paese, fino allora presente all’Onu con l’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina) nella veste di semplice osservatore, diventasse uno Stato membro a pieno titolo. Ma quel tentativo è fallito perché, dopo il voto dell’Assemblea generale spettava al Consiglio di Sicurezza decretare l’ammissione di uno Stato membro a pieno diritto, e gli Stati Uniti avrebbero posto il veto. Washington riteneva e ritiene infatti che si debba arrivare al riconoscimentodi uno Stato palestinese attraverso negoziati con Israele e non con «un colpo di mano» alle Nazioni Unite.
L’esigenza della Casa Bianca coincide con quella israeliana, e blocca la situazione, perché la società politica di Gerusalemme vive una stagione di grande intransigenza. La quale assomiglia a un rifiuto a vere trattative. Alla vigilia delle elezioni politiche, previste per gennaio, nel Likud, principale partito al governo, ha prevalso alle primarie la corrente meno incline a un autentico dialogo con i palestinesi.
Un anno dopo, Abu Mazen comunque ci riprova, ma con una richiesta meno impegnativa. All’Assemblea generale, dove il veto americano non conta, chiede appunto, oggi, che la Palestina sia promossa da entità osservatrice a Stato osservatore (e non a Stato membro, come richiesto nel 2011). Votare l’ammissione di un paese a quel titolo non significa riconoscere diplomaticamente lo Stato, e quindi dichiarare ambasciata la rappresentanza che i palestinesi hanno già in tante capitali.
All’interno delle Nazioni unite il nuovo status aprirebbe tuttavia a loro alcune porte. Ad esempio quella dell’Organizzazione mondiale della sanità o del Programma alimentare. Quella della Corte penale internazionale comporta più problemi, perché in quella sede i palestinesi potrebbero denunciare gli israeliani e quindi promuovere processi scomodi per lo Stato ebraico.
C’è stato un fitto andirivieni tra Washington, Gerusalemme e Ramallah, dove risiede Abu Mazen, per convincere quest’ultimo a impegnarsi su alcuni punti: in particolare a non ricorrere alla Corte Penale internazionale, quando ne avrà acquisito il diritto. In proposito americani e israeliani avrebbero ottenuto una vaga promessa: i palestinesi hanno detto che non usufruiranno di quella possibilità durante i primi sei mesi. Poi si vedrà.
Saeb Erekat, principale negoziatore palestinese, ha respinto un invito a Washington per evitare le pressioni americane. Quando nell’ottobre 2011 la Palestina fu ammessa all’Unesco come Stato membro, gli Stati Uniti sospesero i finanziamenti all’agenzia incaricata della cultura e dell’educazione. Finanziamenti pari a più del venti per cento del suo bilancio. Quali rappresaglie saranno adottate in questa occasione?
Gli israeliani ne hanno agitate parecchie: abrogazione degli accordi di Oslo del 1993, che regolano i rapporti tra Israele e l’Autorità palestinese; aumento degli insediamenti in Cisgiordania che contano già più di seicentomila coloni; confisca dei diritti di dogana; proibizione ai dirigenti palestinesi di uscire dalla Cisgiordania: ma di fronte alla tenacia di Abu Mazen il governo di Gerusalemme ha abbassato i toni. E non si parla più di sanzioni. Dice Yigal Palmor, portavoce del ministero degli esteri, che nulla accadrà se i palestinesi si accontenteranno di fare festa a Ramallah per celebrare la loro vittoria simbolica, e poi ritorneranno sul serio al tavolo dei negoziati. Ma Abu Mazen sa che non può andare a trattative alle condizioni poste dagli israeliani.
Il suo non è soltanto un confronto con Gerusalemme. La battaglia di Gaza, dove gli avversari palestinesi di Hamas celebrano la vittoria che si sono aggiudicati, ha ridotto il suo già scarso prestigio. Gli esaltati combattenti di Hamas considerano la moderazione Abu Mazen come una forma di collaborazionismo. L’iniziativa all’Onu è la sua battaglia incruenta. È l’offensiva politica dei palestinesi che rifiutano l’uso delle armi. Questo è un motivo per assecondarla. È vano condannare il terrorismo se poi non si tende la mano a chi lo rifiuta. Anche tra quelli di Hamas sono emerse in queste ore alcune voci in suo favore.
Il voto di New York interessa Gaza, dove si è imparato che le armi servono a sfogare la collera, a combattere i soprusi, ma non a risolvere i problemi. Alla vigilia dell’appuntamento di New York, Khaled Meshaal, uno dei leader (Mohammed Morsi, il presidente egiziano, l’ha voluto al suo fianco durante la crisi di Gaza) ha dato un pubblico appoggio a Abu Mazen. Lo ha fatto in aperta polemica con Ismail Haniye, il primo ministro. Entrata in società dopo un lungo isolamento, grazie agli alleati e ispiratori egiziani, i Fratelli musulmani al potere al Cairo, e lusingata dai gesti d’amicizia della Turchia di Erdogan, la gente di Gaza seguirà il voto all’Assemblea generale come se fosse una battaglia. L’esito potrebbe contribuire col tempo a demolire le mura del loro ghetto.Sugli europei incombe nelle prossime ore una grossa responsabilità.
Come al solito non sono riusciti a prendere una decisione comune. E quindi vanno dispersi al voto. Ma devono sapere che il loro parere contrario o anche una astensione, con l’inevitabile sapore di viltà, significherebbe una sconfitta per Abu Mazen, e in generale per i palestinesi che come lui rifiutano la violenza e ricorrono alla politica. Decine di ministri arabi visitano Gaza, dove si festeggia un’azione militare che ha appena fatto decine di morti, e migliaia nel passato.
È difficile per un europeo rifiutare, a un vecchio leader armato della sola parola, un voto simbolico che, non solo per i palestinesi, ma anche obiettivamente per gli israeliani, è un segnale di giustizia.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO --- Uri Avnery: "il nostro è uno Stato fondato sull’apartheid: un apartheid totale nei territori occupati e una apartheid crescente in Israele. Continuando così diventerà un regime di apartheid in tutto il territorio” (di Robert Fisk - Intervista).25 novembre 2012, di Federico La Sala
Uri Avnery
Il combattente della pace contro l’ “apartheid israeliano”
Pace e terra. Uri Avnery chiede chiedere uno Stato palestinese entro i vecchi confini del 1967
di Robert Fisk (il Fatto e The Independent 25.11.12)
- © The Independent Traduzione di Carlo Antonio Biscotto
Uri Avnery ha 89 anni, è un personaggio leggendario ed è ancora un combattente. Il famoso scrittore, pacifista e uomo politico di sinistra è tra i pochi che continua a chiedere con insistenza la pace con i palestinesi, con Hamas e uno Stato palestinese entro i vecchi confini del 1967. Avnery è più che mai convinto che Israele potrebbe firmare un trattato di pace domani o la prossima settimana. “È questa la disgrazia di essere un inguaribile ottimista”, commenta.
A guardarlo non è cambiato affatto da quando l’ho visto l’ultima volta, una trentina di anni, fa impegnato a giocare a scacchi con Yasser Arafat in mezzo alle rovine di Beirut. Oggi ha i capelli e la barba bianchi ma conserva la rabbia e il senso dell’umorismo di sempre.
Chiedo che stanno facendo Benjamin Netanyahu e il governo e quale era lo scopo di questo attacco a Gaza?
“Parti dal presupposto che sappiano quello che fanno e che vogliano la pace. Partendo da questo presupposto la loro politica appare stupida o folle. Ma se parti dal presupposto che a loro la pace non interessa affatto e che vogliono uno Stato ebraico che vada dal Mediterraneo al fiume Giordano, allora quel che fanno acquista un senso e diventa comprensibile. Il guaio è che ciò che fanno ci sta portando in un vicolo cieco. Abbiamo già uno Stato in tutta la Palestina storica: per tre quarti è lo Stato ebraico di Israele, per un quarto è costituito dai territori occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza”.
Uri Avnery parla scandendo le parole e con estrema chiarezza e lucidità.
“Se annettessero la Cisgiordania come hanno annesso Gerusalemme est, il risultato sarebbe più o meno lo stesso”, aggiunge. “Il problema è che nel territorio attualmente sotto la dominazione israeliana la popolazione è costituita per il 49% da ebrei e per il 51% da arabi. Lo squilibrio demografico è fatalmente destinato ad aumentare a favore degli arabi. Il problema è che al momento il nostro è uno Stato fondato sull’apartheid: un apartheid totale nei territori occupati e una apartheid crescente in Israele. Continuando così diventerà un regime di apartheid in tutto il territorio”.
Il ragionamento di Avnery è chiaro.
“Se agli arabi fossero concessi i diritti civili e politici, alla Knesset ci sarebbe una maggioranza araba che per prima cosa cambierebbe il nome del paese da Israele in Palestina. Certo nel 21° secolo la pulizia etnica di massa è impensabile. Ma la demografia è un dato di fatto”. Ma non si parla in Israele di questo tema? “No, c’è una sorta di rimozione collettiva. Nessun partito politico parla di questo problema e la parola “pace” non compare in alcun programma elettorale, forse con la parziale eccezione di Meretz”.
E LA SINISTRA ISRAELIANA?
“Sta in ibernazione. È stata uccisa da Ehud Barak nel 2000. Barak tornò da Camp David e ci raccontò che lui era il solo che voleva la pace, ma che non avevamo un interlocutore. Questo fu il colpo mortale. A dire queste parole non è stato Netanyahu, ma il leader del Partito Laburista. E così è morto il movimento Peace Now”.
Scuote la testa, riflette un attimo poi riprende a parlare riuscendo miracolosamente a recuperare un po’ del suo ottimismo: “quando nel 1982 incontrai Arafat le condizioni c’erano già tutte. La situazione oggi non è cambiata: uno Stato palestinese con la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme est come capitale accanto a uno Stato israeliano. Qualche piccola concessione territoriale e una soluzione simbolica al problema dei profughi. Ma questa soluzione - che è già matura da 30 anni - sta appassendo come un fiore come un fiore lasciato in un vaso senza acqua. È vero che abbiamo lasciato Gaza, ma solo per tenerci ben stretta la Cisgiordania”.
Avnery è convinto che Hamas accetterebbe queste condizioni.
“Quando nel 1993 ne parlai, in ebraico, nel corso di una conferenza a Gaza davanti a 500 esponenti dell’ala più radicale di Hamas, venni applaudito e invitato a pranzo”. Gli ricordo che lo statuto di Hamas non prevede la possibilità di una pace con Israele. “Parole, solo parole. Se si firmasse una tregua della durata di 50 anni andrebbe benissimo, al di là delle parole”.
Un’ultima cosa: come mai non c’è stata la temuta invasione di terra?
“Dobbiamo ringraziare e santificare Goldstone. È stato il suo rapporto sui crimini commessi a Gaza durante l’Operazione piombo fuso del 2008-2009 a dissuadere gli israeliani dall’invadere la Striscia”. Sono in molti in Israele ad augurarsi che Avnery viva ancora a lungo.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA .... ANTISEMITISMO. Fatti e opinioni (di Moni Ovadia)24 novembre 2012, di Federico La Sala
Antisemitismo Fatti e opinioni
di Moni Ovadia (l’Unità, 24 novembre 2012)
Il lettore di questo giornale sa che sono un suo collaboratore con una rubrica settimanale e con qualche altra rapsodica «incursione» che mi viene richiesta di tanto in tanto. Spesso approfitto dello spazio concessomi per scrivere di Medioriente e specificamente di conflitto israelo-palestinese (fatto).
Ogni volta che, sulla dolorosa questione, esprimo le mie idee strettamente personali e, ribadisco «strettamente personali» perché non rappresento nessuno, piovono contro di me le accuse di ebreo antisemita, nemico del popolo ebraico o traditore (opinioni). Questo avviene tramite mail, post e dichiarazioni su vari blog e siti inviatimi da fanatici, farabutti o sbroccati di varia risma (opinione). Alcune persone, sia amici che detrattori, ritengono che ciò che dico e penso, anche a causa della passione partecipante con cui mi esprimo, abbia un’influenza rilevante a causa della mia notorietà e che quindi dovrei essere cauto (opinione).
Io sostengo invece che ogni essere umano, in democrazia, sia libero di esprimere come meglio crede le sue idee (opinione) e se coloro che non le condividono o vi si oppongono ravvisano nei suoi discorsi i reati di istigazione all’odio o al razzismo, possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria per denunciarlo (fatto) in luogo di spargere vigliaccamente ripugnanti accuse protetti dalla libertà della rete (fatto).
Sono ebreo e, a mio modo, ho dedicato trent’anni e più della mia vita professionale e di studio, alla cultura ebraica della Diaspora in particolare quella yiddish (fatto). Ho contribuito alla diffusione dei suoi valori e della sua espressività nel mio Paese (fatto).
Antisemitismo è sottocultura dell’odio e della violenza contro gli ebrei (fatto) ed io ho sempre combattuto con tutte le mie forze quest’ideologia criminale come ebreo e come essere umano (fatto).
Ho invece criticato aspramente le politiche di molti governi israeliani (fatto). Esponenti istituzionali e della destra e dell’estrema destra e loro sostenitori in Israele e nella Diaspora, sostengono che chi professa posizioni politiche radicalmente avverse alla loro, sia antisemita tout court (opinione). Io penso invece che costoro siano fanatici, affetti da cortocircuiti psicopatologici o, peggio, siano dei fascisti (opinione).
Non ho mai messo in discussione il diritto di Israele all’esistenza, né la sua piena legittimità (fatto), in primis perché la proclamazione e la nascita dello Stato di Israele è stata sancita a grande maggioranza da una risoluzione dell’Onu (fatto) e io credo al valore della legalità internazionale pur riconoscendo gli enormi limiti che limitano l’efficacia dell’azione degli organismi preposti alla sua tutela (opinione). Altresì condivido l’assioma che non possa essere messo in discussione l’inviolabile diritto a tutelare la sicurezza dei propri cittadini per ogni nazione, nessuna esclusa (fatto).
Nethanyahu, Lieberman e i loro ultras invece praticano il credo che al governo israeliano sia sempre e comunque consentito violare il diritto internazionale (fatto). Condannano giustamente il lancio di razzi da parte di Hamas sulle città israeliane (fatto) e gli attentati terroristici (fatto), ma hanno trovato giusto blindare Gaza come in una gabbia con un blocco totale, compreso quello navale, glissando sulle convenzioni che considerano l’assedio un atto di guerra (fatto).
Praticano l’occupazione e la colonizzazione di terre dei palestinesi con ininterrotto accanimento (fatto), li espropriano dalle loro case a migliaia o le demoliscono (fatto), li cacciano dalle loro terre e gliele rubano (fatto), razionano loro l’acqua (fatto), praticano durante le operazioni militari stragi di civili e punizioni collettive che rendono un inferno la vita della popolazione inerme, in particolare quella dei bimbi (fatto), hanno instaurato un apartheid de facto e promuovono l’ «ebraizzazione» di Gerusalemme con continue requisizioni (fatto).
Questi sedicenti democratici promuovono, senza se e senza ma, questi abusi e criminalizzano chi li condanna con l’infamante calunnia di antisemita (opinione). Ma se stare dalla parte degli oppressi, dei discriminati, dei segregati, chiunque essi siano e chiunque sia l’oppressore è antisemitismo, allora sì, lo confesso, sono un ebreo antisemita (opinione e fatto).
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO ...FARE CHIAREZZA ---- Gaza non sei sola ma la politica EUROPEA ha dimenticato gli ESSERI UMANI (di Amina salina).21 novembre 2012, di Federico La Sala
Gaza non sei sola ma la politica EUROPEA ha dimenticato gli ESSERI UMANI
di amina salina *
Mentre un popolo inerme viene massacrato non da 6 giorni ma da anni con un pesante stillicidio di civili uccisi in modo vigliacco dall’esercito sionista, mentre oltre l’80 per cento del popolo israeliano appoggia questo genocidio, la stampa italiana come al solito mette sullo stesso piano aggressori ed aggrediti.
Nel silenzio tombale della classe politica impegnata a rimanere col deretano attaccato alla poltrona per altri 5 anni, Nichi Vendola ha fatto alcune dichiarazioni a favore dei palestinesi per una pace giusta e duratura.
Scrive sulla sua pagina di FB:«Anche oggi penso al cielo sopra Gaza. A quelle colonne di fumo che vorrebbero nascondere l’oscena contabilità delle "vittime collaterali". Mi dicono che il governo di Israele ipotizza a breve un’operazione di terra. Gaza è sola, anche oggi. Io credo che all’Europa dovrebbero ritirare il premio Nobel per la Pace. Non lo merita».
Sempre su FB era intervenuto dicendo "Ancora morti innocenti, ancora ’esecuzioni mirate’, contrarie a ogni convenzione internazionale e, soprattutto, ad ogni elemento di diritto. La polveriera del medio Oriente rischia di scoppiare. Per noi è fondamentale l’immediato cessate il fuoco e scongiurare il paventato intervento di terra, che porterebbe morte e distruzione in una popolazione civile stremata dall’isolamento imposto da Israele. Una "spedizione punitiva" verso i palestinesi di Gaza sarebbe un crimine inaudito. Chiediamo inoltre che cessi l’occupazione militare israeliana e che il governo italiano insieme all’Ue richieda l’apertura di un tavolo negoziale, per il riconoscimento dello stato di Palestina. Auspichiamo infine che il 29 novembre prossimo l’Onu riconosca con un voto lo status di osservatore per la Palestina".
Subito e arrivata la scomunica del portavoce della Comunita Ebraica che ha dichiarato la sua contrarietà al fatto che Vendola possa avere incarichi di Governo, mettendo un’ipoteca sul futuro Governo italiano.
Da oggi siamo una colonia di Tel Aviv, come se non bastassero gli americani ci si mettono anche i sionisti italiani. Tutto questo in un clima politico allucinante dove non solo in Italia, per fini bassamente elettorali e senza un minimo di etica, le persone non sono più di competenza della politica.
Gaza non è certamente sola contando sull’appoggio a livello mondiale delle masse islamiche di uomini e donne di tutto il mondo, ebrei compresi, e addirittura di rabbini che difendono il diritto all’esistenza ed alla resistenza del popolo palestinese, un popolo a tutt’oggi senza stato, senza una vera e propria autonomia, senza un esercito che si batte disperatamente per il diritto all’esistenza sulla sua terra.
Sono 60 anni che ogni giorno muoiono civili palestinesi che sono persone, esseri viventi e senzienti, non danni collaterali, mentre si parla di loro solo come terroristi, ignorando e tacendo quello che fa Israele ai danni non solo dei palestinesi ma anche degli attivisti pacifisti non di rado picchiati o espulsi, ai danni dei bambini detenuti contro ogni convenzione internazionale, all’uso della tortura eccetera.
L’Europa non ha una politica per il Medio Oriente, cosi come non ha una politica per la crisi poiché ormai le persone non sono più di competenza della politica. Il Nobel per la Pace dato all’UE non è altro che una gigantesca ipocrisia in quanto la pace in Europa e direttamente il frutto della guerra fuori d’Europa. Cosi come i paesi ricchi vivono dello sfruttamento bestiale dei paesi poveri, oltre che dello sfruttamento un po meno bestiale dei loro stessi cittadini ed immigrati poveri, cosi l’Europa vive del traffico di armi, di cui le potenze europee sono le maggiori produttrici. Armi che vengono vendute a chiunque in modo legale o illegale dai Governi come da altri loschi soggetti.
I governanti israeliani hanno impunemente usato un linguaggio irriferibile senza scandalo per le cancellerie europee, cosi sensibili alle offese di soggetti più deboli e meno protetti. Per capire che aria tira sentite il vice premier israeliano Eli Yishai. Secondo il ministro bisognerebbe distruggere «tutte le infrastrutture, comprese strade e fonti d’acqua».
In un’altra occasione disse che i musulmani erano «inferiori all’uomo bianco». Per il vice di Netanyahu, i non ebrei dovrebbero «prestare il loro lavoro sotto forma gratuita in appositi campi». Perché, «i non ebrei che scelgono di vivere in Israele devono in qualche modo ripagare il popolo ebraico di tanta generosità». Naturalmente nessuna solidarietà viene dall’Occidente per un Governo eletto dal popolo, quello di Ismail Hanyeh, colpevole di non aver accettato il genocidio del suo popolo, viene lasciato solo da coloro che dovremmo votare con poche lodevoli eccezioni. Ricordatevene ai seggi. Vergogna.
amina salina
* Il Dialogo, 21 Novembre 2012
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- ISRAELE E PALESTINA. LE CONSEGUENZE DLLA GUERRA21 novembre 2012, di Federico La Sala
Le conseguenze della guerra
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 21 novembre 2012)
Quando i conservatori israeliani se la prendono con ragionamenti troppo pacifisti, o con chi in patria critica la politica dell’occupazione, subito tirano in ballo l’Europa: «Questo è un tipico ragionamento ashkenazita; non ha alcun rapporto con il Medio Oriente!», dice ad esempio Moshe Yaalon, già capo dell’esercito, oggi vice premier, rispondendo al giornalista Ari Shavit in un libro appena edito da Haaretz (Does this mean war?).
L’ebreo ashkenazita ha radici in Germania e in Europa centrale, parla yiddish. E lo stereotipo non è diverso da quello usato ai tempi di Bush figlio: l’America è Marte e virile, il nostro continente è Venere e fugge la spada. L’ashkenazi tornò come altri ebrei in Terra Promessa, ma ha i riflessi della vecchia Europa. Lo storico Tom Segev racconta come erano trattati gli ebrei tedeschi, agli esordi. Li chiamavano yekke: erano ritenuti troppo remissivi, cervellotici, e poco pratici. L’Europa è icona negativa, e lo si può capire: ha idee sulla pace, ma in Medio Oriente è di regola una non-presenza, una non-potenza. Lo scettro decisivo sempre fu affidato all’America.
Tale è, per Yaalon, il vizio di chi biasima Netanyahu e gli rimprovera, in questi giorni, la guerra a Gaza e la tenace mancanza di iniziativa politica sulla questione palestinese. Lo stereotipo dell’ashkenazita mente, perché ci sono ashkenaziti di destra e sinistra. Era ashkenazita Golda Meir. Sono ashkenaziti David Grossman, Uri Avnery, Amira Hass, pacifisti, e espansionisti come Natan Sharansky. Ma lo stereotipo dice qualcosa su noi europei, che vale la pena meditare. Nel continente dove gli ebrei furono liquidati siamo prodighi di commemorazioni contrite, avari di senso di responsabilità per quello che accade in Israele. Predicando soltanto, siamo invisi e inascoltati.
Eppure l’Europa avrebbe cose anche pratiche da dire, sulle guerre infinite che i governi d’Israele conducono da decenni, sicuri nell’immediato di difendersi ma alla lunga distruggendosi. Ne ha l’esperienza, e per questo le ha a un certo punto terminate, unendo prima i beni strategici tedeschi e francesi (carbone, acciaio) poi creando un’unione di Stati a sovranità condivisa.
Le risorse mediorientali sono quelle acquifere in Cisgiordania, gestite dall’occupante e assegnate per l’83% a Israele e colonie. Tanto più l’Europa può contare, oggi che l’America di Obama è stanca di mediazioni fallite. È stato quasi un colpo di fucile, l’articolo che Thomas Friedman, sostenitore d’Israele, ha scritto il 10 novembre sul New York Times: provate la pace da soli, ha detto, poiché «non siamo più l’America dei vostri nonni». Non potremo più attivarci per voi: «Il mio Presidente è occupato-My President is busy». Anche gli ebrei Usa stanno allontanandosi da Israele.
È forse il motivo per cui pochi credono che l’offensiva si protrarrà, ripetendo il disastro che fu l’Operazione Piombo Fuso nel 2008-2009. Ma guerra resta, cioè surrogato della politica, e solo all’inizio la vulnerabilità di Israele scema. Troppo densamente popolata è Gaza, perché un attacco risparmi i civili e non semini odio. Troppo opachi sono gli obiettivi. Per alcuni il bersaglio è l’Iran, che ha dato a Hamas missili per raggiungere Tel Aviv e che ha spinto per la moltiplicazione di lanci di razzi su Israele. Per altri la guerra è invece propaganda: favorirà Netanyahu alle elezioni del 22 gennaio 2013.
Altro è il male di cui soffre Israele, e che lo sfibra, e che gli impedisce di immaginare uno Stato palestinese nascente. Un male evidente, anche se ci s’incaponisce a negarlo. Sono ormai 45 anni - dalla guerra dei sei giorni - che la potenza nucleare israeliana occupa illegalmente territori non suoi, e anche quest’incaponimento ricorda i vecchi nazionismi europei.
Nel 2006 i coloni sono stati evacuati da Gaza, ma i palestinesi vi esercitano una sovranità finta (una sovranità morbida, disse Bush padre, come nella Germania postbellica). Il controllo dei cieli, del mare, delle porte d’ingresso e d’uscita, resta israeliano (a esclusione del Rafah Crossing, custodito con l’Egitto e, fino alla vittoria di Hamas, con l’Unione europea). Manca ogni continuità territoriale fra Cisgiordania (la parte più grande della Palestina, 5.860 km²; 2,16 milioni di abitanti) e Gaza (360 km²; 1,6 milioni). I palestinesi possono almeno sperare nella West Bank? Nulla di più incerto, se solo si contempla la mappa degli insediamenti in aumento incessante (350.000 israeliani, circa 200 colonie). Nessun cervello che ragioni può figurarsi uno Stato palestinese operativo, stracolmo di enclave israeliane.
Se poi l’occhio dalle mappe si sposta sul terreno, vedrà sciagure ancora maggiori: il muro che protegge le terre annesse attorno a Gerusalemme, le postazioni bellicose in Cisgiordania, le strade di scorrimento rapido riservate agli israeliani, non ai palestinesi che si muovono ben più lenti su vie più lunghe e tortuose. Un’architettura dell’occupazione che trasforma le colonie in dispositivi di controllo (in panoptikon), spiega l’architetto Eyal Weizman.
È urgente guardare in faccia queste verità, scrive Friedman, prima che la democrazia israeliana ne muoia. Forse è anche giunto il tempo di pensare l’impensabile, e chiedersi: può un arabo israeliano (1.5 milioni, più del 20% della popolazione) riconoscersi alla lunga in un inno nazionale (Hatikvah) che canta la Terra Promessa ridata agli ebrei, o nella stella di Davide sulla bandiera? Potrà dire senza tema: sono cittadino dello Stato d’Israele, non di quello ebraico?
Questo significa che anche per Israele è tempo di risveglio. Di una sconfitta del nazionalismo, prima che essa sia letale. Separando patria e religione nazionale, la pace è supremo atto laico. Risvegliarsi vuol dire riconoscere i guasti democratici nati dall’occupazione. Le menti più acute di Israele li indicano da anni. Ari Shavit evoca i patti convenienti con Bush figlio, gli evangelicali Usa, il Tea Party: «Patrocinato dalla destra radicale Usa, Israele può condurre una politica radicale e di destra senza pagare alcun prezzo». Può sprezzare le proprie minoranze, tollerare i vandalismi dei coloni contro palestinesi e attivisti pacifisti.
David Grossman ha scritto una lettera aperta a Netanyahu: l’accusa è di perdere ogni occasione per far politica anziché guerre (Repubblica, 6 novembre 2012). L’ultima occasione persa è l’intervista di Mahmoud Abbas alla tv israeliana, l’1 novembre: il capo dell’Autorità palestinese si dice disposto a tornare come turista a Safad (la città dov’è nato a nord di Israele). «Nelle sue parole - così Grossman - era discernibile la più esplicita rinuncia al diritto del ritorno che un leader arabo possa esprimere in un momento come questo, prima dei negoziati». Abbas s’è corretto, il 4 novembre: la volontà di chiedere all’Onu il riconoscimento dell’indipendenza aveva irritato Netanyahu, e Obama di conseguenza ha sconsigliato Abbas. Quattro giorni dopo, iniziava a Gaza l’operazione «Pilastro della Difesa».
L’abitudine alla guerra indurisce chi la contrae, sciupa la democrazia. In Israele, allarga il fossato tra arabi e ebrei, religiosi e laici. Vincono gli integralisti, secondo lo scrittore Sefi Rachlevsky che delinea così il volto della prossima legislatura: una coalizione fra Netanyahu, i nazionalisti di Yisrael Beiteinu, e ben quattro partiti che vogliono - come l’Islam politico - il primato della legge ebraica (halakha) sulle leggi dello Stato. In tal caso non si tornerebbe solo alle guerre nazionaliste europee, ma alle più antiche guerre di religione. Stupefacente imitazione, per un paese dove l’Europa è sì cattivo esempio.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER NETANYAHU E I SUOI GENERALI (di Piergiorgio Odifreddi - Dieci volte peggio dei nazisti)20 novembre 2012, di Federico La Sala
Dieci volte peggio dei nazisti (18) *
di Piergiorgio Odifreddi
Uno dei crimini più efferati dell’occupazione nazista in Italia fu la strage delle Fosse Ardeatine. Il 24 maggio 1944 i tedeschi “giustiziarono”, secondo il loro rudimentale concetto di giustizia, 335 italiani in rappresaglia per l’attentato di via Rasella compiuto dalla resistenza partigiana il 23 maggio, nel quale avevano perso la vita 32 militari delle truppe di occupazione. A istituire la versione moderna della “legge del taglione”, che sostituiva la proporzione uno a uno del motto “occhio per occhio, dente per dente” con una proporzione di dieci a uno, fu Hitler in persona.
Il feldmaresciallo Albert Kesselring trasmise l’ordine a Herbert Kappler, l’ufficiale delle SS che si era già messo in luce l’anno prima, nell’ottobre del 1943, con il rastrellamento del ghetto di Roma. E quest’ultimo lo eseguì con un eccesso di zelo, aggiungendo di sua sponte 15 vittime al numero di 320 stabilito dal Fuehrer. Dopo la guerra Kesselring fu condannato a morte per l’eccidio, ma la pena fu commutata in ergastolo e scontata fino al 1952, quando il detenuto fu scarcerato per “motivi di salute” (tra virgolette, perché sopravvisse altri otto anni). Anche Kappler e il suo aiutante Erich Priebke furono condannati all’ergastolo. Il primo riuscì a evadere nel 1977, e morì pochi mesi dopo in Germania. Il secondo, catturato ed estradato solo nel 1995 in Argentina, è tuttora detenuto in semilibertà a Roma, nonostante sia ormai quasi centenario.
In questi giorni si sta compiendo in Israele l’ennesima replica della logica nazista delle Fosse Ardeatine. Con la scusa di contrastare gli “atti terroristici” della resistenza palestinese contro gli occupanti israeliani, il governo Netanyahu sta bombardando la striscia di Gaza e si appresta a invaderla con decine di migliaia di truppe. Il che d’altronde aveva già minacciato e deciso di fare a freddo, per punire l’Autorità Nazionale Palestinese di un crimine terribile: aver chiesto alle Nazioni Unite di esservi ammessa come membro osservatore! Cosa succederà durante l’invasione, è facilmente prevedibile. Durante l’operazione Piombo Fuso di fine 2008 e inizio 2009, infatti, compiuta con le stesse scuse e gli stessi fini, sono stati uccisi almeno 1400 palestinesi, secondo il rapporto delle Nazioni Unite, a fronte dei 15 morti israeliani provocati in otto anni (!) dai razzi di Hamas. Un rapporto di circa 241 cento a uno, dunque: dieci volte superiore a quello della strage delle Fosse Ardeatine. Naturalmente, l’eccidio di quattro anni fa non è che uno dei tanti perpetrati dal governo e dall’esercito di occupazione israeliani nei territori palestinesi.
Ma a far condannare all’ergastolo Kesserling, Kappler e Priebke ne è bastato uno solo, e molto meno efferato: a quando dunque un tribunale internazionale per processare e condannare anche Netanyahu e i suoi generali?
Piergiorgio Odifreddi
*
 Repubblica cancella il post di Odifreddi su Israele. Lui lascia: “Meglio fermarsi”
Repubblica cancella il post di Odifreddi su Israele. Lui lascia: “Meglio fermarsi”- Il matematico aveva scritto parole dure sul conflitto in Medio Oriente accusando lo Stato ebraico di "logica nazista", ma il suo intervento è scomparso dopo 24 ore. Oggi il saluto ai lettori: "Continuare sarebbe un problema. D’ora in poi dovrei ogni volta domandarmi se ciò che penso o scrivo può non essere gradito a coloro che lo leggono"
 di Redazione (Il Fatto Quotidiano, 20 novembre 2012)
di Redazione (Il Fatto Quotidiano, 20 novembre 2012)Un post pubblicato domenica. Tema: il conflitto israelo-palestinese che in questi giorni sta vivendo un’altra pagina dai toni drammatici. Una presa di posizione molto dura nei confronti dello Stato ebraico, accusato di “logica nazista” nei confronti dei palestinesi. Ma la rimozione del suo intervento dal sito di Repubblica.it ha colto di sorpresa Piergiorgio Odifreddi (matematico, divulgatore scientifico, diventato noto anche per le sue posizioni critiche alla Chiesa cattolica). Ieri sera, infatti, il suo post nel blog “Il non senso della vita” non c’era più. Tanto è bastato, comunque, perché Odifreddi decidesse di scrivere un ultimo intervento, di commiato, per salutare i numerosi lettori che lo hanno seguito fin qui.
“Per 809 giorni Repubblica.it ha generosamente ospitato le mie riflessioni - scrive Odifreddi nel suo saluto - che spesso non coincidevano con la linea editoriale del giornale, e ha offerto loro l’invidiabile visibilità non solo del suo sito, ma anche di un richiamo speciale nella sezione Pubblico. Da parte mia, ho approfittato di questa ospitalità per parlare in libertà anche di temi scabrosi e non politically correct, che vertevano spesso su questioni controverse di scienza, filosofia, religione e politica. Naturalmente, sapevo bene che toccare temi sensibili poteva provocare la reazione pavloviana delle persone ipersensibili. Puntualmente, vari post hanno stimolato valanghe (centinaia, e a volte migliaia) di commenti, e aperto discussioni che hanno fatto di questo blog un gradito spazio di libertà. Altrettanto naturalmente, sapevo bene che la sponsorizzazione di Repubblica.it poteva riversare sul sito e sul giornale proteste direttamente proporzionali alla cattiva coscienza di chi si sentiva messo in discussione o criticato”.
“Immagino che il direttore del giornale e i curatori del sito abbiano spesso ricevuto lagnanze, molte delle quali probabilmente in latino - ammette - Ma devo riconoscere loro di non averne mai lasciato trasparire più che un vago sentore, e di aver sempre sposato la massima di Voltaire: ‘Detesto ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo’. Mai e sempre, fino a ieri, quando anche loro hanno dovuto soccombere di fronte ad altre lagnanze, questa volta sicuramente in ebraico”. Ma poi, ieri, la cancellazione del post che “non è, di per sé, un grande problema: soprattutto nell’era dell’informatica, quando tutto ciò che si mette in rete viene clonato e continua comunque a esistere e circolare. Non è neppure un grande problema il fatto che una parte della comunità ebraica italiana non condivida le opinioni su Israele espresse non soltanto da José Saramago e Noam Chomsky, al cui insegnamento immodestamente mi ispiro, ma anche e soprattutto dai molti cittadini israeliani democratici che non approvano la politica del loro governo, ai quali vanno la mia ammirazione e la mia solidarietà”.
“Il problema, piccolo e puramente individuale, è che se continuassi a tenere il blog, d’ora in poi dovrei ogni volta domandarmi se ciò che penso o scrivo può non essere gradito a coloro che lo leggono: qualunque lingua, viva o morta, essi usino per protestare - Dovrei, cioè, diventare ‘passivamente responsabile’, per evitare di non procurare guai. Ma poiché per natura io mi sento ‘attivamente irresponsabile’, nel senso in cui Richard Feynman dichiarava di sentirsi in Il piacere di trovare le cose, preferisco fermarmi qui”. “Tenere questo blog è stata una bella esperienza, di pensiero e di vita, e ringrazio non solo coloro che l’hanno ospitato e difeso, ma anche e soprattutto coloro che vi hanno partecipato - conclude Odifreddi - La vita, con o senza senso, continua. Ma ci sono momenti in cui, candidamente, bisogna ritirarsi a coltivare il proprio giardino”.
Ma la scomparsa improvvisa del post aveva scatenato proprio i frequentatori più assidui del blog di Odifreddi che, utilizzando lo spazio del suo articolo precedente, non solo hanno chiesto insistentemente al matematico come mai quel testo fosse stato rimosso, ma lo hanno copiato e incollato a beneficio di chi non l’avesse letto. A quel punto, certo, si è sviluppato il dibattito tra chi è d’accordo con la tesi di Odifreddi e chi non lo è.
D’altronde l’intervento in un blog non riflette la linea editoriale del giornale, che del resto nei casi più controversi - come potrebbe essere questo - può scegliere di pubblicare due interventi in antitesi (l’uno che intende confutare l’altro), davanti ai quali i lettori possono confrontarsi.
* Il Fatto quotidiano, 20 novembre 2012
-
> ISRAELE... FARE CHIAREZZA ---- Il governo non è un paese (di Furio Colombo) - Gli errori non vanno taciuti mai (di Vauro Sanesi) - I frutti della guerra (di Barbara Spinelli)21 novembre 2012, di Federico La Sala
Israele/1
Critiche no
Il governo non è un paese
di Furio Colombo (il Fatto, 21.11.2012)
Si può parlar male di Israele? Per rispondere dirò che questo è il destino riservato a Israele: molto prima di decidere sulla portata delle sue azioni e l’eventuale gravità dei suoi errori, bisogna decidere se Israele è un Paese normale. L’Italia, ad esempio, è un Paese normale. Eppure ha distrutto intere popolazioni etiopiche e somale con gas asfissianti, ha spossessato e perseguitato i nostri vicini croati e sloveni che vivevano a Trieste, tormentandoli ed eliminandoli fino alla nostra sconfitta; ha scritto con cura, approvato all’unanimità ed eseguito con fervore le leggi razziali, mandando a morte migliaia di famiglie italiane ebree, compresi i bambini, tutti quelli che hanno potuto trovare.
La Cina, ai nostri giorni è un Paese normale, proprio mentre è intento a distruggere il Tibet, a perseguitare le popolazioni cinesi islamiche (Uiguri) e a stroncare con carcere e morte l’ostinata diversità del vasto gruppo Falun gong.
I Paesi normali possono, a volte, essere rimproverati o ammoniti per i loro comportamenti nel passato o nel presente, ma la discussione su di loro avviene (persino per il Ruanda che aveva provocato un milione di morti e due milioni di profughi) partendo da due punti base.
Uno: un governo non è un Paese, e infatti molti di noi non hanno mai accettato che Berlusconi fosse l’Italia.
DUE: OGNI VOLTA che si richiama il nazismo come chiave di analogia, spiegazione e confronto, si chiamano in causa le vittime, dunque gli ebrei. È il momento in cui, agli occhi degli accusatori, diventano i carnefici. Certo, solo alcuni folli neo-nazisti aggiungeranno la bieca frase “vedi? Non ne hanno fatti fuori abbastanza”. Ma il senso pesa due volte. Primo, il legame ebrei-nazisti diventa, allo stesso tempo, reversibile e ferreo, un destino legato all’altro e la condanna a rifare lo stesso ignobile gioco. Secondo, senza gli ebrei, che diventano i nazisti che li hanno per-seguitati, i palestinesi vivrebbero liberi e felici.
Ogni riferimento ai Pashtun dell’Afghanistan, che sotto il nome di Taliban hanno fatto, fanno e faranno stragi di donne con la lapidazione, e di bambini, con l’immensa diffusione di mine antiuomo, è considerato fuori posto. I Taliban saranno pesanti da sopportare, ma non sono ebrei. Ecco dove e come le critiche a Israele (anche le più legittime) possono diventare uno strano discorso che porta al razzismo: quando si evoca il legame rovesciato vittima-carnefice, indicando per forza l’ebreo come protagonista negativo; quando, anche da persone certamente democratiche, si fa finta di credere che un governo sia un popolo e un Paese (come se David Grossman parlasse da Malta) ; quando si stabiliscono per Israele criteri di giudizio (dunque di condanna) che non si applicano mai a nessun altro Paese (eppure le atrocità nel mondo sono immense anche in questo momento) che non sia ebreo.
Israele/2
Critiche sì
Gli errori non vanno taciuti mai
di Vauro Sanesi (il Fatto, 21.11.2012)
Criticare Israele non solo si può, ma si deve. Critica aperta e libera alla politica israeliana di tutti questi anni sulla questione palestinese e anche riguardo al mancato rispetto di un’infinita serie storica di risoluzioni delle Nazioni Unite. Pare sempre in questi casi che lo Stato di Israele goda di una sorta di non dichiarato salvacondotto rispetto ai canoni minimi di legalità internazionale. Gli esempi sono un’infinità: dalla politica sulle colonie nei Territori Occupati, al bloccare - anche violentemente - in acque internazionali, dunque un atto di pura pirateria i membri militanti pacifisti (come è successo nel 2010 con la nave Mavi Marmara e le sue 9 vittime) che portano aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, all’uso di bombe al fosforo, come è successo durante la precedente operazione israeliana “Piombo fuso”. È un lungo elenco, non c’è forse bisogno di scriverle tutte, anche se la memoria non guasta mai.
La questione è che ogni critica a Israele viene equiparata a una recrudescenza di antisemitismo: non lo trovo soltanto desolante ma anche pericolosissimo. Perché, sempre facendo buon uso della memoria, va ricordato che l’antisemitismo ha portato a uno dei più grandi drammi del Novecento, la Shoah: allo stesso tempo, banalizzare questa tragedia trasformandola in un’occasione opportunistica per nascondere dietro a ciò qualsiasi scelta scellerata di un governo, come quello di Israele, rischia di far perdere ogni valenza storica, morale e attuale.
Il criticare Israele non solo è necessario per rompere il silenzio omertoso che da anni si fa intorno alle condizioni di vita dei palestinesi, ma anche per salvaguardare Israele stessa dalla deriva militarista e autoritaria che rischia di soffocare quel che di democratico c’è, ancora, nello Stato di Israele stesso.
I frutti della guerra
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 21.11.2012)
E lo stereotipo non è diverso da quello usato ai tempi di Bush figlio: l’America è Marte e virile, il nostro continente è Venere e fugge la spada. L’ashkenazi tornò come altri ebrei in Terra Promessa, ma ha i riflessi della vecchia Europa. Lo storico Tom Segev racconta come erano trattati gli ebrei tedeschi, agli esordi. Li chiamavano yekke: erano ritenuti troppo remissivi, cervellotici, e poco pratici. L’Europa è icona negativa, e lo si può capire: ha idee sulla pace, ma in Medio Oriente è di regola una non-presenza, una non-potenza. Lo scettro decisivo sempre fu affidato all’America.
Tale è, per Yaalon, il vizio di chi biasima Netanyahu e gli rimprovera, in questi giorni, la guerra a Gaza e la tenace mancanza di iniziativa politica sulla questione palestinese. Lo stereotipo dell’ashkenazita mente, perché ci sono ashkenaziti di destra e sinistra. Era ashkenazita Golda Meir. Sono ashkenaziti David Grossman, Uri Avnery, Amira Hass, pacifisti, e espansionisti come Natan Sharansky. Ma lo stereotipo dice qualcosa su noi europei, che vale la pena meditare. Nel continente dove gli ebrei furono liquidati siamo prodighi di commemorazioni contrite, avari di senso di responsabilità per quello che accade in Israele. Predicando soltanto, siamo invisi e inascoltati.
Eppure l’Europa avrebbe cose anche pratiche da dire, sulle guerre infinite che i governi d’Israele conducono da decenni, sicuri nell’immediato di difendersi ma alla lunga distruggendosi. Ne ha l’esperienza, e per questo le ha a un certo punto terminate, unendo prima i beni strategici tedeschi e francesi (carbone, acciaio) poi creando un’unione di Stati a sovranità condivisa.
Le risorse mediorientali sono quelle acquifere in Cisgiordania, gestite dall’occupante e assegnate per l’83% a Israele e colonie. Tanto più l’Europa può contare, oggi che l’America di Obama è stanca di mediazioni fallite. È stato quasi un colpo di fucile, l’articolo che Thomas Friedman, sostenitore d’Israele, ha scritto il 10 novembre sul New York Times: provate la pace da soli, ha detto, poiché «non siamo più l’America dei vostri nonni». Non potremo più attivarci per voi: «Il mio Presidente è occupato-My President is busy». Anche gli ebrei Usa stanno allontanandosi da Israele.
È forse il motivo per cui pochi credono che l’offensiva si protrarrà, ripetendo il disastro che fu l’Operazione Piombo Fuso nel 2008-2009. Ma guerra resta, cioè surrogato della politica, e solo all’inizio la vulnerabilità di Israele scema. Troppo densamente popolata è Gaza, perché un attacco risparmi i civili e non semini odio. Troppo opachi sono gli obiettivi. Per alcuni il bersaglio è l’Iran, che ha dato a Hamas missili per raggiungere Tel Aviv e che ha spinto per la moltiplicazione di lanci di razzi su Israele. Per altri la guerra è invece propaganda: favorirà Netanyahu alle elezioni del 22 gennaio 2013.
Altro è il male di cui soffre Israele, e che lo sfibra, e che gli impedisce di immaginare uno Stato palestinese nascente. Un male evidente, anche se ci s’incaponisce a negarlo. Sono ormai 45 anni - dalla guerra dei sei giorni - che la potenza nucleare israeliana occupa illegalmente territori non suoi, e anche quest’incaponimento ricorda i vecchi nazionismi europei. Nel 2006 i coloni sono stati evacuati da Gaza, ma i palestinesi vi esercitano una sovranità finta (una sovranità morbida, disse Bush padre, come nella Germania postbellica). Il controllo dei cieli, del mare, delle porte d’ingresso e d’uscita, resta israeliano (a esclusione del Rafah Crossing, custodito con l’Egitto e, fino alla vittoria di Hamas, con l’Unione europea). Manca ogni continuità territoriale fra Cisgiordania (la parte più grande della Palestina, 5.860 km²; 2,16 milioni di abitanti) e Gaza (360 km²; 1,6 milioni). I palestinesi possono almeno sperare nella West Bank? Nulla di più incerto, se solo si contempla la mappa degli insediamenti in aumento incessante (350.000 israeliani, circa 200 colonie). Nessun cervello che ragioni può figurarsi uno Stato palestinese operativo, stracolmo di enclave israeliane.
Se poi l’occhio dalle mappe si sposta sul terreno, vedrà sciagure ancora maggiori: il muro che protegge le terre annesse attorno a Gerusalemme, le postazioni bellicose in Cisgiordania, le strade di scorrimento rapido riservate agli israeliani, non ai palestinesi che si muovono ben più lenti su vie più lunghe e tortuose. Un’architettura dell’occupazione che trasforma le colonie in dispositivi di controllo (in panoptikon), spiega l’architetto Eyal Weizman. È urgente guardare in faccia queste verità, scrive Friedman, prima che la democrazia israeliana ne muoia. Forse è anche giunto il tempo di pensare l’impensabile, e chiedersi: può un arabo israeliano (1.5 milioni, più del 20% della popolazione) riconoscersi alla lunga in un inno nazionale (Hatikvah) che canta la Terra Promessa ridata agli ebrei, o nella stella di Davide sulla bandiera? Potrà dire senza tema: sono cittadino dello Stato d’Israele, non di quello ebraico?
Questo significa che anche per Israele è tempo di risveglio. Di una sconfitta del nazionalismo, prima che essa sia letale. Separando patria e religione nazionale, la pace è supremo atto laico. Risvegliarsi vuol dire riconoscere i guasti democratici nati dall’occupazione. Le menti più acute di Israele li indicano da anni. Ari Shavit evoca i patti convenienti con Bush figlio, gli evangelicali Usa, il Tea Party: «Patrocinato dalla destra radicale Usa, Israele può condurre una politica radicale e di destra senza pagare alcun prezzo». Può sprezzare le proprie minoranze, tollerare i vandalismi dei coloni contro palestinesi e attivisti pacifisti.
David Grossman ha scritto una lettera aperta a Netanyahu: l’accusa è di perdere ogni occasione per far politica anziché guerre ( Repubblica, 6 novembre 2012). L’ultima occasione persa è l’intervista di Mahmoud Abbas alla tv israeliana, l’1 novembre: il capo dell’Autorità palestinese si dice disposto a tornare come turista a Safad (la città dov’è nato a nord di Israele). «Nelle sue parole - così Grossman - era discernibile la più esplicita rinuncia al diritto del ritorno che un leader arabo possa esprimere in un momento come questo, prima dei negoziati». Abbas s’è corretto, il 4 novembre: la volontà di chiedere all’Onu il riconoscimento dell’indipendenza aveva irritato Netanyahu, e Obama di conseguenza ha sconsigliato Abbas. Quattro giorni dopo, iniziava a Gaza l’operazione «Pilastro della Difesa».
L’abitudine alla guerra indurisce chi la contrae, sciupa la democrazia. In Israele, allarga il fossato tra arabi e ebrei, religiosi e laici. Vincono gli integralisti, secondo lo scrittore Sefi Rachlevsky che delinea così il volto della prossima legislatura: una coalizione fra Netanyahu, i nazionalisti di Yisrael Beiteinu, e ben quattro partiti che vogliono - come l’Islam politico - il primato della legge ebraica (halakha) sulle leggi dello Stato. In tal caso non si tornerebbe solo alle guerre nazionaliste europee, ma alle più antiche guerre di religione. Stupefacente imitazione, per un paese dove l’Europa è sì cattivo esempio.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- Il governo di Bibi non solo ha fatto carne di porco dei valori ebraici ma insulta, intimidisce, perseguita coloro che con passione e disperazione, in Israele e in Diaspora, continuano a difenderli (di Moni Ovadia - Il terrorismo, la violenza e i valori di Bibi)25 agosto 2012, di Federico La Sala
Il terrorismo, la violenza e i valori di Bibi
di Moni Ovadia (l’Unità, 25 agosto 2012)
Il 19 agosto il quotidiano israeliano Ha’aretz, in un articolo a firma di Barak Ravid, ha riferito che il 16 un taxi palestinese ha preso fuoco nei territori occupati, nei pressi dell’insediamento israeliano di Bat Ayin, per il lancio di una bomba incendiaria da parte di alcuni coloni mentre viaggiava vicino al campo rifugiati di Al Arub che si trova vicino alla colonia israeliana. L’atto criminale ha provocato il ferimento grave di sei palestinesi appartenenti alla stessa famiglia.
L’articolo riferisce che il giorno dopo 4 giovani palestinesi sono stati aggrediti a Gerusalemme da una dozzina di loro coetanei israeliani, che secondo alcuni testimoni, giravano in cerca di palestinesi da pestare. Jamal Julani, una delle vittime dell’attacco, versa in serie condizioni. Julani, 17 anni, proveniente dal quartiere di Gerusalemme di Ras al Amud, è stato ammesso all’unità di terapia intensiva dell’ospedale universitario di Hadassah, Ein Karem.
Il vice primo ministro Moshe Aya’alon ha detto: «Gli attacchi dei coloni contro arabi nel West Bank e a Gerusalemme sono atti terroristici. I crimini di odio commessi nel weekend contro arabi in Giudea e Samaria (sic!) e a Gerusalemme sono oltraggiosi ed intollerabili e vanno affrontati con la massima fermezza». Ha poi soggiunto: «Questi attacchi terroristici sono contrari all’etica e ai valori ebraici e costituiscono un fallimento educativo e morale».
Ma di quale fallimento parla il ministro, e soprattutto di quale etica e di quali valori. Quali sarebbero i valori ebraici del governo di Bibi? L’occupazione di terre altrui? La colonizzazione perversa capillare ed inarrestabile di terre espropriate contro tutte le norme della legalità internazionale? Lo sradicamento di migliaia di ulivi? Il razionamento dell’acqua? La demolizione sistematica di case palestinesi? La costruzione di una prigione a cielo aperto? Il disprezzo razzista per chi chiede i propri diritti di popolo? L’apartheid de facto? Il muro della vergogna?
Questi non sono valori ebraici, sono i valori barbari di un nazionalismo fanatico e ottuso. Il governo di Bibi non solo ha fatto carne di porco dei valori ebraici ma insulta, intimidisce, perseguita coloro che con passione e disperazione, in Israele e in Diaspora, continuano a difenderli
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- L’arsenale nucleare d’Israele? Parla tedesco.Un terzo della spesa a carico di Berlino all’insaputa dei cittadini (di Marina Mastroluca)4 giugno 2012
 L’arsenale nucleare d’Israele? Parla tedesco
L’arsenale nucleare d’Israele? Parla tedesco
 Lo Spiegel: atomiche montate sui sottomarini forniti a Tel Aviv
Lo Spiegel: atomiche montate sui sottomarini forniti a Tel Aviv
 Un terzo della spesa a carico di Berlino all’insaputa dei cittadini
Un terzo della spesa a carico di Berlino all’insaputa dei cittadini di Marina Mastroluca (l’Unità, 04.06.2012)
di Marina Mastroluca (l’Unità, 04.06.2012)Israele installa missili nucleari sui sottomarini forniti dalla Germania. Apparentemente non è una notizia: è dalla fine degli anni ‘90 che senza mai una vera e propria conferma ufficiale da parte di Tel Aviv la storia circola sulle stampa internazionale. Ma l’inchiesta oggi in edicola sullo Spiegel è di quelle destinate a far montare la polemica. Perché Israele piazza missili nucleari sui sottomarini che Berlino ha costruito, in larga parte finanziato e per il resto venduto a condizioni agevolate. E il governo tedesco lo ha sempre saputo.
«La Germania anticipa lo Spiegel sta aiutando Israele a sviluppare le sue capacità nucleari militari», a dispetto di quanto ha finora sostenuto. E i contribuenti tedeschi danno una mano a loro insaputa. Non stupisce che il ministro della Difesa israeliano Ehud Barak dichiari al settimanale che «i tedeschi possono essere fieri di aver garantito per molti anni l’esistenza dello Stato di Israele».
U-BOOT E INSEDIAMENTI
«Operazione segreta Sansone», il titolo di copertina dello Spiegel mostra il volto di Angela Merkel e quello di Netanyahu, sullo sfondo azzurrino con la sagoma di un U-Boot. Il settimanale, che ha dedicato mesi all’inchiesta, ha raccolto le testimonianze dell’ex sottosegretario alla Difesa, Lothar Ruehl, e dell’ex responsabile dell’Ufficio di coordinamento, Hans Ruehle. Entrambi hanno spiegato al settimanale di Amburgo di aver dato per scontato che Israele avrebbe montato missili nucleari sui sommergibili costruiti nei cantieri di Kiel.
Israele ha sempre mantenuto un assoluto riserbo sulle proprie capacità nucleari, lasciando tuttavia intendere di essere in possesso di un arsenale che non avrebbe difficoltà ad utilizzare. E secondo lo Spiegel, la Germania sapeva dei programmi nucleari israeliani sin dal 1961. L’ultima occasione documentata in cui la questione è stata sollevata tra i due governi risalirebbe al 1977, quando l’allora cancelliere Helmut Schmidt ne parlò con il ministro degli esteri israeliano Moshe Dayan.
Eppure da quando, dopo la prima Guerra del Golfo, Berlino ha fornito a titolo gratuito i primi due sottomarini ad Israele, i governi tedeschi sono stati estremamente vaghi sul possibile impiego di armi nucleari a bordo. Quando la questione è stata sollevata al Bundestag, in particolare perché i sommergibili erano dotati di tubi lanciasiluri da 650 millimetri compatibili con l’impiego di testate nucleari la risposta è stata che non se ne conosceva la ragione visto che la progettazione era su disegno israeliano.
Finora dai cantieri «Howaldtswerke» sono usciti tre sommergibili già consegnati allo Stato ebraico e segnalati in passato tra il Mediterraneo e il Mar Rosso, da dove facilmente possono tenere sotto tiro l’Iran (che anche ieri ha proferito nuove minacce contro Israele). A bordo secondo quanto rivelato già nel 2003 da ufficiali Usa e israeliani avrebbero la possibilità di alloggiare missili da crociera a lungo raggio, i Popeye Turbo, capaci di colpire fino a 1500 chilometri. Altri tre sottomarini, più grandi e di nuova concezione, verranno forniti dalla Germania entro il 2017. La nuova serie, denominata U-212, è più veloce e silenziosa, più difficile da individuare e dotata di un finora segreto sistema di espulsione dei missili.
Il primo sottomarino di questa seconda serie è già stato consegnato all’inizio dello scorso maggio: si tratta della nave Tanin, coccodrillo in ebraico. E dopo qualche difficoltà a chiudere l’accordo, il governo tedesco ha di recente firmato il contratto per la fornitura del sesto sommergibile ma Israele sta considerando l’acquisto anche di altri tre.
Secondo lo Spiegel, la cancelliera Angela Merkel ha fatto «concessioni sostanziali» ad Israele. «Non solo Berlino finanzia un terzo del costo del sottomarino, circa 135 milioni di euro» ma ha anche consentito a Tel Aviv pagamenti dilazionati fino al 2015. La cancelliera avrebbe anche subordinato la consegna del sesto sottomarino ad uno stop della politica degli insediamenti e all’autorizzazione a realizzare nella Striscia di Gaza un impianto di depurazione delle acque, in parte finanziato dal governo tedesco. Nessuna di queste condizioni, specifica lo Spiegel, è stata finora mantenuta.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- Günter Grass: Israele usa con me i metodi della Ddr (di Alessandro ALvani).12 aprile 2012, di Federico La Sala
Grass: Israele usa con me i metodi della Ddr Il Nobel tedesco replica alle autorità di Tel Aviv che l’hanno dichiarato “persona non gradita”
di Alessandro Alviani (La Stampa, 12.04.2012)
Berlino. L’ ondata di critiche che si è abbattuta su quei suoi versi in cui definiva Israele «una minaccia per la pace nel mondo» non ha scalfito la vena polemica di Günter Grass. Anzi: lo scrittore premio Nobel per la Letteratura rilancia e lo fa con un paragone «politicamente scorretto» nell’odierna Repubblica federale. La reazione di Israele, che lo ha dichiarato persona non grata, ricorda i metodi tipici della Ddr, la defunta Germania dell’Est, e soprattutto della Stasi, l’onnipresente polizia segreta tedesco-orientale, ha scritto Grass sulla Süddeutsche Zeitung.
Il ministro degli Interni israeliano Eli Yishai sullo stesso piano di Erich Mielke, il famigerato numero uno della Stasi? «Finora - argomenta Grass nel commento, intitolato “Allora come oggi” - mi è stato vietato per tre volte l’ingresso in un Paese. Ha cominciato la Ddr, su ordine di Mielke, che alcuni anni dopo annullò sì il divieto, ma ordinò di intensificare le misure di spionaggio nei miei confronti, classificandomi come un “elemento sovversivo” La seconda volta è stata nel 1986, quando la Birmania vietò l’ingresso a me e a mia moglie, ritenendo la nostra visita “indesiderata”».
«In entrambi i casi è stata seguita la prassi tipica nelle dittature», nota Grass. «Adesso è il ministro degli Interni di una democrazia, lo Stato d’Israele, che mi punisce col divieto d’ingresso e la motivazione addotta per la misura coercitiva da lui ordinata ricorda - nei toni - il verdetto del ministro Mielke». «Tuttavia - continua - così non potrà di certo impedirmi di tener vivo il ricordo dei miei numerosi viaggi in Israele, un Paese a cui mi sento ancora inscindibilmente legato». La Ddr non c’è più, conclude Grass, ma il governo israeliano, in quanto potenza atomica di dimensioni incontrollate, si sente arbitrario e non ha recepito finora nessun richiamo. «Soltanto la Birmania lascia germogliare una piccola speranza», è la sua caustica chiusura.
Si tratta della prima reazione di Grass alla decisione di Israele di vietargli l’ingresso sul proprio territorio. Ed è una reazione destinata a riaccendere le polemiche che vanno avanti incessanti da mercoledì scorso, da quando, cioè, l’autore del Tamburo di latta ha pubblicato su alcuni quotidiani europei la poesia Quello che deve essere detto , in cui accusava Israele di rappresentare con la sua potenza nucleare un pericolo per la pace nel mondo, in quanto prepara un attacco preventivo contro l’Iran, e criticava la vendita a Gerusalemme, da parte della Germania, di sottomarini capaci di trasportare missili nucleari.
Immediato lo scontro tra Grass, accusato di antisemitismo, e Israele che non solo ha chiesto di ritirargli il Nobel (pronto il no dell’Accademia svedese), ma gli ha anche chiuso la porta. Una mossa, quest’ultima, biasimata persino da quanti non condividono una virgola della poesia: Grass «non ha capito niente», tuttavia il bando deciso da Gerusalemme «non va bene, assolutamente no», ha detto a La Stampa lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua.
Intanto il neopresidente tedesco Joachim Gauck prepara la sua prima visita ufficiale in Israele, su invito di Shimon Peres. Il viaggio, che si terrà a breve, sarebbe stato concordato prima delle polemiche suscitate da Quello che deve essere detto . Sarà un’occasione per far posare il polverone sollevato «con l’ultimo inchiostro» dall’ottantaquattrenne Grass.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- Israele sbarra le porte a Guenter Grass e lo dichiara «persona non grata».10 aprile 2012, di Federico La Sala
Israele sbarrata per Grass
Israele sbarra le porte a Guenter Grass e lo dichiara «persona non grata». Dopo le polemiche e le accuse di filo-nazismo mascherato, scatta la punizione contro lo scrittore premio Nobel tedesco per la pubblicazione di un contestato poema fresco di stampa, dal titolo “Le cose che vanno dette”, sferzante sulla politica israeliana verso l’Iran. *
La frontiera sbarrata dal governo Netnayahu lascia perplessi molti: può uno Stato democratico bandire un’opinione, per quanto insostenibile? Reazione «profondamente esagerata», la definisce un ministro tedesco, Daniel Bahr. «Basso livello di tolleranza», dice lo storico israeliano della Shoah, Tom Segev: «Delegittimare chi critica è una tendenza molto pericolosa, autocratica e demagogica. Netanyahu e Lieberman sono bravissimi, in questo. Ogni voce contraria è subito indicata come un segnale d’antisemitismo. Ma se davvero ci mettiamo a distribuire i permessi d’ingresso secondo le opinioni politiche delle persone, finiamo in compagnia di Siria e dello stesso Iran».
Dalla sinistra israeliana, si schierano contro il boicottaggio altri intellettuali: gli scrittori Ronit Matalon e Yoram Kaniuk («il prossimo passo è bruciare i libri»), il pittore Yair Garbuz («e allora che dovremmo fare coi libri di quel rabbino che propone d’uccidere i non ebrei?»), il Nobel per la chimica Aaron Ciechanover («non si risponde alla follia con una follia»)... Il dibattito, c’è da giurare, continuerà. E sbucciando le cipolle, per dirla con un titolo di Gunni, alla fine s’arriverà al cuore della questione. Riassunta dalla cancelliera Angela Merkel: «C’è la libertà d’espressione artistica. E per fortuna c’è la libertà d’un governo, il mio, di non doversi per forza esprimere su ogni manifestazione dell’arte».
* l’Unità, 10.04.2012
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- QUANTI INSULTI CONTRO GRASS (di Giuseppe Scuto - Gli insulti di Grass)6 aprile 2012, di Federico La Sala
Gli insulti di Grass
di Giuseppe Scuto (l’Unità, 06.04.2012)
Fa veramente dispiacere ascoltare il coro di insulti ad un vecchio, bravo, onesto scrittore che non si è mai risparmiato. Che dice in fondo, quello che tutti sappiamo: il mondo ha paura perchè sa che lo Stato di Israele, che possiede decine e decine di ordigni nucleari, intende attaccare l’Iran che ne starebbe forse producendo uno. Il regime di Ahmadinejad scricchiola, ci vuole Israele a dargli una patente di difensore della patria. I palestinesi si distanziano sempre più dal terrorismo, ci vuole Israele che ve li risospinga, straziando, come fa, la striscia di Gaza. La favola di Israele stato moderno democratico, razionale, nasconde la follia religiosa: l’invenzione di un moderno stato confessionale-razziale. Solo gli israeliani possono cambiare questa situazione.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- Günter Grass: Quello che deve essere detto.4 aprile 2012, di Federico La Sala
Quello che deve essere detto
di Günter Grass (la Repubblica, 04.04.2012)
 Perché taccio, passo sotto silenzio troppo a lungo
Perché taccio, passo sotto silenzio troppo a lungo
 quanto è palese e si è praticato
quanto è palese e si è praticato
 in giochi di guerra alla fine dei quali, da sopravvissuti,
in giochi di guerra alla fine dei quali, da sopravvissuti,
 noi siamo tutt’al più le note a margine.
noi siamo tutt’al più le note a margine. E’ l’affermato diritto al decisivo attacco preventivo
E’ l’affermato diritto al decisivo attacco preventivo
 che potrebbe cancellare il popolo iraniano
che potrebbe cancellare il popolo iraniano
 soggiogato da un fanfarone e spinto al giubilo organizzato,
soggiogato da un fanfarone e spinto al giubilo organizzato,
 perché nella sfera di sua competenza si presume
perché nella sfera di sua competenza si presume
 la costruzione di un’atomica.
la costruzione di un’atomica. E allora perché mi proibisco
E allora perché mi proibisco
 di chiamare per nome l’altro paese,
di chiamare per nome l’altro paese,
 in cui da anni - anche se coperto da segreto -
in cui da anni - anche se coperto da segreto -
 si dispone di un crescente potenziale nucleare,
si dispone di un crescente potenziale nucleare,
 però fuori controllo, perché inaccessibile
però fuori controllo, perché inaccessibile
 a qualsiasi ispezione?
a qualsiasi ispezione? Il silenzio di tutti su questo stato di cose,
Il silenzio di tutti su questo stato di cose,
 a cui si è assoggettato il mio silenzio,
a cui si è assoggettato il mio silenzio,
 lo sento come opprimente menzogna
lo sento come opprimente menzogna
 e inibizione che prospetta punizioni
e inibizione che prospetta punizioni
 appena non se ne tenga conto;
appena non se ne tenga conto;
 il verdetto «antisemitismo» è d’uso corrente.
il verdetto «antisemitismo» è d’uso corrente. Ora però, poiché dal mio paese,
Ora però, poiché dal mio paese,
 di volta in volta toccato da crimini esclusivi
di volta in volta toccato da crimini esclusivi
 che non hanno paragone e costretto a giustificarsi,
che non hanno paragone e costretto a giustificarsi,
 di nuovo e per puri scopi commerciali, anche se
di nuovo e per puri scopi commerciali, anche se
 con lingua svelta la si dichiara «riparazione»,
con lingua svelta la si dichiara «riparazione»,
 dovrebbe essere consegnato a Israele
dovrebbe essere consegnato a Israele
 un altro sommergibile, la cui specialità
un altro sommergibile, la cui specialità
 consiste nel poter dirigere annientanti testate là dove
consiste nel poter dirigere annientanti testate là dove
 l’esistenza di un’unica bomba atomica non è provata
l’esistenza di un’unica bomba atomica non è provata
 ma vuol essere di forza probatoria come spauracchio,
ma vuol essere di forza probatoria come spauracchio,
 dico quello che deve essere detto.
dico quello che deve essere detto. Perché ho taciuto finora?
Perché ho taciuto finora?
 Perché pensavo che la mia origine,
Perché pensavo che la mia origine,
 gravata da una macchia incancellabile,
gravata da una macchia incancellabile,
 impedisse di aspettarsi questo dato di fatto
impedisse di aspettarsi questo dato di fatto
 come verità dichiarata dallo Stato d’Israele
come verità dichiarata dallo Stato d’Israele
 al quale sono e voglio restare legato
al quale sono e voglio restare legato Perché dico solo adesso,
Perché dico solo adesso,
 da vecchio e con l’ultimo inchiostro:
da vecchio e con l’ultimo inchiostro:
 La potenza nucleare di Israele minaccia
La potenza nucleare di Israele minaccia
 la così fragile pace mondiale?
la così fragile pace mondiale?
 Perché deve essere detto
Perché deve essere detto
 quello che già domani potrebbe essere troppo tardi;
quello che già domani potrebbe essere troppo tardi;
 anche perché noi - come tedeschi con sufficienti colpe a carico -
anche perché noi - come tedeschi con sufficienti colpe a carico -
 potremmo diventare fornitori di un crimine
potremmo diventare fornitori di un crimine
 prevedibile, e nessuna delle solite scuse
prevedibile, e nessuna delle solite scuse
 cancellerebbe la nostra complicità.
cancellerebbe la nostra complicità. E lo ammetto: non taccio più
E lo ammetto: non taccio più
 perché dell’ipocrisia dell’Occidente
perché dell’ipocrisia dell’Occidente
 ne ho fin sopra i capelli; perché è auspicabile
ne ho fin sopra i capelli; perché è auspicabile
 che molti vogliano affrancarsi dal silenzio,
che molti vogliano affrancarsi dal silenzio,
 esortino alla rinuncia il promotore
esortino alla rinuncia il promotore
 del pericolo riconoscibile e
del pericolo riconoscibile e
 altrettanto insistano perché
altrettanto insistano perché
 un controllo libero e permanente
un controllo libero e permanente
 del potenziale atomico israeliano
del potenziale atomico israeliano
 e delle installazioni nucleari iraniane
e delle installazioni nucleari iraniane
 sia consentito dai governi di entrambi i paesi
sia consentito dai governi di entrambi i paesi
 tramite un’istanza internazionale.
tramite un’istanza internazionale. Solo così per tutti, israeliani e palestinesi,
Solo così per tutti, israeliani e palestinesi,
 e più ancora, per tutti gli uomini che vivono
e più ancora, per tutti gli uomini che vivono
 ostilmente fianco a fianco in quella
ostilmente fianco a fianco in quella
 regione occupata dalla follia ci sarà una via d’uscita,
regione occupata dalla follia ci sarà una via d’uscita,
 e in fin dei conti anche per noi.
e in fin dei conti anche per noi.(Traduzione di Claudio Groff)
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- Tutti contro Grass. Lo scrittore in una poesia contesta i piani d’attacco contro l’Iran e «l’ipocrisia dell’Occidente» (di Paolo Soldini - «Lo Stato di Israele minaccia la pace»).5 aprile 2012, di Federico La Sala
 Lo scrittore in una poesia contesta i piani d’attacco contro l’Iran e «l’ipocrisia dell’Occidente»
Lo scrittore in una poesia contesta i piani d’attacco contro l’Iran e «l’ipocrisia dell’Occidente»
 Bufera. Durissime reazioni: «Antisemitismo», «Un aggressivo pamphlet da agit-prop»
Bufera. Durissime reazioni: «Antisemitismo», «Un aggressivo pamphlet da agit-prop» «Lo Stato di Israele minaccia la pace»
«Lo Stato di Israele minaccia la pace»
 Tutti contro Grass
Tutti contro Grass Ancora una volta il premio Nobel scatena il putiferio. Questa volta puntando il dito contro il potenziale «first strike» nucleare contro Teheran. Ed è lui stesso ad anticipare per lui l’accusa di antisemitismo.
Ancora una volta il premio Nobel scatena il putiferio. Questa volta puntando il dito contro il potenziale «first strike» nucleare contro Teheran. Ed è lui stesso ad anticipare per lui l’accusa di antisemitismo.di Paolo Soldini (l’Unità, 05.04.2012)
Si può criticare lo stato di Israele senza cadere nell’antisemitismo? Vecchia questione, particolarmente controversa in Germania, ma certo non solo «tedesca». Qualsiasi persona equilibrata e ragionevole risponde che sì, certo che è possibile. Tant’è che non sono pochi gli ebrei che, anche in Israele, verso la politica di Israele hanno un atteggiamento critico. Al di là del grande bailamme di polemiche e di reazioni sdegnate suscitato nel suo Paese, è questa la Gretchenfrage (la questione fondamentale dalla risposta alla quale tutto dipende, come quella che Faust pone a Margarethe: credi in Dio?) che Günter Grass, con un pizzico di vis provocatoria di troppo, ha buttato sul tappeto scrivendo per la Süddeutsche Zeitung la poesia Was gesagt werden muss: «Che cosa deve essere detto». Di fronte al governo attuale di Israele che apertamente prospetta l’ipotesi di utilizzare in un attacco preventivo contro l’Iran di Ahmadinejad le armi nucleari che possiede e che l’ipocrisia dell’occidente passa sotto silenzio, anche gli amici di Israele in Germania debbono parlare e, vincendo tutte le remore, anche quelle che derivano dalle speciali responsabilità che la Storia ha gettato sulle spalle di ogni tedesco, condannare l’atteggiamento di chi minaccia. E, en passant, anche l’ipocrisia dei governi di Berlino che hanno fornito a Israele i sommergibili da cui potrebbe partire il micidiale first strike.
Le reazioni sono state violente. Una, in particolare, ha suscitato polemiche all’interno della polemica: quella dell’ambasciatore israeliano a Berlino Emmanuel Nahshon, il quale ha accomunato lo scrittore ottantacinquenne ai seminatori di odio antisemita che la storia ha disseminato per l’Europa dal Medio Evo in poi. «È una tradizione europea - ha detto quella di accusare gli ebrei, prima della festa di Pessach, di omicidi rituali. Un tempo erano i bambini cristiani che, così si diceva, venivano uccisi per mischiare il loro sangue nel pane azzimo. Oggi è il popolo iraniano, che, così si dice, lo stato ebreo vorrebbe annientare».
Il curioso rovesciamento di una teoria del complotto che ha prodotto, per secoli, pogrom e tragiche persecuzioni non rende onore né a quanto Grass ha effettivamente scritto né alla manifesta realtà dei fatti: è l’attuale governo israeliano che evoca oggi il colpo preventivo, pur se lo fa in risposta alle sinistre, inaccettabili (e non accettate da tutto il resto del mondo) minacce di Ahmadinejad e con la consapevolezza, richiamata da Nahshon, di essere l’unico stato al mondo di cui è messo in discussione il diritto di esistere.
Anche il presidente della comunità ebraica Dieter Graumann non è stato leggero contro l’«aggressivo pamphlet da agit-prop» con cui Grass avrebbe «demonizzato» Israele: «Un grande scrittore non è necessariamente un grande analista della questione medio-orientale». Ancor più pesante il giudizio di Amos Luzzatto, ex presidente delle comunità italiane: «Un proclama, quello di Grass, da condannare e che può essere archiviato solo da una autosmentita».
Scontate, e spesso ipocrite, le reazioni dei politici più conservatori che non hanno mai amato Grass fin da quando, alla fine degli anni ’50 pubblicò il suo «eversivo e diseducativo» Il tamburo di latta e poi si schierò con Willy Brandt. I vertici della Cdu e il governo, comunque, sono stati molto equilibrati. Il portavoce della cancelleria ha ricordato che in Germania c’è libertà di espressione artistica mentre il ministero degli Esteri ha tenuto a precisare che da Israele non è venuta finora alcuna reazione ufficiale che richiedesse una presa di posizione. D’altronde era stato proprio il più illustre predecessore di Graumann, Ignatz Bubis, a battersi, negli anni ’90, per stabilire la giusta distinzione tra i tedeschi ebrei e lo Stato di Israele.
Una tempesta in un bicchier d’acqua, allora? Non proprio. Grass ha toccato non solo un punto ancora delicatissimo della consapevolezza di sé e del proprio passato dell’opinione tedesca, ma anche - e questo spiega forse l’asprezza delle reazioni - un nodo che riguarda proprio lui, le sue convinzioni e la sua biografia. Non solo il passaggio, giovanissimo, nelle SS, reso pubblico con un ritardo di decenni, ma anche una certa, mai celata, prevenzione contro le «durezze bibliche» che, a suo parere, caratterizzerebbero la dottrina della religione di Abramo. Ma è antisemitismo?
-
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- IMMAGINARE UN ALTRO ABRAMO. Lettra a Robert Klopstock (di Franza Kafka).16 ottobre 2011, di Federico La Sala
- LETTERA DI FRANZ KAFKA
A Robert Klopstock [Matliary, giugno 1921] *
Mio caro Klopstock, veranda, con l’antica insonnia, con l’antico calore degli occhi, la tensione nelle tempie: ... incredulo non sono stato mai in questo punto, ma stupito, angosciato, la testa piena di tanti interrogativi quanti sono i moscerini su questo prato. Nella situazione, diciamo, di questo fiore accanto a me che non è del tutto sano, solleva bensì la testa verso il sole, e chi non lo farebbe ma è pieno di segrete preoccupazioni a causa di dolorosi avvenimenti nelle sue radici e nei succhi, qualcosa vi è successo, e succede ancora, ma esso ne ha soltanto notizie molto vaghe, dolorosamente vaghe, eppure non può curvarsi, scalzare il terreno e controllare, ma deve fare come i suoi fratelli e tenersi ritto, lo fa anche ma con stanchezza.
Potrei anche immaginare un altro Abramo che (ma non arriverebbe a essere il patriarca, anzi nemmeno un mercante di abiti usati) fosse pronto a adempiere la richiesta della vittima, pronto come un cameriere, ma ciò nonostante non riuscisse a fare il sacrificio perché non può allontanarsi da casa, è indispensabile, l’andamento della casa ha bisogno di lui, c’è sempre ancora qualche cosa da mettere in ordine, la casa non è finita, ma senza che sia finita, senza questo appoggio egli non può allontanarsi, lo capisce anche la Bibbia poiché dice: “Egli sistemò la sua casa” e Abramo aveva realmente già prima ogni abbondanza; se non avesse avuto la casa, dove avrebbe allevato suo figlio, in quale trave avrebbe tenuto conficcato il .coltello del sacrificio.
Il giorno seguente: ho riflettuto ancora molto su questo Abramo, ma sono vecchie storie, non mette conto di parlarne, specialmente del vero Abramo; egli ha avuto tutto già prima, vi fu portato fin dall’infanzia, non riesco a vedere il salto. Se aveva già tutto e tuttavia doveva essere condotto piú in alto, ora bisognava togliergli qualcosa, almeno in apparenza, questo è logico e non è un salto. Non così gli Abrami superiori, questi stanno nel loro cantiere e a un tratto devono salire sul Monte Moria; può darsi che non abbiano ancora un figlio e già lo debbano sacrificare. Queste sono cose impossibili e Sarah ha ragione se ride. Rimane dunque soltanto il sospetto che costoro facciano apposta a non portare a termine la loro casa e - per citare un esempio grandissimo - nascondano la faccia in magiche trilogie per non doverla alzare e vedere il monte che sorge in lontananza.
Ma ecco un altro Abramo, uno che vuole assolutamente offrire un sacrificio giusto e, in genere, ha il giusto fiuto di tutta la questione, ma non può credere che tocchi a lui, l’antipatico vecchio, e a suo figlio, il sudicio giovane. Non che gli manchi la vera fede, questa fede ce l’ha, e sacrificherebbe nello stato d’animo giusto, purché potesse credere che si intenda lui. egli teme che uscirà a cavallo in qualità di Abramo con suo figlio, ma lungo il percorso teme di trasformarsi in Don Chisciotte. Il mondo di allora sarebbe rimasto atterrito se avesse guardato Abramo, questo invece teme che a quella vista il mondo muoia dal ridere. Non teme però il ridicolo in sé (certo teme anche questo, soprattutto la sua partecipazione alla risata), soprattutto però teme che questo ridicolo 1o renda ancore più vecchio e antipatico, e suo figlio ancora più sudicio, ancora più indegno di essere realmente chiamato. Un Abramo che arriva senza essere chiamato! È come se lo scolaro migliore dovesse ricevere solennemente il premio alla fine dell’anno e nel silenzio dell’attesa lo scolaro peggiore, in seguito a un malinteso, uscisse dal suo lurido ultimo banco e tutta la classe scoppiasse a ridere. E forse non è affatto m malinteso, egli è stato veramente chiamato per nome, la premiazione del migliore dev’essere, nelle intenzioni del maestro, ad un tempo la punizione del peggiore.
 Cose orrende... basta.
Cose orrende... basta.
 Lei si lamenta della felicità solitaria, che dire della solitaria infelicità? Davvero, fanno quasi una coppia. [...]
Lei si lamenta della felicità solitaria, che dire della solitaria infelicità? Davvero, fanno quasi una coppia. [...]* Franz Kafka, Tutte le opere, Epistolario, vol. IV, t. I, a c. di Ervino Pocar, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1964, pp. 393-395, senza le note.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- Israele e Palestina: due popoli, due Patrie. - Samuel Willerberg, l’eroe di Treblinka tifa per i palestinesi: “Senza un loro Stato sarà la catastrofe”.2 novembre 2011, di Federico La Sala
Israele e Palestina due popoli, due Patrie
di Abraham Yehoshua (la Repubblica, 2.11.2011)
Non c’è nell’identità ebraica concetto più problematico di «patria». «Vattene dalla tua terra, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso la terra che ti mostrerò». È la prima frase che viene detta ad Abramo, il primo ebreo. Nel corso di tutta la storia ebraica, la frase è stata adottata da molti ebrei tanto come comandamento teologico, quanto come possibilità esistenziale e ideologica. Lo stesso Abramo non abbandonò solo la propria patria e la casa paterna, ma perfino la nuova Terra che gli era stata destinata, e discese verso l’Egitto. Il popolo d’Israele non si è formato nella propria patria e anche la Torah, il nucleo essenziale della Bibbia ebraica, non gli è stata consegnata in patria ma nel deserto, zona intermedia fra la diaspora e la patria cui erano diretti.
Sono pochi i popoli che hanno consolidato la propria identità fisica e spirituale in un luogo diverso dalla patria. Gli esiliati condotti in Babilonia dopo la distruzione del primo Santuario di Gerusalemme, cantavano con emozione: «Sui fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordando Sion». Ma quando, dopo soli 40 anni il re di Persia li chiamò per tornare alla loro terra e riedificare il Santuario, solo una parte di loro accettò di tornare nella Terra d’Israele. Per i 600 anni del periodo del Secondo Santuario di Gerusalemme, circa la metà del popolo d’Israele aveva già iniziato a vagare nel mondo antico, contribuendo al progressivo indebolimento del legame fisico con la Terra d’Israele. L’identità nazionale e religiosa ebraica non rinunciò alla patria, ma riuscì a trasformarla da concreta in virtuale.
I romani non esiliarono gli ebrei dalla Terra d’Israele dopo la distruzione del Secondo Santuario di Gerusalemme. Qualsiasi storico di quel periodo può offrirne le prove. E nei 1500 anni seguiti allo sfaldamento dell’impero romano, non c’era alcun presidio di aguzzini sui confini della Terra d’Israele, ad impedire il ritorno degli ebrei alla loro terra. Il falso mito dell’esilio degli ebrei da parte dei romani, profondamente radicato nelle ragioni che ci fanno pretendere il diritto storico sulla Terra, non ha il sostegno neppure della secolare preghiera ebraica, in cui si dice: «A causa dei nostri peccati siamo esiliati dalla nostra terra» e non «siamo stati esiliati». E così, i circa due milioni di ebrei che, secondo le stime più accettate vivevano in tutta la terra d’Israele al momento della distruzione del Secondo Santuario di Gerusalemme, non vennero ammassati su navi romane e forzosamente esiliati (dove poi?), bensì lasciarono pian piano la loro patria (in particolare dopo la rivolta di Bar Kochbà nel 135) e andarono ad unirsi al gran numero di ebrei già sparsi nei Paesi del mondo antico.
Una dispersione che è viva e dinamica anche ai nostri giorni. Dall’Afghanistan all’Iran, da Bukhara all’Uzbekistan, dall’Ucraina alla Romania, alla Turchia, all’Irak, allo Yemen, al Nordafrica e a tutto il bacino Mediterraneo, alla Russia in tutte le sue varianti etnico-regionali, all’Europa occidentale e orientale e in tutto il Nuovo Mondo, e anche le lontanissime Australia e Nuova Zelanda. Dagli inizi del XIX secolo (quando in Terra d’Israele risiedevano secondo fonti storiche solo 5000 ebrei su una popolazione ebraica globale stimata in 2,5 milioni) fino ad oggi, l’80% della popolazione ebraica ha cambiato la propria nazione di residenza. Il massimo dell’orrore può essere rappresentato dal fatto che perfino una gran parte delle vittime della Shoah non è stata eliminata nei luoghi dove risiedeva ma è stata trasportata all’annientamento con la forza, in una non-patria, in campi di sterminio alienati, privi di qualsiasi carattere nazionale.
La «patria virtuale» nella quale gli ebrei si sono specializzati , non è mai piaciuta agli altri popoli. Nelle composizioni filosofiche gordoniane sul rinnovato legame con il lavoro agricolo, nelle ideologie morali brenneriane sulla totale responsabilità verso la realtà, nelle utopie herzliane e nelle ammonizioni di Jabotinsky del genere «se non eliminerete la diaspora, la diaspora eliminerà voi» - i vari padri del sionismo tentarono di convincere gli ebrei agli inizi del XX secolo a restaurare il concetto di patria che tanto si era indebolito con il passare delle generazioni. Urgeva però trovare risposta a un’altra domanda: c’era un territorio libero per realizzare questo programma?
L’unico luogo nel quale sarebbe stato possibile convincere gli ebrei a rinunciare alla propria patria virtuale per identificarsi in una patria reale, fisica, era la Terra d’Israele. Ma la Terra d’Israele era già la patria degli abitanti che vi vivevano. Potevano gli ebrei mantenere con un comando a distanza un diritto storico sulla Terra d’Israele dopo centinaia di anni in cui ne erano stati assenti? Per questo l’unico diritto morale in virtù del quale il popolo ebraico ha potuto rendere la Terra d’Israele patria ebraica reale, gli è derivato dalle tragiche necessità di un popolo che altrimenti sarebbe stato condannato a morte. E così fu. La vecchia-nuova patria salvò di fatto dai campi di sterminio centinaia di migliaia di ebrei europei.
Quindi, dato che la patria non è solo territorio ma anche un elemento primario nella identità individuale e nazionale, la divisione della Terra d’Israele in due Stati non è solo l’unica soluzione politica, ma è anche un imperativo morale. E chi si impossessa di parti di territori palestinesi come fa quotidianamente lo Stato d’Israele al di là della Linea verde, deruba e ferisce la parte più delicata dell’identità dei suoi abitanti.
L’identità patriottica dei palestinesi è quasi opposta alla nostra, e anch’essa ha bisogno di revisione. Di fronte a un popolo che ha cambiato continuamente Paesi di residenza, il concetto di patria dei palestinesi si restringe talvolta al villaggio e alla casa. I palestinesi nei campi profughi a Gaza o in Cisgiordania sono rimasti a vivere a pochi chilometri di distanza dalle case e dai villaggi dai quali sono fuggiti o sono stati allontanati dalla guerra del 1948, e di fatto si trovano ancora nella patria palestinese. Nella loro percezione non sono stati solo esiliati dal villaggio o dalla casa, ma dalla patria stessa, e per questo da 64 anni abitano nelle condizioni umilianti e paralizzanti dei campi profughi. E il diritto al ritorno alla propria patria - una richiesta legittima - si è trasformato nel diritto a tornare nella propria casa dentro Israele - che è una richiesta impossibile e non indispensabile ai fini di una soluzione pacifica.
In giorni di sconforto politico, non vale forse la pena di cercare una nuova strada per la pace, rivedendo nelle due parti concetti antiquati? (Traduzione di Cesare Pavoncello)
L’eroe di Treblinka che tifa per i palestinesi
“Senza un loro Stato sarà la catastrofe”
di Roberta Zunini (il Fatto, 2.11.2011)
All’ultimo piano di una bella palazzina bianca, tardo Deco, su viale Ben Gurion, nel cuore di Tel Aviv, abita Samuel Willerberg, l’ultimo ebreo sopravvissuto alle persecuzioni naziste nel lager di Treblinka. È un eroe nazionale, avendo preso parte alla rivolta del ghetto di Varsavia e a quella del campo di sterminio polacco. “Purtroppo sono anche molto vecchio ormai”, dice sorridendo sul terrazzo dove la moglie Ada annaffia le piante. Nonostante l’età ha 88 anni Willenberg ha una memoria sorprendente: la sua mente è lucidissima, la sua parola ironicamente tagliente e il suo sguardo è preoccupato.
“LA SITUAZIONE non è per nulla rosea, né internamente né per quanto riguarda il conflitto con i palestinesi, per non parlare dell’isolamento internazionale in cui siamo finiti dopo l’esplosione della primavera araba”. È questo voto a favore dell’ingresso della Palestina nell’Unesco (che ieri Israele ha punito bloccando il trasferimento dei fondi all’Autorità nazionale palestinese, ndr) che la preoccupa? “Non è che la logica conseguenza del cambiamento in atto negli equilibri internazionali e dell’inazione intransigente di Israele. Però le vorrei far vedere si alza di scatto e con passo deciso si avvia verso il corridoio quindi entra in una grande stanza piena delle sue sculture - le mappe su cui ho lavorato quando arrivai in Israele dopo essere scampato al genocidio”. Willenberg nacque in Polonia nel 1923, figlio di un insegnante ebreo polacco e di una madre molto devota. “Ma non sono credente: dopo l’Olocausto non ci credo più e non riesco a tornare indietro, a quando ero un giovane fedele praticante che frequentava la sinagoga. Comunque ora parliamo della spartizione di Israele e dei Territori”.
Stendendo la mappa inizia a tracciare con un dito una ipotetica dorsale, al confine tra l’attuale Israele e la Cisgiordania dove secondo lui ci sarebbe stato modo di modificare i confini. “Ho lavorato per tanti anni presso la municipalità e lo Stato israeliano come addetto allo studio delle mappature e non sono d’accordo su come è stato suddiviso il territorio. Avremmo dovuto creare una continuità diversa tra le zone a prevalenza araba, ora ci sarebbero molti meno problemi. Perché, anche se nessuno lo grida, i coloni israeliani e i palestinesi di nazionalità israeliana che vivono a Jaffa, Nazareth, Haifa, (città israeliane a maggioranza araba palestinese, ndr) sono sempre più ai ferri corti: pensi ai coloni estremisti religiosi ebrei che hanno distrutto tombe islamiche e cattoliche nel cimitero di Jaffa”.
Mentre i razzi degli estremisti islamici di Gaza cominciavano a piovere attorno alla capitale amministrativa israeliana, difesa da un potente scudo satellitare. “La situazione si complica, oltre all’imminente voto del Consiglio di Sicurezza Onu che scatenerà il putiferio visto il veto già annunciato di Obama, bisogna vedere se la fratellanza musulmana vincerà le elezioni in Egitto”.
Insomma questo mese sarà cruciale per il Medio Oriente? “Sì, lo sarà, sul fronte diplomatico e arabo, non certo da parte del governo Netanyahu a cui non interessa uscire da questo stallo. È ovvio che i palestinesi cerchino di ottenere ciò che vogliono. Se nessuno risponde fanno bene a chiederlo per via diplomatica.. Siamo noi che non agiamo per biechi scopi elettorali. E non è solo colpa di Netanyahu - che ieri ha deciso di accelerare la costruzione di nuove colonie a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, ndr ma anche della coalizione al governo, fondata sull’ortodossia religiosa più esasperata. Ma non c’è nulla da fare, per sbloccare la situazione, bisogna dare ai palestinesi un Stato indipendente e finirla con l’espansione delle colonie”.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- UN MALE SENZA BANALITA’. Olocausto - La sofferta e incerta conoscenza di un genocidio da collocare nella Storia. .27 gennaio 2012, di Federico La Sala
Un male senza banalità
di Gianpasquale Santomassimo (il manifesto, 27 gennaio 2012)
Per quanto strano possa sembrarci oggi, è relativamente recente la centralità della memoria dello sterminio del popolo ebraico nella coscienza occidentale. Non che non si sapesse cosa era accaduto: ne parlavano i nostri libri di scuola, ma era presentata solo come una grande tragedia fra gli innumerevoli lutti della seconda guerra mondiale. È stato necessario molto tempo perché si elaborassero in tutte le loro implicazioni l’enormità, la specificità e l’unicità del fenomeno: e anche da parte delle vittime è spesso dovuto passare il tempo necessario perché si potesse trovare la forza di raccontare ciò che appariva indicibile.
Commemorazione da un lato, istituzionalizzata nella giornata della memoria del 27 gennaio, e ricerca e riflessione dall’altro sembrano procedere spesso su binari paralleli che raramente si incontrano. Una felice eccezione è stata rappresentata quest’anno in Italia dal convegno fiorentino su Shoah, modernità e male politico che ha teso a fare il punto su acquisizioni e dibattiti più recenti della storiografia internazionale come della riflessione filosofica e sociologica sulla Shoah.
Le prime caratteristiche che emergono dal complesso dei lavori sono senza dubbio quelle dell’ampliamento e dell’approfondimento della tematica. Ampliamento geografico, in primo luogo: l’apertura degli archivi sovietici consente di includere in maniera documentata territori come quelli della Bielorussia e in parte dell’Ucraina, a pieno titolo inseriti nella fabbrica dello sterminio, come anche del collaborazionismo e delle complicità che ovunque accompagnarono il fenomeno. Viene confermata la partecipazione diretta allo sterminio della Wehrmacht e della polizia, a lungo negata o sottaciuta nell’autorappresentazione tedesca (Browning).
Cadono molti luoghi comuni, fortunati e tenaci, come quelli formulati da Hanna Arendt su Eichmann ne La banalità del male: il vertice dello sterminio non era costituito da grigi burocrati, che si limitavano ad eseguire ordini, ma era formato da personale molto qualificato e competente.
Non era la feccia della società, come ci piacerebbe credere, ma una élite di rango anche accademico: antropologi, giuristi, studiosi di scienze sociali, architetti, persone in ogni caso convinte di perseguire una missione che volevano portare fino in fondo (Collotti). Più che opportunismo, era adesione ideologica, che trovava il suo fondamento in un antisemitismo di massa che nel corso della guerra si poneva l’obiettivo di effettuare una trasfusione di sangue nel corpo dell’Europa, cambiando radicalmente la natura del continente.
Antigiudaismo di massa
Contestualizzare la Shoah è tema arduo ma inevitabile, per non farne celebrazione dai toni quasi religiosi e catartici, e include anche inevitabilmente un elemento di comparazione, largamente usata e forse anche abusata in maniera cervellotica negli ultimi vent’anni. Anche chi, fondatamente, teorizza l’unicità e al tempo stesso l’incomparabilità del fenomeno deve aver preliminarmente compiuto una comparazione che giustifichi il suo convincimento.
Le domande di fondo di una contestualizzazione sono quelle riassunte da Browning in questi termini: «Perché gli ebrei? Perché i tedeschi? Perché nel XX secolo?». Alla prima domanda forse è più facile rispondere oggi, perché sono stati ampiamente ripercorsi i sentieri di un antisemitismo e di un antigiudaismo profondamente radicati nell’Europa cristiana (Battini), di intensità diversa nelle singole fasi di questo percorso, e in grado di riaccendersi nei momenti di crisi, in cui la ricerca di un capro espiatorio dei mali della società ritrovava il suo archetipo ideale.
Meno banale e ricca di implicazioni nuove è la domanda: perché i tedeschi? Oggi può sembrarci una domanda scontata, avendo alle spalle una lunga elaborazione, che è stata anche in parte riflessione autocritica della parte migliore della società tedesca, sulla formazione storica del «carattere tedesco» (Burgio, anticipato in sintesi su questo giornale il 19 gennaio). Ma probabilmente un osservatore della fine dell’Ottocento, chiamato a pronosticare il paese che avrebbe avuto più problemi con la questione ebraica nel secolo successivo, avrebbe indicato nella Francia dell’affaire Dreyfus il luogo più critico, mentre in Germania l’integrazione ebraica appariva in via di definitivo compimento. L’intensità e la rapidità dell’affermazione di un antisemitismo di massa tra le due guerre sono tra i fenomeni più sconvolgenti dell’Europa fra le due guerre, premessa necessaria in Germania della costruzione sociale dello sterminio.
Quello che oggi appare indubbio è il coinvolgimento amplissimo e rapido della «società civile» tedesca e delle sue istituzioni portanti. Già nel 1935 sulle toghe nere dei giudici viene applicata un’aquila che regge fra gli artigli una svastica e una spada, e il ritratto di Hitler incombe nelle aule dei tribunali (Schminck-Gustavus). Una adesione così vasta da rendere problematica e sterile la «denazificazione» del secondo dopoguerra. Per la penuria dei giudici, fu istituito il principio per cui ogni giudice non iscritto al partito nazista doveva farsi affiancare da un magistrato compromesso. I risultati furono generalmente assolutori, e anche le condanne vennero in breve annullate da provvedimenti di grazia.
«Non possiamo buttare via l’acqua sporca, finché non abbiamo acqua pulita», è la frase molto significativa attribuita al cancelliere Adenauer: un problema che era indubbiamente serio (e non ignoto, peraltro, anche a noi italiani, ove si pensi che il primo presidente effettivo della Corte Costituzionale - dopo la presidenza onorifica e inaugurale di Enrico De Nicola - fu Gaetano Azzariti, che era stato anche l’ultimo presidente del Tribunale della Razza). Né le cose sembrano essere andate molto meglio nella Rdt, al di là della propaganda ufficiale, dove una rapida conversione al nuovo partito unico garantiva spesso assoluzione e continuità di carriera.
Il secolo della razza
Ma il problema tedesco ha molte altre dimensioni, e contribuisce a porre nuovi interrogativi proprio l’ultima domanda, quella relativa alla periodizzazione. Non mancano certamente i residui di una retorica sul «secolo assassino» e l’agitarsi del fantasma indistinto del «totalitarismo» onnicomprensivo, la più fortunata tra le molte approssimazioni banalizzanti di Hanna Arendt. È molto stimolante l’emergere di una periodizzazione che pone a cavallo tra Otto e Novecento il processo unificato di un racial century (1850-1945). Quel «secolo della razza» che si dipanò in strettissimo collegamento con imperialismo e colonialismo e che produsse rituali e abituali atrocità, e nel quale per la prima volta l’elemento razziale divenne non accessorio ma fondante di espansione e dominio. Da questo punto di vista, assumono un valore prima ignorato gli stermini coloniali a sfondo razziale compiuti nell’Africa Sud-occidentale tedesca, pratica nella quale, come sappiamo, i tedeschi non furono isolati nel novero delle potenze coloniali.
La logica coloniale, come quella imperialistica, è uno dei termini di inquadramento possibili, ma quello che emerge come il vero tratto comune e indispensabile di tutti gli stermini rimasti nella memoria di quello che potremmo definire «secolo lungo», è soprattutto l’elemento della guerra, incubatrice indispensabile per la costruzione sociale e culturale dei genocidi. Vale per turchi e armeni, come per giapponesi e cinesi, e per tutte le popolazioni decimate nelle guerre coloniali.
E da questo punto di vista, va ricordato che tutta l’espansione ad Est fu concepita dalla Germania come guerra di sterminio (Bartov), che i venti milioni di russi uccisi furono dal punto di vista quantitativo l’apice di questa pratica, e che l’estirpazione del popolo ebraico era parte di un progetto di ristrutturazione razziale dell’Europa, e soprattutto di quella orientale, sbocco prestabilito dello spazio vitale che la Germania riservava a sé.
Theodor Adorno, a caldo, paragonò il trauma di Auschwitz per l’umanità del XX secolo a quello che era stato il terremoto di Lisbona del 1755 per Voltaire e gli illuministi. Ma in realtà la portata dell’interrogazione prodotta dallo sterminio era molto più ampia di quella che aveva potuto coinvolgere credenti o deisti come i philosophes, perché andava oltre i termini della fede e investiva l’umanità nel suo complesso (Neuman). Da allora la coscienza occidentale non ha smesso di chiedersi come è stato possibile, e, anche, se può essere ancora possibile (Seppilli).
Colpisce che in molte relazioni, e soprattutto in quella di Zygmunt Bauman, venga richiamato l’episodio recente di Abu Ghraib nella guerra irachena degli Stati Uniti. Non certo per effettuare una comparazione impossibile o istituire un parallelismo privo di senso. Ma per osservare, come in un esperimento di laboratorio, che in clima di guerra dei tipici ordinary men, ragazze e ragazzi della porta accanto, possano trasformarsi - se dotati di potere illimitato e convinti di portare a termine una missione - in qualcosa che loro stessi avrebbero ritenuto impensabile nella loro vita normale.
La sofferta e incerta conoscenza di un genocidio da collocare nella Storia
di Marco Pacioni (il manifesto, 27 gennaio 2012)
La filosofia occidentale si è sempre nutrita della propria voce, come ha criticamente ribadito, non da ultimo, Jacques Derrida in Timpano. Gli eventi esterni hanno potuto fare poco per distoglierla dall’ascoltare soprattutto se stessa. La Shoah, anche in questo specifico argomento, segna una rottura. Non solo rende difficile rintonare il pensiero alla malia della propria voce, ma mette addirittura in discussione la stessa possibilità della filosofia e, in modo specifico, dell’etica. Sul rapporto del pensiero al cospetto della Shoah si è sviluppata un’ampia ricerca che ha all’attivo una consistente bibliografia.
In questo ambito, di particolare importanza sono i testi nei quali chi svolge la riflessione è anche la persona che ha fatto esperienza diretta del campo di concentramento come accade con il sopravvissuto, filosofo e teologo Emil L. Fackenheim, del quale ci si è iniziato ad interessare anche in Italia come attestano le recenti pubblicazioni di Tiqqun. Riparare il mondo (Medusa) e Un epitaffio per l’ebraismo tedesco(Giuntina). A questi libri si deve ora aggiungere il testo Olocausto (Morcelliana, a cura di Massimo Giuliani, pp. 55, euro 8) nel quale Fackenheim (1916 - 2003) affronta in modo più sintetico temi svolti in maniera più distesa ed elaborata in Tiqqun.
La questione di come pensare la Shoah coinvolge argomenti quali la memoria, la testimonianza, la rappresentazione, la divinità. Tutti questi aspetti vengono affrontati lungo un crinale che spesso cede alle idee d’indicibilità, unicità, impensabilità di cui Auschwitz è diventato il luogo per eccellenza e che in ragione di ciò è spesso utilizzato del tutto fuori contesto ogni qualvolta che si deve evocare un inarrivabile culmine di mostruosità. Il paradigma dell’indicibilità non è soltanto evocato, ma anche altrettanto spesso utilizzato contro quelle ricognizioni storiografiche, filosofiche nonché contro opere letterarie e film che invece cercano di trovare un modo per parlare della Shoah.
Sotto questo profilo, il libro di Fackenheim può essere considerato come una riflessione che esprime una posizione moderata da inserire nel versante che vede con favore la rappresentabilità e dunque la pensabilità della Shoah. Fackenheim ritiene che la Shoah sia un «evento unico» nella e non della storia, tale da configurare una sorta di sommità metafisica con tutto ciò che ne consegue in termini religiosi e sacrali. A tal proposito il filosofo scrive che «non si può negare, certo, che Auschwitz sia stato "un altro pianeta", ossia che si sia trattato di un mondo a parte con leggi, codici di comportamento e persino un linguaggio in proprio. Con tutto ciò, e pur essendo senza precedenti, piuttosto che unico, esso va fermamente situato nella storia».
Proprio perché è un evento nella storia, per l’autore la Shoah può essere definita come «un genocidio». (È da notare che questa espressione compare significativamente anche come sottotitolo del recente e importante libro dello studioso americano Donald Bloxham, Lo sterminio degli Ebrei, Einaudi). Per Fackenheim, la Shoah manterrà sempre degli elementi difficili da comprendere e immaginare, ma ciò non inficia completamente la possibilità per noi e le generazioni future di rapportarsi a essa. Anzi, su questo aspetto sta uno degli spunti più importanti del libro di Fackenheim e cioè che la Shoah vada affrontata anche prendendo in considerazione proprio il «noncomprendere», ossia un capire non totalizzante, un conoscere che non vuole chiudersi in un sapere assoluto. Qui Fackenheim sembra raccogliere la critica alla forza soffocante del comprendere di Bataille, Lévinas, Jankélévitch e trattare paradossalmente come una risorsa positiva anziché come un ostacolo lo stesso non-comprendere: forma aperta che proprio grazie alla sua impersuasione agisce come pungolo della memoria che stimola a colmare e non solo a subire le lacune della conoscenza.
Se per Fackenheim conoscere non è sinonimo di sapere, è però certamente sinonimo di costruire, riparare e cioè agire per il futuro. In questa idea sta l’altro elemento cospicuo della conoscenza applicata alla Shoah di Fackenheim che sottolinea l’importanza di proiettare nel futuro gli elementi che si hanno a disposizione dal passato e non risospingerli soltanto indietro con il rischio di allontanarli troppo dal presente.
Meno audaci invece e pericolosamente ancora tentate dall’orizzonte della sacralità della Shoah, sono le sue argomentazioni teologiche che sfociano poi nella politica: «Dopo tali eventi, porre fine all’esilio significa esprimere una volontà e fedeltà alla vita. Il prodotto di tale fedeltà - lo Stato ebraico - è ancora fragile e in un mondo che fatica comunque a capire. Se sull’onda dell’Olocausto non fosse già sorto uno Stato ebraico, sarebbe una necessità religiosa crearlo ora».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA --- Accordo per la liberazione di Shalit,pilota israeliano è prigioniero di Hamas nella Striscia di Gaza dal 2006.11 ottobre 2011, di Federico La Sala
MEDIO ORIENTE
 Shalit, accordo per la liberazione
Shalit, accordo per la liberazione
 mille prigionieri in cambio
mille prigionieri in cambio Il pilota israeliano è prigioniero di Hamas nella Striscia di Gaza dal 2006. I familiari: "Speriamo sia la volta buona"
Il pilota israeliano è prigioniero di Hamas nella Striscia di Gaza dal 2006. I familiari: "Speriamo sia la volta buona"TEL AVIV - Il governo israeliano e Hamas hanno raggiunto un accordo per la liberazione del soldato Gilad Shalit in cambio della scarcerazione di mille prigionieri palestinesi. "Lo scambio di prigionieri per Shalit verrà attuato all’inizio di novembre, con la medizione dell’Egitto", ha annunciato la tv Al Arabiya.
Abu Obeida, portavoce delle Brigate Ezzedin al Qassam, braccio armato di Hamas, ha confermato stasera l’intesa di massima con Israele, mediata dall’Egitto, aggiungendo che il caso Shalit "sarà chiuso in pochi giorni", pronbabilmente nel giro di una settimana.
Shalit è in ostaggio dal 2006: l’accordo prevede che Israele liberi i 1.000 prigionieri palestinesi in due tranche: la prima di 500 quando Shalit lascierà la Striscia di Gaza per passare in Egitto, e gli ulteriori 500 quando tornerà in Israele. Tra i prigionieri liberati ci sarà anche Marwan Barghuti, leader di Tanzim (organizzazione armata legata a Fatah), condannato a 5 ergastoli. Ancora non è chiaro se Barghouti e altri sei miliziani di punta potranno restare nei Territori.
"Abbiamo ricevuto un aggiornamento. Speriamo che questi sviluppi siano seri": hanno dichiarato i familiari del soldato, da oltre un anno sono accampati in una tenda a breve distanza dalla residenza del premier Benyamin Netanyahu, a Gerusalemme. "Manteniamo un cauto ottimismo" hanno aggiunto. "Anche in passato abbiamo visto infatti riunioni urgenti del governo".
Il retroscena. Da fonti politiche israeliane si apprende che dietro allo scambio dei prigionieri fra Israele e Hamas - sul quale è stata convocata una consultazione urgente dei ministri israeliani - c’è stata la apertura di una "finestra di opportunità", di carattere regionale.
Il riferimento è alla situazione creatasi con la ’primavera araba’: in particolare alla crisi nella relazioni fra Hamas e il regime di Bashar Assad a Damasco, aggiunta al desiderio della giunta militare in Egitto di conseguire un successo diplomatico. Viene inoltre citata una asserita necessità per Hamas di ottenere un vistoso successo agli occhi dei palestinesi da opporre a quello registrato da Abu Mazen (Anp) quando ha chiesto la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite.
* la Repubblica, 11 ottobre 2011
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO ---- L’ulivo di Abu Mazen. Chiesto ufficialmente all’Onu lo Stato di Palestina: “Non è contro Israele, ma le colonie sono una minaccia” (di Barbara Schiavulli).24 settembre 2011, di Federico La Sala
L’ulivo di Abu Mazen Chiesto ufficialmente all’Onu lo Stato di Palestina “Non è contro Israele, ma le colonie sono una minaccia”
La pistola non c’è più. Arafat nel 1974 dallo stesso palco chiese di non fargli scivolare l’ulivo dalle mani: aveva un revolver nella fondina. Ieri, Abu Mazen sventola il ricorso
di Barbara Schiavulli (il Fatto, 24.09.2011)
La mano che tremava e il solito vestito grigio scuro. Il viso teso all’inizio tranquillo e poi sempre più animato, fino al sorriso finale che non ha saputo trattenere, quasi intimidito da quella folla di rappresentati alle Nazioni Unite che fino al discorso precedente erano un po’ sonnacchiosi e improvvisamente, si ritrovavano in piedi per applaudire la voglia di pace di un popolo che la chiede da 60 anni. Abu Mazen non è mai stato l’uomo della piazza. L’ha evitata tutta la vita giocando nelle retrovie, negoziando, parlando, pianificando. Ma la Storia sa prendersi beffe dei riservati e ha sbattuto il presidente dell’Autorità palestinese sul podio davanti al mondo. Ha chiesto che il popolo palestinese possa entrare a pieno diritto come Stato nelle Nazioni Unite. Poco prima aveva consegnato la sua domanda a Ban Ki Moon, il segretario dell’Onu (Twitter ha dato la notizia), e poco dopo ne ha sventolata una copia come se lì fossero racchiuse tutte le speranze di un popolo che non ha più voglia di aspettare e che non ha più niente da perdere.
Abu Mazen non ha dato scadenze , non ha posto condizioni, aspetta che le Nazioni Unite votino, conscio che è probabile che con il voto contrario degli Stati Uniti non porti a niente, ma se politicamente quel signore che sembra il vecchietto della porta accanto più di un presidente, rischia di perdere, ha vinto moralmente il suo posto all’Onu.
Perché la sua è stata una sfida proprio contro gli Stati Uniti. Convincere il mondo a entrare nel problema palestinese, significa che neanche il premier Nobel per la pace Obama, è riuscito a ottenere qualche risultato. Pace sì, ma fino a che accadrà, sarà permessa la resistenza pacifica, ha garantito Abu Mazen, mostrando il fianco a chi leggerà questo come una minaccia. “ABBIAMO tentato tutte le strade per la pace”, così ha esordito, elencando poi tutti gli errori degli israeliani, concentrandosi sugli insediamenti che continuanoaesserecostruitieche“minano l’esistenza stessa dell’Autorità palestinese”, non dimenticando i migliaia di prigionieri, i profughi, quella Gerusalemme Est che vorrebbero capitale e quella vita da occupati che sono costretti a vivere.
“Israele continua la sua campagna demolitrice e la sua pulizia etnica verso i palestinesi”, ha detto ancora, aggiungendo che lo stato ebraico“minacciainostriluoghisacri”. Ha ripercorso la storia di negoziati che durano da decenni e che sono sempre falliti. Colpa degli uni e degli altri. Quaranta minuti di discorso, sei interruzioni per applausi, due standing ovation, Abu Mazen non può che essere soddisfatto. Ha ricordato a tutti quel conflitto che esiste da talmente tanto tempo che sembra una cosa normale, ma che non lo è per chi vive nei Territori occupati. “Il cuore del problema è che Israele si è rifiutato di rispettare gli impegni”, è stata la sua accusa. “Il fallimento dei negoziati di pace israelo-palestinesi è colpa della politica colonialista di Israele, della occupazione militarizzata dei Territori e della discriminazione razziale praticata nei confronti dei palestinesi”, ha proseguito, aprendo subito al tavolo delle trattative se si ferma la costruzione degli insediamenti.
“COME disse Arafat, ho un rametto di ulivo in mano, non lasciate che cada”, ha mormorato Abu Mazen, citando il simbolo della lotta per la liberazione palestinese, scatenando un altro applauso e ricordando a tutti la prima apparizione di Arafat all’Onu nel 1974, quando in una mano aveva una pistola e nell’altra un’offerta di pace, appunto. Fu lui che firmò gli accordi di Oslo, quando per un attimo sembrò che tutto fosse possibile. Sono trascorsi 18 anni.
“Ho chiesto di essere ammessi con tutti i diritti alle Nazioni Unite, come Stato indipendente, libero e legittimo, ma la questione è semplice: o si pensa che siamo un popolo che non merita nulla, o che sia necessario uno Stato anche per noi. Abbiamo bisogno che il mondo ci sostenga e ora spero che non dovremo aspettare a lungo. Abbiamo sofferto per 63 anni. È abbastanza. È abbastanza. È abbastanza”.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO ---- NEW YORK, ASSEMBLEA ONU. Abu Mazen: "Riconoscere lo Stato palestinese" Netanyahu: "Vogliono uno Stato senza pace".23 settembre 2011, di Federico La Sala
NEW YORK
 Abu Mazen: "Riconoscere lo Stato palestinese"
Abu Mazen: "Riconoscere lo Stato palestinese"
 Netanyahu: "Vogliono uno Stato senza pace"
Netanyahu: "Vogliono uno Stato senza pace"II presidente dell’Anp incontra il segretario generale dell’Onu. Poi pronuncia il suo discorso davanti all’aula, attaccando la politica di Israele, accusato di "praticare una pulizia etnica". Infine l’offerta: "Siamo pronti a tornare al negoziato". Il premier israeliano: "Non servono le risoluzioni internazionali, ma solo la trattativa tra le parti". Intanto è festa nei territori *
NEW YORK - Prima lo Stato palestinese o prima il negoziato? E’ questo lo scontro, a distanza ravvicinata, andato in scena davanti all’assemblea generale dell’Onu tra il presidente dell’Anp, Abu Mazen e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Che hanno parlato con un intervallo di soli 30 minuti. Alternando attacchi e chiusure. Ma questa giornata sarà ricordata soprattutto per un passaggio storico nelle tormentate vicende del Medio Oriente. La richiesta formale di un riconoscimento della Palestina alle Nazioni Unite, entro i confini del 1967 - cioè prima della guerra dei 6 giorni - e con capitale Gerusalemme. "Siamo l’ultimo popolo sotto occupazione straniera, questa richiesta non può essere respinta", ha detto Abu Mazen. "La pace non può passare attraverso le risoluzioni internazionali, ma solo attraverso il negoziato", ha risposto Netanyahu. Comunque, un punto di svolta simbolico. Anche se la richiesta al Consiglio di Sicurezza è destinata, con ogni probabilità, a cadere nel vuoto.
Abu Mazen. Il leader palestinese Abu Mazen ha senz’altro vinto il confronto sul piano della popolarità. Al suo arrivo, davanti all’assemblea generale, è stato accolto da un lungo applauso. Pochi minuti prima era entrato nell’ufficio del segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, per presentare la richiesta formale di riconoscimento come 194esimo Stato all’Onu. In mano una cartellina bianca con al centro l’aquila palestinese.
"Abbiamo tentato tutte le strade per la pace", è stato l’esordio - davanti all’assemblea - dell’intervento di Abu Mazen. Che poi, però, ha lanciato un durissimo attacco contro la politica israeliana, la confisca delle terre palestinesi, il progressivo aumento delle colonie. "Israele continua la sua campagna demolitrice e la sua pulizia etnica verso i palestinesi", ha detto. Aggiungendo: "Lo stato ebraico minaccia i nostri luoghi sacri. Gli insediamenti minacciano l’esistenza stessa dell’Anp. Questa politica israeliana provoca lo stop del processo di pace e distrugge le possibilità di arrivare alla soluzione ’due popoli due Stati’, sulla quale c’è il consenso della comunità internazionale".
Abu Mazen ha scatenato un applauso quando ha citato lo storico leader dell’Olp, Yasser Arafat. "Nel 1974 - ha ricordato - Arafat venne qui ad assicurare la volontà di pace dei palestinesi ma disse anche non lasciate che i rami d’ulivo cadano dalle mie braccia". "Siamo l’ultimo popolo sotto occupazione straniera. Ne abbiamo abbastanza", ha detto ancora tra gli applausi. E poi ha chiesto, retoricamente: "Il mondo permetterà a Israele di stare sopra la legge e di rifiutare le risoluzioni dell’Onu e quelle della Corte di Giustizia internazionale? Non credo si possa respingere questa richiesta di riconoscimento". Infine, lo spiraglio per la pace: "Siamo pronti a tornare al tavolo del negoziato sulla base della legalità internazionale e della fine dell’attività degli insediamenti", ha detto il presidente palestinese. "Io dico agli israeliani, fate un passo verso la pace".
Mentre era in corso l’intervento, c’è stato un fuori programma. Un uomo ha provato a entrare nell’aula dell’Assemblea, ma è stato bloccato dagli uomini della sicurezza.
Discorso di Netanyahu. Il premier israeliano Netanyahu non era presente durante il discorso di Abu Mazen. Ha preso la parola mezz’ora dopo. E ha cominciato il suo discorso aprendo uno spiraglio: "Tendo la mano ai palestinesi per una pace giusta e durevole". Poi, però, ha detto che la pace non può essere raggiunta attraverso risoluzioni internazionali ma solo con la trattativa diretta tra i due popoli. Infine ha accusato l’altra parte: "Non sono venuto a prendere applausi, sono venuto a dire la verità e la verità è che Israele vuole la pace con i palestinesi", ma "i palestinesi vogliono uno Stato senza la pace". E ancora: "La vera pulizia etnica sarà quella dei palestinesi che, nel loro nuovo Stato, non permetteranno l’ingresso degli ebrei". Quindi ha detto: "E’ tempo che i palestinesi riconoscano Israele come lo Stato ebraico. Viene prima la pace con noi, poi lo Stato palestinese". Poi, rivolto direttamente ad Abu Mazen: "Gli avevamo lasciato le chiavi di Gaza, ma lì l’Autorità palestinese è collassata in un giorno". Infine l’apertura al presidente palestinese: "Ci siamo incontrati una sola volta quest’anno, anche se la nostra porta è sempre rimasta aperta, posso venire a Ramallah, anzi, ho un altra proposta, visto che fatto così tante miglia di volo entrambi: incontriamoci oggi, in questo edificio".
Infine, Netanyahu ha lanciato un attacco a Teheran. "La comunità internazionale deve fermare l’Iran prima che sia troppo tardi o affronteremo tutti lo spettro del terrorismo nucleare". ha detto, mentre il banco della delegazione iraniana era deserto.
Il veto americano. Un punto di svolta per il Medio Oriente, ma la richiesta al Consiglio di Sicurezza è destinata, con ogni probabilità, a cadere nel vuoto. Gli Stati Uniti, infatti, hanno già annunciato il loro veto. "Dobbiamo tutti riconoscere che l’unica strada per creare uno Stato è attraverso negoziati diretti, senza scorciatoie", ha dichiarato l’ambasciatore Usa al Palazzo di Vetro Susan Rice ribadendo il concetto espresso mercoledì da Barack Obama. Veto che la Russia ha fatto sapere di voler sfidare quando la richiesta di riconoscimento arriverà al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per il voto in consiglio i palestinesi dovranno aspettare alcune settimane, ma si sono detti pronti ad attendere prima di studiare delle alternative. Il Quartetto dei mediatori per il Medio Oriente (Onu, Ue, Russia ed Usa) ha comunque definito una road-map per far ripartire i negoziati tra israeliani e palestinesi in base al quale "entrambe le parti si impegneranno a raggiungere un accordo entro un arco temporale che non vada oltre la fine del 2012".
La festa nei territori. Al di là delle complesse procedure dell’Onu, i palestinesi hanno scelto di festeggiare. Un boato della folla ha accolto a Ramallah, come nelle piazze di altre città della Cisgiordania (Betlemme, Hebron, Gerico, Nablus), l’annuncio del presidente palestinese della richiesta di ammissione all’Onu d’uno Stato di Palestina. Il discorso, trasmesso in diretta dai maxischermi davanti a migliaia di persone, è stato punteggiato d’applausi e ovazioni: in particolare quando Abu Mazen ha citato Yasser Arafat, quando ha denunciato con toni forti l’espansione delle colonie israeliane nei Territori occupati, quando ha detto "è tempo per i palestinesi d’avere uno Stato sovrano, libero e indipendente" e quando ha scandito che "dopo 63 anni di tragedia" bisogna dire "basta, basta, basta".
Palestinese ucciso a Nablus. Scontri c’erano stati invece nelle ore precedenti vicino a Nablus, in Cisgiordania. Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti dal fuoco delle truppe israeliane nel villaggio di Kusra. Ha perso la vita un giovane che aveva provato a disperdere una colluttazione di massa tra coloni e palestinesi.
Stato d’allerta in Israele. Per far fronte alla delicata giornata, Israele ha dislocato oltre 20 mila agenti di polizia e ha inviato rinforzi militari in Cisgiordania. A Gerusalemme est migliaia di agenti hanno preso posizione fin dalla prima mattinata per prevenire incidenti durante le preghiere del venerdì nella Spianata delle Moschee. La polizia ha inoltre limitato l’accesso di fedeli islamici in quel santuario. Incidenti si sono così verificati alla fine delle preghiere a Nebi Saleh, Bilin, Naalin e anche al punto di valico di Kalandya, fra Gerusalemme e Ramallah.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- Israele è in pericolo se si isola dal mondo (di Thomas L. Friedman)21 settembre 2011, di Federico La Sala
Israele è in pericolo se si isola dal mondo di Thomas L. Friedman (la Repubblica, 20.09.2011)
NON sono mai stato tanto preoccupato per il futuro di Israele. Lo sgretolamento dei pilastri della sicurezza di Israele - la pace con l’Egitto, la stabilità della Siria e l’amicizia con Turchia e Giordania - abbinato al governo più inetto dal punto di vista diplomatico e più incompetente dal punto di vista strategico della sua storia hanno messo lo Stato ebraico in una situazione pericolosissima.
Il governo americano è stufo marcio di questi leader israeliani, ma è ostaggio della sua inettitudine, perché in un anno di elezioni la potente lobby filoisraeliana può costringere la Casa Bianca a difendere lo Stato ebraico all’Onu anche quando sa che il governo di Tel Aviv sta portando avanti politiche che non sono né nel suo interesse né nell’interesse degli Stati Uniti. Israele non è responsabile del rovesciamento del presidente egiziano Hosni Mubarak o delle rivolte in Siria, o della decisione della Turchia di cercare di ritagliarsi un ruolo guida a livello regionale scagliandosi cinicamente contro Israele per aver spaccato il movimento nazionale palestinese fra Gaza e Cisgiordania. Quello di cui il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu è responsabile è di non aver messo in campo, in risposta a tutte queste trasformazioni, una strategia in grado di difendere gli interessi di Israele sul lungo periodo.
Anzi no, una strategia Netanyahu ce l’ha: non fare nulla, rispetto ai palestinesi o rispetto alla Turchia, che lo costringa ad andare contro la sua base, a scendere a compromessi con le sue idee o a inimicarsi il suo principale partner di coalizione, l’estremista di destra Avigdor Lieberman, che ricopre l’incarico di ministro degli Esteri. Dopo di che, chiedere aiuto agli Stati Uniti per bloccare il programma nucleare iraniano e per farsi tirar fuori da pasticci di ogni genere, ma fare in modo che il presidente Barack Obama non possa chiedere nulla in cambio mobilitando i Repubblicani al Congresso per mettergli i bastoni fra le ruote e incoraggiando i principali esponenti della comunità ebraica a insinuare che Obama è ostile a Israele e sta perdendo i voti degli ebrei. Ecco qua: non si può certo dire che Netanyahu non abbia una strategia.
«Anni di sforzi diplomatici per far accettare Israele in Medio Oriente sono crollati in una settimana con l’espulsione degli ambasciatori dello Stato ebraico da Ankara e dal Cairo, e con la frettolosa evacuazione del personale dell’ambasciata da Amman», ha scritto Aluf Benn sul quotidiano israeliano Haaretz. «La regione sta rigettando lo Stato ebraico, che si rinchiude sempre di più dietro mura fortificate, sotto la guida di una leadership che rifiuta qualsiasi cambiamento, movimento o riforma [...] Netanyahu ha dato prova di una passività totale di fronte ai drammatici cambiamenti avvenuti nella regione e ha consentito ai suoi rivali di prendere l’iniziativa e fissare l’agenda».
Che cosa avrebbe potuto fare Israele? L’Autorità Palestinese, che negli ultimi cinque anni ha fatto grandi passi avanti nella costruzione delle istituzioni e delle forze di sicurezza di uno Stato in Cisgiordania, alla fine si è detta: «I nostri sforzi per costruire lo Stato non hanno indotto Israele a fermare gli insediamenti o a impegnarsi per giungere alla separazione dei Territori Occupati, perciò in pratica non stiamo facendo altro che sostenere l’occupazione israeliana. Andiamo alle Nazioni Unite, facciamoci riconoscere come Stato all’interno dei confini del 1967 e combattiamo Israele in questo modo». Una volta resosi conto della situazione, Israele avrebbe dovuto proporre un suo piano di pace o cercare di influenzare la diplomazia dell’Onu con una risoluzione che riaffermasse il diritto sia del popolo palestinese che di quello ebraico di avere uno Stato all’interno dei confini storici della Palestina, e facendo ripartire i negoziati.
Netanyahu non fatto nessuna delle due cose e ora gli Stati Uniti si stanno barcamenando per disinnescare la crisi, per non essere costretti a opporre un veto alla proposta di creare lo Stato palestinese, una mossa che potrebbe rivelarsi disastrosa in un mondo arabo che marcia sempre più verso l’autogoverno popolare.
Quanto alla Turchia, la squadra di Obama e gli avvocati di Netanyahu in questi ultimi due mesi hanno lavorato instancabilmente per risolvere la crisi nata dall’uccisione di civili turchi da parte di agenti delle forze speciali israeliane nel maggio del 2010, quando la flottiglia turca cercava in tutti i modi di sbarcare a Gaza per portare aiuti alla popolazione. La Turchia pretendeva scuse ufficiali. Poi però Bibi ha smentito i suoi stessi avvocati e ha respinto l’accordo, per orgoglio nazionale e per paura che Lieberman lo usasse contro di lui. Risultato: la Turchia ha espulso l’ambasciatore israeliano. Quanto all’Egitto, la stabilità lì ormai è un ricordo e qualunque nuovo Governo al Cairo dovrà fare i conti con pressioni populiste antisraeliane più forti che mai. Tutto questo in parte è inevitabile, ma perché non mettere in campo una strategia per minimizzare il problema proponendo un vero piano di pace?
Ho grande simpatia per il dilemma strategico di Israele e non mi faccio nessuna illusione sui suoi nemici. Ma Israele oggi non offre ai suoi amici - e Obama è fra loro - nessun elemento per difenderlo. Israele può scegliere di combattere contro tutti oppure può scegliere di non arrendersi e attutire il colpo ricevuto con un’apertura, sul fronte delle trattative di pace, che gli osservatori equilibrati possano considerare seria, in modo da limitare il suo isolamento. Purtroppo oggi Israele non può contare su un leader o su un esecutivo capace di simili sottigliezze diplomatiche. Non resta che sperare che gli israeliani se ne rendano conto prima che questo Governo precipiti ancora di più lo Stato ebraico nell’isolamento, trascinandosi dietro l’America.
Traduzione di Fabio Galimberti
-
> ISRAELE ---- OCCASIONE DA NON PERDERE. Abu Mazen, il 21 settembre, parlerà alle Nazioni Unite in seduta plenaria per chiedere il riconoscimento formale dello Stato palestinese (di Moni Ovadia)10 settembre 2011, di Federico La Sala
Occasione da non perdere
di Moni Ovadia (l’Unità, 10.09.2011)
Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, il 21 settembre, parlerà alle Nazioni Unite in seduta plenaria per chiedere il riconoscimento formale dello Stato palestinese.
La comunità internazionale ha un’opportunità preziosa per riparare ad uno dei più gravi torti commessi nella seconda metà del Novecento nei confronti di un piccolo popolo esemplare nella sua dignità e nel suo coraggio, il popolo palestinese che vive sotto occupazione militare israeliana da quasi cinquant’anni, con milioni dei suoi figli dispersi nell’ esilio, espulsi dalle loro terre, con la sua gente privata di ogni diritto, vessata quotidianamente da una colonizzazione perversa ed espropriatrice. La comunità internazionale non può perdere l’occasione di dare avvio ad un processo riparatore dei guasti e delle devastazioni del colonialismo che sono state all’origine del dramma mediorientale.
La decisione di accogliere lo Stato di Palestina nella comunità delle nazioni non potrà non mettere alle corde la politica del governo Netanyahu che mira alla strisciante e progressiva espropriazione dell’identità palestinese attraverso la compressione dei suoi spazi di esistenza e di cultura fino a ridurla ad una marginalità impotente.
Proprio in questi giorni un milione di israeliani chiedono giustizia sociale, sono gli indignados. Costoro, in risonanza con le primavere arabe potrebbero rimettere in moto un’energia virtuosa che faccia uscire gli israeliani dalla palude del discredito e dell’isolamento al quale li condannano il reaganiano Bibi e il razzista Lieberman, per farli entrare in un futuro migliore di quello del «ghetto» supermilitarizzato.
-
> ISRAELE ---- OCCASIONE DA NON PERDERE. L’Europa lacerata sullo Stato palestinese all’assemblea Onu (di Luigi Offredu)15 settembre 2011, di Federico La Sala
Il 20 il dibattito sul riconoscimento
L’Europa lacerata sullo Stato palestinese all’assemblea Onu
di Luigi Offeddu (Corriere della Sera, 15.09.2011)
BRUXELLES - Fra 5 giorni la Disunione Europea, come qualcuno la chiama beffardamente da anni, sarà chiamata a confermare o smentire questo suo nomignolo, in un palazzo di vetro a New York. Nella mattina del 20 settembre il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon aprirà infatti formalmente il dossier con la richiesta presentata dall’Anp, l’Autorità nazionale palestinese, per il riconoscimento di uno Stato sovrano di Palestina.
Se la risposta venisse demandata direttamente ai 193 Stati che siedono nell’Assemblea generale dell’Onu (non è sicuro, lungo il percorso potrebbe impantanarsi nel Consiglio di sicurezza, dove gli Stati Uniti farebbero quasi certamente valere il loro diritto di veto) allora una fra le decisioni più laceranti e drammatiche dai tempi della Seconda guerra mondiale potrebbe giocarsi su un pugno di voti: i due terzi dell’assemblea, 129, quelli necessari per approvare una risoluzione a maggioranza. E fra i voti più incerti di tutti, ci sono proprio quelli dei 27 Paesi europei. Perché sono fra le 125 e le 140 - si procede a spanne, tutti sono oggi impegnati al silenzio ufficiale - le nazioni che avrebbero già deciso, in un senso o nell’altro. Si va da Israele e dagli Usa, nella trincea del no, a quasi tutta la fetta africana e asiatica del pianeta, nella trincea del sì: pronta se non altro ad assegnare alla Palestina un ruolo di Paese osservatore non membro dell’Onu, senza diritto di voto, come il Vaticano. Questo sarebbe l’unico responso dell’assemblea che aggirerebbe in partenza il parere del Consiglio di sicurezza, e dunque le forche caudine del veto americano. E l’Europa? Fermamente concorde nel disaccordo, appunto. Con un unico principio condiviso: «Una terra, due Stati, attraverso negoziati arabo-israeliani». Ma la Palestina sovrana, e subito, con riconoscimento unilaterale da parte dell’Onu?
Risposte in ordine sparso. Spagna, Francia, Lussemburgo («La Ue non può dar nulla ai palestinesi, almeno dia loro la dignità»), Grecia, Irlanda, Svezia e altri (come la Norvegia, al di fuori della Ue) sarebbero per il sì. Germania, Italia, Olanda, Bulgaria, Repubblica Ceca e altri per il no. La Polonia sarebbe in posizione attendista. Ieri Franco Frattini, il ministro degli Esteri italiano, ha detto che davanti al ricorso palestinese bisogna «evitare una divisione della Ue», cioè «ricercare una piattaforma comune» e «facilitare le iniziative che favoriscono la ripresa urgente del dialogo». Ma ha poi aggiunto che anche l’Italia non ha ancora assunto una «posizione formale in sedi ufficiali». La scommessa è quella di ricompattare tutti, in 5 giorni. «Tutti» vuol dire anche il capo, cioè il ministro degli Esteri della Ue Catherine Ashton, che viene accreditata come filo-palestinese. E che per questo è mal guardata da quei Paesi che accettano il ragionamento proposto dal ministro delle Finanze israeliano Yuval Steinitz: chi offre sostegno a una Palestina sovrana, è motivato anche da antiche pulsioni antisemite. Le discussioni continuano, la Disunione Europea si prepara al nuovo esame.
-
-
> ISRAELE ---- Spiegare come si esce dall’Egitto, come si esce dalla logica di Auschwitz. intervista a Haim Baharier. (a c. di Guido Caldiron)..5 settembre 2011, di Federico La Sala
«Dal Talmud a Internet: l’ebraismo e il molteplice»
intervista a Haim Baharier
a cura di Guido Caldiron (Liberazione, 3 settembre 2011)
“Ebr@ismo 2.0: dal Talmud a Internet”. La dodicesima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si svolge domani in 27 paesi europei e 62 località italiane, intende rileggere la storia plurimillenaria dell’ebraismo alla luce dei nuovi strumenti della cultura e della comunicazione. Un invito all’incontro e alla conoscenza che apre le porte di sinagoghe, musei e quartieri ebraici, presentando concerti, mostre e spettacoli teatrali, proponendo percorsi enogastronomici, visite guidate e appuntamenti culturali.
Quest’anno capofila della manifestazione, organizzata dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sarà Siena (il programma città per città è disponibile sul sito www.ucei.it/giornatadellacultura) dove alle ore 18 si svolgerà la Lectio Magistralis di Haim Baharier, intitolata “Il mondo che viene”. Nato a Parigi da genitori di origine polacca, entrambi passati per Auschwitz, Baharier è stato allievo del filosofo Emmanuel Lévinas e di Léon Askenazi ed è considerato uno dei grandi maestri contemporanei dell’ermeneutica biblica e del pensiero ebraico. Da molti anni vive e lavora a Milano. Per Garzanti ha pubblicato Il tacchino pensante (2006) e La Genesi spiegata da mia figlia (2008).
 Dal Talmud a Internet, quale è il senso di questo viaggio nella cultura ebraica?
Dal Talmud a Internet, quale è il senso di questo viaggio nella cultura ebraica?Ho cercato di dare un nome a questo percorso che vuole essere come un ponte, attingendo alla tradizione: così per accompagnarmi in questo viaggio ho utilizzato un’espressione che in ebraico significa “il mondo che viene”. Su questo concetto i saggi discutono da secoli e secoli e sono emerse due grandi scuole di pensiero: quella che fa capo a Maimonide che ritiene che “il mondo che viene” rimanda a livelli di interiorità che si sono costruiti dentro ciascun essere umano e che, dall’anima, vengono trasmessi per vite future; e quella che fa capo a Nachmanide che definisce come “mondo che viene” quello che fa seguito alla resurrezione dei morti. Gli uomini moderni tendono a sorridere di fronte a simili impostazioni, ma personalmente credo si possa operare una sintesi tra questi due percorsi e immaginare che oggi il punto d’approdo sia definibile nell’idea della “vita perenne della parola”. Il Talmud è la parola, ciò che ci consente di leggere con apertura mentale e riguardo verso l’alterità, una tradizione. Questa lettura diventa tempo, speranza, progetto: io leggo in un certo modo, altri lo faranno a modo loro. Questa è l’idea e il significato del Talmud. E quindi perché non considerare internet come una sorta di secolarizzazione di tutto ciò: la rete fa del resto coesistere e rende possibili tutte le diverse letture nello stesso momento. Perciò l’utilizzo etico e morale di internet riecheggia proprio l’esperienza talmudica e non può che rappresentare per l’identità degli ebrei, ma anche per la terra di Israele, l’orizzonte di una realtà molteplice e di una piena coesistenza tra diversità.
 Da dopo la Shoah l’ebraismo viene soprattutto associato alla memoria, immaginare questo
ponte verso il futuro rappresenta una sfida in più per la cultura ebraica?
Da dopo la Shoah l’ebraismo viene soprattutto associato alla memoria, immaginare questo
ponte verso il futuro rappresenta una sfida in più per la cultura ebraica?Questo per me è un punto davvero sensibile: sono infatti anni che combatto questa idea della memoria celebrativa. Penso che l’equazione terrificante che è stata imposta che è “memoria, uguale, non si riprodurrà più” sia totalmente inattendibile e non abbiamo dovuto aspettare tanto per vedere che delle “mini-Shoah” accadono in varie parti del mondo malgrado il moltiplicarsi dei musei e delle memorie celebrative. Credo che ci si debba intendere sul significato e il valore della parola memoria nella tradizione ebraica. In particolare la memoria della Shoah dovrebbe essere quella che ci conduce a comprendere come si esce dalla logica dello sterminio e quindi come si può evitare di entrare in questa logica: è questa la memoria.
Nella tradizione ebraica c’è un vero paradigma di questo processo che è la schiavitù d’Egitto che è paragonabile a una Shoah, nel senso che il progetto del Faraone era un vero e proprio etnocidio. E la Torah liquida in poche righe ciò che è successo, lamemoria celebrativa, mentre dedica tutto il suo corpus a spiegare come si esce dall’Egitto, come si esce dalla logica di Auschwitz e come poi questa uscita possa essere teorizzata e trasmessa a tutti i popoli della terra.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- «Il muro israeliano a Gerusalemme come quello del ghetto di Varsavia». Il sociologo Bauman riapre la polemica sullo sterminio degli ebrei.4 settembre 2011, di Federico La Sala
«Il muro israeliano a Gerusalemme come quello del ghetto di Varsavia»
Il sociologo Bauman riapre la polemica sullo sterminio degli ebrei
di Francesco Battistini (Corriere della Sera, 02.09.2011)
GERUSALEMME - Com’è malmessa, la Terra Promessa. E bellicosa. E senza pace, perché timorosa della pace. E quanto specula sulla Shoah. E quel muro che divide Israele e la Cisgiordania, poi: roba da nazisti, altroché, niente da invidiare alla muraglia che chiuse il Ghetto di Varsavia... Quante volte li avete sentiti, questi argomenti? Cose già dette, già lette. Già proclamate, già contestate. Così ripetute che nemmeno ci finiscono più, sui giornali israeliani, quando arrivano da chi se l’aspettano.
Diverso, però, se a dirle è Zygmunt Bauman, uno dei più grandi sociologi viventi, ebreo di Poznan che da bimbo visse le persecuzioni hitleriane e da adulto le purghe comuniste, che trovò rifugio a Tel Aviv per preferire poi l’Inghilterra. E che in un’intervista a un settimanale polacco, Politika, ha rovesciato sui politici di Gerusalemme la più urticante delle accuse: di fare ai palestinesi quel che fecero le Ss. «Parole inaccettabili - ha protestato formalmente il governo Netanyahu, in una lettera al giornale del suo ambasciatore in Polonia -. Sgradevoli, ingiuste e senza alcuna base di verità».
Il muro di Betlemme come il muro di Varsavia: si può paragonare l’orribile barriera antiterrorismo all’orrore che fece morire mezzo milione d’ebrei? Bauman, premio Adorno, critico dei totalitarismi e del negazionismo, a 85 anni si permette di rompere il tabù: «Israele sta traendo vantaggio dall’Olocausto per legittimare azioni inconcepibili». Pugno, ergo sum: combatto, quindi esisto? Bauman ne è stracerto: «I politici israeliani sono terrorizzati dalla pace. Tremano, col terrore della possibilità d’una pace. Perché senza guerra e senza una mobilitazione generale, non sanno come vivere. Israele non vede come un male i missili che cadono sulle cittadine lungo i confini. Al contrario: i politici sarebbero preoccupati, perfino allarmati, se non piovesse questo fuoco». E ancora, citando un suo articolo pubblicato su Haaretz, lo stesso giornale israeliano che giorni fa ha ospitato lo scrittore Günter Grass e il suo parallelo fra le vittime della Shoah e le vittime tedesche della Seconda guerra mondiale: «Sono preoccupato - dice il sociologo polacco - del fatto che gl’israeliani più giovani crescano nella convinzione che lo stato di guerra e l’allerta militare siano naturali e inevitabili».
Vite di scarto: sulle opinioni di Bauman, l’opinione pubblica israeliana ha meno certezze della classe politica. Basta leggere i commenti Web all’intervista: «Sono d’accordo, questa destra ci porta alla rovina», scrive Linda, ebrea newyorkese; «è come paragonare le mele alle arance», è perplesso Bobin, di Tel Aviv; «dategli una casa gratis a Sderot - boccia Moshe - e vada là a prendersi i missili da Gaza». Il dibattito finisce anche in tv: un po’ perché è di questi giorni la storia delle scuole francesi che cancellano la Shoah dai libri di testo, e questi veleni qui fanno sempre impressione; un po’ perché Bauman, atteso da oggi a Sarzana per la sua lectio al Festival della Mente, è molto conosciuto (per tre anni insegnò all’università, i suoi libri sono tradotti in ebraico) e ha posizioni che a molti ricordano un’altra bestia nera della destra, lo storico israeliano Ilan Pappé.
«Io ammiro molto il professor Bauman e la sua storia - dice al Corriere l’ambasciatore israeliano a Varsavia, Zvi Rav-Ner, 61 anni, origini polacche -. Lui è stato un esempio: dovette andarsene dalla Polonia nel ’68, per i pogrom contro gli ebrei. Perciò siamo molto stupiti che abbia detto cose d’un odio così cieco. Dal ’71, il professore è tornato in Israele solo tre volte: forse non sa bene che oggi è uno Stato democratico, dov’è ammessa qualsiasi critica, anche la più aspra. Ma dove queste parole sono considerate da antisemita. Le stesse che dicevano i comunisti polacchi dopo la guerra dei Sei giorni: quelli che cacciarono Bauman».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- Contro Netanyahu 400 mila in piazza Gli indignados israeliani rilanciano la sfida4 settembre 2011
LA PROTESTA
Contro Netanyahu 400 mila in piazza
Gli indignados israeliani rilanciano la sfida
E’ la più importante mobilitazione mai avvenuta nel Paese: manifestazioni a Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa, Eilat. Nel mirino, il carovita e le politiche sociali del governo. Il premier costretto a promettere riforme economiche
TEL AVIV - Li hanno chiamati gli indignados israeliani. Da otto settimane martellano il governo protestando contro il carovita, chiedendo riforme economiche all’insegna di una maggiore equità sociale. Erano partiti montando una singola tenda in Rothschild Boulevard, a Tel Aviv. Ora sono riusciti a portare in piazza 400 mila persone, in 15 diverse città israeliane. La manifestazione più imponente proprio a Tel Aviv, con 250 mila persone in piazza: ma erano in decine di migliaia anche a Gerusalemme, a Haifa nel nord, a Eilat sul Mar Rosso. Scuotendo tutto il Paese da un lungo periodo di apatia sociale.
Il loro obiettivo, in realtà, era portare in piazza un milione di persone. E per questo qualcuno adesso parla di fallimento. Ma era una sfida irrealistica, visti i numeri della popolazione israeliana (7 milioni). E si tratta comunque della più grande mobilitazione mai avvenuta nel Paese. Tanto che il premier, Benyamin Netanyahu, è stato costretto a promettere in pubblico un pacchetto di riforme rispetto alla politica liberista finora seguita. Probabile un intervento di riduzione dei carichi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei settori della classe media rimasti esclusi dalla crescità del Pil di questi anni; e poi un piano di edilizia popolare e più fondi all’istruzione. Tutti provvedimenti raccomandanti da una commissione ad hoc, guidata dall’economista Manuel Trajtenberg. E - stando almeno alle promesse - i tempi dovrebbero essere rapidi: entro il Capodanno ebraico, vale a dire fine settembre.
Per la piazza - che non ha risparmiato neppure oggi poster sarcastici e sfottò al premier - si tratta al momento solo di parole: il governo, insomma, starebbe solo cercando di prendere tempo. E i manifestanti si sono detti pronti a continuare. "Hanno sostenuto che la nostra protesta sta segnando il passo", ha detto uno degli organizzatori, il segretario generale degli studenti israeliani, Itzik Shmuli. "Noi, i nuovi israeliani siamo determinati a continuare la lotta per una società più giusta e migliore, pur sapendo che la strada sarà lungo e difficile". Il movimento aveva perso un po’ di slancio la settimana scorsa, dopo la pausa imposta dall’escalation di attentati nel sud e dalle tensioni sul fronte della Striscia di Gaza. Ma è riuscito ad andare al di là dei soli temi della sicurezza e della paura, cavalli di battaglia della destra di governo.
* la Repubblica, 03 settembre 2011
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- LA NON BANALITA’ DEL MALE. Moshe Landau, il giudice che condannò Eichmann e contestò la Arendt (di Gabriele Nissim).27 giugno 2011, di Federico La Sala
La non banalità del male
Landau, il giudice che condannò Eichmann e contestò la Arendt
di Gabriele Nissim (Corriere della Sera, 27.06.2011)
Moshe Landau credeva profondamente nell’autonomia e nell’imparzialità della magistratura. Quando lo incontrai a casa sua una decina di anni fa si lamentò per il comportamento di certi magistrati in Israele che amavano rilasciare dichiarazioni pubbliche. «Un giudice esercita il suo lavoro soltanto in tribunale, altrimenti rischia di non essere credibile. Egli deve ricercare la verità nel corso dei processi e non cercare facili consensi nell’opinione pubblica» . Fu questo lo spirito che lo guidò nel corso del processo Eichmann. Si impegnò fin dal primo giorno affinché non assumesse una natura propagandistica, ma giudicasse esclusivamente le responsabilità dell’imputato. Per questo motivo chiese al procuratore Hausner di limitare gli interventi dei testimoni che si dilungavano sul racconto delle loro sofferenze: «Io sono consapevole che è difficile interrompere certe testimonianze, ma penso che sia suo dovere spiegare ai testimoni che devono concentrarsi soltanto sugli argomenti attinenti al processo» .
Nella sentenza che decretò la condanna a morte di Adolf Eichmann confutò le tesi difensive del criminale nazista che nel corso del dibattimento cercò di giustificarsi, sostenendo di avere soltanto obbedito a degli ordini. «Anche se fosse stato provato che l’imputato avesse agito per obbedienza cieca, come egli sosteneva, avremmo comunque detto che un uomo che ha preso parte a crimini di tale portata avrebbe dovuto scontare la pena massima e non avrebbe potuto ottenere una riduzione della pena. Ma abbiamo invece scoperto che l’imputato ha agito per un’identificazione interiore con gli ordini che gli erano stati dati e per una forte volontà di raggiungere l’obiettivo criminale. È per noi irrilevante se questa identificazione o volontà sia il risultato della formazione che ricevette in quel regime, come sostiene la difesa» .
Riflettendo su quel suo giudizio domandai a Landau cosa pensasse del libro di Hannah Arendt su Eichmann e della sua tesi sulla banalità del male. Non glielo avessi mai chiesto! Pronunciando soltanto il nome della filosofa di Hannover mi giocai la reputazione. Moshe Landau mi guardò storto emi disse di essersi scontrato duramente con Hannah Arendt a casa di Kurt Blumenfeld, presidente della federazione sionista tedesca fino all’avvento di Hitler. «Eichmann ha fatto uccidere gli ebrei con profonda convinzione. Altro che banale... amava con tutto il suo cuore il lavoro che faceva. Ha agito in questo modo perché pensava come un nazista, non perché non era in grado di pensare» .
Recentemente sono stati pubblicati dal settimanale «Der Spiegel» alcuni documenti che sembrano confermare le osservazioni di Moshe Landau. In una conversazione registrata con dei suoi amici nazisti in Argentina prima dell’arresto, Eichmann esprime dispiacere per non avere portato a termine il suo lavoro: «Noi non abbiamo lavorato bene. Si poteva fare molto meglio» . E poi aggiunge: «Io non ero un semplice esecutore di ordini. Non ero uno stupido, facevo parte dei pensatori del progetto. Io ero un idealista» .
Daniel Goldhagen nel suo ultimo libro Peggio della guerra (Mondadori), polemizzando con Hannah Arendt, ricorda che il vero Eichmann era profondamente antisemita e fiero di esserlo. Egli stesso confessò a degli amici nazisti che a motivarlo nelle sue azioni era una convinzione interiore: da qui nasceva il suo fanatismo. «Quando giunsi alla conclusione che fare agli ebrei quello che abbiamo fatto era necessario, lavorai con tutto il fanatismo che un uomo può aspettarsi da se stesso. Non c’è dubbio che mi considerassero l’uomo giusto al posto giusto... Ho agito sempre al cento per cento, e nell’impartire ordini non ero certo fiacco» .
Ancora più rilevante, ricorda Goldhagen, è il fatto che Eichmann si vantava dei milioni di ebrei che aveva ucciso. Pochi mesi prima della fine della guerra disse al suo vice: «Riderò quando salterò dentro la tomba al pensiero che ho ucciso cinque milioni di ebrei. Mi dà molta soddisfazione e molto piacere» . Sono queste le parole- si chiede l’autore- di un burocrate che fa il suo lavoro senza pensare, senza riflettere, senza avere una particolare opinione?
Ha avuto dunque torto Hannah Arendt quando ha dipinto il carnefice nazista come un uomo mediocre e superficiale e lo ha presentato nei suoi scritti come l’emblema degli uomini che commettono i più orribili delitti senza porsi nessun interrogativo morale?
In realtà la filosofa ha cercato nel suo libro di introdurre un nuovo punto di vista sui responsabili del male estremo. «Le sue azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco, né mostruoso» . Ha voluto così sottolineare come gli omicidi di massa nei totalitarismi non sono stati progettati ed eseguiti da uomini che agivano per il gusto del male ma da esseri comuni. Ecco l’intuizione della banalità del male, un’ipotesi per nulla rassicurante, come aveva sottolineato lo scrittore Vasilij Grossman analizzando i delatori che mandavano le persone a morire nei gulag. Grossman osservava che il male veniva compiuto da persone che apparentemente sembravano per bene. «Sapete cosa c’è di più ripugnante nei delatori? Quel che di cattivo c’è in loro, penserete. No! È più terribile ciò che vi è di buono; la cosa più triste è che sono pieni di dignità, che sono gente virtuosa. Loro sono figli, padri, mariti teneri e amorosi, gente capace di fare del bene, di avere grande successo nel lavoro» .
Eichmann, come aveva osservato la Arendt durante il processo, aveva cercato di mostrarsi come un burocrate irreprensibile che eseguiva con zelo gli ordini ricevuti e rispettava le leggi dell’epoca. Si è creato però nel corso degli anni un equivoco sul pensiero della filosofa tedesca. È parso a molti suoi critici, soprattutto in Israele, che il concetto di banalità del male possa venire applicato soltanto a una categoria di persone: coloro che di fronte a dei crimini voltano la testa dall’altra parte e che eseguono degli ordini terribili senza riflettere. Chi invece è convinto di un’ideologia eliminazionista (come lo era appunto Eichmann) non rientra nella tipologia descritta da Hannah Arendt.
Invece, per la filosofa, chi viene sedotto dalle sirene di un’ideologia che propone per la felicità del genere umano l’eliminazione di una parte «infetta» dell’umanità e crede che il mondo possa essere spiegato con un’idea di pura fantasia applicata alla realtà, rientra a pieno titolo nel novero delle persone che abdicano al pensiero. Eichmann aveva molte facce: si comportava come un burocrate ossequiente al potere e nello stesso tempo era convinto della missione a cui era stato chiamato da Hitler, l’eliminazione degli ebrei. Ma in ogni caso egli aveva chiuso la sua mente a ogni forma di compassione, di giudizio e d’inquietudine della propria coscienza: era banale, anche se era convinto di quello che faceva. È quanto probabilmente non ha capito delle osservazioni della Arendt lo straordinario giudice del processo Eichmann, scomparso poche settimane fa, proprio a cinquant’anni dal processo che lo vide protagonista.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT ----- FILOSOFIA IN STATO COMATOSO. USCIRE DAL "CERCHIO DEI CERCHI" DELLA FILOSOFIA HEGELIANA.24 giugno 2011, di Federico La Sala
SAPERE AUDE! USCIRE DAL "CERCHIO DEI CERCHI" DELLA FILOSOFIA DI HEGEL.
PAROLA DI ENRICO BERTI: Più realista, e meno illuminista, di Kant è stato Hegel, il quale ha criticato i pedagogisti suoi contemporanei che volevano insegnare a «pensare con la propria testa».
E’ talmente vero quello che pensa Berti (e, con lui, la maggioranza dei suoi colleghi di filosofia e storia della filosofia) che qualsiasi studente e ogni studentessa per educarsi all’uso della sua propria intelligenza e alla sua "facoltà di giudizio" deve ricorrere non alle sue (e loro) letture di Kant, ma a qualche perito o a qualche manuale di estimo: l’estimo è la disciplina che ha la finalità di fornire gli strumenti metodologici per la valutazione dei beni per i quali non sussiste un apprezzamento univoco!!!
MATERIALI SUL TEMA, NEL SITO, IN:
Gioacchino - da Fiore!!!
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- LA LINGUA DEL POTERE: COSI’ I NAZISTI ASSERVIRONO I CITTADINI.Victor Klemperer, scampato alla Shoah, analizzò il lessico del regime negli anni di Hitler (si Tobia Zevi).9 giugno 2011, di Federico La Sala
La distruzione del parlare
Victor Klemperer, scampato alla Shoah, analizzò il lessico del regime negli anni di Hitler
Il linguaggio venne prostituito per trasformare i tedeschi in ingranaggi di un organismo criminale
La lingua del potere: così i nazisti asservirono i cittadini
«Lti» sta per «lingua tertii imperii», ed è il titolo del taccuino (edito da Giuntina) in cui l’ebreo Kemperer annotò il processo di formazione di una nuova lingua del potere durante i 12 anni di nazismo.
di Tobia Zevi (l’Unità, 09.06.2011)
Esce oggi in libreria l’edizione aggiornata di Lti La lingua del terzo Reich di Victor Klemperer (Giuntina), arricchita di nuove note. Un libro straordinario e relativamente sconosciuto. L’autore fu uno studioso ebreo di letteratura francese, professore al Politecnico di Dresda, sopravvissuto alla Shoah grazie alla moglie «ariana» e alle bombe anglo-americane che distrussero la città, consentendo ai pochissimi ebrei ancora vivi di confondersi nella moltitudine di sfollati. Il volume raccoglie annotazioni sulla lingua del regime compilate nei dodici anni di nazismo: l’acronimo, criptico per la Gestapo, sta per lingua tertii imperii; la scelta di dedicarsi a questo studio mentre agli ebrei era vietato persino possedere dei libri si rivelò un sostegno psicologico per Klemperer, perseguitato per la sua religione e costretto a risiedere in varie «case per ebrei».
La lingua tedesca, secondo il filologo, fu prostituita strumentalmente dai nazisti per trasformare i cittadini in ingranaggi di un organismo potente e criminale. L’obiettivo di questa operazione era ridurre lo spazio del pensiero e della coscienza e rendere i tedesci seguaci entusiasti e inconsapevoli del Führer. Così si spiega l’abuso, la maledizione del superlativo: ogni gesto compiuto dalla Germania è «storico», «unico», «totale». Le cifre fornite dai bollettini di guerra sono incommensurabili e false contrariamente all’esattezza tipica della comunicazione militare e impediscono il formarsi di un’ opinione personale. Termini del lessico meccanico vengono impiantati massicciamente nel tessuto linguistico per favorire l’identificazione di ognuno nel popolo, nel partito, nel Reich; da una parte c’è la razza nordica, dall’altra il nemico, generalmente l’Ebreo, significativamente al singolare. Joseph Goebbels arriva ad affermare: «In un tempo non troppo lontano funzioneremo nuovamente a pieno regime in tutta una serie di settori».
Il terreno è stato arato accuratamente. Il sistema educativo, che ha nella retorica di Adolf Hitler il suo culmine, viene messo a punto da Goebbels, il «dottore», e da Alfred Rosenberg, l’«ideologo»: l’addestramento sportivo e militare sono preferiti a quello intellettuale, ritenuto disprezzabile. La «filosofia» è negletta come il vocabolo «sistema», che descrive una concatenazione logica del pensiero; amatissime sono invece l’«organizzazione» (persino quella dei felini tedeschi, da cui i gatti ebrei verranno regolarmente espulsi!) e la Weltanschauung, testimonianza di un’ambizione alla conoscenza impressionistica basata sul Blut und Boden. Decisivo a questo proposito è l’impiego frequentissimo di «fanatismo» e «fanatico» come concetti positivi. L’amore per il Führer è fanatico, altrettanto la fede nel Reich, persino l’esercito combatte fanaticamente. Il valore risiede ormai nell’assenza del pensiero e nella fedeltà assoluta (Gefolgshaft) al nazismo e ad Adolf Hitler. Di quest’ultimo si parla saccheggiando il lessico divino, familiare al popolo, per deificarlo compiutamente: «Tutti noi siamo di Adolf Hitler ed esistiamo grazie a lui», «...tanti non ti hanno mai incontrato eppure sei per loro il Salvatore».
Ma come ha potuto imporsi una simile corruzione, in ogni classe sociale, fino alla distruzione completa della Germania? Goebbels fu abile nell’immaginare un idioma poverissimo, veicolato da una macchina propagandistica formidabile, in grado di miscelare elementi aulici con passaggi triviali: l’ascoltatore, perennemente straniato, finisce per perdere la sua facoltà di giudizio. Klemperer ripercorre immagini, simboli e parole-chiave del Romanticismo tedesco, individuando in quest’epoca le radici culturali profonde dell’ideologia della razza, del sangue, del sentimento. Una stagione così gloriosa della tradizione germanica fu dunque capace di iniettare i germi del veleno; l’esaltazione dell’assenza di ogni limite (entgrenzung) e della passione sfrenata deflagrò nel mostro nazista e nell’ideologia nazionalista.
Leggere oggi questo volume fa un certo effetto. Nella sua autobiografia Joachim Fest, giornalista e intellettuale tedesco di tendenza liberale, descrive la resistenza tenace di suo padre alle pressioni e alle lusinghe del regime. Una resistenza borghese, culturale, religiosa che in parte si rispecchia nell’incredulità disperata dell’ebreo Klemperer: non si può credere, non si può accettare che i tedeschi si siano trasformati in barbari e gli intellettuali in traditori. Eppure proprio questo accadde nel cuore della civiltà europea. Il libro è in definitiva un inno mite e puntuale a vigilare sulla lingua, un ammonimento che dovremmo tener presente anche oggi. Come affermò Franz Rosenzweig, citato nell’epigrafe a Lti, «la lingua è più del sangue».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. --- HO PAURA CHE AUSCHWITZ STIA SOLO DORMENDO. Ceija Stojka, sopravvissuta ai lager nazisti di Auschwitz, Ravensbruk e Bergen-Belsen (di Luca Kocci - Benedetto XVI riceve 2mila zingari europei).12 giugno 2011, di Federico La Sala
Benedetto XVI riceve 2mila zingari europei
di Luca Kocci (il manifesto, 12 giugno 2011)
Duemila zingari di tutta Europa ricevuti in udienza dal papa in Vaticano. È la prima volta che succede - solo Paolo VI, nel 1965, incontrò un gruppo di rom a Pomezia poco prima della chiusura del Concilio Vaticano II - e, in tempi in cui destra e Lega Nord a Milano agitano la minaccia "zingaropoli" e il sindaco Alemanno a Roma chiama "piano nomadi" gli sgomberi continui e la distruzione dei campi rom, il gesto di Benedetto XVI assume un valore simbolico. E forse anche "riparatorio" per la cacciata da parte dei gendarmi del Vaticano dei 200 rom che, nel venerdì santo, si erano rifugiati nella basilica di San Paolo. «Mai più il vostro popolo sia oggetto di vessazioni, di rifiuto e di disprezzo», ha detto ieri il papa ai duemila rappresentanti dei gruppi rom, sinti, manuches, kale, yenish e travellers, arrivati a Roma da tutta Europa - dove i zingari sono fra i 12 e i 15 milioni, 170mila in Italia - per il 75esimo anniversario del martirio e il 150esimo della nascita del beato Zefirino Giménez Malla, gitano di origine spagnola ucciso durante la guerra civile franchista.
E quattro testimoni hanno raccontato la realtà degli zingari di oggi e di ieri. Fra loro l’austriaca Ceija Stojka, sopravvissuta ai lager nazisti di Auschwitz, Ravensbruk e Bergen-Belsen, dove si è consumato il Porrajmos, «divoramento», ovvero lo sterminio degli zingari - oltre 500mila le vittime - voluto da Hitler e a cui collaborò anche il regime fascista di Mussolini istituendo campi di concentramento a loro dedicati: «Quando sono nata in Austria la mia famiglia contava più di 200 persone e solo sei di noi sono sopravvissuti alla guerra e allo sterminio», ha raccontato. «Ero bambina e dovevo vedere morire altri bambini, anziani, donne, uomini; e vivevo fra i morti e i quasi morti nei campi. Sento ancora gli strilli delle Ss, vedo le sorveglianti con i loro cani grandi che ci calpestavano, sento ancora l’odore dei corpi bruciati. Non è possibile dimenticare tutto questo, l’Europa non deve dimenticarlo. Oggi i campi di concentramento si sono addormentati e non si dovranno mai più svegliare. Ho paura però che Auschwitz stia solo dormendo».
«Siete un popolo che non ha vissuto ideologie nazionaliste, non ha aspirato a possedere una terra o a dominare altre genti. Siete rimasti senza patria e avete considerato idealmente l’intero continente come la vostra casa», ha replicato il papa. «Da parte vostra, ricercate sempre la giustizia, la legalità, la riconciliazione», e le amministrazioni si rendano conto che «la ricerca di alloggi e lavoro dignitosi e di istruzione per i figli sono le basi su cui costruire quell’integrazione da cui trarrete beneficio voi e l’intera società». Chissà se a qualche sindaco "cattolico" saranno fischiate le orecchie.
-
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- L’11 aprile 1961 cominciava lo storico processo che portò alla "banalità del male" (di Michela Marzano).11 aprile 2011, di Federico La Sala
Le polemiche sulla Arendt a 50 anni dal caso Eichmann
L’11 aprile 1961 cominciava lo storico processo che portò alla "banalità del male"
di Michela Marzano (la Repubblica, 11.04.2011)
A cinquant’anni di distanza dal processo di Adolf Eichmann, la nozione di "banalità del male" teorizzata da Hannah Arendt ha ancora un senso? L’11 aprile 1961 comincia a Gerusalemme uno dei processi più spettacolari del Ventesimo secolo, quello dell’uomo che, durante il regime nazista, aveva coordinato l’organizzazione dei trasferimenti degli ebrei verso i campi di concentramento e di sterminio. L’annuncio della cattura e del processo di uno dei principali attori della soluzione finale riapre un capitolo rimasto ancora in sospeso dopo Norimberga e attira l’attenzione e la curiosità di tutti coloro che, più o meno deliberatamente, cercano di dimenticare gli orrori della Seconda Guerra mondiale.
Che cosa aveva potuto spingere un alto funzionario a mettersi al servizio di un progetto folle e scellerato? Si trattava di un "mostro" o di un "uomo qualunque"? Due anni dopo Hannah Arendt pubblica il proprio resoconto del processo e formula, per la prima volta, un’ipotesi scabrosa: Eichmann non è un "mostro"; chiunque di noi, in determinate condizioni, può commettere atti mostruosi. Ma si può osare parlare della Shoah evocando, anche solo come ipotesi teorica, l’idea che il male possa essere banale?
A Parigi, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah celebra in questi giorni il cinquantesimo anniversario del processo e organizza una serie di dibattiti e una mostra imponente: dall’8 aprile al 28 settembre il pubblico può avere accesso a molti documenti inediti, estratti di film, registrazioni e fotografie del processo. A Washington, il Center for Advanced Holocaust Studies ospiterà a maggio un convegno internazionale con la partecipazione della storica Deborah Lipstadt che critica aspramente, nel suo recentissimo The Eichman Trial, la posizione della Arendt. Dopo David Cesarani e Saul Friedländer, che contestano l’idea che la sola "macchina burocratica" abbia potuto portare avanti lo sterminio, la Lipstadt mette in discussione il concetto di "banalità del male". Banalizzare il male contribuirebbe solo ad "assolvere" la cultura europea dalla colpa di antisemitismo. Ma di quale banalità stiamo parlando? Hannah Arendt non voleva assolvere nessuno. Non intendeva fornire alcuna spiegazione storica della catastrofe nazista. Cercava una chiave di lettura antropologica e filosofica dell’azione umana. Della cattiveria. Dell’incapacità di rendersi conto del male compiuto...
Durante il processo, Eichmann non smise mai di proclamare la propria innocenza, spiegando come nella sua vita non avesse fatto altro che ubbidire agli ordini, rispettato le leggi e fatto il proprio dovere. «Le sue azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco, né mostruoso», scrisse allora Arendt per spiegare l’inspiegabile. Esiste una "banalità del male" che non si può non prendere in considerazione se si vuole evitare di ricadere nella spirale infernale dei genocidi. Non certo perché il male, in sé, sia banale. Né perché coloro che lo compiono possano essere ritenuti banali. Ma perché tutti possiamo fare il male, talvolta senza rendercene conto, anche se non siamo né sadici né mostruosi. Non si tratta di negare che la perversione esista e che alcune persone provino una jouissance particolare nel far soffrire gli altri. Si tratta piuttosto di spiegare che il bene e il male non sono separati da una barriera invalicabile. Anche se la barriera esiste sempre, superarla è molto più facile di quanto non si possa immaginare.
Nessuno di noi è al riparo dalla barbarie. Nessuno può sapere come si sarebbe comportato o come si comporterebbe in circostanze particolari. Anzi, tutti possiamo "banalmente" fare il male, perché barbarie e civiltà convivono in ogni essere umano. La cieca obbedienza al dovere può indurre chiunque ad agire senza riflettere. E quando si smette di pensare, non si è più capaci di distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Il concetto di banalità del male non è dunque né un semplice slogan, come commentò Gershom Scholem al momento dell’uscita del libro di H. Arendt, né un modo per minimizzare quello che la stessa filosofa tedesca considerava la "più grande tragedia del secolo".
Al contrario. È forse l’unica possibilità per spiegare la radicalità del male umano: radicale proprio perché banale; radicale perché tutti possono farlo, talvolta banalmente, anche se alcune persone scelgono di non farlo. Non è difficile capire perché si faccia il male. La vera difficoltà è altrove: come si fa a fare il bene, quando è così facile scivolare nella barbarie, quando basta lasciarsi andare al flusso delle pulsioni per dimenticare la nostra comune umanità?
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- Dopo 50 anni, Berlino ricorda il processo al nazista Eichmann (di Laura Lucchini).7 aprile 2011, di Federico La Sala
Il burocrate dell’orrore che portava gli ebrei nei lager
Dopo 50 anni, Berlino ricorda il processo al nazista Eichmann
di Laura Lucchini (il Fatto, 07.04.2011)
I numeri dei deportati erano indicati su un grafico dietro alla sua scrivania. “Ne è certo?” chiede il pubblico ministero israeliano Gideon Hausner. “Sì”, risponde Adolf Eichmann. “Quindi intende dire che la sua sezione sapeva con assoluta esattezza quante persone stavate deportando e quale era la loro destinazione?”. “Sì, lo sapeva. Era mio compito informare al riguardo i miei superiori”.
La condanna a Gerusalemme
QUESTO STRALCIO dell’interrogatorio di Adolf Eichmann è un momento fondamentale del processo contro uno dei principali responsabili dell’Olocausto celebrato a Gerusalemme nell’aprile del 1961, cioè 50 anni fa. La registrazione completa dell’interrogatorio fa parte della mostra Il processo: Adolf Eichmann davanti al tribunale inaugurata l’altro ieri a Berlino per ricordare questo giudizio-chiave nella ricostruzione dell’orrore nazista e della persecuzione d icui furono oggetto gli ebrei da parte del Terzo Reich. Eichmann, che dopo essere stato condannato alla pena capitale dal tribunaledi Gerusalemme fu impiccato nel 1962,fu un ingranaggio decisivo della macchina che rese possibile l’eliminazione sistematica di sei milioni di ebrei.
Nato a Solingen nel 1906 era stato, in particolare, il responsabile del traffico ferroviario per il trasporto degli ebrei nei campi di sterminio. Prese parte a tutte le fasi della cosiddetta soluzione finale con la quale Hitler e i suoi accoliti pianificarono l’annientamento definitivo e totale degli ebrei in Germania e poi nei paesi occupati. Dalla Conferenza di Wannsee del gennaio 1942 fino alla organizzazione dei treni diretti ad Auschwitz, tutta la parte burocratica dello sterminio passò per le mani di questo uomo che finì per diventare l’esempio perfetto ed emblematico del funzionario nazista che si limitava ad eseguire gli ordini.
Il suo ruolo e la sua psicologia furono analizzati in un celebre libro della filosofa Hannah Arendt, La banalità del male. Qui la Arendt sostiene la tesi secondo cui il male può anche non avere radici, non avere memoria e proprio per questo - cioè per l’assenza di un dialogo “morale” - uomini apparentemente banali possono trasformarsi in autentici agenti del male.
Gabriel Bach, il pubblico ministero israeliano che nel 1961, insieme a Gideon Hausner, sostenne l’accusa contro il criminale nazista, l’altro ieri era presente all’inaugurazione della mostra presso il centro di documentazione berlinese Topografia del Terrore. Gabriel Bach, oggi ottantaquattrenne, seduto in prima fila durante la conferenza stampa, aveva con sè una cartella.
Alla fine della conferenza stampa ne ha svelato il contenuto: foto, stampe originali dell’aula del tribunale, immagini che lo ritraggono in prima fila con Adolf Eichmann a pochi metri di distanza, seduto dietro un vetro con due poliziotti a fianco. “Cosa ricordo di più di quel processo? Forse il mio primo incontro con Eichmann. Avevo appena terminato di leggere un libro nel quale si descriveva con quanta crudeltà assassinava i bambini nei campi di concentramento. Gliene parlai. Mi rispose che se ci si è posti l’obiettivo di eliminare una razza, allora bisogna eliminare tutte le generazioni, bambini compresi. Da un punto di vista logico il suo ragionamento non faceva una piega”. Il processo fu possibile grazie a un’azione oggetto di molte polemiche e controversie. Il burocrate nazista nel 1950 era riuscito a fuggire in Argentina: lavorava in una fabbrica della Mercedes Benz nelle provincia di Buenos Aires quando fu sequestrato dal Mossad, trasferito clandestinamente in Israele e processato.
Fu il primo processo contro un criminale nazista celebrato in Israele e si concluse con la condanna a morte di Adolf Eichmann. Al processo potè assistere tutto il mondo in quanto fu filmato e trasmesso per televisione (la relativa documentazione fa parte della mostra di Berlino). Molti, tra i quali la stessa Hannah Arendt, cittadina americana ma di origine tedesca e di religione ebraica, condannarono il tribunale per la sua mancanza di imparzialità.
Assassinare bambini senza provare nulla
“È UN’ACCUSA ridicola”, ha detto l’altro ieri Gabriel Bach. “La sentenza poggiava su prove incontestabili e in nessun momento del procedimento si ebbe la sensazione che la sentenza fosse già stata scritta e che già si sapeva come sarebbe andata a finire”. Quanto ad Hannah Arendt, Gabriel Bach ha ricordato che “prima del processo mi avevano avvertito che dagli Stati Uniti sarebbe arrivata una filosofa per scrivere un libro contro il processo. Come a dire che si sapeva già da prima quale era la sua posizione”.
La mostra di Berlino,che rimarrà aperta fino a settembre, raccoglie tutta una serie di testimonianze dei protagonisti del processo e i filmati degli interrogatori più significativi oltre al materiale messo a disposizione dai mass media di tutto il mondo che all’epoca seguirono il dibattimento. La mostra organizzerà fino a settembre diversi incontri con esperti e testimoni diretti dell’Olocausto.
Copyright El Paìs; traduzione Carlo Antonio Biscotto
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- Caso Eichmann, Arendt imputata? La storica americana Deborah Lipstadt mette in discussione i giudizi espressi da hannah arendt (di Vito Punzi).4 aprile 2011, di Federico La Sala
IL CASO
Caso Eichmann, Arendt imputata?
di Vito Punzi (Avvenire, 1 aprile 2011)
Con la ricorrenza, il prossimo 11 aprile, dei cinquant’anni dall’inizio a Gerusalemme del processo ad Adolf Eichmann, l’organizzatore a livello burocratico dello sterminio degli ebrei europei da parte dei nazisti, la storica americana Deborah Lipstadt ha appena pubblicato un libro (The Eichmann Trial, Nextbook/Schocken) con l’intento di ricostruire le fasi del processo, mettendo in discussione i giudizi espressi da Hannah Arendt con gli articoli scritti all’epoca, da inviata, per "The New Yorker" e poi raccolti nel volume Eichmann a Gerusalemme (1963).
La Lipstadt, pur riservando alla filosofa un solo capitolo del libro, lancia nei suoi confronti accuse molto dure, tanto da far sembrare il suo un vero e proprio "processo ad Hannah Arendt". La storica ne critica in particolare la definizione di Eichmann come semplice "burocrate" e come uomo "terribilmente normale" (e lo descrive piuttosto come «uomo colto che sposò l’idea della causa razziale»). Le accuse più gravi, accompagnate da giudizi piuttosto gratuiti sulla persona (la Arendt sarebbe stata "frivola" e "crudele"), sono tuttavia quelle di aver minimizzato l’antisemitismo, fino ad assolverlo nei fatti, e di non essere stata una convinta sionista.
Le critiche della Lipstadt in realtà non sono nuove e tuttavia meritano un approfondimento. La posizione della Arendt rispetto alla creazione di uno Stato ebraico in Palestina è stata chiara fin dal 1940, quando ancora si trovava in Francia a fianco di un convinto sionista come Erich Cohn-Bendit: secondo lei quella soluzione, il "sogno" di Theodor Herzl, non avrebbe risolto il problema delle minoranze ebraiche in Europa. Di fronte alla minaccia delle deportazioni, meglio sarebbe stata, una volta sconfitto il nazismo, la creazione di un’unione di Stati al cui interno gli ebrei potessero godere del riconoscimento di minoranza nazionale e di una rappresentanza in un Parlamento europeo.
Giunta negli Usa nel 1941, alla Arendt venne affidata su "Aufbau", un giornale per gli esuli ebrei di lingua tedesca, una rubrica per trattare questioni attinenti la politica ebraica: evidentemente per stima, ma anche perché, come ha scritto opportunamente la studiosa arendtiana Antonia Grunenberg, «intellettuale sionista alquanto dotata, energica e bellicosa». Certo è che dopo aver preso le distanze, nel 1942, dalla "Conferenza Biltmore", con la quale si chiedeva la costituzione di uno Stato israeliano con minoranza araba, la sua posizione fu sempre più isolata. E a poco servì la creazione del "Gruppo dei giovani ebrei", insieme a Josef Mair, anche perché lotte e rancori all’interno del movimento sionista erano allora all’ordine del giorno: non a caso la Arendt e Mair si rivolsero polemicamente «a tutti coloro che sanno che la lotta per la libertà non può essere guidata né da notabili né da rivoluzionari internazionali».
Negli ’47 e ’48 la filosofa conobbe Judah Magnes, «leggendario capo sionista» (così Grunenberg), già rettore dell’Università Ebraica di Gerusalemme e propugnatore di una federazione arabo-israeliana. Condividendo con lui la critica all’establishment sionista, la Arendt lavorò come sua intermediaria e persona di fiducia negli Usa. Insomma è davvero difficile condividere il giudizio di Gershom Scholem, fatto proprio dalla Lipstadt, per cui la filosofa «mancava di amore per il popolo ebraico». Quanto ad Eichmann, le questioni gravi messe in luce dalla Arendt furono due: il ruolo dell’accusato in relazione agli eventi e il giudizio che si dovesse dare sull’operato degli stessi ebrei e sulla politica delle loro organizzazioni durante le fasi attuazione dello sterminio.
I suoi articoli provocarono subito critiche durissime da parte dell’intera comunità ebraica (le stesse riprese oggi dalla Lipstadt nel suo libro). Con la definizione di "banalità del male", secondo i suoi critici, avrebbe mirato alla banalizzazione del crimine. In realtà, come essa stessa scrisse rispondendo a Scholem che l’accusò di aver creato uno "slogan", secondo la Arendt «il male è sempre e solo estremo, non "radicale", e le motivazioni che spingono al male non vanno ricercate sul piano del profondo e del demoniaco. Esso può invadere tutto e devastare il mondo intero, precisamente perché si propaga in superficie come un fungo. Solo il bene ha profondità e può essere radicale».
In questo senso l’aver fatto di Eichmann un "mostro", l’averlo posto sul banco degli imputati con intenti che non erano solo giuridici (affrancare il popolo ebraico dal ruolo di vittima), per la Arendt rappresentò una commistione non salutare tra politica e giustizia. La storia potrebbe anche averle dato torto, ma da qui a dire, come fa ora la Lipstadt - non storica ma polemista -, che la filosofa ha fornito allora «una versione dell’Olocausto in cui l’antisemitismo ha un ruolo minoritario», ce ne corre.
Vito Punzi
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO ---- SE I GIOVANI ARABI RICONOSCONO ISRAELE. affermare e pretendere il riconoscimento di Israele e chiedere ai coetanei israeliani di mobilitarsi anche loro per la creazione di uno Stato palestinese, deponendo ogni ostilità (di Roberto Tottoli).4 aprile 2011, di Federico La Sala
Se i giovani arabi riconoscono Israele
di Roberto Tottoli (Corriere della Sera, 04.04.2011)
Manca un ultimo passo alla gioventù araba e musulmana delle rivolte per ambire a un futuro veramente nuovo: affermare e pretendere il riconoscimento di Israele e chiedere ai coetanei israeliani di mobilitarsi anche loro per la creazione di uno Stato palestinese, deponendo ogni ostilità. E chiedere alle forze politiche nuove e forse libere, Fratelli musulmani compresi, di fare lo stesso.
I giovani arabi e musulmani hanno adesso l’occasione storica per chiudere un passato ingombrante. Hanno l’opportunità di tentare vie nuove e di non guardare più dal basso i coetanei israeliani, ma di incalzarli, di rilanciare per la prima volta un’azione politica che non sia stantia e di retroguardia.
Dicano chiaro e tondo che non credono più neppure alla propaganda anti-israeliana e anche antisemita che i loro regimi iniettavano o permettevano a piene mani da decenni. Dicano che hanno capito che lo facevano per aprire una comoda e indolore valvola di sfogo con una mano, mentre con l’altra non facevano nulla di concreto per la causa palestinese. Allo stesso tempo, però, tolgano enfasi e pretese di esclusivismo al fattore religioso di ognuna delle parti, perché non ha ragione storica d’essere. Gerusalemme è importante, ma non è Mecca, né è mai stata nel corso della storia il centro della religiosità musulmana.
Chiedano, i musulmani, che sia riconosciuto loro il diritto di celebrare nei propri luoghi il ricordo di quel che fu Gerusalemme per Maometto e la storia del primo Islam, senza che l’esasperazione simbolica alimenti una pretesa di primato religioso. E chiedano ai giovani israeliani di mobilitarsi e fare lo stesso, di ricondurre la sacralità connessa al Tempio nella sua reale dimensione storica, tralasciando campagne archeologiche che vanno a caccia di luoghi sacri per poter dimostrare una primogenitura sulle pietre. Queste operazioni, per gli uni e per gli altri, non sono più l’esercizio della propria libertà di fede, bensì i frutti avvelenati che la cattiva politica ha generato negli ultimi decenni.
E a quei musulmani che ancora sostengono come la terra di Palestina sia nel cuore della Dar al-islam, «la Casa dell’Islam» , questi giovani figli del web dovrebbero spiegare come il futuro ha ormai travolto vecchi muri e confini. Che non ha più senso continuare a ribadire categorie medievali quando vi sono e prosperano comunità musulmane emigrate ovunque che hanno ben altre prospettive ed esperienze vissute.
Lo facciano ora, chiamando anche i coetanei israeliani fuori dalla loro prigionia di uno Stato accerchiato e di un muro reale che chiude in un nuovo ghetto ogni speranza di convivenza. Il patrimonio politico delle rivolte arabe non potrebbe essere speso meglio.
Se avranno la forza di farlo, e farlo insieme ai coetanei israeliani, o sapranno comunque trovare argomenti convincenti sulla stessa linea, riusciranno in un risultato ancora più grande. Riusciranno a sbugiardare una dirigenza palestinese che non ha più saputo rilanciare un’azione politica incalzante e vincente, e che ha ingrassato aristocrazie della diaspora e illuso milioni di profughi palestinesi abbandonati e senza diritti da decenni. Potranno per la prima volta minare la retorica di governi israeliani che dietro la mobilitazione continua in nome della sicurezza, forse comprensibili trent’anni fa, hanno ormai evidenti istinti di egemonia coloniale con un cinismo non inferiore alla crudeltà dei regimi circostanti.
E insieme a tutto questo, potranno cancellare quella presenza occidentale invadente e continua nel mondo islamico, fatta di interventi umanitari e di Ong, per mezzo delle quali si celebra la retorica di un occidente «buono» accanto a uno «cattivo» , mentre allo stesso tempo si perpetua una presenza straniera massiccia quasi quanto ai tempi del colonialismo. Questi giovani, questi giovani musulmani e quelli che li hanno sostenuti in Europa e nel mondo, sono pronti a guardare al futuro e non più al passato anche per Israele e Palestina? A farlo senza frustrazioni né vittimismi, con voglia di cambiare per sempre il mondo in cui hanno vissuto? Questo potrebbe essere il momento giusto. Ora è l’occasione, irripetibile e unica, per farlo.
* docente di Islamistica Università di Napoli L’Orientale
-
> ISRAELE --- "Ho giustiziato Eichmann. Mai più". Il boia del Boia è stato zitto quasi cinquant’anni. La banalità del boia non si trova nei reportage che Hannah Arendt scrisse al processo (di Francesco Battistini).20 marzo 2011, di Federico La Sala
 Ho giustiziato Eichmann. Mai più
Ho giustiziato Eichmann. Mai più Non volevo. Il suo sangue mi schizzò addosso: ho avuto incubi per un anno
Non volevo. Il suo sangue mi schizzò addosso: ho avuto incubi per un anno
 Sono diventato un religioso, oggi macello polli e pecore secondo la tradizione
Sono diventato un religioso, oggi macello polli e pecore secondo la tradizionedi Francesco Battistini (Corriere della Sera, 20.03.2011)
Come vi capivate, Shalom? «Con le mani. Linguaggio del corpo. Lui non parlava yemenita e io non sapevo il tedesco. Allora facevamo così - gesticola nell’aria -, perché non avevamo altro modo. Alla fine, lui capiva me e io capivo lui» . E com’è che toccò proprio a te? «Sono yemenita, la Shoah è una cosa soprattutto degli ebrei europei: all’inizio non sapevo nemmeno chi fosse, Eichmann. L’avevo scoperto solo dopo. Un giorno il comandante venne da me, si chiamava Merhavi, e mi chiese: "Shalom, ti va di schiacciare il bottone"? È il più grande dei comandamenti: "Cancella la memoria di Amalec", di chi vuole sterminare gli ebrei... Però io dissi che non volevo. C’era qualcuno che se la sentiva, io ero l’unico che non voleva. Tirarono a sorte. E il comandante mi disse: "È un ordine. La sorte ha detto che tocca a te. Lo farai tu"» . La macelleria del boia è uno sterrato sotto l’ombra di due eucalipti e d’una lamiera ondulata, periferia di Holon, la città dei Samaritani. Un caldo pomeriggio, ci sono le donne in fila, i polli da strozzare, due occhi di capra su un tavolo e un amico che scherza: «Sembrano gli occhi di Eichmann, eh?...» .
La polvere, i gatti, un gancio per appendere e dissanguare. A Shalom Nagar, certi animali viene più facile scuoiarli: «Le capre sono sfacciate. Le pecore, no: loro sono innocenti...» . Distante, discreta, una macchina da presa e una piccola troupe: chi viene qui sa di non trovare solo un religioso yemenita che macella carne come kasherut comanda. Ogni tanto, qualche padre passa in auto e indica dal finestrino: guardate quel vecchio, ragazzi, quel piccoletto col capo coperto e i cernecchi bianchi, è il secondino che ha impiccato Adolf Eichmann e vendicato milioni d’ebrei. Il boia del Boia è stato zitto quasi cinquant’anni: «Mi avevano vietato di raccontare questo segreto, non lo sapeva neanche mia moglie» .
Ora ne hanno fatto il protagonista d’un documentario di 62 minuti, The Hangman. L’hanno premiato al Festival di Haifa, magari andrà a quello di Locarno. Lui non è abituato a tanta curiosità: «Alla prima venivano a stringermi la mano, a salutarmi, ero un po’ disorientato. Non immagino che cosa sarà dopo l’ 11 aprile...» .
L’ 11 aprile 1961, a Gerusalemme, cominciò il processo Eichmann: la tv israeliana, il cinquantenario, lo celebrerà trasmettendo la storia di Shalom. «La sua vita m’è sembrata subito simbolica - racconta Netalie Braun, 33 anni, regista telavivi che ha filmato il boia per trenta mesi, l’unica che può girargli le domande dei giornalisti -. Voleva raccontarsi da tempo, ma all’inizio aveva paura di qualche vendetta neonazista. Siamo diventati amici. Quest’uomo è un Forrest Gump: uno che per caso s’è trovato in una storia più grande di lui» .
La banalità del boia non si trova nei reportage che Hannah Arendt scrisse al processo. E di lui non s’è granché parlato al convegno che Gerusalemme ha appena dedicato al «punto di svolta» , come lo chiama Tom Segev, l’evento che mezzo secolo fa cambiò per sempre Israele: «Prima di allora - dice lo storico - la Shoah era un tabù. Commemorazioni pubbliche, certo, ma un dolore vissuto in privato. Il processo fu una terapia, la catarsi che trasformò tanti traumi privati in un trauma collettivo. L’Olocausto diventò un elemento fondante del nuovo Stato e dell’identità israeliana. Questo non significa che la terapia servì a chiarire tutto. Su Eichmann e su altri criminali nazisti, ci sono migliaia di documenti che la Germania non si decide a rendere noti. Perché? Forse per coprire altre responsabilità. Potremmo fare una domanda simile al nostro Mossad: tutti sanno come fu catturato Eichmann in Argentina, ma che sappiamo dei fallimenti? O del perché non s’è mai riusciti a processare uno come Mengele?» .
Nella prigione di Ramla, dove per sei mesi Shalom fece la guardia al general manager della soluzione finale, domande così non si facevano. «Lui era il male racconta il boia- ma si sa com’erano i tedeschi. Dicevano che non ci sarebbero stati arabi o ebrei nel mondo, i bastardi e poi si mostravano così puri, così santi nelle loro azioni quotidiane... Eichmann leggeva tanto, mi diceva sempre "gracias"in spagnolo. L’accompagnavo al bagno e lui stava attento a non farmi sentire la puzza, a lavarsi le mani. Non avessi saputo chi era, l’avrei preso per un santo!» .
Uno scrupoloso senza scrupoli, l’ha descritto la studiosa tedesca Irmtrud Wojak. «A sorvegliarlo eravamo in 22, divisi in cinque stanze. Yemeniti, marocchini. C’erano anche tre ebrei europei, ma a loro non era concesso d’entrare. Io stavo nella sua cella, assaggiavo i suoi cibi. La paura era che l’avvelenassero. "Perché devo assaggiare io?". Chiedevo al comandante. Rideva: "Se perdiamo uno yemenita non è una gran perdita. Ma se perdiamo lui... C’è un processo internazionale". Ci stavo io anche perché ho sempre avuto compassione dei carcerati. Non ne ho mai picchiato uno. Si sa: se ti prendi cura di qualcuno, alla fine un po’ t’affezioni» .
La pietà della vittima per il carnefice, il giorno in cui schiacciò il bottone, divenne terrore. «Non avevo mai visto un uomo impiccato. Avevo 26 anni, che ne sapevo? Ero davanti a lui. Ho visto la sua faccia bianca, gli occhi fuori. Grandi, fissi, come se mi guardasse. Anche la lingua era fuori, insanguinata. Chiesi d’allontanarmi, ma il comandante disse no: "Non è un gioco, tiralo su e levagli il cappio". Tremavo. Non sapevo che avesse aria nello stomaco, che potesse parlare ancora: è come con una radio, quando le stacchi la spina e per qualche secondo continua a funzionare... Eichmann era impiccato eppure biascicava ancora parole! D’improvviso, l’aria dello stomaco gli uscì col sangue. Mi soffiò in faccia. Pensai: "Oh no, sta per mangiarmi!". Quando lo portammo alla fornace, per bruciarlo e cospargere le ceneri in mare, stavo male. Mi fecero accompagnare a casa. Mia moglie mi vide, ero tutto sporco di sangue. "Ma dove sei stato?". Mi chiese. Lo sentirai fra qualche ora al notiziario...» .
Il punto di svolta d’Israele fu il non ritorno per Shalom. «Ho avuto un anno d’incubi: mi ero cosparso del suo sangue, questo è il punto. È da lì che sono diventato religioso. E ho cominciato a sentirmi un po’ meglio» . Il boia ha avuto altri lutti, gli è morto un figlio di cancro. L’hanno mandato a fare la guardia nella prigione di Hebron e pure lì, Forrest Gump, è capitato nel mezzo della strage di Baruch Goldstein, il colono ebreo che negli anni 90 massacrò decine di palestinesi mentre pregavano. «Fu un’altra prova dura. Non me la sentii di stare in un posto del genere. Vedevo le guardie che la notte picchiavano i detenuti: come siamo diventati crudeli, anche noialtri. Io avevo pietà dei miei carcerati, anche se erano terroristi. Gli arabi sono stati creati pure loro a somiglianza di Dio. Sono un popolo, hanno un’anima. Proprio come noi. E la legge ebraica dice che non devi uccidere. Non dice: non devi uccidere Mosè o Maometto. Dice che non devi uccidere. E basta» . Per la regista Netalie, il macellaio di Holon è «l’esempio di che cos’è oggi il buon ebraismo: Israele ha bisogno di questo tipo di persone» .
Quando va in sinagoga, in questi giorni di Purim, Shalom ascolta il Libro di Ester. C’è la storia di Mordechai, il carnefice che alla fine diventa vittima: «Se un giorno mi chiamano e mi dicono che hanno appena condannato a morte Demjanjuk, quell’altro nazista che stanno processando, la risposta ce l’ho già: ne ho avuto abbastanza di Eichmann, grazie. Scordatevi di Demjanjuk. E dime. Questa cosa, io non la faccio più» . (Ha collaborato Ariela Piattelli)
-
> ISRAELE --- "Ho giustiziato Eichmann. Mai più". --- Riemerge lo scontro sull’esecuzione. Dagli Archivi di Stato un’anima ebrea travagliata e combattuta5 aprile 2011, di Federico La Sala
Eichmann. Riemerge lo scontro sull’esecuzione *
Nel giorno in cui Israele ripropone, in dichiarazioni del ministro degli Esteri Avigdor Lieberman, il volto dell’intransigenza, sul riconoscimento di uno Stato palestinese, dagli Archivi di Stato emerge un’anima ebrea travagliata e combattuta: documenti ora pubblicati rivelano che l’impiccagione nel 1962 del gerarca nazista Adolf Eichman fu al centro di un dibattito nazionale, fuori e dentro il governo dell’allora premier Ben Gurion, sull’opportunità o meno di eseguire la condanna a morte pronunciata nel 1961.
Eichmann, rintracciato nel 1960 dal Mossad in Argentina, dove si era rifugiato nel ’50 con falsi documenti rilasciatigli in Italia, fu catturato con azione da commando e fu portato in Israele per esservi processato, condannato, giustiziato. La pubblicazione su internet di molti documenti originali da parte degli Archivi di Stato israeliani avviene nell’imminenza del 50° anniversario dell’apertura del processo, l’11 aprile 1961.
I testi gettano squarci di luce sulle circostanze della cattura, del giudizio, della condanna e dell’esecuzione di uno dei responsabili dell’organizzazione della cosiddetta “soluzione finale” della questione ebraica, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Eichmann, che era un ufficiale delle Ss, organizzò i convogli ferroviari che trasportarono ebrei ed altri deportati verso i campi di sterminio.
Il processo ad Eichmann “resta - afferma la direzione degli Archivi - una pietra miliare nella storia di Israele e nell’atteggiamento degli israeliani sull’Olocausto”. I testi riguardano anche le ripercussioni diplomatiche dell’irrituale arresto e l’atteggiamento del governo di Ben Gurion sulla copertura mediatica dell’evento, la condanna e l’esecuzione.
Proprio all’approssimarsi dell’esecuzione si aprì un dibattito persino aspro sulla opportunità di mettere, o meno, a morte Eichmann. Dirigenti politici come Levy Eshkol e Yosef Burg, filosofi come Martin Buber e Natan Rothenstreich e la “poetessa nazionale” Lea Goldberg erano contrari: gli intellettuali, in extremis, chiesero un atto di clemenza al capo dello Stato Yitzhak Ben Zvi, ma prevalse la linea dell’intransigenza del premier Ben Gurion: Eichman fu impiccato il 31 maggio 1962 e le sue ceneri furono disperse in mare. (g. g.)
* il Fatto Quotidiano, 05.04.2011
-
-
> ISRAELE ---- LA POLITICA DELLA MEMORIA E LE NUOVE GENERAZIONI. COME DELLE GITE SCOLASTICHE A HEBRON ASSOMIGLIANO ALLE VISITE AD AUSCHWITZ25 febbraio 2011, di Federico La Sala
 ISRAELE, LA POLITICA DELLA MEMORIA, E LE NUOVE GENERAZIONI. COME DELLE GITE SCOLASTICHE A HEBRON ASSOMIGLIANO ALLE VISITE AD AUSCHWITZ. Una nota di Gideon Levy
ISRAELE, LA POLITICA DELLA MEMORIA, E LE NUOVE GENERAZIONI. COME DELLE GITE SCOLASTICHE A HEBRON ASSOMIGLIANO ALLE VISITE AD AUSCHWITZ. Una nota di Gideon Levy
 (...) Se il ministro dell’istruzione fosse fedele al suo lavoro e alla sua immagine come ministro relativamente illuminato, avrebbe organizzato un vero tour di Hebron. Un programma "saliamo a Hebron"? In effetti, ma a condizione che sia tutto incluso: la tradizione ebraica e l’ingiustizia ebraica (...)
(...) Se il ministro dell’istruzione fosse fedele al suo lavoro e alla sua immagine come ministro relativamente illuminato, avrebbe organizzato un vero tour di Hebron. Un programma "saliamo a Hebron"? In effetti, ma a condizione che sia tutto incluso: la tradizione ebraica e l’ingiustizia ebraica (...)
-
> ISRAELE ---- Kant, la rivolta dei giovani arabi e l’inganno dello scontro di civiltà.8 marzo 2011, di Federico La Sala
La pace perpetuaIl grande filosofo ha creduto nell’espansione della democrazia e dell’emancipazione
Kant, la rivolta dei giovani arabi e l’inganno dello scontro di civiltà
 Nessuno ha previsto le rivoluzioni democratiche del Nordafrica. I servizi di intelligence sono stati spiazzati
Nessuno ha previsto le rivoluzioni democratiche del Nordafrica. I servizi di intelligence sono stati spiazzati
 In questi decenni ha dominato la paura dell’Islam. Ma le forze della pace hanno continuato ad operare
In questi decenni ha dominato la paura dell’Islam. Ma le forze della pace hanno continuato ad operaredi Pino Arlacchi (l’Unità, 08.03.2011)
Sono in molti a chiedersi in questi giorni come mai le rivoluzioni democratiche del Nordafrica non sono state previste da nessuno, e perché i centri di intelligence, soprattutto americani, nonostante i loro enormi budget, siano rimasti così clamorosamente spiazzati davanti ai cambiamenti epocali in corso.
Questo fallimento ha una spiegazione. Non solo gli analisti dei servizi di sicurezza, ma anche la maggior parte degli studiosi di scienze sociali non sono stati capaci di anticipare nulla di ciò che sta accadendo nel mondo arabo semplicemente perché vittime e autori, allo stesso tempo, di un grande inganno. Parlo di un colossale offuscamento delle coscienze durato quasi due decenni, e basato sull’idea che viviamo in un epoca catastrofica, dove la nostra sicurezza corre un pericolo mortale a causa di una serie di minacce, la prima delle quali è l’ Islam, seguita da altre quali gli stati canaglia, l’ immigrazione, l’ espansione della Cina, il riarmo, i conflitti e le guerre.
Il primo decennio del nuovo secolo, dall’ elezione di Bush II all’ inizio del 2011, è stato dominato dall’inganno e dalla paura, cioè dal mito del caos globale. Una visione negativa delle cose che ha avuto conseguenze politiche rilevanti, perché ha abbassato le nostre aspettative, ci ha costretti sulla difensiva, e ci ha tolto la fiducia in un mondo più decente. Eppure, non ci sarebbe voluto molto per cogliere i segnali di una potente forza contraria: quella del progresso umano e della pace. Una forza che ha continuato ad agire sotto la superficie degli eventi e a dispetto della propaganda della destra globale trionfante, e al potere negli Usa ed altrove.
Una potenza benefica, che ha fatto decrescere la violenza grande e piccola, ridotto o azzerato minacce, accresciuto la sicurezza individuale e collettiva, allargato democrazie e diritti.
La transizione democratica del Nordafrica, allora, non è altro che un tassello del mosaico che le forze della pace hanno continuato a comporre sotto i nostri occhi, e con la nostra partecipazione, sia pure poco convinta.
Al tema dell’ inganno e della paura ho dedicato lo studio più importante della mia vita, scritto nel 2008, prima dell’ elezione di Obama, e pensato nei dieci anni precedenti. In esso ho criticato la visione sbagliata della sicurezza internazionale ancora oggi dominante, ed ho richiamato il pensiero di un grande europeo, Emanuele Kant, il filosofo che più ha creduto nell’ espansione della democrazia e dell’ emancipazione umana.
Sarebbe bastato rileggere qualche pagina di un libretto pubblicato da Kant nel 1795, «La pace perpetua» per non stupirsi di fronte al tramonto dei tiranni Nordafricani. In esso il filosofo tedesco ha disegnato un mondo governato dalle democrazie e dalle organizzazioni internazionali, dove la guerra diventa sempre più rara, obsoleta ed assurda. Un mondo dove i cittadini daranno il loro consenso all’ uso della forza solo per autodifesa, e dove la diffusione dei regimi democratici ha instaurato un metodo della nonviolenza che ha finito con l’ estendersi anche ai rapporti tra gli Stati.
Queste dinamiche hanno continuato ad operare in realtà anche dopo l’ 11 settembre 2001. Le forze della pace kantiana hanno continuato il loro lavoro. Fino a sfociare nella «storia che si è dischiusa» all’ alba di quest’anno, secondo la bella definizione di Obama.
Tutto ciò si è verificato nonostante le idee di un pensatore reazionario, Samuel Huntington, il capofila della teoria dello scontro di civiltà con l’ Islam, fossero diventate un pensiero unico che ha ingannato molte persone in buona fede. La bandiera dello scontro di civiltà ha riportato in auge una legione di profeti di sventura, che hanno vaticinato disastri e guerre che esistevano in realtà solo nei loro desideri. Non ne hanno azzeccata una. Ma le loro errate previsioni hanno svolto la funzione di far crescere le paure collettive che hanno gonfiato a loro volta le spese militari.
Le idee di Kant ci hanno invece aiutato a rafforzare le istituzioni del dialogo e dei diritti universali: le Nazione Unite, il Parlamento e l’ Unione europea, e quella panoplia di trattati e di agenzie internazionali che formano come una rete che scoraggia la guerra e incoraggia la democrazia e la giustizia in ogni angolo del pianeta.
L’ imbroglio dello scontro di civiltà (con annessa teoria della superiorità etico-politica dell’ Occidente) è oggi nella polvere, sconfitto dai giovani arabi che manifestano per i diritti universali. Adesso dobbiamo fare attenzione a non cadere in una trappola.
Quella del trionfalismo progressista, che vede una crescita lineare ed ineluttabile della democrazia. Il catastrofismo di Huntington non va sostituito da una fede ingenua e dogmatica nello sviluppo umano. Da una specie di inganno al rovescio che ci porta ad ignorare le potenze distruttive della violenza e dell’ oppressione.
La continuità del processo in corso dipende da noi. Dalle mosse che saremo in grado di fare per tutelare le conquiste appena ottenute, e per espanderle ancora. Anche qui Kant ci può essere utile. Per lui il progresso etico-politico non era scontato, e poteva conoscere fasi anche molto lunghe di regresso e stagnazione. Per evitare le quali occorreva riflettere bene sugli errori passati, ed imparare a non ripeterli: il celebre learning process kantiano.
Se la rivoluzione democratica del Nordafrica sfocerà in un congiungimento politico di quei paesi all’ Europa e in un passo avanti verso la democrazia universale, invece di ripiegarsi su se stessa ed arretrare verso regimi semi-tirannici o verso situazioni di «stati falliti», dipende in primo luogo dalle azioni di chi combatte in loco. Ma dipende anche da noi. Dal sostegno che sapremo dare alle forze della nonviolenza e della solidarietà. Battiamoci, allora, perchè questo secondo decennio del ventunesimo secolo si svolga all’ insegna della profezia kantiana sulla pace democratica.
-
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN.... Riscopriamo l’etica. Agamben: "Provate a vivere secondo le vostre idee" (di Franco Marcoaldi - Intervista)8 febbraio 2011, di Federico La Sala
Riscopriamo l’etica. Agamben: "Provate a vivere secondo le vostre idee"
intervista a Giorgio Agamben
a cura di Franco Marcoaldi (la Repubblica, 8 febbraio 2011)
In cosa crediamo? Quali sono le credenze civili, religiose, politiche, scientifiche, su cui si regge la società? La risposta si fa particolarmente difficile in un mondo come il nostro, che vede le credenze tradizionali - oggetto di una costante erosione - trasformarsi in surrogati, con il conseguente dilagare delle più diverse forme di superstizione. Oppure, per converso, il trionfo di uno scetticismo e di un’indifferenza che rasentano il nichilismo.
Proveremo a trattare la questione "credere, credenza", affrontandola da diversi punti di vista. E partiremo chiedendo l’aiuto di un filosofo italiano di fama internazionale: Giorgio Agamben. «Nella nostra cultura esistono due modelli di esperienza della parola. Il primo modello è di tipo assertivo: due più due fa quattro, Cristo è risorto il terzo giorno, i corpi cadono secondo la legge di gravità. Questo genere di proposizioni sono caratterizzate dal fatto che rimandano sempre a un valore di verità oggettivo, alla coppia vero-falso. E sono sottoponibili a verifica grazie a un’adeguazione tra parole e fatti, mentre il soggetto che le pronuncia è indifferente all’esito.
Esiste però un altro, immenso ambito di parola del quale sembriamo esserci dimenticati, che rimanda, per usare l’intuizione di Foucault, all’idea di "veridizione". Lì valgono altri criteri, che non rispondono alla separazione secca tra il vero e il falso. Lì il soggetto che pronuncia una data parola si mette in gioco in ciò che dice. Meglio ancora, il valore di verità è inseparabile dal suo personale coinvolgimento».
Il senso profondo del credere andrebbe dunque ricercato proprio qui?
«Certamente. Anche se, nel corso del tempo, il trionfo del primo modello, quello assertivo, ha di fatto cancellato il secondo. Mi fanno sorridere i confronti, oggi molto in voga, tra credenti e non credenti: veri e propri dialoghi tra sordi, visto che preti e scienziati condividono da versanti opposti lo stesso modello di verità. Poco importa che si discuta di leggi fisiche o teologiche, che naturalmente si elidono tra loro. Si tratta in ogni caso di proposizioni assertive. La confusione tra ciò che possiamo credere, sperare e amare e ciò che siamo tenuti a considerare vero, oggi ci paralizza».
Quando sarebbe stato cancellato il secondo tipo di esperienza con la parola?
«Nella tradizione dell’Occidente, è stato Aristotele ad affermare che la filosofia deve occuparsi soltanto delle proposizioni che possono risultare vere o false. Eppure esisteva ed esiste un’altra esperienza della parola: quella della promessa, della preghiera, del comando, dell’invocazione, che è stata esclusa dalla riflessione filosofica. Naturalmente, ciò non significa che essa non abbia continuato ad agire: il diritto e la religione si fondano su di essa».
Un esempio?
«Il più importante di tutti: San Paolo, che definendo la parola della fede, non fa riferimento a criteri di verità, ma parla di vicinanza tra cuore e labbra. È significativo che, tranne una volta, egli usi sempre l’espressione, da lui inventata, "credere in Gesù Cristo" e non, come sarebbe stato normale in greco, credere che Gesù è il figlio unigenito di Dio, eccetera. La differenza è sostanziale. La Chiesa, attraverso i suoi concili, ha cercato di fissare la fede in dogma, in un’esperienza di tipo assertivo. E così si è smarrito un tratto fondamentale della natura umana, che esige una fede estranea a una logica puramente fattuale. La vera fede non aderisce a un principio prestabilito ed è singolare che proprio la Chiesa, che doveva preservare questa idea, se ne sia dimenticata. Da qui la formula "Credo perché è assurdo"».
Quali sono i riflessi negativi di tale logica assertiva sulla nostra vita sociale?
«Infiniti. Pensi all’etica: si afferma che per agire bene bisogna disporre di un sistema di credenze prefissato. Dunque, agirebbe bene soltanto colui che ha una serie di principi a cui deve conformarsi.È il modello kantiano, ancora imperante, che definisce l’etica come dovere di obbedire a una legge. Quando lavoravo sull’idea di "testimonianza", mi colpì la storia di una ragazza che, sottoposta a tortura dalla Gestapo, aveva rifiutato di rivelare i nomi dei suoi compagni. A chi più tardi le chiese in nome di quali principi era riuscita a farlo, rispose soltanto "l’ho fatto perché così mi piaceva". L’etica non significa obbedire a un dovere, significa mettersi in gioco: in ciò che si pensa, si dice e si crede».
Anche perché, travolta la credenza nell’infallibilità di quella certa legge, rimane un campo di rovine.
«Prima o poi accade a tutte le credenze di tipo oggettivo. E difatti: le credenze politiche si sono letteralmente sbriciolate, quelle teologico-religiose si fossilizzano in dogmi contrapposti. Per quanto riguarda quelle scientifiche, esse risultano completamente irrelate rispetto alla vita etica dei singoli individui».
In Credere e non credere Nicola Chiaromonte formula una domanda secca: si può credere da soli?
«È una domanda pertinente. Che io riformulerei in questo modo: com’è possibile condividere una verità o una fede che non siano di tipo assertivo? Io penso che questo accada nei territori dell’esistenza in cui ci si mette in gioco personalmente. Se la veridizione è lasciata ai margini e il solo modello della verità e della fede diventano la scienza e il dogma, la vita diventa invivibile. Di qui l’indifferenza e lo scetticismo generalizzato, oltre che la tetraggine sociale dilagante. Soltanto procedendo a ritroso, ricercando quella diversa esperienza di parola, si può tornare al rapporto originario con la verità, irriducibile a qualunque sua istituzionalizzazione. Le faccio un esempio: la scienza guarda al passaggio dal primate all’uomo parlante unicamente in termini cognitivi, come se fosse soltanto una questione di intelligenza e di volume cerebrale. Ma non c’è solo questo aspetto. La trasformazione deve essere stata altrettanto gigantesca dal punto di vista etico, politico, sensibile. L’uomo non è solo homo sapiens. È un animale che, a differenza degli altri viventi, i quali non sembrano dare importanza al loro linguaggio, ha deciso di correre fino in fondo l’azzardo della parola. E da qui è nata la conoscenza, ma anche la promessa, la fede, l’amore, che esorbitano la dimensione puramente cognitiva».
È una strada ancora aperta?
«L’uomo non ha ancora finito di diventare umano, l’antropogenesi è sempre in corso. Menandro ha scritto: "com’è grazioso - cioè capace di gratuità - l’uomo quando è veramente umano". È questa gratuità che dobbiamo riscoprire. Tanto più che i modelli di credenza che ci vengono proposti non ci persuadono più. Sono, come diceva Chiaromonte, mantenuti a forza, in malafede».
Proviamo dunque a perimetrare il novero di queste credenze più genuine, anche se sotterranee, sommerse.
«Prendiamo la politica: perché non interroga finalmente la vita delle persone? Non la vita biologica, la nuda vita, che oggi è continuamente in questione nei dibattiti spesso vani sulla bioetica, ma le diverse forme di vita, il modo in cui ciascuno si lega a un uso, a un gesto, a una pratica. Ancora: perché l’arte, la poesia, la letteratura, sono museificate e relegate in un mondo a parte, come se fossero politicamente e esistenzialmente irrilevanti?».
Anche lo scrittore russo Alexandr Herzen lamentava a suo modo la cancellazione dell’esperienza vitale soggettiva. Affermando che crediamo in tutto, tranne che in noi stessi.
«Viviamo in società abitate da un Io ipertrofico, gigantesco, nel quale però nessuno, preso singolarmente, può riconoscersi. Bisognerebbe tornare all’ultimo Foucault, quando rifletteva sulla "cura di sé", sulla "pratica di sé". Oggi è rarissimo incontrare persone che sperimentino quella che Benjamin chiamava la droga che prendiamo in solitudine: l’incontro con sé stessi, con le proprie speranze, i propri ricordi e le proprie dimenticanze. In quei momenti si assiste a una sorta di congedo dall’Io, si accede a una forma di esperienza che è l’esatto contrario del solipsismo. Sì, penso che si potrebbe partire proprio da qui per ripensare un’idea diversa del credere: forme di vita, pratica di sé, intimità. Queste sono le parole chiave di una nuova politica».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- L’Auschwitz del pensiero. L’Auschwitz del pensiero. Due stralci delle riflessioni di Elie Wiesel e ohann Baptist Metz).25 gennaio 2011, di Federico La Sala
L’Auschwitz del pensiero
Anticipiamo in queste colonne due stralci delle riflessioni di Elie Wiesel e di Johann Baptist Metz raccolte nel volume ’Dove si arrende la notte. Un ebreo e un cristiano in dialogo dopo Auschwitz’, in uscita nei prossimi giorni per Rubbettino (pagine 148, euro 13,00). Si tratta di due colloqui speculari fatti nel 1993 dai teologi Ekkehard Schuster e Reinhold Boschert Kimmig al teologo cattolico e allo scrittore ebreo.
 Nota nella sua introduzione la curatrice, Mariangela Caporale: «Nella riflessione di Wiesel e di Metz la parola del sapere si traduce nel primato della responsabilità per l’altro uomo, che, per entrambi, trasfigura il mondo secondo quelle promesse che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo ha consegnato alla speranza di ogni uomo».
Nota nella sua introduzione la curatrice, Mariangela Caporale: «Nella riflessione di Wiesel e di Metz la parola del sapere si traduce nel primato della responsabilità per l’altro uomo, che, per entrambi, trasfigura il mondo secondo quelle promesse che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo ha consegnato alla speranza di ogni uomo». A.
A.Elie Wiesel: «Il pericolo è normalizzare l’Olocausto»
«Nella storia solo due popoli sono stati destinati all’estinzione completa: noi e gli Etruschi»
DI ELIE WIESEL (Avvenire, 25.01.2011)
Non voglio scoraggiare nessuno, ma a volte credo che abbiamo perso la lotta per il ricordo. Questo non significa che dobbiamo smettere di lottare. Al contrario, dovremmo continuare a combattere. Il tempo però lavora contro di noi, come diceva Joachim Fest: il tempo è un alleato potente di coloro che parteggiano per la storicizzazione del nazismo. La gente non vuole più ricordare. Non può convivere con la verità e allora pensa di poter vivere contro di essa.
Ma anche se siamo solo in pochi e se diventiamo sempre di meno, dovremo continuare a ricordare. Fra cento anni gli studenti scopriranno che ci furono alcuni che rimasero fedeli alla memoria. Questo è un motivo sufficiente per continuare a ricordare. Spiegare la singolarità di Auschwitz non è semplice.
L’argomento che più frequentemente si ripete è ancora valido: il popolo ebreo era ed è l’unico popolo destinato all’estinzione completa. Questo significa che un ebreo nell’Estremo Oriente o un ebreo a New York o in Norvegia era condannato a morte.
Nessun altro popolo condivide questo destino tranne un popolo dell’antichità, gli Etruschi. Furono estinti e nessuno sa il perché. Un bel giorno i Romani decisero di ammazzare tutti gli Etruschi e questa decisione si trasformò in un fatto. Questa decisione fu tale che i Romani giunsero a distruggere completamente la cultura e la lingua etrusche.
Un ulteriore motivo della singolarità di Auschwitz è che nessun popolo fu mai tanto solo quanto quello ebreo. Durante la guerra anche altri uomini furono eliminati dai tedeschi, non solo gli ebrei. Per tutti esistevano comitati di soccorso che sostenevano questa gente. I comunisti furono sostenuti da Mosca, altri da Washington o Londra, gli ebrei non ebbero alcun aiuto. Non ebbero nessuno alloro fianco.
Perfino dopo la guerra gli ebrei non avevano una patria dove poter andare. Quando un francese fu liberato dal campo di concentramento, poté ritornare a casa sua; addirittura i tedeschi, che erano nei lager, poterono farlo. Gli ebrei non sapevano dove andare. Se fossero tornati dove vivevano prima, sarebbero stati perseguitati anche dopo la guerra, e perfino uccisi.
In Ungheria, per esempio, l’antisemitismo fu più forte dopo la guerra che non prima, poiché coloro che si erano impossessati delle proprietà degli ebrei scacciati non volevano restituire nulla a coloro che erano riusciti a tornare. Le vittime dovevano sopportare una pena doppia. Nonostante tutti questi argomenti ’razionali’, ci deve essere di più, qualcosa di sconosciuto che rende tanto singolare la singolarità. Ci sono storici che vorrebbero far rientrare l’Olocausto nel corso generale della storia, vorrebbero «normalizzare» questo evento.
Fare questo è completamente assurdo. Un evento di questa portata non si può rimuovere. Se accadesse questo, tale evento riemergerebbe con una potenza indomabile. Finché la Germania evita consapevolmente il suo passato, sarà sempre in pericolo.
Quando una persona singola rimuove un avvenimento di un certo peso del suo passato, si ritroverà un giorno o sul lettino dello psichiatra o in un manicomio. E lo stesso può succedere a una comunità.
B.
Johann Baptist Metz: «La Shoah è entrata tardi nella teologia»
«E se anche l’attuale crisi d’umanità fosse figlia della ferita inguaribile del lager?»
DI JOHANN BAPTIST METZ (Avvenire, 25.01.2010)
Come sempre accade, anch’io mi sono accorto tardi, troppo tardi, dell’assenza in teologia di una riflessione su Auschwitz. Quando molta gente, dopo la guerra, affermava di non aver saputo niente di quest’orrore, ritenevo che si trattasse di una menzogna o una rimozione. Quando mia madre mi disse che anche lei non aveva né sentito né saputo niente di questo crimine nazista, ho riflettuto ancora di più sulla cosa. In un certo senso questo oggi mi sembra chiaro: probabilmente allora non seppero davvero niente, soprattutto perché nessuno poteva immaginare una cosa così mostruosa, perché ogni orrore di cui avevano sentito parlare, l’avevano considerato un orrore proprio del tempo di guerra e solo lentamente, dopo la guerra, hanno preso coscienza di quello che era realmente successo. Perciò non mi meraviglio tanto quando, ancora oggi, qualche volta viene fuori qualcuno che nega questa atrocità. Piuttosto mi meraviglio che sono così pochi. In definitiva, la realtà di Auschwitz allarga lo spazio delle nostre vedute.
Naturalmente non si può fare di Auschwitz una specie di «religione negativa» o un «mito negativo» per i cristiani. Su Auschwitz nel nostro ambito cristiano si fa molta retorica della colpa e della responsabilità, retorica che, però, se capisco bene, non arriva fino alle radici della teologia cristiana.
Quello che successe durante la Shoah non esige solo una revisione delle condizioni storiche nelle quali si determinò la relazione tra cristiani ed ebrei, ma esige anche una revisione della teologia cristiana in quanto tale. Il mio amico Jürgen Moltmann a buon diritto ha messo in evidenza con nettezza questa questione.
L’antisemitismo non esiste solo come crudo razzismo: in questa forma non appare più in teologia.
Esiste però in forma molto più raffinata e sottile, ossia in veste psicologica o metafisica. Fu in questa veste che divenne fin dall’inizio il tentatore della teologia cristiana. Mi riferisco soprattutto a motivi e nozioni gnostiche. La domanda teologica dopo Auschwitz non è solamente: dove era Dio ad Auschwitz? Ma è anche: dove era ad Auschwitz l’uomo?
Come si potrebbe credere nell’uomo, o perfino nell’umanità, quando si dovette sperimentare ad Auschwitz di che cosa «l’uomo» è capace? Come continuare a vivere tra gli uomini? Che cosa sappiamo noi della minaccia all’umanità dell’uomo, noi che abbiamo vissuto voltando le spalle a questa catastrofe o che siamo nati dopo di essa?
Auschwitz ha ridotto profondamente il limite di pudore metafisico tra uomo e uomo. A questo sopravvivono solo coloro che hanno poca memoria o coloro che sono riusciti bene a dimenticare che hanno dimenticato qualcosa. Ma nemmeno questi restano illesi.
Non si può peccare quanto si vuole contro il nome dell’uomo. Non solo l’uomo singolo, anche l’idea dell’uomo e dell’umanità è profondamente vulnerabile. Solo pochi collegano ad Auschwitz l’attuale crisi d’umanità: l’insensibilità crescente di fronte a diritti e valori universali e grandi, il declino della solidarietà, la furba sollecitudine nel farsi piccoli pur di adattarsi a ogni situazione, il rifiuto crescente di offrire all’io dell’uomo una prospettiva morale, eccetera.
Non sono tutte scelte di sfiducia contro l’uomo? La catastrofe che è stata Auschwitz costituisce forse una ferita inguaribile?
-
> ISRAELE --- Provo sconcerto dinanzi alla diffusione di nuovi, sconosciuti e gravi fenomeni di sciovinismo nazionalista e di allarmante estremismo religioso in una società della quale credevo di conoscere, nel bene e nel male, tutti i codici (di Abraham Yehoshua).24 gennaio 2011, di Federico La Sala
I giorni bui di un Israele nazionalista
di Abraham Yehoshua (La Stampa, 24.01.2011)
È passato molto tempo da che ho scritto un articolo su ciò che accade in Israele. Mi sono chiesto se questo fosse dovuto alla recente uscita del mio ultimo romanzo: gli ultimi ritocchi alle bozze, l’invio delle prime copie agli amici e, naturalmente, l’emozione e l’attesa delle reazioni forse mi hanno distratto dai recenti avvenimenti del mio Paese. Ma dopo un esame di coscienza ho capito che questi non sono che pretesti. La vera ragione del mio silenzio è lo sconcerto che provo dinanzi alla diffusione di nuovi, sconosciuti e gravi fenomeni di sciovinismo nazionalista e di allarmante estremismo religioso in una società della quale credevo di conoscere, nel bene e nel male, tutti i codici.
In effetti i rappresentanti della mia generazione (e non importa se di sinistra o della destra moderata) che hanno accompagnato da vicino la crescita dello stato ebraico a partire dalla fine degli Anni 40, che per più di sessant’anni hanno partecipato attivamente alle lotte, interne ed esterne, per la sua esistenza e alla formulazione di convenzioni e di norme che ne regolano l’identità, rimangono sbigottiti e confusi dinanzi alla ventata di nazionalismo che cerca di minare quelle stesse norme. Un nazionalismo radicale che attinge da due fonti all’apparenza contraddittorie: da un lato i recessi oscuri della religione ebraica che, accanto a valori di carità e di amore per l’uomo, presenta anche aspetti di evidente razzismo. Dall’altro (sorprendentemente di origine secolare) il vecchio totalitarismo sovietico importato da Lieberman e dal suo partito.
Vero, in tutto il mondo il fondamentalismo religioso e il nazionalismo sono fenomeni in crescita. Rimaniamo sorpresi nel riscontrare queste tendenze in Ungheria, in Olanda, e persino qua e là nelle nazioni scandinave. Anche la nuova destra americana infrange regole ritenute intoccabili dalla vecchia. Ma tutti questi Paesi possiedono una solida identità nazionale e non devono fare i conti con nemici esterni. In Israele, invece, l’identità nazionale è ancora agli inizi. Ci sono abissali differenze tra laici e religiosi, una grande eterogeneità di gruppi di ebrei di provenienze e culture diverse, e una cospicua minoranza di arabi israeliani che rappresenta circa il venti per cento della popolazione. Tutto questo rende complicato mantenere un fondamentale senso di solidarietà sociale, fragile e incline a essere influenzato.
Assistiamo dunque a uno strano paradosso. Nell’ opinione pubblica israeliana si rinsalda la convinzione generale che il consenso, in linea di principio, alla creazione di uno Stato palestinese sia la soluzione al conflitto con i palestinesi (anche se per molti questo consenso si accompagna alla pessimistica sensazione, giustificata o no, che la creazione di uno Stato palestinese avverrà in un futuro molto lontano). Persino l’ultra nazionalista ministro degli esteri Lieberman è teoricamente d’accordo con questo principio. Ma quanto più i toni del dibattito sulla creazione di questo stato si smorzano, e le reali differenze politiche sul tema scompaiono, tanto più in Israele si risveglia un’impetuosa ondata nazionalista che tende a ledere inviolabili diritti civili e a pretendere strambe dichiarazioni di fedeltà alla patria, pena la revoca della cittadinanza.
Così, a momenti, sembra che l’energia che in passato era diretta verso nemici esterni sia ora convogliata verso «nemici interni», considerati dalla destra nazionalista sostenitori delle forti critiche verso Israele da parte dell’Europa. Critiche che arrivano a toccare livelli assurdi, quali la delegittimazione dello Stato ebraico, per esempio. E i rapporti delle organizzazioni per i diritti umani sulla violazione dei diritti dei palestinesi nei territori, o sul comportamento brutale di alcuni soldati che violano il codice morale militare, sono visti da una parte dell’opinione pubblica israeliana quasi alla stregua di un tradimento, quando invece, per molti anni, uno dei punti di forza di Israele è stato quello di concedere piena libertà di espressione ad autocritiche ideologiche pertinenti, e alla possibilità di affrontarle pubblicamente, nel bene e nel male, senza attribuirle a fonti straniere ostili che la alimentano. E cosa fa la sinistra? Anziché essere un po’ più attiva sulla scena politica o ideologica si occupa di cultura. Non c’è mai stato in Israele un periodo di fioritura culturale come quello attuale. Con una popolazione di meno di sette milioni di abitanti il paese sforna decine di produzioni teatrali di tutti i generi, le sue straordinarie compagnie di ballo ottengono riconoscimenti in tutto il mondo, l’industria cinematografica è dinamica e originale, l’opera lirica è attiva e vivace, musicisti di talento riempiono le sale da concerto e numerosi libri, di narrativa e saggistica, sono tradotti in lingue straniere.
Ma sul piano politico l’attività della sinistra è limitata e debole. A eccezione di qualche sporadica manifestazione i partiti progressisti sono più che altro occupati in litigi e scissioni. Qualche loro rappresentante sostiene addirittura la coalizione Netanyahu - Lieberman mentre circoli ultra-liberali non fanno distinzione tra la tutela degli importanti diritti degli arabi israeliani e l’automatica difesa di infiltrati illegali africani. La sinistra ha da tempo perso contatto con i ceti popolari e appare debole, lamentosa e confusa.
La recente spaccatura del Labour e le dimissioni di Ehud Barak da presidente del partito potrebbero essere un’occasione di ripresa dell’ala socialdemocratica. Oppure no. I restanti otto membri del partito alla Knesset potrebbero anche mettersi a litigare su chi sarà il prossimo presidente. Triste.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- HANNAH ARENDT: LA RESISTENZA NONVIOLENTA IN DANIMARCA.5 dicembre 2010, di Federico La Sala
HANNAH ARENDT: LA RESISTENZA NONVIOLENTA IN DANIMARCA *
La storia degli ebrei danesi e’ una storia sui generis, e il comportamento della popolazione e del governo danese non trova riscontro in nessun altro paese d’Europa, occupato o alleato dell’Asse o neutrale e indipendente che fosse. Su questa storia si dovrebbero tenere lezioni obbligatorie in tutte le universita’ ove vi sia una facolta’ di scienze politiche, per dare un’idea della potenza enorme della nonviolenza e della resistenza passiva, anche se l’avversario e’ violento e dispone di mezzi infinitamente superiori. Certo, anche altri paesi d’Europa difettavano di "comprensione per la questione ebraica", e anzi si puo’ dire che la maggioranza dei paesi europei fossero contrari alle soluzioni "radicali" e "finali". Come la Danimarca, anche la Svezia, l’Italia e la Bulgaria si rivelarono quasi immuni dall’antisemitismo, ma delle tre di queste nazioni che si trovavano sotto il tallone tedesco soltanto la danese oso’ esprimere apertamente cio’ che pensava. L’Italia e la Bulgaria sabotarono gli ordini della Germania e svolsero un complicato doppio gioco, salvando i loro ebrei con un tour de force d’ingegnosita’, ma non contestarono mai la politica antisemita in quanto tale. Era esattamente l’opposto di quello che fecero i danesi. Quando i tedeschi, con una certa cautela, li invitarono a introdurre il distintivo giallo, essi risposero che il re sarebbe stato il primo a portarlo, e i ministri danesi fecero presente che qualsiasi provvedimento antisemita avrebbe provocato le loro immediate dimissioni. Decisivo fu poi il fatto che i tedeschi non riuscirono nemmeno a imporre che si facesse una distinzione tra gli ebrei di origine danese (che erano circa seimilaquattrocento) e i millequattrocento ebrei di origine tedesca che erano riparati in Danimarca prima della guerra e che ora il governo del Reich aveva dichiarato apolidi. Il rifiuto opposto dai danesi dovette stupire enormemente i tedeschi, poiche’ ai loro occhi era quanto mai "illogico" che un governo proteggesse gente a cui pure aveva negato categoricamente la cittadinanza e anche il permesso di lavorare. (Dal punto di vista giuridico, prima della guerra la situazione dei profughi in Danimarca non era diversa da quella che c’era in Francia, con la sola differenza che la corruzione dilagante nella vita amministrativa della Terza Repubblica permetteva ad alcuni di farsi naturalizzare, grazie a mance o "aderenze", e a molti di lavorare anche senza un permesso; la Danimarca invece, come la Svizzera, non era un paese pour se debrouiller). I danesi spiegarono ai capi tedeschi che siccome i profughi, in quanto apolidi, non erano piu’ cittadini tedeschi, i nazisti non potevano pretendere la loro consegna senza il consenso danese. Fu uno dei pochi casi in cui la condizione di apolide si rivelo’ un buon pretesto, anche se naturalmente non fu per il fatto in se’ di essere apolidi che gli ebrei si salvarono, ma perche’ il governo danese aveva deciso di difenderli. Cosi’ i nazisti non poterono compiere nessuno di quei passi preliminari che erano tanto importanti nella burocrazia dello sterminio, e le operazioni furono rinviate all’autunno del 1943.
Quello che accadde allora fu veramente stupefacente; per i tedeschi, in confronto a cio’ che avveniva in altri paesi d’Europa, fu un grande scompiglio. Nell’agosto del 1943 (quando ormai l’offensiva tedesca in Russia era fallita, l’Afrika Korps si era arreso in Tunisia e gli Alleati erano sbarcati in Italia) il governo svedese annullo’ l’accordo concluso con la Germania nel 1940, in base al quale le truppe tedesche avevano il diritto di attraversare la Svezia. A questo punto i danesi decisero di accelerare un po’ le cose: nei cantieri della Danimarca ci furono sommosse, gli operai si rifiutarono di riparare le navi tedesche e scesero in sciopero. Il comandante militare tedesco proclamo’ lo stato d’emergenza e impose la legge marziale, e Himmler penso’ che fosse il momento buono per affrontare il problema ebraico, la cui "soluzione" si era fatta attendere fin troppo. Ma un fatto che Himmler trascuro’ fu che (a parte la resistenza danese) i capi tedeschi che ormai da anni vivevano in Danimarca non erano piu’ quelli di un tempo. Non solo il generale von Hannecken, il comandante militare, si rifiuto’ di mettere truppe a disposizione del dott. Werner Best, plenipotenziario del Reich; ma anche le unita’ speciali delle SS (gli Einsatzkommandos) che lavoravano in Danimarca trovarono molto da ridire sui "provvedimenti ordinati dagli uffici centrali", come disse Best nella deposizione che rese poi a Norimberga. E lo stesso Best, che veniva dalla Gestapo ed era stato consigliere di Heydrich e aveva scritto un famoso libro sulla polizia e aveva lavorato per il governo militare di Parigi con piena soddisfazione dei suoi superiori, non era piu’ una persona fidata, anche se non e’ certo che a Berlino se ne rendessero perfettamente conto. Comunque, fin dall’inizio era chiaro che le cose non sarebbero andate bene, e l’ufficio di Eichmann mando’ allora in Danimarca uno dei suoi uomini migliori, Rolf Guenther, che sicuramente nessuno poteva accusare di non avere la necessaria "durezza". Ma Guenther non fece nessuna impressione ai suoi colleghi di Copenhagen, e von Hannecken si rifiuto’ addirittura di emanare un decreto che imponesse a tutti gli ebrei di presentarsi per essere mandati a lavorare.
Best ando’ a Berlino e ottenne la promessa che tutti gli ebrei danesi sarebbero stati inviati a Theresienstadt, a qualunque categoria appartenessero - una concessione molto importante, dal punto di vista dei nazisti. Come data del loro arresto e della loro immediata deportazione (le navi erano gia’ pronte nei porti) fu fissata la notte del primo ottobre, e non potendosi fare affidamento ne’ sui danesi ne’ sugli ebrei ne’ sulle truppe tedesche di stanza in Danimarca, arrivarono dalla Germania unita’ della polizia tedesca, per effettuare una perquisizione casa per casa. Ma all’ultimo momento Best proibi’ a queste unita’ di entrare negli alloggi, perche’ c’era il rischio che la polizia danese intervenisse e, se la popolazione danese si fosse scatenata, era probabile che i tedeschi avessero la peggio. Cosi’ poterono essere catturati soltanto quegli ebrei che aprivano volontariamente la porta. I tedeschi trovarono esattamente 477 persone (su piu’ di 7.800) in casa e disposte a lasciarli entrare. Pochi giorni prima della data fatale un agente marittimo tedesco, certo Georg F. Duckwitz, probabilmente istruito dallo stesso Best, aveva rivelato tutto il piano al governo danese, che a sua volta si era affrettato a informare i capi della comunita’ ebraica. E questi, all’opposto dei capi ebraici di altri paesi, avevano comunicato apertamente la notizia ai fedeli, nelle sinagoghe, in occasione delle funzioni religiose del capodanno ebraico. Gli ebrei ebbero appena il tempo di lasciare le loro case e di nascondersi, cosa che fu molto facile perche’, come si espresse la sentenza, "tutto il popolo danese, dal re al piu’ umile cittadino", era pronto a ospitarli.
Probabilmente sarebbero dovuti rimanere nascosti per tutta la durata della guerra se la Danimarca non avesse avuto la fortuna di essere vicina alla Svezia. Si ritenne opportuno trasportare tutti gli ebrei in Svezia, e cosi’ si fece con l’aiuto della flotta da pesca danese. Le spese di trasporto per i non abbienti (circa cento dollari a persona) furono pagate in gran parte da ricchi cittadini danesi, e questa fu forse la cosa piu’ stupefacente di tutte, perche’ negli altri paesi gli ebrei pagavano da se’ le spese della propria deportazione, gli ebrei ricchi spendevano tesori per comprarsi permessi di uscita (in Olanda, Slovacchia e piu’ tardi Ungheria), o corrompendo le autorita’ locali o trattando "legalmente" con le SS, le quali accettavano soltanto valuta pregiata e, per esempio in Olanda, volevano dai cinquemila ai diecimila dollari per persona. Anche dove la popolazione simpatizzava per loro e cercava sinceramente di aiutarli, gli ebrei dovevano pagare se volevano andar via, e quindi le possibilita’ di fuggire, per i poveri, erano nulle.
Occorse quasi tutto ottobre per traghettare gli ebrei attraverso le cinque-quindici miglia di mare che separano la Danimarca dalla Svezia. Gli svedesi accolsero 5.919 profughi, di cui almeno 1.000 erano di origine tedesca, 1.310 erano mezzi ebrei e 686 erano non ebrei sposati ad ebrei. (Quasi la meta’ degli ebrei di origine danese rimase invece in Danimarca, e si salvo’ tenendosi nascosta). Gli ebrei non danesi si trovarono bene come non mai, giacche’ tutti ottennero il permesso di lavorare. Le poche centinaia di persone che la polizia tedesca era riuscita ad arrestare furono trasportate a Theresienstadt: erano persone anziane o povere, che o non erano state avvertite in tempo o non avevano capito la gravita’ della situazione. Nel ghetto godettero di privilegi come nessun altro gruppo, grazie all’incessante campagna che in Danimarca fecero su di loro le autorita’ e privati cittadini. Ne perirono quarantotto, una percentuale non molto alta, se si pensa alla loro eta’ media. Quando tutto fu finito, Eichmann si senti’ in dovere di riconoscere che "per varie ragioni" l’azione contro gli ebrei danesi era stata un "fallimento"; invece quel singolare individuo che era il dott. Best dichiaro’: "Obiettivo dell’operazione non era arrestare un gran numero di ebrei, ma ripulire la Danimarca dagli ebrei: ed ora questo obiettivo e’ stato raggiunto".
L’aspetto politicamente e psicologicamente piu’ interessante di tutta questa vicenda e’ forse costituito dal comportamento delle autorita’ tedesche insediate in Danimarca, dal loro evidente sabotaggio degli ordini che giungevano da Berlino. A quel che si sa, fu questa l’unica volta che i nazisti incontrarono una resistenza aperta, e il risultato fu a quanto pare che quelli di loro che vi si trovarono coinvolti cambiarono mentalita’. Non vedevano piu’ lo sterminio di un intero popolo come una cosa ovvia. Avevano urtato in una resistenza basata su saldi principi, e la loro "durezza" si era sciolta come ghiaccio al sole permettendo il riaffiorare, sia pur timido, di un po’ di vero coraggio. Del resto, che l’ideale della "durezza", eccezion fatta forse per qualche bruto, fosse soltanto un mito creato apposta per autoingannarsi, un mito che nascondeva uno sfrenato desiderio di irreggimentarsi a qualunque prezzo, lo si vide chiaramente al processo di Norimberga, dove gli imputati si accusarono e si tradirono a vicenda giurando e spergiurando di essere sempre stati "contrari" o sostenendo, come fece piu’ tardi anche Eichmann, che i loro superiori avevano abusato delle loro migliori qualita’. (A Gerusalemme Eichmann accuso’ "quelli al potere" di avere abusato della sua "obbedienza": "il suddito di un governo buono e’ fortunato, il suddito di un governo cattivo e’ sfortunato: io non ho avuto fortuna"). Ora avevano perduto l’altezzosita’ d’un tempo, e benche’ i piu’ di loro dovessero ben sapere che non sarebbero sfuggiti alla condanna, nessuno ebbe il fegato di difendere l’ideologia nazista.
* [Da Hannah Arendt, La banalita’ del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964, 1993, alle pp. 177-182. E’ un brano che abbiamo gia’ altre volte riprodotto su questo foglio.
Hannah Arendt e’ nata ad Hannover da famiglia ebraica nel 1906, fu allieva di Husserl, Heidegger e Jaspers; l’ascesa del nazismo la costringe all’esilio, dapprima e’ profuga in Francia, poi esule in America; e’ tra le massime pensatrici politiche del Novecento; docente, scrittrice, intervenne ripetutamente sulle questioni di attualita’ da un punto di vista rigorosamente libertario e in difesa dei diritti umani; mori’ a New York nel 1975. Opere di Hannah Arendt: tra i suoi lavori fondamentali (quasi tutti tradotti in italiano e spesso ristampati, per cui qui di seguito non diamo l’anno di pubblicazione dell’edizione italiana, ma solo l’anno dell’edizione originale) ci sono Le origini del totalitarismo (prima edizione 1951), Comunita’, Milano; Vita Activa (1958), Bompiani, Milano; Rahel Varnhagen (1959), Il Saggiatore, Milano; Tra passato e futuro (1961), Garzanti, Milano; La banalita’ del male. Eichmann a Gerusalemme (1963), Feltrinelli, Milano; Sulla rivoluzione (1963), Comunita’, Milano; postumo e incompiuto e’ apparso La vita della mente (1978), Il Mulino, Bologna. Una raccolta di brevi saggi di intervento politico e’ Politica e menzogna, Sugarco, Milano, 1985. Molto interessanti i carteggi con Karl Jaspers (Carteggio 1926-1969. Filosofia e politica, Feltrinelli, Milano 1989) e con Mary McCarthy (Tra amiche. La corrispondenza di Hannah Arendt e Mary McCarthy 1949-1975, Sellerio, Palermo 1999). Una recente raccolta di scritti vari e’ Archivio Arendt. 1. 1930-1948, Feltrinelli, Milano 2001; Archivio Arendt 2. 1950-1954, Feltrinelli, Milano 2003; cfr. anche la raccolta Responsabilita’ e giudizio, Einaudi, Torino 2004; la recente Antologia, Feltrinelli, Milano 2006; i recentemente pubblicati Quaderni e diari, Neri Pozza, 2007. Opere su Hannah Arendt: fondamentale e’ la biografia di Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, Bollati Boringhieri, Torino 1994; tra gli studi critici: Laura Boella, Hannah Arendt, Feltrinelli, Milano 1995; Roberto Esposito, L’origine della politica: Hannah Arendt o Simone Weil?, Donzelli, Roma 1996; Paolo Flores d’Arcais, Hannah Arendt, Donzelli, Roma 1995; Simona Forti, Vita della mente e tempo della polis, Franco Angeli, Milano 1996; Simona Forti (a cura di), Hannah Arendt, Milano 1999; Augusto Illuminati, Esercizi politici: quattro sguardi su Hannah Arendt, Manifestolibri, Roma 1994; Friedrich G. Friedmann, Hannah Arendt, Giuntina, Firenze 2001; Julia Kristeva, Hannah Arendt, Donzelli, Roma 2005; Alois Prinz, Io, Hannah Arendt, Donzelli, Roma 1999, 2009. Per chi legge il tedesco due piacevoli monografie divulgative-introduttive (con ricco apparato iconografico) sono: Wolfgang Heuer, Hannah Arendt, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1987, 1999; Ingeborg Gleichauf, Hannah Arendt, Dtv, Muenchen 2000]
* TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO Numero 395 del 5 dicembre 2010
Telegrammi della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- Il governo americano ha protetto per anni i vertici delle SS.Così la Cia ha coperto i criminali nazisti (di Angelo Aquaro)..15 novembre 2010, di Federico La Sala
 Il governo americano ha protetto per anni i vertici delle SS. La verità in un documento del Dipartimento di giustizia
Il governo americano ha protetto per anni i vertici delle SS. La verità in un documento del Dipartimento di giustiziaCosì la Cia ha coperto i criminali nazisti
 Uno scienziato tedesco fu insignito dalla Nasa. In realtà aveva guidato la fabbrica di munizioni di Mittelwerk
Uno scienziato tedesco fu insignito dalla Nasa. In realtà aveva guidato la fabbrica di munizioni di Mittelwerk Il ruolo di Otto Von Bolschwing, braccio destro di Adolf Eichmann nella caccia agli ebrei e sul libro paga dei Servizi
Il ruolo di Otto Von Bolschwing, braccio destro di Adolf Eichmann nella caccia agli ebrei e sul libro paga dei Servizidi Angelo Aquaro (la Repubblica, 15.11.2010)
NEW YORK. Lo scalpo del dottor Mengele nel cassetto del Dipartimento di Giustizia sembra il particolare di un film di Tarantino: e invece è la prova di uno scandalo tenuto nascosto per anni. Il governo degli Stati Uniti ha taciuto la verità nella caccia ai nazisti. Non solo ha fatto niente o poco per assicurarsi la cattura dell’Angelo della Morte di Auschwitz. Addirittura ha coperto per decenni i criminali di Hitler offrendo sicuro riparo da questa parte dell’Atlantico. Di più. Tributando ad alcuni tutti gli onori del caso: come dimostra la vicenda di uno scienziato tedesco che contribuì alla conquista dello spazio e fu insignito dalla Nasa con la più alta delle sue onorificenze.
La storia segreta e parallela della vera caccia ai nazisti è stata scoperta e denunciata in un rapporto dello stesso Dipartimento di Giustizia che però è rimasto incompleto e - anche questo - nascosto per quattro anni. Il principale imputato è - per la verità senza grandi sorprese - la Cia. Da sempre si è parlato della connivenza del servizio segreto americano con i vecchi nazisti che in molti casi furono utilizzati durante la Guerra Fredda. Ma un conto è la ricostruzione romanzata di tanti gialli e film. Un altro mettere per iscritto «la collaborazione del governo con i persecutori» nazisti come fa il rapporto della commissione.
Il documento nasce da un’idea di Richard Clarke. L’avvocato del Dipartimento persuase nel 1999 l’allora ministro della giustizia di Bill Clinton, Janet Reno, a indagare sull’attività dell’Office of Special Investigations, che era stato creato vent’anni prima sotto la spinta di Simon Wiesenthal per dare la caccia ai nazisti. Ma l’avvocato è morto senza vedere realizzato il suo sogno di pubblicare le carte. Solo sotto la minaccia di una causa, intentata dai suoi amici, nel nome di quel Freedom of Information Act che prevede negli Usa la pubblicazione dei documenti segreti, il mega-rapporto è stato finalmente svelato. Barack Obama ha scelto di delegare al Dipartimento la divulgazione dei documenti dopo la promessa di trasparenza fatta in campagna elettorale. Soltanto il New York Times è riuscito però ad avere una copia completa del documento: senza gli omissis che coprivano comunque le informazioni più scandalose. E compromettenti: come la "prova" raccolta e tenuta nascosta dagli americani che davvero la Svizzera si era impossessata dell’oro sporco dei nazisti.
Gli investigatori dell’Office of Special Investigation, svela ora il documento, scoprirono anche che a tanti nazisti «era stato garantito l’ingresso» negli Stati Uniti. «L’America che orgogliosamente si dipingeva come un porto sicuro per i perseguitati divenne, in misura minore, anche un porto sicuro per i persecutori».
Un porto trafficatissimo. Tra i primi a imbarcarsi c’è quell’Arthur L. Rudolph che nella sua Germania aveva comandato la fabbrica di munizioni di Mittelwerk. Rudolph viene spedito nel 1945 negli Usa grazie all’Operazione Paperclip che recluta gli scienziati nazisti che sarebbero potuti essere utili all’America. Peccato che Rudolph non fosse un pesce piccolo come in un primo tempo avevano creduto gli yankee: i rapporti parlano di crudeltà nella gestione di quella fabbrica di munizioni che impiegava gli schiavi ebrei di Hitler. Un particolare che non impedì allo scienziato di sviluppare quel razzo Saturno V che divenne una delle armi della conquista spaziale: un traguardo per cui fu onorato dalla Nasa.
Ancora più imbarazzante il ruolo di Otto Von Bolschwing. Questo signore a libro paga della Cia era stato il braccio destro di Adolf Eichmann nella pianificazione della caccia agli ebrei. C’è un memo degli 007 che negli anni 70 lanciano l’allarme: che facciamo se salta fuori il suo passato? Il signorino muore nel 1981 quando, a 72 anni, gli americani stanno segretamente cercando di deportarlo.
Più avventurosa e angosciante la vera storia del dottor Josef Mengele. Per anni si è favoleggiato del suo ingresso negli Usa (ricordate "I ragazzi venuti dal Brasile"?) ma solo dopo un’analisi del suo Dna gli americani poterono accertare che era davvero morto nel 1979 in Sudamerica. Nel cassetto di un funzionario rimase nascosta una ciocca di capelli che doveva servire per accertare se fosse ancora vivo o morto. E pensare che Quentin Tarantino era stato accusato di aver esagerato immaginando nel suo "Inglourious Basterds" quei cacciatori di nazisti che raccoglievano i loro scalpi.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- L’INDICAZIONE NON RACCOLTA DI PIERRE VIDAL-NAQUET. Come storico, mi sento in parte responsabile dei deliri di cui mi sto per occupare (da "Un Eichmann di carta. Anatomia di una menzogna").6 novembre 2010, di Federico La Sala
"NELLA NOSTRA SOCIETA’ DI SPETTACOLI E DI RAPPRESENTAZIONI, CHE FARE DI UN EICHMANN DI CARTA?" (PIERRE VIDAL-NAQUET, Gli assassini della memoria, Editori Riuniti, Roma 1993, p. 55) "Di fronte a un Eichmann di carta, bisogna rispondere con la carta. Alcuni di noi lo hanno fatto e lo faranno ancora" (p. 74).
Un Eichmann di carta
Anatomia di una menzogna.
Ho esitato a lungo prima di accettare di rispondere all’amichevole richiesta di Paul Thibaud, direttore di Esprit (e che fu anche negli anni 1960-1962, direttore di Verité-Liberté, Quaderni d’informazione sulla guerra di Algeria) e di scrivere queste pagine sul preteso revisionismo, a proposito di un’opera di cui gli editori ci dicono senza ridere: Gli argomenti di Faurisson sono seri. Bisogna rispondere”. Le ragioni di non rispondere erano molteplici [...] Rispondere come, se la discussione è impossibile? Procedendo come si fa con un sofista, cioè con un uomo che assomiglia a colui che dice il vero, e di cui bisogna smontare pezzo per pezzo gli argomenti per smascherarne la falsità. Tentando, anche, di elevare il dibattito, di mostrare che l’impostura revisionista non è la sola che orna la cultura contemporanea, e che bisogna capire non solo il come della menzogna, ma anche il perché. Ottobre 1980
1. Il cannibalismo, la sua esistenza e le relative spiegazioni.
Marcel Gauchet ha dedicato la sua prima cronaca su Débat (n. 7, maggio 1980) a quel che ha chiamato "l’inesistenzialismo". Una delle caratteristiche della cultura’ contemporanea è, infatti, quella di tacciare d’un sol colpo di inesistenza le realtà sociali, politiche, ideali, culturali, biologiche che erano ritenute le più consolidate. Vengono ripiombati nell’inesistenza: il rapporto sessuale, la donna, il dominio, l’oppressione, la sottomissione, la storia, il reale, I’individuo, la natura, lo Stato, il proletariato, l’ideologia, la politica, la pazzia, gli alberi.
 Questi giochetti sono deprimenti, possono anche distrarre, ma non sono necessariamente pericolosi. Che la sessualità e il rapporto sessuale non esistano non disturba gli amanti, e l’inesistenza degli alberi non ha mai tolto il pane di bocca a un boscaiolo o a un fabbricante di pasta da carta.
Questi giochetti sono deprimenti, possono anche distrarre, ma non sono necessariamente pericolosi. Che la sessualità e il rapporto sessuale non esistano non disturba gli amanti, e l’inesistenza degli alberi non ha mai tolto il pane di bocca a un boscaiolo o a un fabbricante di pasta da carta.
 Talvolta può, tuttavia, succedere che il gioco cessi di essere innocente. Come quando si chiamano in causa non la donna, la natura o la storia, ma questa o quella espressione specifica dell’umanità, o un momento doloroso della sua storia.
Talvolta può, tuttavia, succedere che il gioco cessi di essere innocente. Come quando si chiamano in causa non la donna, la natura o la storia, ma questa o quella espressione specifica dell’umanità, o un momento doloroso della sua storia.
 In quella lunga fatica che è stata la definizione dell’uomo di fronte agli dei, di fronte agli animali, la frazione dell’umanità cui apparteniamo ha scelto in particolare, almeno da Omero e da Esiodo nell’VIII secolo a.C., di presentare l’uomo come colui che, a differenza degli animali, non mangia il suo simile. Così diceva Esiodo nel suo poema Le Opere e i Giorni: “Tale è la legge che Zeus figlio di Crono ha prescritto agli uomini: che i pesci, gli animali selvatici, gli uccelli alati si divorino, perché tra loro non c’è giustizia". Esistono trasgressioni alla legge, di rado nella pratica, piú spesso nei racconti mitici. Esistono soprattutto trasgressori classificati come tali: sono certe categorie di barbari che per ciò stesso si escludono dall’umanità. Un ciclope non è un uomo.
In quella lunga fatica che è stata la definizione dell’uomo di fronte agli dei, di fronte agli animali, la frazione dell’umanità cui apparteniamo ha scelto in particolare, almeno da Omero e da Esiodo nell’VIII secolo a.C., di presentare l’uomo come colui che, a differenza degli animali, non mangia il suo simile. Così diceva Esiodo nel suo poema Le Opere e i Giorni: “Tale è la legge che Zeus figlio di Crono ha prescritto agli uomini: che i pesci, gli animali selvatici, gli uccelli alati si divorino, perché tra loro non c’è giustizia". Esistono trasgressioni alla legge, di rado nella pratica, piú spesso nei racconti mitici. Esistono soprattutto trasgressori classificati come tali: sono certe categorie di barbari che per ciò stesso si escludono dall’umanità. Un ciclope non è un uomo.
 Non tutte le società collocano in questo preciso punto la linea di separazione. Ce ne sono alcune, né più né meno <
Non tutte le società collocano in questo preciso punto la linea di separazione. Ce ne sono alcune, né più né meno <della società greca o della società occidentale moderna, che ammettono il consumo di carne umana. Non ce n’è nessuna, credo, che riduca questo consumo a un atto come gli altri: la carne umana non appartiene alla stessa categoria di quella degli animali cacciati o d’allevamento. Naturalmente queste differenze sfuggono all’occhio degli osservatori esterni, smaniosi di trattare da non-uomini coloro che sono semplicemente diversi. [...]  Dividere il reale dall’immaginario, dare un significato all’uno e all’altro è un lavoro che tocca all’antropologo, allo storico, si tratti di antropofagia, di riti nuziali o dell’iniziazione dei giovani [...]
Dividere il reale dall’immaginario, dare un significato all’uno e all’altro è un lavoro che tocca all’antropologo, allo storico, si tratti di antropofagia, di riti nuziali o dell’iniziazione dei giovani [...][...] come molti storici, miei predecessori e miei contemporanei, mi sono interessato alla storia dei miti, alla storia dell’immaginario, pensando che l’immaginario sia un aspetto del reale e che se ne debba fare la storia come si fa quella dei cereali e della nuzialità nella Francia del XIX secolo. Certo questo “reale” è, tuttavia, nettamente meno “reale” di quel che siamo soliti chiamare con tale nome. Tra i fantasmi del marchese di Sade e il Terrore dell’anno II c’è una differenza di qualità, ed anche, al limite, un’opposizione radicale: Sade era un uomo piuttosto mite. Una certa volgarizzazione della psicanalisi è responsabile di questa confusione tra il fantasma e la realtà.
 Ma le cose sono più complesse: una cosa è attribuire all’immaginario una parte nella storia, una cosa è definire immaginaria, come Castoriadis, l’istituzione della società, un’altra è stabilire, alla maniera di Baudrillard, che il reale sociale è composto solo di relazioni immaginarie. Quest’affermazione estrema ne comporta un’altra che dovrò spiegare: quella che dichiara immaginaria tutta una serie di avvenimenti molto reali. Come storico, mi sento in parte responsabile dei deliri di cui mi sto per occupare (Pierre Vidal-Naquet, Gli assassini della memoria, nel saggio “Un Eichmann di carta. Anatomia di una menzogna”, Editori Riuniti, Roma 1993, pp. 3-8)
Ma le cose sono più complesse: una cosa è attribuire all’immaginario una parte nella storia, una cosa è definire immaginaria, come Castoriadis, l’istituzione della società, un’altra è stabilire, alla maniera di Baudrillard, che il reale sociale è composto solo di relazioni immaginarie. Quest’affermazione estrema ne comporta un’altra che dovrò spiegare: quella che dichiara immaginaria tutta una serie di avvenimenti molto reali. Come storico, mi sento in parte responsabile dei deliri di cui mi sto per occupare (Pierre Vidal-Naquet, Gli assassini della memoria, nel saggio “Un Eichmann di carta. Anatomia di una menzogna”, Editori Riuniti, Roma 1993, pp. 3-8) -
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ----- E IL CATTOLICESIMO E IL PROTESTANTESIMO CON LA CROCE UNCINATA. - La pagina oscura di lutro antisemita. Nel 1543 l’ex monaco agostiniano scrisse un violento pamphlet.27 ottobre 2010, di Federico La Sala
La pagina oscura di Lutero antisemitaNel 1543 l’ex monaco scrisse un violento pamphlet contro la «piaga» giudaica, che fu poi usato dai gerarchi della croce uncinata
di VITO PUNZI (Avvenire, 27.10.2010)
A l dosato battage orchestrato da Bompiani per far crescere l’attesa per il nuovo romanzo di Umberto Eco, Il cimitero di Praga, ha dato il proprio contributo anche la rivista
Pagine ebraiche , con un corposo dossier dedicato ai Protocolli dei savi anziani di Sion, il falso di cui periodicamente si torna a parlare. Il perché è presto detto: per quello che si sa, il Professore ha ambientato quest’ultimo libro nell’antico cimitero ebraico della città ceca, cioè nel luogo «dove alcuni grandi falsari dell’odio antiebraico hanno voluto immaginare si svolgessero le cospirazioni di ebrei intenzionati ad assumere il controllo del mondo» (così Guido Vitale, il direttore del mensile di cultura ebraica, nella presentazione del dossier).
L’idea di cogliere l’occasione del nuovo romanzo di Eco per ripercorrere la diffusione dell’antisemitismo nella cultura europea è certo lodevole. Ricordare l’odio antiebraico coltivato da autorevoli maestri del pensiero come Erasmo da Rotterdam, Schopenhauer, Kant, Hegel e Voltaire, come fa Donatella Di Cesare nel suo articolo «Quando il risentimento diventa filosofia», è semplicemente meritorio.
Così come è corretto rileggere i testi antisemiti dei citati umanisti e filosofi per tentare di comprendere l’humus nel quale ha potuto prendere forma la persecuzione sugli ebrei europei messa in atto nel secolo scorso dai nazisti. L’impressione, tuttavia, è che nel quadro generale disegnato da Di Cesare risulti minimizzato il ruolo antisemita svolto da Martin Lutero sul suolo tedesco. Già nel febbraio 2009 Giulio Busi, s’era avventurato nell’affermazione che i protestanti nei confronti degli ebrei «non hanno un corrispettivo tradizionalmente retrivo come quello cattolico». Lo studioso di giudaistica ignorò così, non si sa quanto coscientemente, il livoroso testo che Lutero scrisse nel 1543, Degli ebrei e delle loro menzogne , un libello di violenza inaudita nel quale, tra le altre nefandezze, si invitava a ripulire la Germania dalla «piaga» giudaica, dando «fuoco alle loro sinagoghe e alle loro scuole». Di Cesare da parte sua ricorda quel pamphlet,
indicandolo come «violento», e tuttavia evita di ricordare come solo le comunità protestanti attuali abbiano preso le distanze da quel testo. Gli stessi nazisti, più che negli scritti antisemiti di Hegel o di altri filosofi, trovarono materiale d’ispirazione per le proprie persecuzioni in quel terribile scritto luterano. Come non ricordare che la «notte dei cristalli», quando venne scatenato il pogrom in Germania, Austria e Cecoslovacchia, fu voluta proprio nel giorno che ricordava la nascita di Lutero? «Il 10 novembre 1938 - scriveva in quello stesso anno il vescovo evangelico-luterano di Eisenach, Martin Sasse, - bruciano in Germania le sinagoghe. Dal popolo tedesco viene finalmente distrutto il potere degli ebrei sulla nuova Germania e così viene finalmente incoronata la battaglia del Führer, benedetta da Dio, per la piena liberazione del nostro popolo». «In quest’ora - proseguiva Sasse - dev’essere ascoltata la voce dell’uomo che nel XVI secolo [Lutero, ndr ]
assunse il ruolo di profeta tedesco. Inizialmente come amico degli ebrei e tuttavia, spinto dalla propria coscienza, dall’esperienza e dalla realtà, sarebbe diventato il più grande antisemita del suo tempo, colui che lanciò al suo popolo l’allarme contro gli ebrei».
Come non ricordare poi che brani luterani trasudanti odio antiebraico vennero usati per manuali scolastici accanto a quelli di Hess, Göring, Goebbels e Hitler (vedi per esempio la parte settima di Hirts Deutsches Lesebuch, destinata alla classe 7, pubblicato nel 1940)? Il nazista Julius Streicher (giustamente citato da Di Cesare), a Norimberga, ebbe dunque un buon motivo per affermare che Lutero «oggi, sarebbe sicuramente al mio posto sul banco degli accusati».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ---- Voglio parlare della pace. Dalla Fiera di Francoforte (di David Grossman).11 ottobre 2010, di Federico La Sala
 Dalla “Fiera di Francoforte
Dalla “Fiera di Francoforte Voglio parlare della pace"
Voglio parlare della pace"Pubblichiamo il discorso che ha tenuto ieri in occasione del conferimento de "Il premio della pace" dell’Associazione degli editori e dei librai tedeschi alla Fiera del libro di Francoforte
 "Non posso dire cosa si aspettino i palestinesi: non ho diritto di fare i loro sogni. Posso solo augurare loro che conoscano un’esistenza di libertà e sovranità"
"Non posso dire cosa si aspettino i palestinesi: non ho diritto di fare i loro sogni. Posso solo augurare loro che conoscano un’esistenza di libertà e sovranità"
 "La guerra, per sua natura, annulla le sfumature che rendono unico un individuo e la meravigliosa peculiarità di ogni essere umano e rinnega anche il nostro comune destino"
"La guerra, per sua natura, annulla le sfumature che rendono unico un individuo e la meravigliosa peculiarità di ogni essere umano e rinnega anche il nostro comune destino"
 "La letteratura è la stupefazione per l’uomo e per la sua complessità La scrittura dà il piacere di immaginare Per questo mi auguro che il mio Paese trovi la forza di riscrivere la sua storia"
"La letteratura è la stupefazione per l’uomo e per la sua complessità La scrittura dà il piacere di immaginare Per questo mi auguro che il mio Paese trovi la forza di riscrivere la sua storia"
 "Solo la fine dello scontro darà a Israele una casa, un domani, generazioni future E darà la possibilità di vivere una sensazione mai provata: quella di un’esistenza stabile"
"Solo la fine dello scontro darà a Israele una casa, un domani, generazioni future E darà la possibilità di vivere una sensazione mai provata: quella di un’esistenza stabile" di David Grossman (la Repubblica, 11.10.2010)
di David Grossman (la Repubblica, 11.10.2010)Quando ho cominciato a scrivere A un cerbiatto somiglia il mio amore sapevo di voler raccontare la storia di Israele che da più di cento anni - ancor prima che diventasse una nazione - si trova in uno stato di guerra. E sapevo che l’avrei raccontata attraverso la storia privata, intima, di una famiglia.
Sarete forse d’accordo con me che il vero grande dramma dell’umanità è quello della famiglia. E ognuno di noi è un personaggio di questo dramma in quanto in una famiglia è nato. Ai miei occhi i momenti più significativi della storia non sono avvenuti sui campi di battaglia, in sale di palazzi o di parlamenti bensì in cucine, in camere da letto matrimoniali o in quelle dei bambini.
In A un cerbiatto somiglia il mio amore ho cercato di mostrare come il conflitto mediorientale proietti sé stesso, la sua brutalità, sulla fragile e delicata sfera familiare e come, inevitabilmente, ne modifichi il tessuto.
Ho cercato di descrivere la lotta che persone intrappolate in questo conflitto, o in un qualunque scontro violento e protratto, devono sostenere.
È la lotta per mantenere il sottile e complesso intreccio dei rapporti umani e sentimenti di tenerezza, di sensibilità, di compassione, in una situazione di durezza e di indifferenza nella quale il volto del singolo viene cancellato. A volte paragono il tentativo di preservare questi sentimenti nel pieno di una guerra a quello di camminare con una candela in mano durante una violenta tempesta.
Concedetemi ora di condurvi, con una candela in mano, in mezzo a questa violenta tempesta.
Se mi chiedeste cosa mi auguro per il conflitto israelo-palestinese la mia risposta, ovviamente, sarebbe che finisse al più presto, si risolvesse e regnasse la pace. Ma forse allora insistereste a chiedere: «E se le ostilità dovessero andare avanti ancora a lungo, quale sarebbe il tuo più grande desiderio?». Dopo aver provato una punta di dolore per questa domanda risponderei che in quel caso vorrei imparare a essere il più possibile esposto alle atrocità e alle ingiustizie, grandi e piccole, che il conflitto crea e ci presenta ogni giorno, e non chiudermi in me stesso o cercare di proteggermi.
Per me essere uomo in uno scontro tanto prolungato significa soprattutto osservare, tenere gli occhi aperti, sempre, per quanto io riesca (e non sempre ci riesco, non sempre ho la forza di farlo). Però so di dovere almeno insistere, per sapere ciò che succede, cosa viene fatto a nome mio, a quali cose collaboro malgrado io le disapprovi nella maniera più assoluta. So di dovere osservare gli eventi per reagire, per dire a me stesso e agli altri ciò che provo. Chiamare quegli eventi con parole e nomi miei, senza farmi tentare da definizioni e da termini che il governo, l’esercito, le mie paure, o persino il nemico, cercano di dettarmi.
E vorrei ricordare - e spesso è questa la cosa più difficile - che anche chi mi sta di fronte, il nemico che mi odia e vede in me una minaccia alla sua esistenza, è un essere umano con una famiglia, dei figli, un proprio concetto di giustizia, speranze, disperazioni, paure e limitatezze.
Signore e signori, oggi mi conferite questo prestigioso "Premio della pace", e della pace voglio parlare. È indispensabile parlarne, insistere a parlarne, soprattutto in una realtà come la nostra. È importante praticare una rianimazione costante e intensa alla coscienza terrorizzata e paralizzata di israeliani e palestinesi per i quali la parola "pace" è quasi sinonimo di illusione, di miraggio, se non addirittura di trappola di morte.
Dopo cento anni di guerre e decenni di occupazione e di terrorismo la maggior parte degli israeliani e dei palestinesi non crede infatti più nella possibilità di una vera pace. Non osa nemmeno immaginare una situazione di pace. È ormai rassegnata al fatto di essere probabilmente costretta a vivere in una spirale infinita di violenza e di morte. Ma chi non crede nella possibilità della pace è già sconfitto, si è autocondannato a una guerra continua.
Talvolta occorre ricordare - e di certo su questo autorevole palcoscenico - ciò che è ovvio: le due parti, israeliani e palestinesi, hanno il diritto di vivere in pace, liberi da occupazioni, dal terrorismo, dall’odio; di vivere con dignità, sia a livello del singolo che come popoli indipendenti in un loro stato sovrano, di guarire dalle ferite provocate da un secolo di guerre. E non solo entrambe le parti hanno questo diritto, hanno anche un estremo bisogno della pace, un bisogno vitale.
Non posso parlare di cosa si aspettino i palestinesi dalla pace. Non ho il diritto di fare i loro sogni. Posso solo augurare loro, dal profondo del cuore, che conoscano al più presto un’esistenza di libertà e di sovranità dopo anni di schiavitù e di occupazione sotto turchi, inglesi, egiziani, giordani e israeliani; che costruiscano la loro nazione, uno stato democratico, in cui crescere i figli senza paura, godere di una vita normale, di pace, e di quanto essa può offrire a qualunque essere umano. Posso però parlare dei miei desideri e delle mie speranze di israeliano e di ebreo.
Ai miei occhi la parola "pace" non definisce soltanto una situazione in cui finalmente la guerra, con tutte le sue paure, sarà finita e Israele manterrà buoni rapporti con i suoi vicini. La vera pace, per Israele, significherà un nuovo modo di essere nel mondo, la possibilità di guarire lentamente da distorsioni causate da duemila anni di diaspora, di persecuzioni, di antisemitismo e di demonizzazione. E forse, fra molti anni, se questa fragile pace resisterà, se Israele rafforzerà le basi della propria esistenza e potrà sfruttare appieno il suo grande potenziale umano, spirituale e culturale, anche la sensazione di estraneità esistenziale, di isolamento, che l’uomo ebreo, che il popolo ebreo, prova in mezzo ad altri popoli, svanirà.
Con la pace Israele avrà finalmente dei confini, cosa non da poco, soprattutto per un popolo che per gran parte della sua storia è stato disperso in altre nazioni e molte sue tragedie sono derivate proprio da questo. Pensate: ormai da 62 anni Israele non ha confini definitivi. Le sue frontiere sono instabili, vengono modificate, allargate o ristrette, a ogni decennio. Nel nostro mondo chi non possiede dei confini chiari è paragonabile a chi vive in una casa i cui muri ondeggiano e la terra trema costantemente sotto i suoi piedi. A chi non possiede una vera casa.
Nonostante la sua grande forza militare Israele non è ancora riuscito a infondere nei suoi cittadini il senso di naturale serenità di chi si trova al sicuro nel proprio paese. Non è riuscito - ed è questa la cosa tragica - a guarire gli ebrei da un’amara sensazione di fondo: il disagio di chi non si sente quasi mai a casa nel mondo.
E dopo tutto Israele è stato creato per essere rifugio degli ebrei e del popolo ebreo. Era questo il sogno che ha portato alla sua creazione. Ma fintanto che non ci saranno la pace, dei confini definitivi e concordati e un vero senso di sicurezza noi israeliani non avremo la casa di cui siamo degni e di cui abbiamo bisogno. Non ci sentiremo a casa nel mondo. Di sicuro ve ne rendete conto: certe parole, pronunciate da un ebreo israeliano in Germania, hanno una cassa di risonanza come in nessun’altra parte del mondo. Ciò di cui parlo, i termini che uso, i palpiti della memoria che questi risvegliano, provengono dalla ferita della Shoà e a essa fanno ritorno. Molto di quanto avviene in Israele, sia in ambito privato (nei rapporti di un uomo con sé stesso, con la sua famiglia, con i suoi amici), sia in quello pubblico, politico e militare, intrattiene un discorso complesso con la Shoà, con il modo in cui questa ha forgiato la coscienza ebraica e israeliana. Anche le cose che dico qui, nella Paulskirche, sede del primo parlamento tedesco democraticamente eletto nel 1848, le mie parole, come un colombo viaggiatore della Shoà, tornano sempre "laggiù", a quei giorni.
Ma al tempo stesso, e senza fare paragoni inaccettabili tra situazioni storiche completamente diverse, io rammento a me stesso che qui, in Germania, si può anche vedere come un popolo è in grado di risollevarsi non solo dalla distruzione fisica ma dal superamento di ogni limite e freno, dallo sgretolamento di ogni senso di umanità, e di impegnarsi a rispettare i valori dell’etica e della democrazia e di educare i giovani all’idea della pace.
Ma torniamo alla realtà del Medio Oriente: solo la pace potrà curare Israele dalla profonda paura che palpita nei cuori dei suoi cittadini riguardo al futuro del loro paese e dei loro figli. Credo che non ci sia al mondo un altro stato che viva una tale angoscia esistenziale. Quando leggete sul giornale che la Germania ha grandi progetti per il 2030 la cosa vi sembra logica e naturale, ma nessun israeliano farebbe progetti così a lungo termine. Quando penso a Israele nel 2030 provo una stretta al cuore, come se avessi profanato un qualche tabù concedendomi di immaginare un futuro tanto lontano....
Solo la pace darà a Israele una casa, un domani, generazioni future. E solo la pace permetterà a noi israeliani di vivere una situazione, o sensazione, mai provata prima: quella di un’esistenza stabile.
Chi è stato esiliato, deportato, perseguitato, cacciato ripetutamente per gran parte della sua storia, chi ha errato sospeso tra la vita e la morte per migliaia di anni, può solo aspirare a un’esistenza stabile e sicura nella propria patria. Aspirare a sentirsi un popolo radicato nella propria terra, con confini protetti e riconosciuti dalla comunità internazionale, accettato dai vicini, in buoni rapporti con loro e integrato nel tessuto delle loro vite, con un futuro davanti e finalmente a casa nel mondo.
Eccomi qui a parlarvi della pace. È strano. Io che non mai conosciuto un solo istante di vera pace in vita mia, vengo a parlarne a voi? Eppure ritengo che proprio ciò che so della guerra mi dia il diritto di farlo.
Già da molti anni la mia vita, i miei libri, si dipanano in un questo miscuglio di guerra, di paura delle sue conseguenze, di ansia per Israele e per i miei cari che ci vivono, di lotta per il diritto ad avere una vita privata, intima, non eroica, in una situazione spesso monopolizzata dal conflitto, dalla tempesta, dalla candela.
E quanto più conosco profondamente la distruzione e la devastazione di una vita in uno stato di guerra, più sento il bisogno di scrivere, di creare, come se questo fosse un modo di rivendicare il mio diritto all’individualità, di dire "io" anziché "noi".
La guerra, per sua natura, annulla le sfumature che rendono unico un individuo e la meravigliosa peculiarità di ogni essere umano. E con la stessa violenza rinnega anche la somiglianza fra gli esseri umani, le cose che ci rendono uguali, il nostro comune destino. La letteratura, non solo scrivere libri ma anche leggerli, è l’opposto di tutto ciò. È la totale dedizione all’individuo, al suo diritto di essere tale e al destino che condivide con l’intera umanità. La letteratura è lo stupefazione per l’uomo, per la sua complessità, la sua ricchezza, le sue ombre.
Quando scrivo cerco di redimere con tutte le mie forze ogni personaggio dalla morsa dell’estraneità, della banalità, degli stereotipi, dei cliché, dei pregiudizi. Quando scrivo lotto, talvolta per anni, per cercare di capire ogni aspetto di una figura umana, per essere lei.
C’è un che di tenero, quasi materno, nel modo in cui uno scrittore cerca di percepire con tutti i suoi sensi i sentimenti e le emozioni del personaggio che crea. C’è un che di vulnerabile e di sprovveduto nella sua disponibilità a dedicarsi senza difese ai personaggi di cui scrive. È forse questo ciò che di grande può offrire la letteratura a chi vive in uno stato di guerra, di alienazione, di discriminazione, di povertà, di esilio, di sensazione che il suo "io" venga continuamente calpestato: la capacità di restituirci un volto umano.
Signore e signori, ho aperto questo discorso parlando di come ho cominciato a scrivere A un cerbiatto somiglia il mio amore. Forse sapete che il romanzo narra di un soldato israeliano che parte per la guerra e la madre, in ansia per il figlio, fugge di casa perché un’eventuale brutta notizia non la raggiunga.
Tre anni e tre mesi dopo avere cominciato a scrivere il libro è scoppiata la seconda guerra del Libano in seguito a un improvviso attacco di Hezbollah a una pattuglia israeliana in ricognizione entro i confini di Israele. La sera di sabato 12 agosto 2006, poche ore prima del cessate il fuoco, mio figlio Uri è stato ucciso insieme a suoi tre compagni, l’equipaggio di un carro armato, da un razzo lanciato da Hezbollah.
Dirò solo questo: pensate a un ragazzo sulla soglia della vita, con tutte le speranze, l’entusiasmo, la gioia di vivere, l’ingenuità, l’umorismo e i desideri di un giovane uomo. Così era Uri e così erano migliaia di israeliani, palestinesi, libanesi, siriani, giordani ed egiziani che hanno perso, e continuano a perdere, la vita in questo conflitto.
Al termine della settimana del lutto ho ripreso a scrivere. Quando a un uomo capita una tragedia una delle sensazioni più forti che prova è quella di essere esiliato da tutto ciò in cui credeva, di cui era certo, dalla storia di tutta la sua vita. All’improvviso niente è più scontato.
Per me, tornare a scrivere dopo la tragedia è stato un atto istintivo. Avevo la sensazione che così facendo avrei potuto, in un certo senso, tornare dall’esilio.
Ho ripreso a scrivere. Sono tornato alla storia che, stranamente, era uno dei pochi luoghi della mia vita che ancora potevo capire. Mi sono seduto alla scrivania e ho cominciato a riannodare i fili lacerati della trama. Dopo qualche settimana ho sentito per la prima volta, con un certo stupore, il piacere di scrivere. Mi sono ritrovato a cercare per ore una parola che descrivesse con esattezza un preciso sentimento. Mi sono reso conto di non potermi accontentare di un termine che non rispecchiasse fedelmente quel sentimento. A tratti mi stupivo che qualcosa di tanto piccolo accentrasse a tal punto la mia attenzione quando il mondo intorno a me era crollato. Ma non appena trovavo la parola giusta avvertivo una soddisfazione che pensavo non avrei più provato in vita mia: quella di fare qualcosa come si deve in un mondo tanto caotico. Talvolta mi sentivo come chi, dopo un terremoto, esce dalle macerie di casa, si guarda intorno, e comincia a impilare un mattone sull’altro.
E mentre scrivevo a poco a poco riaffiorava in me il piacere di immaginare, di inventare, lo stimolo del gioco e della scoperta che palpitano in ogni creazione. Inventavo personaggi, soffiavo in loro la vita, il calore e la fantasia che non credevo più ci fossero in me. Davo loro una realtà, una quotidianità. Ritrovavo dentro di me il desiderio di toccare tutte le sfumature di un sentimento, di una situazione, di un rapporto. E non temevo il dolore che talvolta questo contatto provoca. Riscoprivo che scrivere è per me il miglior modo di combattere l’arbitrarietà - qualsiasi arbitrarietà - e la sensazione di essere una vittima impotente dinanzi a essa. E ho imparato che in certe situazioni l’unica libertà che un uomo ha è quella di descrivere con parole sue il proprio destino. Talvolta questo è un modo per non essere più una vittima.
E questo è vero sia per il singolo che per le comunità, i popoli. Mi auguro che il mio paese, Israele, trovi la forza di riscrivere la sua storia. Di porsi in maniera nuova e coraggiosa dinanzi al suo tragico passato e ricrearsi da esso. Mi auguro che tutti noi troveremo la forza necessaria per distinguere i veri pericoli dai potenti echi delle sciagure e delle tragedie che ci hanno colpito in passato, per non essere più vittime dei nostri nemici o delle nostre angosce e per arrivare, finalmente, a casa.
Grazie e shalom
(Traduzione di Alessandra Shomroni)
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- La missione Irene. Israele blocca nave per Gaza. Il falco Lieberman gela Obama (di U. De Giovannangeli).29 settembre 2010, di Federico La Sala
 La missione Irene. Il catamarano portava aiuti umanitari e giocattoli per la Striscia
La missione Irene. Il catamarano portava aiuti umanitari e giocattoli per la Striscia
 Il falco Lieberman gela Obama: ci vorranno decenni per arrivare alla pace con i palestinesi
Il falco Lieberman gela Obama: ci vorranno decenni per arrivare alla pace con i palestinesi Israele blocca nave per Gaza. A bordo nove pacifisti ebrei
Israele blocca nave per Gaza. A bordo nove pacifisti ebrei A bordo della nave della pace anche un sopravvissuto all’Olocausto e il padre di una ragazza uccisa in un attentato a Gerusalemme: «Un vero eroe è colui che cerca di trasformare un nemico in amico».
A bordo della nave della pace anche un sopravvissuto all’Olocausto e il padre di una ragazza uccisa in un attentato a Gerusalemme: «Un vero eroe è colui che cerca di trasformare un nemico in amico». di Umberto De Giovannangeli (l’Unità, 29.09.2010)
di Umberto De Giovannangeli (l’Unità, 29.09.2010)Reuven Moshkovitz, 82 anni, sopravvissuto alla Shoah. Rami Elhan, un padre che ha perso la figlia di 14 anni in un attentato suicida in un centro commerciale di Gerusalemme nel 1997. Reuven e Rami hanno saputo trasformare il loro dolore in energia positiva. In determinazione ad agire contro i soprusi perpetrati da Israele contro la popolazione della Striscia. Una determinazione che li ha spinti a far parte della spedizione dell’ «Irene», il catamarano con a bordo nove pacifisti ebrei, tra i quali anche israeliani, che ieri ha cercato di forzare il blocco navale israeliano per raggiungere Gaza City, con un piccolo carico di medicinali, giocattoli e apparecchiature per la purificazione dell’acqua. «È un dovere sacro per me, come sopravvissuto all’Olocausto - dice Reuven Moshkovitz quello di protestare contro la persecuzione, l’oppressione e la carcerazione del popolo di Gaza, compresi 800.000 bambini».
Grazie al prezioso contributo della Rete romana di solidarietà con il popolo palestinese, riusciamo a metterci in contatto telefonico con gli uomini a bordo dell’«Irene». «Vogliamo dire al mondo che in Israele ci sono anche tante persone che giudicano un crimine contro l’umanità il blocco a Gaza. Non è opprimendo un altro popolo, negandogli libertà di movimento, e il diritto ad uno Stato indipendente, che garantiremo la nostra stessa sicurezza», afferma Rami Elhan. «La nostra aggiunge - vuol essere una protesta non violenta e per questo ancora più forte». La linea cade. Un momento prima, sentiamo voci concitate: «Stanno arrivando», riesce a dire Rami. È l’avvisaglia di ciò che da lì a qualche minuto accadrà. Le ultime parole danno conto di un momento drammatico: «Un cacciatorpediniere israeliano ci taglia la strada...Un’altra piccola imbarcazione si avvicina...Il cacciatorpediniere si sta avvicinando ed anche le piccole barche stanno intralciando al nostra rotta...Hanno mitragliatrici a poppa e prua...Il cacciatorpediniere sta bloccando a prua la nostra rotta mentre il naviglio minore ci sta circondando». Poi, il silenzio.
Un commando della marina israeliana prende il controllo della imbarcazione, battente bandiera britannica. L’azione è confermata da una portavoce militare, secondo la quale l’equipaggio dell’«Irene» è stato contattato mentre si avvicinava alla Striscia di Gaza e sollecitato a cambiare rotta poiché secondo Israele stava «violando la legge israeliana e quella internazionale»’. Ma ha opposto un rifiuto. Di qui l’abbordaggio, conclusosi in ogni caso «senza violenze da una parte o dall’altra», «La sorte di questa barca simboleggia il destino delle speranze di pace in questa regione», rimarca da Londra Richard Kuper della Jews for Justice for Palestinians e del Comitato organizzatore della nave «Irene».
NEL PORTO DI ASHDOD
Nel primo pomeriggio l’«Irene» ha fatto il suo ingresso forzato nel porto israeliano di Ashdod. Il ministero degli Esteri israeliano ha accusato i pacifisti di aver attuato una deliberata «provocazione» e «di versare deliberatamente benzina sul fuoco dell’odio verso Israele nel mondo». Ma per Reuven Moshkovitz, 82 anni, sopravvissuto alla Shoah, «vero eroe è colui che cerca di trasformare un nemico in un amico» . I pacifisti israeliani sono stati fermati dalla polizia per interrogatori, quelli stranieri saranno espulsi.
Dalle acque agitate di Gaza a quelle, non meno tempestose, di un negoziato in bilico. Il presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen) chiede che Israele rispetti una moratoria sulla colonizzazione «fino a quando vi saranno negoziati» di pace. «Chiediamo la moratoria fin quando vi saranno negoziati di pace perché, finché vi saranno negoziati di pace, vi sarà speranza», dice da Parigi il presidente dell’Anp, ai microfoni di Radio Europe. Una risposta, indiretta, viene da New York. Ed è una risposta raggelante. Ad offrirla è il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman. Pochi giorni fa dalla tribuna dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Barack Obama aveva affermato che è possibile, entro un anno, raggiungere una pace fondata su «due popoli, due Stati».
Dalla stessa tribuna, Lieberman, capofila dei falchi israeliani, avverte: c’è’ il rischio che ci vogliano decenni per un accordo tra israeliani e palestinesi, perché occorre risolvere prima la questione iraniana. E da Gerusalemme l’ufficio del premier licenzia una nota ufficiale fortemente irritata: le affermazioni del ministro degli Esteri sul conflitto israelo-palestinese «non rappresentano la posizione del Governo israeliano».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO --- Il «Jews for Justice for Palestinians». veliero di pacifisti ebrei verso Gaza.Sulla barca salpata da Cipro un sopravvissuto all’Olocausto27 settembre 2010, di Federico La Sala
 PER SFIDARE L’EMBARGO
PER SFIDARE L’EMBARGOVeliero di pacifisti ebrei verso Gaza
Il «Jews for Justice for Palestinians» ha obiettivi pacifici
Sulla barca salpata da Cipro un sopravvissuto all’Olocausto *
Una nave, con a bordo una decina di attivisti ebrei provenienti da Israele, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna, ha lasciato ieri il porto di Famagosta, nel nord di Cipro, diretta nella Striscia di Gaza, con la speranza di violare simbolicamente l’embargo israeliano. Richard Kuper, uno degli organizzatori del gruppo britannico «Jews for Justice for Palestinians», ha precisato che uno degli obiettivi dell’iniziativa è mostrare che non tutti gli ebrei approvano la politica israeliana verso i palestinesi. Kuper ha poi precisato che la nave non opporrà alcuna resistenza alle autorità israeliane. La nave trasporta giocattoli per bambini, materiale sanitario e altri aiuti per gli abitanti della Striscia di Gaza.
A bordo dell’imbarcazione che si chiama Irene e batte bandiera britannica, c’è anche un sopravvissuto all’Olocausto, Reuven Moshkovitz, di 82 anni. «È un dovere sacro per me, come sopravvissuto all’Olocausto - ha detto - quello di protestare contro la persecuzione, l’oppressione e la carcerazione del popolo di Gaza, compresi 800.000 bambini». Tra i partecipanti alla missione vi è pure Rami Elhan, un israeliano che ha perso la figlia in un attentato suicida in un centro commerciale a Gerusalemme nel 1997. La traversata dovrebbe durare 36 ore. La missione arriva quasi quattro mesi dopo che i commando israeliani hanno bloccato la «Peace Flottila» e che nove attivisti sono rimasti uccisi negli scontri scoppiati a bordo di una nave turca.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- DAVID GROSSMAN: "Resto in Israele, la patria degli ebrei ma la pace coi palestinesi è essenziale... l’esistenza di due Stati non ha alternative"(di Fabio Scuto).8 settembre 2010, di Federico La Sala
"Resto in Israele, la patria degli ebrei ma la pace coi palestinesi è essenziale"
David Grossman: "Il futuro del Paese più importante dei confini territoriali"
di Fabio Scuto (la Repubblica, 08.09.2010)
 I miei detrattori dovranno continuare a sopportare le mie idee: l’esistenza di due Stati non ha alternative
I miei detrattori dovranno continuare a sopportare le mie idee: l’esistenza di due Stati non ha alternative
 Non è vero che voglio andar via: nell’intervista alla tv inglese è stata estrapolata una frase fuori contesto
Non è vero che voglio andar via: nell’intervista alla tv inglese è stata estrapolata una frase fuori contesto«In quell’intervista alla tv inglese ho parlato di me e della mia famiglia, di come vedo in Israele la mia patria, del mio futuro e dei miei figli; da lì è stata estrapolata fuori contesto una frase, anzi una parte, e i giornali ci hanno fatto i titoli. Ai miei detrattori, a quelli che non aspettano altro per attaccarmi, voglio dire: resto qui e dovranno continuare a sopportarmi con le mie opinioni». Non ha perso il filo della sua ironia, ma certamente David Grossman è molto arrabbiato: «Le mie parole sono state riportate in maniera imprecisa, fuori dal loro contesto». Da tempo - in Israele e nel mondo - il cinquantaseienne scrittore israeliano non è più un privato cittadino, ma un’icona, un punto di riferimento obbligato, per la chiarezza del suo pensiero e del sentimento che lo anima. Dopo la drammatica morte del figlio Uri, ucciso in combattimento con gli Hezbollah negli ultimi giorni della guerra del 2006, Grossman si è trovato «in una situazione estrema», in cui ha esaminato cose diverse, l’idea di lasciare Israele «è stata pure evocata, ma al solo scopo di scartarla».
Ci parli di quei giorni...
«Dopo quella tragedia mi sono tormentato la mente, in quei momenti è il dolore a guidare i tuoi pensieri. Niente ti sembra più scontato, guardi alla tua vita e ti fai delle domande, per esempio: se non fossimo stati qui non sarebbe accaduto. Ma la risposta dentro di me allora come oggi è stata chiara: sono nato qui, appartengo a questa terra, vedo il mio futuro qui e da 30 anni questo posto è il centro di tutto ciò che dico e scrivo. Per noi israeliani la patria è qui, qui dobbiamo affrontare la realtà e affrontare il nostro futuro. E in tutta quell’intervista ho parlato di questo e di quanto sia forte il mio desiderio che Israele sia davvero la "casa" che dovrebbe essere per noi ebrei».
Non è la prima volta che lei diventa un bersaglio per le sue opinioni...
«È mio pieno diritto avere opinioni di sinistra. Essere a favore della spartizione di questa terra in due Stati, di fare rinunce per arrivare alla pace. Ma detto questo è necessario sapere che queste convinzioni vengono proprio da una preoccupazione profonda, da un impegno, da un amore per questa terra. Ci sono persone che la pensano come me e altre che aspettano ogni scusa per attaccarmi. Mi spiace per la loro reazione ma io sono e resto qui. In genere sono felicemente contento di essere un loro bersaglio ma questa volta non posso collaborare, diventare un bersaglio per una cosa che non ho fatto e non ho detto, proprio no. Ripeto sono e resto qui e dovranno continuare a sopportarmi con le mie opinioni»
È preoccupato per il futuro di Israele?
«Sono sempre preoccupato per il futuro del mio Paese. Israele viene sempre più isolato e io credo che invece il futuro sia di essere integrato e di essere il paese che deve essere, cioè uno Stato che esplora, che espande le sue capacità e che realizza il suo grande potenziale. Ma tutto questo dipende dalla capacità di vivere in pace con i Paesi vicini, ma certo non sappiamo se la pace sia garanzia che ciò accada veramente. Viviamo in una regione molto imprevedibile e tanti elementi estremi stanno provando a fare di tutto per assassinare questa pace. Quello che posso garantire è che se non c’è nessuna pace la nostra situazione sarà sempre più pericolosa».
E timori per la democrazia interna?
«Sì certamente ne ho. Perché se continuiamo a vivere in situazioni così estreme la gente sarà presa dall’ansia e dalla disperazione, ci saranno sempre più estremisti che sfrutteranno questa situazione. I nazionalisti, i fondamentalisti e molti altri con le loro promesse di rapide e facili soluzioni. L’unico modo per rimanere veramente noi stessi e per affrontare ciò è guardare la realtà dritta negli occhi, in tutta la sua complessità e possibilità. E di ricordare che noi abbiamo ricevuto una meravigliosa opportunità dalla Storia quando è nato Israele nel 1948 e dobbiamo essere rispettosi di questo privilegio. Dobbiamo capire che il futuro di Israele, la sua identità di Stato e quella dei suoi cittadini sono cose molto, molto, più importanti dei problemi sui confini territoriali».
Grossman che sensazione ha ricavato dalla ripresa del negoziato di pace a Washington dopo quasi due anni di gelo diplomatico?
«Molto dipende dai due leader, sono loro che devono prendere delle decisioni. Io spero che superino le paure e le diffidenze reciproche e che capiscano che la pace è la sola alternativa per noi, per avere una vita qui, per avere una vera vita. Ma penso anche che dopo anni di violenza talvolta noi non agiamo sempre nel vero interesse e spesso abbiamo fatto la scelta sbagliata. Domani sera per noi ebrei è Rosh Hashanah, è Capodanno, il mio auspicio per il nuovo anno è che finalmente saremo tanto coraggiosi da fare l’inevitabile: trovare una soluzione-compromesso per questa terra e non importa quanti problemi avremo poi per questa fragile pace, ma loro la mantengano. O almeno per una volta ci provino davvero».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- DAVID GROSSMANN SI CONFESSA: "TENTATO DI LASCIARE ISRAELE" (di Francesco Battistini).7 settembre 2010, di Federico La Sala
Grossman si confessa: «Tentato di lasciare Israele» Lo scrittore: «Ci ho pensato e ci penso ancora, ma lo farò solo quando scomparirà la democrazia»
di Francesco Battistini (Corriere della Sera, 07.09.2010)
GERUSALEMME - Il venerdì, lui c’è. Quasi sempre. Da mesi. A Gerusalemme Est, David Grossman non si perde i sit in davanti alle case del quartiere arabo di Sheikh Jarrah. Una protesta pacifica, cartelloni e slogan contro lo sgombero di alcune famiglie palestinesi. Un gruppetto di pacifisti testardi, molti che arrivano apposta dall’Europa. Qualche settimana fa, per ripararsi dal caldo, Grossman è arrivato vestito di nero alle solite tre del pomeriggio e s’è seduto su una panchina, sotto un grande ulivo. Stanco. Nessuna voglia di parlare. Per l’afa soffocante, per la delusione che da un po’ gli soffoca le parole: «Non chiedetemi niente. Mi sembra di ripetere certe cose da cent’anni...».
A un cerbiatto somiglia il suo dolore. Un cerbiatto in fuga. Lo scrittore è stanco. Lo confidava da un po’ di tempo, in privato. L’altra sera, a Londra, dove in questi giorni si trova per promuovere una nuova edizione inglese del suo ultimo libro, per la prima volta ha deciso di rendere pubblico il suo disagio.
D’intellettuale. D’israeliano. Dice d’avere una «tentazione» forte: «Ho soppesato l’idea di lasciare Israele e devo riconoscere che la tentazione c’è sempre». Lo sfogo è arrivato in un’intervista a una tv inglese, Canale 10: «Parte della tragedia degli ebrei come individui, ma anche come collettività, è che non abbiamo mai trovato una vera casa nel mondo. Oggi, abbiamo Israele. L’abbiamo da 62 anni. E non è la patria che pensavamo sarebbe stata».
C’entra l’ultima disillusione, ovviamente, su negoziati di pace destinati - pure nella visione di Grossman - alla galleria delle inutili cerimonie: «Non sono sicuro che i nostri due leader, quello israeliano e quello palestinese, siano tanto coraggiosi da fare i passi giusti per raggiungere la pace. Dopo cent’anni di morte, forse abbiamo perso il momento giusto».
Il disagio però va oltre e riguarda, più che l’inconcludente agenda del domani, la paura del dopodomani: «Sì, ho sempre pensato di poter abbandonare questo Paese e questa possibilità c’è sempre. Ma so che me ne andrò solo quando Israele smetterà d’essere una democrazia».
È un’inquietudine che Grossman spiegò già nel 2006, l’anno di Uri, il figlio ucciso in un tank mentre combatteva in Libano: «La nostra famiglia - disse nel commovente ricordo del ragazzo -, questa guerra in cui sei rimasto ucciso, l’abbiamo già persa... Vorrei che potessimo essere più sensibili gli uni nei confronti degli altri. Che potessimo salvare noi stessi, ora, proprio all’ultimo momento, perché ci attendono tempi durissimi». «Dopo il lutto - dice ora lo scrittore -, io sono tornato subito a scrivere. Quel che è cambiato, è solo la consapevolezza di ciò che significa perdere un figlio. E la consapevolezza della realtà in cui viviamo».
Questa consapevolezza divide. E imbarazza. Perché viene da un uomo di sinistra che non ha mai esitato a condividere le fondamenta d’Israele. Qualche giorno fa, Grossman ha aderito al boicottaggio culturale degl’ intellettuali che si rifiutano di partecipare a dibattiti nelle colonie. «E allora - ha replicato un opinionista di destra -, non dovrebbe più vendere nei Territori palestinesi nemmeno i suoi libri. Perché non succede?».
Adesso, arriva il commento d’un falco delle colonie come Noam Arnon: «Grossman se ne vuole andare? S’accomodi. Capisco il ragionamento che lo porta a questa conclusione. Questi scrittori vivono dentro la Linea Verde e si sentono nel giusto. Dimenticano che la guerra dei Sei giorni non fu voluta da Israele, e che le colonie nacquero allora. Dimenticano che Israele si fonda su quelle cose in cui loro non si vogliono più riconoscere. È gente che si costruisce un’idea di mondo completamente scollata dalla realtà».
C’è chi capisce, però: «Per andarsene, David non deve aspettare che in questo Paese finisca la democrazia - dice Jonatan Gefen, scrittore e nipote del primo presidente israeliano Weizman -. Anch’io ho provato ad andarmene, più d’una volta. Ma non ci sono mai riuscito. Se un giorno si presentasse la possibilità, credo che Grossman non sarebbe l’unico a farlo».
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA ----Così fu identificato Eichmann. Il figlio aveva una fidanzata ebrea.25 luglio 2010, di Federico La Sala
 A BUENOS AIRES
A BUENOS AIRES Il figlio aveva una fidanzata ebrea
Il figlio aveva una fidanzata ebrea
 Così fu identificato Eichmann
Così fu identificato Eichmann Il criminale nazista fu impiccato in Israele nel 1962 *
Il criminale nazista fu impiccato in Israele nel 1962 *Adolf Eichmann venne scoperto in Argentina grazie al fatto che il figlio ventenne si era innamorato di una ragazza ebrea di 16 anni, residente come la famiglia del criminale nazista a Buenos Aires. Lo rivela un documentario che va in onda domenica sera sulla prima rete televisiva tedesca Ard, basato sulle ricerche della storica amburghese Bettina Stangneth. Nel 1956 il figlio di Eichmann, Klaus, si era innamorato di Silvia Hermann, il cui padre Lothar era riuscito a scampare all’Olocausto dopo essere stato internato per sei mesi nel campo di concentramento di Dachau. Nessuno dei due ragazzi conosceva la storia delle rispettive famiglie, così quando Silvia condusse Klaus a casa dei suoi genitori, Lothar Hermann chiese al figlio del criminale nazista che cosa avesse fatto il padre in Germania durante il nazismo. «È stato in guerra ed abbiamo fatto numerosi trasferimenti, abitando per un certo tempo perfino a Praga. Papà diceva che eravamo lì per diffondere nel mondo i valori tedeschi».
RICONOSCIMENTO E CATTURA - Dopo pranzo Hermann chiese alla figlia come si chiamasse il suo ragazzo, ma dopo aver appreso il nome di Eichmann era rimasto sconvolto. Poco fiducioso nelle autorità argentine, Lothar Hermann aveva scritto a Fritz Bauer, il procuratore generale tedesco che stava dando la caccia ai nazisti superstiti. «La informo che, secondo le mie informazioni, qui a Buenos Aires vive il criminale nazista Adolf Eichmann», aveva scritto il supersite della Shoah, il quale aveva pregato la figlia, che nel frattempo aveva lasciato Klaus Eichmann, a riallacciare i suoi rapporti con il figlio dello sterminatore di Auschwitz, in modo da verificarne con assoluta certezza l’identità. Da quel momento si era messa in moto la macchina che nel maggio 1960 avrebbe permesso al Mossad, il servizio segreto israeliano, di rapire Eichmann per condurlo in Israele, dove al termine di un lungo processo venne impiccato il 31 maggio 1962. Per timore di rappresaglie da parte dei nazisti superstiti, Lothar Hermann aveva fatto emigrare nel 1974 la figlia negli Stati Uniti, dove vive tuttora con un’altra identità. (Fonte Agi)
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- "Jonathan Sacks, grande rabbino di Londra, scriveva che, a memoria del passato, doveva ricordarsi delle atrocità commesse dai suoi nemici ma che, per costruire il futuro, il dialogo si imponeva come un imperativo morale" (Antoine Nouis)27 giugno 2010, di Federico La SalaCHE COSA SIGNIFICA DIALOGARE: Jonathan Sacks, grande rabbino di Londra, scriveva che, a memoria del passato, doveva ricordarsi delle atrocità commesse dai suoi nemici ma che, per costruire il futuro, il dialogo si imponeva come un imperativo morale: “Per l’amore dei miei figli e dei figli dei miei figli che non sono ancora nati, non potrei costruire il loro futuro sugli odi del passato, né insegnare loro che ameranno di più Dio amando meno le persone.”
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO ---- -“Gerusalemme, un laboratorio della biodiversità umana”. Un prete ortodosso, Jean-Yves Leloup, e un saggista palestinese, Elias Sanbar, sono gli autori di due dictionnaires amoureux. Uno su Gerusalemme, l’altro sulla Palestina. Hanno accettato di dialogare (di Josyane Savigneau - "Le Monde").3 luglio 2010, di Federico La Sala
 “Gerusalemme, un laboratorio della biodiversità umana”
“Gerusalemme, un laboratorio della biodiversità umana” colloquio di Jean-Yves Leloup e Elias Sanbar,
colloquio di Jean-Yves Leloup e Elias Sanbar, a cura di Josyane Savigneau
a cura di Josyane Savigneau in “Le Monde” del 3 luglio 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)
in “Le Monde” del 3 luglio 2010 (traduzione: www.finesettimana.org) Un prete ortodosso, Jean-Yves Leloup, e un saggista palestinese, Elias Sanbar, sono gli autori di
due dictionnaires amoureux. Uno su Gerusalemme, l’altro sulla Palestina. Hanno accettato di
dialogare.
Un prete ortodosso, Jean-Yves Leloup, e un saggista palestinese, Elias Sanbar, sono gli autori di
due dictionnaires amoureux. Uno su Gerusalemme, l’altro sulla Palestina. Hanno accettato di
dialogare.Jean-Yves Leloup, lei ha scritto un “Dictionnaire amoureux de Jérusalem” (Plon, p. 960, € 27) e lei, Elias Sanbar, un “Dictionnaire amoureux de la Palestine” (Plon, p. 496, € 24,50). Avrebbe accettato questo dialogo se l’autore del “Dictionnaire amoureux de Jérusalem” fosse stato un ebreo israeliano?
Sanbar: Se si trattasse di attaccamento personale, non di un qualsiasi diritto esclusivo sulla città basato sulla religione, sì, sinceramente.
Simbolicamente, l’editore ha pubblicato questi due libri contemporaneamente, ma uno è fatto da un palestinese, quindi dall’interno, l’altro da un cristiano francese.
Leloup: Un cristiano aperto ai palestinesi, agli ebrei e a tutte le tradizioni che sono vive a Gerusalemme.
Jean-Yves Leloup, che cosa pensa dell’affermazione di Elias Sanbar su Gerusalemme, una città che deve essere concepita in funzione della condivisione, “una capitale per due Stati”?
Leloup: È forse una cosa possibile, conoscendo l’attaccamento degli uni e degli altri a questa terra e a questa città, e la confusione che vi regna tra il politico e il religioso?
Sanbar: Io ci credo. Bisognerà arrivare a questo, perché non c’è altra soluzione. La grande difficoltà, ancor prima che inizino i negoziati, è la confusione permanente tra lo strato spirituale, simbolico della città, ciò che costituisce la sua universalità, e il problema della sovranità. Per il momento, i negoziati e i discorsi trattano la città come un luogo di disputa tra due sovranità divine: vale a dire, quale dio sarebbe più sovrano? E la cosa è tanto più complicata per il fatto che è lo stesso dio per i tre monoteismi! Bisogna riconoscere alla città la sua importanza spirituale e, su questo piano, essa appartiene all’umanità. Ma bisogna anche trattarla come una città, semplicemente, non diversa da altre città del paese, senza tuttavia rinnegare la sua dimensione di futura capitale della Palestina. Come avrete capito, parlo di Gerusalemme est. Solo a quel punto, si potrà negoziare.
Leloup: Ogni realtà è una realtà “costruita” o immaginaria. Particolarmente a Gerusalemme dove ciascuno investe talmente tanti sentimenti e così tante memorie sulle sue pietre... Come ritrovare la terra che vi è sotto?
Sanbar: I palestinesi hanno il vantaggio di non dover fare nulla per considerarla anche come una città reale. Noi ci stiamo. Sentiamo così tanti discorsi deliranti, sulla Terra santa, i Luoghi santi, ma per noi è anche la nostra terra, banalmente. Abbiamo pagato caro il prezzo di questi immaginari. L’imposizione dell’aspetto mitico sui luoghi è stata origine di morte e non di vita. Senza rinnegare la sua dimensione universale, se non ci si rende conto anche che questo paese esiste, non si troverà la soluzione.
Che cosa significa per voi due l’idea di “città santa”?
Leloup: La santità è l’alterità. Una città santa è il luogo di incontro delle alterità. Gerusalemme è una sorta di laboratorio della biodiversità umana. Non far entrare in relazione queste alterità rende la vita impossibile all’umanità.
Elias Sanbar, nel suo dizionario, alla voce “Fondamentalismo” lei scrive: “È una malattia che colpisce i tre monoteismi.”
Leloup: Lo penso anch’io, è una patologia che vuol ridurre l’altro a sé: fare di Gerusalemme una città ebraica, una città musulmana o una città cristiana. Gerusalemme all’origine è una sorgente in un deserto, un pozzo; bisogna avere cura del pozzo, non solo per sé, ma anche per i cammelli dell’altro.
Elias Sanbar, che cosa ha pensato della voce “Palestina” del “Dictionnaire amoureux de Jérusalem”?
Sanbar: È una breve voce storica. Io torno allo spazio reale e alla terra familiare, cosa complicata per i nativi di questa terra, perché alla loro familiarità dei luoghi viene sempre opposta l’immensità del sacro. Ma essa è anche terra familiare. L’identità della Palestina è spesso a torto analizzata col metro della vicinanza di comunità del vicino Libano. In Palestina, non si è nelle terre vicine. Ma in una realtà forgiata nella durata, che fa sì che le persone del luogo, pur appartenendo ciascuna ad una religione, si ritengono depositari, attraverso il luogo, di tutto ciò che vi è accaduto. Si parla molto di questa pluralità della Palestina, oggi minacciata, poiché sia il sionismo che il fondamentalismo musulmano cercano di darle un solo colore. Anche le crociate, un tempo, hanno cercato di darle un colore, allora esclusivamente cristiano. Nella seconda metà del XIX secolo, ci sono stati degli scontri “comunitari” sanguinosi nei paesi vicini, Libano e Siria, dovuti fondamentalmente all’arrivo della modernità industriale, che sconvolgeva le strutture tradizionali. In Siria, ad esempio, abbiamo assistito ad un’alleanza della comunità ebraica e di quella musulmana contro la comunità cristiana. In Libano, ci sono stati degli scontri tra drusi e maroniti. Da noi, questo non è avvenuto. Certi parlano di una sorta di “attitudine democratica” precoce nei palestinesi: è ridicolo. Semplicemente si tratta del sentimento dei palestinesi di essere i depositari di tutto ciò che era accaduto nella loro terra. È ciò che chiamerei la loro pluralità. Del resto oggi minacciata, e questo per la prima volta nella loro storia.
Jean-Yves Leloup, la sua voce “Terrorismo” è molto breve. Perché ha affrontato il tema? In un “Dictionnaire amoureux”, si è totalmente liberi di scegliere le voci.
Leloup: I terroristi si presentano purtroppo anche come innamorati della legge, della religione, della terra. Uccidono in nome del loro amore. Di quale amore parlano, di quale dio parlano? Per quanto mi riguarda, dico con Albert Camus: “Quale che sia la causa che si difende, essa resterà sempre disonorata dal cieco massacro della folla innocente.”
Jean-Yves Leloup, lei ha sviluppato molto le voci “Resistenti”, “Commando-suicidi”...
Sanbar: Ho affrontato non il terrorismo, ma il problema che mi sembra inglobare tutto ciò, nella voce “Vivere e morire”. Ciò che è molto preoccupante oggi, è che sia la morte e non la libertà a diventare la finalità della lotta. Capisco la metafora usata da Jean-Yves Leloup su terrorismo e amore. Ma essa non esprime la terribile realtà, quella realtà nuova che fa dire a dei giovani: “Io mi batto per morire.” Le generazioni precedenti hanno certo rischiato e spesso perso la vita, ma si battevano per vivere, la finalità della loro lotta era la libertà: vivere liberi, a rischio, e non con lo scopo, di morire per questo.
Il suo “Dictionnaire amoureux”, Elias Sanbar, è quello di un esiliato.
Sanbar: Sì, ma ho anche voluto presentare la Palestina reale. Noi siamo vivi e c’è un modo di ridere palestinese, di autoderisione, che si esprime bene nei nostri film e nella nostra letteratura. È una forma superiore di resistenza, perché esprime la fede nella vita che abita, malgrado tutto, questa terra semplice, schiacciata in un conflitto interminabile.
A Gerusalemme più che altrove, secondo lei, Jean-Yves Leloup, ci si può interrogare sull’idea di un’etica universale.
Leloup: Ritrovare la realtà di Gerusalemme significa ritrovare il senso dell’altro, del volto unico di ciascuno. Non è forse lì l’inizio dell’etica che può liberarti da ogni idolatria, cioè da ogni forma di appropriazione esclusiva?
Lei dice anche di essere partito dall’idea di un dizionario di una certa leggerezza amorosa e di essere sfociato ad una certa gravità.
Leloup: Non si può essere leggeri né con la Shoah, né con l’esilio dei palestinesi, né con l’emigrazione dei cristiani. Ma, malgrado tutto, tante volte distrutta e tante volte ricostruita, Gerusalemme testimonia una vita più forte della morte.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- LA FINANZA E IL VITELLO D’ORO. I leader politici europei si incontrano per salvare l’euro e l’Unione europea. Lo stesso dovrebbero fare i leader religiosi. È per questo che vengo a Roma (di Jonathan Sacks)9 dicembre 2011, di Federico La Sala
 Per riscoprire i valori religiosi alla base dell’economia di mercato
Per riscoprire i valori religiosi alla base dell’economia di mercato La finanza
e il vitello d’oro
La finanza
e il vitello d’oro di JONATHAN SACKS *
di JONATHAN SACKS *- Rabbino capo delle Congregazioni ebraiche unite del Commonwealth e membro della Camera dei Lord
 I leader politici europei si incontrano per salvare l’euro e l’Unione europea. Lo stesso dovrebbero fare i leader religiosi. È per questo che vengo a Roma: per discutere delle nostre preoccupazioni comuni durante l’udienza con il Papa e nel corso di colloqui presso l’Università Gregoriana.
I leader politici europei si incontrano per salvare l’euro e l’Unione europea. Lo stesso dovrebbero fare i leader religiosi. È per questo che vengo a Roma: per discutere delle nostre preoccupazioni comuni durante l’udienza con il Papa e nel corso di colloqui presso l’Università Gregoriana.
L’idea potrebbe apparire assurda. Cosa ha a che fare la religione con l’economia o la spiritualità con le istituzioni finanziarie? La risposta è che l’economia di mercato ha radici religiose. Essa è infatti emersa in un’Europa permeata di valori ebraico-cristiani.
Come ha evidenziato l’economista di Harvard, David Landes, fino al XV secolo, la Cina era molto progredita in una vasta gamma di tecnologie rispetto all’Occidente. Tuttavia, la Cina non ha creato un’economia di mercato, non ha visto la nascita della scienza moderna né la rivoluzione industriale. Come afferma Landes, essa non possedeva l’insieme di valori che l’ebraismo e il cristianesimo hanno dato all’Europa.
L’economia di mercato è profondamente coerente con i valori esposti nella Bibbia ebraica. La prosperità materiale è una benedizione divina. La povertà schiaccia lo spirito e il corpo, e alleviarla è un compito sacro. Il lavoro è una nobile vocazione. "Vivrai - recita il Salmo - del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene".
La competizione alimenta il fuoco dell’inventiva: "La rivalità fra gli scribi aumenta la sapienza". Dio ci invita - dicevano i rabbini - a essere suoi collaboratori nell’opera della creazione. I diritti di proprietà privata sono fondamentali per la libertà. Quando il ruolo di guida di Mosè viene messo in discussione, egli afferma: "Io non ho preso da costoro neppure un asino". Elia sfida re Acab per la confisca della vigna di Nabot. Oltre a ciò, afferma Landes, la Bibbia introduce il concetto del tempo lineare, rifiutando l’idea che il tempo sia un ciclo in cui, in definitiva, nulla cambia.
I primi strumenti finanziari del capitalismo moderno furono sviluppati nel XIV secolo dalle banche nelle città cristiane di Firenze, Pisa, Genova e Venezia. Max Weber ha tracciato i collegamenti fra l’etica protestante e lo spirito del capitalismo moderno. Michael Novak ha fatto la stessa cosa per il cattolicesimo. Gli ebrei, pur essendo solo lo 0,2 per cento della popolazione mondiale, sono stati insigniti di più del 30 per cento dei premi Nobel per l’economia. Quando ho chiesto all’economista dello sviluppo Jeffrey Sachs che cosa motivava il suo lavoro, ha risposto senza esitare, tikkun olam, l’imperativo ebraico di "risanare un mondo disgregato". La nascita dell’economia moderna è inseparabile dalle sue radici ebraico-cristiane.
Tuttavia, non si tratta di un equilibrio stabile. Il mercato mina i valori stessi che gli hanno dato origine. La cultura consumistica è profondamente antitetica alla dignità umana. Accende il desiderio, mina la felicità, indebolisce la capacità di rinviare la soddisfazione dei propri istinti e ci rende ciechi di fronte alla distinzione, di vitale importanza, fra il prezzo delle cose e il loro valore.
Gli strumenti finanziari al centro della crisi attuale, mutui subprime e cartolarizzazione del rischio, sono così complessi che i governi, le autorità normative e, a volte, persino i banchieri stessi non sono riusciti a comprenderli nella loro estrema vulnerabilità. Quanti hanno incoraggiato le persone ad accendere mutui che poi non sono in grado di pagare, si sono resi colpevoli di ciò che la Bibbia definisce mettere "inciampo davanti al cieco".
La creazione di un debito personale e collettivo in America e in Europa dovrebbe aver inviato segnali di allarme a chiunque abbia familiarità con le istituzioni bibliche degli anni sabbatici e giubilari, indetti proprio a causa del pericolo che le persone venissero intrappolate dal debito.
Questi sono sintomi di un fallimento più ampio: considerare il mercato come un mezzo e non come un fine. La Bibbia offre un’immagine vivida di cosa accade quando le persone smettono di vedere l’oro come mezzo di scambio e cominciano a considerarlo come oggetto di culto. Chiama questo il vitello d’oro. Il suo antidoto è il sabato: un giorno su sette in cui né lavorare né dare lavoro, né vendere né comprare. È un tempo dedicato a cose che hanno un valore, non un prezzo: famiglia, comunità e rendimento di grazie a Dio per ciò che abbiamo, invece di preoccuparci di quel che ci manca. Non è una coincidenza che in Gran Bretagna, la domenica e i mercati finanziari siano stati deregolati più o meno nello stesso momento.
Stabilizzare l’euro è una cosa, guarire la cultura che lo circonda è un’altra. Un mondo in cui i valori materiali sono tutto e i valori spirituali sono nulla, non genera né uno Stato stabile né una buona società. È giunto il momento di riscoprire l’etica ebraico-cristiana della dignità umana a immagine di Dio. L’umanità non è stata creata per servire i mercati. I mercati sono stati creati per servire l’umanità.
(©L’Osservatore Romano 9-10 dicembre 2011)
- Rabbino capo delle Congregazioni ebraiche unite del Commonwealth e membro della Camera dei Lord
-
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. FARE CHIAREZZA: RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. ----Smarrimento nei diritti umani (di Adam Haslett).21 giugno 2010, di Federico La Sala
Smarrimento nei diritti umani
di Adam Haslett (Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2010)
Non esistono diritti umani fondamentali. Esistono stati nazione che dichiarano di promuoverli, esiste una dichiarazione delle Nazioni Unite al riguardo, ed esistono organizzazioni non governative che ne sostengono l’adozione. Ma come ci ha mostrato la storia, nulla di tutto ciò previene assassini o torture qualora siano in ballo il successo militare, la sicurezza interna o la difesa nazionale.
I diritti, si dice, valgono solo nella misura in cui si ha la capacità di farli rispettare. E in ogni parte del mondo praticamente tutte le vittime di quelle che chiamiamo violazioni dei diritti umani sono prive di tale capacità. A questo scopo esistono, naturalmente, la Convenzione di Ginevra e, dal 2002, la Corte Penale Internazionale dell’Aja. Ma la prima ha giurisdizione solamente sui conflitti armati e la seconda può perseguire solo i crimini avvenuti negli stati membri o i casi che le vengono sottoposti dalle Nazioni Unite. I paesi su cui ha giurisdizione la Corte Penale Internazionale rappresentano una minoranza della popolazione mondiale.
Fra i paesi non firmatari: Stati Uniti, Iran, Sudan, Israele, Russia e India. La corte non ha accesso alle prigioni cinesi o ai centri di detenzione segreti della Cia. Ha aperto un’inchiesta sui leader miliziani della Repubblica Democratica del Congo, ma nessuna burocrazia europea o istituzione internazionale ha saputo fermare la marea di sangue civile che scorre nel paese.
D’altra parte, com’è spesso il caso nel diritto internazionale, i diritti umani sono per lo più materia di esortazione. Gli stati e gli altri soggetti politici vengono esortati dalle istituzioni internazionali e dalle Ong come Amnesty International a rispettarli, ma c’è poco da fare se questi non intendono farlo. È come se la polizia di New York spendesse tempo ed energie a incoraggiare i criminali a non commettere omicidi ma non fosse autorizzata ad arrestarli all’atto pratico. Un tale limite ci costringerebbe a dire che non esiste un diritto a non essere vittime di omicidio, ma solo un atteggiamento generale di deterrenza nei confronti di tale pratica. Questa è oggi la situazione dei diritti umani. Sono ideali che nel concreto non vengono fatti rispettare.
Da dove originino questi ideali è questione dibattuta. Molti indicano Kant, che delineò un fondamento filosofico dell’eguaglianza umana universale basata sulla capacità razionale. Altri alla dichiarazione dei diritti universali dell’uomo a opera della Rivoluzione francese. Ma siccome il concetto di universale del diciottesimo secolo era applicato di solito ai soli cittadini maschi, potremmo dire che l’idea moderna di questi diritti ha il suo vero inizio con la Convenzione di Ginevra e la reazione all’Olocausto.
In un libro di prossima uscita, lo storico Samuel Moyn lascia intendere che anche così si retrodata un fenomeno successivo, e che l’idea che abbiamo oggi dei diritti umani fondamentali e inalienabili comincia in realtà con l’impulso anti-statalista e liberazionista emerso in Occidente fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta.
Quel che è chiaro è che la nostra idea contemporanea di universalità in materia di diritti umani si è espansa a comprendere tutte le razze e le etnie ed entrambi i generi. La categoria di quanti riteniamo meritevoli di protezione coincide con l’intera specie. Non escludiamo le persone affette da handicap mentali per il loro difetto di capacità razionale o i rifugiati perché non hanno cittadinanza. Il requisito è diventato di natura essenzialmente biologica.
Se l’universo di quanti sono compresi sotto l’insegna dei diritti umani si è espanso, altrettanto ha fatto la sostanza degli stessi diritti. La Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani annuncia tutte le libertà dalla violenza di stato e dalla detenzione e punizione arbitraria che in genere associamo al peggiore comportamento dei regimi oppressivi. Ma annuncia altresì il «diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite» (Articolo 24) e il «diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere famiglia» (Articolo 25). Quale paese può affermare in tutta onestà di rispettare questi standard per tutti i suoi cittadini?
Ad accompagnare quest’espansione nella portata e nella sostanza dei diritti si è registrato un terzo fattore in aumento: la capacità di documentare in tutto o in parte le violazioni dei diritti al di fuori dei canali ufficiali, grazie alla diffusione di telecamere digitali e internet. Non passa giorno senza che da qualche parte del mondo non giunga testimonianza di pulizie etniche, stupri e assassinii politici o detenzioni illegali (l’assenza di uno standard adeguato di vita, naturalmente, non fa notizia). Interi regimi si reggono su simili pratiche. E queste non sono che le pratiche più abominevoli fra indite altre.
Se allora prendiamo seriamente la concezione dei diritti umani che abbiamo oggi, e prestiamo attenzione al telegiornale, la sola conclusione razionale che possiamo trarre è che l’esistenza della vasta maggioranza delle persone sul pianeta costituisce una catastrofe senza fine.
L’ampiezza di tale conclusione porta a un’interessante omologia. Se dovessimo sostituire le parole "violazione dei diritti umani" con il termine "peccato", e dovessimo immaginare per un attimo la Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani come una versione odierna dei Dieci Comandamenti, riusciremmo subito a vedere come la struttura retorica e l’asserzione ontologica che stanno dietro alla nostra idea moderna di diritti umani siano di tipo religioso, e più specificamente cristiano. In questo nostro mondo caduto, regna il disastro morale. È una condizione generalizzata.
Le vie dell’uomo sono perverse. I deboli e i poveri sono afflitti dai ricchi e dai potenti. Contro questa situazione impossibile si pone un gruppetto di persone determinate e altruiste che usano un linguaggio evangelico contro gli empi re e despoti che cercano di svergognare. Ogni detenuto impiccato o donna violentata è martire della causa. Nella nostra cosmologia del castigo, ovviamente, la redenzione è sempre su questa terra: una cessazione delle sofferenze secolari piuttosto che un posto a sedere vicino al Signore.
In un certo senso, non deve sorprendere. L’originaria elaborazione kantiana dell’uguaglianza umana universale emerse dal Pietismo protestante. E le organizzazioni religiose occidentali rimangono fra i gruppi più attivi e costanti nell’appello al rispetto dei diritti umani universali. Non equivale a una critica, per lo meno a mio modo di vedere, far notare le premesse religiose di ciò che la comunità internazionale tratta come una missione laica. Ma riconoscere l’omologia fra retorica dei diritti umani e teologia cristiana potrebbe almeno aiutarci a comprendere e mantenere meglio il nostro orientamento a riguardo.
Perché? Perché se non si può dire che i diritti umani fondamentali esistono materialmente in un mondo in cui non li si fa rispettare, allora per continuare a credere in questi diritti ci serve qualcosa di più che la legge e le esortazioni. Ci serve qualcosa di più vicino alla fede.
(Traduzione di Francesco Pacifico)
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- Sulla critica della ragione ateistica (Massimo Cacciari - postfazione a "Il problema dell’ateismo" di A. Del Noce).19 giugno 2010, di Federico La Sala
L’Occidente non è soltanto ateismo e razionalismo
Nel centenario della nascita torna in libreria per Il Mulino un volume del filosofo Augusto Del Noce. Con una postfazione di Cacciari che anticipiamo.
di Massimo Cacciari (Corriere della SerA, 18 giugno 2010)
La novità e l’importanza de Il problema dell’ateismo consistono nell’aver posto al centro della storia della filosofia moderno-contemporanea la posizione (che si fa opzione o postulato) ateistica; questa non è più considerata come il «punto di vista» di questo o quel pensatore, ma come il destino stesso del razionalismo e dell’idealismo europei. Poiché la filosofia è il farsi cosciente del significato di un’epoca, tale suo esito rappresenta perciò la «realtà invadente», «senza precedenti storici» (p. 335) del fenomeno dell’ateismo nel Moderno in tutti i suoi aspetti. La stretta connessione nel libro tra dimensione teoretica e meta-politica, elemento essenziale dell’intera ricerca di Del Noce, si arricchisce qui dell’apporto decisivo della prospettiva propriamente teologica.
Se la filosofia moderna è «segnata» fin dalle sue origini dall’esito ateistico, è evidente come la sua storia debba essere tracciata in connessione stretta con la teologia (p. 75), a differenza di ciò che avviene in quelle «storie» che si muovono dal tacito, e inindagato, presupposto del «progresso» atheos del pensiero occidentale. L’ateismo non potrebbe definirsi, infatti, se non in opposizione a elementi essenziali della tradizione teologica. Per Del Noce ciò non comporta affatto una semplice «sistemazione» storiografica, per quanto originale e «spaesante», il problema dell’ateismo rimane per lui fondamentalmente irrisolto, e cioè permane come aporia immanente allo sviluppo del razionalismo e idealismo moderni fino a quei suoi esiti contemporanei (tra Nietzsche e Heidegger), che potrebbero anche apparire nel più radicale contrasto con le sue premesse.
Un assunto di così straordinario impegno può essere svolto soltanto attraverso una pluralità di approcci, teoretici, teologici, storico-politici, «sincronicamente» e insieme una, direi, vichiana sensibilità per la storia del pensiero, dove la considerazione puntuale dei suoi diversi momenti, nel loro intreccio, sia sempre riportata al comune «destino» di cui appaiono necessaria manifestazione.
Da questo punto di vista, la prima domanda riguarda la differenza essenziale tra l’ateismo moderno e quello antico, ovvero in che termini l’ateismo nella cristianità rappresenti una autentica novitas rispetto alle sue testimonianze grecoromane; su tale base, occorrerà procedere nel distinguere i diversi momenti della storia dell’opzione ateistica, in rapporto alle diverse forme che assumono razionalismo e idealismo moderni, fino al loro apparente dissolversi; infine, si dovranno analizzare proprio tali esiti, esplicitamente ateistici, per coglierne non solo le stridenti differenze, ma come, dal loro stesso interno, riemerga o ri-corra proprio quel problema di Dio, che l’ateismo assoluto o compiuto aveva dichiarato risolto. È a questo punto che si farà maggiormente valere la posizione filosofica e teologica dello stesso Del Noce, e che si renderanno manifesti i presupposti e le ragioni della sua «lotta» al dilagante affermarsi del postulato ateistico (...).
Ma che cosa intendiamo con il termine ateismo? Ne è possibile una definizione in generale, che ne abbracci le diverse epoche? L’ateo è colui che nega l’esistenza di Dio? Ma quale Dio? O ateo è invece chi sostiene che non-è Dio tutto ciò di cui è dimostrabile l’esistenza? In quest’ultimo caso, la posizione atea si avvicinerebbe «pericolosamente» proprio ad un misticismo di impronta neoplatonica.
Forse è possibile, in primissima istanza, e sulla scorta delle indicazioni dello stesso Del Noce, definire ateistica la negazione della possibilità stessa del soprannaturale (p. 356), l’affermazione (che Del Noce ritiene «senza prove») che ogni idea di «trascendenza» determina un’insanabile lacerazione nell’unità dell’Io. Un simile «postulato» sembra precedere e fondare l’ateismo in quanto «certezza» che al termine «Dio» nulla corrisponda di determinato o determinabile. Questa «certezza» si fa strada nella storia della filosofia e nella cultura, nel significato antropologico del termine, europee insieme con la «evidenza» del successo straordinario della comprensione razionale-scientifica della natura.
Da un iniziale agnosticismo è necessario, per Del Noce, che si giunga per questa via ad un ateismo assoluto, e che questo dia vita ad una prassi, ad un agire politico, che si configura per lui come un autentico «stato di guerra» contro Dio.
Ma i passaggi attraverso i quali questo «destino» si dispiega sono essenziali per comprenderne l’intero impianto, poiché essi non segnano momenti che progressivamente si oltrepassano, bensì invece, piuttosto, fattori interni dell’idea stessa di ateismo.
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- Superman? Un eroe figlio di Israele. Il lato inquietante di una storia (di Elena Loewenthal).18 giugno 2010, di Federico La Sala
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- E I COSTITUZIONALISTI ITALIANI (E NON SOLO) PRESI NELLA TRAPPOLA BIPOLARE. Materiali18 giugno 2010, di Federico La Sala
-
> ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN. ---- IL SERVITORE DELLO STATO!!! (di Francesco Merlo - La menzogna di Stato).18 giugno 2010, di Federico La Sala
La menzogna di Stato
di Francesco Merlo (la Repubblica, 18.06.2010)
Gianni De Gennaro non è un uomo qualunque, è da moltissimi anni un pezzo importante dello Stato italiano, ha alle spalle una carriera di poliziotto modello. Ma proprio per questo la sentenza che lo condanna non dovrebbe spingere nessuno a recitare le solite tragicommedie del garantismo e del giustizialismo alle quali purtroppo stiamo invece assistendo.
Un servitore dello Stato, un ex capo della Polizia oggi Signore dei servizi segreti, non può apparire come un manipolatore di testimoni, non può permettersi una condanna anche se non definitiva, non può consentire che la gente pensi a lui come a un bugiardo. Ha ovviamente diritto alla presunzione di innocenza ma ha il dovere di liberare lo Stato dalla fosca ombra che lo sovrasta. Non sappiamo cosa De Gennaro deciderà, ma abbiamo fiducia nella sua coscienza, nel suo spirito di servizio, nel suo alto senso dello Stato che, mai come oggi, coincide con la sua dignità di insospettabile.
E però, più inquietante della sentenza c’è la solidarietà meccanica, ideologica, quasi fosse "di partito", del ministro dell’Interno Maroni e del ministro della Giustizia Alfano. Le loro dichiarazioni a caldo, istintive e assolutorie finiscono con l’apparire come una prova involontaria della giustezza della sentenza: come si può essere solidali con un condannato di questa portata? Che fine ha fatto quell’idea rigorosa di Stato che un tempo dai suoi servitori esigeva zelo, dedizione, efficienza e pulizia assoluta? Neppure De Gennaro è, secondo noi, solidale con se stesso come Maroni e Alfano lo sono con lui. E se fosse stato direttore del Tg1 o del Tg5 di sicuro De Gennaro avrebbe evidenziato nei titoli la notizia che invece Minzolini e Mimun hanno nascosto. Come si fa a non capire che delegittimare o malcelare una sentenza così rilevante finisce con il rafforzarla, con il fornire ulteriori argomenti alla colpevolezza?
Insomma, più grave della sentenza c’è la complicità politica con il reo, l’idea che la politica possa annullare le ragioni della giustizia. Di sicuro non è bello lo scontato crucifige ideologico dei soliti nemici di De Gennaro e della polizia, ma si tratta in fondo di pezzi di un’opposizione d’antan e tribunizia di pochissimo peso istituzionale. Ben più indecente è l’amicizia ammiccante di Maroni e di Alfano. E in tv ci ha colpito il silenzio del procuratore antimafia Piero Grasso che, seduto per caso tra Alfano e Maroni che difendevano il condannato, esibiva una impassibilità che somigliava - ci è parso - allo sconcerto trattenuto, allo scandalo dissimulato. Cosa avrebbe detto Piero Grasso se fosse stato lui il condannato, magari pure ingiustamente? Come reagisce un Servitore della Cosa Pubblica se il suo operato vulnera l’istituzione che rappresenta? Difende se stesso anche a costo di offendere lo Stato? Tratta se stesso come un uomo qualunque quando invece è un pezzo di Stato?
Ma voglio essere ancora più chiaro. A noi piacciono i capi che coprono i loro uomini, capiamo le ragioni psicologiche e anche professionali, specie di un poliziotto che ha vissuto i giorni pesanti di Genova, dove però le violenze cieche, di strada, sono purtroppo risultate alla fine meno cruente delle violenze di Stato, quelle costruite a freddo contro degli inermi. De Gennaro insomma lo capiamo senza giustificarlo. Ha le attenuanti del capo che si compromette in favore dei suoi. C’è una nobiltà nella ignobiltà che ha commesso.
Ma la solidarietà dei ministri degli Interni e della Giustizia sconfessa l’operato dei giudici in maniera sconsiderata, solo perché De Gennaro è uno dei loro, uno come loro. Il messaggio che arriva agli italiani è che la corporazione, la cricca, la casta e l’amicizia rendono innocente anche un reo condannato. L’impunità è la peggiore delle sporcizie di Stato.
-