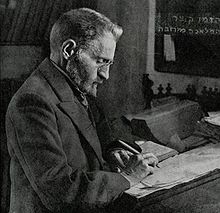
ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA - di Massimo Leone.
giovedì 29 giugno 2006. Alla lingua ebraica
Alla lingua ebraica
 Memoria di Eliezer Ben-Yehuda
Memoria di Eliezer Ben-Yehuda
 di Massimo Leone*
di Massimo Leone*
La mia ombra si proietta nel cerchio chiaro di una lampada, mentre siedo, la nuca irrigidita, ad una delle scrivanie di questa biblioteca. Sono qui dentro da undici ore, chino sul mio lavoro. La vista mi si annebbia e gli occhi sono ormai due piccoli bracieri, la schiena mi si incurva e gambe e braccia ormai mi dolgono. Respiro affannosamente, qualche piccola macchia rossa si nasconde minacciosa nel mio fazzoletto. Ho sessantun anni, ma mi sento molto più giovane e molto più vecchio. Giovane è la mia impresa, vecchio l’involucro del mio corpo. Tossisco una, due volte, una fitta lancinante mi scuote il petto. Ma non posso fermarmi. Colui il cui nome sia benedetto per quanti granelli di sabbia ha il deserto dei deserti plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma poi l’uomo dimenticò questi nomi. Tanto tempo è passato, e tanto dolore. E per questo io adesso sono qui, con il mio piccolo, insignificante dolore. Cerco di ricordare. Di ricordare tutti questi nomi.
Accanto a me un giovane americano legge una traduzione inglese dei Mystères de Paris. Mi chiedo se questa lettura avrà su di lui la stessa influenza che ebbe su di me, tanti anni fa. Probabilmente no, il ragazzo sbadiglia. Invece mi torna in mente [come un lampo che squarcia la notte] la sorpresa dei miei genitori, quando un amico di mio padre ci portò una copia in Ebraico di quel romanzo. Chissà quanto tempo Kalman Schulman aveva dedicato a questa versione. Chissà come la rifarebbe adesso, se potesse consultare il mio dizionario. All’epoca, nella piccola Luzhky, il villaggio dove passai i primi anni della mia vita, quando il gelido freddo invernale si impossessava della Lituania, non vi erano scrittori che fossero più in auge: Kalman Schulman, il grande traduttore, ma ancor di più Abraham Mapu, il bardo ebreo dell’Amore di Sion. Quanti avranno deciso di partire leggendo questo romanzo, uno dei primi in lingua ebraica! Me lo chiedo spesso.
Curioso, poi, che Sue, lo stesso autore che gli aveva ispirato questo inno alla terra promessa, scrivesse qualche anno dopo l’Ebreo errante. Le parole "errante" ed "errore" hanno la stessa radice etimologica, un lessicografo lo sa bene. Ciò vuol dire che chi ha commesso un errore è destinato a smarrire la propria strada, oppure invece che lo stesso essere errabondi, senza una terra propria, è il segno di una storia sbagliata? Sono stati forse i Cristiani ad inventare questa storia, secondo cui l’ebreo che errò insultando Cristo crocefisso fu costretto ad errare in eterno, senza meta? Ma io credo il contrario. Credo che sia la storia ad aver sbagliato, a renderci errabondi per tanti secoli. Questa è la nostra croce, come direbbero i gentili. Ecco perché Mapu sognava una Sion che accogliesse tutti gli ebrei, anche se allora i nostri sogni erano maldestri come la nostra lingua.
Quando mio padre era ancora un bambino un gruppo sparuto di coraggiosi cercava di ridare linfa vitale alla lingua ebraica, scomparsa come lingua d’uso quotidiano in seguito ad una diaspora millenaria. Tuttavia, se non era difficile scrivere un romanzo biblico in Ebraico biblico, parlare della vita di tutti i giorni con questo lessico di 8000 parole non era impresa semplice. Ancora sorrido quando penso che l’Ebraico biblico ha solo tre colori, il bianco, il nero e il rosso, e che in tutti gli esperimenti di romanzo dell’epoca le leggiadre fanciulle erano destinate ad avere la pelle bianca come la neve, le guance rosse ed i capelli nero pece. Senza contare che le circonlocuzioni adottate per sfuggire all’esiguità del lessico rischiavano sempre di oltrepassare la linea sottile fra il ridicolo e il blasfemo. Nel ginnasio russo che decisi di frequentare dopo aver abbandonato la yeshiva, la scuola talmudica, un amico ebreo raccoglieva in un quadernetto tutte le espressioni curiose che si coniavano all’epoca. Dal Salmo 113, 5-6 l’espressione "Lui che siede nelle altitudini e si abbassa per guardare" fu presa a prestito per indicare "ciò che è troppo basso perché vi si possa sedere", vale a dire una balaustra. Anche i giochi di parole non erano infrequenti; "choli ra’", "brutta malattia", parve parola adatta per denominare il colera. Senza poi nemmeno menzionare la pesantezza di certe frasi: "ho dato il mio orologio a un orologiaio" diventava "ho dato il mio indicatore di ore a un riparatore di indicatori di ore".
Nel 1877, lo stesso anno in cui terminai il mio ginnasio, la Russia dichiarò guerra contro l’Impero Ottomano al fine di supportare i Bulgari nelle lotte per la loro indipendenza. I Greci ce l’avevano fatta nel 1829 (e ancora circolava per l’Europa il fantasma irrequieto di Byron, accorso in difesa dell’Ellade e poi morto di malaria); intorno alla metà del secolo gli Italiani avevano sognato e ritrovato una patria. Così, pensai che anche gli Ebrei dovevano ritrovare una patria, ma non immaginai soltanto un pezzo di terra in cui vivere insieme.
Sognai - ed è questo il sogno che ancora mi spezza la schiena - che tutti gli Ebrei potessero un giorno abitare la stessa lingua. Lasciai dunque la Russia nel 1878, deciso a recarmi in Palestina. Prima, tuttavia, volevo studiare medicina a Parigi, per poter essere d’aiuto agli altri Ebrei. In Francia trovai insieme la gioia ed il dolore. Non ricordo più dove conobbi il primo colpo di tosse, come non so quando e dove sopraggiungerà l’ultimo. Tuttavia, mi piace pensare che io abbia scoperto la prima macchia di sangue in quello stesso caffè dove incontrai anche la gioia.
Non potrò mai dimenticare il colore verde brillante delle sedie, il fruscio dei paltò lungo i tavoli, una tenue campanella che indicava nervosamente l’aprirsi ed il chiudersi della porta, il viavai dei camerieri. Era una giornata fredda e solare, una di quelle in cui i pensieri si affinano ed acquistano insieme vigore e leggerezza. Fu lì, seduto in quel caffè lungo il boulevard Montmartre, che ebbi una conversazione interamente in lingua ebraica con Getzel Zelikovitz e Mordecai Adelman. Di certo non si trattò di una lunga chiacchierata: pochi erano i nostri vocaboli e la nostra lingua era ancora legata. Ma fu in quella occasione che capii, per la prima volta, che l’Ebraico poteva tornare a vivere. E fu allora che presi una decisione irrevocabile, che vaste conseguenze avrebbe avuto sulla mia vita. Qualunque cosa accadesse, per quante difficoltà si presentassero, non avrei mai parlato altra lingua che l’Ebraico (con gli altri Ebrei, naturalmente, ma non c’è bisogno di specificarlo...).
Così, quando nel 1881 arrivai a Jaffa, parlai in Ebraico con un cambiavalute, poi con il proprietario di un albergo, quindi con un carrettiere. Tuttavia, ben presto mi accorsi di quanto impoverita e frusta fosse divenuta questa lingua. Ebrei di diversa provenienza lo parlavano nelle strade e nelle piazze, è vero, ma quanto stentatamente, e ognuno con una diversa pronuncia, che spesso rendeva le parole degli uni incomprensibili agli orecchi degli altri. Ad ogni piccola difficoltà l’Ebraico veniva mescolato con altre lingue, e poi soprattutto non varcava le porte delle case. Quasi ogni ebreo, nel chiuso delle mura domestiche, parlava una lingua diversa dall’Ebraico.
Questo deprimente scenario mi fece compiere uno dei passi più dolorosi della mia vita. Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, va’ nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e si mise in viaggio verso il luogo che gli era stato indicato. Il mio coltello mai si è levato contro mio figlio, ma quando egli nacque, nel 1882, in un certo senso lo votai a un sacrificio in nome dell’Altissimo: feci promettere a Deborah, mia moglie, che l’avremmo allevato come il primo bambino di lingua interamente ebraica della storia moderna. Non una singola parola di un’altra lingua sarebbe stata proferita in sua presenza, né da noi, né dai nostri amici e conoscenti. La lingua del popolo ebraico sarebbe cresciuta assieme a mio figlio, ma alto era il prezzo da pagare per questa impresa. Il mio cuore di vecchio si stringe ancora quando penso agli eccessi di quell’epoca. A quattro anni, mio figlio era ancora incapace di parlare. Lo mandavo a letto quando ospiti non ebrei venivano nella mia casa, ed arrivai persino ad impedirgli di ascoltare il nitrito dei cavalli, o il raglio degli asini. Solo il suono dell’Ebraico doveva passare dalle sue orecchie. Poi un giorno, tornando a casa, scoprii Deborah che gli cantava una ninna-nanna in russo, dondolandolo fra le braccia. Andai su tutte le furie e cominciai a gridare. Fu allora che avvenne un piccolo miracolo. L’angelo mi chiamò dal cielo e mi disse: "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male!" Quindi, come Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio, io sentii, e ancora risuona nella mia memoria, la prima parola in Ebraico pronunciata da mio figlio.
Egli aveva bisogno ogni giorno di nuove parole, così come gli Ebrei di Palestina. Ma è difficile trovare nella Bibbia parole come "bambola", "gelato", "budino", "omelette", "fazzoletto", "asciugamano", "bicicletta", e molti altri ancora. Capii dunque che se volevo far rinascere l’Ebraico come lingua moderna non potevo limitare la mia ricerca lessicologica alla Bibbia, ma dovevo estenderla ad altre fonti, di altri periodi. E poi dovevo coniare parole nuove sulla base di quelle vecchie, continuare modestamente il lavoro di Adamo.
All’inizio la mia passione linguistica fu oggetto più di scherno che di ammirazione, poi pian piano cominciò a suscitare entusiasmo. Nel 1889 fondai l’associazione Safa Berura, un "comitato di letteratura" incaricato di estrapolare i vocaboli ebraici dai testi in cui si trovavano relegati, per poi pubblicarli. Con la supervisione di grammatici e scrittori, il comitato poteva anche proporre dei neologismi. Fra il 1880 e il 1900, associazioni di questo genere sorsero un po’ dappertutto in Europa, ma fu solo a partire dal 1904 che la mia testardaggine iniziò a dare i suoi frutti. Da quando ero giunto a Gerusalemme mantenevo me stesso e la mia famiglia lavorando come giornalista. Nel 1884 avevo fondato un nuovo giornale, HaTzevi, dapprima un settimanale, poi un quotidiano. Scrivevo tutti i miei articoli ricorrendo all’"Ebraico totale", basato su fonti ebraiche di tutti i tempi, ma inventai anche moltissime parole nuove, più di 230, se ricordo bene.
Lentamente, poi, e proprio grazie al mio giornale, questi neologismi entrarono a far parte dell’Ebraico quotidiano: diedi un nome al ristorante, al giornale, alla bicicletta, all’orologio, all’arte, alla bambola, alla rosa, al colore grigio e all’ombrello, al fazzoletto, all’ufficio, al marciapiede. Ma poi, con la guerra del 1914, dovetti dare un nome anche ai soldati, al fronte, alla bomba, alla pistola. Paradossalmente, scelsi di imprigionare il mio corpo per sempre dietro una di queste scrivanie nel 1894, quando le autorità turche mi obbligarono a trascorrere in prigione un breve periodo. Mio suocero aveva pubblicato un articolo in HaTzevi, e una delle sue frasi, "Ne’esof chayil venelekh kadima", "riuniamo le nostre forze e andiamo avanti", fu interpretata come "riuniamo un esercito per conquistare l’Oriente". Questo episodio fece scattare in me il desiderio di compilare un dizionario che raccogliesse tutte le parole dell’Ebraico e le associasse ad un significato preciso. La prigione mi diede tempo a sufficienza per dare avvio a questa impresa, che in seguito ho proseguito a Londra, Oxford, Cambridge, Parigi, Berlino, San Pietroburgo, Parma, Livorno e nel Vaticano, dovunque si nascondano testi in Ebraico. Dopo quindici anni di ricerche, la maggior parte dei quali passati a lavorare fino a diciotto ore al giorno, il primo volume del Thesaurus della lingua ebraica antica e moderna ha visto la luce 11 anni fa, nel 1910. Altri volumi sono stati completati negli anni successivi, e ora la mia mano stanca continua a riempire schede su schede di minute parole, sotto il cerchio di questa lampada. Lavoro al settimo volume del mio agognato dizionario, memoria delle parole di Adamo. Tra le tante parole del passato, ve ne sarà anche qualcuna interamente mia, figlia della mia propria lingua come il primo bambino di lingua ebraica è stato figlio dei miei lombi. Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?
*
 www.golemindispensabile.it,
www.golemindispensabile.it,
 n° 11 - novembre 2003
n° 11 - novembre 2003
- Ben-Yehuda Dictionary: "The Ben-Yehuda Dictionary is a historical Hebrew dictionary. The first volume was published in 1908 by Eliezer Ben-Yehuda, while the last was published long after his death, in 1958 by his wife and his son. An important feature of the dictionary was its inclusion of various new words invented by Ben-Yehuda to describe modern objects which did not yet have words for them.[...]".
Scheda:
LA LINGUA
È assai strano il destino della lingua ebraica: dopo la Diaspora, gli Ebrei sparsi per il mondo avevano cominciato a utilizzare le parlate locali, servendosi dell’ebraico biblico unicamente come lingua del culto o come lingua letteraria. La lingua cominciò a risorgere con il movimento sionista. Il principale fautore della rinascita fu Eliezer ben Yehuda (1858-1922), il quale, trasferitosi dalla Lituania in Palestina, introdusse l’ebraico nella sua casa, rendendo quotidiano l’uso della lingua tradizionale. Imitato da una cerchia di amici e conoscenti, diede così origine alla prima famiglia di lingua ebraica, lasciando in eredità alla sua gente il Dizionario di ebraico antico e moderno, tuttora testo fondamentale della letteratura neoebraica.
Dopo la fondazione dello stato d’Israele, comunità ebraiche giunsero da tutto il mondo al loro paese tradizionale e si sentì il bisogno di ritrovare anche l’antica lingua tradizionale. Così venne naturale seguire l’esempio di Eliezer ben Yehuda e riutilizzare nell’uso comune la lingua e la scrittura ebraica. Caso praticamente unico nella storia delle lingue, l’ebraico tornò ad essere lingua viva e vegeta, ed attualmente è lingua ufficiale dello stato d’israele. Qui, l’Accademia per la Lingua Ebraica presiede alle modifiche cui inevitabilmente la lingua, adattata alle esigenze della civiltà moderna, è sottoposta.
Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo, Edizioni Medusa, Milano 2010, p. 265:
 "Theodor Herzel (...) la sua visione non fu abbastanza visionaria: la vecchia lingua che egli considerava morta è rinata" (p. 276, con nota)
"Theodor Herzel (...) la sua visione non fu abbastanza visionaria: la vecchia lingua che egli considerava morta è rinata" (p. 276, con nota)
 Nota: "Nello Stato ebraico, Zionist Organization, London 1936, Herzel scrive: "Non possiamo, dopo tutto, conversare tra noi in ebraico. Quanti di noi conoscono abbastanza l’ebraico da chiedere un biglietto del treno in quella lingua? Non si può fare" (p. 134)
Nota: "Nello Stato ebraico, Zionist Organization, London 1936, Herzel scrive: "Non possiamo, dopo tutto, conversare tra noi in ebraico. Quanti di noi conoscono abbastanza l’ebraico da chiedere un biglietto del treno in quella lingua? Non si può fare" (p. 134)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una indicazione (1930) di Freud
EMIL FACKENHEIM, TIQQUN.RIPARARE IL MONDO
fls
Forum
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. --- PALESTINA, ISRAELE, LA LINGUA EBRAICA: SULLA "TERRA PROMESSA" ALL’INTERA UMANITA’ ("EARTHRISE").6 settembre 2024, di Federico La Sala
TEATRO (STORIA) METATEATRO (METASTORIA), E FILOLOGIA ("LOGOS"):
SULLA "TERRA PROMESSA" ALL’INTERA UMANITA’ ("EARTHRISE").
- ALCUNI APPUNTI a margine della domanda di Paul Adrian Fried, "How is Hamlet received or avoided in Israel?" - September 05, 2024.
RICORDANDO una riflessione del filosofo Emil L. #Fackenheim sul fatto che la "visione" di Theodor Herzel "non fu abbastanza visionaria: la vecchia lingua che egli considerava morta è rinata" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo", Edizioni Medusa, Milano 2010), ed è rinata grazie al lavoro di Eliezer Ben-Yehuda, FORSE, è bene ricordare anche cosa proprio Ben Yeheuda, il "padre" dell’ebraico moderno) scriveva in una sua "Memoria": “[...] Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” (cfr. Massimo Leone, "Alla lingua ebraica. Memoria di Eliezer Ben-Yehuda", 2003).
Plaudendo ("cum grano salis") alla "analogia" storica tra Israele e Palestina con la situazione hamletica dello "stato di Danimarca" e lo "stato di Norvegia", dopo la morte del "Re Amleto", proposta da Paul Adrian Fried, c’è da chiedersi, in riferimento al "presente storico" dell’attuale rapporto tra la "terra" di Israele e la "terra" della Palestina: ma "Hamlet", la "figura" di "Amleto", capace di ricordare la promessa fatta da suo padre "("Ricordati di me!"), riflettere sul da farsi, di mantenere la parola data, e di decidersi a fermare il "gioco", dov’è?!
METASTORICA-MENTE, IERI COME OGGI, IL PROBLEMA E’ UNA #QUESTION LOCALE E GLOBALE DI LUNGA DURATA, TEOLOGICO-POLITICA E ANTROPOLOGICA: UNO=ONU. Bisogna uscire dal "letargo" (#DanteAlighieri) e, hamleticamente, rompere l’ipnosi "millenaria" indotta dalla musica del Re-Pifferaio e restituire alla "parola" il suo legame il "Logos", con la "lingua", la "terra" #comune.
ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA) E "DIVINA COMMEDIA". DA NON DIMENTICARE, a mio parere, che il nodo da sciogliere proposto da Shakespeare, alla intera cultura teologico-politica dell’Europa dell’epoca (egemonizzata dalla tradizione cattolico-spagnola) è legato al doppio filo del problema del "corpo mistico" del Re (#androcentrismo) e della struttura della "Sacra Famiglia": ad Amleto ("Cristo") il "presepe" messo su dallo "zio" - "re" (e dalla madre-regina) non può assolutamente piacere (egli è già "sacrificato" a morte, in partenza) ed è un #presepe che non ha alcuna consonanza né con quello di Francesco di Assisi" né di Dante Alighieri, né di Michelangelo, e nemmeno quello "sognato" da Kafka ("[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" ).
- Nota:
- ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E STORIA: PALESTINA, ISRAELE, E LA LINGUA EBRAICA.
 Cfr. Gaston Zananiri, "Ben Yehouda" "SENS", I-1978.
Cfr. Gaston Zananiri, "Ben Yehouda" "SENS", I-1978.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. --- LINGUISTICA, ANTROPOLOGIA, E POLITICA. "GAD LERNER: ISRAELE IN BILICO". La "possibilità di nuovo percorso si può dare solo ... Se la lingua ebraica torna ad essere uno strumento di scambio e non solo una lingua sacra (di David Bidussa - "Doppiozero")..9 luglio 2024, di Federico La Sala
Gad Lerner: Israele in bilico
di David Bidussa ("Doppiozero, 12 Giugno 2024)
"Gaza. Odio e amore per Israele" di Gad Lerner è un libro necessario. Non sono d’accordo su tutto (nella parte finale indicherò dove ho perplessità), ma questo non ne ridimensiona la rilevanza. Non è prevalentemente un bilancio esistenziale o una confessione in pubblico (è anche questo, ma non è questo il tratto essenziale). È una messa a giorno di molti temi che riguardano la condizione della politica oggi. Anche molto lontano da Gaza e da Israele. Ci sono due pagine che riguardano un mio maestro, Zeev Sternhell, che Gad ricorda opportunamente e che molti hanno dimenticato. È molto importante averlo ricordato. Non era scontato. Così come molto importante aver sottolineato [p. 241] che la fase postbellica - quando sarà - necessiterà di processi di riconciliazione, giustizia riparativa e pratiche di cura che dovranno fare fronte ai traumi. La pace non sarà solo «silenzio delle armi», sarà soprattutto «cura delle persone».
Il primo dato riguarda alcune parole che circolano con insistenza. Per esempio la parola «genocidio».
Gad Lerner insiste sul fatto che a Gaza non sia in atto un genocidio, ma un crimine di massa. Forse a molti può apparire una questione puramente formale. Se è così allora significa che il linguaggio del qualunquismo ha vinto. Nel giudizio storico le parole hanno un significato. Non sono pura emozione, o testimonianza delle proprie ansie. Le parole servono per capire, non servono per urlare.
Marcello Flores, uno storico che gli stermini li ha studiati, ha precisato, opportunamente, più volte in queste settimane come per la Convenzione sul genocidio che è stata promulgata il 9 dicembre 1948 - un testo a cui tutti nominalmente si richiamano -, “genocidio è la distruzione parziale o completa di un gruppo etnico, religioso o nazionale. Nel caso in cui, però, c’è l’intenzione da parte di chi commette quella violenza di distruggere il gruppo in quanto tale” le sue considerazioni si possono leggere più estesamente qui.
Dunque, è in atto questa pratica a Gaza? Se la risposta è affermativa, allora la domanda a cui occorre rispondere è questa: perché non è in atto nessun atto di sterminio a Nazareth, nei confronti della popolazione araba? Perché il genocidio non è una cosa che dipende da «dove lo si fa», ma è in relazione a «chi lo fa». Se a Nazareth non c’è nessun sterminio in corso, allora la categoria di genocidio non è appropriata.
Secondo dato. C’è una domanda che ritorna spesso nelle pagine di Gad Lerner ed è questa: perché tra tutti i conflitti in corso quello che si svolge a Gaza occupa il centro della scena, fino a percepirlo come una cosa che riguarda «tutti noi»? Perché i molti conflitti in corso in Africa non ci riguardano? Perché il conflitto in Ucraina lo viviamo con noia, con fastidio, comunque, come una cosa non nostra e quello a Gaza ci appassiona fino a dissolvere consolidate amicizie, rompere consuetudini, o sollecitare la mobilitazione pubblica?
Gad Lerner si dà molte risposte che mi sembrano tutte molto fondate.
Nell’ordine:
perché abbiamo introiettato un rapporto con Israele come risarcimento e dunque abbiamo, nei confronti di ciò che quel paese fa e di come si comporta, delle categorie culturali che fondano la sua politica su un punto di sensibilità.
Oppure: perché abbiamo una presenza islamica considerevole e un flusso di processo migratorio che negli ultimi venti anni hanno modificato il nostro rapporto con le aree di quello che un tempo era il mondo delle colonie.
O anche: perché avvertiamo, almeno per una certa parte dell’opinione pubblica, che Israele è quello che un tempo era il Berlino Ovest per l’Occidente: la soglia più a Est della civiltà occidentale oltre la quale si trova il nemico.
In tutto questo al centro non ci sono le trasformazioni che hanno coinvolto da una/due generazioni (ovvero 20/40 anni) ciascun attore (sociale, politico, culturale, nazionale...) presente in quell’area, ma ci siamo noi. Qui.
Quella crisi, tuttavia, vive anche di trasformazioni lì che per molti aspetti hanno i tratti che prefigurano il nostro presente/futuro qui. Anche per questo ci riguarda e per questo un occhio a che cosa è accaduto lì negli ultimi 20/40 anni è essenziale per rimettere ordine nell’agenda politica e culturale di questo tempo, anche qui.
Il primo aspetto riguarda la trasformazione culturale e politica di Israele, da realtà politica costruita con un vocabolario del laburismo e che oggi testimonia di una metamorfosi politica tale da rientrare nella categoria di etnodemocrazia.
Sostenere che quella israeliana è un’etnocrazia non infrange nessun tabù. È stato Sami Smooha circa 50 anni fa ad aprire in Israele la discussione su questo tema [Smooha 1978] e gran parte della discussione prodotta dai nuovi storici israeliani tra anni ’80 e primi anni del XXI secolo indipendentemente dagli esiti politici che ciascuno di loro ha avuto (Yael Zerubavel, Anita Shapira, Tom Segev, Ilan Pappe, Benny Morris...) discende da quella premessa, che nessuno di loro disconosce. Discussione che intreccia, opportunamente, teoria politica, cultura religiosa, teologia, antropologia, soprattutto, narrazione storica.
È importante sottolinearlo per due motivi, almeno: perché qualsiasi contesto politico va collocato in un tempo storico e perché quel processo non è univoco. Infatti, riguarda il mondo ebraico israeliano e quello palestinese; quello ebraico fuori di Israele, quello dei palestinesi fuori dalla Palestina. Ovvero tutte le diaspore che hanno relazioni con quello spazio.
Quel processo ha il suo consolidamento a partire dal dopo 1967 e con l’inizio del processo insediativo nei territori occupati dopo la «Guerra dei 6 giorni» (5-10 giugno 1967) e ha un suo consolidamento nel processo che stabilisce le norme di cittadinanza nel 2018 che marcano una frattura rispetto al compromesso in atto nel momento della fondazione dello Stato. Gli arabi israeliani, dunque anche quelli presenti sul territorio di Israele prima del 5 giugno 1967 non sono attori che godono degli stessi diritti dei cittadini ebrei israeliani. La lingua araba che fino a quel momento è riconosciuta come seconda lingua dello Stato retrocede a lingua ammessa nello spazio pubblico. Sul piano formale e sostanziale la definizione dello Stato di Israele come Stato ebraico implica l’abbandono della definizione di «Stato di tutti i suoi cittadini».
Processo che è favorito anche dal tipo di immigrazione che sostanzia la società attuale israeliana dove la componente espulsa dai paesi arabi è in crescita, dove la componente di provenienza russa post-sovietica ha un tratto nazionalista. Una realtà che dal punto di vista delle diverse «tribù interne» testimonia degli odi e dei torti patiti nel luogo di origine.
Si potrebbe anche osservare come quel processo di etnicizzazione e di discriminazione sia parallelo in molti paesi arabi nonché all’interno del mondo palestinese, a dimostrazione che il processo di costruzione del futuro Stato palestinese è facilmente prevedibile che dovrà misurarsi con lo stesso tipo problema, a cominciare dalla natura laica della politica e delle forme di rappresentanza politica interna, senza dimenticare che la sua minoranza interna cristiana non gode poi di molte libertà.
Quel processo, tuttavia, e qui sta un tema strutturale della riflessione di Lerner, ha avuto una trasformazione a partire dagli anni ’80.
Lerner si limita a analizzare la realtà israeliana, ed ebraico-diasporica, ma sarebbe molto importante, oltreché necessario che quello stesso percorso di ricostruzione critica e problematica si producesse anche in campo palestinese e nelle diaspore arabofone.
Quelle realtà sociali in quel territorio e contemporaneamente le diaspore che a quelle realtà fanno riferimento, hanno avuto una metamorfosi fondamentalista tanto nei percorsi di identità religiosa come nei processi di identità culturale. In breve, gli spazi e i percorsi di critica interna al gruppo si sono ristretti, il processo di mentalità totalitaria ha avuto un percorso di crescita, i margini di dissenso interno e di discussione si sono ridotti.
Se è vero che tra XIX e XX secolo i margini di laicità, - qui mi limito a considerare l’esperienza del mondo ebraico -, hanno avuto processi di abbandono, ne hanno però vissuti anche altri di profonda innovazione, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Francia, in alcuni momenti anche in Italia, nella Palestina mandataria e poi in Israele ovviamente.
Il processo di laicizzazione voleva dire inaugurare un nuovo rapporto col testo, interrogarlo, uscire dall’interpretazione letterale e tradizionale, ibridare interpretazioni inglobando sollecitazioni dal linguaggio della filosofia, dell’antropologia, della sociologia, della semiotica, della critica letteraria, della teoria del linguaggio.
Implicavano la presenza di un filone di tradizione e di osservanza anche ortodossa, radicale, ma aperta al confronto con le molte forme della modernità. Il processo di radicalismo teologico degli ultimi quarant’anni, così come i processi di fondamentalismo propri nel mondo islamico, hanno attraversato e avuto forza anche nei diversi mondi ebraici, in Israele e nelle diaspore, e hanno limitato fino quasi a dissolvere questa possibilità.
Questo aspetto è quello che non mi fa pensare - e qui sono più pessimista di Lerner - che in sé ci sia un mondo della diaspora che salverà Israele. Quella possibilità di nuovo percorso si può dare solo se segmenti inquieti tanto delle diaspore come dell’ortodossia e della riflessione pubblica in Israele (che ci sono e non tacciono) trovano luoghi comuni di confronto e dialogo. Se la lingua ebraica torna ad essere uno strumento di scambio e non solo una lingua sacra.
Invece se quel confronto tra Israele e diaspore non si nutre di inquietudini che parlano un linguaggio comune, nel senso tecnico della parola; se la possibilità di parlarsi in una lingua non è anche la costruzione di un vocabolario che si nutre delle sollecitazioni e inquietudini che generano concetti e parole chiave che obbligano a rivedere i significati, e dunque anche i molti luoghi comuni che un sapere codificato inevitabilmente produce nel tempo; allora quel confronto tra Israele e diaspore sarà solo una delle molte forme in cui si sancirà un reciproco allontanarsi e alla fine vincerà solo chi si sentirà padrone delle regole. Di solito, in quel caso, vince chi ha i codici d’accesso all’identità e chi detiene le chiavi della legge. In una parola: chi ha lo - e chi è - Stato. In quel caso le diaspore, volenti o nolenti, sono destinate ad essere contorno.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” --- Abitare da stranieri una Terra-Sposa (di Donatella Di Cesare).26 maggio 2021, di Federico La Sala
ISRAELE - PALESTINA /SENZA FINE
ABITARE DA STRANIERI UNA TERRA-SPOSA
Tra Israele e Palestina l’idea dei due popoli e due stati non regge più
Chi conosce i territori sa bene che sono strettamente intrecciati e che sotto ogni aspetto una divisione netta, oltre a essere irrealistica, sarebbe artificiosa e alla fin fine nociva. Quasi una resa. Per questo serve immaginare un laboratorio politico nuovo
di Donatella Di Cesare (L’Espresso, 25.05.2021)
«Quelli sono occupanti! E gli altri sono occupati». Più esplicitamente: «Quel paese è frutto di occupazione!». Oppure con il nuovo motto: «Basta con l’esproprio etnico!». Sono solo alcuni esempi di slogan che circolano ovunque, dal web alle piazze, e che rilanciano una vecchia, vecchissima accusa (quasi immemoriale): Israele non dovrebbe essere lì dov’è. Non ci sarebbe quasi altro da aggiungere.
Il «peccato originale» che avrebbe segnato la nascita di Israele sarebbe quello di aver scalzato un popolo che c’era prima, indigeno, nativo, insomma autoctono. Alla fin fine non si tratta neppure tanto di limiti e confini, di linea verde e territori contestati. Dietro calcolo e contabilità, a cui spesso si fermano statisti e politologi, si nascondono questioni ben più profonde che di solito vengono aggirate. Forse perché non riguardano solo Israele e Palestina, ma investono tutti noi, le nostre frontiere, gli stati nazionali in cui siamo inseriti, il nostro abitare e il rapporto con gli altri.
 Perciò occorre forse una prospettiva nuova, un modo diverso a cui guardare quel terribile conflitto che non per caso ci turba e ci coinvolge tutti con un’ondata di emozioni talvolta irrefrenabili, al punto da rendere impossibile una riflessione. E se nella tragedia si nascondesse invece una chance? Se Israele e Palestina fossero il laboratorio politico della globalizzazione?
Perciò occorre forse una prospettiva nuova, un modo diverso a cui guardare quel terribile conflitto che non per caso ci turba e ci coinvolge tutti con un’ondata di emozioni talvolta irrefrenabili, al punto da rendere impossibile una riflessione. E se nella tragedia si nascondesse invece una chance? Se Israele e Palestina fossero il laboratorio politico della globalizzazione?Forse bisognerebbe chiedersi anzitutto che cosa significa «occupare». Questo verbo, che è il punto dirimente, non sembra solo legato alla frontiera e al fronteggiarsi. Rinvia anche al possesso originario, alla mitologia dell’origine, a cui non si sottraggono neppure i palestinesi quando rivendicano di essere i primi abitanti. La battaglia delle cartine è arrivata anche su facebook. Colori e bandiere diversi si avvicendano per quello stretto lembo di terra che va dal Giordano al Mediterraneo. E di nuovo: lo scontro non è tanto sulla geografia, quanto sulla storia. Chi c’era prima? I palestinesi che sono stati poi scalzati. Sono loro gli abitanti originari, gli autoctoni. Quelli che sono arrivati dopo - gli ebrei, gli israeliani - sono occupanti, colonialisti, ecc. Ma i nomi contengono anche una testimonianza storica. L’etimologia di «palestinese» va ricondotta a liflosh, ovvero filisteo, cioè invasore, e si riferisce a un popolo venuto dal mare. Dopo aver raso al suolo Gerusalemme i romani chiamarono Palestina la terra di Israele per sottolineare la rottura rappresentata dall’Impero e cancellare anche nel nome il ricordo del popolo ebraico. I palestinesi di oggi, discendenti in gran parte dall’immigrazione araba intorno al 1930, sono andati costruendo una identità nazionale nel confronto-scontro con Israele rivendicando radicamento e possesso originario.
Sono allora gli ebrei i veri autoctoni? No - e lo dice il nome. Perché ivrì, cioè venuto da altrove, non può essere del luogo. Abramo, il primo emigrante, segue l’ingiunzione: «va, vattene!». E così lascia tutto per andare a vivere da straniero in una terra non sua, promessa. Insomma, quelli che credono di essere venuti prima sono invece sempre venuti dopo.
 Chi sono allora gli abitanti originari, gli autoctoni, di questa terra, e di ogni terra? Ma forse sbagliata è proprio la domanda: nessun popolo può dimostrare di essere autoctono.
Chi sono allora gli abitanti originari, gli autoctoni, di questa terra, e di ogni terra? Ma forse sbagliata è proprio la domanda: nessun popolo può dimostrare di essere autoctono.Eppure, questo mito potentissimo alimenta ancora oggi la politica degli stati nazionali. Basti pensare alla guerra contro i migranti. È l’idea della terra-madre che, mettendo fuori gioco le donne, genera direttamente i suoi figli, tutti maschi e tutti cittadini, perché nati proprio lì, in quella zolla di terra, nel suolo stesso della città. Perciò sono i proprietari esclusivi, i figli legittimi, ben nati, in grado di respingere gli altri, i bastardi e gli stranieri. Questo avviene nell’Atene patria del sé, modello fulgido di pura, presunta autoctonia. Ma l’esempio - lo sappiamo - può vantare una tradizione secolare che nulla ha interrotto, nemmeno l’hitlerismo, la forma più esasperata dello ius soli. E oggi quel mito continua ad affermarsi tra radici inestirpabili e malattia identitaria, che ovunque rischiano di ridurre la democrazia a etnocrazia, una forma politica dove valgono non i diritti del popolo, ma quelli della stessa etnia. Si può puntare l’indice solo su Israele, parlando di stato etnico e magari usando una parola grave come «apartheid»? Oppure non si dovrebbe guardare anzitutto a quel che avviene nei paesi europei, anzitutto in Italia, dove la cittadinanza è basata ancora sul sangue e sul suolo?
Chi conosce i territori israeliani e palestinesi sa bene che sono strettamente intrecciati e che sotto ogni aspetto una divisione netta, oltre a essere irrealistica, sarebbe artificiosa e alla fin fine nociva. Quasi una resa. E infatti sono sempre più le voci critiche che negli ultimi anni si sono levate contro la «soluzione dei due stati», giudicata una fantasia che dimentica la storia e ignora il contesto politico. D’altronde ovunque, sotto la spinta della globalizzazione, lo stato perde sovranità e i confini diventano un limite. In tale scenario quello tra Israele e Palestina è il conflitto tra uno stato post-nazionale e uno stato proto-nazionale. Sta qui in gran parte l’insolubilità.
 Le due parti non si incontrano anche perché si trovano in fasi diverse della propria storia. Israele ha compiuto la «liberazione nazionale» e in molti ambiti (dallo high tech all’informatica) oltrepassa continuamente i referenti statuali. Resta allora la questione dello Stato palestinese. Al di là delle divisioni interne, si può essere sicuri che la fondazione di un nuovo stato sarebbe criterio di equità e favorirebbe la pace? La logica degli stati nazionali, che ancora nel secolo scorso poteva essere considerata la via dell’emancipazione, da tempo mostra tutte le proprie pecche, dall’aggressività nazionalistica alla costruzione di identità artificiali. Le «patrie» che gli stati nazionali hanno costruito per i propri popoli si sono rivelate trappole senza uscita.
Le due parti non si incontrano anche perché si trovano in fasi diverse della propria storia. Israele ha compiuto la «liberazione nazionale» e in molti ambiti (dallo high tech all’informatica) oltrepassa continuamente i referenti statuali. Resta allora la questione dello Stato palestinese. Al di là delle divisioni interne, si può essere sicuri che la fondazione di un nuovo stato sarebbe criterio di equità e favorirebbe la pace? La logica degli stati nazionali, che ancora nel secolo scorso poteva essere considerata la via dell’emancipazione, da tempo mostra tutte le proprie pecche, dall’aggressività nazionalistica alla costruzione di identità artificiali. Le «patrie» che gli stati nazionali hanno costruito per i propri popoli si sono rivelate trappole senza uscita.Puntare a una comune cittadinanza deterritorializzata e denazionalizzata sarebbe invece la strada insieme più concreta, ma anche più lungimirante. Si tratta peraltro di un esperimento che viene praticato anche in altre parti del mondo, dove gli stati gomito a gomito impediscono la convivenza, oppure in alcune grandi città nelle quali è molto alto il numero degli immigrati (esemplare è il caso di New Haven che ha concesso stato civile e diritti politici). Tutto questo non potrebbe in nessun modo lasciare immutato lo stato di Israele che, anzi, proprio perciò, dovrebbe andare al di là dello stato.
Non avrebbe dovuto essere questo il suo compito? Mentre è accusato di occupare una terra non sua, mostrare la possibilità di un altro abitare? Era questo il senso della promessa, una promessa certo non dettata dalla Shoah, dei cui esiti atroci Israele ha dovuto semmai farsi carico. Eppure, ancora oggi Israele è inquisito nel suo essere: si contesta quel ritorno, negando la continuità della presenza su quella terra, e dunque la storia stessa del popolo ebraico. Capita che lo facciano subdolamente esimi storici che su youtube ironizzano sull’antico regno di Israele. Come se questo fosse il punto.
Ma che dire degli sfratti a Sheikh Jarrah? Soprattutto per ciò di cui sono simbolo? E tutta la miope e belligerante politica di espansione della destra che in questi ultimi anni ha provocato enormi e inutili tensioni? Si può ormai parlare di una tragicità del sionismo politico che sulla scia della normalizzazione ha inscritto Israele nella modernità al prezzo di un nazionalismo esasperato e una simbiosi con la terra. Proprio il popolo che dovrebbe mostrare la possibilità di un altro abitare, non nel solco del radicamento, bensì nella separazione. Questo vuol dire kadosh, santo, separato. Terra in cui si risiede come stranieri, venuti da fuori, come ospiti che non possono non concedere ospitalità.
 Non una terra-madre, bensì una terra-sposa. Impossibile dimenticare l’estraneità, sacralizzando idolatricamente la terra. D’altronde in ebraico gher, straniero, è connesso con ghur, abitare. Si può e si deve abitare da stranieri. Nessun mito di autoctonia.
Non una terra-madre, bensì una terra-sposa. Impossibile dimenticare l’estraneità, sacralizzando idolatricamente la terra. D’altronde in ebraico gher, straniero, è connesso con ghur, abitare. Si può e si deve abitare da stranieri. Nessun mito di autoctonia.Abitare e coabitare sono verbi oggi politicamente decisivi e vanno al di là di vecchie categorie politiche che non rispondono più allo scenario attuale e all’ordine statocentrico. Si capisce che il conflitto tra Israele e Palestina abbia ripercussioni ovunque. Già solo perché viene tacitamente scossa la sovrana autocoscienza delle nazioni che vantano radici e possesso territoriali. Israele è una effrazione nel dimorare della Palestina e i palestinesi, i più prossimi, sono quasi delegati degli altri popoli, che d’un tratto si trovano faccia a faccia con il vuoto statuale e nazionale di cui Israele è memoria. In tal senso, guardando oltre il quadro bellico, è quello il laboratorio politico dove due popoli, loro malgrado, sono costretti a inaugurare nuove forme di coabitazione che saranno forse modello per gli altri.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. --- La memoria e il possibile ("Mens-a"): “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”. Intervista a Fania Oz-Salzberger: «L’ascolto cambia il mondo».22 maggio 2019, di Federico La Sala
LA MEMORIA NELLE PAROLE. PER AMOS OZ.... *
Intervista.Fania Oz: «L’ascolto cambia il mondo»
Parla la storica israeliana: «Oggi la solidarietà è ancora viva, ma l’Europa ha il dovere di impedire che siano messi in discussione i valori fondamentali»
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, mercoledì 22 maggio 2019)
- [Foto] Fania Oz-Salzberger
- La memoria e il possibile è il tema della terza edizione di “Mens-a”, l’evento sui temi dell’ospitalità e del cosmopolitismo che da qui a settembre toccherà Modena, Vignola, Parma e Ravenna.
 Si parte giovedì 24 maggio alle 20,30 dall’Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni 5), con la serata dal titolo “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”, durante la quale l’intervento di Fania Oz-Salzberger si intreccerà con le letture di Alessio Vassallo da Una storia d’amore e di tenebra, capolavoro riconosciuto del grande scrittore israeliano scomparso nei mesi scorsi: la moderazione è affidata all’ebraista Sarah Kaminski.
Si parte giovedì 24 maggio alle 20,30 dall’Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni 5), con la serata dal titolo “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”, durante la quale l’intervento di Fania Oz-Salzberger si intreccerà con le letture di Alessio Vassallo da Una storia d’amore e di tenebra, capolavoro riconosciuto del grande scrittore israeliano scomparso nei mesi scorsi: la moderazione è affidata all’ebraista Sarah Kaminski.
 Tra venerdì e sabato si susseguiranno, sempre a Bologna, gli incontri con monsignor Erio Castellucci, con Benianimo de’ Liguori Caino della Fondazione Olivetti, con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con i filosofi Francesca De Vecchi, Rocco Ronchi e Sergio Givone, con lo psichiatra Eugenio Borgna, con lo studioso di estetica Pietro Montani e con numerosi altri ospiti. Per infomazioni www.mens-a.it.
Tra venerdì e sabato si susseguiranno, sempre a Bologna, gli incontri con monsignor Erio Castellucci, con Benianimo de’ Liguori Caino della Fondazione Olivetti, con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con i filosofi Francesca De Vecchi, Rocco Ronchi e Sergio Givone, con lo psichiatra Eugenio Borgna, con lo studioso di estetica Pietro Montani e con numerosi altri ospiti. Per infomazioni www.mens-a.it.
Fania Oz-Salzberger non ha dubbi: «Le parole possono peggiorare o migliorare il mondo - dice - ma ascoltare gli altri, ascoltarli veramente, può soltanto migliorarlo». È il suo modo di reinterpretare l’eredità ricevuta dal padre, il grande romanziere israeliano Amos Oz, morto a Tel Aviv negli ultimi giorni del 2018. Insieme, alcuni anni fa, avevano scritto un libro illuminante, Gli ebrei e le parole, edito in Italia da Feltrinelli. Ed è proprio sul legame strettissimo fra memoria, linguaggio e destino che la studiosa, docente di Storia delle idee all’Università di Haifa, si soffermerà domani a Bologna durante la lezione inaugurale di Mens-a, l’evento internazionale sul pensiero ospitale e il cosmopolitismo in calendario fino a sabato. «Ma c’è un’altra parola che aggiungerei alla lista», osserva Fania Oz-Salzberger.
Quale?
Verità. Mentre lavoravamo al libro, mio padre e io ci interrogavamo spesso sul suo significato. In che senso, mettiamo, un racconto biblico va considerato “vero”? Abramo e Sara potrebbero anche non essere esistiti, eppure la loro storia ha cambiato il mondo. Anche la verità letteraria non si basa sui fatti: Amleto non è una figura storica, ma attraverso di lui Shakespeare continua a svelarci qualcosa che si annida nella profondità della natura e dell’esperienza umana. “I fatti possono essere i peggiori nemici della verità”, ha dichiarato mio padre. Un racconto d’invenzione riesce a toccarci in maniera molto più autentica e decisiva rispetto alle notizie del telegiornale.
Scopriamo qual è il nostro destino?
Ecco, questo è un termine sul quale ci siamo subito intesi, mio padre e io. Essendo ebrei secolarizzati, siamo sempre stati persuasi che la storia sia un prodotto dell’azione umana e delle circostanze esteriori. Quanto alla memoria, la questione è più complessa: quella personale non coincide con quella storica ed entrambe differiscono da quella letteraria. Tutte insieme, però, cambiano il mondo. I ricordi di mio padre sulla madre, il modo in cui ebrei e palestinesi ricostruiscono il proprio passato, le nostre reminiscenze di lettori ( Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, nella fattispecie, influenzò molto mio padre): ciascuno di questi elementi modifica la relazione che intratteniamo con la famiglia, la tradizione, l’amore, il lutto. Entrano in gioco materiali mentali diversi, un po’ come accade con gli strumenti e i codici simbolici delle varie arti: pittura, musica, scrittura.
Qui entra in scena il linguaggio?
Ogni grande scrittore si nutre della propria lingua madre, che nel caso di mio padre era l’ebraico. Lo amava, ci giocava. In quanto storica, non posso permettermi un atteggiamento così disinvolto, ma ho comunque la facoltà di interrogare la lingua e approfondirne la comprensione. L’ebreo moderno, in questo senso, è stata la più importante startup linguistica del Novecento. Nessun’altra lingua ha avuto uno sviluppo altrettanto rapido, nessun’altra è riuscita a partire dal nulla fino a superare la soglia di dieci milioni di parlanti.
Come è potuto accadere? Grazie alla combinazione di due fattori irripetibili: l’alto livello di alfabetizzazione, specie maschile, e il permanere di una forte tradizione testuale. Ancora adesso, la Bibbia rappresenta una miniera inesauribile di espressioni, e così il Talmud, la poesia ebraica medievale, la letteratura profana. L’ebraico è una delle lingue più vive di oggi e il successo di molti autori contemporanei lo dimostra in modo eloquente.
Ma questo non contrasta con il ritorno del pregiudizio antisemita?
Mio padre amava ripetere che Hitler e Stalin, pur senza volerlo, ci hanno vaccinati contro l’odio razziale e il genocidio, ma che dopo settant’anni l’effetto del trattamento sta cominciando a svanire. L’affievolirsi della memoria risveglia i demoni e l’antisemitismo, come sappiamo, è uno tra i più feroci. Gli ebrei sono minacciati da destra e da sinistra. Da una parte li si identifica in blocco con lo Stato di Israele, giungendo a negare il loro diritto all’esistenza. Dall’altra, si torna ad accusarli di complotti globali e malefatte universali. Ci sono musulmani che si proclamano antisemiti e antisemiti che sono anche islamofobi. La discriminazione non si sposa bene con la logica.
Come si dovrebbe reagire?
Lo dico con chiarezza: è l’ora che l’Europa si prenda le sue responsabilità. A essersi rimessi in marcia, infatti, sono proprio i demoni della storia europea. Decine di migliaia di ebrei stanno lasciano la Francia, la Gran Bretagna e diversi Paesi dell’Est. Questa volta, per fortuna, hanno un posto in cui rifugiarsi, un luogo in cui sentirsi a casa. Ma un’Europa senza ebrei sarebbe ancora Europa?
Che cosa pensa dell’ondata populista?
Il filosofo Isaiah Berlin, che è stato mio maestro a Oxford, distingueva sempre tra nazionalità e nazionalismo. La prima va tranquillamente a braccetto con la democrazia, che il secondo invece non sopporta proprio. I nazionalisti amano l’ethnos, la componente etnica, e disprezzano il demos, perché la declinazione moderna del demos, ossia della cittadinanza nel suo complesso, prevede la compresenza di gruppi etnici tra loro differenti. Vogliono convincerci che nell’era del web la democrazia sia ormai fuori moda e che i social network diano una spinta al populismo, diffondendo l’odio in modo molto più rapido e capillare di quanto accada con l’amore e la solidarietà. Anche mio padre la pensava così. In questo, tra di noi, c’era una certa incomprensione generazionale. Al contrario di lui, io mi servo di internet, interagisco sulle piattaforme sociali e credo fermamente che il populismo vada combattuto dall’interno, contrastando con estrema durezza ogni incitamento all’odio presente in rete. Non abbiamo scelta: internet è una realtà irreversibile, è la piazza nella quale siamo chiamati a esprimerci, è il nostro campo di battaglia.
Anche la solidarietà è a rischio?
Lasci che le parli un po’ dell’impegno dei miei studenti a Lesbo, in Grecia. In questo momento, questo gruppo di giovani israeliani, sia ebrei che arabi, è la più efficace tra le organizzazioni non governative che operano con i rifugiati siriani raccolti sull’isola. Sono molto fiera di loro. Insieme con milioni di altre brave persone attive in tutto il mondo, dimostrano che ancora oggi amore e compassione sono più vivi e vitali che mai. Il problema è che troppo spesso il loro lavoro non viene percepito, perché è meno facile da twittare rispetto al razzismo e su Instagram risulta meno attraente di un’ereditiera viziata. Ma non possiamo dimenticare che l’attuale crisi dei migranti in Europa non deriva solo dal razzismo, ma anche da decisioni politiche inadeguate. Per accogliere milioni di persone non è sufficiente spendere qualche bella parola e neppure un bel mucchio di soldi. Occorre un serio lavoro sul campo, specie nella sensibilizzazione dei nuovi arrivati e degli abitanti di ciascun Paese, che devono essere messi in grado di capire quali valori vadano preservati e quali criteri di giustizia economico-sociale vadano rispettati. Si tratta di una transizione enorme, che purtroppo la maggioranza dei Paesi europei non ha saputo governare, accontentandosi di discorsi zuccherosi e di proclami solenni.
A che cosa si riferisce?
Trovo inaccettabile che, in nome del rispetto tra le culture, il ruolo della donna possa essere sminuito. E questo vale anche per le aggressioni agli ebrei, vale per la svalutazione dei valori fondamentali di convivenza. Se l’Europa vuole restare fedele a se stessa, deve liberarsi di queste ambiguità.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Palestina, Israele e la rinascita della lingua ebraica....
- ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA]
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA --- Israele stato-nazione del popolo ebraico. Anatomia di una scelta ingiusta. (di David Grossman).3 agosto 2018, di Federico La Sala
Anatomia di una scelta ingiusta
Così Israele spezza l’uguaglianza
di David Grossman (la Repubblica, 03.08.2018)
Il potenziale di divisione e di distruzione contenuto nella legge che proclama Israele stato-nazione del popolo ebraico salta talmente all’occhio che l’ostinazione del Primo ministro a non introdurre nessun emendamento alla suddetta legge risveglia il sospetto che vi sia un’intenzione nascosta: quella di voler mantenere aperta la ferita dei rapporti tra Stato e minoranza araba. Una ferita infiammata e minacciosa. Da cosa potrebbe derivare l’intenzione di Netanyahu? Perché il governo e chi lo guida vorrebbero una cosa simile? Possiamo solo immaginarlo. Forse perché una minoranza con una ferita aperta è più vulnerabile e più facile a manipolazioni, a essere sobillata, intimidita, divisa. Forse perché è più propensa a subire una politica di "divide et impera".
È così che si mantiene aperta una ferita: di colpo, con una legge inutile, con la quale Netanyahu e il suo governo hanno fatto mancare la terra sotto ai piedi a un quinto della popolazione. E ancora una volta: perché? Perché possono. Perché sono sicuri che nessuna forza abbia il potere di fermarli.
Perché vogliono che i cittadini arabi di Israele vivano in un costante senso di insicurezza esistenziale. Di incertezza sul futuro. Vogliono che ricordino sempre, in ogni momento, che dipendono dalla buona - o dalla cattiva - volontà del governo. Che la loro presenza qui è condizionata, e in qualsiasi momento potrebbero diventare una presenza invisibile.
E questa legge dice chiaramente un’altra cosa: il Primo ministro israeliano ha deciso di non mettere fine all’occupazione e allo stato di apartheid nei territori palestinesi, bensì il contrario: ha deciso di rinsaldarlo e di spostarlo entro i confini di Israele. In altre parole, questa legge è essenzialmente una rinuncia alla possibilità di porre fine al conflitto con i palestinesi. E per quanto riguarda la "retrocessione" dello status della lingua araba da "ufficiale" a "speciale" decretato dalla legge: un idioma è un mondo intero, una coscienza, un’identità, una cultura. È un canovaccio infinito che tocca i vasi capillari dell’esistenza. Un uomo - un politico - deve avere un’arroganza e una sfrontatezza incredibili per ferire e umiliare, anche soltanto in maniera formale (come si sono giustificati i legislatori) l’idioma di un altro popolo. L’ebraico e l’arabo sono lingue sorelle che si sono intrecciate nel corso della storia.
Milioni di ebrei israeliani hanno succhiato l’arabo col latte materno. Non ci sono parole sufficienti nella lingua ebraica per protestare e strepitare contro lo schiaffo inflitto alla sorella.
Per centinaia e migliaia di anni il popolo ebraico è stato una minoranza nei paesi in cui ha vissuto e questa esperienza ha plasmato la sua identità e ha acuito la sua sensibilità morale.
Ora siamo noi la maggioranza nel nostro Paese e questa è un enorme responsabilità, una grande sfida politica e sociale ma soprattutto umana che ci impone di capire che il comportamento nei confronti di una minoranza è una delle più grandi prove di democrazia. Questa settimana il governo israeliano ha fallito questa prova e il suo fallimento ha sollevato echi in tutto il mondo. In quel mondo che noi accusiamo ripetutamente di discriminare la minoranza ebraica che in esso vive. Sarebbe quindi deplorevole se la locale comunità drusa si accontentasse di ricevere un "compenso" economico o di altro tipo per l’offesa subita dalla legge che riconosce Israele come Stato della nazione ebraica. La situazione che si è creata in seguito alla giustificata ondata di proteste di questa comunità potrebbe essere l’inizio di un processo molto più ampio, con i drusi in prima linea nella lotta per l’uguaglianza di tutte le minoranze musulmane e cristiane in Israele. Il consenso - almeno per il momento - dei leader drusi ad accettare la proposta di Netanyahu di un compenso, dimostra che probabilmente anni di discriminazione e di promesse vuote hanno fatto dimenticare loro il vero sapore di una completa uguaglianza.
Nella torbida realtà israeliana sarebbe bene ricordare che l’uguaglianza non è una specie di "premio" assegnato ai cittadini per i servigi resi al Paese, e nemmeno per aver sacrificato la propria vita. Anche gli ultra-ortodossi che si rifiutano di arruolarsi nell’esercito sono cittadini con pari diritti.
L’uguaglianza è il punto di partenza della cittadinanza, non un suo prodotto. È il terreno su cui la cittadinanza cresce. È anche ciò che permette una rispettosa libertà - la libertà di essere diverso, dissimile dagli altri, eppure uguale, con gli stessi diritti.
Ritengo che le ultime leggi approvate dall’attuale governo siano in buona parte il risultato di un modo distorto di pensare prodotto da cinque decenni di occupazione e di un senso di superiorità etnico creatosi dopo avere sguazzato con entusiasmo in un qualche "noi" farisaico e nazionalista che vuole "buttar fuori di casa" tutto ciò che non ci appartiene - un altro popolo, un’altra religione, una diversa tendenza sessuale.
Ma forse questa legge in realtà ci fa un grosso favore perché mostra a tutti noi, di destra e di sinistra, senza illusioni e senza auto-inganni, a che punto siamo arrivati, dove è precipitato Israele. Forse questa legge darà finalmente una scossa a chi, tra noi, si preoccupa per il proprio Paese, per il suo spirito, la sua umanità, i suoi valori ebraici, democratici e umani.
Non ho dubbi che molte persone, di destra, di sinistra e di centro, oneste e disincantate, siano consapevoli che questa legge è un atto di barbarie e un tradimento dello Stato nei confronti dei suoi cittadini. Netanyahu, come al solito, lo descrive come uno scontro tra destra e sinistra. Ma è uno scontro molto più profondo e fatidico. È una lotta tra chi è disperato e chi invece ancora spera. Tra chi si è arreso alla tentazione del nazionalismo razzista e chi continua a opporvisi e a mantenere nel cuore un’immagine, un’idea, una speranza di come potrebbero essere le cose in un paese normale.
 Traduzione di Alessandra Shomroni
Traduzione di Alessandra Shomroni -
> ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” -- Freud e il non europeo (di Edward W. Said).28 giugno 2018, di Federico La Sala
ISRAELE E PALESTINA - e la Terra promessa.... *
Freud e il non europeo
di Edward W. Said (Le parole e le cose, 28 giugno 2018)
- [L’editore Meltemi ha appena pubblicato Freud e il non europeo, a cura di Giovanbattista Tusa, una controversa conferenza tenuta da Said nel 2001 presso il Brunei Centre della School of Oriental and African Studies di Londra. Ne pubblichiamo un estratto, ringraziando l’editore].
Dubito fortemente che Freud potesse immaginare che avrebbe avuto lettori non europei o che, nel contesto della lotta per la Palestina, avrebbe avuto anche lettori palestinesi. E però li ha avuti e ne ha ancora. Ma diamo una rapida occhiata ai risultati dei suoi scavi - in senso sia figurato sia letterale - da queste nuove prospettive, inaspettatamente perturbanti e sorprendentemente pertinenti. Prima di tutto, direi che, nonostante gli sforzi dell’antisemitismo specificamente europeo, l’insediamento di Israele in un territorio non europeo consolidò politicamente l’identità ebraica in uno Stato che adottò posizioni legali e politiche assai specifiche per blindare quest’identità nei confronti di tutto ciò che non fosse ebreo.
Nel definirsi come uno stato di e per il popolo ebreo, Israele consentì soltanto agli ebrei di immigrare sul proprio suolo e riservò solo a loro il diritto di proprietà sulla terra, nonostante prima vi fossero residenti non ebrei e, in quel momento, cittadini non ebrei, i cui diritti furono soggetti a restrizioni e addirittura, nel caso dei primi, abrogati retroattivamente. I palestinesi che vivevano in Palestina prima del 1948 non possono né tornare (nel caso dei rifugiati) né avere accesso alla terra allo stesso modo degli ebrei. La legislazione israeliana, assai lontana dallo spirito intenzionalmente provocatorio di Freud sull’origine non ebrea del fondatore dell’ebraismo e delle sue origini nel contesto del monoteismo egizio non ebreo, contravviene, reprime e persino cancella quell’apertura dell’identità ebraica nei confronti dei propri antecedenti non ebrei, che Freud si sforzò invece ostinatamente di mantenere. La complessa stratificazione del passato è stata cancellata dall’Israele ufficiale.
Al contrario Freud - per come lo leggo io nel quadro delle politiche deliberatamente ideologiche di Israele - aveva lasciato aperto uno spazio considerevole a quanto di non ebreo vi è nell’ebraismo, nelle sue origini, come nel suo presente. Vale a dire che, nello scavo archeologico dell’identità ebraica, Freud insistette sul fatto che essa non aveva avuto inizio apartire da sé, ma piuttosto a partire da altre identità (egizia e araba): la dimostrazione di ciò, in L’uomo Mosè e la religione monoteistica, obbliga a percorrere un lungo cammino per scoprirlo e costringe così nuovamente a mettere tale identità sotto verifica. Di fatto quest’altra storia, non ebrea e non europea, è stata cancellata e di essa non esiste più alcuna traccia nell’identità ebrea ufficiale.
Credo che ancora più rilevante sia il fatto che, in ragione di una delle conseguenze dell’insediamento di Israele che viene generalmente ignorata, i non ebrei - in questo caso, i palestinesi - siano stati dislocati in un luogo in cui, secondo lo spirito che anima gli “scavi” freudiani, potrebbero chiedersi cosa sia rimasto delle tracce della loro storia, profondamente legata alla realtà della Palestina prima della fondazione di Israele.
Per cercare di rispondere vorrei spostarmi dall’ambito politico e giuridico verso un territorio molto più vicino al racconto di Freud sull’origine del monoteismo ebraico. Penso di essere nel giusto se dico che Freud mobilitò il passato non europeo con l’intento di indebolire qualsiasi tentativo dottrinale di fondare l’identità ebraica su una base solida, religiosa o secolare che fosse. E dunque, non dovrebbe sorprenderci scoprire che, quando l’identità ebraica fu consacrata dalla fondazione dello Stato di Israele, sia stata scelta la scienza dell’archeologia per consolidare quest’identità in un’epoca secolare: il feudo della storia sacra venne dato in consegna ai rabbini e agli eruditi specializzati in “archeologia biblica”[1].
Si noti che un gran numero di commentatori ed esperti di archeologia - da William Albright ed Edmund Wilson a Yigal Yadin, Moshe Dayan e persino Ariel Sharon - hanno sostenuto che l’archeologia è la scienza israeliana privilegiata par excellence. Come afferma Magen Broshi, un noto archeologo israeliano:
- Il fenomeno israeliano, una nazione che torna alla propria nuova terra del passato, non ha precedenti. È una nazione impegnata in un processo per recuperare familiarità con la propria terra, e in questo l’archeologia gioca un ruolo importante. In questo processo, l’archeologia fa parte di un sistema più ampio noto come yedi’at ha-Aretz, conoscenza della terra (il termine ebraico viene molto probabilmente dal tedesco Landeskunde). [...] Gli immigrati europei trovarono un paese verso il quale sentivano, paradossalmente, un senso di familiarità, e insieme un senso di estraneità. L’archeologia in Israele, uno stato sui generis, servì come mezzo per dissipare l’alienazione dei suoi nuovi cittadini. [2]
Così, l’archeologia diventa la strada più semplice verso un’identità giudaico-israeliana e si rivendica con insistenza che grazie a essa, ai giorni nostri, nella terra di Israele la Bibbia si realizza materialmente, la storia prende corpo, il passato viene recuperato e collocato in ordine dinastico. Queste affermazioni, ovviamente, ci spingono, in modo misterioso, non verso il luogo, esplorato da Freud, dell’archivio dell’identità ebraica, ma piuttosto verso la sua ubicazione geografica ratificata in maniera ufficiale (e dovremmo anche aggiungere: violenta) dal moderno Israele. -Ciò che si viene a scoprire è un poderoso tentativo revisionista per sostituire una nuova struttura positiva della storia ebraica agli sforzi ostinatamente più complessi e discontinui in “stile tardo” fatti da Freud per affrontare lo stesso tema, con uno spirito totalmente “diasporico” e con risultati molto differenti, persino decentranti.
Questo è un buon momento per riconoscere il mio enorme debito nei confronti del lavoro di una giovane studiosa, Nadia Abu el-Haj, autrice di un testo fondamentale intitolato Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society. L’autrice ci offre, in primo luogo, una storia della sistematica esplorazione archeologica coloniale in Palestina, che risale agli scavi britannici a metà del XIX secolo. -Prosegue poi con la storia del periodo precedente alla fondazione di Israele, connettendo la pratica concreta dell’archeologia alla nascente ideologia nazionale - un’ideologia che pianifica un ritorno al possesso della terra attraverso un’azione di ridenominazione dei luoghi e di trasferimenti di popolazione in nuovi insediamenti, azioni che si giustificano archeologicamente come un’estrazione schematica dell’identità ebraica, a dispetto dell’esistenza di nomi arabi e di tracce di altre civiltà.
 Questo sforzo, sostiene in maniera convincente l’autrice, prepara epistemologicamente la strada verso la piena maturazione, dopo il 1948, del sentimento d’identità giudaico-israeliana, fondato sull’assemblaggio di frammenti archeologici eterogenei - resti sparsi di opere murarie, tavolette, ossa, tombe, etc. - in una sorta di biografia spaziale dalla quale Israele emerge “in maniera visibile e linguisticamente, come la casa nazionale ebrea” [3].
Questo sforzo, sostiene in maniera convincente l’autrice, prepara epistemologicamente la strada verso la piena maturazione, dopo il 1948, del sentimento d’identità giudaico-israeliana, fondato sull’assemblaggio di frammenti archeologici eterogenei - resti sparsi di opere murarie, tavolette, ossa, tombe, etc. - in una sorta di biografia spaziale dalla quale Israele emerge “in maniera visibile e linguisticamente, come la casa nazionale ebrea” [3].Soprattutto, l’autrice sostiene che questa narrazione apparentemente biografica di una terra permette - se non addirittura causa -, e va di pari passo con, uno specifico stile di insediamento coloniale che decreta pratiche concrete come l’uso dei bulldozer, o la rinuncia a fare ricerche su storie che non siano israelite - per esempio quella degli Asmonei - o ancora, il costume di trasformare un’intermittente e sparpagliata presenza ebrea di rovine sparse e frammenti sepolti in una continuità dinastica, a dispetto di prove contrarie e a dispetto dell’evidenza di storie endogamiche non ebree.
 Dovunque venga fuori una schiacciante e innegabile evidenza di una molteplicità di altre storie, come nell’enorme palinsesto dell’architettura bizantina, crociata, asmonea, israelita e musulmana di Gerusalemme, la norma consiste nel presentare ciò come un segno di tolleranza della cultura liberale israeliana, ma, allo stesso tempo, viene affermata la preminenza nazionale di Israele, rispondendo così alle critiche dell’ebraismo ortodosso al sionismo moderno, facendo diventare Gerusalemme sempre più un sito nazionale del giudaismo[4].
Dovunque venga fuori una schiacciante e innegabile evidenza di una molteplicità di altre storie, come nell’enorme palinsesto dell’architettura bizantina, crociata, asmonea, israelita e musulmana di Gerusalemme, la norma consiste nel presentare ciò come un segno di tolleranza della cultura liberale israeliana, ma, allo stesso tempo, viene affermata la preminenza nazionale di Israele, rispondendo così alle critiche dell’ebraismo ortodosso al sionismo moderno, facendo diventare Gerusalemme sempre più un sito nazionale del giudaismo[4].La meticolosa decostruzione dell’archeologia israeliana di Nadia Abu el-Haj è anche una storia della negazione della Palestina araba che non è stata, per ovvie ragioni, considerata degna di un’indagine di livello simile. Tuttavia, con l’emergere negli anni ’80 in Israele di un movimento di revisionismo della storia postsionista e, allo stesso tempo, con la progressiva crescita nell’ultimo ventennio di un’archeologia palestinese come pratica di lotta di liberazione, gli atteggiamenti basati sul modello “ereditario” di un’archeologia esclusivamente biblica sono stati messi duramente alla prova. Mi piacerebbe avere il tempo di approfondire questo tema e di discutere in che modo la tesi nazionalista che difende la separazione della storia di Israele da quella della Palestina ha cominciato a orientare le dispute archeologiche in Cisgiordania e di come, per esempio, l’attenzione palestinese alle ricchissime sedimentazioni di storia rurale e alle tradizioni orali sia potenzialmente capace di modifi care lo statuto di oggetti che, da monumenti e artefatti morti destinati a musei, o a parchi a tema ispirati alla storia, divengono invece resti di una vita nativa attuale e pratiche attive palestinesi per una ecologia umana sostenibile [5].
Note
[1] Si veda K.W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History, Routledge, London 1996.
[2] Citato in Nadia Abu el-Haj, Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society, University of Chicago Press, Chicago 2002, p. 48.
[3] Ivi, p. 74.
[4] Si veda in questo contesto, G. Bowersock, Palestine: Ancient History and Modern Politics, in E.W. Said e C. Hitchens (a cura di), Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, Verso, London-New York 1987. Stranamente, questo studio non viene menzionato da Abu el-Haj, che è in altri casi estremamente esaustiva nella sua ricerca.
[5] Si veda anche la drammatica storia raccontata in E. Fox, Palestine Twilight: The Murder of Dr. Albert Glock and the Archaeology of the Holy Land, Harper Collins, London 2001.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Per la pace e il dialogo, quello vero ...
 ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una riflessione di Freud (1930).
ISRAELE E PALESTINA ... la Terra promessa. Una riflessione di Freud (1930).FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” - Tikkun. Il dono che salverà Gaza (di Yaniv Iczkovits)15 giugno 2018, di Federico La Sala
Israele-Palestina
Il dono del tikkun che salverà Gaza
Il tikkun (riparazione) di un uomo è la catastrofe di un altro e ancora oggi non si è trovata la riparazione per questa parte del mondo
di Yaniv Iczkovits (Corriere della Sera, 14.06.2018)
Mio nonno, Moshe Iczkovits, non era registrato nelle liste dei tedeschi, eppure salì su un trasporto diretto ad Auschwitz. Salì sul treno della morte per seguire la sua amata, senza poter immaginare quale sorte li aspettava. All’arrivo mio nonno era destinato a morire, ma un medico del campo di Auschwitz ebbe pietà di lui e modificò il numero che aveva sul braccio. Fu così che mio nonno si salvò e fu spedito in un campo di lavoro. Dopo la guerra, quando tornò alla cittadina dov’era cresciuto, si rese conto di non poter restare oltre nella terra dove era nato.
Il suo Paese l’aveva tradito. Israele rappresentò il suo tikkun, la sua riparazione. Quando nacqui all’ospedale Soroka di Beersheva, negli anni Settanta, insieme a me erano nati altri bambini, arabi, figli di persone del posto, a cui il nonno raccontò una storia del tutto diversa. Vivevano in paesi e città della Palestina, finché un giorno scoppiò la guerra e furono costretti ad abbandonare le loro case. Alcuni raccontano di essere scappati per paura, altri che gli ebrei li cacciarono dalle loro abitazioni.
Comunque sia andata, il giusto tikkun ottenuto dagli ebrei con la fondazione dello Stato di Israele significò la catastrofe per molti figli di questa terra. Il tikkun di un uomo è la catastrofe di un altro e ancora oggi non si è trovata la riparazione per questa parte del mondo. Noi israeliani abbiamo imparato a convivere con il conflitto come si convive con un tumore. Periodicamente ricominciamo l’ennesimo aggressivo ciclo di sedute di chemioterapia, da terra o dall’aria, ma ogni volta il tumore colpisce un’altra parte del corpo. Un tempo c’erano infiltrazioni dalla Striscia di Gaza, e abbiamo costruito le recinzioni. Poi è stata la volta dei missili Qassam, e ci siamo riparati sotto una Cupola di Ferro. Dopodiché hanno scavato i tunnel e noi abbiamo levato una barriera.
Adesso è la volta degli aquiloni che incendiano i nostri campi. Forse inventeremo il frumento che non brucia. Chi lo sa come andrà a finire. Per quanto noi possiamo inventare e perfezionare, nessun tikkun arriverà. Le due parti sono troppo occupate a fare paragoni e discutere di chi ha sofferto di più e a quali privilegi questo gli dà diritto.
Nel corso degli anni, i politici hanno tentato di disegnare mappe, definire linee di confine e firmare accordi parziali. Nessuno si occupa più di ciò che costituisce il cuore del conflitto: il dolore dei due popoli. Si tratta di un ottimo esempio di completo fraintendimento del concetto di tikkun: questa terra non richiede mappe, bensì una consapevolezza condivisa. Non un coinvolgimento internazionale, ma fiducia. Non unilateralità, collaborazione.
 L’ultimo romanzo che ho scritto («Tikkun o la vendetta di Mende Speismann per mano della sorella Fanny») viene a rammentarci che il tikkun nell’anima di un uomo, o nello spirito di un popolo, non può avvenire se non si rovista nelle ferite. Il tikkun richiede di superare i confini, di uscire dalla zona di comfort. Ci costringe a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Ci obbliga a riconoscere quello che abbiamo sempre cercato di dimenticare. Ci invita a raccontarci una storia diversa da quella a cui siamo abituati.
L’ultimo romanzo che ho scritto («Tikkun o la vendetta di Mende Speismann per mano della sorella Fanny») viene a rammentarci che il tikkun nell’anima di un uomo, o nello spirito di un popolo, non può avvenire se non si rovista nelle ferite. Il tikkun richiede di superare i confini, di uscire dalla zona di comfort. Ci costringe a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Ci obbliga a riconoscere quello che abbiamo sempre cercato di dimenticare. Ci invita a raccontarci una storia diversa da quella a cui siamo abituati.È questa la grande forza della letteratura. Mentre la realtà produce giustificazioni e spiegazioni su quanto avvenuto, su cosa bisogna fare e come bisogna reagire, la letteratura esige attenzione. La realtà ci incanala subito verso la nostra visione, la letteratura impone di cancellare i confini. Mi ricordo un giorno, ero impegnato come riservista nella Striscia di Gaza e mi trovavo a un posto di blocco a osservare «i miei nemici» attraverso un binocolo. D’un tratto nel cortile di una delle case ho visto un papà di Gaza giocare a calcio con i figli e le figlie.
Ricordo di essere rimasto stupefatto di fronte a quel quadretto così banale. I miei occhi non erano avvezzi a scene simili. Le mie orecchie non erano abituate a udire scoppi di risa dall’altra parte. Sono rimasto a fissare per ore quella famiglia che nemmeno sapeva di essere osservata, come se si trattasse di un miracolo. È questo che succede quando le persone sono rinchiuse nei loro confini. La comprensione basilare, naturale, dell’umanità dell’altra parte, diventa quasi impossibile. Ecco, oggi sia da parte degli israeliani sia da parte dei palestinesi non avvengono molti miracoli, e le barriere si fanno sempre più alte.
Eppure alla base di tutto, volendo essere ottimisti per un momento, sia nella storia israeliana sia nella storia palestinese ci sono dolore e giustizia. Le storie sono lì, aspettano qualcuno che faccia il primo passo e attraversi il confine.
 Per quanto la soluzione del conflitto sembri impossibile da un punto di vista diplomatico e storico, per quanto la sicurezza paia irraggiungibile.
Alla fine due persone, un palestinese e un israeliano, si troveranno una di fronte all’altra, alzeranno gli occhi dalle mappe, si guarderanno negli occhi e diranno: noi vogliamo la riparazione, vogliamo il tikkun.
Per quanto la soluzione del conflitto sembri impossibile da un punto di vista diplomatico e storico, per quanto la sicurezza paia irraggiungibile.
Alla fine due persone, un palestinese e un israeliano, si troveranno una di fronte all’altra, alzeranno gli occhi dalle mappe, si guarderanno negli occhi e diranno: noi vogliamo la riparazione, vogliamo il tikkun.
 (Traduzione di Raffaella Scardi)
(Traduzione di Raffaella Scardi)
Sul tema, nel sito, si cfr.:- Palestina, Israele e la rinascita della lingua ebraica.... ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?”
Walter Benjamin e il futuro ... “È fatto divieto agli ebrei di concedere a Hitler vittorie postume” (Emil Fackenheim, 1970). "Tiqqun. Riparare il mondo" (Emil Fackenheim, 1982).
Federico La Sala
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. -- Gerusalemme Ovest capitale di Israele e Gerusalemme Est capitale della Palestina. Appello di Daniel Barenboim.21 dicembre 2017, di Federico La Sala
L’appello
Israele e Palestina due stati con pari diritti
di Daniel Barenboim (Corriere della Sera, 21.12.2017)
La decisione del governo americano di trasferire l’ambasciata Usa a Gerusalemme, riconoscendola di fatto come capitale di Israele, è l’ultimo di una serie di gravi interventi geopolitici nel conflitto israelo-palestinese. La decisione evidenzia come ogni iniziativa esterna tenda a favorire una delle due parti in conflitto e a demoralizzare l’altra, generando euforia da un lato e violenza dall’altro. Senza una contrapposizione risoluta e compatta a questa recente decisione, la soluzione del conflitto si allontanerà ulteriormente.
La nuova esplosione di violenza seguita alla mossa statunitense e le reazioni internazionali ribadiscono la necessità di esaminare alcuni aspetti del conflitto. Ormai da vari decenni il mondo parla della possibilità di una soluzione a due Stati. Occorre però chiedersi: dov’è il secondo Stato?
Questo aspetto è particolarmente importante in quanto il conflitto israelo-palestinese è diverso dalle centinaia di conflitti della storia dell’umanità. Le ostilità si scatenano in genere tra due nazioni o tra due gruppi etnici che si contendono risorse come l’acqua o il petrolio. Invece il conflitto israelo-palestinese non riguarda due nazioni o Stati, ma due popoli profondamente convinti di aver diritto allo stesso piccolo pezzo di terra, sul quale vogliono vivere, preferibilmente senza l’altro. Ecco perché questo scontro non si può risolvere né sul piano militare né su quello meramente politico: occorre trovare una soluzione umana.
I fatti sono noti, non è necessario riportarne il dettaglio. La risoluzione del 1947 di dividere la Palestina ha incontrato il netto rifiuto da parte della totalità del mondo arabo. Forse questa decisione o la reazione conseguente sono state un errore, comunque dal punto di vista palestinese è stata una catastrofe. Ma la decisione era presa e tutti hanno dovuto imparare a fare i conti con i suoi effetti. I Palestinesi hanno da tempo rinunciato al loro diritto all’intero territorio della Palestina, dichiarandosi a favore di una divisione del Paese mentre Israele continua la pratica illegale degli insediamenti nei territori, mostrando scarsa disponibilità a imitare i Palestinesi. Alcuni aspetti del conflitto sono in una certa misura simmetrici. Altri sono invece asimmetrici. Israele è già uno Stato, uno Stato molto forte e deve quindi assumersi una parte maggiore di responsabilità.
Nessuno oggi mette seriamente in dubbio il diritto di Israele di esistere. Tuttavia, sulla questione israeliana il mondo è diviso. Da un lato esistono nazioni che si sentono responsabili per gli orrori inflitti dall’Europa agli ebrei e non si può che essere grati per il perdurare di questo senso di responsabilità. Purtroppo dall’altro lato esistono tuttora persone che negano l’Olocausto, fatto che alimenta alcune posizioni estreme nel mondo arabo e suscita giustamente disperazione tra la popolazione ebraica di Israele. Ciò nondimeno, malgrado tutte le giustificate critiche all’ostilità palestinese nei confronti di Israele, non si può considerarla una continuazione dell’antisemitismo europeo.
Di fronte alla decisione unilaterale degli Usa, faccio un appello al resto del mondo: riconoscete lo Stato della Palestina come avete riconosciuto Israele. Non ci si può attendere che due popoli - nemmeno due persone - che non si riconoscono reciprocamente trovino un compromesso. Per una soluzione a due Stati servono appunto due Stati che al momento non ci sono.
La Palestina è occupata da 50 anni e non ci si può certo aspettare che i Palestinesi entrino in trattativa da questa posizione. Tutte le nazioni sinceramente interessate a una soluzione a due Stati devono riconoscere la Palestina e pretendere che venga immediatamente avviato un dialogo serio. Una soluzione a due Stati con pari diritti sarebbe la sola strada verso la giustizia per i Palestinesi e la sicurezza per Israele.
Per quanto concerne Gerusalemme, la soluzione mi sembra logica: Gerusalemme è una città santa per l’ebraismo come lo è per l’islamismo e per il cristianesimo. Nell’ambito di una soluzione a due Stati alla pari non vedo alcun problema nel considerare Gerusalemme Ovest capitale di Israele e Gerusalemme Est capitale della Palestina.
Lancio quindi un appello alle grandi nazioni che non l’hanno ancora fatto affinché riconoscano subito la Palestina, con l’impegno ad avviare immediatamente i negoziati sui confini e sugli altri aspetti essenziali del conflitto. Non sarebbe un passo contro Israele, ma un passo in direzione di una soluzione sostenibile per entrambe le parti.
È assolutamente chiaro che la volontà di pace di entrambi i popoli, Israeliani e Palestinesi, deve partire dagli stessi presupposti. Non si può forzare una soluzione dall’esterno.
Quindi mi spingo oltre con il mio appello e invito i popoli di Israele e della Palestina a dichiarare in modo netto e chiaro che non ne possono più di questo conflitto decennale e che vogliono finalmente la pace. -(traduzione di Maria Franca Elegante)
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate --- Gerusalemme può divenire modello extrastatale e banco di prova di future lungimiranti relazioni fra i popoli.11 dicembre 2017, di Federico La Sala
PER LA PACE PERPETUA... *
Gerusalemme, città unica, indivisibile e inappropriabile
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, 11.12.2017)
Unica, indivisibile, inappropriabile, impossibile da capitalizzare, Gerusalemme è la città che si sottrae all’ordine degli Stati-nazione. Ne eccede la ripartizione, la trascende, la interdice. Contro questo scoglio, o meglio, contro questa rocca, sono naufragati tutti i tentativi che, in un’ottica statocentrica e nazionale, hanno mirato solo a frazionarla e segmentarla. Smacco della diplomazia e, ancor più, fallimento di una politica che procede con il metro e con il calcolo.
Gerusalemme non divide; al contrario, unisce. Ed è proprio questa unità la sfida che non è stata raccolta. Perché già da tempo avrebbe dovuto essere immaginata una nuova forma politica di governo capace di rispondere alla sovranità verticale di questa città straordinaria, di rispondere alla sua costitutiva apertura orizzontale.
Qui sta il punto della questione, ma nulla di ciò è avvenuto. Piuttosto si è fatta valere l’ipotesi, oramai sempre più lontana, di due Stati separati da confini incerti, precari, minacciosi.
Non sarebbe stata, non è, anzi, più saggia, seppure inedita, la via di due comunità confederate? Sono oramai molti a crederlo.
Città degli stranieri, culla dei monoteismi, residenza dell’Altro sulla terra, anche per i laici, Gerusalemme è quel luogo dell’ospitalità che resiste a una forzata e artificiosa spartizione.
Yerushalaim, capitale di Israele - chi potrebbe non riconoscerlo? - ma anche soglia che Israele è chiamato a oltrepassare. Come ha già fatto - è bene ricordarlo - con la libertà di culto. Ogni rivendicazione nazionalistica, da ambo le parti, è fuori luogo.
Qui dove si richiederebbero mitezza, prudenza, perspicacia, l’atto arrogante e fragoroso del trumpismo danneggia sia israeliani sia palestinesi. E tuttavia, proprio perché è lo scoglio teologico contro cui urta la politica, Gerusalemme può divenire modello extrastatale e banco di prova di future lungimiranti relazioni fra i popoli.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. Memoria -- Discorso di Trump: ’Gerusalemme capitale di Israele. Scelta necessaria per la pace’. Dure reazioni.6 dicembre 2017, di Federico La Sala
Trump: ’Gerusalemme capitale di Israele. Scelta necessaria per la pace’
’Nuovo approccio su questione israelo-palestinese’. ’Impegno Usa per facilitare processo pace in Mo’
di Redazione ANSA *
NEW YORK. Donald Trump tira dritto e dichiara Gerusalemme capitale di Israele. La conferma della sua decisione provoca la dure reazioni internazionali, dalla Francia (con Macron che la definisce ’deplorevole’) all’Onu ma anche quella pesante di Hamas afferma che in questo modo il presidente Usa "ha aperto le porte dell’inferno".
A Gaza dal pomeriggio sono in corso cortei di protesta. Il presidente palestinese Abu Mazen ha detto di aver ordinato alla delegazione diplomatica palestinese di lasciare Washington e di rientrare in patria. ’’Gerusalemme - ha insistito - e’ la capitale eterna dello Stato di Palestina’’. Il presidente palestinese ha anche accusato Trump di aver offerto un premio immeritato ad Israele ’’che pure infrange tutti gli accordi’’.
"Gerusalemme capitale e’ il riconoscimento della realta’. Ho dato istruzioni di muovere l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme", ha detto il presidente americano Donald Trump.
- IL DISCORSO DI TRUMP
"E’ il momento - ha detto il presidente Usa - di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele’’. "Non si può continuare con formule fallimentari. La scelta di oggi su Gerusalemme è necessaria per la pace".
’Gerusalemme deve restare aperta a cristiani, musulmani ed ebrei’, ha aggiunto. "La pace in Medio Oriente - ha detto in un altro passaggio - è necessaria per espellere il radicalismo".
"Faro’ tutto cio’ che e’ in mio potere per un accordo di pace israelo-palestinese che sia accettabile per entrambe le parti. E gli Stati Uniti continuano a sostenere la soluzione dei due Stati".
"Non possiamo risolvere la questione mediorientale con il vecchio approccio, ne serve uno nuovo".
"Dio benedica gli israeliani, Dio benedica i palestinesi": cosi’ il presidente americano Donald Trump ha chiuso il breve discorso sul riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele, durato circa cinque minuti.
Il vice presidente americano, Mike Pence, ha annunciato Trump, sara’ nei prossimi giorni in Medio Oriente. Il viaggio segue il riconoscimento di Trump di Gerusalemme come capitale di Israele.
LE REAZIONI - "La decisione di Trump è un passo importante verso la pace, perche’ non ci può essere alcuna pace che non includa Gerusalemme come capitale di Israele", ha detto il premier Benyamin Netanyahu che ha aggiunto: "Voglio anche che sia chiaro che non ci sarà alcun cambiamento nello status quo dei Luoghi Santi. Israele assicurerà sempre libertà di culto a ebrei, cristiani e musulmani". "Una pietra miliare", "una decisione storica": così il premier Benyamin Netanyahu ha definito la scelta del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. "Un atto giusto e coraggioso", ha aggiunto Netanyahu.
’’La decisione odierna di Trump equivale ad una rinuncia da parte degli Stati del ruolo di mediatori di pace’’, dice il presidente palestinese Abu Mazen in un discorso alla Nazione. Secondo Abu Mazen il discorso di Trump e’ in contrasto con le risoluzioni internazionali su Gerusalemme.
"Solo realizzando la visione di due stati che convivono in pace e sicurezza, con Gerusalemme capitale di Israele e della Palestina, tutte le questioni sullo status saranno risolte in via definitiva attraverso negoziati, e le legittime aspirazioni di entrambi i popoli saranno raggiunte": lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, commentando la decisione di Donald Trump. "Dal mio primo giorno qui - ha aggiunto - mi sono costantemente dichiarato contrario ad ogni misura unilaterale che metta a repentaglio la prospettiva della pace".
La Francia "non approva" la "deplorevole" decisione del presidente Usa Donald Trump su Gerusalemme: lo dice il presidente francese Emmanuel Macron invitando alla calma. Macron è attualmente impegnato in una tournée diplomatica in Algeria e Qatar.
"L’Egitto denuncia la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme quale capitale di Israele e respinge ogni effetto di questa decisione". Lo scrive l’agenzia Mena sintetizzando un comunicato del ministero degli Esteri del Cairo.
"Condanniamo la dichiarazione irresponsabile dell’amministrazione Usa di riconoscere Gerusalemme come la capitale di Israele" che "avrà effetti negativi sulla pace e la stabilità nella regione". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri turco, Ahmet Cavusoglu, pubblicando una nota in cui si chiede all’amministrazione americana "di riconsiderare questa decisione sbagliata".
La decisione di Donald Trump su Gerusalemme "aiuterà le organizzazioni estremistiche a intraprendere una guerra di religione che danneggerà l’intera regione che attraversa momenti critici, e ci trascinerà dentro guerre senza fine". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen in un discorso tv, ripreso dalla Cnn. "Abbiamo sempre messo in guardia da questo", ha aggiunto.
Il presidente palestinese Abu Mazen ha detto di aver ordinato alla delegazione diplomatica palestinese di lasciare Washington e di rientrare in patria. ’’Gerusalemme - ha insistito - e’ la capitale eterna dello Stato di Palestina’’. Il presidente palestinese ha anche accusato Trump di aver offerto un premio immeritato ad Israele ’’che pure infrange tutti gli accordi’’.
"L’Egitto denuncia la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme quale capitale di Israele e respinge ogni effetto di questa decisione". Lo scrive l’agenzia Mena sintetizzando un comunicato del ministero degli Esteri del Cairo
* ANSA, 06 dicembre 2017 (ripresa parziale).
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. “Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” -- Gerusalemme! Gerusalemme! Guai a toccare la Città Santa per tre fedi. La mossa del cavallo di Donald Trump implica parecchie incognite.6 dicembre 2017, di Federico La Sala
The Donald, la gaffe che può incendiare tutto il Medio Oriente
Guai a toccare la Città Santa per tre fedi. Washington vuole un blocco con sauditi e Israele opposto all’asse Russia-Iran, ma anche gli alleati sono perplessi
di Leonardo Coen (Il Fatto, 06.12.2017)
Gerusalemme! Gerusalemme! La mossa del cavallo di Donald Trump implica parecchie incognite: trasferire l’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, significa indirettamente riconoscerla come capitale d’Israele, il che è inaccettabile, secondo il punto di vista dei palestinesi, per i quali la Città Santa (per gli ebrei, per i musulmani e per i cristiani) è un territorio occupato, e comunque se mai si arriverà a stabilire il principio dei “due popoli due stati”, ecco, pure i palestinesi a loro volta rivendicano Gerusalemme, o almeno una sua parte, quale futura capitale della Palestina.
Inoltre, non si possono trascurare le conseguenze a livello internazionale: la maggior parte dei Paesi membri dell’Onu e delle organizzazioni internazionali non riconosce - e questo sia a livello giuridico che sul piano politico - l’annessione di Gerusalemme Est da parte di Israele, tantomeno come capitale di Stato. Insomma, Trump sta scardinando equilibri delicatissimi e una complessità d’intrecci religiosi, politici, sociali che hanno attraversato la storia per secoli e secoli e devastato questa Terra Promessa che ha solo mantenuto promesse di sangue e di odio, purtroppo. Trump è consapevole di aver sollevato il sipario su di uno scenario drammatico e tragico?
La clamorosa e diciamo pure provocatoria iniziativa del presidente statunitense vuole compiacere l’alleato Netanyahu, il leader di destra che guida Israele, ma non è poi così sicuro che la dirigenza israeliana abbia apprezzato la pericolosa decisione della Casa Bianca, in un momento assai delicato come quello che sta attraversando oggi il Medio Oriente.
Si sta infatti disegnando una sorta di inedito asse tra Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele, contrapposto all’alleanza tra Mosca, Ankara e Teheran. Nemmeno il tempo di aver sconfitto il Califfato, che subito si sono riaccesi conflitti che parevano assopiti. L’Arabia Saudita contende ormai all’Iran la leadership regionale, il Libano è di nuovo preda di tensioni tra le varie fazioni e gli Hezbollah foraggiati da Teheran, nel Golfo Persico si è sta consumando una sorta di guerra fredda fra Qatar filo Iran e Emirati Arabi Uniti sostenuti da Ryad. Enfatizzare lo spostamento dell’ambasciata è come dar fuoco alle polveri: potrebbe scatenarsi una nuova Intifada. Gerusalemme è un simbolo da sempre.
Da quando Elena, la madre dell’imperatore Costantino, ne capì la profonda importanza, il significato politico non poteva prescindere da quello religioso e su questo crinale si acuì il conflitto tra Occidente e Oriente, e anche la questione ebraica, la diaspora, il mito dell’eterno ritorno, il rimpallo delle responsabilità del cristianesimo e dell’Islam.
Persino la stampa israeliana ha evocato le possibili derive collaterali della scelta di Trump. Il quale, non a caso, si è preoccupato di telefonare ieri ad Abu Mazen, presidente dell’Autorità palestinese, per informarlo sulle sue intenzioni. Mahmoud Abbas (Abu Mazen) gli ha risposto mettendolo in guardia, così ha dichiarato il portavoce palestinese Nabil Abu Rdainah, perché una simile decisione potrebbe avere “pericolose conseguenze sul processo di pace e sulla sicurezza e stabilità nella regione e del mondo”.
Inquietudine che si ritrova nelle parole di Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco: “Lo status di Gerusalemme rappresenta la linea rossa per i musulmani”, non escludendo così una possibile rottura diplomatica con Israele. Parole minacciose che hanno indotto Trump ad annunciare, ma non ad attuare. Ha insomma tastato il terreno. Parlandone con Macron, il presidente francese che ha subito messo i paletti: “La questione dello status di Gerusalemme deve avere una soluzione, ma nell’ambito dei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi”. Perché, come ha spiegato ieri Ahmed Abul Gheit, segretario generale della Lega araba, l’evenienza prospettata da Trump non solo può essere considerata “pericolosa” ma “avrebbe ripercussioni in tutta la regione araba e islamica”. Ennesima gaffe dell’improvvido Trump.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. -- Theodor Herzl, il sogno diventato start-up. Nell’agosto 1897 si riunì a Basilea il Primo Congresso Sionista (di lea Luzzati).25 agosto 2017, di Federico La Sala
EBRAISMO E DEMOCRAZIA. PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO... *
Theodor Herzl, il sogno diventato start-up
Nell’agosto 1897 si riunì a Basilea il Primo Congresso Sionista. Ispirandosi al Risorgimento italiano, il suo animatore guardava alle radici bibliche per forgiare l’ebreo nuovo, non più disposto a subire violenze e disprezzo
di Lea Luzzati (La Stampa, 25.08.2017)
«Se lo volete non sarà un sogno» è la frase che ne disegna la storia: una proposizione ipotetica che in principio aveva tutti i connotati dell’utopia assurda, ma che a poco a poco prese corpo, sostanza, realtà. «Se lo volete non sarà un sogno», disse Theodor Herzl in occasione del Primo Congresso Sionista, 120 anni fa, nella quieta Basilea, e lo ripeté sino alla fine della sua breve vita.
Nato a Budapest in una famiglia ebraica assimilata e profondamente acculturata, il fondatore del movimento risorgimentale ebraico si ritrovò giovane corrispondente per la Neue Freie Presse a Parigi, nella tempesta dell’infame processo Dreyfus che, se condannò il povero e fedele ufficiale francese all’esilio, regalò invece a lui una disincantata folgorazione: l’antisemitismo è inguaribile e si radica anche nelle società evolute, a dispetto dei Lumi e dei diritti civili quasi universalmente riconosciuti. Per gli ebrei l’unica soluzione di sopravvivenza e dignità è la conquista di una «completezza» nazionale e di una autonomia politica. Il ritorno a una patria. I figli d’Israele dovevano diventare «un popolo come gli altri», riavere tutto ciò che definisce una nazione: terra, bandiera, autodeterminazione.
A questo obiettivo Herzl dedicò il resto della propria vita - ma morì a soli 44 anni, nel 1904, senza fare in tempo a vedere nella Shoah la più drammatica conferma del suo pessimismo e nella nascita dello Stato d’Israele, dove dal 1950 riposano le sue spoglie, la realizzazione di quello che non rimase un sogno.
Tempi di pogrom
Cento e venti anni fa a Basilea il movimento sionista si riunì con l’obiettivo di dare una autonomia politica e civile al popolo ebraico disperso ai quattro angoli del mondo e vittima in quegli anni di sfoghi di violenza e persecuzioni: i pogrom che imperversavano nell’impero zarista mietevano vittime e costringevano alla fuga migliaia di anime.
Come bene esempla il titolo del libro di Herzl che teorizza seppure in forma narrativa la nascita del futuro Stato - Altneuland, «nuova vecchia terra» - il sionismo guardava al passato remoto, tornava alle radici bibliche della storia, a quando gli israeliti avevano un regno sulla propria terra. Ma per contro aveva come obiettivo quello di forgiare un ebreo nuovo, non più disposto a chinare la testa passivamente davanti alla catena di avversità, odio e disprezzo che avevano segnato gli ultimi duemila anni. Un ebreo nuovo capace di riprendere - in primo luogo fisicamente con il lavoro manuale - il contatto con la terra.
E in fondo tutta la storia del sionismo, che prende il nome da una collina di Gerusalemme, Sion, evocata con nostalgia dagli esuli della prima Diaspora deportati in Babilonia, è un cammino sul filo in equilibrio tra passato e futuro.
Da Theodor Herzl, che aveva nel Risorgimento italiano il suo primo e fondamentale modello politico, a David Ben Gurion, padre della patria che sempre propugnò il cammino verso Sud, verso il deserto del Negev dove secondo lui stavano il futuro del popolo e le risorse materiali e mentali per edificare la storia, tutta l’epopea del sionismo è segnata sia da un richiamo alle radici lontane sia dalla ricerca di un futuro libero, aperto.
Il Primo Congresso Sionista, tenutosi a Basilea dal 29 al 31 agosto 1897, avvia un processo interno ebraico: si creano organizzazioni, si definiscono i lineamenti di una educazione alla rinascita nazionale. Theodor Herzl e gli altri esponenti del movimento si dedicano a una fervida attività politica e diplomatica in cerca di un focolare nazionale per i figli d’Israele. Il sionismo è dunque un insieme di iniziative politiche, culturali ed economiche volte alla rinascita nazionale per il popolo ebraico. È anche e forse soprattutto un insieme di ideali intrinseco all’ebraismo, cui la modernità può dar voce. Nulla di artificiale, anzi: è l’autentico spirito dell’ebraismo che si confronta con la storia.
Lo Stato d’Israele
Cinquant’anni esatti dopo il Primo Congresso Sionista, il 29 novembre 1947, le Nazioni Unite approvano a maggioranza una risoluzione che prevede la creazione di due Stati «palestinesi»: uno ebraico e uno arabo. Nella Palestina sotto mandato britannico c’era infatti da generazioni una società ebraica strutturata, attiva, consapevole: uno Stato di fatto, dotato di istituzioni politiche, sistema educativo, servizi.
Nel maggio del 1948 nasce lo Stato d’Israele. Da allora esso vive il conflitto. Ma ancora una volta, al di là delle questione politiche e fermo restando il diritto dei palestinesi arabi a un’autonomia nazionale, la storia ebraica si è caricata del solito «sovratesto» distorto per colpa del quale «sionismo» è diventato una parolaccia, la definizione di un’ideologia del male, sinonimo di razzismo, come è detto nella risoluzione Onu 3379 del novembre 1975.
Un ideale ancora vivo
Se è vero che dal 1897 in poi, e anche prima, il movimento sionista ha conosciuto diverse espressioni, lo è altrettanto l’evidenza che col razzismo non c’entra per nulla. Da Martin Buber a Zeev Jabotinsky, da Rav Kook a Abraham Yehoshua - e con loro tantissimi intellettuali e uomini di politica - in tutte queste voci il sionismo si configura come un ideale di «normalizzazione» ebraica capace di conservare quel portato umanistico che si trova espresso nella Bibbia e in tutta la tradizione d’Israele.
Lo Stato ebraico esiste da quasi 70 anni, è una realtà costruita su un ideale. Eppure, malgrado abbia raggiunto il suo scopo, l’ideale sionista è ancora vivo. Non solo nel guidare le recenti immigrazioni di ebrei (dalla Russia, dalla Francia, dall’India), non solo nella memoria di quei fondatori sparsi per il Paese (come ad esempio il nucleo italiano di molti kibbutzim storici, da Netzer Sereni a Ruchama), ma anche nel suo essere la più autentica declinazione dell’ebraismo contemporaneo. Nel quotidiano confronto, non sempre liscio ma sempre costruttivo, tra Diaspora e realtà nazionale israeliana. Nel paradosso che fa oggi di questo paese dalle radici ancestrali in cui si parla la stessa lingua dei Profeti e dei Patriarchi la «start-up nation» proiettata verso le più avveniristiche tecnologie. Nel suo essere parte dello scacchiere politico e culturale del presente, con le sue energie intellettuali, con la sua spinta di vita.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
No al SUPERMAN...ismo israeliano
 Il sionismo non è l’ebraismo!!! Lettera a ISRAELE - di Moni Ovadia
Il sionismo non è l’ebraismo!!! Lettera a ISRAELE - di Moni OvadiaFREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. Memoria - "La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati" ( Ahron Bregman).3 luglio 2017, di Federico La Sala
EBRAISMO E DEMOCRAZIA. PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo")
Decostruito il mito di Israele
Guerra dei sei giorni. Sulla base di inedite fonti d’archivio ancora sotto segreto, Ahron Bregman mostra le tappe successive dell’occupazione, nei suoi effetti sui popoli dei Territori: «La vittoria maledetta», da Einaudi
di Massimiliano De Villa (il manifesto, 02.07.2017)
Il mattino del 14 maggio 1967, il primo ministro israeliano Levi Eshkol sta osservando, dalla terrazza del suo ufficio, la sfilata del Giorno dell’Indipendenza quando il generale Yitzhak Rabin gli riporta movimenti sospetti di reparti egiziani che, attraversato il Canale di Suez, sono sbarcati nel Sinai. È solo l’inizio: nel giro di tre settimane, l’Egitto ordina ai caschi blu delle Nazioni Unite di ritirarsi dalla penisola sinaitica, schiera sette divisioni militari lungo il confine con Israele, chiude gli stretti di Tiran, importantissimo passaggio per le navi israeliane, e sigla un accordo di difesa con la Giordania.
Lo schieramento di forze egiziane turba un equilibrio già assai fragile: dalla crisi di Suez del 1956, del resto, il presidente egiziano Nasser, leader popolare di un panarabismo montante, non ha mai smesso di parlare della distruzione di Israele e, nei mesi precedenti il giugno 1967, la sua propaganda anti-israeliana si è fatta più virulenta. I nemici sionisti - va ripetendo Nasser con retorica pettoruta, mentre gli altri capi di stato arabi gli fanno variamente eco - devono essere cancellati e ributtati in mare. Per gli israeliani, spaventati dal riproporsi di recenti spettri, la chiusura degli stretti è il casus belli: di qui l’attacco, improvviso e rapidissimo.
Nel giro di sei giorni, dal 5 al 10 giugno 1967, le Forze di difesa israeliane sbaragliano tre fronti, l’egiziano, il giordano e il siriano, irrompendo nei territori arabi e occupando il deserto del Sinai, la Striscia di Gaza, le alture del Golan e la Cisgiordania, compresa la parte orientale della città di Gerusalemme. Per Israele, questa guerra che, con la velocità del fulmine, ne triplica il territorio è una vittoria straordinaria. Un’ondata di fervore messianico dilaga nel paese, gli osservanti parlano di miracolo, i laici non nascondono l’emozione. La terra di Israele è stata restituita ai suoi antichi abitanti, questa è la voce che corre dal deserto del Negev al Mare di Galilea, mentre il mondo sbalordisce alla rapidità e alla potenza dell’apparato militare israeliano. Le operazioni belliche si chiudono in pochi giorni e si apre, in parallelo, la questione, insieme spinosa e delicatissima, dei Territori occupati e degli insediamenti israeliani. Un’occupazione - dicono gli osservatori esterni - che durerà poco e che invece, tolto il Sinai e, solo da qualche anno, la Striscia di Gaza, entra oggi nel suo cinquantesimo anno.
Sono molti i libri che, negli anni e nei mesi scorsi, hanno ripercorso, interpretato, indagato la Guerra dei Sei Giorni nel suo cinquantesimo anniversario. Tra le analisi più acute, quella di Ahron Bregman, inS La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati (Einaudi, traduzione di Maria Lorenza Chiesara, pp. 340, euro 33,00).
Già il titolo rivela il taglio del saggio: quella che da Israele era stata vissuta come una benedizione, il compiersi dell’antica promessa fatta da Dio ai padri e il suggello trionfale dell’impresa sionista, mostrerà, nel giro di poco, il suo vero volto, mutando in modo definitivo la fisionomia medio-orientale e trasformando Israele, agli occhi dell’Occidente, da vittima della storia a paese occupante.
Il saggio di Bregman, israeliano emigrato a Londra durante la prima intifada per esplicito dissenso politico e ora professore di storia militare al King’s College, ha inizio inquadrando il problema da un punto di vista giuridico: quella di Israele nei confronti dei territori conquistati nel 1967 è de iure un’occupazione, condotta in aperta violazione della Convenzione dell’Aja, stipulata a inizio Novecento, e della più tarda e più famosa Convenzione di Ginevra del 1949.
Sulla base di inedite fonti d’archivio israeliane, in parte ancora coperte dal segreto, Bregman dimostra, con coerenza aristotelica e senza mai rinunciare a una narrazione brillante, le tappe successive dell’occupazione nei suoi effetti sulla popolazione dei Territori: la creazione di governi militari israeliani, l’uso dell’esercito per soggiogare gli occupati, la raffica di decreti d’urgenza e di ordinanze militari, l’avvio di una vertiginosa macchina burocratica che disciplinerà, di lì in avanti, ogni centimetro di vita pubblica, dall’accesso agli impieghi all’accesso alla rete idrica e all’elettricità, con estenuanti trafile per ottenere, nel migliore dei casi, un permesso o una licenza. Poi le restrizioni sugli spostamenti, i lunghissimi controlli alle frontiere, gli espropri coatti, la pulizia etnica dei territori conquistati, la distruzione di antichissimi villaggi arabi con i trasferimenti forzati dei loro abitanti in Giordania o in Siria, la costruzione, sul medesimo terreno, di basi militari e insediamenti ebraici, e l’invio di coloni israeliani, spesso ebrei ortodossi, a ripopolarli.
Nella ricostruzione storica, il resoconto cede spesso il passo alle memorie e alle testimonianze di prima mano degli occupati, facendo vibrare la corda del vissuto personale senza inficiare la sobrietà dell’analisi e rivelando anzi alcuni angoli ciechi sui quali non era stata fatta sufficiente luce.
Saldamente ancorato a un criterio cronologico, Bregman passa in rassegna le pratiche e i metodi dell’occupazione israeliana, suddividendo l’esposizione in tre parti: il primo decennio di occupazione - con una sezione per ogni territorio occupato a stagliare, di ognuno, la particolare fisionomia - il secondo decennio che culmina con la prima intifada e, infine, gli ultimi vent’anni con il procedere a singhiozzo degli accordi di pace, l’assassinio di Yitzhak Rabin, la passeggiata di Ariel Sharon sulla spianata delle Moschee e l’innesco della seconda intifada fino alla roadmap della pace e al disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza.
Il fuoco principale della ricostruzione storica, l’occupazione israeliana dei Territori, non impedisce all’autore di seguire altri fili, dalla resistenza palestinese alla guerriglia armata, agli attacchi terroristici contro Israele, dalla leadership di Arafat ai successi elettorali di Hamas.
Di decennio in decennio, con i passi accorti e precisi dell’indagine storiografica, Bregman decostruisce, nelle sue pagine, il mito, diffuso dagli israeliani all’indomani della Guerra dei Sei Giorni, dell’occupazione illuminata. Mai - sostennero infatti fin da subito gli israeliani - un popolo che, come il loro, aveva vissuto sulla pelle la spaventosa esperienza della persecuzione avrebbe replicato il trattamento su altri.
 Eppure - Bregman lo sottolinea fin dalle prime pagine traendo conclusioni amare - «un’occupazione illuminata è una contraddizione in termini, come quella di un triangolo quadrilatero. Nessuna occupazione può essere illuminata.
Eppure - Bregman lo sottolinea fin dalle prime pagine traendo conclusioni amare - «un’occupazione illuminata è una contraddizione in termini, come quella di un triangolo quadrilatero. Nessuna occupazione può essere illuminata.
 I rapporti tra occupante e occupato sono sempre basati su paura e violenza, umiliazione e dolore, sofferenza e oppressione; in quanto sistema di padroni e schiavi, l’occupazione non può che essere un’esperienza negativa per l’occupato. Che Israele - una nazione piena di vita e istruita, terribilmente consapevole dei mali della storia - abbia imboccato la strada dell’occupazione militare è di per sé abbastanza stupefacente».
I rapporti tra occupante e occupato sono sempre basati su paura e violenza, umiliazione e dolore, sofferenza e oppressione; in quanto sistema di padroni e schiavi, l’occupazione non può che essere un’esperienza negativa per l’occupato. Che Israele - una nazione piena di vita e istruita, terribilmente consapevole dei mali della storia - abbia imboccato la strada dell’occupazione militare è di per sé abbastanza stupefacente». -
> ELIEZER BEN-YEHUDA. Memoria --- “Insegno ebraico a Gaza, ora dobbiamo parlarci”. Dalle armi alla cattedra la scommessa di Ahmed Alfaleet (di Fabio Scuto)15 aprile 2016, di Federico La Sala
Dalle armi alla cattedra la scommessa di Ahmed
“Insegno ebraico a Gaza
ora dobbiamo parlarci”
Ha imparato la “lingua del nemico” in carcere dove ha trascorso vent’anni per aver ucciso un israeliano.
Ora ha aperto una scuola nella Striscia.
“Ho cambiato opinione su molte cose dopo aver letto Oz, Grossman, Yehoshua e molti poeti”
di Fabio Scuto (la Repubblica, 06.04.2016)
GAZA CITY. «Tov», bene, dice l’insegnante alla sua classe di studenti di varia età dopo aver spiegato alla lavagna il significato della parola “meayin” (da dove). Una classe di lingua ebraica come un’altra, ma questo non è un posto come un altro. È Gaza, il fazzoletto di terra che ha visto quattro guerre con Israele negli ultimi dieci anni. Da qui partono quasi ogni notte, uno, due razzi verso il sud d’Israele. Tanto per ricordare che la partita, gli islamisti, non la considerano chiusa, ma solo temporaneamente sospesa.
Siamo al sesto piano di un palazzone sulla Talafimi Street, a quattro passi dall’Università Al Quds, che ospita il Nafha Center per lo studio della lingua ebraica. A guidarlo c’è Ahmed Alfaleet, un uomo alto per la statura media dei palestinesi, con gli occhi chiari e mani grandi.
Alfaleet è un ex guerrigliero della Jihad islamica che ha passato vent’anni nelle carceri israeliane di massima sicurezza, venne liberato nel 2011 nell’ambito dello scambio di 1000 prigionieri con il soldati israeliano Gilad Shalit e dopo essere stato scarcerato ha lasciato la lotta armata e raccolto la sfida di diffondere la lingua ebraica a Gaza. È così importante, vista la prossimità territoriale, e pochi arabi la conoscono. Anche a Gaza l’ebraico non è più la lingua del nemico.
Alfaleet, che oggi ha 42 anni e ha messo su famiglia, venne condannato all’ergastolo per l’uccisione di un israeliano nelle vicinanze dell’insediamento di Kfar Darom - che un tempo era al centro della Striscia - e in ventuno anni passati in cella ha conseguito tre lauree - compresa una in Relazioni Internazionali - alla Open University di Israele e un master alla Hebrew University. Racconta del lungo sciopero della fame in cella per ottenere il permesso dall’Israel Prison Service di studiare a distanza all’università israeliana e non presso gli istituti arabi. Ma soprattutto della sua scelta di vita. «Dopo che sono stato rilasciato ho lavorato un po’ come insegnante privato di lingua ebraica, poi con qualche soldo e molti aiuti di parenti ho deciso di aprire questa scuola». Perché? «Come occupante, nemico o semplice vicino, Israele esiste accanto a Gaza. Non possiamo cambiare la Storia».
«In cella», racconta Alfaleet, «c’era molto tempo e ho letto qualunque cosa, libri, giornali, riviste. Poi ho pensato che potevo mettere a frutto questo interesse e immaginare forse anche un altro futuro». «Guardando la tv in cella mi sono reso conto che in Israele sapevano tutto di noi e noi nulla di loro, ho cambiato opinione su molte questioni, dopo aver letto Amos Oz, Avraham Yehoshua, David Grossman e altri poeti e scrittori classici in lingua ebraica: da allora le cose non sono state più le stesse». Lo spiega bene Alfaleet come, lentamente man mano che mentre studiava e leggeva, anche la visione di Israele cambiava. «Oggi mi invitano spesso come esperto di Israele in tv e alla radio qui a Gaza, ma devo stare attento a quello che dico e a come lo dico per non essere bollato come un “cattivo ragazzo” ma per me tutto è cambiato».
I suoi studenti, e finora ne ha avuti oltre 1200, sono giornalisti, medici, farmacisti, avvocati e uomini d’affari che devono comunicare con gli israeliani. Ed è molto soddisfatto dei risultati ottenuti, la maggior parte dei suoi allievi adesso parla un ebraico fluente e chiaro. «Se conosci la lingua non ci sono incomprensioni», dice sorridendo e pensando agli avvocati palestinesi che devono difendere i loro clienti davanti alle Corti israeliane dove tutto è redatto in ebraico o ai farmaci che le Ong mandano nella Striscia e che hanno il bugiardino stampato in ebraico e in russo. Infatti, spiega, «ci sono 4 canali specifici di specializzazione per i professionisti che hanno necessità e vocabolari linguistici diversi».
In passato la gente di Gaza era piuttosto aperta nei confronti degli israeliani, nonostante le guerre. I canali tv israeliani - specie Channel 1 e Channel 10 - erano la stazioni più viste nella Striscia ed era quasi una tradizione ascoltare alle 6 del pomeriggio il bollettino quotidiano in arabo di Radio Israele. Migliaia di lavoratori avevano il permesso di uscire dalla Striscia ed erano una sorta di ponte fra le due comunità.
Tutto è cambiato negli anni 2000 con la seconda intifada e poi l’inesorabile discesa dopo la presa del potere di Hamas e le 4 guerre (2006-2009-2012-2014) che hanno ridotto la Striscia ad una terra maledetta da dove, tutti, vogliono soltanto fuggire. Eyad, è un ragazzo di 22 anni che studia giornalismo alla Al Quds University, dice che sta venendo a lezione per imparare l’ebraico per avere più chance per la sua carriera: «Non si può fare il giornalista a Gaza senza capire e leggere i media israeliani». Ecco, alla scuola di Alfaleet questa chance non costa nemmeno cara. Imparare la lingua del “vicino” costa 250 shekel (50 euro) per 40 ore di lezione e 1200 per 140 ore. E allora “Be-hatzlachah” (Buona fortuna), professor Alfaleet.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. --- IL TALMUD RINASCE DAI ROGHI. Il sapere antico degli ebrei in italiano (Giulio Busi - Paolo Salom)2 aprile 2016, di Federico La Sala
Il Talmud rinasce dai roghi
E’ molto più di una raccolta di norme e interpretazioni della legge ebraica. Un libro dialogico e aperto nel quale neppure Dio può avere l’ultima parola
di Giulio Busi (Il Sole-24 Ore, 27 marzo 2016)
- Talmud babilonese. Trattato Rosh haShanah (Capodanno), curatore Riccardo Shemuel Di Segni, Giuntina, Firenze, pagg. 416, € 40 (in libreria dal 5 aprile)
È il libro più vilipeso, cancellato e bruciato della storia occidentale. Portato al rogo a carrettate, imbrattato d’inchiostro per renderne illeggibili le carte, letteralmente strappato di mano ai suoi lettori. Che il Talmud approdi ora a una traduzione integrale in italiano, con i fondi e l’interessamento dello stato, è una giusta, seppur tardiva riparazione a tanti torti. C’è qualcosa, nell’opera smisurata, imbastita da generazioni di maestri ebrei, che l’ha resa capace di tener testa all’incomprensione e al malanimo. Credo che l’energia che circonda queste migliaia e migliaia di parole, e che le conserva ancor oggi ben vitali, sia il loro carattere corale.
Il Talmud è innanzitutto una raccolta di norme giuridiche, d’interpretazioni e di opinioni sulla legge ebraica. Ma è ancor di più una grande narrazione a infinite voci. Nasce in un’età, quella dei primi secoli dell’era volgare, in cui il popolo d’Israele ha perso la propria autonomia politica. Il Tempio è distrutto, Gerusalemme in mano agli stranieri, l’esilio è destino obbligato e quotidiano. Dalle rovine del passato, e dalla dispersione, non sgorgano opere di singoli, voci intimistiche di sconforto. Non è più il tempo dei profeti biblici, che, coraggiosi e solitari, s’ergevano ad ammonire sovrani o a inveire contro gli errori e le sconsideratezze dei loro correligionari.
A una sciagura collettiva, la società ebraica risponde con un progetto intellettuale altrettanto collettivo. Sono i rabbini, ovvero i maestri della tradizione, a farsi carico dell’impresa. Non sono sacerdoti (il Santuario non funziona più, e il sacrificio è stato sospeso). Non sono dignitari altolocati, spesso appartengono a una classe modesta: fabbri, calzolai, piccoli commercianti. Ma sono assieme, sanno fare gruppo. Si trovano per studiare, per pregare, per discutere, per vedere chi conosca meglio la Bibbia, chi ne capisca di più, chi l’ami d’un amore più devoto.
Dimenticatevi la cultura dei grandi poeti, o degli scrittori altezzosi. Sfogliando le pagine del Talmud entrerete spesso in case dimesse, verrete a sapere di fatti quotidiani, leggerete qualche volta di comari e di pescatori, di sgualdrine e di ladri. Non è forse vero che la legge s’applica a tutti, e che i precetti del Signore valgono per l’intero Israele, senza eccezioni? Per i ricchi e per i poveri, per i pii e per chi è tentato di trasgredirli, i comandamenti, spesso e volentieri. I maestri studiano e studiano, voltano e rivoltano ogni versetto della Scrittura. Se fosse un giardino fiorito, diresti che questi giardinieri troppo zelanti l’hanno messo sotto sopra. Ma la Bibbia, per i rabbini, è come un campo da rendere fertile col lavoro. Più viene dissodato, più le interpretazioni si accumulano l’una sull’altra, migliore sarà il raccolto. E non pensiate che vadano sempre d’amore e d’accordo. Il Talmud è pieno di discussioni, di dispute, e di qualche sonoro diverbio. Perché non si può amare se non ci si appassiona, e la passione scalda.
In una celebre pagina del trattato Bava Mezia, Rabbi Eliezer è talmente convinto di aver ragione, che chiama a proprio testimone una voce celeste. Ed ecco, puntualmente, che la voce dall’alto si mette dalla sua parte. Credete che i colleghi se ne stiano zitti? Nemmeno per sogno. Un altro rabbi, senza scomporsi, ha da ridire persino sul cielo. Da quando la Torah è stata data agli uomini, sostiene, è affar loro capirla e metterla in pratica. Persino Dio deve rimanersene buono: sulla terra, è la maggioranza dei saggi che decide, liberamente, e guai a intromettersi.
Una simile democrazia basata sullo studio, e siffatto orgoglio intellettuale, mansueto sì ma indomito, non potevano passare inosservati. Il Talmud, che è il documento più importante della cultura rabbinica, esprime una consapevole scelta di autonomia. Fonda l’indipendenza giuridica di Israele, poiché unisce la legge biblica alla vita quotidiana dell’esilio. E stabilisce allo stesso tempo il prestigio e la legittimazione dei maestri, che danno voce all’identità del gruppo ebraico.
Per lunghi secoli, la Chiesa ha mal sopportato l’opera, perché l’ha considerata il baluardo della “cocciutaggine” ebraica. In altre parole, se gli ebrei non vogliono convertirsi, se rimangono fedeli alle loro tradizioni, la colpa sarà di questo loro manuale di resistenza. Distrutto il libro, tolto di mezzo l’ostacolo. Ed ecco che fioccano i divieti e le persecuzioni. Dalle bolle del Medioevo e dell’età della Controriforma, è tutto un accanirsi contro il Talmud, considerato blasfemo (conterrebbe passi contro Gesù) o falso o sciocco.
Nella sua bolla Etsi doctoris gentium, pubblicata nel 1415, l’antipapa Benedetto XIII dà voce in maniera inequivocabile alla corrispondenza tra Talmud e autodeterminazione ebraica: «Poiché è manifesto... che la causa prima della cecità giudaica... è una certa dottrina perversa... che fu formulata dopo Gesù e che gli ebrei chiamano Talmud... abbiamo stabilito che nessuno possa presumere di ascoltare, leggere o insegnare tale dottrina».
Confische, censure, roghi, a intervalli regolari il libro ha rischiato l’estinzione. E ogni volta, gli sforzi degli inquisitori sono stati vani. È vero che i manoscritti antichi sono rarissimi, a causa delle persecuzioni, ma è altrettanto certo che il Talmud è come un fiume contro cui si sono costruiti argini e si sono ammassate dighe, senza metterlo mai in secca. Un autore solo lo si poteva cacciare in prigione, e bruciare. Ma cento, mille?
Nel 1553, per volere di Giulio III, si fece un gran falò di copie del Talmud a Campo de’ Fiori, a Roma. Ad andare in cenere furono carte e pergamene, l’opera continuò a circolare. La diaspora era vasta, molto più capiente di una piazza o di una città. D’altronde, anche tra gli intellettuali cristiani del Cinquecento cominciava ad affacciarsi il dubbio che tali metodi non risolvessero poi granché.
«Prima di bruciare un libro», aveva scritto l’umanista tedesco Johannes Reuchlin a difesa del Talmud, «sarebbe meglio leggerlo». Verità indiscutibile, e che metteva a nudo il problema. Invece di distruggerlo per partito preso, perché non provare a capirlo, questo mondo rabbinico?
Nonostante i buoni propositi di alcuni, nessuno aveva tentato finora di portare in italiano tutto il Talmud babilonese, quello approntato nelle antiche terre di Mesopotamia. Il manipolo di esperti guidato da Rav Riccardo Di Segni s’è messo all’opera di buona lena, coadiuvato dal Cnr. Ci vorranno anni, e ci sarà lavoro per molte mani e per molte teste, che è poi il modo migliore di dire, e di fare, Talmud.
Ecco il Talmud in italiano
Il sapere antico degli ebrei
di Paolo Salom (Corriere della Sera, 02.04.2016)
Un’impresa titanica per un’opera titanica che ha superato i millenni, accompagnando le sorti degli ebrei. È la traduzione in italiano, la prima nella storia, del Talmud, il corpus di sapienza, usi, leggi e consuetudini ebraiche compilato in epoche diverse in due luoghi differenti. Testo sacro secondo soltanto alla Bibbia (Torah, in ebraico, ovvero il Pentateuco), il trattato si divide nel Talmud di Gerusalemme, terminato alla fine del IV secolo, e nel Talmud Babilonese, concluso un secolo più tardi. «Noi - dice al “Corriere” rav Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma e presidente del progetto (mentre direttore è la professoressa Clelia Piperno) - abbiamo affrontato la traduzione del solo Talmud Babilonese, il più corposo, completo e studiato: un’impresa titanica, è vero. Ma in passato altri hanno trasferito l’opera in altre lingue, come l’inglese e il tedesco, dunque era possibile farlo anche in italiano».
Il 5 aprile il primo volume di un’opera che, alla fine, si svilupperà in oltre trenta tomi, tutti editi da Giuntina, verrà donato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sede dell’Accademia dei Lincei, a Roma: è il Trattato di Rosh haShanà (Capodanno), 450 pagine comprensive di note, indici e tabelle esplicative. Certo non un libro alla portata di tutti. «Però necessario - puntualizza rav Di Segni - anzi indispensabile, direi, per tutti gli studiosi, non soltanto di area ebraica, interessati ad approfondire la conoscenza di un universo culturale che nel Talmud ha il suo cuore».
Cuore che ha visto le stampe interamente per la prima volta a Venezia, nel 1523, a opera di Daniel Bomberg. E contiene migliaia di frasi che spesso pronunciamo senza saperne l’origine. Come «chi salva una vita, salva il mondo intero»; «la pace è per il mondo quello che il lievito è per la pasta»; «se io non sono per me, chi è per me? E se io sono solo per me stesso, cosa sono? E se non ora, quando?». Originale a fronte, la versione italiana del testo sacro ha avuto la sua genesi in un finanziamento di 5 milioni di euro del ministero dell’Istruzione (Miur) e nella fruttuosa collaborazione tra la presidenza del Consiglio, lo stesso Miur, il Cnr e l’Ucei, l’Unione delle comunità ebraiche italiane.
Cinquanta esperti-traduttori hanno lavorato al volume, che comprende 70 pagine nell’originale del Talmud su un totale di oltre cinquemila. «Il Cnr ci ha fornito un programma che ha consentito di lavorare digitalmente non importa da che luogo, se in Italia o al di là dell’oceano», racconta rav Di Segni. Ne è scaturito un lavoro su carta. «Ma in futuro sarà a disposizione anche una versione digitale dell’opera».
Talmud, in ebraico «studio». È la summa della tradizione orale compilata per preservare caratteristiche e unità di un popolo che, dopo la Diaspora, rischiava di scomparire. Diviso sostanzialmente in Mishnah, insegnamento da ripetere, e Ghemarah, complemento, ovvero commenti vari al testo, nel suo insieme il Talmud è tutt’altro che un testo monolitico, anche se contiene la Halakah, ovvero la «via da seguire»: il codice penale e civile degli ebrei. Piuttosto, qualunque questione affrontata da rabbini e saggi del tempo viene esaminata e risolta attraverso i pareri (anche contrapposti) annotati a margine. In alcuni passi il Talmud sa essere anche oscuro, o ambiguo. Scritto in ebraico e in aramaico, non può certo essere affrontato come si affronta un saggio qualunque.
Nella storia dei rapporti tra cristiani ed ebrei, il Talmud è stato motivo di dispute feroci. Che spesso si concludevano con il rogo pubblico del testo sacro (il primo nel 1244) o con il sequestro dei volumi trovati nei Ghetti. Questo perché frasi estrapolate dal contesto portavano ad accuse di «perfidia» e «blasfemia». Addirittura, siccome in alcuni brani sparsi qua e là («che messi insieme in totale non fanno più di 2 o 3 fogli, un millesimo dell’intera opera», spiega rav Di Segni), si parla di un certo «Yeshu» (Gesù) e di una certa «Miriam» (Maria) - con riferimenti molto dubbi ai personaggi del Vangelo -, nei secoli il Talmud ha subito censure e autocensure, e dunque le edizioni classiche sono state «espurgate» dei delicati riferimenti.
Si parlerà di Yeshu nell’edizione italiana? «La nostra versione terrà conto dei testi originali e degli interventi censori, che anch’essi sono parte della storia - conferma il rabbino capo di Roma -. E lo studioso, o chiunque sarà interessato, troverà tutti i riferimenti o nel testo stesso o nelle note». L’intero lavoro sarà terminato nel giro di qualche anno: al momento i 50 esperti hanno trascritto un quarto del totale, anche se una data certa di «fine lavoro» non è prevedibile, considerata la complessità dell’opera. Ma, come è scritto nel Talmud: «Tu non sei tenuto a finire il lavoro ma non te ne puoi esimere».
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. --- IL TALMUD. Parla Adin Steinsaltz: “Studiarlo è come stare seduti attorno a un tavolo e discutere al presente con Mosè e i profeti”.5 aprile 2016, di Federico La Sala
Se il Talmud non risponde hai sbagliato la domanda
Parla Adin Steinsaltz, il più grande traduttore del testo ebraico che ora esce in italiano
 “Studiarlo è come stare seduti attorno a un tavolo e discutere al presente con
Mosè e i profeti”
“Studiarlo è come stare seduti attorno a un tavolo e discutere al presente con
Mosè e i profeti”di Susanna Nirenstein (la Repubblica, 05.04.2016)
ROMA Arriva direttamente da Tel Aviv al nostro appuntamento romano, piccolo, vestito in modo caotico di nero come gli ebrei ortodossi ashkenaziti, incorniciato dai capelli e la barba bianca disordinati, con una voce sottile, musicale, come abituata al ragionamento continuo tra sé e sé, e tra sé e i massimi sistemi. Il rabbino Adin Steinsaltz, massimo esperto di Talmud nel mondo (ieri un’edizione di “Parole semplici” è uscita a Taiwan e pochi giorni fa in Iran!), il suo traduttore per eccellenza, nonostante i suoi ottanta anni ha sorrisi e sguardi che tradiscono tutta la forza vitale, mentale, incantano. È qui perché deve presentare oggi all’Accademia dei Lincei il volume del Talmud il Trattato di Rosh haShanà tradotto in italiano, il primo dell’intera opera che sarà pubblicata dalla Giuntina, un’impresa mastodontica (le pagine in tutto sono 5422, i trattati 36, gli ordini 6) voluta dal rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, presidente del Comitato in cui sono parte importante anche le istituzioni italiane.
Guarda un foglio dove abbiamo appuntato le nostre domande, e dice subito, ridacchiando, che non è disposto a stare dieci ore insieme a noi. È stanco? «Io non sono mai stanco» risponde. E prende una sua strada, molto personale, un diluvio di parole, per rispondere (estrapoliamo) innanzitutto che il Talmud Babilonese (ce n’è anche uno di Gerusalemme, meno ampio e frequentato) sunteggia la legge ebraica orale (la Mishnà, ovvero il codice normativo trasmesso sul Sinai a Mosè in ebraico ma non per scritto) e il suo commento redatto in aramaico-ebraico, una sintesi delle discussioni dei maestri, i chakhamim, sulla Mishnà stessa, perché il Talmud è l’unico libro sacro al mondo che non solo permette ma incoraggia ogni domanda, ogni dubbio, e accetta, anzi sprona, risposte discordanti, e le riporta pur cercando infine elementi in comune che non sempre arrivano.
Va bene, ma perché tradurlo, non perderemo parte del significato, i riferimenti all’uso della stessa parola in altri testi, o il suo valore numerico? Lei è stato il primo a trasporlo tutto in ebraico, ed è stato anche molto criticato.
«Conosco una bella frase in italiano, “il traduttore è un po’ un traditore”, ed è vero. Ma è alla base del rapporto tra le civiltà. Ogni traduzione perde qualcosa, ma se vuoi trasportarla nel mondo devi rischiare, anche se nel trasmetterla va via un po’ di bellezza, un po’ di sostanza. Rendere così accessibile il Talmud è un atto, un gesto che in qualche modo cambia una tradizione per cui, specie ai tempi della trasmissione orale, lo studio era ristretto a una cerchia limitata, al maestro e ai suoi discepoli. Qualcuno pensa ancora che sia questa la condizione migliore. Ma io no, e non solo io evidentemente. Ho letto una Divina Commedia in ebraico, e sicuramente non era la stessa cosa. È più facile tradurre la fisica, la matematica. Ed è ancor più facile farlo se mettiamo mano a un testo che appartiene alla stessa epoca e alla stessa cultura della lingua in cui lo trasponiamo, che so, un romanzo italiano in un romanzo francese del Novecento. Ma per i libri antichi e per di più provenienti da una tradizione diversa, sono guai. Inoltre il linguaggio del Talmud non era nemmeno allora comune, si tratta di una sorta di gergo tra aramaico e ebraico. Spero che l’italiano usato in questa opera comunque renda l’idea della sua bellezza».
Ma perché in italiano poi, una lingua parlata da pochi milioni di persone, un paese con una comunità ebraica piccolissima? È un testo universale? Cosa ci cercherà un non ebreo?
«Certo sarebbe meglio che uno studiasse la lingua e la cultura ebraica per affrontarlo. Ma chi ha tutto quel tempo? Vede, il Talmud è stato per secoli un grande mistero, la gente era sicura che dentro ci fossero dei segreti oscuri. Spesso lo prendevano e lo davano alle fiamme, dall’antichità giù giù fino ai nazisti, lo distruggevano: pensavano che attraverso quelle pagine gli ebrei mandassero non si sa quali maledizioni o evocassero strani poteri. Era più una leggenda che un fatto. E i miti, i pregiudizi, continuano ancora. In Italia spesso ad esempio si pensa che gli ebrei siano mezzo milione invece dei 35.000 che sono! Noi ora prendiamo la nostra scatola chiusa e l’apriamo: che guardino dentro. Se la Bibbia è la prima pietra del giudaismo, il Talmud ne è il pilastro centrale: leggano, non ci sono arcani. Al massimo potranno dire che siamo pazzi».
Qual è la caratteristica principale del Talmud, invece?
«La sua essenza ha trasmesso al mondo il grande messaggio del pensiero dialettico. E il mondo ne ha un grande bisogno perché traversa un periodo di follia, di estremi. Occorre guardare, capire, porre e porsi molte domande. Tentare di rispondere. Tutto il Talmud è fatto di dibattito e pensiero, su qualsiasi argomento, scienza, uomini, donne, astronomia, economia, agricoltura, persino fecondazione artificiale... ».
Lei ha scritto che nel Talmud ci sono soggetti che è impossibile veder accadere nella realtà, come allora probabilmente era la fecondazione artificiale.
«È un modo meraviglioso per imparare a fare le domande migliori. Su tutto. La scienza ti risponderà sulla differenza tra la luce rossa e la luce blu, ma i veri punti interrogativi riguardano cosa c’è tra un uomo e un altro. La matematica non se ne occupa. Il Talmud dibatte di cosa è fatta la vita. E ogni allievo ebreo apprende come porre non una ma cento questioni, e cerca una risposta. Anche ai quesiti più assurdi, tipo immaginare un oggetto in quarta dimensione, e in quinta e magari in sesta. La teoria fisica delle stringhe molti secoli dopo ne ha parlato».
Un procedere per paradossi?
«No, una visione del mondo, il Talmud è vivo, è capace come un artista di scolpire nel marmo una fontana con l’acqua scrosciante. Penseresti che è impossibile e invece lo è. Studiare il Talmud, è come stare seduti a un tavolo lunghissimo e discutere con Mosè, i profeti, i maggiori maestri, e me, e lei. Al presente».
Il giusto rispetto per il Talmud
di Gavriel Levi (La Stampa, 05.04.2016)
Il Talmud è, in sostanza, la bibbia orale degli ebrei. O meglio: il motore di questa bibbia orale. Stampato, copre una ventina di volumi. Ma la scrittura è un’apparenza, perché le pagine sono tutte parlate.
Come dato storico, il Talmud è, appunto, un testo orale (la mishnà) che, in un periodo di difficoltà, è stato salvato su una pagina scritta e che è stato subito restituito all’oralità, da un’esplosione mirata di tanti testi orali (la ghemarà).
Il Talmud è come il pentagramma che esiste soltanto per essere suonato. Non si può comprendere il Talmud senza partire da questo assunto e senza entrare nella memoria emotiva del discorso orale.
Il discorso talmudico è la somma di tanti dialoghi. Di due persone che, per affrontare il problema pratico di qualcosa da fare, parlano di un testo e lo confrontano con un altro testo e lo interpretano rispetto ad altri dialoghi ed altri testi.
Lo sfondo in cui questo dialogo complesso si muove è costituito da diverse dimensioni conflittuali: il conflitto tra situazioni concrete particolari e principi teorici più o meno generali; il conflitto tra norme religiose e norme etiche; o comunque anche tra diverse norme religiose o tra diverse norme etiche; il conflitto tra la logica umana (sevarah) e la trascrizione del messaggio divino (qabbalah); il conflitto tra le verità che ogni alunno-maestro porta con sé e che si risolve soltanto scoprendo la verità di un altro alunno-maestro.
La discussione talmudica è un grande gioco caleidoscopico. Ogni norma può essere confrontata e pensata rispetto a qualsiasi altra norma. Ogni fatto umano rispetto a qualsiasi altro fatto umano. Qualsiasi norma con qualsiasi fatto. I collegamenti sono stabiliti in base a regole linguistiche ed a regole logiche. Ma l’insieme dimostra una realtà potenziale infinita. Con un filo rosso che costruisce un percorso antropologico, ad intensità religiosa crescente.
Va considerato un altro punto caratteristico. La discussione talmudica è presentata come se tutti quelli che parlano stessero seduti intorno allo stesso tavolo. Ma la gran parte degli interlocutori che sembrano parlare a botta e risposta, non si sono mai neppure incontrati.
Per capirci con un esempio: un dialogo è aperto da un allievo-maestro vissuto nel 350, che pone una domanda rispetto a un altro allievo-maestro vissuto nell’anno 210 (in contraddizione con un’idea espressa nell’anno 180).
Il dibattito sembrerebbe senza sbocco, se non intervenisse una risposta formulata nell’anno 270 da un altro allievo-maestro su un argomento più o meno parallelo...
È evidente che il dialogo talmudico riassume diverse discussioni, cucite secondo un filo logico coerente ma in qualche modo surreale. Insomma: la redazione talmudica utilizza consapevolmente il contrasto che esiste tra la logica del discorso e la sua proiezione cronologica.
È giusto interrogarsi sul senso di questa straordinaria formula. Perché mantenere una sequenza formalmente fuori del tempo? Si poteva benissimo sviluppare, almeno nella scrittura un ragionamento coerente tanto per i passaggi logici quanto per la successione temporale. Perché portare ogni futuro studioso del Talmud in una specie di macchina del tempo, inventata apposta per lui?
La risposta è semplice e non banale. Gli allievi-maestri del Talmud hanno scelto di inventare un monte Sinai umano: se Dio ha parlato una volta sul Sinai e se vogliamo continuare questo dialogo, il Sinai lo dobbiamo costruire noi. Tutti assieme, in una realtà vista all’infinito e quindi fuori dal tempo.
In sintesi: il Talmud è il ribaltamento della rivelazione divina. Quella che, con tutti i limiti dell’essere umano, parte da terra per arrivare al cielo.
Un’ultima annotazione conclusiva: il Talmud è stato trasmesso dai maestri farisei in oltre 600 anni di confronto e durante diverse ondate di persecuzioni. Il Talmud è stato messo al rogo in diverse città d’Europa, nel Medioevo come alle soglie della modernità.
Il pregiudizio antigiudaico che ha portato ai roghi del Talmud esiste ancora. Oggi si esprime con l’uso dei termini farisei, rabbinico e talmudico come sinonimi di formalismo rituale, ipocrisia, aridità morale e peggio.
Forse è giunto il momento di alzare una voce forte e chiara per restituire al Talmud e ai farisei il giusto rispetto.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. - IL TALMUD. Con il trattato sulle “Benedizioni” prosegue la traduzione integrale del testo sacro ebraico: insegna quando pregare e quando studiare di Elena Loewenthal7 dicembre 2017, di Federico La Sala
Talmud, la rivelazione permanente
Con il trattato sulle “Benedizioni” prosegue la traduzione integrale del testo sacro ebraico: insegna quando pregare e quando studiare
di Elena Loewenthal (La Stampa, 07.12.2017)
C’è qualcosa di profondamente paradossale ma non meno congeniale all’ebraismo nel fatto che la tradizione d’Israele chiami «Torah orale» un immenso corpus di testi scritti. Questo suggestivo ossimoro porta con sé l’idea di una sorta di rivelazione permanente che comincia con la chiamata di Abramo - che in ebraico significa «Padre grande» -, prosegue con la dettatura della Legge su al Sinai, s’incammina nella storia del popolo d’Israele con i Profeti e gli Agiografi, e procede in una progressiva discesa ma anche diluizione dell’ispirazione divina che continua peraltro ad animare i detti dei rabbini e il loro inesauribile discutere intorno al testo sacro, cioè la Torah scritta - la Bibbia ebraica.
La Torah she beal peh, «Torah che sta sulla bocca» è fondamentalmente il Talmud, parola ricavata dalla radice ebraica che - in nome di quella straordinaria didattica dello scambio che fa dire a un grande maestro: «Ho imparato soprattutto dai miei discepoli» - significa a un tempo «imparare» e «insegnare»: un immenso verbale di discussioni, commenti, divagazioni e interpretazioni della Bibbia, passo per passo. Non fine a sé stesso, beninteso, bensì parte integrante di un continuo dialogare tra cielo e terra alla ricerca di quegli infiniti significati che la Bibbia contiene ma che non sono palesi.
Giunto alla sua redazione finale intorno al VI secolo, il Talmud è composto da sei ordini e 63 trattati, per un totale di molte migliaia di pagine. Questo testo straordinario (di cui a dire il vero esistono due redazioni, una detta «di Gerusalemme» e una, quella canonica, che viene invece «da Babilonia» perché quello era allora il fulcro della cultura ebraica) è ben più di un dotto commento alla Legge divina, cioè alla Bibbia: è una vera e propria enciclopedia della vita, per quanto disordinata e difficilissima da esplorare, in cui il materiale si delinea - sempre disordinatamente - secondo due categorie: la halakhah, cioè l’insieme di regole, e la haggadah, cioè la narrazione.
In questi giorni esce il secondo volume del monumentale progetto che prevede la prima traduzione italiana integrale di tutti i 63 trattati talmudici, avviato ormai molti anni fa e sostenuto fra gli altri dal Miur e dalla Presidenza del Consiglio (https://www.talmud.it). Si tratta del trattato Berakhot, che vede oggi la luce nella nostra lingua con la prefazione del rabbino Gianfranco Di Segni (in due tomi per i tipi della Giuntina, € 90) e che è forse il più suggestivo, il più ricco di evocazioni di tutto il Talmud.
Berakhot si traduce convenzionalmente con «Benedizioni» ed è uno dei trattati contenuti nell’ordine Zeraim, cioè «sementi» (e dunque tutto ciò che è legato alla vita produttiva dell’uomo e al suo rapporto con la terra, con la materia). Ma nell’universo ebraico la benedizione è qualcosa di difficile se non impossibile traduzione, perché, scrive Di Segni, «non rende bene la ricchezza semantica e concettuale che risuona nel termine ebraico. [...] È il modo più tipicamente ebraico con cui si esprime la fede in Dio Re e Creatore del mondo». L’uomo benedice Dio e Dio benedice l’uomo in una dinamica in cui attivo e passivo si scambiano, l’astratto si fa concreto e viceversa, come quando è il Signore stesso a imporre all’uomo «Benedicimi!».
I primi tre capitoli del trattato si occupano della lettura dello Shema («Ascolta Israele», la professione di fede dell’ebraismo), e delle relative benedizioni; seguono parti dedicate alla preghiera «generica» e a quella che si ha da recitare «in piedi» (Amidah); poi si tratta delle benedizioni per il pasto, i cibi, i fenomeni naturali, i miracoli, la salvezza, i vestiti nuovi..., perché tutto è degno di benedizione. Ma, come scrive il più grande talmudista vivente, Rav Adin Steinsaltz, il tema centrale di queste pagine è la fede stessa attraverso un dialogo a molte voci che coinvolge lo spazio e il tempo del mondo.
Forse più il tempo dello spazio, perché l’ebraismo per millenni ha abitato nel primo molto più che nella geografia reale. E allora uno dei temi centrali del trattato Berakhot è quello di capire quando pregare, quando dedicarsi allo studio: «Come faceva re David a capire quando era mezzanotte? Lui aveva un segno per sapere quando era mezzanotte. C’era un’arpa appesa sopra il letto di David, e quando giungeva la mezzanotte veniva un vento dal Nord e soffiava attraverso l’arpa, e l’arpa suonava da sola.
Immediatamente David si alzava e si occupava di Torah fino al sorgere dell’alba». È proprio così che il Talmud si dipana: interrogando il testo sacro là dove esso tace, cercando ciò che in apparenza manca e che invece sta lì, negli inesauribili spazi bianchi fra le righe, là dove tutto è detto, fuori del tempo e dello spazio.
-
>La "Memoria" di Eliezer Ben-Yehuda ---Muro erotico. Verità nascoste. Gerusalemme Est, soldi a scuole che rinunciano al programma palestinese.30 gennaio 2016, di Federico La Sala
Gerusalemme Est, soldi a scuole che rinunciano al programma palestinese
Israele/Territori occupati. Li offre il ministero dell’istruzione israeliano, ha rivelato il quotidiano Haaretz.
 Diana Buttu: «Israele vorrebbe trasformare i palestinesi in sionisti, convincerli ad abbracciare la narrazione israeliana di quanto è accaduto in questa terra». Sullo sfondo il sistema scolastico palestinese in condizioni critiche
Diana Buttu: «Israele vorrebbe trasformare i palestinesi in sionisti, convincerli ad abbracciare la narrazione israeliana di quanto è accaduto in questa terra». Sullo sfondo il sistema scolastico palestinese in condizioni critichedi Michele Giorgio (il manifesto, 30.01.2015)
GERUSALEMME Nessuno può accusare di scarso impegno il ministro israeliano dell’istruzione Naftali Bennett. Un impegno che però sembra indirizzarsi più verso obiettivi politici che a favore dell’apprendimento degli studenti. Alla fine del 2015 Bennett aveva vietato gli interventi nelle scuole ai rappresentanti di “Breaking the Silence”, l’Ong dei soldati israeliani che rompono il silenzio su crimini commessi nei Territori occupati.
A inizio del nuovo anno ha proibito l’uso nelle scuole superiori del romanzo di Dorit Rabinyan “Borderlife” che racconta la storia d’amore tra una ebrea e un palestinese. Ora, riferiva ieri in prima pagina il quotidiano Haaretz, il ministero dell’istruzione prepara un piano che prevede fondi extra solo per le scuole arabe di Gerusalemme Est che adotteranno il programma israeliano al posto di quello palestinese.
Quando nel 1995 furono firmati gli Accordi di Oslo II, ai palestinesi di Gerusalemme Est, che non sono (tranne una esigua minoranza) cittadini israeliani, fu riconosciuto il diritto di adottare il programma del ministero dell’istruzione della neonata Autorità nazionale palestinese al posto di quello della Giordania.
Delle 180 scuole palestinesi soltanto otto hanno scelto, in questi ultimi venti anni, il programma israeliano e solo due di queste sono istituti pubblici. Un dato che conferma il rifiuto del controllo israeliano della zona araba di Gerusalemme, anche in materia di istruzione, da parte degli oltre 300mila palestinesi nella Città Santa. «Israele vorrebbe trasformare i palestinesi in sionisti, convincerli ad abbracciare la narrazione israeliana di quanto è accaduto in questa terra» spiega al manifesto Diana Buttu, una esperta di diritto internazionale «i palestinesi però intendono rimanere quello che sono e continuare a far parte del mondo arabo». Per questa ragione, aggiunge Buttu, «anche questo tentativo è destinato a non avere successo».
Allo stesso tempo la condizione delle scuole arabe a Gerusalemme Est è grave: il numero degli studenti aumenta con il passare degli anni e non ci sono aule sufficienti. Molte scuole pubbliche operano in edifici spesso fatiscenti che necessitano urgenti lavori di ristrutturazione, scarseggiano attrezzature, computer e materiali didattici. Qualche dirigente scolastico perciò potrebbe essere tentato ad adottare il programma israeliano in cambio dei fondi offerti dal ministero.
«A mio avviso è un ricatto, soldi in cambio di una rinuncia» afferma Diana Buttu «i palestinesi sotto occupazione hanno diritto ai quei fondi senza dover rinunciare alla loro identità, alla loro cultura, al loro programma scolastico in linea con il resto del mondo arabo. Lo dice il diritto internazionale che Israele è chiamato a rispettare. Per questo mi auguro che questo passo del ministero dell’istruzione israeliano venga subito condannato dalle istituzioni internazionali».
Lo sdegno è forte tra i palestinesi di Gerusalemme. Le scuole arabe, affermano, non accetteranno l’offerta del ministero israeliano. Anche perchè i genitori non lo permetterebbero, di fronte a libri di testo e a un programma scolastico che tendono a negare quasi del tutto storia e cultura palestinese.
Nel corso degli anni i governi israeliani si sono spesso lamentati del contenuto dei libri usati nelle scuole palestinesi che non riconoscebbero pienamente lo Stato ebraico e «istigherebbero alla violenza». A loro volta i testi inclusi nel programma israeliano offrono una narrazione totalmente anti-araba, che nega radici e storia dei palestinesi nella loro terra. Lo spiega bene la docente israeliana Nurit Peled Elhanann nel suo libro “La Palestina nei testi scolastici di Israele. Ideologia e propaganda nell’istruzione” (2012, edito in Italia dal Gruppo Abele).
Gli arabi, scrive Peled Elhanann, sono rappresentati come profughi in strade e luoghi senza nome. «Nessuno dei libri», spiega la docente, «contiene fotografie di esseri umani palestinesi e tutti li rappresentano in icone razziste o immagini classificatorie avvilenti come terroristi, rifugiati o contadini primitivi». Raramente si parla di “Palestina” o “Palestinesi” piuttosto si fa riferimento a “non ebrei”, “arabi”, o al “problema palestinese” descritto il più delle volte come un problema demografico.
Secondo il ministero dell’istruzione israeliano i palestinesi da un lato protestano e dall’altro, in numero crescente, intenderebbero seguire il programma scolastico israeliano. Riferisce che l’anno scorso 1400 studenti arabi hanno scelto il “Te’udat Bagrut”, ossia il diploma di maturità israeliano e non quello palestinese (Tawjihi). Quest’anno se ne prevedono 2.200. Ma sono soltanto il 5% dell’intera popolazione scolastica palestinese.
- EBRAISMO E DEMOCRAZIA. PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo"):
Muro erotico
Verità nascoste
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 30.01.2016)
Il presidente della Repubblica ha detto che i settanta anni di pace e di sviluppo in Europa sono fondati anche «nel sangue e nella terra fredda, mista a cenere» dei campi di concentramento tedeschi. L’affermazione del presidente è involontariamente ironica: a minare oggi la credibilità dell’Europa e dell’Occidente, è proprio la soluzione data alla catastrofe etica di cui sono stati espressione i campi di annientamento degli ebrei.
Addossando l’intera responsabilità all’eccezionalità del mostro nazista, come se questo mostro fosse nato dal nulla, senza il fallimento di tutti, ci siamo affidati, di fatto, alla logica della colpa di un popolo, quello tedesco.
Espiata la colpa (nel tempo necessario di una lunga sofferenza), siamo al punto di partenza. L’occidente non ha voluto vedere nello sterminio il risultato di una sua grave difficoltà a costruire un senso d’identità eccentrico al suo centro di gravità, aperto senza possibilità di ritorno alle trasformazioni. È un’impasse storica delle civiltà il misconoscimento della loro co-costituzione con il barbaro, lo straniero.
L’ebraismo è stato storicamente una componente fondante della civiltà occidentale (insieme alla cultura greco-romana, il cristianesimo e l’illuminismo ateo), ma anche la parte che più l’ha estroversa, l’ha spinta verso il decentramento, l’esilio da se stessa. Ha posto un problema -la capacità di desiderare il diverso nel punto in cui più destabilizza la nostra autoreferenzialità - che l’occidente, nel momento più decisivo della sua storia, ha rimosso. Nelle rimozioni trovare una meta appropriata al desiderio è l’ultima delle preoccupazioni. Piuttosto che estrovertirci, riaprendosi all’alterità, abbiamo usato la parte estrovertente di noi per occupare la terra di altri.
Gli ebrei riaccolti nella nostra civiltà sono stati usati come nostra enclave nel mondo musulmano. Mandarli via dalla loro casa (l’Europa), perché tornassero a casa loro, che loro non era (Palestina), è stata la forma paradossale con cui si è estrinsecato il nostro rifiuto di lasciarci attrarre, prendere da un altro luogo/modo di essere e la scelta di trattare la casa altrui come estensione della nostra.
Recentemente, il libro premiato di una scrittrice israeliana, che racconta l’amore tra un’ebrea e un palestinese, è stato escluso dalla lista dei libri adottati dai licei. Secondo il ministero d’istruzione israeliano le relazioni intime tra ebrei e non ebrei potrebbero rappresentare una «minaccia alle identità separate»: «Gli adolescenti tendono a romanticheggiare e non includono nel loro punto di vista considerazioni sulla preservazione dell’identità nazionale e sul significato dell’assimilazione». Nella censura dell’incontro erotico tra ebrei e palestinesi, ciò che preoccupa le autorità israeliane -per loro stessa ammissione - non è tanto una relazione sessuale di per sé, quanto la sua trasformazione in matrimonio, in una compenetrazione stabile che porti a una mescolanza profonda di identità che devono restare separate. Questa censura getta luce sulla vera linea di demarcazione tra il mondo occidentale e il mondo islamico.
Il muro materiale che separa Israele dai territori arabi è la rappresentazione simbolica di una divisione erotica che congela la nostra esistenza.
Lo scambio tra culture diverse e la loro integrazione in uno spazio più ampio, che le trascende, è impossibile senza il desiderio erotico che fa attraversare i confini: l’interdizione dei matrimoni misti è l’indicatore più sicuro della loro incapacità di comunicare.
Chi porta nelle vene tracce di «sangue impuro» (simbolo di amori proibiti) non dorma tranquillo.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. Memoria --- Far passare il Gran Muftì di Gerusalemme come l’ispiratore di Hitler nella strategia di sterminio degli ebrei è un falso colossale. Questo il giudizio che sull’uscita di Netanyahu dà Mauro Canali, storico dell’età contemporanea22 ottobre 2015
Halina Birenbaum
“Scandaloso. Ha stravolto la realtà”
di Francesca Paci (La Stampa, 22.10.2015)
«Non potevo credere alle mie orecchie: dal 1967 vado nelle scuole a raccontare cosa ho vissuto a Auschwitz, ho parlato con migliaia di studenti israeliani e centinaia di tedeschi, faccio incontri in tutta Europa e ora Netanyahu viene a spiegarmi che avevo frainteso le intenzioni di Hitler».
Dire che Halina Birenbaum è arrabbiata è riduttivo. Classe 1929 è cresciuta nel ghetto di Varsavia prima e poi nel più noto dei lager nazisti dove ha perso la famiglia ma non la forza per emigrare nel ’47 in quello che sarebbe diventato Israele: «Se penso al dolore, mamme e figli in fila per essere gasati, la fame, l’umiliazione... e oggi devo ascoltare queste idiozie. Mi chiedo in che mani siamo. Netanyahu vuole scaricare tutto lo sporco sugli arabi, vuole provare che non ci sono chance di dialogo né di pace perché ci odiano da sempre e cavalcare l’antisemitismo che pure esiste. O forse voleva compiacere i tedeschi. Non capisco. Ma è uno scandalo. In questa situazione poi, con le colonie che si moltiplicano e vogliono sempre più terra, gli accoltellamenti, così non finirà mai».
Lo storico Mauro Canali: è un falso clamoroso, l’incontro con Hitler solo nel 1941 ma il leader islamico era antisemita e in sintonia col nazismo
 Corriere della Sera, 22.10.2015
Corriere della Sera, 22.10.2015Far passare il Gran Muftì di Gerusalemme come l’ispiratore di Hitler nella strategia di sterminio degli ebrei è un falso colossale. Questo il giudizio che sull’uscita di Netanyahu dà Mauro Canali, storico dell’età contemporanea che ha studiato a fondo il fascismo e esplorato anche le vicende del Medio Oriente nel periodo fra le due guerre (per esempio con «Mussolini e il petrolio iracheno», Einaudi 2007).
Basta incrociare due date per svelare la bufala: Haj Amin al-Husseini incontra Hitler, dopo una rocambolesca fuga dall’Iraq dove aveva tentato un golpe anti-britannico, nel dicembre 1941, quando la politica di sterminio del popolo ebraico era già avviata; il massacro di Babij Jar, il fossato nei pressi di Kiev dove i soldati nazisti uccisero 33.771 civili ebrei, è della fine di settembre dello stesso anno. Tuttavia, secondo Canali, Netanyahu ha costruito una tesi falsa su dati veri o verosimili: è vero per esempio che in un primo tempo il Führer pensava di confinare gli ebrei in una enclave lontana dall’Europa, ma quando capì che così avrebbe favorito la nascita di una nazione ebraica abbandonò l’idea.
«Il gran Muftì di Gerusalemme, figlio del radicalismo islamico, tra i primi sostenitori dei Fratelli Musulmani, era fautore di un panarabismo che univa una forte politica anti-inglese all’odio contro gli ebrei - dice Canali -. Con il crollo dell’impero ottomano e la nascita dei mandati britannici e francesi, dopo il sogno iniziale di costruire una nazione panaraba, una Grande Siria che comprendeva la Mesopotamia e anche la Terra Santa, al-Husseini circoscrive le sue ambizioni alla Palestina. Il suo principale obiettivo è ostacolare la realizzazione della dichiarazione Balfour del 1917, che favoriva la nascita di un focolaio ebraico in Palestina».
Evaporata l’illusione panaraba, «è evidente che al-Husseini, personaggio centrale nel radicalismo mediorientale fra le due guerre, saluti con favore l’ascesa al potere dell’antisemita Hitler e cerchi alleanze anche con l’Italia». Prima di andare a Berlino, dove incontrerà Ribbentrop e Hitler, il Muftì passa dall’Italia (il ministro degli Esteri Ciano ammetterà di averlo finanziato).
Durante la guerra si spinge a organizzare dei reparti musulmani nei Balcani che si distingueranno nella lotta contro i partigiani di Tito e soprattutto nel massacro degli ebrei bosniaci. Dalla Germania, a conflitto concluso, al-Husseini cercherà rifugio in Svizzera, verrà catturato in Francia e fuggirà in Egitto per nascondersi infine nella citta vecchia di Gerusalemme, dove gli inglesi non riterranno prudente andarlo a scovare.
Il nome del Gran Muftì tornerà infine al processo di Norimberga, tra gli amici di Eichmann, il burocrate della «soluzione finale». Ciò non toglie che al-Husseini sia da iscrivere tra i seguaci, non certo tra gli ispiratori di Hitler.
Lo storico del nazismo Kellerhoff:
“Le prime fantasie di sterminio vennero al Führer già nel 1919”
“Antisemitismo ossessivo”
Il “Mein Kampf” sarà ristampato a gennaio: “Ecco le sue bugie”
di Tonia Mastrobuoni (La Stampa, 22.10.2015)
- Il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, è stato deciso: "Non c’è nessun motivo per cambiare la storia". E ha continuato: "Conosciamo bene l’origine dei fatti ed è giusto che la responsabilità sia sulle spalle dei tedeschi".
All’inizio degli anni Venti, Adolf Hitler era ospite fisso dei salotti di Monaco, dove i ricchi borghesi si divertivano ad ascoltare l’eccentrico austriaco abbaiare i suoi proclami antisemiti. Quando l’attenzione scemava, il tribuno di Braunau schioccava il suo frustino sugli stivali da cavallerizzo, per costringere famiglie come i Bechstein - quelli dei pianoforti - a non perdersi neanche una sillaba delle sue tirate contro gli ebrei «parassiti». I monacensi facoltosi adoravano quello strano politicante che indossava lisi completi blu e che da lì a poco avrebbe organizzato l’inquietante putsch nella capitale bavarese. E il suo odio viscerale, ossessivo per gli ebrei non li disturbava: «l’antisemitismo era molto diffuso, nella borghesia tedesca, ma anche in quella francese o austriaca, in quegli anni» ricorda Sven Felix Kellerhoff.
Un odio antico
Nel 1919, sottolinea lo storico e giornalista tedesco, Hitler aveva già espresso in una lettera ad un soldato, Adolf Gemlich, il suo odio malato contro gli ebrei, evocando pogrom, discriminazioni per legge, allontanamenti. «Le fantasie da sterminio - argomenta Kellerhoff - sono già evidenti in quella lettera, ma anche in “Mein Kampf”», il delirante manifesto scritto in carcere nel 1924 e venduto 12 milioni di copie prima della fine della Seconda guerra mondiale. Kellerhoff ritiene «totalmente prive di ogni fondamento storico» le argomentazioni del premier israeliano Netanyahu: Hitler «sognava già di sterminare gli ebrei quando il Muftì di Gerusalemme non era neanche lì». L’antisemitismo ossessivo e la teoria dello spazio vitale per i tedeschi sono i due cardini del libro del Fuehrer, argomenta l’esperto di storia del nazismo.
Kellerhoff ha appena dato alle stampe un documentatissimo libro sulla bibbia dei nazisti: «“Mein Kampf”. Die Karriere eines deutschen Buches» (Klett-Cotta), alla vigilia di un evento storico. A gennaio dell’anno prossimo sarà pubblicata in Germania la prima edizione commentata del manifesto di Hitler, dopo ben 70 anni. Il libro non è mai stato vietato, ricorda l’autore: ne è stata proibita la ristampa, dopo la guerra (i diritti appartengono al Land Baviera). «Un errore clamoroso - per Kellerhoff - perché ha alimentato miti e leggende false». In quasi 800 pagine il Fuehrer ha condensato un’opera «intellettualmente misera, piena di errori grammaticali, stilisticamente obbrobriosa, che pullula di insulti, falsi autobiografici - su cui sono inciampati persino biografi del calibro di Joachim Fest - e assurdità storiche». Kellerhoff ha le idee chiare sull’origine dell’antisemitismo di Hitler, ma smaschera il teorico del Terzo Reich anche su aspetti biografici assolutamente grotteschi.
Manie di grandezza
La frenesia agiografica dei nazisti ha distorto molti aspetti della vita di Hitler, cercando di confermare i deliri di «Mein Kampf». Kellerhoff ne elenca molti. Il primo è quello della giovinezza povera e disagiata a Vienna e Monaco. È vero che nella capitale asburgica Hitler visse momenti terribili, alla vigilia della Grande guerra, di fame e pernottamenti negli alberghi dei poveri. Anni in cui fu aiutato economicamente, peraltro, da alcuni amici ebrei. Ma la verità è che riusciva ogni mese a spendersi la pensione da orfano e i soldi della famiglia in un battibaleno. Un bamboccione, più che un bohèmien.
Nessun eroismo
Anche i racconti epici delle battaglie combattute nell’esercito tedesco durante la Grande guerra sono da ridimensionare. Il «battesimo di fuoco» di Hitler avvenne effettivamente nelle Fiandre. «Mein Kampf» non lascia spazio alla fantasia: pallottole che fischiano intorno alle orecchie del giovane Fuehrer, botti assordanti, un corpo a corpo micidiale e la battaglia che culmina in un coro che si leva dalle prime file, intona «Deutschland, Deutschland ueber alles», contagiando tutto il battaglione.
Fantasie, secondo la ricostruzione storica: di fronte all’avanzata micidiale dei francesi, molti commilitoni si buttarono a terra fingendosi morti, il comandante gridò tre volte invano «all’attacco». E Hitler? A giudicare dalle cronache, al suo solito posto: nelle retrovie. E fu la costanza - non l’eroismo - mostrata in quelle retrovie che gli valse poi la Croce di ferro. Medaglia di cui il Fuehrer parlò sempre con timidezza. Strano, si dirà. Ma il motivo è ovvio. Il luogotenente che aveva insistito per conferire una medaglia al merito al giovane Hitler, Hugo Gutmann, era ebreo.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. ---- THEODOR HERZL. Si riscopre "Vecchia terra nuova", l’opera visionaria del 1902 in cui il padre del sionismo prefigurò in ogni dettaglio lo Stato ebraico (di Bruno Ventavoli - Il romanzo che inventò Israele).21 settembre 2012, di Federico La Sala
Il romanzo che inventò Israele
Si riscopre Vecchia terra nuova, l’opera visionaria del 1902 in cui il padre del sionismo prefigurò in ogni dettaglio lo Stato ebraico
di Bruno Ventavoli (La Stampa, 20.09.2012)
“Senza il sole le piante muoiono, ma si possono salvare se si piantano nel terreno adatto, lo stesso vale per gli uomini. Ed è quello che è successo qui». Il «qui» è la Palestina dell’Impero ottomano all’alba del ’900. Gli esseri umani in questione sono gli ebrei, da secoli sotto le tenebre dell’odio. Lo scrive Theodor Herzl, in Vecchia terra nuova, il romanzo (ora tradotto e curato da Roberta Ascarelli, Bibliotheca Aretina, pp. 238, € 20) che immaginò e raccontò Israele prima che Israele esistesse. L’opera visionaria uscì infatti nel 1902, quando il progetto di convincere gli ebrei della diaspora a trasferirsi nella terra dei padri abbandonata da un paio di millenni era poco più che un’idea scandalosa.
Il brillante giornalista ungherese padre del sionismo girava instancabile sinagoghe, salotti, corti, dal Kaiser a Rotschild al sultano della Porta, per spiegare che il trasloco in Medio Oriente era un buon affare per tutti. Agli ebrei, ancora vittime di violenze, pregiudizi, ostracismi, avrebbe dato libertà; agli antisemiti una comoda soluzione a uno sgradevole problema. Dopo aver stilato il manifesto politico dello Stato d’Israele (1896), decise di fornirgli un’anima letteraria per rendere più avvincente il suo sogno rivoluzionario.
Nacque così questo romanzo, narrativamente mediocre (lo stesso autore lo ammetteva) ma talmente carico di entusiasmo e verve utopica da diventare realtà, come a nessun’altra opera è mai accaduto, nemmeno a Verne, Dick o altri compagni di merende fantascientifiche con le loro intuizioni tecnologiche.
Vecchia nuova terra racconta il viaggio di un giovane avvocato ebreo deluso d’amore che ha rinunciato alla professione per seguire un milionario misantropo nei mari del Sud e passa nella Palestina colonizzata dai pionieri sionisti nel futuro 1923 (Herzl morì nel 1904). La descrizione del paesaggio, delle città nate dal nulla, dei porti, delle strade, del brulichio vitale, è incredibilmente simile a ciò che poi sarebbe avvenuto, e che un altro ungherese, Sándor Márai, (peraltro poco amico degli ebrei) descrisse con entusiasmo in un suo tour da quelle parti in Sulle tracce degli dei.
I coloni hanno dissodato la terra con entusiasmo trasformandola in un paradiso fertile, piantando alberi, fondando cooperative agricole. Gli architetti hanno reso Haifa una delle città più moderne al mondo, perché Herzl immagina anche l’urbanistica, le tramvie sospese, le gallerie sotterranee per cavi e tubature.
Herzl, come scriveva Zweig, era bello, cortese, affabile, amatissimo dalla borghesia delle vecchia Austria. Ma quando chiedeva ai facoltosi di lasciar le ville della Ringstrasse, affari, incarichi, serate a teatro, per emigrare in Palestina a fondarvi una nazione, lo consideravano un po’ balzano, se non quasi pericoloso. Sono quindi i diseredati cresciuti negli scantinati bui, braccati dall’odio antisemita a costruire la patria di benessere e libertà. Laggiù rinascono anche nei corpi. Non più mendicanti curvi, pallidi, macilenti, con gli occhi pieni di vergogna, ma abbronzati, forti, virili, sani, «sicuri di sé», finalmente orgogliosi del proprio ebraismo, si compiace di sottolineare Herzl.
La «Nuova società» è giusta («il singolo non viene stritolato dagli ingranaggi del capitalismo né decapitato dal livellamento socialista»), rifiuta la politica professionista («una malattia che siamo riusciti a evitare»), pensando a cariche solo onorarie, affidate a persone meritevoli sottraendole agli «arrivisti». C’è la proprietà privata, ma disprezza il denaro, idolatrato come un vitello d’oro dai borghesi fine secolo. Offre alle donne diritto di voto e parità nei compiti, nei ruoli sociali. Promuove l’istruzione gratuita, in modo che tutti partano alla pari nella gara della vita, e l’agonismo dello sport (cricket, calcio, canottaggio) perché allenare il corpo serve a foggiare lo spirito. E crede soprattutto nella volontà (il sottotitolo del romanzo è programmaticamente «Se lo volete non è una favola»), nell’intelligenza, nell’entusiasmo, nella ragione unica vera religione per un ebreo che si riconosce laicamente nella tradizione degli avi.
Herzl romanziere ha previsto ogni dettaglio del nuovo Israele. Nel suo messianesimo laico immagina una società libera, tollerante, cosmopolita che coinvolgerà anche gli arabi. Prevede che i palestinesi vendano entusiasti pezzi di deserto, paludi, tuguri che non valevano niente pensando a un buon affare. E di fatto così accadde con i primi arrivi. Ma inciampa in un eccesso d’ottimismo. Quando uno dei protagonisti chiede a un abitante locale: «Siete davvero strani voi musulmani! Non considerate questi ebrei degli intrusi? », ottiene una risposta che suona un po’ stonata col senno di poi: «Gli ebrei ci hanno arricchito, perché dovremmo avercela con loro? Vivono con noi come fratelli, perché non dovremmo amarli? ». L’umanità ci mette del suo a guastare i romanzi.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. ---- L’espansione israeliana nelle terre arabe. Tra colonie e posti di blocco chiusa la via della pace (di Sergio Romano)7 giugno 2012, di Federico La Sala
 Tra colonie e posti di blocco chiusa la via della pace
Tra colonie e posti di blocco chiusa la via della pace
 L’espansione israeliana nelle terre arabe
L’espansione israeliana nelle terre arabe di Sergio Romano (Corriere della Sera, 07.06.2012)
di Sergio Romano (Corriere della Sera, 07.06.2012)La mia guida attraverso gli insediamenti ebraici costruiti intorno a Gerusalemme est è un ebreo americano. Si chiama Daniel Seidemann ed è giunto in Israele verso la fine degli anni Cinquanta, all’età di 22 anni. Era un entusiasta sionista quando mise piede nello Stato da poco creato e non ha smesso di esserlo. Ma qui è divenuto avvocato e si è specializzato in questioni di contenzioso immobiliare, vale a dire in una materia dietro la quale vi è il più controverso ed esplosivo dei problemi israelo-palestinesi: la proprietà della terra.
Grazie a una lunga pratica giuridica Seidemann conosce perfettamente la geografia degli insediamenti e l’ha ricostruita nel suo principale strumento di lavoro: una mappa dell’area che si estende al di là dei confini urbani di Gerusalemme est ma rientra nella zona teoricamente destinata allo Stato palestinese.
Nella carta di Seidemann le terre abitate dai palestinesi sono dipinte in verde e quelle israeliane, edificate oltre la frontiera del 1967, in azzurro. L’effetto visivo è più efficace di una qualsiasi arringa giudiziaria. Le macchie azzurre s’insinuano tra le zone verdi e hanno già frantumato la continuità del territorio palestinese. Gli insediamenti sono spesso relativamente piccoli, ma bastano a giustificare la presenza delle forze di sicurezza israeliane, le barriere di protezione e i posti di blocco.
I coloni ebrei, intanto, si rafforzano, consolidano la loro presenza e hanno ottenuto, tra l’altro, una sorta di monopolio archeologico per gli scavi della zona in cui si sono installati. Se ne servono per valorizzare le tracce della presenza giudaica e stanno trasformando la terra (sono parole di Seidemann) in una sorta di «parco biblico».
Da un grande belvedere che si affaccia su un fianco del monte Scopus la mia guida mi indica un antico cimitero giudaico costruito alla base della collina. Ma quando alziamo lo sguardo verso Gerusalemme, al di là della valle e delle mura, i nostri occhi vedono la cupola dorata della grande moschea, il quartiere del Santo Sepolcro, la cattedrale luterana voluta dall’imperatore Guglielmo di Germania durante il suo viaggio in Palestina nel 1898 e, sotto di noi, un piccolo convento francescano oscurato da un pilone dell’energia elettrica che sarebbe stato meglio costruire altrove.
Il sionismo di Seidemann non gli impedisce di constatare che Gerusalemme è una società per azioni di cui sono comproprietari con quote diverse, insieme agli ebrei, i musulmani, i cattolici, gli ortodossi, gli armeni, i copti, i luterani, gli anglicani. La soluzione migliore, per l’amministrazione del condominio, sarebbe quella del «corpo separato» fra due entità statali, previsto dalla risoluzione dell’Onu del 1947. Ma «i fatti sul terreno», come vengono qui definiti gli insediamenti, rende tale prospettiva sempre più improbabile.
È almeno possibile sperare che su questa terra sorgano domani due Stati? Seidemann non ha ancora perso interamente il suo ottimismo e crede che in un clima di buona volontà sarebbe possibile correggere lo stato delle cose nella terra al di là e al di qua della linea verde. Ma apre la sua mappa e punta il dito su una grande rettangolo irregolare, tratteggiato in grigio e chiamato E1, che rappresenta un progetto non ancora definitivamente approvato. Con una metafora efficace dice che i piccoli insediamenti hanno fatto aumentare la pressione sanguigna del malato, la realizzazione di E1 equivarrebbe a un infarto. Può esistere uno Stato palestinese in cui la capitale sarebbe separata dal resto del suo territorio? È lecito immaginare un presidente che può muoversi attraverso il suo Paese soltanto attraverso un percorso costellato da posti di blocco, muri e barriere?
I posti di blocco non servono soltanto a controllare il movimento dei palestinesi. Servono anche a impedire che gli israeliani entrino nelle zone amministrate dall’Autorità palestinese. Per molti anni gli uni e gli altri si sono mossi con una certa libertà da un’area all’altra, e i secondi, in particolare, sono stati una parte considerevole della forza-lavoro dell’economia israeliana.
Oggi, dopo la seconda Intifada, si vuole che ciascuno dei due gruppi viva a casa propria e frequenti soltanto la propria gente. Se un israeliano ha conservato, insieme alla cittadinanza d’Israele, quella del Paese da cui proveniva e ha buoni motivi per andare a Ramallah, sede dell’Autorità palestinese, si servirà del suo vecchio passaporto. Se ne ha soltanto uno dovrà probabilmente rinunciare. Questa separatezza ha avuto effetti economici e sociali.
Nel suo ufficio di Tel Aviv, Aluf Benn, direttore di Haaretz (un quotidiano liberale), mi dice che i palestinesi, ormai usciti in gran parte dal mercato del lavoro israeliano, sono stati sostituiti con immigrati provenienti dall’Europa e dall’Asia: romeni o bulgari per l’edilizia, filippini per i lavori domestici e l’assistenza alle persone, lavoratori del sub-continente indiano e del sud-est asiatico per gli altri mestieri di una economia che si è prodigiosamente sviluppata soprattutto nell’informatica e nelle nuove tecnologie. È accaduto anche negli Stati Uniti e in Europa, ma con una importante differenza.
Israele non può assorbire e integrare questi immigrati senza rinunciare alla sua identità nazional-religiosa e li tratta quindi con maggiore rigore di quanto non accadesse in Germania quando il miracolo tedesco richiese l’arrivo di un numero importante di Gastarbeiter (lavoratori ospiti). Mentre la Repubblica federale rinnovava i contratti di lavoro e i permessi di soggiorno, Israele ha fissato un limite, cinque anni, al di là del quale non intende andare. Niente preoccupa il governo israeliano quanto la prospettiva di un bambino filippino che impara l’ebraico e si sente, dopo il completamento degli studi, a casa propria.
Tutto diventerebbe molto più semplice se l’economia israeliana potesse contare sui giovani cittadini di uno Stato palestinese che attribuisce grande importanza alla educazione e alla formazione. Ma i palestinesi sono inutilizzabili per ragioni politiche e i Gastarbeiter non possono restare più di cinque anni. I secondi sapevano, prima di partire, quale sarebbe stata la politica del governo israeliano nei loro confronti e non hanno il diritto di lamentarsi. I primi, invece, non hanno rinunciato a un obiettivo che sembrava, qualche anno fa, a portata di mano: la costituzione di uno Stato palestinese. Ne esistono ancora le condizioni? Con quali argomenti e strumenti l’Autorità palestinese spera ancora di raggiungere questo obiettivo? L’ho chiesto ai miei interlocutori palestinesi durante un viaggio a Ramallah e ne parlerò in un prossimo articolo.
 (1/continua)
(1/continua)
Via libera a nuovi insediamenti Corriere della Sera, 07.06.2012
Corriere della Sera, 07.06.2012GERUSALEMME - Il premier Benjamin Netanyahu ha ordinato ieri la costruzione di 300 nuove unità abitative nella colonia israeliana di Beit El e poche ore dopo di altre 551 unità in altre colonie in Cisgiordania. Una mossa intesa a placare la rabbia dei coloni per la rimozione, ordinata dall’Alta Corte di Giustizia, di 5 palazzine nell’insediamento di Ulpana perché costruite su un terreno di proprietà palestinese. Un deputato nazionalista ha presentato una legge per aggirare la sentenza, ma Netanyahu l’ha affondata col sostegno di 69 deputati, contro 22, dicendo che avrebbe provocato critiche internazionali. Ha presentato un piano alternativo, che prevede lo spostamento delle case di Ulpana a Beit El. I palestinesi hanno condannato il piano di ampliare l’insediamento.
-
> ELIEZER BEN-YEHUDA. ---- Potrei anche immaginare un altro Abramo. Lettera del 1921 a Robert Klopstock (di Franz Kafka).16 ottobre 2011, di Federico La Sala
- "Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka - da una lettera del giugno 1921 a Robert Klopstock, l’amico medico, che lo seguì sino alla morte).
- LETTERA DI FRANZ KAFKA
A Robert Klopstock [Matliary, giugno 1921] *
Mio caro Klopstock, veranda, con l’antica insonnia, con l’antico calore degli occhi, la tensione nelle tempie: ... incredulo non sono stato mai in questo punto, ma stupito, angosciato, la testa piena di tanti interrogativi quanti sono i moscerini su questo prato. Nella situazione, diciamo, di questo fiore accanto a me che non è del tutto sano, solleva bensì la testa verso il sole, e chi non lo farebbe ma è pieno di segrete preoccupazioni a causa di dolorosi avvenimenti nelle sue radici e nei succhi, qualcosa vi è successo, e succede ancora, ma esso ne ha soltanto notizie molto vaghe, dolorosamente vaghe, eppure non può curvarsi, scalzare il terreno e controllare, ma deve fare come i suoi fratelli e tenersi ritto, lo fa anche ma con stanchezza.
Potrei anche immaginare un altro Abramo che (ma non arriverebbe a essere il patriarca, anzi nemmeno un mercante di abiti usati) fosse pronto a adempiere la richiesta della vittima, pronto come un cameriere, ma ciò nonostante non riuscisse a fare il sacrificio perché non può allontanarsi da casa, è indispensabile, l’andamento della casa ha bisogno di lui, c’è sempre ancora qualche cosa da mettere in ordine, la casa non è finita, ma senza che sia finita, senza questo appoggio egli non può allontanarsi, lo capisce anche la Bibbia poiché dice: “Egli sistemò la sua casa” e Abramo aveva realmente già prima ogni abbondanza; se non avesse avuto la casa, dove avrebbe allevato suo figlio, in quale trave avrebbe tenuto conficcato il .coltello del sacrificio.
Il giorno seguente: ho riflettuto ancora molto su questo Abramo, ma sono vecchie storie, non mette conto di parlarne, specialmente del vero Abramo; egli ha avuto tutto già prima, vi fu portato fin dall’infanzia, non riesco a vedere il salto. Se aveva già tutto e tuttavia doveva essere condotto piú in alto, ora bisognava togliergli qualcosa, almeno in apparenza, questo è logico e non è un salto. Non così gli Abrami superiori, questi stanno nel loro cantiere e a un tratto devono salire sul Monte Moria; può darsi che non abbiano ancora un figlio e già lo debbano sacrificare. Queste sono cose impossibili e Sarah ha ragione se ride. Rimane dunque soltanto il sospetto che costoro facciano apposta a non portare a termine la loro casa e - per citare un esempio grandissimo - nascondano la faccia in magiche trilogie per non doverla alzare e vedere il monte che sorge in lontananza.
Ma ecco un altro Abramo, uno che vuole assolutamente offrire un sacrificio giusto e, in genere, ha il giusto fiuto di tutta la questione, ma non può credere che tocchi a lui, l’antipatico vecchio, e a suo figlio, il sudicio giovane. Non che gli manchi la vera fede, questa fede ce l’ha, e sacrificherebbe nello stato d’animo giusto, purché potesse credere che si intenda lui. egli teme che uscirà a cavallo in qualità di Abramo con suo figlio, ma lungo il percorso teme di trasformarsi in Don Chisciotte. Il mondo di allora sarebbe rimasto atterrito se avesse guardato Abramo, questo invece teme che a quella vista il mondo muoia dal ridere. Non teme però il ridicolo in sé (certo teme anche questo, soprattutto la sua partecipazione alla risata), soprattutto però teme che questo ridicolo 1o renda ancore più vecchio e antipatico, e suo figlio ancora più sudicio, ancora più indegno di essere realmente chiamato. Un Abramo che arriva senza essere chiamato! È come se lo scolaro migliore dovesse ricevere solennemente il premio alla fine dell’anno e nel silenzio dell’attesa lo scolaro peggiore, in seguito a un malinteso, uscisse dal suo lurido ultimo banco e tutta la classe scoppiasse a ridere. E forse non è affatto m malinteso, egli è stato veramente chiamato per nome, la premiazione del migliore dev’essere, nelle intenzioni del maestro, ad un tempo la punizione del peggiore.
 Cose orrende... basta.
Cose orrende... basta.
 Lei si lamenta della felicità solitaria, che dire della solitaria infelicità? Davvero, fanno quasi una coppia. [...]
Lei si lamenta della felicità solitaria, che dire della solitaria infelicità? Davvero, fanno quasi una coppia. [...]* Franz Kafka, Tutte le opere, Epistolario, vol. IV, t. I, a c. di Ervino Pocar, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1964, pp. 393-395, senza le note.
-
> “Tante parole nuove dovranno essere inventate .... --- Al filosofo e linguista americano Noam Chomsky, Israele nega l’ingresso: respinto!!!18 maggio 2010, di Federico La Sala
 Israele nega l’ingresso
Israele nega l’ingresso
 Chomsky: respinto
Chomsky: respintoFunzionari israeliani hanno negato l’ingresso in Cisgiordania, domenica pomeriggio, al filosofo e linguista americano Noam Chomsky, noto anche per le sue posizioni critiche nei confronti della politica israeliana. Chomsky ha definito “regime stalinista” il governo israeliano che gli ha impedito di tenere una lezione all’Università palestinese di Bir Zit, nei pressi di Ramallah.
* il Fatto, 18.05.2010
-
> Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA ---- Lingua ebraica in crisi: allarme in Israele.7 gennaio 2010, di Federico La Sala
Lingua ebraica in crisi: allarme in Israele
◆ Il governo israeliano vuole rafforzare la lingua ebraica in un tempo in cui altre lingue sono dominanti. Così un giorno per la lingua ebraica sarà celebrato ogni anno nell’anniversario della nascita di Eliézer Ben Yehuda, l’iniziatore principale della rinascita dell’ebraico come lingua parlata all’inizio del XX secolo.
Secondo il calendario ebraico, Ben Yehuda è nato il 21 del mese di tevet 5818 ovvero il 7 gennaio 1858. Il ministro dell’Educazione in Israele, Guidon Saar, ha annunciato che il prossimo anno scolastico sarà dedicato all’ebraico e ha auspicato la creazione di un museo della lingua ebraica.
Inoltre, un premio, che porterà il nome di Eliézer Ben Yehuda, sarà assegnato ogni anno a chi contribuirà allo sviluppo e al rafforzamento dell’ebraico. E altre numerose iniziative sono in programma.
* Avvenire, 07.01.2010
-
> “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” Memoria di BEN YEHUDA19 aprile 2007, di Federico La Sala
Se i palestinesi non studiano l’ebraico e gli israeliani non studiano l’arabo
di Francesca Paci *
Cresce il divario linguistico tra le due comunità
Nonostante sia sempre attenta alle cose che uniscono, ai ponti più che ai muri, e nonostante sia convinta che la società palestinese e quella israeliana convivano nel day-by-day assai più naturalmente di quanto la politica racconti e di quanto faccia per creare divisioni, mi ha colpito un articolo del quotidiano The Jerusalem Post: cresce il divario linguistico, sempre meno giovani palestinesi studiano l’ebraico e sempre meno giovani israeliani studiano l’arabo. Fino ad alcuni anni fa la lingua era una chance reciproca professionale e di conoscenza. Ora no. Che i due popoli non si amino è noto, che ci siano comunque forti legami anche. Ma che uno strumento come la lingua, sia pur utilizzato per scopi lavorativi, venga abbandonato mi sembra una brutta notizia. Uno può studiare la lingua del nemico per necessità ma studiandola intanto comincia a conoscerla e forse ad averne meno paura. Ma se rinuncia a monte condanna al silenzio anche quel piccolo legame in divenire.
* La Stampa, 9/4/2007
-
>Memoria di BEN YEHUDA .... La guerra della memoria. Il governo Netanyahu si annette la Tomba dei Patriarchi Hebron quella di Rachele a Betlemme. E a Gerusalemme... (di U. De Giovannangeli).25 febbraio 2010, di Federico La Sala
 Dopo la terra Israele occupa i luoghi sacri di Palestina
Dopo la terra Israele occupa i luoghi sacri di Palestina
 La guerra della memoria. Il governo Netanyahu si annette la Tomba dei Patriarchi
La guerra della memoria. Il governo Netanyahu si annette la Tomba dei Patriarchi
 a Hebron quella di Rachele a Betlemme. E a Gerusalemme...
a Hebron quella di Rachele a Betlemme. E a Gerusalemme...
 L’imposizione del Muro. Confisca la terra e i campi, ma anche i luoghi di identità
L’imposizione del Muro. Confisca la terra e i campi, ma anche i luoghi di identità
 Robert Serry, Onu: «Impediscono la pace. Allarmanti le imposizioni istraeliane»
Robert Serry, Onu: «Impediscono la pace. Allarmanti le imposizioni istraeliane» di Umberto De Giovannangeli (l’Unità, 25.02.2010)
di Umberto De Giovannangeli (l’Unità, 25.02.2010)Questa è una triste storia. Una storia dove passato e presente s’intrecciano indissolubilmente, in cui ogni corda identitaria viene toccata e tesa all’estremo. Una storia nella quale politica e religione si fondono dando vita a una miscela esplosiva. Una storia che fa riemergere quella bramosia di possesso assoluto in nome della quale si è combattuto e sparso sangue in Terrasanta. «Dopo la terra ora vogliono toglierci anche i luoghi della memoria. Dopo l’annientamento politico, i falchi israeliani hanno deciso di espropriarci anche di qualcosa ancor più importante della terra: la memoria storica di ciò che è stato, di ciò che è la Palestina», dice a l’Unità Sari Nusseibeh, rettore dell’Università Al Quds di Gerusalemme Est, il più autorevole intellettuale palestinese.
A scatenare l’ira dei palestinesi è stata la decisione del governo di Benyamin Netanyahu di includere fra i luoghi della «memoria storica» del popolo ebraico che vanno preservati anche la Tomba di Rachele a Betlemme e la Tomba dei Patriarchi a Hebron. Luoghi santi che si trovano in zone autonome palestinesi e sono venerati sia da fedeli ebrei sia da fedeli islamici.
La decisione israeliana «è una provocazione per i musulmani di tutto il mondo e soprattutto per i palestinesi», denuncia il capo dei negoziatori dell’Anp, Saeb Erekat. «Siamo di fronte ad una ulteriore, gravissima escalation politica unilaterale, dei fatti compiuti, messa in pratica dai governi israeliani succedutisi negli ultimi quindici anni», gli fa eco Hanan Ashrawi, più volta ministra dell’Anp oggi paladina dei diritti umani nei Territori. «Il dialogo, per avere senso ci dice Ashrawi deve partire dal riconoscimento non solo delle ragioni dell’altro, ma ancor prima, riconoscerne l’esistenza in quanto nazione, con una sua storia, una sua identità culturale. Una sua memoria». «Ora aggiunge Ahrawi, prima donna portavoce della Lega Araba come si può pensare ad una pace fondata su due Stati se Israele rifiuta anche di condividere luoghi sacri a ambedue i popoli?».
Una considerazione che ci conduce al cuore di questa sottrazione in divenire. Ci porta a Hebron, alla grotta di Makpelah, dove la tradizione vuole siano inumati Abramo, Isacco, Giacobbe con le loro mogli. È la Tomba dei Patriarchi, luogo di culto sia per i musulmani che per gli ebrei. Luogo conteso, che venerdì 25 febbraio 1994 si trasformò in un campo di battaglia. Quella mattina, giorno di Purim per gli ebrei, ultimo venerdì di Ramadan per i musulmani, un colono di Kiryat Arba, il grande insediamento presso Hebron, roccaforte della destra ultranazionalista ebraica, superati controlli militari israeliani all’ingresso della Moschea di Abramo, dove sorge anche la sinagoga che gli ebrei chiamano Makpelah, si avvia verso una delle sale la sala Isacco dell’edificio. Baruch Goldstein, medico piuttosto noto tra i coloni, nasconde un fucile mitragliatore M16 in una borsa sportiva blu. Indossa la divisa da riservista. Senza pronunciar parola, spara diversi caricatori sui musulmani in preghiera, uccidendone trenta e ferendone decine prima di essere a sua volta linciato dai sopravvissuti. Negli incidenti che seguirono altri 20 palestinesi saranno uccisi dall’esercito israeliano.
Da quel giorno tragico, la tomba di Goldstein, a Kiryat Arba, è meta di continui pellegrinaggi dei militanti dell’estrema destra moltissimi i giovani che considerano «Baruch, eroe di Erez Israel». Tra i gli organizzatori delle visite alla tomba di «Goldstein, re d’Israele» c’era pure Yigal Amir, l’assassino di Yitzhak Rabin. «Israele non ha il solo il diritto ma anche il dovere di preservare i luoghi della memoria del popolo ebraico. E Makpelah è parte inalienabile di essi. A sancirlo è la Torah, guai a dimenticarlo...», dice a l’Unità David Wilder, leader degli ultraortodossi israeliani, in maggioranza originari degli Stati Uniti, che vivono 500, circondati da 170mila palestinesi in una enclave trasformata in fortino nel cuore di Hebron.
La tensione è tornata altissima. Un portavoce della Jihad islamica ha detto al sito web del quotidiano Yediot Ahronot che la iniziativa di Netanyahu è un tentativo israeliano di «annettere» luoghi islamici di preghiera, e dunque un atto «aggressivo» che provocherà la ripresa degli attacchi armati. In una Terrasanta che si «nutre» di simboli, è altamente simbolico anche il fatto che l’annuncio del governo israeliano di un piano nazionale per «riabilitare» circa 140 siti storico-religiosi dell’ebraismo, è stato dato dopo un Consiglio dei ministri straordinario, tenutosi a Tal Hai, nel nord di Israele, luogo in cui nel 1920 ebrei e arabi combatterono. «L’annessione della Tomba dei Patriarchi incalza l’ex ministro Mustafa Barghouti e di quella di Rachele a Betlemme, non è altro che una dichiarazione da parte di Israele del fatto che imporrà azioni concrete: annettendo terre e impedendo la pace».
Preoccupazione condivisa dall’emissario Onu per il processo di pace israelo-palestinese, Robert Serry, che definisce allarmanti le rivendicazioni israeliane sul «territorio palestinese occupato». Per realizzare questa «sottrazione di memoria» è funzionale anche la Barriera di sicurezza (il muro dell’apartheid per i palestinesi) in Cisgiordania. Nel settembre 2002, le autorità israeliane approvarono l’inclusione della Tomba di Rachele (la seconda moglie di Giacobbe), alle porte di Betlemme, all’interno dei confini del Muro.
Da allora il progetto è marciato spedito. Quella barriera impedisce ai palestinesi di Betlemme di recarsi a pregare alla Tomba di Rachele. Il piano rientra a pieno titolo nel disegno della «Grande Gerusalemme» ebraica coltivato dalla destra oggi al governo in Israele. La Barriera-Muro spezza in mille frammenti la Cisgiordania e crea dei ghetti. Uno di essi, il ghetto-sud, una volta portato a compimento, comprenderebbe Betlemme e Hebron, e i loro luoghi sacri. La Tomba dei Patriarchi, la Spianata delle Moschee, la Tomba di Rachele... Ciò che un intero popolo, quello palestinese, vive è una doppia confisca: quella della terra, e quella, non meno dolorosa, dei luoghi di identità.
Legami che uniscono, è il titolo di prima pagina del Jerusalem Post che parla dell’inserimento della Tomba dei Patriarchi a Hebron e della Tomba di Rachele a Betlemme nella lista dei 150 siti dell’identità nazionale israeliana. Ma ciò che unisce Israele spezza i palestinesi, espropriandoli del passato e del futuro. «Vi chiediamo di impedire ad Israele di attuare il suo brutale, espansionistico progetto di annettere la zona della Tomba di Rachele e le terre circostanti e di chiudere l’entrata principale della nostra città che collega Betlemme con Gerusalemme, impedendo il flusso dei pellegrini e dei turisti in Betlemme». Era l’appello disperato rivolto dai palestinesi di Betlemme al mondo libero. Un appello rimasto senza risposta.
-
> Memoria di BEN YEHUDA .... Con i rabbini a raccogliere olive per i palestinesi (di Arturo Marzano)2 gennaio 2012, di Federico La Sala
Con i rabbini a raccogliere olive per i palestinesi
di Arturo Marzano (l’Unità, 2 gennaio 2012)
Da ebreo, rabbino, israeliano, sionista non è facile per me dirvi queste cose, criticare Israele, il paese che amo e in cui ho scelto di vivere. Però - come diceva il mio allenatore di football quando ero adolescente negli Stati Uniti - gridi quando ti sta a cuore, gridi perché credi che possa fare la differenza». A dirlo è Arik Ascherman,uno dei membri dell’organizzazione israeliana per i diritti umani Rabbis for Human Rights (Rabbini per i diritti umani). Ha 52 anni, è emigrato in Israele dalla Pennsylvania. Da anni si occupa del programma che l’organizzazione porta avanti nei Territori Occupati Palestinesi a difesa degli agricoltori palestinesi che coltivano ulivi.
È il venerdì mattina di qualche settimana fa, sono le otto e mezzo. Arik guida un gruppo di 8 ebrei americani che attualmente si trovano a Gerusalemme. La maggior parte di loro studia per diventare rabbini. Sono riformati, conservativi e ricostruzionisti, a dimostrazione della grande pluralità dell’ebraismo americano. Hanno deciso di andare a raccogliere le olive con alcuni contadini palestinesi a Sinjil, nel nord della Cisgiordania. Come molti altri villaggi palestinesi, anche Sinjil è stretto tra una serie di insediamenti israeliani. Uno di questi è Shilo. Un nome centrale per l’ebraismo. È a Shilo che, secondo la tradizione, era conservata l’Arca dell’Alleanza prima che fosse costruito il Primo Tempio a Gerusalemme.
Marisa Elana è del Connecticut. Anche lei studia per diventare rabbino. «Nella Torah - dice appena l’autobus lascia Gerusalemme per dirigersi verso Sinjil - c’è scritto chiaramente: è vietato tagliare o sradicare gli alberi del nemico, anche se si è in guerra. Purtroppo, i coloni israeliani se ne sono dimenticati. Sono centinaia gli ulivi che vengono incendiati, tagliati, avvelenati. E sono tanti gli agricoltori palestinesi attaccati mentre raccolgonole olive. Sono venuta qui per proteggerli dagli attacchi dei coloni israeliani. Solo una minoranza di loro si comporta così, ma il clima che si respira negli ultimi anni è sempre più pesante. La mia presenza serve da deterrente, per evitare che accadano episodi del genere. C’è anche un’altra ragione, però, che mi spinge ad essere qui. I palestinesi di molti villaggi della Cisgiordania conoscono solo coloni e i soldati. Non hanno quasi nessun altro contatto con gli israeliani. Io voglio mostrare loro un altro Israele, un altro ebraismo. È importante che sappiano che l’ebraismo, quello in cui credo, difende gli oppressi, si batte per i diritti umani, la pace, la giustizia».
Sinjil dista da Gerusalemme solo 39 chilometri. Poco più di mezz’ora di autobus. Alle dieci, il gruppo è già al lavoro. Si stendono grandi teli sotto gli alberi, per raccogliere le olive sfilate dai rami e lasciate cadere. Alcuni si arrampicano. Altri prendono delle scale. «È la prima volta che raccolgo le olive. Non credevo fosse così», dice Sam, di Indianapolis. Sua moglie, Rachel, studia per diventare rabbino. Anche lei fa parte del gruppo. «So poco del conflitto. Prima di venire in Israele credevo di avere le idee molto chiare: Israele aveva ragione e i palestinesi torto. Ora mi rendo conto della complessità del conflitto. Sono qui per capire un po’ di più, per vedere come stanno le cose dall’altra parte».
Il sole in Medio Oriente è sempre forte, anche adesso. Fa caldo e l’ombra degli ulivi è rinfrescante. È lì che Kamal distribuisce il the. Bicchierini di vetro, come si usa in Palestina. «Questa terra è nostra da generazioni. La coltivava già il nonno di mio nonno» racconta. Ha47 anni. Non se la ricorda la Guerra dei Sei Giorni, perché aveva solo tre anni. Ma l’occupazione la conosce bene. È tutta la vita che ci convive. «Ho lavorato a Gerusalemme per 18anni, prima della Seconda Intifada. Ho vari amici israeliani. Ma solo pochi vengono a darci una mano. Arik è tra questi. È sempre in prima linea, a difenderci dagli attacchi dei coloni, a sostenere le battaglie legali che facciamo contro gli insediamenti limitrofi, costruiti su parte delle nostre terre».
Rabbis for Human Rights, infatti, non organizza solo gruppi che scortano i contadini palestinesi durante la raccolta delle olive. Fa consulenza legale, sostiene i beduini del Negev, aiuta i più poveri tra i nuovi immigrati in Israele, principalmente etiopi. Insieme all’associazione gemella Rabbis for Human Rights North America, organizza campagne di informazione negli Stati Uniti e in Canada. E per loro che Joshua Bloom lavora, a New York. È in Israele per un mese, per guidare un gruppo di 19 americani, rabbini e non. «È importante che gli ebrei americani abbiano una visione meno ideologica del conflitto. Rabbis for Human Rights non fa politica, non intende presentare soluzioni al conflitto. Però, si batte per il rispetto dei diritti umani nei Territori Occupati e organizza dei tour per far capire all’estero che cosa realmente accade in Israele e in Palestina».
«Il nostro lavoro ha radici antiche», dice Arik mentre l’autobus torna a Gerusalemme. «Abramo intercede presso Dio per garantire la salvezza degli abitanti di Sodoma che nemmeno conosce. Sarebbe troppo facile se noi lottassimo solo per i diritti dei nostri familiari, dei nostri amici. Dobbiamo lottare per i diritti di chi non conosciamo, persino dei nostri nemici, perché questo significa essere ebrei».
Sono quasi le tre di pomeriggio. Sta per entrare il sabato ebraico. Ci si deve preparare per accoglierlo. Anche riflettendo su quanto Arik ha appena detto.
-
-