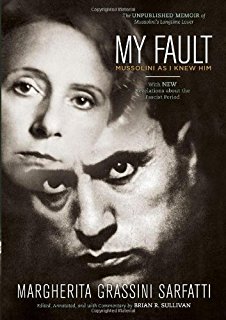
IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE. Alcune note - di Federico La Sala
BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI
GRAMSCI: "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (1924). All’interno di uno straordinario articolo, scritto per celebrare Lenin (morto il 21 gennaio 1924), nella prima pagina dell’Ordine Nuovo del 1° marzo 1924, con il titolo “Capo” (ripreso, poi, nell’Unità del 6 novembre 1924 col titolo Lenin capo rivoluzionario), Antonio Gramsci - in contrapposizione - delinea con magistrale e storica lungimiranza i tratti essenziali del governo guidato dal “Duce”:
 “Abbiamo in Italia il regime fascista, abbiamo a capo del fascismo Benito Mussolini, abbiamo una ideologia ufficiale in cui il «capo» è divinizzato, è dichiarato infallibile, è preconizzato organizzatore e ispiratore di un rinato Sacro Romano Impero. Vediamo stampati nei giornali, ogni giorno, decine e centinaia di telegrammi di omaggio delle vaste tribù locali al «capo». Vediamo le fotografie: la maschera più indurita di un viso che già abbiamo visto nei comizi socialisti.
“Abbiamo in Italia il regime fascista, abbiamo a capo del fascismo Benito Mussolini, abbiamo una ideologia ufficiale in cui il «capo» è divinizzato, è dichiarato infallibile, è preconizzato organizzatore e ispiratore di un rinato Sacro Romano Impero. Vediamo stampati nei giornali, ogni giorno, decine e centinaia di telegrammi di omaggio delle vaste tribù locali al «capo». Vediamo le fotografie: la maschera più indurita di un viso che già abbiamo visto nei comizi socialisti.
 Conosciamo quel viso (...) Abbiamo visto la settimana rossa del giugno 1914. Più di tre milioni di lavoratori erano in piazza, scesi all’appello di Benito Mussolini, che da un anno circa, dall’eccidio di Roccagorga, li aveva preparati alla grande giornata, con tutti i mezzi tribunizi e giornalistici a disposizione del «capo» del partito socialista di allora, di Benito Mussolini: dalla vignetta di Scalarini al grande processo alle Assise di Milano.
Conosciamo quel viso (...) Abbiamo visto la settimana rossa del giugno 1914. Più di tre milioni di lavoratori erano in piazza, scesi all’appello di Benito Mussolini, che da un anno circa, dall’eccidio di Roccagorga, li aveva preparati alla grande giornata, con tutti i mezzi tribunizi e giornalistici a disposizione del «capo» del partito socialista di allora, di Benito Mussolini: dalla vignetta di Scalarini al grande processo alle Assise di Milano.
 Tre milioni di lavoratori erano scesi in piazza: mancò il «capo», che era Benito Mussolini. Mancò come «capo», non come individuo, perché raccontano che egli come individuo fosse coraggioso e a Milano sfidasse i cordoni e i moschetti dei carabinieri. Mancò come «capo», perché non era tale, perché, a sua stessa confessione, nel seno della direzione del partito socialista, non riusciva neanche ad avere ragione dei miserabili intrighi di Arturo Vella o di Angelica Balabanoff.
Tre milioni di lavoratori erano scesi in piazza: mancò il «capo», che era Benito Mussolini. Mancò come «capo», non come individuo, perché raccontano che egli come individuo fosse coraggioso e a Milano sfidasse i cordoni e i moschetti dei carabinieri. Mancò come «capo», perché non era tale, perché, a sua stessa confessione, nel seno della direzione del partito socialista, non riusciva neanche ad avere ragione dei miserabili intrighi di Arturo Vella o di Angelica Balabanoff.
 Egli era allora, come oggi, il tipo concentrato del piccolo borghese italiano, rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale dai vari secoli di dominazione degli stranieri e dei preti: non poteva essere il capo del proletariato; divenne il dittatore della borghesia, che ama le facce feroci quando ridiventa borbonica, che spera di vedere nella classe operaia lo stesso terrore che essa sentiva per quel roteare degli occhi e quel pugno chiuso teso alla minaccia. (...)
Egli era allora, come oggi, il tipo concentrato del piccolo borghese italiano, rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale dai vari secoli di dominazione degli stranieri e dei preti: non poteva essere il capo del proletariato; divenne il dittatore della borghesia, che ama le facce feroci quando ridiventa borbonica, che spera di vedere nella classe operaia lo stesso terrore che essa sentiva per quel roteare degli occhi e quel pugno chiuso teso alla minaccia. (...)
 Benito Mussolini ha conquistato il governo e lo mantiene con la repressione più violenta e arbitraria. Egli non ha dovuto organizzare una classe, ma solo il personale di una amministrazione. Ha smontato qualche congegno dello Stato, più per vedere com’era fatto e impratichirsi del mestiere che per una necessità originaria. La sua dottrina è tutta nella maschera fisica, nel roteare degli occhi entro l’orbite, nel pugno chiuso sempre teso alla minaccia...
Benito Mussolini ha conquistato il governo e lo mantiene con la repressione più violenta e arbitraria. Egli non ha dovuto organizzare una classe, ma solo il personale di una amministrazione. Ha smontato qualche congegno dello Stato, più per vedere com’era fatto e impratichirsi del mestiere che per una necessità originaria. La sua dottrina è tutta nella maschera fisica, nel roteare degli occhi entro l’orbite, nel pugno chiuso sempre teso alla minaccia...
 Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo” (Antonio Gramsci, Sul fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 223-229)
Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo” (Antonio Gramsci, Sul fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 223-229)

STORIA E STORIOGRAFIA: DE FELICE (1966). Renzo De Felice, nel capitolo quinto del volume della biografia del “Duce”, dedicato a “Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925” (Einaudi, Torino, 1966), scrivendo delle “prime esperienze di governo” del Duce, riprende e ricorda questo “noto articolo” di Gramsci e, pur apprezzandone la “lucida intuizione (al fondo della quale si sente l’antico socialista che aveva visto in Mussolini l’uomo nuovo del socialismo italiano e ne era rimasto deluso): Mussolini non era un «capo»” e pur esprimendo la giusta persuasione che questo giudizio “merita a nostro avviso di essere attentamente vagliato” (p. 464), mostra di essere assolutamente dimentico della nota iniziale dell’analisi gramsciana (“Abbiamo in Italia il regime fascista, abbiamo a capo del fascismo Benito Mussolini, abbiamo una ideologia ufficiale in cui il «capo» è divinizzato, è dichiarato infallibile, è preconizzato organizzatore e ispiratore di un rinato Sacro Romano Impero. Vediamo stampati nei giornali, ogni giorno, decine e centinaia di telegrammi di omaggio delle vaste tribù locali al «capo». Vediamo le fotografie: la maschera più indurita di un viso che già abbiamo visto nei comizi socialisti”) e alla sua nota finale (“Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, Romolo Augustolo”)! E, assunta a tutto solo una parte (“Mussolini [...] il tipo concentrato del piccolo borghese italiano, rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale dai vari secoli di dominazione degli stranieri e dei preti”, p. 464) , così conclude:
 “Detto questo ci pare ci si debba però guardare dall’accettare la tesi generale che sottende tutto l’articolo di Gramsci: che cioè Mussolini non fu un «capo» [...] Se si accettasse questa tesi generale si dovrebbe negare la qualità di vero «capo» non solo a Mussolini, ma - facciamo solo l’esempio più macroscopico - a Hitler, il che in sede storica sarebbe veramente un assurdo. La risposta alla domanda se Mussolini, come un qualsiasi altro uomo politico, sia stato o no un vero «capo» non può essere ricercata in banali formule e in facili sillogismi” (p. 464)!
“Detto questo ci pare ci si debba però guardare dall’accettare la tesi generale che sottende tutto l’articolo di Gramsci: che cioè Mussolini non fu un «capo» [...] Se si accettasse questa tesi generale si dovrebbe negare la qualità di vero «capo» non solo a Mussolini, ma - facciamo solo l’esempio più macroscopico - a Hitler, il che in sede storica sarebbe veramente un assurdo. La risposta alla domanda se Mussolini, come un qualsiasi altro uomo politico, sia stato o no un vero «capo» non può essere ricercata in banali formule e in facili sillogismi” (p. 464)!

DE FELICE (1975): IL MITO DELLA ROMANITÀ E L’AVVIO DI UNA “AUTOCRITICA”. Nel 1975, nell’intervista sul fascismo, De Felice (con alle spalle già gran parte della sua imponente costruzione biografica dedicata a Mussolini e al fascismo) ricorda che, nel 1961 (all’inizio del lavoro sistematico sulla figura del “Duce”), in occasione del lavoro per la “Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo” (Einaudi, 1961), ha avuto “la fortuna, più che altro sul piano della curiosità umana, di poter parlare a lungo - tutto un pomeriggio d’inverno - con Margherita Sarfatti, poco prima che morisse, in un appartamento d’albergo, in via Veneto a Roma”; e, al contempo, dichiara (e fa intendere in modo più che chiaro e forte) di non aver considerato a pieno o, meglio, di aver del tutto sottovalutato, relativamente al processo di conquista e di organizzazione del potere da parte di Mussolini, proprio il ruolo e la figura dell’autrice di “Dux”, la biografia ufficiale pubblicata con tale titolo nel 1926 (e già anticipata nel 1925, in una edizione londinese, con titolo “The life of Benito Mussolini”, con la prefazione dello stesso Mussolini):
 “Da questa conversazione, attualmente, documentariamente, non ho cavato nulla. Mi è servita moltissimo, invece, per capire questa donna, per capire (...) il tipo di influenza che deve aver avuto per alcuni anni. Dopo quella conversazione mi sono chiesto, per esempio, quanto del mito della romanità fosse farina del sacco di Mussolini, e non invece piuttosto frutto dell’influenza della Sarfatti. Perché non ho mai conosciuto in vita mia una persona malata come lei di romanità” (Renzo De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di Michael Ledeen, Bari, Laterza, 1975, pp. 12-13).
“Da questa conversazione, attualmente, documentariamente, non ho cavato nulla. Mi è servita moltissimo, invece, per capire questa donna, per capire (...) il tipo di influenza che deve aver avuto per alcuni anni. Dopo quella conversazione mi sono chiesto, per esempio, quanto del mito della romanità fosse farina del sacco di Mussolini, e non invece piuttosto frutto dell’influenza della Sarfatti. Perché non ho mai conosciuto in vita mia una persona malata come lei di romanità” (Renzo De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di Michael Ledeen, Bari, Laterza, 1975, pp. 12-13).
MARGHERITA SARFATTI (1880-1961), RENZO DE FELICE (1929-1996), E "LUCIFERO". Nel 1993, nella “Prefazione” del loro lavoro “Margherita Sarfatti. L’altra donna del duce” (Mondadori, Milano), 1993), dedicato "a Renzo De Felice", Philip V. Cannistraro - Brian R. Sullivan così scrivono:
 “Abbiamo cominciato a scrivere questo libro per tentare di risolvere un mistero. In un piovoso pomeriggio di febbraio 1984 Philip Cannistraro raccontò a Brian Sullivan che forse le lettere di Benito Mussolini alla sua amante e confidente Margherita Sarfatti erano negli Stati Uniti. A rivelarglielo era stato l’anno precedente a Roma Renzo De Felice, il noto storico del fascismo italiano. (...) Seguendo gli indizi che ci fornì il professor De Felice, cominciammo le ricerche (...) Mentre eravamo alla ricerca delle lettere scomparse, scoprimmo Margherita Sarfatti. Come molte donne, Margherita era stata volutamente cancellata dalla storia. Mussolini non solo tentò di negarne il ruolo nella creazione del fascismo, ma dopo l’alleanza con Hitler non tollerò più che l’opinione pubblica fosse a conoscenza che una donna - un’ebrea - aveva contribuito quanto lui a costruire il regime fascista. Negli ultimi anni della dittatura ne fece una “non persona”. Lei, per salvar se stessa e la famiglia, si prestò al gioco. La conseguenza fu che ancora prima di morire, Margherita Sarfatti sparì nel nulla. A quei pochi che la ricordavano non sembrava altro che la protagonista della più lunga storia d’amore di Mussolini” (pp. 3-4).
“Abbiamo cominciato a scrivere questo libro per tentare di risolvere un mistero. In un piovoso pomeriggio di febbraio 1984 Philip Cannistraro raccontò a Brian Sullivan che forse le lettere di Benito Mussolini alla sua amante e confidente Margherita Sarfatti erano negli Stati Uniti. A rivelarglielo era stato l’anno precedente a Roma Renzo De Felice, il noto storico del fascismo italiano. (...) Seguendo gli indizi che ci fornì il professor De Felice, cominciammo le ricerche (...) Mentre eravamo alla ricerca delle lettere scomparse, scoprimmo Margherita Sarfatti. Come molte donne, Margherita era stata volutamente cancellata dalla storia. Mussolini non solo tentò di negarne il ruolo nella creazione del fascismo, ma dopo l’alleanza con Hitler non tollerò più che l’opinione pubblica fosse a conoscenza che una donna - un’ebrea - aveva contribuito quanto lui a costruire il regime fascista. Negli ultimi anni della dittatura ne fece una “non persona”. Lei, per salvar se stessa e la famiglia, si prestò al gioco. La conseguenza fu che ancora prima di morire, Margherita Sarfatti sparì nel nulla. A quei pochi che la ricordavano non sembrava altro che la protagonista della più lunga storia d’amore di Mussolini” (pp. 3-4).
 E nei “Ringraziamenti”, alla fine, gli Autori ancora precisano con chiarezza e forza: “Il professor Renzo De Felice, il maggior studioso del fascismo italiano, ci ha non solo suggerito l’argomento, ma ci ha ripetutamente dimostrato la sua simpatia e generosità fornendoci documenti, fonti e indicazioni preziose, e aprendoci, con la sua estesa rete di contatti, le porte degli archivi pubblici e privati. Il nostro debito nei suoi confronti è enorme” (p. 643).
E nei “Ringraziamenti”, alla fine, gli Autori ancora precisano con chiarezza e forza: “Il professor Renzo De Felice, il maggior studioso del fascismo italiano, ci ha non solo suggerito l’argomento, ma ci ha ripetutamente dimostrato la sua simpatia e generosità fornendoci documenti, fonti e indicazioni preziose, e aprendoci, con la sua estesa rete di contatti, le porte degli archivi pubblici e privati. Il nostro debito nei suoi confronti è enorme” (p. 643).

Nel 1993, De Felice - evidentemente molto segnato dall’incontro del 1961 - in una intervista con Stefano Folli (“La bella Margherita guardò Lucifero. Lì c’era scritto il destino di Benito”, “Il Corriere della Sera”, 1° febbraio 1993), ritorna ancora sul tema e fornisce ulteriori elementi relativi al “sogno” sarfattiano, del “rinato Sacro Romano Impero” (Gramsci), e della «riapparizione dell’impero sui colli fatali di Roma» (Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, la sera del 9 maggio 1936):
 “Di Mussolini non parlava quasi mai negli ultimi anni della sua vita... Mi disse: «Anche Augusto, dopo la morte di Livia, si avviò a diventare un Tiberio». Il significato autobiografico era evidente. Lei si identificava in Livia. Come dire: finché lui è rimasto con me, io sapevo tenerlo sulla retta via (...) Conservò sempre un particolare riserbo (...) Quando la conobbi era già molto vecchia. Non molto ieratica ma certo una bella donna. Consapevole del suo passato. (...) Le idee guida della sua vita si erano trasformate quasi in ossessioni. La principale era la romanità. Cioè il senso delle forme classiche come motivo dominante della civiltà artistica (...)".
“Di Mussolini non parlava quasi mai negli ultimi anni della sua vita... Mi disse: «Anche Augusto, dopo la morte di Livia, si avviò a diventare un Tiberio». Il significato autobiografico era evidente. Lei si identificava in Livia. Come dire: finché lui è rimasto con me, io sapevo tenerlo sulla retta via (...) Conservò sempre un particolare riserbo (...) Quando la conobbi era già molto vecchia. Non molto ieratica ma certo una bella donna. Consapevole del suo passato. (...) Le idee guida della sua vita si erano trasformate quasi in ossessioni. La principale era la romanità. Cioè il senso delle forme classiche come motivo dominante della civiltà artistica (...)".
MARGHERITA SARFATTI E "IL CULTO DEL LITTORIO". E non ultimo, sempre nel 1993, Emilio Gentile, allievo di De Felice, presso Laterza, pubblica “Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista”. In questo lavoro, e in particolare in tutto il capitolo intitolato “I templi della fede” (pp.197-228), l’attenzione al ruolo e al contributo di Margherita Sarfatti comincia a essere portata al livello dovuto e a dare i suoi frutti, ai fini di una nuova e più profonda comprensione di come e quanto, “fin dai primi anni del fascismo al potere” - come scrive Gentile (p. 240) -, la “euforia per la «nuova Era» sbrigliò” non solo “la fantasia monumentalistica degli architetti”, ma la fantasia degli uomini e delle donne della gran parte della società italiana e delle sue Istituzioni (e non solo laiche, ma anche religiose)!

STORIOGRAFIA. Nel 2003, nella scia del lavoro di Philip V. Cannistraro - Brian R. Sullivan e di Emilio Gentile, viene pubblicata la biografia di Simona Urso, “Margherita Sarfatti. Dal mito del Dux al mito americano” (Venezia, Marsilio, 2003): un lavoro fondamentale, per ripensare la figura di una protagonista della storia italiana e per ricominciare a riscrivere una più “felice” biografia sia di Mussolini sia del fascismo!

Nel 2015, Rachele Ferrario,nella sua biografia “Margherita Sarfatti” (Mondadori, 2015), pur focalizzando maggiormente l’attenzione sull’aspetto di “regina dell’arte nell’Italia fascista”, riprende l’intervista di Stefano Folli e, così, continua e commenta:
 “De Felice, che aveva colto la sensibilità di raffinato storico dell’arte della Sarfatti, vicino agli intellettuali europei - Focillon, Warburg, Le Corbusier -, era rimasto colpito dal racconto che Margherita aveva accompagnato con un gesto simbolico: «La ricordo benissimo nel vano della finestra aperta. Mi fece avvicinare e alzò un braccio esile, con un ditino lungo e un po’ arcuato. Per la precisione non indicò la luna, ma una stella. E con un tono concitato e allusivo sibilò: “Lucifero...”. Si riferiva, credo, alla stella del destino, che determina le azioni e la fine degli uomini» “(pp. 182-183).
“De Felice, che aveva colto la sensibilità di raffinato storico dell’arte della Sarfatti, vicino agli intellettuali europei - Focillon, Warburg, Le Corbusier -, era rimasto colpito dal racconto che Margherita aveva accompagnato con un gesto simbolico: «La ricordo benissimo nel vano della finestra aperta. Mi fece avvicinare e alzò un braccio esile, con un ditino lungo e un po’ arcuato. Per la precisione non indicò la luna, ma una stella. E con un tono concitato e allusivo sibilò: “Lucifero...”. Si riferiva, credo, alla stella del destino, che determina le azioni e la fine degli uomini» “(pp. 182-183).
MITO E STORIA: "LA STELLA DEL DESTINO" (1993). Delio Cantimori, nella prefazione al primo volume del lavoro di De Felice (“Mussolini il rivoluzionario 1883-1920”, Einaudi, Torino 1965), a solo quattro anni dall’incontro del suo allievo e amico con Margherita Sarfatti, già accennando alla “fine della carriera personale e individuale di Benito Mussolini” e all’ultimo volume di un’opera “così importante e di così ampio respiro” (p. XI), sottolinea la difficoltà del lavoro dello storico, richiama “la saga dei Nibelungi nella traduzione cinematografica di Fritz Lang, o, se si vuole, alcune pagine del vecchio Rovani”, e così prosegue:
 “[...] Nel giro della saga nibelungica Benito Mussolini era stato trascinato, durante gli ultimi anni della sua presenza sulla scena storica e politica, dal concatenarsi di eventi da lui in qualche modo presentiti [...] -Trascinato, in fin dei conti, e non sa da chi, né come: un uomo che cerca, - per usare un’immagine di De Felice, - e cammina seguendo una sua stella, - per usare un’immagine che fu attribuita a Mussolini -: la stella lo trae, - non si sa dove [...] ed osserviamo come ad un protagonista si addica non solo questo presentarsi quale uomo trascinato da questo o da quel «Fato» o «Destino», ma anche quel carattere generico e «classico» delle sue intuizioni politiche a lunga scadenza: propone e impone la direzione generale, e spesso vede o intravvede quel che c’è da fare in una situazione storica e in una data prospettiva, ma si lascia trainare dalla sua stella, non si occupa direttamente delle possibilità ed eventualità particolari” (p. XII).
“[...] Nel giro della saga nibelungica Benito Mussolini era stato trascinato, durante gli ultimi anni della sua presenza sulla scena storica e politica, dal concatenarsi di eventi da lui in qualche modo presentiti [...] -Trascinato, in fin dei conti, e non sa da chi, né come: un uomo che cerca, - per usare un’immagine di De Felice, - e cammina seguendo una sua stella, - per usare un’immagine che fu attribuita a Mussolini -: la stella lo trae, - non si sa dove [...] ed osserviamo come ad un protagonista si addica non solo questo presentarsi quale uomo trascinato da questo o da quel «Fato» o «Destino», ma anche quel carattere generico e «classico» delle sue intuizioni politiche a lunga scadenza: propone e impone la direzione generale, e spesso vede o intravvede quel che c’è da fare in una situazione storica e in una data prospettiva, ma si lascia trainare dalla sua stella, non si occupa direttamente delle possibilità ed eventualità particolari” (p. XII).
PROBLEMA: "LUCIFERO!". Prima che a Stefano Folli, nell’intervista del 1993, del lungo incontro del 1961 con Margherita Sarfatti, a Philip V. Cannistraro (in un colloquio del 6 ottobre 1985) Renzo De Felice aveva già così raccontato: “[...] verso la fine della conversazione Margherita si alzò dalla sedia e andò alla finestra, che inquadrava la luna piena sullo sfondo del cielo scuro. Tornando verso il suo ospite, gli posò una mano ossuta sulla spalla. «Venga, venga, professore,» lo pregò. Quando con De Felice raggiunse la finestra, Margherita lentamente alzò il braccio sottile e con il dito lungo e ricurvo indicò la stella della sera ed esclamò: «Lucifero!»" (cfr. Philip V. Cannistraro - Brian R. Sullivan, op.cit., p. 639).
Con il suo tono sibilante o esclamativo, cosa Margherita Sarfatti avesse voluto indicare o significare con la evocazione di “Lucifero”, a De Felice non fu chiaro né quella fatidica sera, né nel 1985, e né nel 1993. Con il voler credere che ella si volesse riferire “alla stella del destino”, egli continuò a ingannare solo se stesso e - come era già avvenuto - il suo stesso maestro, Delio Cantimori! E, paradossalmente, finì col ripetere - nei confronti di Margherita Sarfatti - lo stesso gioco del «duce»!

«VENGA, VENGA, PROFESSORE»: LA “LEZIONE” DELLA SARFATTI. Dal resoconto del racconto (a e) di Cannistraro, si percepisce in modo chiaro quale sia stato il tono del colloquio: “Si incontrarono nelle stanze di Margherita all’Hotel Ambasciatori in una sera tetra, gelida, e parlarono per ore. Margherita non si offrì di mostrare documenti al giovane studioso, né gli fornì rivelazioni. Gli aprì però uno squarcio sulla propria influenza sulla politica culturale del fascismo parlando a lungo del classicismo, che negli anni del regime era stato per lei uno dei capisaldi della critica d’arte. Per definire, inoltre, il proprio ruolo accanto a Mussolini e le cause della sua caduta citò un episodio della storia romana: «Anche Augusto, dopo la morte di Livia, si avviò a diventare un Tiberio...»" (op.cit., p. 639).
Per De Felice, l’intervista concessa da Margherita, contrariamente a quanto forse all’inizio avrà pensato, alla fine si è risolta in una sorprendente lezione e, al contempo, in un vero e proprio trauma! Per lo storico che nel 1961 aveva già tutto impostato e “da poco cominciato lo studio sistematico di Mussolini e del regime fascista”, la “provocazione” della Sarfatti fu inaccoglibile - insopportabile!
Nel 1965, infatti, fin dall’inizio del capitolo primo (“Gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza”) del volume primo, con il titolo “Mussolini il rivoluzionario 1883-1920” (Einaudi, 1965), con una dichiarazione (carica di straordinaria “superficialità” e di “autoritario” sprezzo), nei confronti della Sarfatti e della sua biografia (il “Dux” dell’edizione del 1932 alla 13
edizione - non del 1926, e senza alcun riferimento all’edizione inglese del 1925), così scrive (pp. 3-4):
 “I biografi di Mussolini, quelli che scrissero di lui dopo che egli era ormai divenuto il «duce» dell’Italia fascista, i Beltramelli [1923], le Sarfatti [1932], i De Begnac [1936], lo stesso Megaro [1947
(ed. inglese 1938)] - l’unico che per molti anni si sia posto di fronte alla figura di Mussolini non con l’animus dell’apologeta, ma neppure con quello del pamphlétaire, bensì con quello dello storico - hanno dato una grande importanza al fatto che egli sia nato e cresciuto in Romagna, alla sua «romagnolità»” (pp.3-4).
“I biografi di Mussolini, quelli che scrissero di lui dopo che egli era ormai divenuto il «duce» dell’Italia fascista, i Beltramelli [1923], le Sarfatti [1932], i De Begnac [1936], lo stesso Megaro [1947
(ed. inglese 1938)] - l’unico che per molti anni si sia posto di fronte alla figura di Mussolini non con l’animus dell’apologeta, ma neppure con quello del pamphlétaire, bensì con quello dello storico - hanno dato una grande importanza al fatto che egli sia nato e cresciuto in Romagna, alla sua «romagnolità»” (pp.3-4).
Per De Felice, la reazione (o, meglio, la “negazione”) fu sì “naturale” (come se l’incontro non ci fosse mai stato, continuò “tranquillo” per la sua strada), ma noi, di "Lucifero!" - come della Romagna, di Mussolini, di Sarfatti, e dello stesso Fascismo - ovviamente, continuiamo a sapere e a capire ancora ben poco!
L’ITALIA GIACOBINA, L’EFFETTO "LUCIFERO!" E “IL PREMIO NOBEL". All’incontro con Margherita Sarfatti, storica dell’arte, giornalista, scrittrice e intellettuale cosmopolita (e" ghostwriter del Duce", come hanno ben mostrato nel 1993 Cannistraro e Sullivan proprio sulle indicazioni di approfondimento dello stesso De Felice!), Renzo De Felice si era - per così dire! - preparato fin dall’inizio con il suo lavoro sul periodo della rivoluzione francese e dell’Italia giacobina, dalle tesi sulle "Correnti del pensiero politico nella prima repubblica romana" (1954), allo studio del "triennio giacobino in Italia (1796-1799)", alle ricerche "sugli illuminati e il misticismo rivoluzionario (1789-1800)", all’evangelismo giacobino e altri studi.
Nel saggio sulla "Opinione pubblica, propaganda e giornalismo politico nel 1796-1799", De Felice così scrive:
 "Ai giacobini italiani - in gran parte intellettuali e per il lungo esulato avulsi dalla vita e dal processo economico nazionale - mancò, oltre all’adesione delle masse e alla capacità di procurarsele, soprattutto una vera autonomia politico-sociale dal resto della borghesia. la loro grande forza fu una forza del tutto spirituale, psicologico-morale: fu la fede nella Rivoluzione e nella sua forza di rigenerazione. Nella loro azione è, da questo punto di vista, riscontrabile un che di religioso che inizia veramente il Risorgimento e inizia Mazzini. La loro grande debolezza fu di rimanere egemonizzati dal gradualismo della borghesia italiana del tempo" (cfr.: "I giornali giacobini italiani", a c. di R. De Felice, Milano 1962, p. 50).
"Ai giacobini italiani - in gran parte intellettuali e per il lungo esulato avulsi dalla vita e dal processo economico nazionale - mancò, oltre all’adesione delle masse e alla capacità di procurarsele, soprattutto una vera autonomia politico-sociale dal resto della borghesia. la loro grande forza fu una forza del tutto spirituale, psicologico-morale: fu la fede nella Rivoluzione e nella sua forza di rigenerazione. Nella loro azione è, da questo punto di vista, riscontrabile un che di religioso che inizia veramente il Risorgimento e inizia Mazzini. La loro grande debolezza fu di rimanere egemonizzati dal gradualismo della borghesia italiana del tempo" (cfr.: "I giornali giacobini italiani", a c. di R. De Felice, Milano 1962, p. 50).
Se è vero, come è vero, che alla fine del suo percorso, "da molto, tempo, andava palesando la sua insoddisfazione per l’interpretazione del fascismo che aveva dato fino ad allora", sicuramente - e contrariamente a quanto ipotizza Emilio Gentile (“Renzo De Felice. Lo storico e il personaggio”, Laterza, Bari 2003, p. 140) - "sarebbe tornato a studiare i «suoi» giacobini, come egli era solito ripetere con una certa civetteria", e avrebbe ripreso la sua strada in compagnia di Gramsci, proprio dal “Lucifero!” della Sarfatti (da tener presente: molto amica di Antonio Fogazzaro, convertita al cattolicesimo nel 1928), cioè, dal poeta dell’Inno a Satana, dal Carducci giacobino, a partire dalla nota sul racconto di Filippo Crispolti (giornalista, scrittore, e uomo politico, molto amico di Antonio Fogazzaro e cattolico favorevole alla collaborazione con il fascismo, in Parlamento fino agli ultimi anni della sua vita nel 1942 ):
 “Il premio Nobel. Filippo Crispolti ha raccontato in un numero del «Momento» del giugno 1928 (della prima quindicina) che quando nel 1906 si pensò in Svezia di conferire il premio Nobel a Giosuè Carducci, nacque il dubbio che un simile premio al cantore di Satana potesse suscitare scandalo tra i cattolici: chiesero informazioni al Crispolti che le dette per lettera e in un colloquio col ministro svedese a Roma, De Bildt. Le informazioni furono favorevoli. Così il premio Nobel al Carducci sarebbe stato dato da Filippo Crispolti” (“Quaderni del carcere”, Torino 1975, I, p. 79)!
“Il premio Nobel. Filippo Crispolti ha raccontato in un numero del «Momento» del giugno 1928 (della prima quindicina) che quando nel 1906 si pensò in Svezia di conferire il premio Nobel a Giosuè Carducci, nacque il dubbio che un simile premio al cantore di Satana potesse suscitare scandalo tra i cattolici: chiesero informazioni al Crispolti che le dette per lettera e in un colloquio col ministro svedese a Roma, De Bildt. Le informazioni furono favorevoli. Così il premio Nobel al Carducci sarebbe stato dato da Filippo Crispolti” (“Quaderni del carcere”, Torino 1975, I, p. 79)!
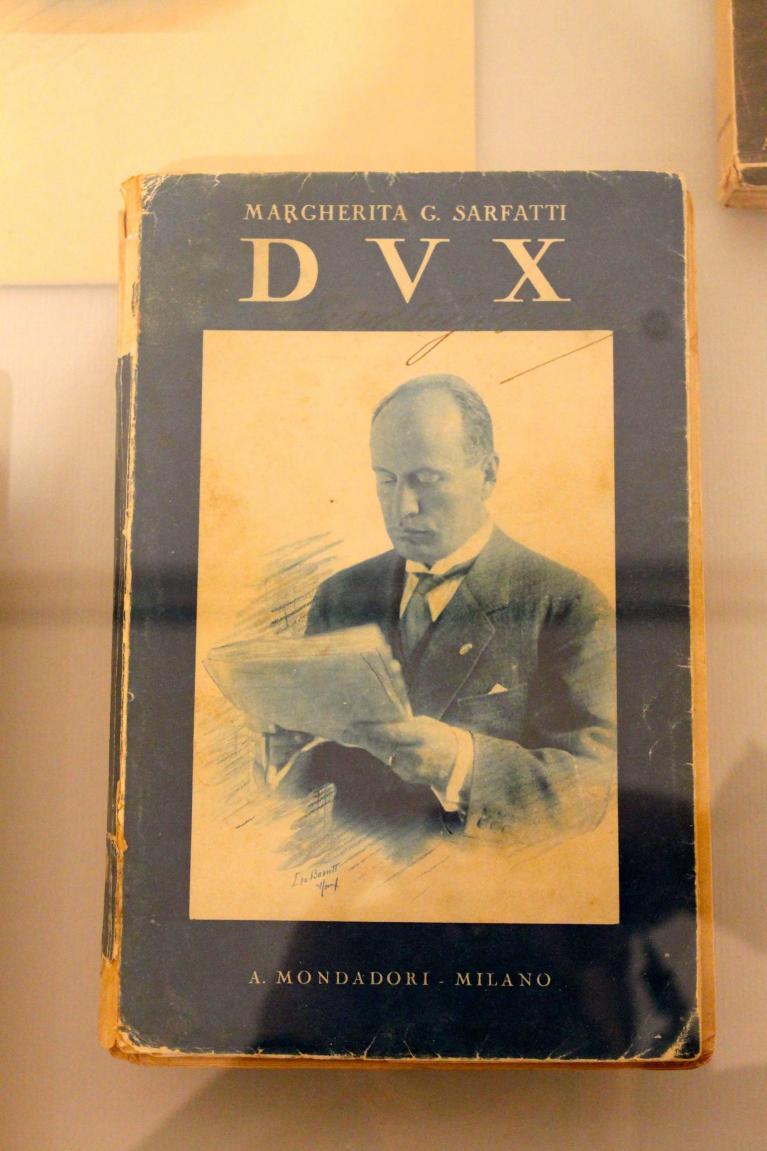
Nel capitolo dedicato al libro della Sarfatti, "Dux", nel loro lavoro, Cannistraro e Sullivan, con grande acume hanno colto il filo di questo nodo: "Già nel 1919, al momento della fondazione del primo fascio, Margherita aveva insistito sul valore ideologico e propagandistico che avrebbe avuto l’associazione del fascismo con Roma imperiale. Margherita vagheggiava un capo che imponesse alla civiltà moderna un nuovo genere di cultura, una cultura che poggiasse sulle virtù romane dell’ordine e della disciplina. La concezione che Margherita aveva di Roma non derivava tanto dallo studio approfondito dei classici, quanto dalla letteratura italiana del tardo Ottocento, in particolare dal poeta Giosue Carducci"; e, brillantemente, cercano di chiudere il cerchio: "Una quarantina d’anni dopo uno studioso italiano [Renzo De Felice], intervistando Margherita, rimase colpito nel constatare quanto fosse ancora malata di romanità"(op.cit., pp. 337-338).
“Carducci giacobino”: "Decapitaro, Emmanuel Kant, Oddio,/ Massimiliano Robespierre, il re" ("Versaglia. Nel LXXIX anniversario della Repubblica Francese", sulla "Plebe" di Lodi, 2 novembre 1871). Un tema carico di (storia e) teoria, su cui ricollegandosi al lavoro già di Gramsci in dialogo con Croce, Edoardo Sanguineti (anch’egli poco prima di morire, nel 2007) ha cercato ("Cultura e realtà", Milano, 2010, pp. 111-122) di chiarire con la sua straordinaria e viva intelligenza il "nodo epocale filosofico e politico", proprio per neutralizzare l’“effetto Lucifero” e, finalmente, uscire dall’inferno! Coraggiosamente: ha cercato, ha lottato, ma non è riuscito a venir fuori dal labirinto.
La questione è filologica, certamente - ma non è solo storica: è filosofica, teologica, e antropologica - e bisogna scavare ancora nella direzione indicata da Gramsci (e Marx, e Feuerbach, e Kant: a riguardo, cfr., in particolare, le note su "Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi") . E proseguire nel lavoro di De Felice - e dello stesso Sanguineti. Ricominciando, ovviamente, da "capo" - da Kant e Gramsci, dalla critica dell’ideologia dell’uomo supremo e del superuomo di appendice!
Federico La Sala
- MONARCHIA, NOBILTA’, CONSULTA ARALDICA, E FASCISMO: "Con il regio decreto 11 febbraio 1923, n 325 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 28 febbraio 1923, n 49), l’Ufficio della Consulta Araldica passa alle dipendenze della Presidenza del consiglio [Benito Mussolini, fls].
 A luglio 1923 viene inviata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica, ai Prefetti del Regno, circa la Repressione, abusi ed usurpazioni di titoli e distinzioni nobiliari (Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, vol. VIII).
A luglio 1923 viene inviata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica, ai Prefetti del Regno, circa la Repressione, abusi ed usurpazioni di titoli e distinzioni nobiliari (Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, vol. VIII).
 Il decreto ministeriale 29 agosto 1923, riconosce il titolo di «Nobile Romano» alla famiglia (Ratti) dell’allora regnante pontefice Pio XI"
Il decreto ministeriale 29 agosto 1923, riconosce il titolo di «Nobile Romano» alla famiglia (Ratti) dell’allora regnante pontefice Pio XI"
 (cfr. Pier Felice degli Uberti, L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO NOBILIARE NEL REGNO D’ITALIA E LA SUA “RESIDUALITÀ” NELLA REPUBBLICA ITALIANA, ARAMHG, XVI, 2013, p. 340).
(cfr. Pier Felice degli Uberti, L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO NOBILIARE NEL REGNO D’ITALIA E LA SUA “RESIDUALITÀ” NELLA REPUBBLICA ITALIANA, ARAMHG, XVI, 2013, p. 340).
- La politica nobiliare del Regno d’Italia 1861-1946. Actes du colloque de Rome, 21-23 novembre 1985 (Giorgio Rumi)
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
- Ex - "Impero"...
 ISTITUIRE LA GIORNATA DELLA MEMORIA per 500mila Africani uccisi dalla presenza coloniale italiana in LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA. UNA PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA
ISTITUIRE LA GIORNATA DELLA MEMORIA per 500mila Africani uccisi dalla presenza coloniale italiana in LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA. UNA PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA
- A. GRAMSCI, IL RISORGIMENTO ITALIANO (Ebraismo e antisemitismo). Nota su una recensione (1933) di ARNALDO MOMIGLIANO
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- CHIESA CATTOLICA E FASCISMI: "Nessuna protesta pubblica fu invece levata dai pulpiti contro le leggi di Norimberga, promulgate nel settembre 1935, che misero definitivamente al bando gli ebrei dalla vita pubblica, classificandoli come razza inferiore e pericolosa. Se proteste ci furono, furono solo in difesa degli ebrei battezzati. Le Chiese aprirono gli archivi parrocchiali alla verifica degli ascendenti ariani dei propri fedeli (Emilio Gentile, Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi, Feltrinelli 2011).
- CATTOLICESIMO E FASCISMO: "Secondo la posizione ortodossa, l’affermazione di qualsiasi credenza in contrasto con la dottrina della Chiesa rischia di porre il battezzato (e quindi, per quanto riguarda l’Italia, la quasi totalità della popolazione) nella condizione di “eretico”. A tale riguardo è illuminante l’esposizione di Giuseppe De Luca sotto la voce “eresia” nell’Enciclopedia Italiana" [Nota: "P Giuseppe De Luca era un collaboratore del p. Tacchi Venturi per le tematiche religiose dell’Enciclopedia, alla quale contribuì con ben 170 articoli. Scriveva inoltre sulle riviste fasciste di Giuseppe Bottai ed era amico di mons. Giovanni Battista Montini" (cfr. Thomas Dana Lloyd, "Il Tempio assalito: studio della campagna antiesoterica nell’Italia fascista", Politica Romana n. 5, 1998/1999).
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Walter Benjamin, l’inquilino in nero (Massimo Palma, "Alfabeta2", 11 gennaio 3017),
Enzo Traverso, il principio malinconia (Massimo Palma - "Alfabeta2", 24 marzo 1917).
Federico La Sala
L’EUROPA, LA SAGGEZZA STRANIERA, E L’ERRORE DEI GRECI (A. MOMIGLIANO). Nota
Forum
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- IL "DXV" DI DANTE, IL «CINQUECENTO E DIECI E CINQUE, MESSO DI DIO», ANCORA "RINCHIUSO" NELL’IMMAGINARIO DEL "DVX" ("DUCE") COSTANTINIANO.28 marzo 2025, di Federico La Sala
DANTE ALIGHIERI, LA "#MONARCHIA" DEI "#DUESOLI" E IL "DXV", IL «CINQUECENTO E DIECI E CINQUE, MESSO DI DIO», ANCORA "RINCHIUSO" NELL’IMMAGINARIO DEL "#DVX" ("DUCE") DELL’IMPERATORE #COSTANTINO ("IN HOC SIGNO VINCES", "I.H.S. VINCES"):
a) Dantedì (#25marzo 2025). Un’indicazione per uscire dal " #sottosuolo" (#DonDeLillo, "#Underworld", 1997):
 «Trasumanar significar per verba / non si porìa; però l’essemplo basti / a cui esperienza grazia serba.» (Par. I, 70-71);
«Trasumanar significar per verba / non si porìa; però l’essemplo basti / a cui esperienza grazia serba.» (Par. I, 70-71);b) Il “messo di Dio” di Gian Luca Potestà *:
"«Io sono uno di quelli che si rinfrancano lo spirito con gli anagrammi. La teologia è un po’ fuori dal mio campo», ci avverte Don Delillo in Americana. Dante è quel che ci vuole per rinfrancare questo spirito! A partire dal Veltro di Inferno I, la Commedia presenta diversi personaggi i cui profili restano racchiusi in enigmi e giochi di parole. Nella sezione finale del Purgatorio - comunemente detta “l’apocalisse di Dante” - la scena è occupata da un gigante violento che, montato su di un carro, se lo porta via (è Filippo il Bello, che deporta la Chiesa romana in Francia). Poco più sotto Dante gli contrappone un erede imperiale indicato solo come «un cinquecento diece e cinque, | messo di Dio» (Purgatorio XXXIII 43-44). Di lui non dice altro. Forse perché, scrivendo dopo la morte di Enrico VII, non sa chi potrà prenderne il posto.
Ma perché lo chiama così? I trattati medievali di grammatica attestano l’abitudine di trasformare termini indicanti numeri nelle corrispettive cifre numeriche romane. In questo caso, “cinquecento diece e cinque” = DXV. E poiché DXV non dà senso, già i primi lettori della Commedia proposero di modificare la successione delle lettere, leggendo DVX (= DUX) al posto di DXV. Ma perché Dante, se vuole evocare un DVX, non scrive semplicemente “cinquecento cinque e diece”? [...] Si presuppone che il lettore conosca il celeberrimo seicentosessantasei, misterioso nome della “bestia” secondo l’Apocalisse. In cifre romane: DCLXVI. Prese in questa sequenza, le lettere non significano nulla. Lungo la tradizione teologica latina si era peraltro trovato un curioso espediente interpretativo. Basta disporle diversamente, e le lettere rivelano il tratto più caratteristico dell’Anticristo, la sua fascinazione abbagliante: DIC LVX (“di’: luce”).
Ora capiamo: Dante civetta con l’Apocalisse di Giovanni e, insieme, con la tradizione che aveva inteso e spiegato il 666 come un anagramma. Nella propria apocalisse, per dare un nome al messia vendicatore prende tre numeri trasformabili in lettere (tre delle sei di Giovanni) e li dispone in sequenza anagrammatica. Al lettore comprendere e risolvere. Pochi versi più sotto, precisa che si tratta di un “enigma forte”. Enigma al quadrato: spetterà infatti alla storia rivelare il vero nome dell’atteso liberatore. Se oggi “la teologia è un po’ fuori dal campo”, talvolta aiuta almeno a “rinfrancare lo spirito”. (cfr. AA. VV., "DANTE, PADRE DEL POPOLO ITALIANO", "Vita e Pensiero", 2025 - n. 1).
- NOTA:
- STORIA, #STORIOGRAFIA, #ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, #LETTERATURA E #FILOLOGIA: L’ITALIA, IL SEDILE, LA SELLA CURULE, LA "X" DI "REX" E "DUX", HENRY W, #LONGFELLOW, E IL "DVX" DEL FASCISMO....
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- DANTE 2021: LE "RES GESTAE" DI AUGUSTO, L’ITALIA, E LE SUE "28 COLONIE".14 dicembre 2021, di Federico La Sala
DANTE 2021: ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA, E STORIOGRAFIA...
A 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI, UN INVITO A RILEGGERE la sua "Monarchia", a cercare di capire meglio le ragioni di "quella Roma onde Cristo è romano" (Purg. XXXII, 102), e rimeditare le "Res Gestae" di Augusto, alla luce dei 2046 anni dalla fondazione di Aosta, avvenuta nel 25 a. C., in coincidenza con il solstizio d’inverno.
AUGUSTO, L’ITALIA, E LE SUE "28 COLONIE":
- Le Res gestae divi Augusti, cioè Le imprese del divino Augusto, o Index rerum gestarum, sono un resoconto redatto dallo stesso imperatore romano Augusto prima della sua morte e riguardante le opere che compì durante la sua lunga carriera politica. Il testo ci è giunto inciso in latino e in traduzione greca sulle pareti del tempio di Augusto e della dea Roma (Monumentum Ancyranum) ad Ancìra (latino Ancyra), l’odierna Ankara in Turchia.
- Indice
- 1 L’originale e le copie sopravvissute
 2 Funzione e testo delle Res Gestae
2 Funzione e testo delle Res Gestae
 3 Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum
3 Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum
 [...]
[...]
- Testo latino e traduzione delle Res Gestae dal Monumentum Ancyranum
- Il testo si compone di un’introduzione, 35 paragrafi raggruppabili in 3 sezioni, e un’appendice.
- Pars prima (paragrafi 1 a 14): essa descrive la carriera politica di Augusto, il suo cursus honorum, le cariche, uffici e onori che egli ha ricevuto o dato.
- Pars altera (paragrafi 15 a 24): essa cita le distribuzioni di denaro, i giochi e i monumenti offerti al popolo di Roma.
- Pars tertia (paragrafi 25 a 35): in essa Augusto parla delle sue conquiste militari e della sua azione diplomatica.
- Appendix: scritta in terza persona contrariamente al resto del testo, non fu probabilmente scritta per mano di Augusto. Questa appendice riassume le spese sostenute da Augusto per l’erario, per i monumenti dell’Urbe, per i giochi e per far fronte a diverse calamità naturali. Illuminante l’ultima frase cui si citano le spese sostenute per amici e senatori, caduti tanto in disgrazia da non avere più il censo richiesto per far parte del senato. Tali spese furono innumerabilis, ovvero, non conteggiabili.
- Introduzione
- «Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi Romani subiecit, et impensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum in duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar sub[i]ectum.»
- «Narrazione delle imprese del divino Augusto attraverso le quali sottomise tutto il mondo al potere del popolo romano, e del denaro che spese per la Repubblica e per il popolo romano, come sta scritto su due pilastri di bronzo a Roma.
- [N 1. «La praescriptio non fu certamente scritta da Augusto, come dimostra l’epiteto divus conferito all’imperatore divinizzato solo dopo la sua morte.»]
- [...]
- «28. Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achai[a] Asia S[y]ria Gallia Narbonensi Pi[si]dia militum deduxi. #Italia autem XXVIII [colo]nias, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, me auctore deductas habet.»
- «28. Fondai colonie di soldati in Africa, in Sicilia, in Macedonia, in entrambe le Spagne, in Acaia, in Asia, in Siria, nella Gallia Narbonense, in Pisidia. L’#Italia poi possiede, fondate per mia volontà, ventotto colonie, che durante la mia vita furono assai prosperose e popolose»
- [N 53. Sull’identificazione delle 28 colonie augustee d’Italia, cfr. M. Lilli, "L’Italia romana delle regiones", 2004. La deduzione coloniale da parte di Augusto appare ragionevolmente certa per Ariminum, Ateste, Augusta Praetoria, Augusta Taurinorum, Bononia, Dertona, Fanum, Luceria, Lucus Feroniae, Minturnae, Parma, Pisae, Puteoli, Suessa, Urbs Salvia, Venafrum].
- [...]
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- Augusto (Roma, 23 settembre 63 a.C. - Nola, 19 agosto14) è Augusto; Costantino (Naissus, 27 febbraio 274 - Nicomedia, 22 maggio 337) è Costantino e la Donazione di Costantino è la donazione di Costantino - in memoria di Lorenzo Valla.
STORIA E STORIOGRAfIA DEL FASCISMO, "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (A. GRAMSCI, 1924).
 IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.
IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
Federico La Sala
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE. --- ’’Mario Sironi. Sintesi e grandiosità’’. Al Museo del Novecento di Milano, Mario Sironi in cento opere a 60 anni dalla morte (di E. Stefanelli).3 agosto 2021, di Federico La Sala
Mario Sironi in cento opere a 60 anni dalla morte
Al Museo del Novecento di Milano fino al 27 marzo
di Elisabetta Stefanelli (ANSA, 22 luglio 2021).
MILANO - Ci si perde nelle oltre cento opere di Mario Sironi esposte dal 23 luglio al 27 marzo al Museo del Novecento di Milano ma poi si trova il senso del suo percorso artistico. Per chi ama questo grande artista del secolo scorso, ’’Mario Sironi. Sintesi e grandiosità’’ è una lezione di storia dell’arte che attraversa tutte le forme dei suoi capolavori, dai colori asciutti quasi materici delle periferie, ai ritratti sempre ammantati di dolore, agli studi per gli affreschi monumentali come quello dell’Aula Magna della Sapienza a Roma. E poi le fasi umane ed artistiche che arrivano fino al tardo abbandono a quel male di vivere che lo aveva rincorso per tutta la vita, dandogli il dono di attraversare con una carica umana di straordinaria intensità una stagione di violenza. ’’Affrontare il progetto di una grande mostra su Mario Sironi con l’ambizione di raccontare, con uno sguardo nuovo, il percorso artistico e la vicenda umana che ha determinato le scelte, le relazioni e l’andatura della sua ricerca, è certamente un lavoro complesso’’, dice Anna Maria Montaldo direttrice del Museo del Novecento di Milano e curatrice della mostra insieme ad Elena Pontiggia, presentando la grande retrospettiva che ripercorre l’opera del Maestro a sessant’anni dalla morte avvenuta il 13 agosto del 1961 a Milano. La mostra è in collaborazione con Andrea Sironi-Strausswald (Associazione Mario Sironi, Milano) e Romana Sironi (Archivio Mario Sironi di Romana Sironi, Roma).
L’idea è infatti quella di ricostruire l’intero percorso artistico: dalla giovanile stagione simbolista all’adesione al futurismo; dalla sua originale interpretazione della metafisica nel 1919 al momento classico del Novecento Italiano; dalla crisi espressionista del 1929-30 alla pittura monumentale degli anni Trenta fino al secondo dopoguerra e all’Apocalisse dipinta poco prima della morte. Dal Museo del Novecento la mostra si estende anche nelle sale sironiane del Museo stesso e della Casa Museo Boschi Di Stefano, e si avvale di prestiti dai maggiori musei italiani tra cui la Pinacoteca di Brera, Ca’ Pesaro e la Fondazione Guggenheim di Venezia, il MART di Trento e Rovereto e da collezioni private. Il risultato è unico, e si possono ammirare alcuni capolavori che non comparivano in un’antologica sironiana da quasi mezzo secolo (l’affascinante Pandora, 1921-1922; Paese nella valle, 1928; Case e alberi, 1929; L’abbeverata, 1929-30), e altri completamente inediti.
Ampiamente rappresentato in mostra è il ciclo dei paesaggi urbani, il tema più famoso di Sironi, che acquista intensità dopo il suo arrivo a Milano nel 1919 ed esprime sia la drammaticità della città moderna, sia una volontà potente di costruire, in tutti i sensi. Tra questi ci sono capolavori ben noti come Sintesi di paesaggio urbano, 1921; La cattedrale, 1921; Paesaggio urbano col tram 1925-28, del Museo del Novecento, esposto alla Biennale di Venezia del 1928; la Periferia del 1943. Sironi però è stato anche un grande interprete della figura umana. Ne danno testimonianza qui un nutrito gruppo di opere, tra cui il pierfrancescano Nudo del 1923, prediletto da MargheritaSarfatti; la misteriosa Donna con vaso del 1924; il Pescatore, 1925; La fata della montagna, 1928; la Niobide del 1931, e il doloroso Lazzaro, 1946, dove, per la prima volta nella millenaria iconografia del soggetto, Sironi dipinge un Lazzaro che non risorge, simbolo del crollo di tutte le sue idee, a cominciare dal fascismo in cui aveva creduto.
Ampio spazio è poi dedicato al suo legame con la pittura murale negli anni Trenta, di cui fu teorico e interprete. Presenti, capolavori monumentali quali la luminosa Vittoria alata, il gigantesco studio per l’aula magna della Sapienza di Roma, il visionario Condottiero a cavallo (tutti realizzati nel 1935) e il potente studio preparatorio, lungo quasi sei metri, della Giustizia Corporativa (1937-38).
Lasciata alle spalle la sezione dedicata alla pittura murale, il "viaggio" nell’arte di Sironi volge al termine nelle ultime sale che documentano i drammatici anni finali dell’artista, tormentato anche dalla perdita della figlia Rossana, che si toglie la vita nel 1948 a diciotto anni.
Ad accompagnare la mostra, il catalogo realizzato della Casa Editrice Ilisso. "Mario Sironi. Sintesi e grandiosità" è parte de "La Bella Estate", il palinsesto culturale estivo promosso dal Comune di Milano che, fino al 21 settembre proporrà un ricco calendario di iniziative. (ANSA).
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- Il mito di Roma antica dall’Africa del Petrarca al fascismo (di Sara Benaglia - "Antinomie").13 maggio 2021, di Federico La Sala
Il mito di Roma antica dall’Africa del Petrarca al fascismo
di Sara Benaglia *
Pensando all’arte in Italia, alla sua distinzione tra antica e contemporanea e al ruolo patrimoniale oltre che culturale che essa ha in questo specifico territorio, non possono non essere notate contraddizioni in cui è chiaro che per garantire valore economico ad alcune opere si stia chiudendo un occhio sulla loro implicazione politica nel certificare il subumano.
Per quanto riguarda l’umanesimo, queste incongruenze emergono con chiarezza nell’opera forse maggiore di Francesco Petrarca (1304-1374). E l’interesse, e i dubbi verso l’umanesimo sono qui proposti alla luce di un limite del Post-human di Rosi Braidotti. Come evidenziato da David Lloyd in Under Representation: the Racial Regime of Aesthetics (2018), i termini che si riuniscono intorno al concetto di umano - libertà, autodeterminazione, diritti, proprietà - costituiscono le stesse linee di demarcazione che separano i soggetti umani dagli umani sottomessi. Nel Rinascimento - che potremmo dire iniziato proprio col Petrarca - l’essere universale è l’uomo bianco europeo. Il post-umano con le sue implicazioni scientifiche e tecnologiche è uscito da un desiderio di universalità? Come rispondere a questo quesito rispetto all’identità nera o sinti, per esempio? A chi appartiene l’universale (post-umano)?
Che cosa sono l’umano e il subumano nell’umanesimo petrarchesco? Questa domanda è posta rispetto all’opera che diede a Petrarca la gloria, quella per cui i suoi contemporanei lo premiarono con la corona di lauro in Campidoglio [1] sulle rovine della Roma classica: quest’opera è L’Africa.
La cultura Rinascimentale è strettamente legata alle espansioni geografiche, ma la relazione tra Rinascimento e “scoperte” ( vd. conquiste) ha per “tradizione” connotazioni positive. Nel XIV secolo viene riscoperta la letteratura greca, diffuso il superiore sapere dell’antichità, e avanzano i confini geografici - si pensi alla colonizzazione delle Canarie nel 1312 da parte di Lancelotto Malocello - il che non necessariamente implica una tolleranza di culture altre, anzi, può avere spinto l’italiano[2] rinascimentale a recuperare vecchi miti. È questo il caso de L’Africa, composta da Petrarca tra il 1339 e il 1343 e dedicata al re di Napoli Roberto d’Angiò[3]. Boccaccio (che negli stessi anni componeva De Canaria et insulis reliquis ultra hispaniam noviter repertis), e i circoli del primo umanesimo hanno in grande considerazione quest’opera, composta in lingua latina e appartenente al genere letterario dell’epopea. L’eroe protagonista dell’opera è Publio Cornelio Scipione l’Africano (Roma, 236 a.C. - Liternum, 183 a.C.), il vir vere Romanus che, dopo aver invaso l’Africa in risposta all’invasione dell’“Italia” da parte di Annibale, sconfigge quest’ultimo a Zame (202 a.C.). L’opera è un poema epico ispirato al Somnium Scipionis (54 a.C.) di Cicerone, il brano del De re publica in cui la seconda guerra punica viene narrata tramite l’espediente del sogno. A Scipione Emiliano compare in sogno Scipione l’Africano preannunciandogli glorie future e una morte prematura.
- [Foto] Anonimo, Francesco Petrarca nello studium, affresco murale, ultimo quarto del secolo XIV, Reggia Carrarese, Sala dei Giganti
Il Petrarca decide di narrare la gloria di Scipione l’Africano dopo aver visitato Roma nel 1337, sospinto da uno spirito volto al ritorno delle grandiosità romane antiche. Per molti anni il poeta intrattiene uno scambio epistolare con l’imperatore Carlo IV, per il quale desidera che dia “inizio al rinnovamento del dominio romano sul mondo, cominciando con la liberazione della Terra Santa”[4]. Petrarca è il più celebre continuatore del sistema letterario classico, ed è fiero di questa posizione che egli vede in stretta connessione con un tipo concreto di civiltà. Egli desidera che l’imperatore risieda a Roma e che da lì, da questa componente “naturale” del mondo classico, governi il mondo. Per il poeta l’impero romano è un’idea eterna, la riappropriazione dell’antichità, dei suoi eroi mitici.
Petrarca sognava che L’Africa sarebbe stata riscoperta in futuro [5] e che, riemersa dalle tenebre, avrebbe dato origine a un nuovo rinascimento. Ebbene, il mito di Roma antica riemerge proprio nella propaganda fascista, che si propone come una riedizione delle vecchie glorie romane. E ancora prima di lui è l’inno risorgimentale di Mameli ad aprirsi proprio con l’elmo di Scipio, di cui l’Italia si sarebbe cinta la testa prima della guerra di indipendenza dall’Austria. Il cesarismo petrarchesco di Scipione l’Africano non lascia affatto indifferente né il risorgimento imperialista né il duce Benito Mussolini, che imita l’Imperatore Ottaviano.
Le campagne coloniali sono strumentali per la creazione dell’unità nazionale italiana, e il loro precedente storico è proprio l’Impero Romano. Il recupero di una romanità fittizia è evidente anche nel film di propaganda fascista[6] Scipione l’Africano (1937). Questo colossal di Carmine Gallone rientra tra i tentativi di legittimare una continuità storica tra Roma antica e l’impero fascista, con lo scopo di portare Mussolini sul piano del condottiero latino Scipione. Per fare questo il regime non bada a spese, producendo uno dei fiaschi più clamorosi della storia del cinema[7].
- [Foto] Domenico Ghirlandaio, Decio, Scipione e Cicerone in Apoteosi di san Zanobi e ciclo di uomini illustri (1482-84), Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio a Firenze
L’impero romano è stato un “arsenale di miti” tanto per la nascita del Rinascimento quanto per la scrittura di miti fascisti. È molto poco spesso evidenziata la responsabilità del Rinascimento nel veicolare fantasie virili, mentre dà lustro alla sua committenza, qualificando l’immagine pubblica di uomini (mercanti banchieri, papi e capitani di sventura) che spesso hanno una reputazione improbabile[8]. Il machismo fascista è invece condensato in una retorica dietro a cui è celata la violenza di Stato.
L’Africa del Petrarca nei secoli è stata dimenticata, e dell’autore sono state tramandate soprattutto le poesie in volgare. Ma è proprio questo prolungato silenzio accompagnato dalla “copertura” delle cattiverie rinascimentali con l’ideale di Bellezza, ad aver stimolato in me l’idea che in qualche modo una radice del fascismo italiano possa risiedere proprio nell’intoccabile Rinascimento italiano. Non è forse questa tradizione classica una forma di giustificazione di un confine geografico e umanistico che segna una sorta di primato italico pre-moderno?
Un fattore caratteristico del fascismo eterno è proprio il culto della tradizione - quella, però, che Walter Mignolo (1995) definisce come il processo di ricordare e dimenticare -, poiché la sua cultura sincretistica tollera contraddizioni in nome di una verità primitiva [9], e tale verità potrebbe essere proprio il tentativo secolare di scrivere, di decretare l’esistenza, di un’italianità priva di origine.
E se la storia dell’arte ha condannato artisti come Mario Sironi per la loro relazione con il fascismo, perché i futuristi sono entrati in collezioni museali senza che la collusione politica alterasse valutazioni del loro operato se non marginalmente? Che ruolo ha la bellezza nelle rimozioni di certe parti della Storia? Come ha attecchito la retorica del classicismo nell’arte contemporanea?
[1] La corona d’allora fu offerta a Petrarca sia dalla città di Roma sia dall’Università di Parigi. Petrarca rifiutò il rito medievale offerto dalla seconda e optò per una incoronazione da parte del Senato di Roma e del suo popolo per patriottismo.
[2] Ovviamente si tratta di una generalizzazione geografica, perché non c’è stata nessuna Italia prima del 1861.
[3] Bodo Guthmüller, Il volgarizzamento dell’«Africa» di Fabio Marretti: contributo alla fortuna del Petrarca nel Cinquecento, Lettere Italiane, Vol. 32, No. 1 (GENNAIO-MARZO 1980), pp.43-53. Pubblicato dalla Casa Editrice Leo S. Olschki.
[4] Jiří Špička, Petrarca e l’impero romano, Lettere Italiane, Vol. 62, No. 4 (2010), p. 529. Pubblicato dalla Casa Editrice Leo S. Olschki.
[5] Nel Quattrocento i valori estetico-culturali dati alle opere di Petrarca mutano: il fatto che gli autori antichi fossero considerati irraggiungibili e idealizzati porta a una tendenza verso il purismo linguistico (con Virgilio e Cicerone come modelli esclusivi) e quindi a un allontanamento dall’ammirazione incondizionata delle opere del Petrarca in lingua latina. Per questa ragione opere volgari che il Petrarca stesso considerava di poco valore furono le più apprezzate di questo autore.
[6] Il cinema è “l’arma più efficace” secondo il regime fascista e la creazione della mostra internazionale di Venezia (1932) e la Fondazione di Cinecittà (1937) sono due esempi del rilancio fascista dell’industria filmica italiana
[7] Il film è riportato da The Hollywood Hall of Shame (1984) tra le follie fasciste a fianco del tedesco Kolberg (1945), nonostante gli enormi sforzi promozionali anche del Ministero della Cultura Popolare. Come evidenziato da Giuman e Parodo, fu Luigi Freddi - alla Direzione Generale per la cinematografia - a scegliere di evitare una propaganda troppo diretta del regime, favorendo la produzione di “filmi” quali Squadrone bianco (1936), Luciano Serra Pilota (1938) o L’assedio di Alcazar (1940). In Garrone è chiara l’equivalenza tra Roma dei Cesari e Roma fascista, e a noi la sua insensatezza.
[8] Alexander Lee, Il Rinascimento cattivo. Sesso, avidità, violenza e depravazione nell’età della bellezza, Bompiani, Milano 2013, p. 24.
[9] Umberto Eco, Il fascismo eterno, La nave di Teseo, Milano 2017, pp. 34-35.
* Fonte: Antinomie, 05/05/2021 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE. -- STORIA E STORIOGRAFIA: USA 1920/USA 2020. First Ladies: Jill Biden, sulle orme di Eleanor Roosevelt (di Rossella Rossini).13 novembre 2020, di Federico La Sala
Jill Biden, il cambio della first ladyship sulle orme di Eleanor
First Ladies. Nel primo anno da first lady Eleanor Roosevelt guadagnava quanto il presidente, spendendo i suoi soldi per cause sociali e l’emancipazione delle donne.
di Rossella Rossini (il manifesto, 13.11.2020)
Complice oltre un secolo di storia di emancipazione delle donne, di cui il suffragio universale, nel 1920 in tutti gli Stati dell’Unione, segnò una tappa importante, la svolta produsse un cambio di rotta nella first ladyship degli Stati uniti e continua a rappresentare un lascito prezioso. La scelta di Jill Biden di non rinunciare alla sua professione di insegnante di lingua e letteratura inglese colloca la nuova prima cittadina sulla strada dell’indipendenza aperta da Eleanor Roosevelt nei dodici anni trascorsi alla Casa Bianca (1933-1945), ma già imboccata come first lady dello Stato di New York, di cui Franklin Delano Roosevelt fu governatore.
Eleanor Roosevelt aveva nutrito dubbi sulla candidatura del marito e aveva accolto con perplessità la vittoria alla convenzione democratica, nel timore che ciò potesse comportare la rinuncia alla sua vita pubblica e alle sue molteplici attività. Invece, avrebbe saputo arricchire il nuovo ruolo di inedite funzioni, cementando l’unione con Franklin come «coppia politica» e divenendo negli anni una first lady a tutto tondo, che condivideva e sosteneva gli obiettivi del consorte e intanto faceva passi da gigante lungo il cammino dell’autonomia.
 Leader riconosciuta nel mondo dell’associazionismo, si batteva per la pace, l’eguaglianza e la democrazia; per l’internazionalismo; per i diritti delle donne, degli afroamericani e delle fasce più emarginate della popolazione, destreggiandosi con la stessa maestria sulla scena pubblica e politica degli Stati Uniti e tra i suoi numerosi interessi e mestieri.
Leader riconosciuta nel mondo dell’associazionismo, si batteva per la pace, l’eguaglianza e la democrazia; per l’internazionalismo; per i diritti delle donne, degli afroamericani e delle fasce più emarginate della popolazione, destreggiandosi con la stessa maestria sulla scena pubblica e politica degli Stati Uniti e tra i suoi numerosi interessi e mestieri.Di essi fecero parte l’insegnamento di storia, letteratura e affari pubblici alla Todhunter School di New York, una scuola privata per ragazze di cui era anche comproprietaria e co-direttrice; l’intenso lavoro giornalistico per testate e stazioni radiofoniche, anche commerciali, che portavano la sua voce e il suo pensiero fino negli angoli più remoti del paese; l’attività di imprenditrice, con la fondazione e gestione assieme a due amiche femministe delle Val-Kill Industries, di cui facevano parte una fabbrica di mobili, una fornace per metalli e una tessitura, che insegnavano un mestiere e davano lavoro a giovani non più in grado di mantenersi nei campi impoveriti dalla depressione.
 Alla fine del primo anno da first lady della nazione Eleanor guadagnava quanto il presidente, spendendo tutti i suoi introiti per cause sociali e, forse, vedendo la sua lotta per consolidare la propria indipendenza anche economica connessa alla più ampia battaglia per i diritti e l’emancipazione combattuta per tutte le donne.
Alla fine del primo anno da first lady della nazione Eleanor guadagnava quanto il presidente, spendendo tutti i suoi introiti per cause sociali e, forse, vedendo la sua lotta per consolidare la propria indipendenza anche economica connessa alla più ampia battaglia per i diritti e l’emancipazione combattuta per tutte le donne.L’indipendenza non fu solo economica. Dopo l’elezione di Franklin alla guida della nazione, furono quasi 40.000 i chilometri percorsi da Eleanor nei primi mesi del primo dei quattro mandati del marito per diffondere i valori e le politiche del New Deal, avere un resoconto di prima mano dello stato in cui versava il paese sconvolto dalla Grande Depressione e riferirne al presidente, contribuendo attivamente all’adozione delle politiche di relief.
 Ma se apparentemente si prestava a svolgere il ruolo di supporting wife, come aveva già fatto in qualità di first lady dello Stato di New York, nel corso di quelle visite e di quei viaggi maturava non solo la Eleanor «occhi e orecchie» del presidente, limitato nei suoi spostamenti dalla poliomielite che lo aveva colpito nel 1921, ma l’attivista e riformatrice, colei che, già conosciuta e riconosciuta come leader politica autonoma e fortemente radicata in quella che oggi si definisce la società civile, rappresentava l’ala più progressista della nuova era, attenta e sensibile alle questioni di giustizia economica e sociale, ai diritti delle donne e dei giovani, delle minoranze e dei lavoratori e impegnata a battersi contro razzismo e discriminazioni.
Ma se apparentemente si prestava a svolgere il ruolo di supporting wife, come aveva già fatto in qualità di first lady dello Stato di New York, nel corso di quelle visite e di quei viaggi maturava non solo la Eleanor «occhi e orecchie» del presidente, limitato nei suoi spostamenti dalla poliomielite che lo aveva colpito nel 1921, ma l’attivista e riformatrice, colei che, già conosciuta e riconosciuta come leader politica autonoma e fortemente radicata in quella che oggi si definisce la società civile, rappresentava l’ala più progressista della nuova era, attenta e sensibile alle questioni di giustizia economica e sociale, ai diritti delle donne e dei giovani, delle minoranze e dei lavoratori e impegnata a battersi contro razzismo e discriminazioni.All’interno della partnership politica con il marito, Eleanor cercò sempre di portare avanti i progetti che le stavano più a cuore: la battaglia per l’adesione degli Stati Uniti alla Corte internazionale di giustizia; l’estensione alle donne dei programmi volti ad aumentare l’occupazione nei lavori pubblici; il progetto di riqualificazione abitativa per le famiglie povere dei minatori della Virginia occidentale; le politiche a favore degli afroamericani; programmi per i giovani, con la creazione della National Youth Administration, a lei dovuta e di cui andava fiera; una legge federale contro i linciaggi.
 Oltre 200 disegni sono stati respinti al Congresso per 120 anni dal blocco dei suprematisti bianchi del Sud eletti al Senato, fino al Justice for Victims of Lynching Act of 2019 che rende il linciaggio crimine federale, discusso e approvato all’unanimità il 14 febbraio 2019.
Oltre 200 disegni sono stati respinti al Congresso per 120 anni dal blocco dei suprematisti bianchi del Sud eletti al Senato, fino al Justice for Victims of Lynching Act of 2019 che rende il linciaggio crimine federale, discusso e approvato all’unanimità il 14 febbraio 2019.
 A presentarlo come prima firmataria la senatrice democratica Kamala Harris. Dovrebbero mancare pochi passi perché diventi definitivamente legge ed entri nel codice penale.
A presentarlo come prima firmataria la senatrice democratica Kamala Harris. Dovrebbero mancare pochi passi perché diventi definitivamente legge ed entri nel codice penale. -
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- Sabaudia diventa Città. Conferito dal presidente della Repubblica Mattarella in accoglimento della proposta del Ministro dell’Interno Lamorgese.1 novembre 2020, di Federico La Sala
Sabaudia diventa Città: il Consiglio straordinario per la presa d’atto del titolo
Conferito dal presidente della Repubblica Mattarella in accoglimento della proposta del Ministro dell’Interno Lamorgese. La cerimonia in piazza del Comune
di Redazione (Latina Today, 05 agosto 2020)
“Sabaudia, una comunità che cresce e diventa città”: così si racchiude tutto il senso della cerimonia di oggi, 5 agosto, alle 19 in piazza del Comune con la seduta straordinaria del Consiglio comunale per la presa d’atto del titolo di Città, conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in accoglimento della proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.
Una data storica quella di oggi, e “un’assegnazione importante sotto il profilo istituzionale - commentano dall’Amministrazione - attraverso il quale la massima carica dello Stato riconosce l’importanza storica, architettonica, culturale e artistica di Sabaudia, emblema di un territorio che ha saputo riscattarsi nel tempo, spodestando il contesto malarico e paludoso per iniziare, nei primi anni Trenta, un percorso virtuoso di insediamento demografico e di urbanizzazione, arrivando a definire al contempo un assetto sociale, economico e culturale degno di nota”.
Il Consiglio Comunale verrà aperto dall’Inno d’Italia e l’Inno alla Gioia, eseguiti dalla Banda Musicale del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia diretta dal Maresciallo Pasquale Casertano. A conclusione dell’Assise si terrà invece il cambio del Gonfalone, della Bandiera della Città di Sabaudia e della fascia tricolore del sindaco. Il Gonfalone e la Bandiera utilizzati prima del riconoscimento del titolo di Città, entreranno a far parte dell’archivio storico di Sabaudia e verranno esposti presso il centro di documentazione “A.Mazzoni”.
A seguire, in considerazione dell’alto momento istituzionale e in virtù del senso di comunità che vedrà la città riunita, l’Amministrazione comunale conferirà un riconoscimento simbolico a quanti hanno offerto il proprio contributo e supporto nella gestione del problema che ha coinvolto le scuole del territorio in gran parte dell’anno scolastico 2019/2020. Il momento, all’insegna della coesione e di spiccata solidarietà sarà introdotto da altri due brani eseguiti sempre dalla Banda dell’Artiglieria : Ischia Marcia Brillante del Maestro Michele Lufrano e Otto e mezzo, dall’omonimo film di Federico Fellini, del Maestro Nino Rota.“
Sabaudia, il presidente della Repubblica Mattarella assegna il titolo di Città
Accolta la proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Un titolo che riconosce l’importanza storica, architettonica, culturale e artistica di Sabaudia. Il sindaco: “Siamo orgogliosi”
di Redazione (LatinaToday, 26 giugno 2020)
Sabaudia diventa Città. La notizia diffusa dall’Amministrazione dopo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con apposito decreto, ha conferito il titolo onorifico al Comune pontino, accogliendo la proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.
“Un riconoscimento che inorgoglisce e che arriva - quasi inaspettatamente considerato il delicato momento che l’Italia sta vivendo - al termine di un iter procedurale iniziato con la deliberazione di Consiglio comunale (n. 56 del 28 novembre 2019) e proseguito con il parere favorevole della Prefettura di Latina” commentano dall’Amministrazione.
“Con l’assegnazione del titolo di Città è stata ufficialmente riconosciuta l’importanza storica, architettonica, culturale e artistica di Sabaudia, emblema di un territorio che ha saputo riscattarsi nel tempo, spodestando il contesto malarico e paludoso per iniziare, nei primi anni Trenta, un percorso virtuoso di insediamento demografico e di urbanizzazione, arrivando a definire al contempo un assetto sociale, economico e culturale degno di nota.
La relazione del Ministro dell’Interno - proseguono dal Comune - traccia un quadro ben chiaro di tutto ciò, evidenziando non solo la rinomata architettura razionalista, ancora oggi oggetto di studio per studenti e ricercatori, ma anche la sua vocazione turistico-culturale e quel suo essere punto di riferimento per la storia e l’archeologica. Particolare valore è stato dato alla sua essenza ‘green’ e alla sua permanenza all’interno del Parco Nazionale del Circeo, uno dei cinque parchi ‘storici’ italiani, senza dimenticare il rapporto privilegiato con il comparto agricolo e con il mondo del cinema e dello sport. Infine la posizione strategica, il lungomare e i tre bacini lacustri, l’aspetto demografico, il welfare, la cultura e l’attenzione al fenomeno immigratorio, elemento importante per una città accogliente per antonomasia”.
“Il titolo di Città ci inorgoglisce e rende felici perché dà ancora più valore alla nostra Sabaudia, alle sue peculiarità e alle tante bellezze ed eccellenze di cui si fregia. Ma ancor di più, rafforza la nostra visione strategica del territorio, che inizia con la tutela e valorizzazione del passato e che prosegue proiettandosi al futuro, in un continuo percorso di sviluppo che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini, inglobandoli in un rapporto di crescita e reciproco scambio - commenta il sindaco Giada Gervasi - A nome di tutta l’Amministrazione e della comunità che rappresento, vorrei ringraziare il Presidente Mattarella e il Ministro Lamorgese per questo importante riconoscimento conferito, senza tralasciare Sua Eccellenza il Prefetto di Latina Trio, per il sostegno dato alla causa e per la sua instancabile presenza a tutela di un territorio secondo a nessuno. Mi sia consentito un ringraziamento al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Settore Affari Generali e in particolare all’Assessore Gianpiero Macale, che ha fortemente voluto consegnare a Sabaudia il titolo onorifico impegnandosi in prima persona per tutto quanto necessario. Infine, e non per ultimo, rivolgo un pensiero ai miei concittadini, affinché possano tutti, indistintamente, gioire di questo conferimento e festeggiare simbolicamente la nostra Sabaudia che cresce e diventa Città”.“
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- UNA LEZIONE DI ARALDICA. Un approfondimento sullo stemma della città di Aprilia (di don Antonio Pompili).1 novembre 2020, di Federico La Sala
LO STEMMA DELLA CITTA’ DI APRILIA *
Un approfondimento
di don Antonio Pompili, Socio Ordinario dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano
Lo stemma di una città riflette le peculiarità, le tradizioni del suo territorio, della sua storia, rappresentando, attraverso figure e colori scelti per il loro significato simbolico, i valori sui quali la città è stata concepita e nei quali una intera comunità si riconosce, perché assimilatati nel corso delle generazioni e degli eventi che ne hanno caratterizzato il passato. Aprilia, come gli altri comuni di fondazione dell’Agro Pontino è il risultato di un intervento massiccio e invasivo dell’uomo che, attraverso la bonifica tentata per più volte nel corso della storia ma realizzata solo nel secolo passato, ha modificato sostanzialmente un ambiente ostile all’uomo e al suo insediamento, convertendolo alle sue esigenze economiche, politiche e strategiche. Si tratta di uno scenario completamente nuovo rispetto ad origini molto più antiche vantate da moltissimi altri comuni italiani che, nati a partire dal Medioevo, trovarono la base vitale per la genesi dei relativi stemmi civici nelle insegne dei signori che dominavano i loro territori, o in miti legati alla loro fondazione, o ancora negli stilemi architettonici di torri, castelli, abbazie e altri monumenti che ne tratteggiarono i connotati e tutt’oggi ne costituiscono il fascino.
 Il processo di composizione delle insegne araldiche di Aprilia è stato fortemente condizionato dall’assenza di una storia civica o di miti fondatori cui appellarsi, prevalendo dunque inevitabilmente l’aspetto politico e ideologico, insieme al nome stesso imposto alla Città, scelto per il suo valore simbolico.
Il processo di composizione delle insegne araldiche di Aprilia è stato fortemente condizionato dall’assenza di una storia civica o di miti fondatori cui appellarsi, prevalendo dunque inevitabilmente l’aspetto politico e ideologico, insieme al nome stesso imposto alla Città, scelto per il suo valore simbolico.Lo stemma della Città di Aprilia si caratterizza come un’arma «parlante», più specificamente diremmo «alludente», in quanto le figure che lo caratterizzano, le 5 rondini che si stagliano su un campo di cielo, richiamano in maniera allusiva il nome stesso della Città, che è legato alla fondazione nel mese di Aprile (del 1936).
 Quarta città dell’Agro Pontino bonificato (dopo Littoria, oggi Latina, quindi Sabaudia e Pontinia), il nome che le fu imposto suona come fortemente augurale poiché allude all’«aprirsi» del luogo ad una nuova vita. Presso l’Archivio Centrale dello Stato si trova un documento a firma dell’Architetto Oriolo Frezzotti, autore del piano regolatore di Latina e degli edifici pubblici di Pontinia e anche di alcuni a Sabaudia.
Quarta città dell’Agro Pontino bonificato (dopo Littoria, oggi Latina, quindi Sabaudia e Pontinia), il nome che le fu imposto suona come fortemente augurale poiché allude all’«aprirsi» del luogo ad una nuova vita. Presso l’Archivio Centrale dello Stato si trova un documento a firma dell’Architetto Oriolo Frezzotti, autore del piano regolatore di Latina e degli edifici pubblici di Pontinia e anche di alcuni a Sabaudia.
 In una cartella presente nel fondo relativo al Comune di Pontinia si trova un appunto manoscritto dello stesso Frezzotti che descrive l’origine del nome dei centri dell’Agro Pontino. Secondo tale documento la descrizione dell’origine del nome di Aprilia, sulla quale si basa l’iconografia simbolica dello stemma della Città, è da individuarsi - similmente agli altri comuni pontini di nuova fondazione - come aggettivo del sostantivo civitas, per cui Aprilia civitas è «la città dell’Aprile o della Primavera».
In una cartella presente nel fondo relativo al Comune di Pontinia si trova un appunto manoscritto dello stesso Frezzotti che descrive l’origine del nome dei centri dell’Agro Pontino. Secondo tale documento la descrizione dell’origine del nome di Aprilia, sulla quale si basa l’iconografia simbolica dello stemma della Città, è da individuarsi - similmente agli altri comuni pontini di nuova fondazione - come aggettivo del sostantivo civitas, per cui Aprilia civitas è «la città dell’Aprile o della Primavera».Il primo bozzetto acquerellato dello stemma del nuovo centro dell’Agro Pontino fu predisposto da Araldo di Crollalanza, presidente dell’O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti), e erede di una famiglia di insigni araldisti che contribuirono tra la fine del XIX sec. e l’inizio del XX a un aggiornamento in Italia della scienza del blasone. -Il Crollalanza spedì il bozzetto, realizzato su un cartoncino di tipo bristol di dimensioni 24 per 32 centimetri, il 2 ottobre del 1937: esso consisteva in uno scudo azzurro su cui erano presenti cinque rondini nere sormontate dal Capo del Littorio, che in base alle leggi allora in vigore (R.D. n. 1440 del 12 ottobre 1933) doveva completare gli stemmi civici e che era di rosso con fascio littorio d’oro, circondato da due rami di quercia e d’alloro annodati da un nastro dei colori nazionali. Tra il capo e il campo principale vi era un «filetto d’argento». -Tale presenza si giustificava probabilmente ai fini di una corretta sintassi araldica, per evitare quello che in termine tecnico si direbbe un «cucito», vale a dire l’accostamento diretto tra di loro di due dei cinque «colori» (rosso, azzurro, verde, porpora, nero) o dei due «metalli» (oro e argento) contemplati come «smalti» propri dall’araldica. In questo caso per evitare l’accostamento tra il rosso del capo littorio e l’azzurro del campo principale.
 Simile accortezza non è riscontrabile negli originali stemmi degli altri comuni pontini che pure furono costituiti nelle loro versioni al tempo del regime fascista da uno scudo d’azzurro. Lo scudo del bozzetto per lo stemma di Aprilia era infine sormontato da una corona color giallo-oro e ornato ai fianchi e in punta da un listello bicolore giallo e verde.
Simile accortezza non è riscontrabile negli originali stemmi degli altri comuni pontini che pure furono costituiti nelle loro versioni al tempo del regime fascista da uno scudo d’azzurro. Lo scudo del bozzetto per lo stemma di Aprilia era infine sormontato da una corona color giallo-oro e ornato ai fianchi e in punta da un listello bicolore giallo e verde.Nell’istanza di richiesta indirizzata dal Commissario prefettizio (che ad Aprilia assolveva alle funzioni del Podestà) al Re Vittorio Emanuele III, oltre al disegno a colore dello stemma, furono indicati i criteri seguiti per la composizione simbolico-raffigurativa dello stemma comunale. Ne emergeva da una parte come lo stemma volesse illustrare il nome di Aprilia, e dall’altra come per tale composizione mancava una simbologia precedente a cui appellarsi, anche in relazione dell’origine artificiale del territorio su cui sorgeva il nuovo Comune, ultimo dei quattro di fondazione dell’Agro Pontino bonificato.
 Si legge infatti nella deliberazione n. 4 datata 28 gennaio 1938:
Si legge infatti nella deliberazione n. 4 datata 28 gennaio 1938: - «Lo stemma ed i colori del Comune di Aprilia non hanno e non possono avere riferimenti storici in quanto il Comune è sorto il 25 Aprile del 1936 con R.D. nr. 669. Essi hanno, invece, un significato tutto ideale. L’azzurro e le rondini vogliono richiamare la primavera, in armonia col nome della città, coì come la stessa toponomastica, con nomi di piante e di fiori, sta a testimoniare il ritorno alla vita, il rifiorire della giovinezza in queste plaghe che solo la volontà di un Uomo e la genialità possente di un capo hanno potuto restituire al lavoro fecondo».
 Non manca nella motivazione della simbologia adottata l’esaltazione del regime fascista, sebbene gli elementi della composizione araldica non siano direttamente evocativi dell’ideologia fascista (al contrario di quanto era osservabile invece negli stemmi delle altre città dell’Agro Pontino, almeno nella loro originaria versione, poi modificata con l’avvento della Repubblica).
Più fortemente connesso con la realizzazione dello stemma risulta il nome della città, quel nome che ne doveva rappresentare la vocazione, l’indole e la natura.
Non manca nella motivazione della simbologia adottata l’esaltazione del regime fascista, sebbene gli elementi della composizione araldica non siano direttamente evocativi dell’ideologia fascista (al contrario di quanto era osservabile invece negli stemmi delle altre città dell’Agro Pontino, almeno nella loro originaria versione, poi modificata con l’avvento della Repubblica).
Più fortemente connesso con la realizzazione dello stemma risulta il nome della città, quel nome che ne doveva rappresentare la vocazione, l’indole e la natura.
 Anche se un velato riferimento al nome del fondatore della Città sembra non mancare nello stemma. Esso è dato dalla disposizione delle rondini che non sembra affatto casuale. Infatti le rondini tracciano idealmente una lettera M maiuscola considerate insieme all’andamento perpendicolare dei fianchi dello scudo (soprattutto se visto nella forma che questo aveva nel bozzetto originale).
Anche se un velato riferimento al nome del fondatore della Città sembra non mancare nello stemma. Esso è dato dalla disposizione delle rondini che non sembra affatto casuale. Infatti le rondini tracciano idealmente una lettera M maiuscola considerate insieme all’andamento perpendicolare dei fianchi dello scudo (soprattutto se visto nella forma che questo aveva nel bozzetto originale).
 Tale stratagemma del richiamo al nome di Mussolini era più esplicito nella prima versione dello stemma di Pontinia, nel campo del quale si innalzava un melo attraversato alla base da una pala e accostato da due fasci littori, essi e il melo uniti da un nastro rosso chiaramente posto a formare una M (non più osservabile nella versione attuale dello stemma che conserva solo il melo e la pala). Un richiamo del genere si trovava anche nell’originario stemma di Sabaudia, nel quale campeggiava un’aquila caricata da uno scudo sabaudo e posata su tre monti che, per numero e disposizione, accennavano ad una lettera M.
Tale stratagemma del richiamo al nome di Mussolini era più esplicito nella prima versione dello stemma di Pontinia, nel campo del quale si innalzava un melo attraversato alla base da una pala e accostato da due fasci littori, essi e il melo uniti da un nastro rosso chiaramente posto a formare una M (non più osservabile nella versione attuale dello stemma che conserva solo il melo e la pala). Un richiamo del genere si trovava anche nell’originario stemma di Sabaudia, nel quale campeggiava un’aquila caricata da uno scudo sabaudo e posata su tre monti che, per numero e disposizione, accennavano ad una lettera M.
Merita attenzione anche l’aspetto grafico del bozzetto. Questo rispecchiava lo stile e le espressioni grafiche dell’epoca, ricordando canoni estetici propri dell’architettura razionalista - secondo i nuovi ed inediti criteri della quale era stata concepita l’urbanistica di Aprilia - e mostrando l’influsso del movimento artistico-culturale futurista. Infatti l’impianto grafico del disegno era caratterizzato da un aspetto stilizzato e di gusto dinamico, soprattutto a motivo della forma arcuata dello scudo, evidenziata dal movimento del nastro decorativo, oltre che dalla corona turrita, che non corrispondeva alla grafica propria della corona araldica codificata per gli stemmi civici ma ne era una libera più moderna interpretazione, pur conservandone indubbiamente la funzione di contrassegno.
 Di fatto, il bozzetto non era corrispondente alle regole stabilite in materia araldica. Lo scudo doveva essere di forma sannitica, mentre troviamo una libera interpretazione della sua foggia, per quanto interessante potesse essere il suo stile; il nastro decorativo era un vezzo che non poteva avere spazio dovendo gli elementi esterni allo scudo avere solo il ruolo identificativo del rango dell’ente territoriale; la corona turrita manteneva solo un vago aspetto della corona muraria che era prescritta per gli stemmi civici.
Di fatto, il bozzetto non era corrispondente alle regole stabilite in materia araldica. Lo scudo doveva essere di forma sannitica, mentre troviamo una libera interpretazione della sua foggia, per quanto interessante potesse essere il suo stile; il nastro decorativo era un vezzo che non poteva avere spazio dovendo gli elementi esterni allo scudo avere solo il ruolo identificativo del rango dell’ente territoriale; la corona turrita manteneva solo un vago aspetto della corona muraria che era prescritta per gli stemmi civici.
 Anche se non conforme alle regole araldiche, lo stemma civico campeggiava, in una versione scultorea realizzata secondo le fattezze del bozzetto originario e con tanto di nastro decorativo, all’ingresso dell’arengario, andato distrutto insieme alla torre civica con i bombardamenti che hanno duramente provato la Città. La stessa raffigurazione proposta per la concessione, in stile più contemporaneo e non rispondente alla foggia poi effettivamente concessa, si trova sulla medaglia commemorativa coniata per Aprilia, raffigurante da un lato il profilo del Duce, dall’altra lo stemma civico.
Anche se non conforme alle regole araldiche, lo stemma civico campeggiava, in una versione scultorea realizzata secondo le fattezze del bozzetto originario e con tanto di nastro decorativo, all’ingresso dell’arengario, andato distrutto insieme alla torre civica con i bombardamenti che hanno duramente provato la Città. La stessa raffigurazione proposta per la concessione, in stile più contemporaneo e non rispondente alla foggia poi effettivamente concessa, si trova sulla medaglia commemorativa coniata per Aprilia, raffigurante da un lato il profilo del Duce, dall’altra lo stemma civico.Ma tornando all’iter per la concessione dello stemma, si comprende bene come la relazione a Benito Mussolini svolta dal Commissario del Re presso la Consulta Araldica il 16 dicembre del 1938 in merito alle istanze presentate dal Podestà di Aprilia nel precedente mese di aprile, riporti un blasone nel quale non si parla del nastro ornamentale ma si richiamano le ornamentazioni caratteristiche degli stemmi civici: «Lo stemma proposto può così descriversi; campo di cielo, a cinque rondini di nero al volo spiegato, in formazione di cuneo rovesciato. Capo del Littorio: di rosso (porpora) al fascio Littorio d’oro circondato da due rami di quercia e d’alloro annodati da un nastro dei colori nazionali, sostenuto da una fascia d’argento. Ornamenti esteriori di Comune».
 Notiamo che nel blasone descritto nel testo nella concessione regia dello stemma e del gonfalone comunale, non si nominerà la «fascia d’argento» (in realtà, secondo una più precisa terminologia, considerata la ridottissima altezza di questo elemento, dovremmo dire il «filetto d’argento»), che pure era presente nel bozzetto originario, come nel testo della deliberazione del Commissario Prefettizio del gennaio 1938. Notiamo inoltre che il campo principale non è di azzurro, ma «di cielo». Si tratta di una variante dell’azzurro caratteristica dell’araldica italiana, che riproduce il cielo nel suo aspetto naturalistico, anche comprensivo di formazioni nuvolose indistinte. Di fatto non corrisponde dunque ad un campo ripieno di un piatto celeste (come poteva ad esempio essere inteso dalla suddetta deliberazione, in cui si parlava di un «campo celeste chiaro», non essendo necessariamente note agli amministratori comunali le regole per una corretta blasonatura). -Esattamente il campo di cielo sarà quello descritto nella concessione di Re Vittorio Emanuele III con R.D. dell’8 aprile 1939: Campo di cielo, a cinque rondini di nero al volo spiegato, in formazione di cuneo rovesciato. Capo del Littorio, di rosso (porpora) al Fascio Littorio d’oro, circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodato da un nastro dei colori nazionali. Ornamenti esterni da Comune.
Notiamo che nel blasone descritto nel testo nella concessione regia dello stemma e del gonfalone comunale, non si nominerà la «fascia d’argento» (in realtà, secondo una più precisa terminologia, considerata la ridottissima altezza di questo elemento, dovremmo dire il «filetto d’argento»), che pure era presente nel bozzetto originario, come nel testo della deliberazione del Commissario Prefettizio del gennaio 1938. Notiamo inoltre che il campo principale non è di azzurro, ma «di cielo». Si tratta di una variante dell’azzurro caratteristica dell’araldica italiana, che riproduce il cielo nel suo aspetto naturalistico, anche comprensivo di formazioni nuvolose indistinte. Di fatto non corrisponde dunque ad un campo ripieno di un piatto celeste (come poteva ad esempio essere inteso dalla suddetta deliberazione, in cui si parlava di un «campo celeste chiaro», non essendo necessariamente note agli amministratori comunali le regole per una corretta blasonatura). -Esattamente il campo di cielo sarà quello descritto nella concessione di Re Vittorio Emanuele III con R.D. dell’8 aprile 1939: Campo di cielo, a cinque rondini di nero al volo spiegato, in formazione di cuneo rovesciato. Capo del Littorio, di rosso (porpora) al Fascio Littorio d’oro, circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodato da un nastro dei colori nazionali. Ornamenti esterni da Comune.- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- UNA LEZIONE DI ARALDICA. Un approfondimento sullo stemma della città di Aprilia (di don Antonio Pompili).1 novembre 2020, di Federico La Sala
- continuazione e fine
LO STEMMA DELLA CITTA’ DI APRILIA *
Un approfondimento
di don Antonio Pompili, Socio Ordinario dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano
- [...]
Il Gonfalone concesso viene così descritto: drappo di colore nero, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento “COMUNE DI APRILIA”. Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto nero con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma.
Il gonfalone, donato dal Comune di Capannori in provincia di Lucca (uno dei comuni rurali più grandi d’Italia) fu benedetto dal cardinale Granito Pignatelli di Belmonte e consegnato ad Angela Vacchi Curzola, colona di Aprilia e madre di dodici figli, scelta come madrina della Città appena inaugurata, il 29 ottobre dello stesso anno.
Lo stemma fu ufficializzato con la concessione dopo la fine della seconda guerra mondiale. Eliminata la «pezza» araldica innalzante l’emblema fascista, lo stemma sarà fissato nella sua forma attuale con decreto del 10 aprile del 1954 a firma del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.
 Dall’originario stemma era stato correttamente rimosso solo il capo del littorio, in quanto le altre figure non evocavano la tramontata ideologia del deposto regime, ma si trattava di simboli universali e condivisibili anche nell’accezione originaria: la rondine, sul campo di cielo, è evocativa della primavera, dell’avvento di una nuova stagione che prelude al lavoro nei campi e al raccolto. Questo a differenza di quanto era accaduto con gli stemmi degli altri comuni di fondazione pontina, i quali hanno conosciuto nel dopoguerra una modifica molto più marcata o sostanziale. Possiamo forse pensare che lo stile con cui erano state rappresentate le rondini nello stemma di Aprilia potesse richiamare il glifo che era innalzato nell’emblema dell’Ala Littoria, la prima compagnia aerea di linea italiana di proprietà statale, data la forte somiglianza raffigurativa.
D’altra parte le rondini dello stemma comunale nella formazione a cuneo rovesciato ricordavano proprio degli aeroplani, il che accentuava quel dinamismo già presente nella particolare forma dello scudo secondo il bozzetto originario dello stemma, foggia che, ben lontana dai canoni relativi alle armi civiche, era in perfetta linea con i canoni stilistici dell’epoca in cui irrompevano le suggestioni del futurismo e del razionalismo.
Dall’originario stemma era stato correttamente rimosso solo il capo del littorio, in quanto le altre figure non evocavano la tramontata ideologia del deposto regime, ma si trattava di simboli universali e condivisibili anche nell’accezione originaria: la rondine, sul campo di cielo, è evocativa della primavera, dell’avvento di una nuova stagione che prelude al lavoro nei campi e al raccolto. Questo a differenza di quanto era accaduto con gli stemmi degli altri comuni di fondazione pontina, i quali hanno conosciuto nel dopoguerra una modifica molto più marcata o sostanziale. Possiamo forse pensare che lo stile con cui erano state rappresentate le rondini nello stemma di Aprilia potesse richiamare il glifo che era innalzato nell’emblema dell’Ala Littoria, la prima compagnia aerea di linea italiana di proprietà statale, data la forte somiglianza raffigurativa.
D’altra parte le rondini dello stemma comunale nella formazione a cuneo rovesciato ricordavano proprio degli aeroplani, il che accentuava quel dinamismo già presente nella particolare forma dello scudo secondo il bozzetto originario dello stemma, foggia che, ben lontana dai canoni relativi alle armi civiche, era in perfetta linea con i canoni stilistici dell’epoca in cui irrompevano le suggestioni del futurismo e del razionalismo.
 Il connubio tra la vocazione bucolica di Aprilia e il mito del volo e della velocità caro al movimento futurista non è privo di fascino. Una cosa è certa: applicata la normativa che prevedeva la soppressione del capo littorio, il resto dell’impianto iconografico dello stemma civico il quale non prevedeva altri simboli utilizzati dal fascismo, poteva rimanere tranquillamente inalterato. Evidentemente, eliminato il capo littorio, era ancor meno necessaria la fascia (il filetto) d’argento che separava la pezza dal campo principale dello scudo.
Il connubio tra la vocazione bucolica di Aprilia e il mito del volo e della velocità caro al movimento futurista non è privo di fascino. Una cosa è certa: applicata la normativa che prevedeva la soppressione del capo littorio, il resto dell’impianto iconografico dello stemma civico il quale non prevedeva altri simboli utilizzati dal fascismo, poteva rimanere tranquillamente inalterato. Evidentemente, eliminato il capo littorio, era ancor meno necessaria la fascia (il filetto) d’argento che separava la pezza dal campo principale dello scudo.
 Nel documento presidenziale veniva concesso al Comune di Aprilia anche il gonfalone attualmente in uso, che invece aveva subito una modifica più sostanziale, essendo cambiato il colore del drappo; da nero, colore utilizzato per tutti i comuni di fondazione fascista ed evocativo dell’ideologia del regime, è stato cambiato in azzurro, che peraltro corrispondeva al colore originario richiesto a suo tempo dal Podestà di Aprilia perché meglio riflettesse la natura del neo costituito Comune.
Nel documento presidenziale veniva concesso al Comune di Aprilia anche il gonfalone attualmente in uso, che invece aveva subito una modifica più sostanziale, essendo cambiato il colore del drappo; da nero, colore utilizzato per tutti i comuni di fondazione fascista ed evocativo dell’ideologia del regime, è stato cambiato in azzurro, che peraltro corrispondeva al colore originario richiesto a suo tempo dal Podestà di Aprilia perché meglio riflettesse la natura del neo costituito Comune.
 Lo stemma nuovamente concesso è così blasonato: Campo di cielo a cinque rondini di nero al volo spiegato, in formazione di cuneo rovesciato.
Lo stemma nuovamente concesso è così blasonato: Campo di cielo a cinque rondini di nero al volo spiegato, in formazione di cuneo rovesciato.
 Il gonfalone ufficiale si presenta come un: “Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopradescritto con l’iscrizione centrata in argento “Comune di Aprilia”. Le parti in metallo e i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. La cravatta e nastri tricolorati dei colori nazionali e frangiati di argento”.
Il gonfalone ufficiale si presenta come un: “Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopradescritto con l’iscrizione centrata in argento “Comune di Aprilia”. Le parti in metallo e i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. La cravatta e nastri tricolorati dei colori nazionali e frangiati di argento”.Lo stemma del Comune, oltre alla descrizione già citata, si compone di uno scudo di aspetto «sannitico moderno», che secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 circa le «Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del linguaggio normativo» deve mantenere una proporzione di 7 moduli di larghezza per 9 moduli di altezza. Lo scudo siffatto è timbrato da una corona «formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonature a muro sui margini, sostenente una cinta aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d’argento murato di nero». Terzo elemento dello stemma è l’elemento decorativo: «consiste in due rami: uno di quercia con ghiande e uno di alloro con bacche, tra loro incrociati sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro dai colori nazionali».
Il gonfalone consiste in un drappo quadrangolare di un metro per due del colore di uno degli smalti dello stemma del Comune, sospeso mediante un bilico mobile ad un’asta, ricoperta di velluto dello stesso colore con bullette poste a spirale, e terminante in punta con una freccia sulla quale è riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome del comune. Il drappo riccamente ornato e frangiato, è caricato nel centro dello stemma del Comune, sormontato dall’iscrizione centrata: «Comune di Aprilia». La cravatta frangiata consiste in nastri tricolore. Le parti metalliche, i ricami, i cordoni, l’iscrizione e le bullette sono d’argento.
Nel 2012, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che conferisce ad Aprilia il titolo di Città, cambiano diversi dettagli dello stemma e del gonfalone. Oltre all’iscrizione «Città» invece che «Comune» al di sopra dello stemma, i comuni insigniti del titolo di «Città» utilizzano una corona turrita formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonature a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero. Le parti metalliche, così come i ricami, i cordoni, l’iscrizione e le bullette a spirale del gonfalone, da argentate, passano ad essere dorate.
A conclusione di questo breve percorso può essere utile una riflessione finale sulla attualità della simbologia dello stemma di Aprilia, radicato nel nome della Città e nelle sue origini. Infatti, pur essendo scampato ai bombardamenti e alla damnatio memoriae seguita alla caduta del regime fascista, il contenuto dello stemma è stato in qualche modo superato dalla trasformazione della società civile e dell’economia, che ha fatto di Aprilia dal dopoguerra in poi un sito industriale.
 La Città ha visto una trasformazione del territorio che la circonda e uno sviluppo demografico ed edilizio che, insieme allo sviluppo industriale, rendono impossibile allo stemma così come concepito al momento della sua fondazione di essere pienamente espressivo della sua radicale trasformazione, della sua storia più recente e della sua contemporanea missione civica.
La Città ha visto una trasformazione del territorio che la circonda e uno sviluppo demografico ed edilizio che, insieme allo sviluppo industriale, rendono impossibile allo stemma così come concepito al momento della sua fondazione di essere pienamente espressivo della sua radicale trasformazione, della sua storia più recente e della sua contemporanea missione civica.
 E tuttavia, la composizione araldica, legata nella sua origine al significato bucolico del nome che intendeva celebrare il fiorire di una nuova vita nei territori prima inospitali e malsani delle paludi pontine, mantiene inalterata l’attualità di un messaggio: quello dell’aprirsi al futuro, al mutamento sociale e alle peregrinazioni in terra straniera, come quelle dei coloni chiamati a popolare i nuovi insediamenti.
E tuttavia, la composizione araldica, legata nella sua origine al significato bucolico del nome che intendeva celebrare il fiorire di una nuova vita nei territori prima inospitali e malsani delle paludi pontine, mantiene inalterata l’attualità di un messaggio: quello dell’aprirsi al futuro, al mutamento sociale e alle peregrinazioni in terra straniera, come quelle dei coloni chiamati a popolare i nuovi insediamenti.
 Lo stormo delle cinque rondini che si stagliano sul campo di cielo sembra un felice intramontabile simbolo della speranza di una sempre nuova primavera che può fiorire grazie al senso civico e al lavoro serio e generoso del singolo cittadino come della collettività di cui egli fa parte.
Lo stormo delle cinque rondini che si stagliano sul campo di cielo sembra un felice intramontabile simbolo della speranza di una sempre nuova primavera che può fiorire grazie al senso civico e al lavoro serio e generoso del singolo cittadino come della collettività di cui egli fa parte.Approfondimento a cura di don Antonio Pompili, Socio Ordinario dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano
Bibliografia:
Aa.Vv. Dizionario di Toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani, Torino 1997.
 Giacomo Bascapè - Marcello Del Piazzo, Insegne e simboli. Araldica pubblica e privata medievale e moderna, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 11, Roma 1983.
Giacomo Bascapè - Marcello Del Piazzo, Insegne e simboli. Araldica pubblica e privata medievale e moderna, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 11, Roma 1983.
 Luigi Borgia, «Introduzione allo studio dell’araldica civica italiana con particolare riferimento alla Toscana», in Gli stemmi dei Comuni toscani al 1860, a cura di Pagnini G.P, Firenze 1991, pp. 81-117.
Luigi Borgia, «Introduzione allo studio dell’araldica civica italiana con particolare riferimento alla Toscana», in Gli stemmi dei Comuni toscani al 1860, a cura di Pagnini G.P, Firenze 1991, pp. 81-117.
 Corrado Lampe (ed.), Regione Lazio - Stemmi e sigilli, Roma 1988.
Corrado Lampe (ed.), Regione Lazio - Stemmi e sigilli, Roma 1988.
 Giovanni Papi, Aprilia città della terra. Arte, architettura, urbanistica, Roma 2005.
Giovanni Papi, Aprilia città della terra. Arte, architettura, urbanistica, Roma 2005.
 Antonio Rossi, Agraldica. L’araldica civica nelle città di fondazione dell’Agro Pontino, 20172.
Antonio Rossi, Agraldica. L’araldica civica nelle città di fondazione dell’Agro Pontino, 20172.
 Alberto Paolo Torri, Gli stemmi e i gonfaloni delle province e dei comuni italiani, Firenze 1963.
Alberto Paolo Torri, Gli stemmi e i gonfaloni delle province e dei comuni italiani, Firenze 1963.
 Massimiliano Vittori - Carlo Fabrizio Carli - Roberta Sciarretta (ed.), Futurismo e Agro Pontino, Latina 2000.
Massimiliano Vittori - Carlo Fabrizio Carli - Roberta Sciarretta (ed.), Futurismo e Agro Pontino, Latina 2000.* Fonte: Città di Aprilia
NOTA:
A BEN RIFLETTERE, SE SI CONSIDERA che "Il primo bozzetto acquerellato dello stemma del nuovo centro dell’Agro Pontino fu predisposto da Araldo di Crollalanza, presidente dell’O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti), e erede di una famiglia di insigni araldisti che contribuirono tra la fine del XIX sec. e l’inizio del XX a un aggiornamento in Italia della scienza del blasone" e, ancora, che "un velato riferimento al nome del fondatore della Città sembra non mancare nello stemma. Esso è dato dalla disposizione delle rondini che non sembra affatto casuale. Infatti le rondini tracciano idealmente una lettera M maiuscola considerate insieme all’andamento perpendicolare dei fianchi dello scudo" (cit. - vedi, sopra), NON E’ IMPENSABILE CHE nel "gioco" dell’immagine elaborata da Araldo di Crollalanza sia presente una volontà di alludere a Dante (alla "M", all’Aquila, del canto XVIII del Paradiso) e, al contempo, di inviare un "messaggio" al "primo duce", D’Annunzio (e al suo "Dantes Adriacus")!
Federico La Sala
- «Lo stemma ed i colori del Comune di Aprilia non hanno e non possono avere riferimenti storici in quanto il Comune è sorto il 25 Aprile del 1936 con R.D. nr. 669. Essi hanno, invece, un significato tutto ideale. L’azzurro e le rondini vogliono richiamare la primavera, in armonia col nome della città, coì come la stessa toponomastica, con nomi di piante e di fiori, sta a testimoniare il ritorno alla vita, il rifiorire della giovinezza in queste plaghe che solo la volontà di un Uomo e la genialità possente di un capo hanno potuto restituire al lavoro fecondo».
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE ... IL VOLO DELL’ARCANGELO. Le tre morti di Gabriele D’Annunzio (di Raffaele K. Salinari).19 giugno 2020, di Federico La Sala
- Gabriele D’Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 - Gardone Riviera, 1º marzo 1938)
Le tre morti di Gabriele D’Annunzio
Il saggio. Una serie di morti annunciate accompagnano la vita del poeta, dal parto, al duello, a Fiume, al volo dal balcone della Sala della musica
di Raffaele K. Salinari (il manifesto, Alias, 05.10.2013)
«Sono in una notte di tregua, disceso dalla mia officina, più scorato che stanco; perché quando in un’ora di grazia io sento di aver discoperto per pochi attimi il volto della bellezza e di averle rapito alcun lineamento e trasposto per pochi attimi o per i volubili secoli, perché ho sempre il desiderio di annientarmi, di dissolvermi?».
Così Gabriele D’Annunzio si confessa nel suo Libro Segreto. Ma il cupio dissolvi della morte non poteva essere per il Vate, uomo d’armi e di amori - erotica heroíca - semplice fatto letterario o moto dell’anima. E infatti, «disprezzando di morire tra due lenzuola, tento la mia ultima invenzione»: niente meno di questo annuncia egli stesso in un sibillino messaggio del 1937, pochi mesi prima della sua «morte eterna», avvenuta il 1 marzo del 1938. Curiosamente la stampa dell’epoca, abituata agli annunci iperbolici del Poeta, interpreta la frase con queste parole: «Il Poeta ha deciso, quando sentirà l’ora del trapasso, di immergersi in un bagno che provocherà immediatamente la morte e contemporaneamente distruggerà i tessuti del suo corpo. È il Poeta stesso che ha scoperto la formula del liquido».
Gli annunci di morte
Questa fantasia di dissoluzione, questo vagheggiare una scomparsa del corpo fisico, anche se non servì fattualmente al Vate, aggiunse certamente un ulteriore capitolo a quella sequela di «morti annunciate» che aveva costellato tutta la sua vita.
Il rapporto di D’Annunzio con la previsione della «morte eterna», e con le «morti intermedie» che egli soggettivamente visse, segnano la sua biografia sin dalla gioventù. Nel novembre del 1880, a soli diciassette anni, scrive alla Gazzetta della domenica di Firenze una cartolina a firma G. Rutini dove annuncia che «il giovane poeta, già noto nella repubblica delle lettere, di cui si è parlato spesso su questo giornale, è morto, cadendo da cavallo sulla strada di Francavilla». Naturalmente fu lo stesso poeta, dopo che i suoi si erano meravigliati per le condoglianze che andavano ricevendo, a smentire la falsa notizia.
Qualche decennio dopo, all’inizio del secolo, costretto a letto e con un occhi bendato - circostanza che tornerà altre volte nella sua vita - a causa di una palla di neve tiratagli dalla bella nipote di Lady Hamilton, dichiarò solennemente di sapere che sarebbe morto tra il 1905 ed il 1906. Passato anche questo anno fatidico, il 28 agosto 1907 il Mattino di Napoli, in occasione della Coppa Florio organizzata a Brescia scriveva: «Gabriele D’Annunzio corre a 120 all’ora perché una fattucchiera gli ha predetto con certezza che non morirà prima del 1909, per colpa di una pugnalata al cuore. Il poeta conosce il giorno e l’ora esatti del suo decesso». E ancora, nel 1908, mentre viveva nella villa «La Versiliana», annunciò ai parenti la sua morte per il 17 aprile di quello stesso anno: lo aveva detto una maga fiorentina.
Un’altra volta la data fu fissata per il 17 luglio 1910, addirittura profetizzata da Madame de Thèbes (1845-1916), pseudonimo di Anne Victorine Savigny, notissima veggente e chiromante francese che esercitava presso il suo studio a Parigi nell’avenue de Wagram. Ogni anno, a Natale, la Madame pubblicava le sue profezie e, tra queste, D’Annunzio dichiarò di aver letto anche quella della sua morte. Evidentemente uno dei due si sbagliava.
Gli annunci si susseguirono numerosi in tutta la sua vita, ne troviamo diverse tracce nel Libro Segreto, sino agli ultimissimi, pochi mesi prima di morire realmente, come quando scrive all’amico Maroni nel luglio del 1937: «Tu sai, tu indovini, che io sono in punto di morte», o ancora, nel febbraio 1938 a Tom Antongini: «Credo che sono morto come il cavalier Baiardo all’assedio di Brescia... L’anniversario cadrà poco prima del mio marzo funebre».
Il «marzo funebre» e il lunario Barbanera
Ed è allora, in quel fatidico 1938, che le spacconate sulla sua morte, le previsioni fallaci o inventate per attirare, ancora una volta, l’attenzione su di sé, sembrano condensarsi sino a precipitare addosso al Vate come il filo di una falce fatale. In effetto, come sappiamo, il «marzo funebre» arriverà: il 1 marzo di quello stesso anno una emorragia celebrale stroncherà il Vate. Curiosa coincidenza, tra le altre che vedremo, in una lettera del 1935 a Mussolini, il Poeta dichiara: «il mio cranio di lucido cristallo può incrinarsi facilmente». Tutti questi annunci preconizzatori, i numerosi accenni alla morte che cospargono le sue memorie, così come il richiamo a questa nelle sue opere - pensiamo solo al Trionfo della morte, alla Contemplazione della morte, per non citare che i testi più noti - ci dicono allora non solo di qualcosa di letterario, estetizzante, decadente, come era nello stile del Poeta, ma forse di una profezia che egli vuole si avveri, in altre parole di una morte non solo «annunciata», allusiva, ma anche cercata ed infine, ottenuta.
Come si spiega, infatti, la inquietante circostanza che vuole il Vate morire proprio nel marzo previsto nella sua ultima missiva, col capo chino sul suo scrittoio nella Zambracca, la stanza che usava al Vittoriale per comporre i suoi poemi, e con il dito ad indicare la data esatta, cerchiata di rosso, del lunario Barbanera che vaticinava per quel giorno «la morte di un italiano illustre»?
D’Annunzio non fece mai mistero di consultare il famoso lunario che, anzi, era per lui «il fiore dei tempi e la saggezza delle nazioni». Il Barbanera era il suo livre de chevet, come confessa al parroco di Gardone Riviera quando gli scrive: «la gente comune pensa che al mio capezzale io abbia l’Iliade o l’Odissea, o la Bibbia o Virgilio, o Flacco o Dante, invece...». E allora, date le circostanze, si potrebbe avanzare l’ipotesi di un suicidio? La morte per emorragia cerebrale risulta dal certificato medico stilato dal dottor Alberto Cesari, primario dell’ospedale di Salò, e dal dottor Antonio Duse, medico curante del Poeta. -Ma di fronte alla ragion di Stato, specie in epoca fascista e considerando la figura pubblica e politica di D’Annunzio, ogni ipotesi è plausibile. La segretezza mantenuta sul suicidio può essere variamente giustificata, non ultimo dal fatto che, se fosse stata resa pubblica la morte volontaria, non si sarebbe potuto celebrare il solenne funerale religioso, con l’immaginabile imbarazzo per il Duce, a nemmeno dieci anni di distanza dai Patti Leteranensi.
Sospettosa circostanza, in aggiunta alla misteriosa profezia del Barbanera e della location della morte, i funerali furono organizzati con estrema rapidità. D’Annunzio morì il martedì sera verso le 20 e Mussolini partì da Roma per Gardone Riviera la mattina dopo, il tempo strettamente necessario per disdire gli appuntamenti di Stato e organizzare il treno presidenziale che lo portò a Desenzano con i ministri Ciano, Starace, Alfieri, Benni e il segretario particolare Sebastiani. Le esequie vennero poi celebrate la mattina di giovedì 3 marzo, attorno alle 8,30. Gli onori estremi furono resi, quindi, al Vate della Patria in tempi assai stretti e, soprattutto, evenienza strana in quei casi, senza essere preceduti o seguiti da autopsia e accertamenti che approfondissero le cause del decesso. La morte, infatti, venne certificata come emorragia celebrale solo in base a reperti esterni, clinici, non supportati da esami autoptici.
D’Annunzio aveva 75 anni e da tempo era fisicamente decadente e sessualmente impotente. Scrisse, infatti, all’amante Luisa Baccara, in una lettera del 1 novembre 1934, che era giunto il momento del «Basta», poiché la sua virilità era ormai «caduta». Seguendo questa ipotesi si può citare la testimonianza dell’ex segretario dello scrittore abruzzese, Tom Antongini, che validò l’abitudine di D’Annunzio d’ingerire piccolissime dosi di stricnina e quindi la sua familiarità con i veleni.
Le morti vissute
Certo la morte ha sfiorato il Poeta diverse volte. Nel 1885, in duello, venne colpito alla testa; in guerra sul Carso o nell’impresa di Fiume dove perse un occhio. Durante la grande Guerra, come ricordò l’amico Marcel Boulenger «un obice quasi cadde ai suoi piedi».
Eppure, in tutte queste occasioni «oggettive», il Poeta non sente la morte come sua. Quante volte, allora, sente di essere morto Gabriele D’Annunzio? Tre sono le morti «soggettive» evocate dal Vate prima di quella «eterna».
La prima ce la descrive nell’incipit de Il libro segreto, cento e cento pagine del poeta tentato di morire: «nel nascere io fui come imbavagliato dalla morte; sicché non diedi grido, né avrei potuto trarre il primo respiro a vivere, se mani esperte e pronte non avessero rotto i nodi e lacerata quella specie di tonaca spegnitrice. Dipoi, nei primi anni dell’infanzia portai al collo, chiusa entro un breve, quella ligatura insolita che l’antichissima superstizione della mia gente reputava propizia». La «prima morte» di D’Annunzio, in effetto, venne evitata attraverso una pratica di magia tradizionale che consisteva nel «corazzare», come disse il Poeta stesso, con ben quattrocento monete di argento il suo corpicino e di appendergli al collo un «abitino» (sorta di contenitore fatto di pelle animale: il breve, di cui parla D’Annunzio) che conteneva pezzi del legamento del suo cordone ombelicale.
Anche il passaggio dalla giovinezza alla maturità è vissuto da D’Annunzio come una «seconda morte». In Esequie della giovinezza così dice. «da che lotto e soffro non mi sono mai sentito morire come oggi. Mi sembra di avere alla punta del cuore quel piccolo varco onde gemono le gocciole eguali della clessidra funebre. Tutto, pensieri sogni ricordi rimpianti, propositi desideri passioni glorie miserie, tutto vi passa; e non è niente. Bisogna che io imbalsami infine il cadavere della giovinezza, che fasciato di bende io lo chiuda tra quattro assi e che io la faccia passare per quella porta, ove lo spettro della vecchiaia è apparso tra i battenti socchiusi e con un accenno quasi familiare mi ha augurato il buon giorno».
Questa è la «seconda morte» del Vate, seguita dopo pochi anni dalla terza: il Volo dell’Arcangelo. Nel 1922, il 13 di agosto, D’Annunzio cadde da una finestra della sua Stanza della musica al Vittoriale, battendo il capo su una pietra sottostante e rimanendo in coma, tra la vita e la morte, per dodici giorni. La dinamica della caduta è piuttosto oscura, essendo legata ad un corteggiamento «ardito» che il Poeta pare ponesse in atto nei confronti di Jole, violinista stimata, ma soprattutto sorella di Luisa Baccara, sua amante del momento: sembra ad un certo punto che Jole, nella foga di svincolarsi dall’abbraccio del Vate, lo abbia inavvertitamente spinto di sotto.
Questo il bollettino dei medici Antonio Duse, Francesco d’Agostino, Davide Giordano, Mario Donati, Raffaele Bastianelli, Augusto Murri: «segni manifesti di frattura della base del cranio estesa all’orbita destra. Commozione cerebrale. stato d’incoscienza. segni di compressione cerebrale dubbi. Disturbi di motilità e di sensibilità non manifesti. ferite lievi escoriate all’arto inferiore destro. leggera contusione a destra del torace. Ambe le mani sono incolumi. non v’è indicazione urgente di atto chirurgico. polso regolare 67. respiro regolare 25. temperatura 37,8. prognosi tuttavia riservata».
Risvegliatosi dal coma scrive immediatamente e di getto questi versi visionari: «io sono Gabriele che mi presento agli dei, fra alati fratelli il più veggente alunno di Postvorta, sacerdote dell’arcano e del divino, interprete dell’umana demenza, volatore caduto dall’alto, principe ed indovino». Il «volatore caduto» si confessa alunno di Postvorta, la divinità romana del passato: la «terza morte» ha chiuso per sempre un altro trancio di vita alle sue spalle.
Anche questo episodio assurge così al rango di «morte vissuta» non solo per la sensibilità irenica del Vate, ma anche per la comparsa del fantasma della sempre amata madre. Poco prima del Volo dell’Arcangelo, infatti, un fotografo aveva ritratto D’Annunzio al tavolo di lavoro. Uscito dal coma il Poeta fece notare che nella fotografia era visibile come una mano che gli sorreggesse il volto. Nell’ombra volle riconoscere la mano della madre che lo aveva salvato dalla sua «terza morte».
La vecchiaia mise infine il Piccolo Nume di fronte alla irrimediabilità del momento supremo e lo costrinse, forse, a porre in atto disperatamente ciò che non poteva più essere solo annunciato per essere in realtà rinviato: in una lettera alla sorella del 1938 D’Annunzio scrive Io resto con il nulla che mi sono creato. Torna qui lo spettro del suicidio del Vate come punto finale e coerente della sua eterna schermaglia con la Grande Signora. Un mistero ultimo, insondabile, che Gabriele D’Annunzio sembra chiaramente evocare ed al tempo stesso nascondere nella sibillina frase che troviamo nel Libro Segreto: «ma chi era presente? chi vide? chi mai potrà ridire?».
Scaffale
L’ipotesi del suicidio di D’Annunzio è trattata nel libro di Attilio Mazza e Antonio Bortolotti Le medicine di D’Annunzio, edizioni Ianieri. Attilio Mazza, si sofferma sull’enigma della morte del Poeta, mentre Antonio Bortolotti, a sua volta, cataloga accuratamente i medicinali e i prodotti affini rinvenuti nello scaffale della Zambracca: anche questo, un utile strumento di conoscenze sulle sue consuetudini di vita e, di riflesso, sul suo profilo di uomo e di scrittore.
Il Libro segreto di D’Annunzio è l’ultima fatica del Poeta, attraversato da un addensamento continuo di memorie, simboli, intuizioni poetiche, immagini letterarie, deliri mistici, proiettati verso l’interpretazione dei ricordi impregnati in una prefigurazione della morte.
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ - MARGHERITA SARFATTI ---MOSTRA. A Milano, in confronto diretto Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, numi della scultura europea del primo Ottocento (di A. Beltrami).12 dicembre 2019, di Federico La Sala
Arte.
Canova e Thorvaldsen: si scrive neoclassico, si legge modernità
Una mostra alle Gallerie d’Italia a Milano mette per la prima volta in confronto diretto Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, numi della scultura europea del primo Ottocento
di Alessandro Beltrami (Avvenire, giovedì 28 novembre 2019)
- [Foto] “Le tre Grazie” di Canova (a sinistra) e di Thorvaldsen (a destra) a confronto nelle Gallerie d’Italia a Milano (Flavio Lo Scalzo)
Stupisce, ma è così: è la prima volta che una mostra mette fianco a fianco Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, vertici non solo della scultura ma dell’intero fenomeno culturale che corre sotto il nome di neoclassicismo. Costantemente accostati nei volumi e nei manuali di storia dell’arte (per quanto con spazi diversi: in Italia sono ben più ampi quelli dedicati a Canova), ebbero entrambi i propri atelier a Roma nei primi due decenni dell’Ottocento, condivisero almeno in parte le committenze, godettero di una fama immensa che portò alla creazione di due musei personali: per Canova, post mortem, la gipsoteca nella nativa Possagno, mentre quello di Thorvaldsen a Copenaghen è il primo mai dedicato a un artista in vita.
L’occasione di questo faccia a faccia è la mostra, a cura di Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca, che ai due dedicano le Gallerie d’Italia a Milano (fino al 15 marzo. Catalogo Gallerie d’Italia - Skira), nuovo ulteriore tassello di un percorso di rilettura e recupero di un secolo complesso e spesso sottovalutato come l’Ottocento.
Sulla traccia narrativa di vite parallele, la mostra ricostruisce l’ambiente, le fortune, le pratiche, i temi (Amore e Psiche, la danza, le Grazie...) comuni ai due innanzitutto perché propri di un’epoca e poi perché campo di una prova a distanza: Thorvaldsen, più giovane di 20 anni, guardò sempre a Canova come esplicito termine di confronto - spesso anche per opposizione - mentre il veneto si limita a esprimere verso il collega giudizi di tipo critico, anche lusinghieri. Il risultato è che i due, portando al trionfo la scultura sulle altre arti, segnano - come dice il sottotitolo della mostra - l’atto di “nascita della scultura moderna”.
Questo può sembrare un controsenso, dato che per entrambi la radice è l’antichità. Non bisogna confondere però l’apparenza del linguaggio dai problemi che l’opera si pone. È difficile trovare un’epoca più “di transizione” del XIX secolo, dove si manifestano ed evolvono con decisione i temi e i nodi problematici della contemporaneità (sociali, politici, religiosi, ermeneutici) mentre gli strumenti linguistici per esprimerli restano ancorati a griglie e registri consolidati.
 Basti pensare a come questa scultura deve affrontare il modo di rappresentare la storia - e che storia: sono gli anni che seguono la Rivoluzione e vivono in prima persona Napoleone, hegeliana manifestazione dello “spirito del mondo” - al di fuori di se stessa, proiettata nell’eternità del piano ideale, oltre la narrazione a cui costringe l’episodio o il costume.
Basti pensare a come questa scultura deve affrontare il modo di rappresentare la storia - e che storia: sono gli anni che seguono la Rivoluzione e vivono in prima persona Napoleone, hegeliana manifestazione dello “spirito del mondo” - al di fuori di se stessa, proiettata nell’eternità del piano ideale, oltre la narrazione a cui costringe l’episodio o il costume.
 La fonte è la Grecia, ma la scultura che ne sgorga è differente e per motivi diversi. C’è prima di tutto una questione anagrafica.
La fonte è la Grecia, ma la scultura che ne sgorga è differente e per motivi diversi. C’è prima di tutto una questione anagrafica.- [Foto] Antonio Canova, bozzetto per il monumento a Vittorio Alfieri, in mostra a Milano (Flavio Lo Scalzo)
Canova è uomo dall’educazione pienamente settecentesca, che assorbe il mondo classico prima di tutto attraverso la tradizione veneziana: e giustamente l’amico Leopoldo Cicognara lo colloca al vertice del percorso lunghissimo che copre tutta la storia della scultura italiana. A Roma il giovane Canova si preoccupa di traghettare il mondo tardobarocco verso una dimensione europea, fino a definire un vero e proprio standard per il classicismo internazionale: ma il suo greco, come quello di Winckelmann, resta ellenistico.
Per i contemporanei Canova, il solo paragonabile a Fidia e Michelangelo, fa letteralmente risorgere la scultura dandole nuova vita e gloria eterna: e attraverso di essa porta su un piano mitologico i personaggi del suo tempo (Napoleone-Marte; Paolina-Venere; Lubomirski-Eros...). Tanto epica quanto lirica, la scultura di Canova non fa dell’antico una ripresa meccanica ma una questione di metodo critico, una rilettura dell’oggetto come fonte e via alla vitalità della natura e della storia.
Thorvaldsen si pone il problema del classicismo da una prospettiva tedesca (non importa che sia danese, è una questione quasi “etnica”): e il classicismo tedesco parla “dorico”. Dorici sono i colonnati degli edifici di Schinkel attraverso cui la Prussia costruisce la propria immagine morale di nazione guida capace di riunificare politicamente sotto il suo manto le membra disperse del popolo tedesco. Un rispecchiamento che prosegue nell’“amore per la sapienza”, attraverso una lingua plastica e rigorosa come quella ellenica.
 Su questo piano le scelte e il rigore di Thorvaldsen (si pensi alla sua capacità di ricostruire nel Giasone col vello d’oro le proporzioni del canone policleteo dalle molte derivazioni del Doriforo in un’epoca in cui la statua non era ancora stata identificata) vanno inseriti in un bacino culturale in cui parte notevole ha la forgiatura della scienza filologica, che sarebbe sfociata nel metodo di Lachmann.
Su questo piano le scelte e il rigore di Thorvaldsen (si pensi alla sua capacità di ricostruire nel Giasone col vello d’oro le proporzioni del canone policleteo dalle molte derivazioni del Doriforo in un’epoca in cui la statua non era ancora stata identificata) vanno inseriti in un bacino culturale in cui parte notevole ha la forgiatura della scienza filologica, che sarebbe sfociata nel metodo di Lachmann.Scrive Grandesso in catalogo: «Thorvaldsen doveva essere riconosciuto come il campione nordico del classicismo... Se ne era impadronito al massimo grado, risalendo alle più pure fonti dell’arte greca. Attraverso una tabula rasa della tradizione moderna così presente a Canova, Thorvaldsen rappresentava la riforma e la possibilità di una palingenesi dell’intera arte nordica e tedesca, che si sarebbe rigenerata come erede della grecità più incorrotta».
Il punto è questo: Canova, per il quale il classico è lingua naturale, appare come sintesi e culmine di un percorso; -Thorvaldsen, nell’astrazione di una lingua fatta propria con un atto intellettuale, come “inizio”. Il minimalismo del Novecento nordico (tedesco e scandinavo) è la versione distillata del distacco, dell’equilibrata solidità, della razionale e serena purezza dei volumi della scultura di Thorvaldsen tanto quanto dell’architettura di Schinkel.
Ma nella sintonia tra il classicismo aulico e austero di Thorvaldsen con la questione della “superiorità” del Volk tedesco (il riferimento alla Grecia più arcaica e pura come immagine guida nella costruzione di una nazione consente di aggirare l’eredità latina) trova anche genesi una retorica di forme che sarà amata dal Sonderweg (l’“eccezionalismo” prussiano) fino al totalitarismo nazista, il quale non a caso non conosce la fase rivoluzionaria delle avanguardie: tra questa scultura e le immagini degli atleti di Olympia, il film di Leni Riefenstahl, c’è una discendenza diretta. Il totalitarismo italiano di certo non potrà pescare dalle “mollezze” e dalla levità canoviane: molto più efficace la rude virilità di Roma e dell’arte dei popoli italici.
Canova e Thorvaldsen si muovono davvero su binari paralleli. Il confronto in mostra tra la Ebe canoviana e quella del danese è decisivo. La prima è un’apparizione, una polena che avanza danzando in volo, i cui abiti che aderiscono al corpo manifestandolo in trasparenza hanno la stessa densità della nuvola. La seconda è una figura immobile, casta, inattingibile: ma molto più solida della collega italiana.
Eppure in Thorvaldsen sembra esserci una sorta di compressione, un pulsare sotto la superficie. Lo si nota nei suoi ritratti, dove Thorvaldsen nasconde la modernità sottopelle all’antico, come ad esempio in quello di Vincenzo Camuccini, apparentemente all’antica ma efficacissimo nella resa psicologica con quello sguardo che taglia obliquo, i capelli arruffati e persino il dettaglio alla moda delle basette sul viso glabro e affilato. O come nel ritratto di Horace Vernet, dove la pelle appare tesa sopra ossa e muscoli. È un guizzo che i ritratti di Canova nella pur strepitosa resa naturalistica (memorabile quello del compositore Domenico Cimarosa) non sembrano avere.
O ancora nei gruppi delle Tre Grazie attorno a cui tutta la mostra sembra orbitare. Il capolavoro supremo di Canova ha eleganza e ricchezza di affetti: ma ciò che concatena le tre figure in un fluido infinito abbraccio circolare è un sentimento agapico.
 Thorvaldsen sceglie invece una forma salda, simmetrica: l’abbraccio si chiude sulla figura centrale, come le ali di un trittico. Ma i gesti (il dito, la mano) con cui le giovani ai lati ne dividono il moto, creando vettori di apertura della forma, suggeriscono una dimensione narrativa assente nel gruppo canoviano. A muoverle è indubitabilmente Eros, che suona la cetra ai loro piedi.
Thorvaldsen sceglie invece una forma salda, simmetrica: l’abbraccio si chiude sulla figura centrale, come le ali di un trittico. Ma i gesti (il dito, la mano) con cui le giovani ai lati ne dividono il moto, creando vettori di apertura della forma, suggeriscono una dimensione narrativa assente nel gruppo canoviano. A muoverle è indubitabilmente Eros, che suona la cetra ai loro piedi. -
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE. -- Recensione del libro “Margherita Sarfatti Più” di Massimo Mattioli (di Federico Giannini).28 agosto 2019, di Federico La Sala
TODI FESTIVAL - INCONTRI CON L’AUTORE*
Per una corretta ricollocazione di Margherita Sarfatti. Il pamphlet di Massimo Mattioli
di Federico Giannini *
- Recensione del libro “Margherita Sarfatti Più” di Massimo Mattioli (Manfredi Edizioni, 2019)
La pesante damnatio memoriae cui Margherita Sarfatti (Venezia, 1880 - Cavallasca, 1961) è stata costretta a causa dei suoi noti legami col regime fascista non ha permesso una serena, piena e corretta valutazione della sua dimensione di critica d’arte, ha drasticamente ridotto la sua elevata statura intellettuale, e dovrebbe essere finalmente e totalmente superata (ferma restando l’ovvia condanna per la complicità col fascismo, dal quale comunque lei stessa, ebrea costretta all’esilio nel 1938, fu infine colpita) al fine di consentirci d’apprezzare una delle più eccelse figure del ventesimo secolo, che dev’essere ricollocata al posto che le spetta nell’ambito della letteratura storico-artistica, dalla quale il suo nome è stato quasi del tutto cancellato: sono queste le premesse alla base di Margherita Sarfatti più, l’agile pamphlet, edito da Manfredi Edizioni, con il quale il critico e giornalista Massimo Mattioli pone all’attenzione di pubblico e studiosi il problema della rivalutazione della critica veneziana, nata Margherita Grassini.
 La pubblicazione del volume giunge a poca distanza dalla doppia mostra che il Museo del Novecento di Milano e il Mart di Rovereto le hanno dedicato tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, e che probabilmente ha sancito, sino a questo momento, il punto più alto del lento cammino verso una riconsiderazione di Margherita Sarfatti: un cammino che, giova ricordarlo, è stato intrapreso solo di recente, e con timidi risultati.
La pubblicazione del volume giunge a poca distanza dalla doppia mostra che il Museo del Novecento di Milano e il Mart di Rovereto le hanno dedicato tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, e che probabilmente ha sancito, sino a questo momento, il punto più alto del lento cammino verso una riconsiderazione di Margherita Sarfatti: un cammino che, giova ricordarlo, è stato intrapreso solo di recente, e con timidi risultati.Nuovo è infatti l’interesse degli studî specialistici per Margherita Sarfatti: i primi contributi d’un certo spessore rimontano agli anni Novanta, ma è col decennio successivo che s’allarga il novero di quanti si sono occupati di lei, benché spesso, evidenzia Mattioli, la lettura del suo rilievo intellettuale sia stata in larga misura segnata dal rapporto che la legava da una parte al regime e dall’altra a Benito Mussolini, e solo negli ultimi anni (in particolare, con la biografia Margherita Sarfatti. La regina dell’arte nell’Italia fascista, scritta da Rachele Ferrario nel 2015 e pubblicata da Mondadori) il dibattito avrebbe preso piena coscienza del primo problema: smarcare Margherita Sarfatti dall’ingombrante presenza del Duce.
 La proposta di riposizionamento avanzata dall’autore prende avvio proprio dall’abbattimento del principale luogo comune che ha viziato tante disamine dell’apporto che Margherita Sarfatti ha garantito alla cultura italiana: il suo presunto ruolo di “dittatrice della cultura” che la critica le ha affibbiato soprattutto per la sua militanza, la sua capillare presenza nei più alti circoli culturali del suo tempo, il suo impegno nel delineare le basi su cui sarebbe poi sorto il gruppo Novecento, e la sua attività nel promuoverlo.
La proposta di riposizionamento avanzata dall’autore prende avvio proprio dall’abbattimento del principale luogo comune che ha viziato tante disamine dell’apporto che Margherita Sarfatti ha garantito alla cultura italiana: il suo presunto ruolo di “dittatrice della cultura” che la critica le ha affibbiato soprattutto per la sua militanza, la sua capillare presenza nei più alti circoli culturali del suo tempo, il suo impegno nel delineare le basi su cui sarebbe poi sorto il gruppo Novecento, e la sua attività nel promuoverlo.
 Mattioli ha compiuto un’approfondita ricerca nel Fondo Sarfatti conservato al Mart di Rovereto (e che annovera scritti, lettere e documenti, alcuni dei quali sinora inediti), e le premesse per smontare il mito della “Sarfatti dittatrice” si possono riscontrare in una lettera che Mussolini invia all’ex amante nel luglio del 1929, e nella quale l’allora presidente del consiglio del Regno d’Italia condanna fermamente il gruppo Novecento (“questo tentativo di far credere che la posizione artistica del fascismo, sia il vostro ’900, è ormai inutile ed è un trucco... poiché non possedete ancora l’elementare pudore di non mescolare il mio nome di uomo politico alle vostre invenzioni artistiche o sedicenti tali, non vi stupiate se alla prima occasione e in un modo esplicito, vi preciserò la mia posizione e quella del Fascismo di fronte al cosiddetto ’900 o quel che resta del fu ’900”), ma potrebbero essere rintracciate anche in alcune circostanze precedenti, come l’opposizione da parte d’alcuni intellettuali fascisti (Marinetti, Ojetti, Oppo), o nel crescente disinteresse di Mussolini nei confronti del ruolo di Margherita (un disinteresse che va acuendosi già dopo la marcia su Roma).
Mattioli ha compiuto un’approfondita ricerca nel Fondo Sarfatti conservato al Mart di Rovereto (e che annovera scritti, lettere e documenti, alcuni dei quali sinora inediti), e le premesse per smontare il mito della “Sarfatti dittatrice” si possono riscontrare in una lettera che Mussolini invia all’ex amante nel luglio del 1929, e nella quale l’allora presidente del consiglio del Regno d’Italia condanna fermamente il gruppo Novecento (“questo tentativo di far credere che la posizione artistica del fascismo, sia il vostro ’900, è ormai inutile ed è un trucco... poiché non possedete ancora l’elementare pudore di non mescolare il mio nome di uomo politico alle vostre invenzioni artistiche o sedicenti tali, non vi stupiate se alla prima occasione e in un modo esplicito, vi preciserò la mia posizione e quella del Fascismo di fronte al cosiddetto ’900 o quel che resta del fu ’900”), ma potrebbero essere rintracciate anche in alcune circostanze precedenti, come l’opposizione da parte d’alcuni intellettuali fascisti (Marinetti, Ojetti, Oppo), o nel crescente disinteresse di Mussolini nei confronti del ruolo di Margherita (un disinteresse che va acuendosi già dopo la marcia su Roma).- [Foto] Copertina di Margherita Sarfatti più di Massimo Mattioli
- [Foto] Margherita Sarfatti ritratta da Ghitta Carell
- Ghitta Carell, Ritratto di Margherita Sarfatti con berretto e collana, dettaglio (1925-1930 circa; Rovereto, Mart, Archivio del ’900, Fondo Margherita Sarfatti)
Il saggio di Mattioli prende poi a seguire l’ascesa di Margherita Sarfatti, soffermandosi sul momento del suo arrivo a Milano, nel 1902, dopo il trasferimento dalla natia Venezia: è col tramite di Anna Kuliscioff e Filippo Turati che la giovane veneta ha l’occasione di conoscere Marinetti, Carrà, Boccioni, Sant’Elia, personalità che non faticano a riconoscere presto il suo talento e la sua personalità. Il libro suggerisce, seppur in maniera velata, l’importanza del sodalizio che comincia a crearsi con Anna Kuliscioff, non foss’altro per il fatto ch’entrambe, donne, lottavano alacremente per affermarsi entro gli angusti confini d’un mondo maschile e maschilista: Margherita Sarfatti stessa, nei suoi scritti, non si risparmiava dal lanciar strali contri i suoi colleghi, come quando, nella sua biografia di Mussolini uscita in Inghilterra nel 1925 (The Life of Benito Mussolini), scrive della Kuliscioff che “she was destined to see the ambitions of her whole life thwarted by the mediocrity of the men through whom she worked” (“era destinata a veder le ambizioni della sua intera vita affossate dalla mediocrità degli uomini coi quali lavorò”).
 Proprio alla questione del genere nell’ambito della cultura del tempo è dedicata una breve sezione del contributo di Mattioli, che affronta con certa rapidità l’argomento (per quanto occorra specificare che si tratta d’un tema su cui molte pagine son già state spese), ma non s’esime dal sottolinearne l’importanza, individuando nella stessa Margherita Sarfatti la figura femminile che più delle altre ha marcato la cultura del tempo: “al di là della figura di donna emancipata, brillante, influente”, spiega l’autore, “la sua identità più profonda, perseguita con passione, determinazione e anche sofferenza, è quella della critica d’arte, la prima donna a esercitarla in senso moderno”. E questo suo primato fa sì che Margherita diventi “l’antesignana di una serie di donne straordinarie che segneranno l’arte italiana nel secolo breve”.
Proprio alla questione del genere nell’ambito della cultura del tempo è dedicata una breve sezione del contributo di Mattioli, che affronta con certa rapidità l’argomento (per quanto occorra specificare che si tratta d’un tema su cui molte pagine son già state spese), ma non s’esime dal sottolinearne l’importanza, individuando nella stessa Margherita Sarfatti la figura femminile che più delle altre ha marcato la cultura del tempo: “al di là della figura di donna emancipata, brillante, influente”, spiega l’autore, “la sua identità più profonda, perseguita con passione, determinazione e anche sofferenza, è quella della critica d’arte, la prima donna a esercitarla in senso moderno”. E questo suo primato fa sì che Margherita diventi “l’antesignana di una serie di donne straordinarie che segneranno l’arte italiana nel secolo breve”.Viene dunque a delinearsi una sorta d’introibo necessario a ribaltare i termini del rapporto tra Margherita Sarfatti e Mussolini per come certa storiografia lo avrebbe dipinto: un percorso critico che, ad ogni modo, è andato costruendosi già a partire dagli anni Novanta (Mattioli riconosce che gl’inizî rinviano a De Felice), sebbene abbia sempre incontrato varie e ardite resistenze (e certo non hanno giovato le tante biografie che nelle titolazioni facevano continuamente riferimento alla liaison che la critica ebbe col capo del fascismo). Dalla veloce e incalzante analisi dell’autore emerge, al contrario di quanto parrebbe risultare da altri ritratti, il quadro d’una relazione nella quale non mancarono dissapori (anche sulle posizioni politiche: Sarfatti, per esempio, era contraria alle mire fasciste sulle colonie), e che spesso vede la personalità di Margherita prevalere su quella del Duce, come gli studî più recenti hanno riconosciuto e come sembra attestare una nota inedita che Mattioli pubblica nel suo libro (scriveva la critica che “la vera profonda influenza della donna sull’uomo non consiste tanto nel determinare di volta in volta le sue azioni e le sue decisioni con i consigli che può dargli, ma nel determinare, con la sua influenza e soprattutto con ciò che ella pensa di lui, lo svolgimento del carattere di lui”).
 Quest’appunto rafforza l’idea d’una Margherita Sarfatti che introduce un Mussolini poco più che trentenne alla filosofia socialista, allo studio dell’economia e della storia, che gli suggerisce, specifica ulteriormente Mattioli, “di approfondire Aristotele, facendogli scoprire il pensiero di Machiavelli”, e che non mancherà di consigliare il suo amante anche quando quest’ultimo entrerà in politica e s’impossesserà del governo del paese. In fondo, per lei, Mussolini altro non fu, afferma Mattioli, che “un anello della sua strutturata catena relazionale”.
Quest’appunto rafforza l’idea d’una Margherita Sarfatti che introduce un Mussolini poco più che trentenne alla filosofia socialista, allo studio dell’economia e della storia, che gli suggerisce, specifica ulteriormente Mattioli, “di approfondire Aristotele, facendogli scoprire il pensiero di Machiavelli”, e che non mancherà di consigliare il suo amante anche quando quest’ultimo entrerà in politica e s’impossesserà del governo del paese. In fondo, per lei, Mussolini altro non fu, afferma Mattioli, che “un anello della sua strutturata catena relazionale”.Altro nodo centrale è quello del gruppo Novecento, che la vulgata fa talora passare da un lato come un movimento ch’ebbe l’egemonia sulla cultura italiana negli anni del fascismo, e dall’altro come l’unico episodio significativo occorso alla carriera di Margherita Sarfatti. Se il primo dei due luoghi comuni è già stato abbondantemente smentito (si cita De Felice: “per la maggior parte dell’era fascista, il regime cercò il consenso degli artisti e il legame tra arte e Stato fu caratterizzato dal riconoscimento reciproco sotto la guida ufficiale”, e s’aggiunge Emilio Gentile: “con la sua politica culturale, il fascismo mirò a diffondere la propria ideologia attraverso un’oculata orchestrazione di temi e di interpretazioni del passato e del presente, con forme diversificate di rappresentazione, non sempre ideologicamente esplicite, per evitare gli effetti controproducenti di un eccesso di propaganda politica in una massa già esposta alla costante pedagogia totalitaria delle altre istituzioni del regime e specialmente della liturgia politica”, e tali considerazioni “valgono per tutte le forme di organizzazione e di espressione culturale del regime fascista, che in questo campo mantenne sempre un atteggiamento eclettico, rinunciando a imporre, specialmente nel campo delle manifestazioni letterarie ed estetiche, un’arte di Stato”), il secondo è invece decisamente più pertinace.
 Uno dei risultati più interessanti del saggio di Mattioli è il rinvenimento d’un’ulteriore nota inedita, che data 25 marzo 1913 (epoca in cui Margherita Sarfatti aveva trentatré anni), e con la quale la giovane, nel tracciare in tre passaggi l’evoluzioni dell’arte con riferimento alla figura del cavallo, si poneva il problema del rinnovamento della “visione espressiva della plastica e grafica” all’indomani dei progressi conseguiti dall’arte della fotografia, e nel periodo del pieno sviluppo di cubismo e futurismo.
Uno dei risultati più interessanti del saggio di Mattioli è il rinvenimento d’un’ulteriore nota inedita, che data 25 marzo 1913 (epoca in cui Margherita Sarfatti aveva trentatré anni), e con la quale la giovane, nel tracciare in tre passaggi l’evoluzioni dell’arte con riferimento alla figura del cavallo, si poneva il problema del rinnovamento della “visione espressiva della plastica e grafica” all’indomani dei progressi conseguiti dall’arte della fotografia, e nel periodo del pieno sviluppo di cubismo e futurismo.
 L’appunto dimostra, secondo Mattioli, che Margherita Sarfatti era già profondamente consapevole della direzione che l’arte italiana avrebbe dovuto intraprendere, e aveva piena contezza dei problemi di più stringente attualità. Problemi che la giovane critica avrebbe seguitato a sfidare anche dopo l’esperienza di Novecento: si fanno gli esempî di Segni, colori e luci, dove Margherita Sarfatti si rapporta alla tradizione nei termini della ricerca d’un classico e non d’un classicismo, o della Storia della pittura moderna, fondamentale compendio delle sue teorie. L’ipotesi è che, pur restando Novecento uno snodo centrale nella carriera di Margherita Sarfatti, la lunga elaborazione teorica che condusse alla costituzione del gruppo e le conseguenze che ne sortirono, sarebbero presupposti bastevoli a smentire l’idea che Novecento rappresenti un fugace e unico momento.
L’appunto dimostra, secondo Mattioli, che Margherita Sarfatti era già profondamente consapevole della direzione che l’arte italiana avrebbe dovuto intraprendere, e aveva piena contezza dei problemi di più stringente attualità. Problemi che la giovane critica avrebbe seguitato a sfidare anche dopo l’esperienza di Novecento: si fanno gli esempî di Segni, colori e luci, dove Margherita Sarfatti si rapporta alla tradizione nei termini della ricerca d’un classico e non d’un classicismo, o della Storia della pittura moderna, fondamentale compendio delle sue teorie. L’ipotesi è che, pur restando Novecento uno snodo centrale nella carriera di Margherita Sarfatti, la lunga elaborazione teorica che condusse alla costituzione del gruppo e le conseguenze che ne sortirono, sarebbero presupposti bastevoli a smentire l’idea che Novecento rappresenti un fugace e unico momento.Ciò che segue è storia recente: il suo ritiro dopo la guerra, il silenzio calato attorno alla sua figura fino agli anni Novanta, giudizî viziati e distorti, una riscoperta lenta ancora in attesa d’arrivare a risultati pieni ma che, come attestano le summenzionate mostre degli ultimi mesi, sembra essere ben indirizzata. E alla cui urgenza, anche per una più completa comprensione di quanto accadde all’arte italiana negli anni del fascismo (oltre che per rendere giustizia a una donna straordinaria e a lungo dimenticata), rinvia l’appassionato, fervido e pressante saggio di Massimo Mattioli che si concentra, più che su di una ricostruzione della vita e dell’opera di Margherita Sarfatti, sull’identificazione delle basi a partire dalle quali si dovrebbe lavorare per conferirle nuovo valore.
 Un saggio che neppure manca d’essere provocatorio: cosa sarebbe successo, si domanda a un certo punto l’autore, se un’intellettuale dalla cultura tanto vasta, di così alto spessore intellettuale, che frequentava le più affascinanti personalità culturali del tempo quando Mussolini ancora insegnava nelle scuole di provincia, non avesse mai incontrato il futuro Duce? Probabilmente, oggi Margherita Sarfatti sarebbe riconosciuta e unanimemente celebrata come una delle donne più importanti del XX secolo e come “personaggio centrale nello sviluppo delle idee e nell’elaborazione del pensiero culturale e politico di un’importante parte del ’900”, si riconoscerebbe pienamente il suo valore di prima donna al mondo a ricoprire il ruolo di critica d’arte in senso moderno, e forse sarebbe divenuta, provoca ulteriormente Mattioli, un’icona del femminismo. Siamo in tempo per recuperare.
Un saggio che neppure manca d’essere provocatorio: cosa sarebbe successo, si domanda a un certo punto l’autore, se un’intellettuale dalla cultura tanto vasta, di così alto spessore intellettuale, che frequentava le più affascinanti personalità culturali del tempo quando Mussolini ancora insegnava nelle scuole di provincia, non avesse mai incontrato il futuro Duce? Probabilmente, oggi Margherita Sarfatti sarebbe riconosciuta e unanimemente celebrata come una delle donne più importanti del XX secolo e come “personaggio centrale nello sviluppo delle idee e nell’elaborazione del pensiero culturale e politico di un’importante parte del ’900”, si riconoscerebbe pienamente il suo valore di prima donna al mondo a ricoprire il ruolo di critica d’arte in senso moderno, e forse sarebbe divenuta, provoca ulteriormente Mattioli, un’icona del femminismo. Siamo in tempo per recuperare.Massimo Mattioli
 Margherita Sarfatti più
Margherita Sarfatti più
 Manfredi Edizioni, 2019
Manfredi Edizioni, 2019
 119 pagine
119 pagine
 14 euro
14 euro* Finestre sull’Arte, 02/04/2019 (ripresa parziale, senza immagini).
*
TODI FESTIVAL:
MARGHERITA SARFATTI. PIÙ
 Con Massimo Mattioli
Con Massimo MattioliUn pamphlet biografico su questo intrigante personaggio: la prima donna critico d’arte della storia, penalizzata dalla storiografia perchè ebbe “l’avventura” di essere una delle amanti di Benito Mussolini.
Introduce Antonino Ruggiano, Sindaco di Todi
 Con la partecipazione di Bruno Ceccobelli, Autore della copertina
Con la partecipazione di Bruno Ceccobelli, Autore della copertina -
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO -- 1938, lo Stato italiano contro gli ebrei. Non solo Mussolini, il parlamento e il re ma anche i volenterosi carnefici del regime.13 ottobre 2018, di Federico La Sala
1938, lo Stato italiano contro gli ebrei
Non solo Mussolini, il parlamento e il re ma anche i volenterosi carnefici del regime
di Vladimiro Zagrebelsky (La Stampa, 13.10.2018)
La responsabilità delle leggi razziali antiebraiche introdotte a partire dal 1938 è certo di Mussolini, del parlamento fascista (alla Camera dei Deputati 340 voti favorevoli, 0 contrari) e di Vittorio Emanuele III; quest’ultimo successore sul trono di Carlo Alberto, che novant’anni prima aveva dato lo Statuto (tutti i regnicoli sono eguali dinanzi alla legge) e riconosciuto a ebrei e valdesi i diritti civili. Tra leggi e circolari l’espulsione degli ebrei dalla vita sociale fu progressiva e alla fine completa. L’impulso politico che aveva prodotto le leggi e le circolari ministeriali richiese atti di esecuzione.
La macchina della vergogna
In particolare, per l’espulsione degli ebrei dai posti che occupavano nelle professioni liberali e nella pubblica amministrazione, furono necessari atti amministrativi individuali per ciascuno dei colpiti. Molti organismi, molte persone furono quindi coinvolti e parteciparono all’opera.
Alla ricostruzione dell’esecuzione delle leggi razziali e all’identificazione di coloro che ne furono vittime si sono dedicati gli autori di due recenti studi. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense hanno da poco pubblicato un volume sull’allontanamento di magistrati e avvocati ebrei. Annalisa Capristo e Giorgio Fabre, per Il Mulino, pubblicano ora
- Il Registro - La cacciata degli ebrei dallo Stato italiano nei protocolli della Corte dei Conti, 1938-1943 (pp. 344, € 26).
 Questo volume raccoglie le informazioni derivanti dalla documentazione della Corte dei Conti, chiamata a registrare la maggior parte dei provvedimenti di esclusione dai posti nella Pubblica Amministrazione.
Questo volume raccoglie le informazioni derivanti dalla documentazione della Corte dei Conti, chiamata a registrare la maggior parte dei provvedimenti di esclusione dai posti nella Pubblica Amministrazione.
Il censimento
Si tratta di circa 720 funzionari ebrei (56 dei quali sarebbero poi finiti nei campi di concentramento nazisti). Vi fu un censimento innanzitutto, con richiesta a centinaia di migliaia di dipendenti pubblici di fornire indicazioni sulla loro razza, discendenza, religione. Tutti dovettero rispondere (e risposero) e quindi, applicando complessi criteri, fu compilato l’elenco di coloro che dovevano ritenersi ebrei. Prima di essere cacciati, molti dipendenti pubblici, magistrati, avvocati ebrei scelsero di dimettersi o di cancellarsi dagli albi degli avvocati. Furono 14 i magistrati esclusi dall’Ordine giudiziario. Ogni posto «liberato» fu occupato da un dipendente non ebreo.
Si tratta di volumi che non solo coltivano il ricordo di chi fu colpito e la memoria dell’infamia dello Stato, ma anche consentono di non limitare e, per così dire, esaurire l’esecrazione con la condanna dei massimi responsabili politici. È infatti necessario allargare lo sguardo e chiedersi come fu possibile la rapida, solerte esecuzione di simili leggi, nella sostanziale indifferenza della società e dei colleghi delle vittime. E poi chiedersi come reagirebbero oggi la società italiana e le sue varie istituzioni, dovesse mai riprodursi una situazione di tanto grave ingiustizia delle leggi.
Una prima risposta richiama il peso schiacciante della dittatura e l’eliminazione dell’indipendenza della magistratura e dell’autonomia dell’avvocatura. I Consigli dell’Ordine degli avvocati erano stati progressivamente privati di competenze e sostituiti dal Sindacato fascista.
Una formula brutale
Ma a quel contesto istituzionale, da cui oggi siamo tanto lontani, va aggiunta la posizione della legge nel diritto e nella cultura giuridica di quel tempo: la legge indiscutibile, nessuna istanza superiore alla legge, cui richiamarsi per metterla in discussione. L’unica alternativa alla applicazione della legge era la sua violazione, oppure, sporadicamente, sforzi interpretativi e limitativi di cui in qualche caso fece uso la magistratura.
Quelle leggi e quelle introdotte nella Germania nazista e in altri Stati europei, poi concluse con la Shoah, hanno messo in crisi nel dopoguerra la pretesa di indiscutibilità delle leggi. Dopo l’esperienza nazista vi fu chi come Gustav Radbruck, il filosofo del diritto tedesco, riprese l’idea di un diritto al di sopra delle leggi, rispetto al quale le leggi positive possono tradursi in torto legale e quindi da non applicare. La riflessione filosofica è poi divenuta una realtà normativa, quando in Italia e in gran parte d’Europa si affermò la superiorità della Costituzione sulle leggi. Venne poi resa concreta la responsabilità degli Stati rispetto ai diritti fondamentali, con le Carte internazionali e particolarmente, in Europa, con la Convenzione europea dei diritti umani e la sua Corte.
Il criterio che si riassume nella brutale formula dura lex sed lex è oggi inammissibile. Non è più necessario il coraggio di rifiutare l’applicazione di una legge ingiusta, incompatibile con i diritti fondamentali dell’uomo. Ora, qualunque sia la forza del legislatore, qualunque sia l’atteggiamento dell’opinione pubblica, per tutti e in primo luogo per i giudici sarebbe un dovere sottoporre una simile legge a uno scrutinio superiore, quello fondamentale della giustizia.
- Il Registro - La cacciata degli ebrei dallo Stato italiano nei protocolli della Corte dei Conti, 1938-1943 (pp. 344, € 26).
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO -- MARGHERITA SARFATTI. L’ ambasciatrice della cultura italiana del primo Novecento raccontata in due mostre, a Milano e Rovereto (di Tiziana Pikler).23 settembre 2018, di Federico La Sala
Arte
Margherita Sarfatti: l’ambasciatrice della cultura italiana del primo Novecento raccontata in due mostre, a Milano e Rovereto
scritto da Tiziana Pikler (Il Sole-24 Ore, il 21 Settembre 2018)
Verso la fine degli anni Venti, il panorama culturale italiano si presentava ricco di individualità e di gruppi che facevano capo a diversi movimenti in giro per l’Italia: la Scuola romana nella Capitale, il Gruppo dei Sei a Torino, i gruppi milanesi Novecento e Corrente, artisti per i quali il cosiddetto “ritorno all’ordine” si traduceva in uno stile figurativo solido e monumentale che racchiudeva in sé l’intento di declinare i temi della grande tradizione italiana, soprattutto prerinascimentali, con la modernità.
A cogliere questa nuova esigenza del panorama culturale italiano è proprio una donna, Margherita Sarfatti, a cui sono dedicate due mostre, inaugurate contemporaneamente, al Museo del Novecento di Milano e al Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, entrambe visitabili fino al 24 febbraio 2019. Mentre a Milano viene approfondita l’arte degli anni Venti nel capoluogo lombardo attraverso un percorso espositivo che vede ben 11 sezioni (Milano, centro di modernità - Margherita Sarfatti nella città che cambia - La rete culturale milanese: artisti, critici, galleristi - Le note d’arte di Margherita Sarfatti: segni, colori e luci - La nascita del movimento artistico “Novecento” - Il “Novecento Italiano” - Il “Novecento Italiano” e la sua organizzazione - Gli orientamenti del gusto e gli acquisti pubblici: il caso delle collezioni milanesi - Il rapporto di Margherita Sarfatti col potere - Dalla redazione dell’Avanti all’esilio dall’Italia), a Rovereto è dato spazio, in altre sei sezioni, al programma di espansione culturale voluto dalla donna.
Margherita Grassini (Venezia, 8 aprile 1880 - Cavallasca, 30 ottobre 1961) nasce in un’importante famiglia ebrea, a soli diciotto anni sposa Cesare Sarfatti, matrimonio che non le impedisce di diventare una figura chiave del sistema culturale italiano, dalla fine della Prima guerra mondiale fino ai primi anni Trenta. Giornalista, curatrice, critica d’arte e fascista convinta, troppo spesso ricordata solo per essere stata una delle amanti di Benito Mussolini, si trasferisce a Milano nel 1902 dove risiede fino alla fine degli anni Venti, quando è costretta a lasciare l’Italia, per un decennio, in seguito alla promulgazione delle Leggi razziali, di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario. Prima però è lei a fondare, nel 1922, il movimento Novecento Italiano, insieme ad artisti come Mario Sironi, Achille Funi, Giorgio Morandi e lo scultore Marino Marini. Per loro, anche con il favore del regime, si fa impellente la necessità di un nuovo ordine compositivo, più moderno, seppure nella consapevolezza dei valori storici italiani, in quell’ambizioso programma di espansione culturale, definito da una delle curatrici, Daniela Ferrari, “colonialismo estetico”.
È anche il periodo in cui si inizia a delineare un moderno “sistema dell’arte” che vede coinvolti critici, galleristi, artisti e mercanti, mentre le mostre d’arte contemporanea iniziano ad attirare l’attenzione del pubblico. Ed è ancora Margherita Sarfatti a promuovere l’arte italiana oltreoceano, con la passione e la dedizione tipiche della caparbietà femminile, tanto da valergli, in quel periodo, il ruolo di ambasciatrice dell’arte italiana nel mondo.
INFO
Museo del Novecento, Milano
Margherita Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano
Orari: lunedì 14.30-19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30
Ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Margherita Sarfatti. Il Novecento Italiano nel mondo
Orari: martedì-domenica 10.00-18.00; venerdì 10.00-21.00; lunedì chiuso
Ingresso: intero 11 euro, ridotto 7 euro
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
- MARGHERITA SARFATTI (Museo del Novecento-Milano).
- MARGHERITA SARFATTI (Mart- Rovereto)
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.Federico La Sala
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI -- Una doppia mostra al Mart di Rovereto e al Museo del 900 di Milano racconta l’ascesa e la caduta di Margherita Sarfatti (di Natalia Aspesi).23 settembre 2018, di Federico La Sala
Sarfatti
Il Duce e l’amica troppo geniale
Una doppia mostra al Mart di Rovereto e al Museo del 900 di Milano racconta l’ascesa e la caduta di Margherita Sarfatti: anima intellettuale del primo fascismo poi scaricata da Mussolini. E infine costretta all’esilio: perché ebrea
di Natalia Aspesi (la Repubblica, Robinson, 23.09.2018)
L’ombra che oscura la figura di Margherita Sarfatti e che lei stessa aveva cercato di allontanare scrivendo nel 1955 Acqua passata, dopo il ritorno in Italia dal lungo esilio, è parte essenziale della sua storia ma non è tutta la sua storia: che due mostre contemporanee e congiunte, (fino al 24 febbraio, catalogo Electa), al museo del ‘900 di Milano (curata da Anna Maria Montaldo e Danka Giacon) e al Mart di Rovereto (curata da Daniela Ferrari), cercano di ricostruire oltre quell’ombra il suo ruolo di importante critica d’arte, di collezionista, di organizzatrice di mostre in Italia e all’estero. E pure ricordando il suo celebre salotto milanese di corso Venezia, dove ogni mercoledì si incontravano politici, poetesse, futuristi, galleristi, novecentisti, celebrità varie. Femministe. Socialisti. Bolsceviche. Fascisti. Un giovanotto dagli occhi prensili, un poeta seduttore, Mussolini e D’Annunzio.
Ma si può davvero separare Margherita Sarfatti da Benito Mussolini, la ricca, audace, colta (sa perfettamente tedesco, inglese, francese) signora dal rustico figlio di un fabbro romagnolo, colei che insegnò come indossare le ghette e scegliere il capello, da chi imporrà anni dopo una stupida divisa a tutti, dai figli della lupa alle maestre?
Forse sì, è possibile restituire Margherita Sarfatti a sé stessa, oltre l’avventura fascista con il suo ‘devotissimo selvaggio’: che prima delle Marcia su Roma le scrive qualcosa come, “Mio amore, il mio pensiero, il mio cuore ti accompagnano. Abbiamo passato ore deliziose ... ti abbraccio forte, ti bacio con tenerezza violenti...”. (citato da Antonio Scurati, in M Il figlio del secolo); e poi nel luglio del 1929, anno VII dell’era fascista, con la sua scrittura aguzza e minacciosa la cancella con livore: “Gentilissima Signora, leggo un articolo nel quale ancora una volta voi tessete l’apologia del cosiddetto ‘900, facendovi alibi del Fascismo e del sottoscritto. Lo disapprovo nella maniera più energica ...”.
Questa e altre decine di lettere, fotografie, documenti, manifesti, libri, per la maggior parte del fondo Sarfatti conservato al Mart, intrecciano le vicende politiche con la ricchezza dell’arte di quei primi decenni del secolo scorso, di cui la signora è certo protagonista: i ‘suoi’ artisti formano il gruppo ‘900 e sono Bucci, Dudreville, Funi, Malerba, Oppi, Sironi, Marussig le cui opere si ritrovano nelle due mostre come autori dei suoi tanti ritratti, come parte della sua collezione privata, come immagini di quel tempo artisticamente vivo, in quella Milano al centro di ogni tumulto politico.
Le fotografie di inaugurazioni mostrano la signora, unica donna in mezzo a decine di uomini con i baffi, le palandrane e il capello. Sono anni in cui le donne si stanno imponendo: a Milano ci sono la socialista Anna Kulishoff che combatte per il suffragio femminile, Angelica Balabanoff vicedirettrice dell’Avanti! quando direttore è Mussolini, Ersilia Maino presidente della Lega Femminile, Ada Negri che è arrabbiata per non aver ricevuto il Nobel, le operaie che precederanno gli uomini negli scontri di piazza contro i fasci.
Margherita è irrefrenabile, scrive sull’Avanti! dove ha conosciuto Mussolini e poi sul Popolo d’Italia da lui fondato; dirige Gerarchia, la rivista ideologica del fascismo, cresce tre figli, perde in guerra Roberto, 17 anni, resta vedova, scivola spesso a Palazzo Venezia come tante altre signore, gira l’Italia e il mondo per i suoi artisti e per il duce.
I collezionisti privati e pubblici sono sempre meno inclini a prestare le loro opere, e infatti Milano e Rovereto hanno dovuto rinunciare ad alcune importanti: ma tra le quasi 200 opere esposte ci sono i nudi femminili dalle cosce possenti di Casorati e Bacci, le signore annoiate sotto i cappelini ai tavoli dei caffè di Marussig e Borra, le nature morte di Oppi e Morandi, gli autoritratti di Dudreville e Funi, i paesaggi di Soffici e Salletti, le tozze madonne simili alle stupefatte massaie rurali di Tozzi e Saetti, i muratori d Campigli, i pastori di Sironi. E i tanti Mussolini scolpiti da Wildt, Thayat, Bertelli, la foto da divo del cinema prima della marcia su Roma, poi travestito da Napoleone con la scritta «una fisionomia storica che ritorna, il pallido corso - il fiero romagnolo», in divisa e a cavallo, con pennacchio bianco sul copricapo; e i ritratti più fascinosi e privati con dedica alla colta e utile amante.
Nel 1932 Margherita viene allontanata dal Popolo d’Italia, è l’anno in cui in uno sfrecciare di macchine sulla strada Roma Ostia, Mussolini alla guida di una Alfa Granturismo Zagato sorpassa quella su cui viaggia la signorina Claretta Petacci: lui ha trent’anni più di lei e tre anni meno di Margherita, cui nel 1936 viene proibito l’ingresso a Palazzo Venezia.
Non solo l’antica amante è diventata fastidiosa, ma è anche ebrea: nel 1938 anno delle leggi razziali, lei sa che non sarà risparmiata e può solo fuggire. Torna nel 1947, appestata dal suo passato, abbandonata dagli ex amici, insultata anche in strada. Muore nella sua casa di campagna nel Comasco nel 1961, a 81 anni.
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO --- IL "DISCORSO DI TRIESTE", 1938. "Roma è qui. È qui sul vostro Colle e sul vostro Mare; è qui nei secoli che furono e in quelli che saranno; qui, con le sue leggi, con le sue armi, e col suo Re" (Mussolini)15 settembre 2018, di Federico La Sala
Fascismo razzista
Il giorno che gli ebrei scoprirono di essere nemici degli italiani
di Alberto Sinigaglia (La Stampa, 15.09.2018)
Il 18 settembre 1938 a Trieste Mussolini tenne un discorso tremendo contro gli ebrei. Per la prima volta giustificava al Paese e al mondo le leggi che il re Vittorio Emanuele III aveva già firmate il 5 e il 7 settembre, preludio sinistro al 17 novembre: Regio Decreto 1728 «per la razza italiana», estremo frutto del «manifesto» dei dieci scienziati pubblicato il 14 luglio sul Giornale d’Italia.
Il duce calcolò il momento, il luogo, le parole. Avvertì importanti giornali stranieri. Scelse la città più internazionale, prossima a confini incandescenti: l’Austria invasa dal Reich, la Cecoslovacchia in pericolo, a giorni la Conferenza di Monaco. Scelse la terza comunità ebraica dopo quelle di Roma e di Milano, che contava ebrei fascisti e irredentisti. Andò a gridargli in faccia che l’ebraismo era «un nemico irreconciliabile», che si decideva per loro una «politica di separazione».
Le «soluzioni necessarie» non sarebbero tardate: via dai libri di testo quelli scritti o curati da ebrei; via i bambini dalle scuole pubbliche e gli studenti dalle università; via i padri, le madri e i nonni dalle cattedre accademiche, dai giornali, da assicurazioni, banche, notai, pubblico impiego; spogliati della divisa coloro che avevano combattuto per l’Italia e ancora la servivano in armi; vietati i matrimoni con ariani.
Il capo del fascismo lanciò due precisi messaggi a chi lo considerava emulo di Hitler e a chi difendeva gli ebrei: «Sono poveri deficienti» quanti credono «che noi abbiamo obbedito ad imitazioni o, peggio, a suggestioni»; «il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore, a meno che i semiti di oltre frontiera (...) e i loro improvvisati amici (...) non ci costringano a mutare radicalmente cammino».
Un operatore cinematografico ufficiale filmò tutto. Paolo Gobetti alla fine degli Anni 70 avrebbe acquistato la pellicola da un collezionista per l’Archivio storico della Resistenza da lui fondato con Franco Antonicelli a Torino. Vi si vede e ascolta il solito Mussolini tonitruante quella mattina in una Piazza Unità d’Italia imbandierata a festa e gremita di popolo, che acconsentiva, applaudiva, urlando di entusiasmo e invocando il suo nome. Dal punto di vista della propaganda fascista, un risultato perfetto: i termini, il tono, l’attore, la scena.
 Perché il cinegiornale dell’Istituto Luce mostrò soltanto l’inizio del discorso e poco più? Fu il regime a censurarlo? E per quale strategia il dittatore, pur tornando spesso al tema razziale, non dedicò agli ebrei altri discorsi di quella forza, anzi evitò di nominarli?
Perché il cinegiornale dell’Istituto Luce mostrò soltanto l’inizio del discorso e poco più? Fu il regime a censurarlo? E per quale strategia il dittatore, pur tornando spesso al tema razziale, non dedicò agli ebrei altri discorsi di quella forza, anzi evitò di nominarli?Il silenzio di Mussolini li ingannò: furono in molti a illudersi, a non cercare riparo oltreoceano, a non poter immaginare che, comunque cittadini italiani, da altri italiani sarebbero stati consegnati ai nazisti e avviati ai Lager. Poiché quel destino fu segnato dal «discorso di Trieste», il Polo del ’900 e l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte hanno pensato che ad aprire le manifestazioni torinesi in memoria delle leggi razziali nulla fosse più efficace di quelle immagini e di quel sonoro: un grumo di odio, disprezzo e «chiara, severa coscienza razziale», certo inattuale, ma salutare alla memoria.
“Occorre una coscienza razziale per stabilire non solo differenze ma superiorità nettissime”
di Benito Mussolini (La Stampa, 15.09.2018)
È questa, o Triestini e Triestine, la quarta volta che ho la ventura, l’onore e la gioia di rivolgervi la parola. La prima fu nel dicembre del 1918, quando nell’aria della vostra città e nelle vostre anime c’era ancora, visibile e sensibile, la vibrazione del grande evento che si era compiuto con la Vittoria. [...]. Dopo molti anni torno fra voi e sin dal primo sguardo ho potuto riconoscere il grande, il poderoso balzo innanzi compiuto dalla vostra, dalla nostra Trieste.
Non sono venuto tra voi per rialzare il vostro morale, così come gli stilopennivori d’oltre monte e d’oltre mare hanno scioccamente stampato. Non ne avete bisogno, perché il vostro morale fu sempre altissimo. (...) Sono venuto per vedere ciò che avete fatto e per vedere altresì come sia possibile di bruciare rapidamente le tappe per giungere alla mèta. Sono venuto per ascoltarvi e per parlarvi. (...)
Triestini!
Vi sono dei momenti nella vita dei popoli in cui gli uomini che li dirigono non devono declinare le loro responsabilità, ma devono fieramente assumerle in pieno. Quello che sto per dirvi non è soltanto dettato dalla politica dell’Asse Roma-Berlino, che trova le sue giustificazioni storiche contingenti, né soltanto dal sentimento di amicizia che ci lega ai Magiari, ai Polacchi e alle altre nazionalità di quello che si può chiamare lo Stato mosaico numero due. Quello che sto per dirvi è dettato da un senso di coscienza che vorrei chiamare, più che italiano, europeo.
Quando i problemi posti dalla storia sono giunti ad un grado di complicazione tormentosa, la soluzione che si impone è la più semplice, la più logica, la più radicale, quella che noi Fascisti chiamiamo totalitaria. Nei confronti del problema che agita in questo momento l’Europa la soluzione ha un nome solo: Plebisciti. Plebisciti per tutte le nazionalità che li domandano, per le nazionalità che furono costrette in quella che volle essere la grande Cekoslovacchia e che oggi rivela la sua inconsistenza organica. Ma un’altra cosa va detta: ed è che, ad un certo momento, gli eventi assumono il moto vorticoso della valanga, per cui occorre far presto, se si vogliono evitare disordini e complicazioni. Questo bisogno del far presto deve essere stato sentito dal Primo Ministro britannico, il quale si è spostato da Londra a Monaco, messaggero volante della pace, perché ogni ritardo non affretta la soluzione, ma determina l’urto fatale. Questa soluzione sta già, malgrado la campagna di Mosca, penetrando nel cuore dei popoli europei.
Noi ci auguriamo che in queste ultime ore si raggiunga una soluzione pacifica. Noi ci auguriamo altresì che, se questo non è possibile, il conflitto eventuale sia limitato e circoscritto. Ma se questo non avvenisse e si determinasse, pro o contro Praga, uno schieramento di carattere universale, il posto dell’Italia è già scelto.
Nei riguardi della politica interna il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito ad imitazioni, o peggio, a suggestioni, sono dei poveri deficienti, ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. IL perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in relazione con la conquista dell’Impero, poiché la storia ci insegna che gli Imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale, che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto.
L’ebraismo mondiale è stato, durante sedici anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del Fascismo. In Italia la nostra politica ha determinato, negli elementi semiti, quella che si può oggi chiamare, si poteva chiamare, una corsa vera e propria all’arrembaggio. Tuttavia gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili, nei confronti dell’Italia e del Regime, troveranno comprensione e giustizia. Quanto agli altri si seguirà nei loro confronti una politica di separazione. Alla fine, il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore, a meno che, i semiti di oltre frontiera e quelli dell’interno, e soprattutto i loro improvvisati ed inattesi amici, che da troppe cattedre li difendono, non ci costringano a mutare radicalmente cammino. [...]
Ma per noi Fascisti la fonte di tutte le cose è l’eterna forza dello spirito, ed è per questo che rivendico a me il privilegio di realizzare quello che fu l’ideale bisecolare della vostra città, l’Università completa nei prossimi anni. Padova, che fu per secoli il solo Ateneo delle genti venete, nel suo vigilante patriottismo comprende, e sarà Padova che offrirà il gonfalone alla neoConsorella giuliana.
Triestini e Triestine!
Dopo quanto vi ho detto io vi domando: C’è uno solo fra voi di sangue e di anima italiana che possa per un solo istante dubitare dell’avvenire della vostra città unita sotto il simbolo del Littorio, che vuol dire audacia, tenacia, espansione e potenza? Non abbiate qualche volta l’impressione che Roma, perché distante, sia lontana. No, Roma è qui. È qui sul vostro Colle e sul vostro Mare; è qui nei secoli che furono e in quelli che saranno; qui, con le sue leggi, con le sue armi, e col suo Re.
Mai prima tanta violenza e livore in un proclama
di Amedeo Osti Guerrazzi (La Stampa 15.09.2018)
L’odio si crea, l’odio si insegna. A Trieste, davanti una folla immensa, Mussolini attacca per la prima volta apertamente gli ebrei italiani e «l’ebraismo internazionale». Fino a quel momento, le sue rare uscite sul tema dell’antisemitismo e del razzismo sono state dichiaratamente critiche. In un discorso del 1934, ha addirittura schernito «talune dottrine d’oltralpe» riferendosi al razzismo nazista. La svolta del regime è cominciata già dal 1937, con l’inizio della campagna di stampa antiebraica. Ma è a Trieste che Mussolini si espone personalmente con un discorso che è un violentissimo attacco, ma anche un capolavoro retorico.
Per la prima volta, «l’ebraismo mondiale» viene indicato come «un nemico inconciliabile» del fascismo. Per la prima volta l’opinione pubblica italiana scopre di avere un nemico.È un passo importantissimo, fondamentale: fino al 1938, nonostante la campagna di stampa partita l’anno precedente, gli ebrei sono stati insultati ed attaccati, anche in maniera pesante, ma mai con questa virulenza e livore, e soprattutto mai da figure di primo piano del regime.
Inoltre Mussolini qui non spiega in alcun modo perché gli ebrei sono dei nemici e suggerisce, invece, che il regime è «costretto» a difendersi da un nemico pericoloso e aggressivo. Il fascismo è giusto e generoso, ma nonostante ciò è attaccato dall’interno (gli ebrei italiani) e dall’esterno (l’ebraismo internazionale).
Come tutte le dittature, il fascismo ha bisogno di presentare al «popolo» dei «nemici» contro i quali mobilitarsi, e le conseguenze funeste di questa politica si vedranno durante l’occupazione nazista, quando i fascisti più radicali aiuteranno le SS nelle deportazioni. Il percorso dell’esclusione e della persecuzione, e la retorica dell’odio contro il «nemico» ebreo, voluto da Mussolini con un cinismo rivoltante, comincia da questo discorso.
I giudici e “le leggi abominevoli”, molti grigi esecutori e pochi eroi
di Giuseppe Salvaggiulo (La Stampa, 15.09.2018)
Il ruolo dei giudici nell’applicazione della legislazione razzista è scandagliato nel volume «Razza e inGiustizia», meritoriamente pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con l’Unione delle comunità ebraiche italiane e presentato ieri in Senato.
Dal 1923 il fascismo aveva limitato l’indipendenza dei magistrati, degradandoli a «funzionari»: il governo ne decideva promozioni e trasferimenti; nominando i capi delle corti, influiva sulle sentenze. Ai giudici di rango inferiore erano imposti camicia nera e saluto fascista. Chi dimostrava «atteggiamenti incompatibili con le generali direttive politiche del governo» era dispensato dal servizio. I reati politici erano sottratti alla magistratura e devoluti a un tribunale speciale. Il Csm era non era più eletto dai giudici, ma designato dal potere esecutivo e ridotto a organo consultivo del ministro. Nel 1941 la tessera del partito sarebbe diventata requisito per l’esercizio della professione.
In questo contesto, non stupisce che il 17 novembre 1938, quando Vittorio Emanuele III firmò il regio decreto 1728 che poneva le basi giuridiche della discriminazione cancellando il principio di eguaglianza tra i «regnicoli» sancito dall’articolo 24 dello Statuto albertino, il contagio nel mondo giuridico fosse già diffuso. Alti magistrati, avvocati di fama e accademici di prestigio contribuivano alla rivista «Il diritto razzista». In generale, la magistratura si adeguò. Prevalse - chi per paura, chi per viltà - la zona grigia, l’ossequio formale a quelle che Calamandrei definì «leggi abominevoli».
I venti magistrati che aderirono fieramente al razzismo antiebraico furono posti al vertice della piramide giudiziaria, salvo riciclarsi in ranghi ancor più elevati dopo la Liberazione. Gli ebrei erano sfiduciati. Fino al 1943 solo 60 fecero ricorso contro provvedimenti discriminatori.
Ma ci fu una parte dei giudici che invece praticò, sotto diverse forme, una resistenza. L’epurazione di 18 magistrati ebrei fu immediata, all’insegna della «purezza razziale dell’intero apparato».
Una forma di resistenza fu quella di chi cercò di limitare, quando non di vanificare, gli effetti delle leggi razziali con una puntigliosa, creativa e cavillosa interpretazione del proprio ruolo. Scrive Giovanni Canzio, ex presidente della Cassazione: «Mentre in Germania i giudici applicavano le norme razziali facendosi interpreti del comune sentimento popolare e conformandosi all’ideologia nazista, in Italia almeno una parte dei giudici interpretava analoghe norme rifacendosi ai principi generali dell’ordinamento, sì da interporre un qualche argine di legalità formale al controllo assoluto messo in atto dal regime».
L’articolo 26 del regio decreto del 1938 attribuiva la competenza esclusiva e insindacabile in materia al ministro dell’Interno, che era lo stesso Mussolini; una legge del 1939 istituiva commissioni speciali, i cosiddetti «tribunali della razza» affidati ad alti magistrati fascistizzati e quindi sostanzialmente emanazione del regime.
Nonostante ciò, alcuni magistrati civili e amministrativi si ritagliarono un ruolo, operando una distinzione: al ministro la decisione «in merito a chi fosse ebreo», ai giudici quella sul godimento dei diritti civili e politici e sullo stato delle persone. Un campo assai vasto: dal lavoro alla famiglia, dal patrimonio all’impresa. Per altro verso, si sostenne un’applicazione restrittiva di leggi considerate eccezionali e si rigettò l’idea, all’epoca (solo?) diffusa, di interpretare il diritto «alla luce del comune sentimento popolare».
La dottrina più autorevole e illuminata - Calamandrei, Galante Garrone, Jemolo - teorizzò il carattere politico, più che la portata giuridica, delle leggi razziali, spiegando che «il concetto di razza è estraneo all’ordinamento italiano». Nel 1939, in una causa in materia di filiazione, la Corte d’appello di Torino (presidente Domenico Riccardo Peretti Griva) rivendicava la propria competenza «a conoscere dell’appartenenza a razza determinata» di un cittadino quando necessario a determinare i limiti della capacità giuridica.
La parte della magistratura schierata col regime non tacque. Giulio Ricci, primo presidente della Corte torinese, contestò l’orientamento con due circolari, che denunciavano l’elusione delle disciplina discriminatoria e paventavano responsabilità dei magistrati fuori linea. Ma Consiglio di Stato e Cassazione difesero i giudici dissidenti, motivando che le deroghe all’autonomia della giurisdizione non potessero essere oggetto di interpretazione estensiva.
I giudici amministrativi annullarono la revoca del nulla osta all’iscrizione universitaria disposta dal ministro degli Esteri nei confronti di un tedesco di origine ebraica. La Corte dei conti restituì la pensione a un’anziana signora. Fu, quello giudiziario, un eroismo sottile e cocciuto che va ricordato. E coltivato.
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO -- Nell’autunno 1938 il regime fascista emanò una serie di leggi, le cosiddette "leggi razziali"... Non solo gli ebrei. Così morì lo Stato (di Anna Foa).6 settembre 2018, di Federico La Sala
Non solo gli ebrei. Così morì lo Stato
Commento di Anna Foa (la Repubblica, Robinson, 02.09.2018)
Nell’autunno 1938 il regime fascista emanò una serie di leggi, le cosiddette "leggi razziali", seguite da ulteriori circolari e disposizioni, che introducevano radicali discriminazioni fra i cosiddetti appartenenti alla "razza ariana" e i non ariani, in particolare gli ebrei. All’epoca, gli ebrei presenti in Italia erano 47.000, di cui 10.000 circa stranieri. Un ebreo ogni mille "ariani", quindi.
Le leggi razziali si abbatterono come un fulmine a ciel sereno sul mondo ebraico italiano, partecipe in larga misura del consenso generale al regime fascista. Le mille disposizioni con cui le leggi colpivano gli ebrei erano inaspettate, anche se fra il 1936 e il 1937 non erano mancate avvisaglie di una possibile svolta razzista, e se il sempre più stretto avvicinamento alla Germania hitleriana appariva a molti preoccupante.
Anche dopo l’emanazione delle leggi, però, il mondo ebraico italiano non ebbe piena consapevolezza della portata della catastrofe. Prevalse l’idea che poco a poco tutto sarebbe finito nel dimenticatoio, mentre molti tentavano la strada delle domande di "discriminazione" per meriti fascisti o altro, ossia l’esenzione individuale dalle norme razziste, per lo più respinte dal regime e che comunque non sarebbero riuscite più tardi ad evitare la deportazione dei "discriminati". Anche tra gli antifascisti, tranne poche voci, scarsa fu la consapevolezza della gravità di quanto accaduto. Il mondo stava precipitando verso la catastrofe e le leggi razziste furono generalmente sottovalutate anche dagli oppositori del regime. Fra gli "ariani" pochissimi reagirono.
Certo, c’era una dittatura che già si era sbarazzata dei suoi oppositori col carcere, l’esilio, il confino. Ma i non ebrei fecero tesoro della propaganda razzista diffusa a piene mani dal regime. I professori delle Università furono pronti ad occupare le cattedre liberate dai colleghi ebrei, gli insegnanti cacciarono da scuola gli studenti ebrei senza mostrare rammarico, un trauma rimasto nella memoria di quei bambini a tutt’oggi. Chi continuava a avere rapporti con gli ebrei era definito "pietista".
Nessuno allora comprese che con queste leggi era definitivamente morto lo Stato creato dal Risorgimento. Che la ferita più grande le leggi l’avevano inferta non agli ebrei, ma all’Italia.
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, IL FASCISMO, MARGHERITA SARFATTI - La grande arte italiana al tempo del fascismo: "Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics. Italia 1918-1943 (di Ada Masoero)18 febbraio 2018, di Federico La Sala
Il Ventennio, che bellezza! La grande arte italiana al tempo del fascismo
di Ada Masoero *
Abbiamo il forte sospetto che la mostra Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics. Italia 1918-1943, che si apre oggi in Fondazione Prada a Milano, rimescolerà pesantemente le carte nella pratica curatoriale che ha dominato l’ultimo ventennio. E che darà una spallata agli «accostamenti emozionali», agli «apparentamenti creativi», ai «confronti evocativi» di certi allestimenti (ancora?) alla moda.
In questa mostra bellissima e monumentale, che occupa quasi per intero gli spazi della Fondazione, Germano Celant ha infatti voluto dar voce ai soli documenti - fotografici soprattutto, ma anche testuali - e presentare le opere esattamente come furono presentate allora, nelle grandi mostre istituzionali, nelle gallerie private di punta o nelle case di collezionisti di fama - come F.T. Marinetti o il mercante francese Léonce Rosenberg, di cui si rievoca la celebre Sala dei Gladiatori di Giorgio de Chirico -, restituendo così le opere al contesto storico, culturale, politico in cui furono fruite. Perché, scrive, «ricollocare l’artefatto nel sistema d’uso», servendosi di tali strumenti “oggettivi”, significa «attuare una ricostruzione quasi antropologica della produzione artistica e del suo apparire».
Di quegli anni figurano perciò in mostra solo opere di cui esistano fotografie delle occasioni pubbliche o private in cui furono viste: «è il documento che ha comandato l’ordinamento», ci ha spiegato mentre allestiva, tanto che lo spettacolare Dinamismo di un foot-baller (1913) di Umberto Boccioni, giunto dal MoMA di New York, non si trova all’inizio del percorso, bensì nelle sale degli anni ’30. Fu scattata nel 1934, infatti, l’impagabile fotografia di Marinetti - il grande rivoltoso - che, di fronte a quel dipinto appeso nella sala da pranzo della sua casa romana di piazza Adriana, mette in scena una gag da gran borghese (quale era in realtà, per nascita e per censo), impartendo un ordine a una cameriera che pare uscita da un manuale di bon ton, con tanto di crestina e grembiulino di pizzo: un trattatello di sociologia condensato in un’immagine, appunto.
Le opere emergono dunque dallo sfondo d’ingrandimenti sgranati di foto d’epoca. Sono in gran parte capolavori, ma non sono mai decontestualizzate, come si suole fare per congelarle in quel ruolo. Se si esclude l’incipit, con i ritratti di Marinetti dipinti negli anni ’20 da Fortunato Depero e Rougena Zatková, la cui fotografia-guida è del 1931 (ma la scelta qui era dettata dal titolo della mostra, che cita le marinettiane «parole in libertà»), di qui in poi tutte le opere sono esposte in 24 grandi ricostruzioni scandite dalla data delle immagini che le mostrano nei contesti d’epoca: ci s’imbatte così nelle opere di Depero e di Giacomo Balla com’erano disposte nella Biennale veneziana del 1926 (la prima cui parteciparono i Futuristi), e nella celebre Natura morta del 1920 di Morandi, “incastonata” nella fotografia della sua parete in Das Junge Italien, la mostra che si tenne a Berlino nel 1921. Ci sono i marmi di Wildt della Biennale del 1922, poi le sculture di Arturo Martini e i dipinti di Mario Sironi posti nelle gigantografie delle loro sale in Biennale, nel 1932. E così è, più avanti, per Fausto Melotti, le cui archetipiche figure maschili sono mostrate nel geniale allestimento di BBPR per la Triennale di Milano del 1936.
I grandi appuntamenti espositivi del tempo sono tutti documentati: ci sono le mostre sarfattiane di “Novecento Italiano”, le Quadriennali di Roma (con Gino Severini in primo piano), i Premi Carnegie (qui è Felice Casorati il primattore), la rassegna epocale Fantastic Art Dada and Surrealism, curata nel 1936 da Alfred H. Barr al MoMA, con i de Chirico metafisici. E le gallerie private più influenti (la Casa d’Arte Bragaglia, il Milione, il Cavallino, la Cometa...), oltre ad affondi su personalità-chiave per la cultura del ’900, alcune organiche, come Luigi Pirandello e Margherita Sarfatti, altre d’opposizione, come Piero Gobetti, Carlo Levi, Alberto Moravia, Lionello Venturi. -Proseguendo con l’identico modello, e senza dimenticare gli artisti ribelli all’ufficialità novecentista (dalla Scuola di via Cavour ai “Sei di Torino”, a Corrente) si giunge all’epilogo, nel 1943: qui, nel gran salone al piano terreno del Podium, sfilano i bozzetti per l’ultimo, grande “ruggito” urbanistico del regime, l’E42, pensato per celebrare il ventennale della Rivoluzione fascista con l’Esposizione Universale Roma, Eur. Mentre, di fronte, si alzano le voci degli artisti dissidenti, da Aligi Sassu a Ernesto Treccani, a un Mino Maccari fascista pentito (siamo nel 1943, e il 25 luglio Mussolini è stato sfiduciato dal Gran Consiglio e arrestato) con la serie satirica Dux.
In un simile, documentatissimo affresco di quel periodo tragico, che vide però fiorire una stagione artistica e architettonica (anch’essa ben presente in mostra) di prim’ordine, non poteva mancare la Mostra del Decennale della Rivoluzione Fascista, organizzata nel 1932 in Palazzo delle Esposizioni a Roma. A quella mostra impressionante è dedicato l’enorme spazio del Deposito: qui, su otto altissimi schermi scorrono gli ingrandimenti delle foto delle sale della mostra, ognuna assegnata a un artista o a un architetto. Ci sono Mario Sironi e Achille Funi, Giuseppe Terragni, Marcello Nizzoli, Adalberto Libera e altri ancora: come dire, lo Stato Maggiore delle arti visive del tempo, in uno spettacolo grandioso che riesce ancora a stupire.
- “Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics. Italia 1918-1943”, Milano, Fondazione Prada, fino al 25 giugno
* Il Sole-24 Ore, Domenica, 18 febbraio 2018 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO - "Brill’s Companion to the Classics, Fascist Italy and Nazi Germany". L’antichità smontata e ricomposta dai nazifascisti (di Carlo Franco).11 febbraio 2018, di Federico La Sala
L’antichità smontata e ricomposta dai nazifascisti
Un Companion pubblicato da Brill. A quale «Classico» si riferivano Hitler e Mussolini? Una raccolta di saggi, perlopiù anglosassoni, cerca radici, usi e sviluppi di un paradigma flessibile
di Carlo Franco ( Il manifesto, Alias, 11.02.2018)
A sentire i fondatori, tutto chiaro. «Roma è il nostro punto di partenza: è il nostro simbolo; o se si vuole, il nostro mito. Noi sogniamo l’Italia romana, cioè saggia e forte, disciplinata e imperiale». Così Mussolini in occasione del «Natale di Roma» sul proprio giornale, nell’aprile 1922. Ante marcia, quindi. Più astratto e generico Hitler, in un discorso al Reichstag del gennaio ’39, sei anni dopo la Machtergreifung, sei anni prima della fine: «Il debito che il germanesimo ha con l’antichità, nel campo dell’assetto statale ma poi anche del proprio sviluppo spirituale e nel settore della cultura in generale, è non misurabile nei dettagli e, nel complesso, gigantesco». E oltre alle linee espresse dai capi, molto altro: soprattutto in Italia, libri, francobolli, monete, statue, monumenti, film. L’antichità aveva grande spazio nei fascismi europei. Fa il punto sul tema il Brill’s Companion to the Classics, Fascist Italy and Nazi Germany, curato da Helen Roche e Kyriakos Demetriou nel quadro di una serie dedicata alla Classical Reception (Leiden, pp. 471, € 182).
Ma a quale antichità si faceva riferimento? Il paradigma era flessibile, sicché ogni sintesi è parziale. Si diceva «antichità», «Grecia», «Roma», ma da questi contenitori venivano ritagliati dei momenti, per costruire una immagine ideale, una narrazione rigenerante utile a proiettare gli animi verso nuovi (ma antichi e già scritti) destini. Ne derivava una combinazione mutevole.
Per il fascismo, si guardò a Roma, soprattutto imperiale, più o meno cristiana a seconda delle opportunità di relazioni col Vaticano: un mito utile per raccontare sia la rivoluzione, sia la conservazione. Per il nazismo, invece, contava una varia combinazione di Grecia (guerriera, spartana), Germania (purezza genetica, purezza etica) e Roma imperiale (per le infrastrutture: come la Kongresshalle di Norimberga). Forse anche per questa varietà, valutare il ruolo dei modelli antichi sui due movimenti è più difficile che non sembri. Di certo, non basta liquidare la romanità littoria o la «spartanità» nazista come un ciarpame privo di gusto o di senso: caduca può apparire oggi certa esteriorità di manifestazioni, ma profondi e persistenti segni di quella stagione marcarono piazze, musei e biblioteche, e forse le coscienze.
Assoluzioni complici o smemorate
Il tema è rimasto a lungo estraneo all’interesse degli storici, ma occupa da quarant’anni filologi e archeologi. Il primo ripensamento venne già da quanti furono direttamente coinvolti, come protagonisti o vittime, o come testimoni. Ma l’elaborazione ha conosciuto un percorso difficile, segnato da reticenze e polemiche, in Italia come in Germania. Si sono viste sia assoluzioni complici o smemorate di studiosi compromessi con i regimi, sia pesanti e irrevocabili condanne. Il Companion Brill cerca la via mediana, invitando a non credere sempre all’innocenza di quelli che furono vicini al potere, ma nemmeno all’idea che tutto quanto si scrisse o si fece allora sia sempre disprezzabile perché dettato dall’ideologia (o dall’adulazione).
Rispetto all’antico, Italia e Germania mostrano due elaborazioni differenti. Varia fu la continuità che portò dai classicismi e i filellenismi di età romantica ai nazionalismi, e alle dittature. Poco conta che Mussolini o Hitler mostrassero una conoscenza del tema superficiale o errata: non di filologia o storia si nutriva il loro discorso. E il loro pensiero, alla bisogna, riceveva forma più colta grazie a solerti pennivendoli.
I saggi del Companion si rivolgono piuttosto a ricercare radici, usi e sviluppi del paradigma. Senza sistematicità, per altro: e dunque, per la Germania, si muove dalle fasi ottocentesche della ricerca sugli «Ariani», con le successive ricadute razziste e antisemite, e poi le ambiguità del circolo riunito negli anni trenta del Novecento intorno al poeta Stefan George: un approccio alla grecità antistorico e antifilologico, che piacque anche al conte von Stauffenberg (l’attentatore del luglio 1944). Da quella linea nicciana e antifilologica derivarono (particolarmente per Platone) interpretazioni che oggi appaiono pre-naziste, ma che forse non sono morte con il nazismo.
Più esplicitamente propagandistico fu l’approccio ai classici imposto(si) nelle scuole del Terzo Reich, studiato da Helen Roche. Se si passa alle scelte individuali, si incontrano quelle tormentate, al tempo del regime, di studiosi (non antichisti) come Adorno, Auerbach e Klemperer, e soprattutto il notevole ruolo degli archeologi - vista la forza evocativa di oggetti e monumenti. In Germania il gruppo accademico ha a lungo difeso, come mostra Stefan Altekamp, l’idea fallace che l’archeologia classica non fosse compromessa con il nazismo (a differenza da quella preistorica e dalla storia antica): il condizionamento fu molto notevole, e con effetti di lunga durata, anche per l’emigrazione forzata di molti importanti studiosi.
La terza Roma sognata da Mazzini
Per l’Italia il Companion non si sofferma sulle radici del «mito di Roma», mito che però attraversa tutto l’Ottocento italiano: una «terza Roma», dopo quella dei cesari e dei papi, era stata sognata da Mazzini, prima che da Mussolini. L’antichistica italiana è inquadrata direttamente nell’età del fascismo: Dino Piovan esamina gli esemplari percorsi e le differenti scelte politiche di studiosi come De Sanctis, Ferrabino, Momigliano e Treves, alle prese con il regime ma anche con il ripensamento storico della propria disciplina accademica.
Il fascismo, meno interessato alla cultura greca, esibiva una romanità militaresca, disciplinata, dominatrice, virile, più italica che ellenistica, quindi «nazionale». Ma, come mostra Jan Nelis, non era (solo) un mito regressivo, quanto piuttosto un approccio paradossale, palingenetico alla modernità. Per questo è opportuno soffermarsi con attenzione sul «piccone del regime»: quello che operò in Roma città larghi sventramenti allo scopo di creare il «teatro del consenso» e lasciare i monumenti a «giganteggiare nella solitudine» (ma la pratica aveva importanti precedenti di fine Ottocento).
Per questo oggi si possono considerare con sguardo nuovo, superato il rigetto totale alla Bruno Zevi, i prodotti dell’architettura durante il ventennio, gli edifici di Vaccaro o Moretti, e persino di Piacentini. I quali produssero in Italia risultati assai migliori rispetto ai classicismi e ai gigantismi creati da Speer in Germania: quella grandiosità celava di fatto un’ossessiva pulsione di sacrificio e morte, cui risposero le bombe angloamericane...
Non c’era poi solo il mondo accademico: l’antico parlava con più immediata evidenza quando era veicolato da mezzi potenti e popolari, come il cinema. Le differenze tra i due regimi, per mezzi e messaggi, si comprendono assai bene ponendo l’opera di Leni Riefenstahl versus quella di Carmine Gallone. Importanti osservazioni vengono anche da eventi come le Olimpiadi di Berlino (1936) e la Mostra augustea della Romanità (’37-’38).
Nel caso della Mostra, l’impegno scientifico si mescolò inestricabilmente a una operazione tutta propagandistica. Nel Companion si parla, ovviamente, del Führer in visita a Roma nel maggio 1938, la «giornata particolare» del film di Scola: ma non si parla di Bianchi Bandinelli, l’archeologo e poi antifascista che fece da guida a Hitler e Mussolini, e li ritrasse sotto gli pseudonimi di Mario e Silla nel memorabile Diario di un borghese, pubblicato nel ’48. Negli anni del massimo consenso per il regime, dopo che nel ’36 l’impero era tornato per poco tempo sui colli fatali, pochissimi capivano dove quell’orgia romanolatrica poteva condurre.
Su un tema così vasto, un Companion non può dire tutto: poco utile allora rilevare che manca, per esempio, il ruolo della «romanità» nelle colonie, soprattutto in Libia. Non disturbano troppo i (parecchi) refusi nell’italiano e nel tedesco. Spiace invece certo squilibrio nella concezione e nella qualità dei contributi. Numerose sovrapposizioni erano evitabili con un editing più stringente. Si nota poi che la maggior parte dei saggi è affidata a studiosi stranieri: ossia né italiani né tedeschi. Certo, nazismo e fascismo sono temi di ricerca internazionali, e non necessariamente lo sguardo dall’interno dei paesi coinvolti è il migliore. Ma l’esito è l’emarginazione della ricerca italiana e tedesca e, per contro, la valorizzazione di recenti lavori anglosassoni presentati come «pionieristici», ma di fatto volti a temi già ben studiati (in altre lingue). Sono gli effetti ormai generalizzati del monolinguismo storiografico: diventerà monopensiero?
Incertezze emergono quando si passa dai fatti o dalle idee alle persone: la vicenda culturale degli studiosi e accademici coinvolti nella macchina delle dittature richiede esperienza. Per capire la fascistizzazione dell’Antico si deve conoscere il dettaglio di persone e luoghi (e consultare con cura il Dizionario Biografico degli Italiani). Spiace, per esempio, leggere di D’Annunzio «futurista» (p. 273), o che «gran parte della nostra esperienza attuale di città iconiche come Firenze e Venezia è il prodotto di scorci legati all’era fascista» (p. 345). Dette in inglese, alcune cose fanno forse meno effetto: ma certe osservazioni banali sopra la «totalitarian legacy» in Italia e Germania andavano evitate (p. 448-54). Certo, in Italia sopravvivono segni pubblici del fascismo (e anche ritratti esposti di Mussolini), mentre in Germania no: ma ciò dipende dalle vicende belliche e postbelliche, più che dallo sfondo ideologico dei due regimi, e dei due paesi.
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE - Mussolini e i giornalisti americani, cronaca di un idillio finito male (di Umberto Gentiloni).9 gennaio 2018, di Federico La Sala
Mussolini e i giornalisti americani
cronaca di un idillio finito male
di Umberto Gentiloni (la Repubblica, 09.01.2018)
- Il libro
- La scoperta dell’Italia di Mauro Canali (Marsilio pagg. 496 euro 20)
«Mussolini è come un Roosevelt latino», un paragone a dir poco azzardato che torna nei giudizi dei corrispondenti americani in servizio a Roma durante il ventennio: «Immaginate un Theodore Roosevelt consapevole del posto che avrebbe occupato nella storia degli Stati Uniti, e avrete l’immagine di Benito Mussolini in Italia». Il fascismo attira curiosità e attenzioni, un fenomeno nuovo, un fermento politico difficile da decifrare, per molti un enigma.
 A partire dagli anni Venti il drappello di corrispondenti americani diventa cospicuo, agenzie, quotidiani e periodici si attrezzano per raccontare ai lettori d’oltreoceano cosa stia avvenendo in un angolo della vecchia Europa. Una rete di relazioni e rapporti tra diplomatici, uomini di governo, giornalisti al lavoro su biografie, racconti, reportage. Un mondo che si muove nell’Italia fascista, in un crocevia incerto tra la libertà e la curiosità di scrivere e gli strumenti coercitivi di controllo e censura del regime. Uno spaccato del fascismo attraverso una sua proiezione fuori dai confini nazionali. Un volume mette insieme le corrispondenze statunitensi sulla società del ventennio (Mauro Canali, La scoperta dell’Italia. Il fascismo raccontato dai corrispondenti americani, Marsilio, € 20,00).
A partire dagli anni Venti il drappello di corrispondenti americani diventa cospicuo, agenzie, quotidiani e periodici si attrezzano per raccontare ai lettori d’oltreoceano cosa stia avvenendo in un angolo della vecchia Europa. Una rete di relazioni e rapporti tra diplomatici, uomini di governo, giornalisti al lavoro su biografie, racconti, reportage. Un mondo che si muove nell’Italia fascista, in un crocevia incerto tra la libertà e la curiosità di scrivere e gli strumenti coercitivi di controllo e censura del regime. Uno spaccato del fascismo attraverso una sua proiezione fuori dai confini nazionali. Un volume mette insieme le corrispondenze statunitensi sulla società del ventennio (Mauro Canali, La scoperta dell’Italia. Il fascismo raccontato dai corrispondenti americani, Marsilio, € 20,00).Una ricerca complessa, tra archivi privati di giornalisti, fonti ufficiali, documenti conservati dalle testate a New York, Chicago o Los Angeles. Il segno delle corrispondenze muta nel tempo.
Di fronte ai primi passi molti sono abbagliati, folgorati dall’illusione della popolarità del giovane dittatore capace di imporre regole e comportamenti in una società conflittuale, disordinata, potenzialmente conquistabile dalle sirene della rivoluzione comunista. Estimatori convinti definiscono Mussolini «una sovrumana dinamo umana», o ancora «una personalità notevolmente brillante che stava compiendo meraviglie in Italia». Si fa a gara per avere udienza, trovare un canale diretto, fissare un’intervista che possa svelare ambiti privati, lati meno conosciuti del fascismo e del suo capo: «Il Grande Uomo del momento! Che Dio lo benedica e protegga lui e l’Italia», in un crescendo di considerazioni apologetiche, persino imbarazzanti. Si dà risalto all’aspetto fisico «di una forza della natura» fino a descriverlo come un «divino dittatore pieno di fascino, forza e gentilezza» capace di suscitare emozioni intense «per molto tempo ancora dopo averlo salutato». Un idillio che secondo l’autore ha delle radici ben precise: «Rimasero colpiti nei primi anni del regime quando il dittatore cercava di presentare il fascismo come una sorta di terza via tra comunismo e capitalismo, moderatore degli eccessi di quest’ultimo e nel contempo solido argine nei confronti del comunismo».
Ma nel breve spazio di pochi anni la natura del regime cominciò a venir fuori. Mussolini esercitò un controllo diretto e costante sui corrispondenti: voleva trasmettere un’immagine positiva e accattivante, cercava il consenso delle comunità di italoamericani.
Con la metà degli anni Venti e soprattutto con l’introduzione delle “leggi fascistissime” del novembre 1926 il controllo diventò serrato. «Il regime cercò di corrompere i corrispondenti stranieri per garantirsi quantomeno un atteggiamento benevolo». Chi non ci stava, chi non accettava il ruolo di megafono del regime veniva individuato, controllato e intercettato: «I corrispondenti potevano essere ammoniti, diffidati, minacciati o anche espulsi».
Con la guerra di aggressione all’Etiopia quelle aspettative illusorie dei primi anni si trasformano in una presa di distanze critica da parte della stampa statunitense, nel momento di maggiore consenso del fascismo nella società italiana.
Non esistevano alternative, «O sei con Noi o contro di Noi». Molti cedettero (quasi la metà, secondo l’opinione del 1945 di uno sconsolato Paul Scott Mower), altri cercarono di raccontare opponendosi all’idea che la stampa potesse essere trasformata in un organo di propaganda e non di critica.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.MADDALENA SANTORO E -- "Margherita Sarfatti. Dal mito del Dux al mito americano" (S. Urso). Note
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO -- IL RISORGIMENTO E GLI EBREI: LA LEZIONE DI GIUSEPPE VERDI. Note.29 settembre 2017, di Federico La Sala
IL RISORGIMENTO E GLI EBREI: LA LEZIONE DI GIUSEPPE VERDI ...
Risorgimento italiano, Ebrei, Antisemitismo ....
 Una nota di Gramsci ....
Una nota di Gramsci .... - “Jérusalem”, la terra promessa di Verdi
Il Festival di Parma apre con la versione francese dei «Lombardi»
Giuseppe Verdi e il Risorgimento
di Maria Rosa Mazzola *
- La popolarità del melodramma nell’ottocento
Nell’Ottocento tra le varie forme di musica il melodramma era senz’altro la forma che più godeva del favore del pubblico e suscitava un grande interesse sia nelle persone semplici che negli intellettuali e negli aristocratici. La rappresentazione di un’opera era allora un evento di straordinario interesse: per effetto della sua natura che mette insieme lo spettacolo scenico, la musica e l’intreccio narrativo spesso commovente, essa costituiva un’occasione unica capace di suscitare vero impeto in un’epoca in cui le possibilità di intrattenimento non erano molte. Per questo molti guardavano al melodramma come a uno dei mezzi più efficaci per far conoscere le nuove idee di libertà, di indipendenza e di amor di patria.
- La Musica di Verdi - colonna sonora del Risorgimento
Le opere che Giuseppe Verdi scrisse tra il 1842 e il 1849 avevano tutte una forte componente patriottica e vennero tutte accolte dall’entusiasmo del pubblico. Le arie e i cori che parlavano ai cuori e alle coscienze, venivano bissati in teatro e cantati nelle piazze, andando in un certo senso a costituire la "colonna sonora" del Risorgimento.
Da allora iniziò il mito di Giuseppe Verdi, mito che continua tuttora, perché, come disse il presidente Ciampi in occasione del centenario della morte di Verdi, "se l’Italia divenne una sola nazione lo si deve anche a lui e alla forza del suo linguaggio musicale".
- L’opera risorgimentale
Quando Verdi portò Nabucco alla Scala era un giovane di ventinove anni che non presentava particolari velleità patriottiche o sobillatrici. Verdi aveva un unico desiderio, fortissimo e comprensibile: voleva affermarsi artisticamente. Verdi voleva uscire da quel tunnel buio nel quale era entrato negli ultimi anni e nel quale aveva sopportato tragedie immense come l’annientamento della sua famiglia, gli stenti placati solo dall’aiuto di Barezzi e di qualche amico, l’umiliazione prodotta dall’insuccesso di Un giorno di Regno.
- Nabucco - Una fortunata combinazione
Verdi ambiva al successo, alla tranquillità economica, all’indipendenza. Perciò quando si ritrovò fra le mani il libretto di Nabucco è inverosimile che si fosse messo a tavolino per progettare un’opera che avrebbe inaugurato il risorgimento musicale italiano.
Fu una fortunata combinazione il fatto che il libretto contenesse la storia di un popolo oppresso da un potere straniero. Fu una combinazione il fatto che Verdi potesse rappresentare quest’opera alla Scala, nel più importante teatro italiano, in una delle città dove il movimento liberale si stava animando. Non fu una combinazione la musica travolgente che Verdi seppe imporre a questo libretto, una musica accesa, infiammata, vivida. Era questa la musica dell’anima verdiana ed era perfettamente calibrata per evocare una sentimentalità patriottica.
- I Lombardi alla prima Crociata
L’opera successiva a Nabucco fu I Lombardi alla prima Crociata. Opera simile al Nabucco dal punto di vista compositivo. Stessa sequenza di brani, cori posti con funzione drammatica analoga, temi musicali con evidenti similitudini, focosità replicata ed accresciuta.
Ancora opera di masse, di grandi temi popolari. I Lombardi alle prese con una Crociata, ed i riferimenti alla grande Crociata che gli italiani dovevano decidersi ad intraprendere furono intenzionalmente marcati. Per raggiungere l’effetto che cercava, Verdi, utilizzò ogni mezzo. Tamburi, trombe squillanti, cori, preghiere, invocazioni a Dio, tutto ciò che poteva infiammare il pubblico.
- Va pensiero e O Signore dal tetto natio
Il popolo, protagonista in Nabucco come nei Lombardi, si presenta però in quest’ultima con ruolo diverso, opposto rispetto a quello che contraddistingue lo sfortunato popolo ebraico di Nabucco. Una prova di questa diversità ce la offre il coro “O signore dal tetto natio”, simile al “Va pensiero” nel ruolo emotivo ma antitetico nella psicologia di fondo.
Nel “Va pensiero” gli Ebrei sognano la loro terra natia; nel coro de I Lombardi i milanesi sognano le loro belle colline nebbiose, fresche e attraversate dai fiumi.
Ma mentre nel “Va pensiero” gli Ebrei sono conquistati ed oppressi dai cattivi assiri, nel coro dei Lombardi, i lombardi sono ad Antioca, durante una Crociata, a giocare il ruolo di invasori, di conquistatori. Piccola differenza che comunque ci mostra quanta diversa intenzione ci sia fra le due opere. Verdi, nei Lombardi, comincia a porre i buoni fra gli attivi, i belligeranti. I buoni non sono più gli Ebrei rassegnati, ora sono i lombardi battaglieri.
- La battaglia di Legnano
Con il librettista Salvatore Cammarano, da sempre sostenitore di aspirazioni patriottiche, a Napoli, Verdi mise in scena, non senza problemi con la censura, La battaglia di Legnano. Questa opera, dal contenuto sovversivo, fu rappresentata durante la Repubblica romana, la sera del 27 gennaio 1849, qualche giorno avanti la proclamazione dell’effimera repubblica. Verdi, che curò personalmente l’allestimento della prima, ebbe un successo travolgente, tanto che il compositore fu investito di una onorificenza repubblicana. Questo fatto, però, danneggiò la fama dell’opera che, in altre riprese fatte durante l’Ottocento, fu sottoposta al cambiamento del titolo, dell’ambientazione e dei personaggi.
Per quanto riguarda il compositore, subito dopo la prima, se ne andò frettolosamente a Parigi. Ma Verdi era uomo di musica e non d’armi; stando a Parigi si era illuso di poter comporre e portare avanti opere sovversive. La sua opera continuava a raccogliere consensi e a coinvolgere i patrioti che trovavano nella sua cifra melodica e nella sua vigorosa orchestrazione ispirazione e esortazione per le loro lotte.
- Cappello all’Ernani e ...musica del cannone!
Durante le cinque giornate di Milano, un osservatore straniero, J. Alexander von Hübner, così scriveva: «In mezzo a questo caos di barricate si pigiava una folla variopinta. Preti molti col cappello a larghe tese, fregiato di coccarda tricolore, signori in giustacuore di velluto... borghesi portanti il cappello alla Calabrese o in onore di Verdi il cappello all’Ernani». Nell’aprile di quello stesso anno Verdi scrisse al librettista Piave, arruolato a Venezia nella Guardia Nazionale, una lettera nella quale faceva esplicite affermazioni: «... Sì, sì, ancora pochi anni forse pochi mesi e l’Italia sarà libera, una, repubblicana. Cosa dovrebbe essere? Tu mi parli di musica! Cosa ti passa in corpo?... Tu credi che io voglia ora occuparmi di note, di suoni?... Non c’è né ci deve essere che una musica grata alle orecchie degli Italiani nel 1848. La musica del cannone!...».
- Il tramonto degli ideali risorgimentali
Ma i moti del 1848 si concluderanno con una sostanziale sconfitta dei sostenitori della rivoluzione e, con essi, anche gli ideali repubblicani subiranno un grave colpo. Tanti i nomi che passeranno alla causa monarchica e tra essi troviamo anche Verdi (appena eletto delegato per Busseto dopo l’annessione al Piemonte), che in una lettera dell’8 settembre 1859 scriveva al podestà di Busseto:
«L’onore che i miei concittadini vollero conferirmi nominandomi loro rappresentante all’Assemblea delle Provincie parmensi mi lusinga, e mi rende gratissimo. Se i miei scarsi talenti, i miei studi, l’arte che professo mi rendono poco atto a questa sorta d’uffizi, valga almeno il grande amore che ho portato e porto a questa nobile ed infelice Italia. Inutile il dire che io proclamerò in nome dei miei concittadini e mio: la caduta della Dinastia Borbonica; l’annessione al Piemonte; la Dittatura dell’illustre italiano Luigi Carlo Farini. Nell’annessione al Piemonte sta la futura grandezza e rigenerazione della patria comune. Chi sente scorrere nelle proprie vene sangue italiano deve volerla fortemente, costantemente; così sorgerà anche per noi il giorno in cui potrem dire di appartenere ad una grande e nobile nazione».
* Cfr. Maria Rosa Mazzola, O Patria mia! La musica e il sentimento patriottico (ripresa parziale).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità
 LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.Federico La Sala
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI -- STORIA DEGLI EBREI CHE FECERO MILANO. Interv. a Rony Hamaui (di Francesco Cancellato).29 settembre 2017, di Federico La Sala
La curiosa storia degli ebrei che fecero Milano
Dalla banca popolare all’Asilo Mariuccia, dal socialismo al fascismo, dal Risorgimento alla Resistenza. Storia di una comunità ebraica anomala. Che Rony Hamaui ha raccontato in un libro
di Francesco Cancellato *
«Milano, per la comunità ebraica italiana, è un’anomalia». Senza ghetto, senza sinagoghe nascoste, senza cimiteri abbandonati. Ma nello stesso tempo, non c’è città italiana - sicuramente non negli ultimi due secoli - che debba così tanto agli ebrei nel definirne l’identità economica, sociale e culturale. A raccontarlo, Rony Hamaui, nel suo nuovo libro “Ebrei a Milano” (il Mulino) che sarà presentato nell’ambito della manifestazione Jewish in the city, festival internazionale di cultura ebraica giunto alla sua terza edizione, che si terrà dal 29 al 31 maggio a Milano.
Hamaui, perché Milano è un’anomalia, nella storia degli ebrei italiani?
Quello dei ghetti ebraici, delle comunità chiuse non è solo uno stereotipo. È lo standard perlomeno per le comunità ebraiche italiane, Roma in particolare.
Perché Milano non fa parte di questo standard, quindi?
Perché quella di Milano è una comunità ebraica recente, molto eterogenea, che ha trovato nella città un terreno fertile nell’integrazione.
In cosa consiste questa fertilità?
Facciamo un passo indietro. Gli ebrei a Milano non erano potuti vivere per molti secoli. Erano stati tenuti lontani dalla città. Con l’illuminismo austriaco prima e con Napoleone poi, Milano diventa un polo molto attraente. È una città con un clima di libertà e di tolleranza. E soprattutto è un polo economico in crescita. Il luogo ideale per lavorare L’aperturta dello sportello di sconto della Banca d’Italia a Milano, nella seconda metà dell’ottocento, fu un momento di svolta. Per Milano fu un momento di enorme sviluppo. Ed è anche per questo che molti ebrei affluirono sotto la Madonnina.
Da dove?
Da tutta Italia, anche dal nord Europa, ma soprattutto da Mantova.
Come mai proprio Mantova?
Era la comunità più vicina ed è una città con una lunga tradizione ebraica. Milano nasce come un appendice della comunità Mantovana. Molti mantovani erano andati a vivere a Milano. Non è un caso che anche il primo rabbino di Milano venga da Mantova. Questo fino al 1866 - giusto centocinquant’anni fa - quando c’è il distacco amministrativo e giuridico della comunità ebraica milanese, non senza opposizione da parte dei mantovani.
E cosa succede, a questo punto?
Succede che ancora di più Milano continua ad attrarre ebrei da tutta Italia e da tutta Europa. A Milano, però, arrivano ebrei che non si conoscono tra di loro e non parlano la stessa lingua. Faticano a diventare una comunità. Le strutture che nascono per loro, prima fra tutta la scuola ebraica, sono poco frequentate. Non a caso, Il tempio viene costruito molti decenni dopo, nel 1892, in via Guastalla.
Come mai?
Perché gli ebrei milanesi hanno voglia di integrarsi, di guadagnarsi uno status sociale. L’Italia era un po’ da costruire. E come diceva D’Azeglio c’erano da fare anche gli italiani. C’era un clima di grande eterogeneità, in Italia e soprattutto a Milano. E la sociologia moderna ci insegna che strutture eterogenee inglobano molto meglio l’immigrazione. In più - altro elemento che ha facilitato il processo - gli ebrei milanesi erano di alto livello culturale.
- «Fu Luigi Luzzatti, ebreo, a fondare la Banca Popolare di Milano. Anche la Banca Commerciale Italiana nasce con capitali ebraici, tre dei suoi primi quattro amministratori delegati erano ebrei. E poi ci sono le banche familiari: gli ebrei avevano un terzo del sistema bancario milanese, pur essendo un duecentocinquantesimo della popolazione. E poi facevano grande attività filantropica, culturale, politica»
Qual è l’effetto su Milano di questa integrazione?
È determinante per lo sviluppo della città, sotto ogni punto di vista.
Qualche esempio?
Il Risorgimento milanese ha una fortissima matrice ebraica. I Finzi, ad esempio, giocarono un ruolo fondamentale nelle Cinque Giornate di Milano. E lo stesso Enrico Guastalla, figura emblematica nel risorgimento italiano, era ebreo, così come tantissimi garibaldini.
Come mai?
Perché la libertà dagli austriaci, era la loro libertà. Non è solo una tendenza milanese, questa. Gli ebrei romani, ad esempio, erano così pro risorgimentali che il papato cominciò a preoccuparsi. E non a caso qualche traccia di antisemitismo c’è, a quell’epoca.
Anche a Milano?
No, a Milano no. Basta pensare a Giuseppe Verdi, che rappresenta il Nabucco alla Scala, mettendo al centro della liberazione il popolo ebraico. Sarebbe stato impensabile in un contesto antisemita. Milano era un luogo in cui gli ebrei erano davvero protagonisti dello sviluppo economico e sociale.
Qualche esempio?
Fu Luigi Luzzatti, ebreo, a fondare la Banca Popolare di Milano. Anche la Banca Commerciale Italiana nasce con capitali ebraici, tre dei suoi primi quattro amministratori delegati erano ebrei. E poi ci sono le banche familiari: gli ebrei avevano un terzo del sistema bancario milanese, pur essendo un duecentocinquantesimo della popolazione. E poi facevano grande attività filantropica, culturale, politica.
Come?
L’Umanitaria presenta elementi fortissimi di ebraicità. L’asilo Mariuccia fu fondato da ebrei. E parlando di cultura, ricordo che furono i Treves, con la loro tipografia, a pubblicare per la prima volta Verga e D’Annunzio. Mentre a livello politico va ricordato l’impegno nella creazione del socialismo riformista milanese, di cui Anna Kuliscioff è un esempio, ma anche del fascismo, con Margherita Sarfatti.
- «Milano anche oggi rimane una città molto aperta. Negli ultimi mesi, però, ci sono stati alcuni episodi di antisemitismo. Forse è un caso, forse è un’onda lunga che arriva da lontano. Qualche attenzione in più è necessaria, però»
Addirittura il fascismo?
Gli ebrei si distribuirono anche a destra. Margherita Sarfatti, ebrea, fu amante di Mussolini e scrisse Dux, libro che aveva l’obiettivo di far conoscere Mussolini nel mondo. Non a caso, la prima edizione fu in inglese. Lui la ripudiò per motivi personali e politici. Scappò in America latina per via delle leggi razziali.
Ecco, parliamone, delle leggi razziali...
Il periodo delle leggi razziali è una cesura storica. Milano era la città più liberale d’Europa, in quegli anni. Non credevano ai loro occhi, gli ebrei, quando nel 1938 furono emanate le leggi razziali. Fu una pugnalata. Ma in quel momento l’ebraismo milanese trovò un unità che non ebbe mai trovato prima. Si può dire che le leggi razziali misero d’accordo tutti gli ebrei. Che, ad esempio, iniziarono a mandare i figli in una scuola ebraica. Nacque una specie di ghetto sociale, lì dove non c’era mai stato.
Ci fu qualche forma di resistenza contro il nazifascismo?
C’erano centri di resistenza molto forti. Soprendentemente, l’università Bocconi fu uno di quelli. Erano ebrei personaggi come Sraffa, Delvecchio, Mortara. La Bocconi è una storia nella storia molto interessante.
E oggi?
Milano anche oggi rimane una città molto aperta. Negli ultimi mesi, però, ci sono stati alcuni episodi di antisemitismo. Qualche segno di preoccupazione c’è. Le recenti aggressioni dei ragazzi con papalina, o del rabbino per Milano sono una specie di choc. Non era mai successo prima. C’era una matrice anti-istraeliana, politica, ma niente di antisemita. Milano era un isola felice, da questo punto di vista. Forse è un caso, forse è un’onda lunga che arriva da lontano. Qualche attenzione in più è necessaria, però.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO
- “Jérusalem”, la terra promessa di Verdi
Il Festival di Parma apre con la versione francese dei «Lombardi»
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO -- Il sapore della Roma tardo antica raccontato da Peter Brown (di Marco Tagliaferri).28 settembre 2017, di Federico La Sala
STORIA E STORIOGRAFIA.... *
Il sapore della Roma tardo antica raccontato da Peter Brown
di Marco Tagliaferri *
- Peter Brown, Il mondo tardo antico (trad. di Maria Vittoria Malvano), Einaudi, 2017, pp. 236
«Possibile mai che rinunciassero / alla loro bella vita; ai divertimenti / quotidiani di ogni sorta; al loro splendido / teatro, luogo di incontro dell’Arte / col fervore dell’eros, della carne?». Forse i versi di Kavafis sprigionano, intrisi come sono di uno spirito agli antipodi del mero Historismus (nell’accezione che Benjamin diede a questo termine), il sapore di un’epoca, quella tardo antica, in cui, come scrisse Glen Bowersock, «poteva trovare il proprio posto un edonista, al tempo stesso cristiano e greco»; un’epoca che Peter Brown, in un volume appena pubblicato da Einaudi in una nuova edizione, Il mondo tardo antico (traduzione di Maria Vittoria Malvano), riesce a evocare coniugando la precisione dello studioso di storia e antropologia con la finezza profonda di un Montaigne, incline quindi a leggere i meri dati che la ricerca storiografica ed epigrafica comunica mutandoli in una sintassi strutturata e sensibilissima, in un discorso evocatore di molteplici significati.
Se al cultore di materie storiche il nome di Peter Brown è naturalmente ben noto, non sarà d’altro canto infruttuoso presentarne sommariamente la figura e le linee di pensiero al profano che voglia avvicinarsi al periodo sul quale la sua ricerca ha insistito e alla sua opera.
Nato a Dublino nel 1935 e laureatosi a Oxford nel 1956 sotto il magistero di Arnaldo Momigliano, Peter Brown è autore di alcuni testi fondamentali per comprendere la tarda antichità, dai quali emerge un approccio le cui principali direttrici possono essere individuate: in una visione che, a scapito di un modo di intendere la Storia come isomorfica alla vita biologica, con il suo processo ineluttabile di nascita, ascesa e decadenza (rappresentato da uno storico come Gibbon o da un autore che, invece, storico non fu: Oswald Spengler), sa cogliere al contrario le continuità, il permanere di strutture arcaiche (ma non archetipali, sempre comprese nel loro alveo storico) o superate, osservate nelle loro sopravvivenze (per usare un termine caro a Warburg) sotto le spoglie che il divenire storico ha loro imposto, allontanandole così dal significato originario (in un’epistrofe verso un’origine, come ha dimostrato abilmente Georges Didi-Huberman in un bel saggio su Blanchot, non mai raggiungibile); nella considerazione del fenomeno religioso come fatto centrale, promotore assieme ai fenomeni economici e politici dei mutamenti in atto e non attore secondario, un filo vigoroso, insomma, che innerva abitudini, idee, corpi; e, infine, nella dilatazione del periodo cosiddetto tardo antico fino al IX secolo, fino al nascere e all’attestarsi dell’Islam.
Non stupirà, quindi, che il suo testo su Il culto dei santi (sempre pubblicato da Einaudi), venga considerato da Carlo Ginzburg come l’opera più importante per comprendere un fenomeno il quale, senza le peculiarità appena esposte, sarebbe materia di un’interpretazione tanto vaga quanto inesatta nel suo volervi attribuire una natura di novità troppo radicale e ignorandone così la continuità con l’habitus pagano.
Ne Il mondo tardo antico Brown traccia un disegno pulsante e vividissimo della metamorfosi cui l’impero romano è sottoposto durante il III secolo d.C., quando l’ansia che, sottile, pervade già più di un secolo prima quell’opera straordinaria che è il De defectu oraculorum di Plutarco, si manifesta, con un’evidenza fino a quel momento inedita, nell’insicurezza che dal 240 d.C. le invasioni barbariche cominciano a instillare nel tessuto sociale, creando così un contesto che poco più di un decennio prima un autore come Dione Cassio non aveva nemmeno presentito, sicuro com’era dell’immutabilità non solo di Roma eterna, ma anche dei privilegi che quella società, rigidamente divisa fra un’aristocrazia senatoria e un mondo oscuro di contadini sottosviluppati, di “zotici” e “barbari, garantiva, attraverso un approccio che Erich Neumann avrebbe chiamato “negazione della negazione”: se, infatti, «le classi governanti dell’impero romano si erano mantenute in gran parte immuni dai più virulenti esclusivismi dei regimi coloniali moderni», tuttavia non riuscirono a evitare di esigere il conformismo al proprio stile di vita e alla propria cultura, conditio sine qua non per elevarsi dallo stadio infimo nel quale l’assenza di una paideia solidamente classica confinava.
Il perfetto realizzarsi della propria interiorità in una vita pubblica organizzata, come i templi e le cerimonie pagane, si interrompe, proprio in quegli anni, dando vita a una rivoluzione spirituale gravida di conseguenze profondissime; Plotino e Antonio, «questi due straordinari egiziani», sebbene antitetici, rappresentano con grande chiarezza la Stimmung di questa epoca: in un ripiegamento verso la propria interiorità, attraverso il quale il corpo e l’esteriorità possano perdere i propri privilegi a favore dello spirito e dell’intelletto, la dialettica di “conversione” e “rivelazione” inizia, lentamente, a creare la figura di un uomo nuovo, capace di trovare la propria fisionomia in una biografia che non contempli, per forza, episodi eclatanti, ma che sia la storia del proprio cuore e dei movimenti, allo stesso tempo sottilissimi e squassanti, che esso produce. Un processo che avrebbe trovato, in una figura monumentale come quella di Agostino, compiuta fine e stentato inizio, in un movimento che ancora oggi non vediamo esaurito.
* TRECCANI Magazine/Atlante, 28.09.2017.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
ROMOLO AUGUSTOLO. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO" -- "REX" E "DUX". Nardò e il Sedile, l’altro ieri, ieri, e oggi.
IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.
Federico La Sala
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO - IL "DVX" MARGHERITA SARFATTI E IL "REX" E IL" DUX" DEL SEDILE DI NARDO’ (LECCE).27 settembre 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, IL SEDILE, LA SELLA CURULE, LA "X" DI "REX" E "DUX", HENRY W, LONGFELLOW, E IL "DVX" DEL FASCISMO....
AD AMPLIARE e a contribuire a rendere più comprensibili ed evidenti i nessi tra i vari livelli del brillante lavoro di Armando Polito sul SEDILE di Nardò (Lecce), è bene tenere presente e ricordare cosa era la SELLA CURULE nella società dell’antica Roma:
"La sella curule (in lat. sella curulis) era un sedile pieghevole a forma di "X" ornato d’avorio, simbolo del potere giudiziario, riservato inizialmente ai re di Roma e in seguito ai magistrati superiori dotati di giurisdizione, detti perciò "curuli".
I magistrati solevano portare con sé la sella curulis assieme agli altri simboli del loro potere (fasci, verghe e scuri) e ovunque disponessero questi simboli, lì era stabilita la sede del loro tribunale.
Durante il periodo della Repubblica, il diritto di sedere sulla sella curule era riservato a: consoli, pretori, edili curuli, sacerdoti massimi, dittatori e al magister equitum. In epoca imperiale l’uso della sedia curule fu ampliato anche all’imperatore, al praefectus urbi e ai proconsoli.
Il simbolo di potere rappresentato dalla sedia curule affonda le sue radici nell’antica Etruria; infatti già gli Etruschi consideravano lo scranno pieghevole a forma di sella una prerogativa di chi poteva esercitare il potere (giudiziario ed esecutivo) sul popolo. Fu portato a Roma dal quinto re, Tarquinio Prisco.[1]
- (LAT.)
 « Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit. Alii ab numero avium quae augurio regnum portenderant eum secutum numerum putant. Me haud paenitet eorum sententiae esse quibus et apparitores hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse Etruscos quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lictores dederint. »
« Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit. Alii ab numero avium quae augurio regnum portenderant eum secutum numerum putant. Me haud paenitet eorum sententiae esse quibus et apparitores hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse Etruscos quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lictores dederint. »
- (IT)
 « Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunita in assemblea la massa che non avrebbe mai potuto unificarsi in un unico organismo popolare se non con leggi, Romolo dettò norme giuridiche. Dunque, stimando che esse sarebbero apparse inviolabili a un materiale umano ancora rozzo solo se egli stesso si fosse reso venerabile per mezzo di segni esteriori dell’autorità, si fece più maestoso con fasto dell’abbigliamento e particolarmente con la guardia dei dodici littori. Alcuni ritengono che egli abbia considerato il numero degli uccelli che gli avevano presagito il potere. A me non dispiace l’opinione di coloro che pensavano che anche questo tipo di guardie derivasse dai vicini Etruschi da cui fu ricavata anche la sella curule e la toga pretesta, e pensano che anche il numero dei littori venisse di là e che tale fosse presso gli Etruschi per il fatto che, dopo che i dodici popoli avevano eletto in comune il re ciascuno di essi gli assegna un littore. » (Liv. Hist. I, 8) "( cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sella_curule).
« Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunita in assemblea la massa che non avrebbe mai potuto unificarsi in un unico organismo popolare se non con leggi, Romolo dettò norme giuridiche. Dunque, stimando che esse sarebbero apparse inviolabili a un materiale umano ancora rozzo solo se egli stesso si fosse reso venerabile per mezzo di segni esteriori dell’autorità, si fece più maestoso con fasto dell’abbigliamento e particolarmente con la guardia dei dodici littori. Alcuni ritengono che egli abbia considerato il numero degli uccelli che gli avevano presagito il potere. A me non dispiace l’opinione di coloro che pensavano che anche questo tipo di guardie derivasse dai vicini Etruschi da cui fu ricavata anche la sella curule e la toga pretesta, e pensano che anche il numero dei littori venisse di là e che tale fosse presso gli Etruschi per il fatto che, dopo che i dodici popoli avevano eletto in comune il re ciascuno di essi gli assegna un littore. » (Liv. Hist. I, 8) "( cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sella_curule).
RICORDARE CHI ERA HENRY W. LONGFELLOW:
"Henry Wadsworth Longfellow (Portland, 27 febbraio 1807 - Cambridge, 24 marzo 1882) è stato uno scrittore e poeta statunitense, tra i primi letterati americani ad assurgere alla fama mondiale.
Longfellow fu il più famoso poeta della scena del New England nell’’800 e scrisse numerose opere tra cui Evangeline e Il faro.
Fu un acceso promotore dell’abolizione della schiavitù negli anni prima e durante la Guerra Civile Americana insieme ad altri intellettuali che gravitavano nell’orbita di Harvard e soprattutto insieme all’allora Governatore del Massachusetts John Andrew.
Intorno al 1862 insieme ai letterati James Russell Lowell, Oliver W. Holmes e George Washington Greene diede vita al cosiddetto "Circolo Dante", atto a promuovere la conoscenza della Divina Commedia di Dante Alighieri negli Stati Uniti. Insieme ai suoi colleghi del circolo, Longfellow ne portò a termine la prima traduzione statunitense in inglese nel 1867.
Da allora il successo dell’opera di Dante in America fu costante ed in seguito il Circolo diventò la "Dante Society", una delle più famose associazioni di dantisti nel mondo [...]" (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Wadsworth_Longfellow).
LE PAROLE ("DVX-LVX, REX-LEX") SCRITTE SULLA "CROCE" INSCRITTA NEL "CERCHIO" SULLA TOMBA DI LONGFELLOW sicuramente - via Dante Alighieri (e probabilmente anche via Dante Gabriele Rossetti) - si ricollegano al filo della tradizione religiosa cristiana, e sono riferite a CRISTO, concepito come LUCE, LEGGE, RE, DUCE.
E, ANCORA, per capire come e perché siano apparse le scritte "REX" e "DVX" sulla parete del SEDILE di Nardò (Lecce), bisogna RICORDARE chi era MARGHERITA GRASSINI SARFATTI e rileggere il suo "DVX" (sul tema, mi sia consento, cfr IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE).
E, INFINE, PER CAPIRE MEGLIO, E ALLA LUCE DEL SOLE ("INVICTUS"), IL SENSO DELLE "QUATTRO PAROLE" (LVX, LEX, REX, DVX), LEGGERE E RILEGGERE E ANCORA RILEGGERE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ....
Federico La Sala
- (LAT.)
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI -- GLI EBREI D’ITALIA, IL RISORGIMENTO, E ARNALDO MOMIGLIANO (di A. Gramsci).8 settembre 2017, di Federico La Sala
FASCISMO E LEGGI PER LA DIFESA DELLA RAZZA (1938). De Felice, Mussolini, e la "percentuale" del 1932 ...
Risorgimento italiano: Ebraismo, Antisemitismo. Una nota di Gramsci: *
In una recensione («Nuova Italia» del 20 aprile 1933) del libro di Cecil Roth (Gli ebrei in Venezia, Trad. di Dante Lattes, Ed. Cremonese, Roma, 1933, pp. VII-446, L. 20) Arnaldo Momigliano fa alcune giuste osservazioni sull’ebraismo in Italia.
- «La storia degli Ebrei di Venezia, come la storia degli Ebrei di qualsiasi città italiana in genere, è essenzialmente appunto la storia della formazione della loro coscienza nazionale italiana. Né, si badi, questa formazione è posteriore alla formazione della coscienza nazionale italiana in genere, in modo che gli Ebrei si sarebbero venuti a inserire in una coscienza nazionale già precostituita. La formazione della coscienza nazionale italiana negli Ebrei è parallela alla formazione della coscienza nazionale nei Piemontesi o nei Napoletani o nei Siciliani: è un momento dello stesso processo e vale a caratterizzarlo. Come dal XVII al XIX secolo, a prescindere dalle tracce anteriori, i Piemontesi o i Napoletani si sono fatti italiani, così nel medesimo tempo gli Ebrei abitanti in Italia si sono fatti Italiani. Il che naturalmente non ha impedito che essi nella loro fondamentale italianità conservassero in misura maggiore o minore peculiarità ebraiche, come ai Piemontesi o ai Napoletani il diventare Italiani non ha impedito di conservare caratteristiche regionali».
Questa tesi, storicamente esatta nella sua essenza, è da confrontare con quella di un altro ebreo, Giacomo Lumbroso nel libro I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII, 1796-1800, Firenze, Le Monnier, 1932, in 8°, pp. VIII-228 (e in proposito vedi «Critica» del 20 marzo 1933, pp. 140 sgg.). Che nei moti popolari registrati dal Lumbroso ci fosse qualsiasi traccia di spirito nazionale è un’allegra trovata, anche se tali mori siano degni di studio e di interpretazione. In realtà essi furono popolari per modo di dire e solo per un aspetto molto secondario e meschino: il misoneismo e la passività conservatrice delle masse contadine arretrate e imbarbarite. Presero significato dalle forze consapevoli che li istigavano e li guidavano più o meno apertamente e queste forze erano apertamente reazionarie e antinazionali o anazionali. Solo recentemente i gesuiti hanno preso a sostenere la tesi dell’italianismo dei sanfedisti che solo «volevano unificare l’Italia a modo loro». [...]
In Italia non esiste antisemitismo proprio per le ragioni accennate dal Momigliano, che la coscienza nazionale si costituì e doveva costituirsi dal superamento di due forme culturali: il particolarismo municipale e il cosmopolitismo cattolico, che erano in stretta connessione fra loro e costituivano la forma italiana più caratteristica di residuo medioevale e feudale. Che il superamento del cosmopolitismo cattolico e in realtà quindi la nascita di uno spirito laico, non solo distinto ma in lotta col cattolicismo, dovesse negli ebrei avere come manifestazione una loro nazionalizzazione, un loro disebreizzarsi, pare chiaro e pacifico. Ecco perché può esser giusto ciò che scrive il Momigliano, che la formazione della coscienza nazionale italiana vale a caratterizzare l’intero processo di formazione della coscienza nazionale italiana, sia come dissoluzione del cosmopolitismo religioso che del particolarismo, perché negli ebrei il cosmopolitismo religioso diventa particolarismo nella cerchia degli Stati nazionali.
* A. Gramsci, Quaderni del carcere, Quaderno 15 (II) § (41). Cfr. anche Arnaldo Momigliano, Pagine ebraiche, Einaudi, Torino, 1987, pp. 241-242.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
FASCISMO E LEGGI PER LA DIFESA DELLA RAZZA (1938). De Felice, Mussolini, e la "percentuale" del 1932.
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO. -
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI -- Il Risorgimento italiano, Theodor Herzl e il Sionismo (di Lea Luzzati).25 agosto 2017, di Federico La Sala
EBRAISMO E DEMOCRAZIA. PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO... *
Theodor Herzl, il sogno diventato start-up
Nell’agosto 1897 si riunì a Basilea il Primo Congresso Sionista. Ispirandosi al Risorgimento italiano, il suo animatore guardava alle radici bibliche per forgiare l’ebreo nuovo, non più disposto a subire violenze e disprezzo
di Lea Luzzati (La Stampa, 25.08.2017)
«Se lo volete non sarà un sogno» è la frase che ne disegna la storia: una proposizione ipotetica che in principio aveva tutti i connotati dell’utopia assurda, ma che a poco a poco prese corpo, sostanza, realtà. «Se lo volete non sarà un sogno», disse Theodor Herzl in occasione del Primo Congresso Sionista, 120 anni fa, nella quieta Basilea, e lo ripeté sino alla fine della sua breve vita.
Nato a Budapest in una famiglia ebraica assimilata e profondamente acculturata, il fondatore del movimento risorgimentale ebraico si ritrovò giovane corrispondente per la Neue Freie Presse a Parigi, nella tempesta dell’infame processo Dreyfus che, se condannò il povero e fedele ufficiale francese all’esilio, regalò invece a lui una disincantata folgorazione: l’antisemitismo è inguaribile e si radica anche nelle società evolute, a dispetto dei Lumi e dei diritti civili quasi universalmente riconosciuti. Per gli ebrei l’unica soluzione di sopravvivenza e dignità è la conquista di una «completezza» nazionale e di una autonomia politica. Il ritorno a una patria. I figli d’Israele dovevano diventare «un popolo come gli altri», riavere tutto ciò che definisce una nazione: terra, bandiera, autodeterminazione.
A questo obiettivo Herzl dedicò il resto della propria vita - ma morì a soli 44 anni, nel 1904, senza fare in tempo a vedere nella Shoah la più drammatica conferma del suo pessimismo e nella nascita dello Stato d’Israele, dove dal 1950 riposano le sue spoglie, la realizzazione di quello che non rimase un sogno.
Tempi di pogrom
Cento e venti anni fa a Basilea il movimento sionista si riunì con l’obiettivo di dare una autonomia politica e civile al popolo ebraico disperso ai quattro angoli del mondo e vittima in quegli anni di sfoghi di violenza e persecuzioni: i pogrom che imperversavano nell’impero zarista mietevano vittime e costringevano alla fuga migliaia di anime.
Come bene esempla il titolo del libro di Herzl che teorizza seppure in forma narrativa la nascita del futuro Stato - Altneuland, «nuova vecchia terra» - il sionismo guardava al passato remoto, tornava alle radici bibliche della storia, a quando gli israeliti avevano un regno sulla propria terra. Ma per contro aveva come obiettivo quello di forgiare un ebreo nuovo, non più disposto a chinare la testa passivamente davanti alla catena di avversità, odio e disprezzo che avevano segnato gli ultimi duemila anni. Un ebreo nuovo capace di riprendere - in primo luogo fisicamente con il lavoro manuale - il contatto con la terra.
E in fondo tutta la storia del sionismo, che prende il nome da una collina di Gerusalemme, Sion, evocata con nostalgia dagli esuli della prima Diaspora deportati in Babilonia, è un cammino sul filo in equilibrio tra passato e futuro.
Da Theodor Herzl, che aveva nel Risorgimento italiano il suo primo e fondamentale modello politico, a David Ben Gurion, padre della patria che sempre propugnò il cammino verso Sud, verso il deserto del Negev dove secondo lui stavano il futuro del popolo e le risorse materiali e mentali per edificare la storia, tutta l’epopea del sionismo è segnata sia da un richiamo alle radici lontane sia dalla ricerca di un futuro libero, aperto.
Il Primo Congresso Sionista, tenutosi a Basilea dal 29 al 31 agosto 1897, avvia un processo interno ebraico: si creano organizzazioni, si definiscono i lineamenti di una educazione alla rinascita nazionale. Theodor Herzl e gli altri esponenti del movimento si dedicano a una fervida attività politica e diplomatica in cerca di un focolare nazionale per i figli d’Israele. Il sionismo è dunque un insieme di iniziative politiche, culturali ed economiche volte alla rinascita nazionale per il popolo ebraico. È anche e forse soprattutto un insieme di ideali intrinseco all’ebraismo, cui la modernità può dar voce. Nulla di artificiale, anzi: è l’autentico spirito dell’ebraismo che si confronta con la storia.
Lo Stato d’Israele
Cinquant’anni esatti dopo il Primo Congresso Sionista, il 29 novembre 1947, le Nazioni Unite approvano a maggioranza una risoluzione che prevede la creazione di due Stati «palestinesi»: uno ebraico e uno arabo. Nella Palestina sotto mandato britannico c’era infatti da generazioni una società ebraica strutturata, attiva, consapevole: uno Stato di fatto, dotato di istituzioni politiche, sistema educativo, servizi.
Nel maggio del 1948 nasce lo Stato d’Israele. Da allora esso vive il conflitto. Ma ancora una volta, al di là delle questione politiche e fermo restando il diritto dei palestinesi arabi a un’autonomia nazionale, la storia ebraica si è caricata del solito «sovratesto» distorto per colpa del quale «sionismo» è diventato una parolaccia, la definizione di un’ideologia del male, sinonimo di razzismo, come è detto nella risoluzione Onu 3379 del novembre 1975.
Un ideale ancora vivo
Se è vero che dal 1897 in poi, e anche prima, il movimento sionista ha conosciuto diverse espressioni, lo è altrettanto l’evidenza che col razzismo non c’entra per nulla. Da Martin Buber a Zeev Jabotinsky, da Rav Kook a Abraham Yehoshua - e con loro tantissimi intellettuali e uomini di politica - in tutte queste voci il sionismo si configura come un ideale di «normalizzazione» ebraica capace di conservare quel portato umanistico che si trova espresso nella Bibbia e in tutta la tradizione d’Israele.
Lo Stato ebraico esiste da quasi 70 anni, è una realtà costruita su un ideale. Eppure, malgrado abbia raggiunto il suo scopo, l’ideale sionista è ancora vivo. Non solo nel guidare le recenti immigrazioni di ebrei (dalla Russia, dalla Francia, dall’India), non solo nella memoria di quei fondatori sparsi per il Paese (come ad esempio il nucleo italiano di molti kibbutzim storici, da Netzer Sereni a Ruchama), ma anche nel suo essere la più autentica declinazione dell’ebraismo contemporaneo. Nel quotidiano confronto, non sempre liscio ma sempre costruttivo, tra Diaspora e realtà nazionale israeliana. Nel paradosso che fa oggi di questo paese dalle radici ancestrali in cui si parla la stessa lingua dei Profeti e dei Patriarchi la «start-up nation» proiettata verso le più avveniristiche tecnologie. Nel suo essere parte dello scacchiere politico e culturale del presente, con le sue energie intellettuali, con la sua spinta di vita.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
No al SUPERMAN...ismo israeliano
 Il sionismo non è l’ebraismo!!! Lettera a ISRAELE - di Moni Ovadia
Il sionismo non è l’ebraismo!!! Lettera a ISRAELE - di Moni OvadiaFREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO -- Ricerca Anpi. Sulla Rete le pagine «nere» conquistano un milione di nostalgici del Duce.22 agosto 2017, di Federico La Sala
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO...
La ricerca.
Sulla Rete le pagine «nere» conquistano un milione di nostalgici del Duce
Facebook ospita 2.700 profili di propaganda fascista: almeno 300 profili inneggianti Forza Nuova e Casa Pound. La ricerca dell’Anpi
Souvenir del fascismo (da internet)
di Gigio Rancilio *
Perché Facebook non rimuove le pagine social che, in contrasto con la legge Scelba, fanno apologia del fascismo? Leggendo la policy internazionale del social network più grande del mondo non si trova traccia di alcun divieto in questo senso. La scusa di Facebook è che «i nostri standard devono valere in ogni Paese» mentre - aggiungiamo noi - l’apologia del fascismo è vietata solo in Italia (come in Germania quella del nazismo). Quindi non si può proprio fare niente? La stessa Facebook Italia consiglia di segnalare contenuti e pagine illegali alla Polizia Postale o all’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale). «Dopo una loro verifica, Fb avvierà la rimozione di tali contenuti e pagine». A parole è tutto perfetto (o quasi). Ma alla prova dei fatti sembra che le cose vadano diversamente. Lo dimostra il fatto che molte delle pagine Fb che fanno apologia del fascismo sono già state segnalate all’Unar a febbraio: in cinque mesi avrebbero già dovuto essere sottoposte al centro di controllo di Facebook e rimosse dal social. Ma sono ancora lì.
Che i social network premino le posizioni estreme (in tutti i campi) è un dato di fatto. Ma la denuncia dell’Anpi fa comunque effetto: «Su Facebook ci sono circa 2.700 pagine in italiano di propaganda fascista, 300 di queste apertamente apologetiche». Possibile? Iniziamo la nostra ricerca digitando su Facebook la parola ’fascisti’. Il primo risultato che appare rimanda alla pagina ’I giovani fascisti italiani’, seguita da quasi 93mila persone. Entriamo. I post scritti sono pochi. Vanno invece alla grande le foto di Mussolini, i video dei suoi discorsi e le cartoline militanti da condividere sui social. Gli stessi contenuti si trovano anche su pagine ’amiche’ come ’Essere fascista non è reato’, che ha 54mila fan, ’Fascisti italiani, che ha 32mila fan, e ’Repubblica Sociale Italiana’, ferma a poco più di 1.500 mi piace.
Siccome non si vive di sola politica militante, ogni giorno su queste pagine appaiono anche foto che pubblicizzano ’prodotti fascisti’: il portafoglio con l’effigie di Mussolini, i cuscini con la faccia del duce (ma non sarà irriverente sedervisi sopra?) e - molto apprezzato - un manganello nero («in legno massello», specificano i curatori della pagina) disponibile con la scritta (a scelta) ’Boia chi molla’, ’Me ne frego’, ’Credere obbedire combattere’, ’Molti nemici molto onore’. Ogni volta che qualcuno chiede il prezzo di uno degli oggetti, la risposta dei moderatori è sempre uguale: «Camerata, contattaci in privato«. Come se la vendita fosse segreta. Come se la vendita fosse destinata solo a pochi privilegiati. Un’autentica furbata. Che fa apparire ’militanti’ e ’segrete’ delle pagine di fatto promozionali legate al negozio Duxstore.it - con sede legale a Castel Campagnano, in provincia di Caserta - specializzato in gadget fascisti. Stesso repertorio di foto, cartoline, video e slogan si trova anche nella pagina Facebook ’I giovani fascisti italiani - destra italiana’, seguita da 27.198 persone.
Digitando su Facebook la parola ’Mussolini’ la prima pagina che appare è ’Benito Mussolini’, che piace a 144.449 persone. Ci sono post nostalgici ma anche contro i vaccini, l’Europa, il Governo, i giornali bugiardi e tutto il solito repertorio ’anti’. Sempre sul duce c’è la pagina ’Benito Mussolini eterna passione’ (26.350 fan). Sulla pagina ’Gioventù italiana del littorio’ (che piace a 15.149 persone) si trovano quasi esclusivamente foto e manifesti dell’epoca fascista.
Devono però avere qualche problema di repertorio visto che in un anno hanno ripetuto sei volte la foto di un quadro di Mussolini, uno scatto dove il duce fa il saluto romano e un manifesto fascista. ’Camerati uniti per l’Italia’ pubblica molti post di Forza Nuova. La pagina è seguita da 12.929 persone. Ma gli iscritti sono poco reattivi: il post più premiato degli ultimi mesi ha raccolto 12 ’like’. La pagina Facebook ’Camerati italiani’ ha 8.214 iscritti. Anche qui dietro la militanza c’è il business. L’indirizzo web ufficiale della pagina rimanda a un negozio online con sede a Limana (Belluno) che vende gadget marchiati ’Camerati italiani’: dalle classiche t-shirt (dai 20 ai 26 euro) alle infradito (18,99 euro).
Per capire la portata della presenza dei fascisti sui social, il quindicinale Patria indipendente dell’Associazione Nazionale Partigiani ha promosso un progetto web. Si trova all’indirizzo patriaindipendente.it/progetto-facebook/ Cliccandoci appare l’enorme galassia delle pagine social di estrema destra. L’impatto visivo è molto forte. Ma la navigabilità non è semplice e alla fine è difficile mettere ordine in una mole di dati visuali che mischia pagine legali e illegali. Grazie al progetto scopriamo però che le pagine social di estrema destra più seguite sono quelle di Forza Nuova (222.820 persone) e Casa Pound (214.885 fan). Che - va sottolineato - non violano alcuna legge, a differenza di molte altre citate qui. Il ’Centro documentazione Repubblica Sociale Italiana’ è seguito su Fb da 25mila persone. Mentre la pagina ’Xª Flottiglia MAS’ ha oltre 13mila seguaci. Accanto appare la pagina ’X flottiglia mas store’, dove sono pubblicizzati i gadget.
Basta andare sul sito collegato per trovare magliette, felpe, polo, cover per telefonini, distintivi, portachiavi e orologi ’dal licenziatario ufficiale della X Flottiglia Mas’, con sede a Taranto. Sul social più frequentato del mondo si possono creare anche gruppi, aperti (cioè visibili a tutti) o chiusi (per vedere i post o commentarli bisogna essere iscritti). Tra i gruppi chiusi spopola con oltre 12mila iscritti ’Fascisti del terzo millennio’. Seguito da ’Onore al duce’ che conta 8.979 membri e da ’Dux mea lux!’ con 8.772 membri. La palma per il nome più lungo va a ’Benito Mussolini, il Duce... un uomo che ha fatto grande l’Italia 1883-1945’ che conta 3.689 iscritti. Il gruppo ’Fascisti e fascismo’ si ferma invece a 2.285 adepti. L’elenco è sterminato. Tra i gruppi social più curiosi ci sono ’Fascisti Italiani non c’è più tempo dobbiamo ritornare’ (49 componenti) e ’Fascisti non per piacere ma per dovere’ (159 iscritti). Decisamente ’esclusivi’ sono i gruppi ’Per soli veri fascisti’ (8 iscritti) e ’I veri fascisti’ (4 componenti). Gli Artisti fascisti sono invece 43. Mentre i ’Golfisti fascisti’ (intesi come militanti fascisti possessori dell’auto Golf - sì, esistono anche loro) sono 13. Il più piccolo è il gruppo ’Fascismo è vita’ che ha un solo componente.
Alla ricerca delle parole ’nazismo’, ’nazisti’, ’SS’ e ’camicie nere’ Facebook non restituisce invece pagine apologetiche o degne di nota. Mentre digitando ’Adolf Hitler’ si trova solo il gruppo ’Adolf Hitler capo del mio governo’ che ha soltanto 10 membri. Il motivo è presto detto: Facebook ha rimosso e/o oscurato le pagine e i gruppi che inneggiavano al nazismo. Aspettate però a gioire. Il social l’ha fatto solo dopo avere ricevuto moltissime proteste. E c’è chi ha imparato ad aggirare i divieti. Sulla pagina dell’Associazione culturale Thule Italia, seguita da 10.000 persone, quasi ogni giorno appare la foto di un soldato nazista ma senza alcun testo di accompagnamento. Così mentre i sostenitori mandano cuori e scrivono ’bellissimo’, l’associazione è formalmente salva. Sta facendo ’ricostruzione storica’ non apologia. Anche per questo è difficile dire quanto sia vasta la presenza nazi-fascista sui social. Ma basta sommare i nostalgici iscritti ai gruppi o alle pagine nominate in questo articolo per superare il milione di persone. E abbiamo solo scalfito la superficie. Per fermare l’apologia fascista sui social, Emanuele Fiano ha presentato una proposta di legge. Ma per ora è ancora tutto in alto mare.
* Avvenire, domenica 20 agosto 2017 (ripresa parziale - senza note e immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
- FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE. -- Il Duce e le donne: storia di un’ossessione (di Mario Avagliano).11 agosto 2017, di Federico La Sala
STORIA DEL FASCISMO. LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.... *
Il Duce e le donne: storia di un’ossessione
di Mario Avagliano (Nuovo Monitore Napoletano, Giovedì, 10 Agosto 2017)
Benito Mussolini non era bello, non era snello e neppure alto. Non aveva un portamento elegante e non presentava una sola di quelle particolari caratteristiche che normalmente affascinano il pubblico. Eppure “una gran massa di italiani visse in una sorta di simbiosi psicologica col suo corpo, desiderandolo nella componente femminile, sognando di essere come lui in quella maschile”.
Il sesso come simbolo del potere politico. Anche così il duce ha incarnato il mito della potenza nell’Italia fascista. È la tesi di fondo del bel saggio Dux. Una biografia sessuale di Mussolini [2012], scritto con competenza storica e sapienza narrativa da Roberto Olla, responsabile di Tg1 Storia, autore della fortunata serie di Combat Film.
In questo libro, uscito in Inghilterra prima che in Italia col titolo Il Duce and his women, si sostiene che il “mussolinismo” (che è cosa diversa dal fascismo) è stato costruito e si è fondato sul mito del suo corpo da contadino padano, con la mascella quadrata e il petto villoso: dalle schegge conficcate nelle sue carni durante la prima guerra mondiale ai muscoli esibiti col piccone in mano durante le demolizioni per aprire a Roma via della Conciliazione.
Alle radici di questo mito c’è il rapporto di Mussolini con le donne. Quattrocento sarebbero, secondo una stima attendibile, quelle “amate” nel corso della sua vita dal duce, che mise al mondo figli legittimi e illegittimi, intrattenendo molteplici amanti, brune e bionde, magre e procaci, di varie nazionalità: “Sono giovani e belle, le prendo, poi non ricordo più né il loro nome né come sono fatte”.
Il racconto di Olla, tutt’altro che pruriginoso anche se non privo di particolari piccanti e virulenti (“le fonti - si scusa l’autore - non permettono di rispettare questa esigenza di eleganza”), parte dall’apprendistato, invero alquanto rude, del giovane Benito nella Romagna contadina del tardo Novecento, da parte di tale Virginia B., come raccontò lo stesso futuro duce: “la presi lungo le scale, la gettai in un angolo dietro a una porta e la feci mia. Si rialzò piangente e avvilita”.
All’inizio Mussolini scelse donne intelligenti e moderne. Due su tutte: la rivoluzionaria ucraina Angelica Balabanoff, che affinò, politicamente e sessualmente, l’imberbe e rozzo Mussolini, e l’ebrea Margherita Sarfatti, coltissima e abile, che con il suo libro Dux [1926] esportò il suo Mito a livello mondiale.
Unitosi in matrimonio religioso con Rachele Guidi nel 1925, il duce continuò imperterrito nella sua collezione di donne, consumando gli amplessi davanti alle carte della sua scrivania a Palazzo Venezia, portandole al mare, in barca e in montagna.
Un “furor eroticus” che non ebbe fine neppure quando Mussolini “ufficializzò” il suo rapporto con Claretta Petacci, la donna che lo seguì fino al tragico epilogo di Piazzale Loreto. Claretta sostenne il suo Ben nella bufera della seconda guerra mondiale e di fronte ai segni del declino fisico, gli procurò il miglior afrodisiaco dell’epoca, l’antesignano del moderno Viagra: l’Hormovin, prodotto in Germania.
La “biografia sessuale di Mussolini” è un ritratto impietoso dal quale emerge un uomo politico ch’era preda, come si direbbe oggi, di una forma compulsiva di dipendenza dal sesso, e che porta alla luce ipocrisie, volgarità, aspetti caratteriali e della personalità del Dux, demolendo, se ce n’era ancora bisogno, anche dal punto di vista morale la vulgata buonista del “brav’uomo”.
Mario Avagliano
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
MUSSOLINI, IDA DALSER, E BENITO ALBINO MUSSOLINI: UNA TRAGEDIA ITALIANA.
STORIA E STORIOGRAfIA DEL FASCISMO, "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (A. GRAMSCI, 1924). IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.
Storiografia in crisi d’identità ...
 LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.Federico La Sala
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ E LA BIOLOGIA. Nature riscrive la storia dell’Egeo usando i dati del Dna. I greci sono davvero figli di Agamennone e Ulisse4 agosto 2017, di Federico La Sala
STORIA E STORIOGRAFIA: IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ E LA BIOLOGIA. LA PUNTA DI UN ICEBERG. ...*
I greci sono davvero figli di Agamennone e Ulisse: lo dice il dna
Nature riscrive la storia dell’Egeo usando i dati del Dna dei tempi di Ulisse e di Minosse. Ma fra gli studiosi è dibattito: il genoma non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto scritto da Omero ed Erodoto
di ELENA DUSI *
L’analisi del Dna permette di ricostruire le migrazioni delle popolazioni antiche. Uno studio pubblicato su Nature oggi entra nei dettagli della storia greca, tracciando l’albero genealogico degli abitanti dell’Egeo dall’età del bronzo a quella odierna. Il genoma di 19 scheletri antichi dissepolti a Creta, nella penisola ellenica o nella Turchia dell’ovest è stato messo a confronto con quello di oltre 2mila individui di oggi. Il risultato - non sorprendente - è che i greci moderni sono figli di Agamennone: buona parte del loro Dna coincide con quello dei micenei, mentre più ridotto è il grado di parentela con i minoici. Sia il Dna di Minosse che quello di Ulisse derivano per tre quarti dal genoma dei primi agricoltori dell’Anatolia occidentale. Da lì, gli antichi uomini dell’età del bronzo (epoca che va dal 3.300 al 1.200 a.C.), avrebbero occupato l’Egeo e Creta. I micenei, in più, mostrano un legame più recente con i popoli delle steppe del Caucaso.
Ricostruzioni come queste sono preziose per dipanare la storia, ad esempio, di alcuni popoli primitivi. Ma di fronte a una civiltà raccontata da Erodoto e Omero, cosa hanno da dire le sequenze di geni sfornate dai computer ultrapotenti del Max Planck Institute, dell’università di Washington o da quella di Harvard? L’articolo di Nature ha aperto un dibattito fra gli esperti su quale possa essere il ruolo della genetica nello studio della storia.
"I risultati confermano quel che si sapeva già” è l’esordio (diplomatico) di Lorenzo Perilli, che insegna filologia classica all’università di Roma Tor Vergata. "Ribadiscono che il miracolo greco non esiste. L’immagine di un popolo che risplende nel suo isolamento, nata fra il ‘700 e l’800, non ha nulla a che vedere con la realtà. Minoici e micenei avevano, come è naturale, legami non solo commerciali, ma culturali e di parentela con le popolazioni vicine". L’origine di una civiltà così raffinata come quella minoica, nel terzo e secondo millennio avanti Cristo, resta avvolta nel mistero anche dopo l’analisi genetica. "Occorrerebbero fonti scritte, molte più di quelle che abbiamo. E purtroppo il Dna non potrà dirci molto a questo proposito" dice Perilli.
Il viaggio degli agricoltori anatolici verso est avvenne - conferma Nature - nel Neolitico. Ovvero diversi millenni prima della fioritura delle civiltà minoica e micenea. L’idea di risalire alle radici di queste migrazioni usando il Dna è venuta a George Stamatoyannopoulos, genetista dell’università di Washington con la passione per la storia. "Da più di un secolo circolano idee controverse sulle origini dei greci" spiega. "C’è l’ipotesi dell’Atena Nera, secondo cui la civiltà classica avrebbe origini afroasiatiche. E c’è l’ipotesi dello storico tedesco Fallmerayer, che nel 19esimo secolo scrisse che i discendenti degli antichi greci si erano estinti nel medioevo". Altre idee sostenevano che i micenei fossero una popolazione straniera arrivata forse da nord, estranea all’ambiente dell’Egeo. E che i minoici avessero un livello di cultura troppo elevato (inclusa una scrittura mai decifrata) per essersi sviluppato fra le rive di Creta. Forse - si arrivò a suggerire - erano i figli di una civiltà molto avanzata che decise di abbandonare la madrepatria.
Queste teorie vengono squalificate dal Dna. "Ma nessuno ci credeva ormai più" chiosa Perilli. "La realtà - spiega Giovanni Destro Bisol, antropologo della Sapienza di Roma - è che questi grandi progetti di genomica stanno soppiantando le ricerche sul campo". Ormai i grossi laboratori come quelli coinvolti nello studio di Nature hanno apparecchiature capaci di sequenziare un intero genoma umano in poche ore. "Hanno una potenza di fuoco enorme, non c’è che dire" prosegue Destro Bisol. "I loro risultati sono estremamente precisi. Ma si è creata una sorta di oligopolio, con pochi grandi laboratori che dominano il campo. I gruppi di ricerca che non hanno grandi risorse vengono tagliati fuori. Questo non è necessariamente un bene nella scienza".
Se Mario Capasso dell’università del Salento, presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, giudica "comunque utili gli apporti della genetica, anche se in questo caso non aggiungono molto a quel che sapevamo già", più perplesso di dichiara Luciano Canfora, filologo classico dell’università di Bari e saggista: "Sono scettico, ma non sono Don Ferrante, non mi intendo dell’argomento e mi auguro fervidamente di essere contraddetto. Facciamo però l’esempio della peste di Atene. Fu narrata da uno dei più grandi storici, contagiato lui stesso, eppure ancora oggi gli scienziati dibattono su quale fosse esattamente la natura dell’epidemia. Quanto ai resti del Dna, che conservazione possono avere dopo tanti millenni?".
Il più critico nei confronti della genetica applicata al Minotauro è sicuramente Mario Torelli, archeologo e accademico dei Lincei. "Una volta, durante un convegno sulla Magna Grecia, arrivai quasi alle mani con un famoso genetista, Luigi Luca Cavalli Sforza" ammette. "Nel Mediterraneo, in epoca paleolitica, ci sono stati spostamenti enormi di popolazioni. E’ successo di tutto, e penso che le informazioni che ci arrivano dalla genetica siano irrilevanti. La storia è un’altra cosa”.
Non aggiungerà nulla di nuovo, ma il Dna degli antichi greci aiuta a fare ordine in un quadro - quello della storia dell’Egeo - dove teorie e ipotesi non sempre scientifiche si sono sovrapposte per secoli. "Le origini della civiltà micenea e greca sono state collegate fin dall’800 alla diffusione dei popoli indoeuropei". Dove per indoeuropei possiamo leggere anche ariani.
"Soprattutto in passato, il concetto è stato molto dibattuto” spiega ad esempio Marco Pacciarelli, che insegna preistoria e protostoria all’università di Napoli Federico II. Una delle tesi suggerite dagli scienziati di Nature è che la piccola differenza fra il genoma dei micenei rispetto a quello dei minoici nasca da una migrazione dall’est dell’Europa. “A parere degli autori questo confermerebbe l’ipotesi, avanzata in passato ma accolta all’inizio con scetticismo, che la lingua indoeuropea parlata dai micenei fosse arrivata in Grecia da qui" spiega Pacciarelli. "Secondo questa teoria, che risale a Marija Gimbutas, un gruppo di pastori e guerrieri delle steppe, sia pur minoritario, sarebbe riuscito a imporre il suo idioma. Della lingua dei minoici, infatti, si sa poco. Ma la maggior parte degli studiosi ritiene che non fosse indoeuropea".
E che gli antichi greci non fossero ariani biondi e con gli occhi azzurri è confermato anche da Nature, che li descrive scuri di occhi e di capelli, con la pelle chiara. Come oggi. E come in fondo li ritraeva l’arte dell’epoca.
*
Sul tema, si cfr.:
la recensione del lavoro di Johann Chapoutot, "Il nazismo e l’antichità", nello "Speciale/Terzo Reich" (Alfabeta-2, 27 luglio 2017): Nazisti antiquari, non filologi di Roberto Danese, con due mie note.
Federico La Sala
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ E LA BIOLOGIA - I GRECI E LA "GLOBALIZZAZIONE" ELLENISTICA: LA LEZIONE STORIOGRAFICA DI ARNALDO MOMIGLIANO.6 agosto 2017, di Federico La Sala
I GRECI, LA "GLOBALIZZAZIONE" ELLENISTICA, E LA SAGGEZZA STRANIERA: LA LEZIONE DI ARNALDO MOMIGLIANO...
- Arnaldo Momigliano, Pagine ebraiche, Con un’intervista inedita ad Arnaldo Momigliano, A cura di Silvia Berti, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2016. *
MOMIGLIANO
di Davide Bidussa *
Il ritorno in libreria, dopo trenta’anni di Pagine ebraiche (ora per le Edizioni di Storia e Letteratura, nel 1987 il volume era stato edito da Einaudi) la raccolta degli scritti di Arnaldo Momigliano, magistralmente “creata” (più che redazionalmente curata) da Silvia Berti, per certi aspetti è di nuovo un evento (come trenta anni fa); per altri, ha la caratteristica di un contro evento. Sono più per la seconda ipotesi, perché il modello storiografico che dà significato alla ricerca di Momigliano, corrisponde a un senso storico che oggi mi sembra latitare o procedere con circospezione.
Prima di tutto il libro.
Pagine ebraiche è la raccolta di saggi o anche di recensioni che hanno per tema la storia degli ebrei e il modo di discuterne o di scavarci intorno. Nel caso si Momigliano significa piccole “perle” - per esempio la recensione a Cecil Roth, Gli ebrei in Venezia, testo che attrae l’attenzione di Antonio Gramsci che ne scrive nei suoi Quaderni del carcere e qui riproposti a pp. 163-167. Per Momigliano si può ripetere ciò Scholem scriveva di Benjamin - come ricorda Silvia Berti: anche nell’accenno marginale, apparentemente eccentrico s’intravede un tesoro di informazioni, ma anche di visioni. “Nel minimo si rivela il massimo”.
Elemento che corrisponde a un metodo e che consiste nel guardare alle culture come macchine, come costruzione nel tempo e soprattutto come dialogo con altre culture con cui ci si misura, ma soprattutto da cui si assorbe, si riformula.
L’idea di partenza è che nessuna cultura è un mondo a sé e dunque la storia della propria cultura non è mai la storia dello sviluppo naturale, del proprio codice interno.
Un tema che nella ricerca appassionata di Momigliano è costituito dalle ricerche dedicate al tema dell’ellenismo e che significativamente raccoglie e propone in un libro dal titolo provocatorio Saggezza straniera (che Einaudi pubblica nel 1980 e poi mai più riedito). Testo dedicato al rapporto tra l’ellenismo e le altre culture antiche: ovvero di come la Grecia e la sua espansione culturale (non disgiunta da quella politico-militare) fosse recepita dalle altre culture dell’area mediterranea; ma anche il problema contrario: come la Grecia recepisse le altre. Una storia di fraintendimenti, idealizzazioni, osmosi reciproche, contrasti e fascinazioni, tipiche di quella prima grande “globalizzazione” europeo-asiatica che fu l’ellenismo.
Proviamo a uscire da quella lunga congiuntura storica.
Dice niente a noi così immersi nello “scontro di civiltà”o convinti dell’ “autonomia” - meglio del’autosufficienza - di ogni singola cultura identitaria?
E’ l’identità la riproduzione di un solo codice culturale, quello della propria appartenenza, codice impermeabile, “senza porte né finestre” e quand’anche capace di assorbire servendosi solo dei propri strumenti interni?
Non è solo un problema di ibridazione di codici culturali, ma anche di rilevanza di metodi di analisi e dunque di modi di leggere e studiare i testi.
Proviamo a riprendere in mano un testo dal titolo Studi biblici e studi classici (scritto originariamente nel 1980). E’ il testo che apre Pagine ebraiche. Otto pagine in tutto che valgono il libro.
A un certo punto scrive Momigliano: “io non ho nulla da obiettare, in linea di principio, all’attuale moltiplicazione di metodi d’analisi retorica di testi storici. Si può fare tutta l’analisi retorica che si ritiene necessaria, purché essa porti al’accertamento della verità - o all’ammissione che la verità, in un dato caso, è purtroppo fuori portata. Ma dev’essre chiaro una volta per tutte che I Giudici e Gli Atti degli Apostoli, Erodoto e Tacito sono testi storici e devono essere esaminati allo scopo di recuperare le verità del passato”.
Si può dire meglio? Forse. In ogni caso vale ripeterlo.
*
David Bidussa: Arnaldo Momigliano, "Pagine Ebraiche", Edizioni di Storia e Letteratura. 2016.
-
> I GRECI E LA "GLOBALIZZAZIONE" ELLENISTICA: LA LEZIONE STORIOGRAFICA DI ARNALDO MOMIGLIANO -- L’antica Grecia era multiculturale (di Eva Cantarella).28 agosto 2018, di Federico La Sala
L’antica Grecia era multiculturale. Una civiltà sbocciata da tanti semi
 La contrapposizione tra l’Occidente e l’Oriente un tempo non esisteva affatto
La contrapposizione tra l’Occidente e l’Oriente un tempo non esisteva affatto
 Sono evidenti le analogie tra i miti ellenici e le tradizioni di altri popoli
Sono evidenti le analogie tra i miti ellenici e le tradizioni di altri popoli
 Intensi rapporti di scambio hanno sempre caratterizzato il Mediterraneo
Intensi rapporti di scambio hanno sempre caratterizzato il Mediterraneodi Eva Cantarella (Corriere della Sera, 28.08.2018)
Conoscere il passato è sempre importante. Purtroppo, anche a causa di una formazione scolastica che lascia ben poco (e sempre meno) spazio alle materie storiche, la conoscenza delle popolazioni antiche è spesso scarsa. Qualunque occasione di approfondirla è dunque importante e benemerita. Ma, ciò premesso, quando la storia che possiamo approfondire è quella della Grecia classica, il discorso acquista un valore ulteriore: cosa questa - è bene dirlo subito - che nulla ha a che vedere con la pretesa e per tanto tempo asserita superiorità della Grecia sulle altre culture antiche.
Il diverso valore dipende dal fatto che la cultura che i Greci ci hanno lasciato è stata ed è tuttora alla base di quella occidentale, nella quale viviamo. Il che non significa, peraltro, che alla base della nostra cultura stia solamente la Grecia. Oggi, fortunatamente, non si parla più del cosiddetto «miracolo greco», vale a dire il presunto fiorire quasi dal nulla, nella Grecia nel V secolo a.C., della filosofia, del teatro, dell’arte, della scienza e dei concetti di libertà e democrazia.
Oggi sappiamo che dietro a quel presunto miracolo stavano secoli di scambi culturali con le culture orientali, a confermare i quali è intervenuta, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, la decifrazione delle scritture cuneiformi, che ha reso possibile, tra l’altro, il confronto dei miti teogonici orientali con quelli greci. Ed eccone un esempio: grazie alla Teogonia di Esiodo, siamo a conoscenza, sin dai tempi della scuola, della storia di Urano, il primo re degli dèi greci, evirato e detronizzato da suo figlio Crono. Ebbene: nella Teogonia orientale del popolo mesopotamico degli Hurriti (tradotta in inglese come Kingship in Heaven, in italiano Regalità celeste), il re degli dèi Anu viene detronizzato ed evirato da suo figlio Kumarbi, che prende così il suo posto (così come Crono prende quello di Urano).
Difficile pensare a una coincidenza. Anche se Greci e Hurriti erano separati dall’intera Anatolia e dalla Mesopotamia (e quindi probabilmente non vennero mai a diretto contatto), la religione degli Hurriti venne assimilata dagli Ittiti, che abitavano nell’Anatolia centrale, e in quella occidentale dai Luvii. E questi ultimi ebbero certamente contatti culturali con il mondo greco miceneo, che precedette la civiltà delle poleis.
All’interno degli intensi rapporti commerciali e intellettuali esistenti tra il continente asiatico, quello africano e la parte orientale di quello che oggi chiamiamo europeo, i miti viaggiavano insieme ai marinai e alle mercanzie, mescolandosi e fondendosi in un mondo di cui era parte integrante il territorio che sarebbe diventato greco.
E veniamo a un altro esempio: nei secoli VII-VI a.C. nella penisola anatolica, ove erano stanziate le colonie greche, esisteva una cultura comune. I Greci, avendo appreso l’alfabeto dai Fenici, lo avevano insegnato ai Frigi, e avevano adottato la moneta inventata in Lidia. Senza nulla togliere ai nostri infiniti debiti verso i Greci, come non riconoscere che questi avevano a loro volta (e noi con loro) dei debiti verso le popolazioni orientali, sia indoeuropee sia semite?
Non è poco, dunque, la necessità che oggi si pone a chi si avvicina al mondo antico, di riconoscere un modello multiculturale che spieghi la nascita e lo sviluppo della civiltà greca nel contesto di quelle che fiorivano sulle rive del Mediterraneo.
I problemi del rapporto tra le culture europee e quelle che si affacciano sulle coste mediterranee dell’Asia Minore e dell’Africa sono difficili e complessi: se è vero infatti che il Mediterraneo può essere un concetto senza tempo e trans-storico, quel che ricade nella sua orbita non è tale. Le diverse zone che compongono quel mondo sono connesse tra loro in modo che dipende dalle attività di chi le abita. E poiché l’estensione geografica di queste connessioni varia, quel che può essere chiamato Mediterraneo cambia al punto che, a volte, il centro di quel mondo può essere fuori dell’Europa, in regioni dell’Asia e dell’Africa, marginalizzate dagli studi su questo mare. Come accadde, ad esempio, nella tarda età del Bronzo, quando la Mesopotamia era parte del Mediterraneo, e questo (quantomeno quello orientale), era l’Oriente. La contrapposizione Oriente-Occidente allora non esisteva.
E oggi? Qual è il Mediterraneo di oggi? Quali popoli ne fanno parte, o ne hanno fatto parte nei tempi di un colonialismo le cui responsabilità sembrano dimenticate? Di chi è - tra i tanti problemi - il dovere di farsi carico dei popoli che tentano di attraversarlo?
Alcuni decenni or sono Arnaldo Momigliano, il più grande storico antichista del secolo scorso, scrisse che «là dove tutta la civiltà è minacciata la conoscenza delle sue radici diventa essenziale». Mai come oggi io credo sia necessario ricordarlo, nel momento in cui quel mare che i nostri antenati Romani amavano chiamare mare nostrum, nostro (solo nostro) non è più da tempo, e non possiamo continuare a trattarlo come tale. Anche per questo serve approfondire la storia dell’antichità.
-
-
> IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO -- IL NAZISMO E L’ANTICHITÀ. Nazisti antiquari, non filologi (di Roberto M. Danese).28 luglio 2017, di Federico La Sala
IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ: LA PUNTA DI UN ICEBERG. Molti filologi, storici, archeologi e filosofi italiani e tedeschi si prestarono a favorire questa operazione ...*
Nazisti antiquari, non filologi
di Roberto M. Danese (Alfabeta-2, 27 luglio 1917)
- Johann Chapoutot, Il nazismo e l’Antichità, traduzione di Valeria Zini, Einaudi 2017, 523 pp., € 34
Nel 2008 esce in Francia il volume di Johann Chapoutot Le national-socialisme et l’Antiquité per le edizioni PUF. Nel 2012 il libro viene ripubblicato in edizione rivista con il titolo Le nazisme et l’Antiquité. È quest’ultima versione che esce ora in Italia come Il nazismo e l’Antichità. La differenza nel titolo non è secondaria. Se vogliamo trovare infatti un limite in quest’opera, è il tono generale un po’ troppo apertamente irridente nei confronti dei nazisti, a partire dalla scelta di sostituire nel titolo l’originario national-socialisme con il più polemico nazisme usato negli anni Venti dagli oppositori di Hitler.
Chapoutot è un brillante storico del Terzo Reich, che ha voluto riservare specifica attenzione a un fenomeno già piuttosto noto e indagato, ma comunque bisognoso di una nuova analisi scientifica. La necessità di un libro come questo, molto ben documentato e altrettanto ben costruito, è data non solo dall’interesse per un aspetto importante della politica culturale nazista, ma anche dall’impatto che uno studio del genere può avere sul nostro tempo.
Chapoutot dimostra con grande abilità che il nazismo non si è limitato a mistificare la cultura greca e romana, ma ha fatto di questa mistificazione una base fondamentale per la giustificazione ideologica del proprio agire politico e uno strumento formidabile di indottrinamento per il popolo tedesco. Insomma, ben più di quanto fece il fascismo con il folclorico riutilizzo della romanità. Hitler (e in qualche modo Himmler) prima crearono, grazie alla connivenza di studiosi tedeschi proni al dettato ideologico del Reich, una base scientifica che sancisse in modo indiscutibile l’origine germanica delle grandi civiltà greca e romana, quindi utilizzarono questa - per loro - incontrovertibile verità per rivendicare a sé tutti i migliori frutti di quelle antiche culture, a cominciare dalle città e dalle opere d’arte.
Non fu purtroppo solo un gioco propagandistico, ma una delle giustificazioni principali per l’espansionismo tedesco e per il progressivo irrobustirsi della politica razziale: proclamandosi eredi e insieme padri delle civiltà di Pericle e Augusto (entrambi, per loro, di sangue nordico), si arrogarono il diritto di proclamare inferiori, corrotte e corruttrici tutte quelle razze e quelle culture che non rientravano in questa netta linea genealogica, arruolando come campioni della razziologia autori quali Tirteo oppure Orazio.
Sulla reviviscenza di quegli antichi valori modellarono poi il loro inquietante programma ideologico: superiorità della razza nordica, eliminazione delle razze degenerate di origine negroide-semitica, una institutio nazionale che unisse cura del corpo e della mente, fede nell’irrazionalismo e nello Stato sociale contro il razionalismo di matrice umanistica, opposizione fra l’uomo “totale” ariano e l’uomo “scisso” di ascendenza cristiana.
Il libro di Chapoutot è molto dettagliato e complesso, ma di lettura agevole e avvincente, soprattutto chiaro nel mettere a fuoco gli obiettivi che il nazismo perseguiva nell’utilizzo dell’antichità classica. Sarebbe interessante analizzare molti aspetti di questo saggio, ma ne sceglierò solo un paio per cercare di mostrarne l’utilità e l’attualità. Nel 1933 Hitler volle una grande riforma scolastica che contribuisse a formare sin dall’infanzia il vero uomo tedesco.
Molti filologi, storici, archeologi e filosofi tedeschi si prestarono a favorire questa operazione, che voleva inculcare nei ragazzi i grandi ideali “nordici” della Grecia e di Roma, senza però farli riflettere troppo sui testi. Chapoutot documenta molto bene il dibattito che si accese in merito fra politica, classicisti e insegnanti di scuola: bisognava esaltare l’affinità di sangue e di cultura con gli antichi, ma bisognava anche diminuire le ore di greco e di latino nelle scuole, privilegiando gli studi storico-ideologici a discapito di quelli linguistico-grammaticali.
Se guardiamo al dibattito oggi in atto in Italia e in Europa sugli studi classici, non possiamo non accorgerci che si stanno usando simili argomentazioni per limitare il ruolo e lo studio delle lingue antiche, in vista del perseguimento di una cultura del fare più che del pensare.
Scrive Chapoutot sul programma educativo nazista: “Il sapere è legittimo solo nella misura in cui è immediatamente utile alla comunità del popolo e allo Stato”. E poi: “Il sapere specializzato consacrato dal regime è un sapere tecnico, pratico, immediatamente disponibile e utilizzabile, che dunque esclude ogni meditazione e quella libertà disinteressata che è propria del pensiero”.
Leggete gli attacchi contemporanei verso il liceo classico e verso lo studio del greco e del latino sui nostri giornali e sul web, considerate la filosofia di accreditamento degli Atenei da parte delle Agenzie per la Valutazione dell’Università e della Ricerca, quindi provate a fare un confronto con la cultura del fare esaltata dal regime nazista e messa alla base di ogni suo progetto formativo. Alla fine anche Heidegger aveva capito che tutto ciò era pericoloso, molto pericoloso...
Veniamo poi al marcato antifilologismo di tanti intellettuali al servizio del Führer. Chapoutot ci racconta che Hitler volle un aumento di attenzione verso l’antichità classica ma un’attenuazione del suo studio dal punto di vista veramente scientifico.
È qualcosa di simile a quello che sta succedendo oggi, in un quadro di crescente attenzione per l’antichità classica: nelle università ci sono sempre più archeologi che non sanno una parola di greco o di latino, modernisti che non riusciranno mai a leggere Stazio o Virgilio in latino, latinisti e grecisti che considerano un fastidio fare edizioni critiche e lavorare su testi ecdoticamente fondati. Non parliamo di quello che succede nei licei.
Lo studio delle grammatiche e della prassi filologica per l’antichità classica insegna a non dar mai per scontato nulla di fronte a un testo, insegna a interrogarsi sempre su ciò che una sequenza di parole o di immagini vuol veramente dire, insegna a capire le retoriche.
Questo per i nazisti non solo era inutile, ma anche dannoso: la verità sul significato dei testi antichi su cui si fondava la loro ideologia la diceva il regime stesso, quindi perché fornire allo studente i mezzi per cercare di comprendere da solo quei testi, rischiando di fargli nascere nella testa idee “sbagliate”?
La filologia è invece un bene prezioso perché, come ci hanno mostrato i primi grandi umanisti, raffina l’arte del dubbio: e anche oggi non dobbiamo dimenticare quanto si debba stare in guardia nei confronti di chi subdolamente bolla come inutile al progresso e perditempo colui che indugia nel lento esercizio della perplessità e della riflessione.
Il libro di Chapoutot non è dunque solo interessante, ma anche assai utile e la sua lettura dovrebbe essere consigliata a molti, se è vero che historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ, magistra vitæ, nuntia vetustatis.
*
SUL TEMA, SI CFR.:
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- UNA LEZIONE DI JOYCE (da "FINNEGANS WAKE")
- L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. -
> MARGHERITA SARFATTI E IL MITO DELLA ROMANITÀ - LA CHIESA E IL FASCISMO. Il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’22 luglio 2017, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito. UNA MEMORIA DI "VECCHIE" SOLLECITAZIONI. Il cardinale Martini, dalla “città della pace”, lo sollecita ancora!!!
Sulla tomba di KANT
"Legge Morale"
e
"Cielo stellato"
sulla tomba dell’EUROPA
Napoleone-Hegel-Heidegger?!
-
> MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO DELLA ROMANITÀ. -- "Il nazismo e l’Antichità". Il nazismo non ha passato? Prendiamoci quello di Sparta (di M. Panarari)9 luglio 2017, di Federico La Sala
- STORIA E STORIOGRAGIA DEL FASCISMO, "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (A. GRAMSCI, 1924).
 MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO DELLA ROMANITÀ.
MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO DELLA ROMANITÀ.
- FASCISMO E LEGGI PER LA DIFESA DELLA RAZZA (1938). - La «cultura» della purezza razziale (di Emilio Gentile).
Il nazismo non ha passato? Prendiamoci quello di Sparta
Così il Terzo Reich venerò (e falsificò) l’antichità classica per teorizzare la millenaria unità razziale di greci, romani, tedeschi
di Massimiliano Panarari (La Stampa, Tutto Libri, 08.07. 2017)
- Autore: Johann Chapoutot, Titolo: Il nazismo e l’Antichità, Editore: Einaudi
La fabbricazione del mostro fu accompagnata da un fittissimo dibattito. Un lavoro che vide saldarsi la febbrile attività di tutto un arcipelago intellettuale e la ricerca di pilastri ideologici da parte del nazismo, e che iscrisse nel dna sottoculturale del Terzo Reich un’autentica adorazione per la classicità.
Un’antichità greco-romana naturalmente immaginaria, reinventata all’insegna di una delle varie operazioni di falsificazione della storia compiute dal brodo di coltura e dalle uova del serpente da cui scaturì il nazionalsocialismo, e che venne istituzionalizzata in maniera massiccia dall’hitlerismo perché la relazione con il passato, il luogo temporale e simbolico delle «sacre» origini, risulta fondativa (come mostrano, per esempio, le politiche artistiche, totalmente impermeabili, a differenza di quelle dello stesso fascismo, rispetto a qualunque espressione della modernità).
Il retaggio del sangue, difatti, insieme al differenzialismo biologista, doveva servire a smantellare i messaggi e il progetto dell’Illuminismo. L’eredità aveva la funzione di contrastare le «pretese» della libertà e di forgiare l’uomo nuovo del regime, perseguito per via fisiologica attraverso l’eugenismo e il biologismo (e la «zootecnia di Stato»). Da cui l’invenzione della tradizione del nordicismo, nella quale vennero inserite in maniera coatta anche la Grecia e Roma, all’insegna della «favola bella» (implementata nel film horror dello sterminio del «diverso») di un indogermanesimo ariano che si era propagato per il globo, partorendo anche le civiltà della classicità.
Partendo non dall’India, bensì dalle terre della Germania del nord: ex septentrione lux, come sosteneva ossessivamente, rovesciando il paradigma hegeliano della civiltà che da Oriente si dirigeva a Occidente, il potentissimo ideologo del Terzo Reich Alfred Rosenberg, e come proclamava la dottrina nordicista di Hans Günther, il razziologo ufficiale della Nsdap (il partito nazionalsocialista dei lavoratori).
Il Führer disprezzava i germani li considerava troppo primitivi a confronto di Atene o Roma
Ne Il nazismo e l’Antichità, il giovane e rinomato storico della Sorbona Johann Chapoutot (membro dell’Institut universitaire de France e commentatore del quotidiano Libération) prosegue il suo lavoro di ricostruzione del gigantesco edificio ideologico che ha sorretto il nazismo.
In questo volume lo fa dall’angolazione di un funzionale immaginario classicista al quale contribuirono teorie immonde, dottrine strampalate (come quella, ricolma di occultismo, su Atlantide, peraltro presto emarginata) e una cieca e sanguinaria volontà di potenza, e in cui si giocava l’opportunismo delle carriere di gerarchi in competizione tra loro provenienti da una galassia di organizzazioni (come la Società Thule e le altre sette del nazismo magico).
Una vasta opera di genealogia quella compiuta dallo studioso, che restituisce un quadro estremamente articolato, dal momento che tutte le discipline della «governamentalità biopolitica» - dalla «scienza delle razze» a quella preistorica, dall’antropologia alla propaganda, dalla pedagogia all’estetica, dalla geopolitica alla «scienza giuridica» - vennero messe al servizio del radicamento nel popolo nazificato dello stereotipo di un antico Mediterraneo nordico.
Sebbene con ragguardevoli divergenze di vedute nelle alte sfere: come nel caso del conflitto che contrappose il Führer, pieno di disprezzo nei confronti dei germani considerati troppo primitivi a confronto dei venerati greco-romani (nelle cui lande mediterranee, come «spiegava» la teoria dei climi, il «genio nordico» aveva trovato condizioni meteorologiche più favorevoli per essere rigoglioso), e il germanomane Heinrich Himmler, a cui rispondevano gli archeologi-Ss (resi popolari dagli scontri cinematografici con Indiana Jones) dell’Anhenerbe, la «società di ricerca dell’eredità ancestrale» (fortemente influenzata dall’esoterismo), sguinzagliata ai quattro angoli d’Europa a caccia delle supposte tracce primigenie della razza ariana.
E negli anni Trenta e Quaranta, mentre il filo-elleno Heidegger si dedicava al ripristino dell’originario «pensiero dell’essere» presocratico, i circoli accademici si applicavano alla narrazione di un «Platone nordico», teorico di uno Stato razzista totalitario e di una comunità organicista, una sorta di «filosofo-re» precursore di Hitler, l’autentico «pensatore ufficiale» (perfino più di Nietzsche, come scrive Chapoutot) di quel Terzo Reich che coincideva con la «seconda Sparta».
Un progetto totalitario che si appropria di arti plastiche battaglie, eroi leggendari
Un repertorio sterminato quello del «discorso delle origini», che andava dall’architettura imperiale all’imperialismo come riedizione della colonizzazione romana, fino al nichilismo della catastrofe pensato come grande spettacolo e ultima coreografia che, di fronte all’offensiva del «giudeo-bolscevismo» e del «Cristo-bolscevismo», doveva spronare all’odio razziale e a una possibile futura vendetta contro ebrei e nazioni liberali. Continuando, così, sino all’atto finale il parallelo tra Roma e il Reich.
- STORIA E STORIOGRAGIA DEL FASCISMO, "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (A. GRAMSCI, 1924).
-
> MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E --- «L’eredità» di Corrado Stajano. La memoria riesumata del presente (di Marco Revelli).7 luglio 2017, di Federico La Sala
La memoria riesumata del presente
Diario. 1939-1945, gli anni che hanno segnato l’Italia repubblicana. «L’eredità» di Corrado Stajano
di Marco Revelli (il manifesto, 07.07.2017)
Si può camminare sull’orlo di un precipizio senza neppure accorgersene. Ci si può avviare verso una catastrofe a occhi chiusi, senza neppur coglierne i segni. Ci sono voluti gli occhi di un bambino e i ricordi di un anziano, compresi in un’unica voce narrante, per darci la misura di questa nostra maledizione (personale e nazionale).
È questa la sensazione attualissima - sconvolgente - che ho provato leggendo il più recente libro di Corrado Stajano, appena pubblicato dal Saggiatore. L’Eredità (pp. 165, euro 18) di cui parla - e che dà il titolo al libro - è appunto questa storia depositata dentro di noi, costellata di tragedie reali e di normalità virtuali. D’illusioni attese e di rovine concrete. La demagogia della politica (meglio: del Potere) e le dure repliche della Storia.
AL PRINCIPIO E AL CUORE del libro il 1939 (la madre di tutte le tragedie). Un giorno di maggio, anzi, un pomeriggio. In una città di confine, Como. Un bimbetto in divisa da «Figlio della Lupa», inquadrato alla meglio con gli altri scolari, agita la bandierina tricolore distribuita dal «maestro nero», in orbace, in attesa del grande evento, la limousine di Stato con sopra due signori in divisa, coperti di decorazioni, le aquile dorate sui cappelli, che passano veloci, sorridenti e salutanti, tra la gente in festa, e sono già oltre, in un amen.
Erano Galeazzo Ciano e Joachim von Ribbentrop, si preparavano a firmare il «Patto d’acciaio», l’alleanza mortale dell’Italia fascista con la Germania di Hitler, («su un foglio di carta la giovinezza perduta di milioni di uomini») ma lì, a quell’angolo di strada, tra la cappelleria Rossini e la Casa dei filati col suo odore di vecchia bottega, sembravano il ritratto della bonomia e dell’amicizia.
Appena il tempo di ricordare frammenti di quella «tragica estate mascherata di serena letizia», i caffé eleganti affollati, l’orchestrina che suona canzoni leggere. E subito la scena cambia: le strade del centro di Milano devastate dalle bombe dei Lancaster alleati, macerie ovunque, con le case che mostrano impudiche i propri interni.
ORA IL BAMBINO fattosi ragazzo - sono passati quattro anni appena - si aggira attonito nei luoghi consueti caduti in rovina, Palazzo Marino sventrato. corso Magenta una grattugia, piazza San Fedele irriconoscibile. Sbircia tra i muri diroccati della «bella basilica delle Grazie», dove il Chiosco dei morti distrutto rivela, dallo squarcio di un muro, lo spettacolo leonardesco de L’ultima cena, miracolosamente sopravvissuta.
È L’AGOSTO DEL ’43. Tra poco Milano si riempirà di fabbriche dell’orrore, villa Triste con i sadici della Banda Koch, l’Albergo Regina a quattro passi dalla Scala, le urla dei torturati dalle SS. Una catena di sofferenze, prima che la festa d’aprile del ’45 ponga fine al terrore.
Sullo sfondo, la sfilata di ritratti, uomini e donne del regime, carriere folgoranti in camicia nera all’insegna della fedeltà al Duce e repentine cadute in disgrazia: come quella di Giuseppe Terragni, l’architetto del razionalismo fascista, ingenuo adoratore di un «fascismo onesto», passato dagli altari della Patria alla polvere e al ghiaccio della ritirata di Russia, da cui uscirà inebetito e disilluso per morire solo, a 44 anni, di trombosi alla vigilia del 25 luglio. O come quella di Margherita Sarfatti, la «Maga Circe del Fascismo», riverita e omaggiata amante del Capo, onnipotente signora dei Salotti letterari prima di essere emarginata dalla volubilità di Lui e infine travolta dalle leggi razziali. Una successione di mondi caduti. Le icone della fatuità del successo maturato all’insegna del servilismo e della dedizione a un uomo solo al comando.
È QUESTA L’EREDITÀ - la legacy, direbbero gli inglesi, il «lascito» - che dovremmo riattivare ogniqualvolta assistiamo a una parata, un Vertice, una Conferenza internazionale o un proclama governativo. Per imparare a guardar dietro ai sorrisi di circostanza o alle fotografie di gruppo. Per tentare di vedere il sotterraneo lavoro della Storia al di là delle verità di comodo o di regime, siano le conclusioni di un G7 o le Conferenze stampa di un Premier. Quando Schauble parla di Grecia. Quando Theresa May parla di Brexit. Quando Donald Trump parla di America great again. Quando Matteo Renzi parla dell’Italia che «cambia verso». Quando tutti insieme a Taormina parlano di clima. E ancora a quell’eredità dovremmo tornare, col pensiero, quando - tra un bail-in e un bail out di banche - leggiamo sui giornali la minaccia del Governo di chiusura dei porti in faccia ai soccorritori dei migranti, dopo aver ascoltato un Ministro dell’Interno che si dice «di sinistra» vantare gli accordi feroci con le «40 tribù» libiche del confine col deserto per respingervi i flussi di profughi.
DOVREMMO DISSEPPELLIRE dalla memoria - pure questo fa parte del «lascito» descritto da Stajano - quanto, meno di un secolo fa, fecero sulla stessa costa libica da cui partono oggi i barconi baldi italiani come Graziani e Badoglio: i 40.000 ammazzati in operazioni di repressione, e gli altri 100.000 in tutta la Cirenaica, a cui aggiungere lo sterminio di Etiopia, con l’uso sistematico dei gas, iprite, fosfene, i gioielli della nostra chimica. Anche nel convivere, silenziosi o inerti, di fianco a tutto ciò sta il nostro «danzare giulivi» sotto la «cappa nera» che ci oscura il futuro, in un tempo in cui - direbbe Montale, oggi come allora - «la bussola va impazzita all’avventura/e il calcolo dei dadi più non torna» (La casa dei doganieri, 1939).
-
> MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E --- CORRADO STAJANO. «Eredità»: ricordi personali e memoria collettiva (di Paolo Di Stefano)28 giugno 2017, di Federico La Sala
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
Il passato può ancora tornare
Ricordi personali e memoria collettiva in «Eredità» (il Saggiatore) di Corrado Stajano
Protagonista un Figlio della Lupa davanti alle tragedie della Seconda guerra mondiale
di PAOLO DI STEFANO *
Ci portiamo dentro eredità non dichiarate, non consegnate a nessun documento ufficiale, eredità come fiumi sotterranei che ci attraversano e si irradiano in noi a nostra insaputa. Alcune fortemente bramate, altre indesiderate. Eredità è il titolo del nuovo libro di Corrado Stajano (Il Saggiatore), e la prima domanda è se quel sostantivo vada inteso come un singolare o come un plurale.
 A pagina 60, dove si conclude un bel ritratto di Margherita Sarfatti, si osserva che potrebbe essere stata lei «il modello e l’interprete più autorevole della condanna nazionale di cui ha scritto Cesare Garboli». Quale condanna? La condanna del fascismo, un «male forse geneticamente inseparabile dalla natura degli italiani (i quali per atavica sindrome imperiale si sentono fascisti non appena si sentono italiani)». In Ricordi tristi e civili, del 2001, Garboli segnalava come una minaccia la rinascita del fascismo «scortato da idee liberali, attraverso e dentro le idee liberali». «Eredità», postilla Stajano. È sul terribile pensiero di quella minaccia sempre attuale che si regge il libro di Stajano.
A pagina 60, dove si conclude un bel ritratto di Margherita Sarfatti, si osserva che potrebbe essere stata lei «il modello e l’interprete più autorevole della condanna nazionale di cui ha scritto Cesare Garboli». Quale condanna? La condanna del fascismo, un «male forse geneticamente inseparabile dalla natura degli italiani (i quali per atavica sindrome imperiale si sentono fascisti non appena si sentono italiani)». In Ricordi tristi e civili, del 2001, Garboli segnalava come una minaccia la rinascita del fascismo «scortato da idee liberali, attraverso e dentro le idee liberali». «Eredità», postilla Stajano. È sul terribile pensiero di quella minaccia sempre attuale che si regge il libro di Stajano.Ma le eredità sono tante: quelle collettive e quelle individuali, e la narrazione di Stajano ne accoglie (e ne propone) molte e diverse, perché la narrazione, come la intende Stajano (l’ha detto e ribadito più volte), si avvicina a quella di Walter Benjamin, che rivaluta e rilancia il suo significato originale. Narrazione come esperienza vissuta che porta in sé un consiglio, una morale. Scrive Benjamin: «Il consiglio, incorporato nella vita vissuta, è saggezza».
La narrazione di Stajano non solo porta intenzionalmente una morale, ma è inscindibile da quella morale. In un mondo di romanzi che si compiacciono del proprio cinismo irridente (il conformismo del cosiddetto «politicamente scorretto»), è anche questo il tratto che caratterizza la scrittura di Stajano: la determinazione nel proporre un insegnamento a futura memoria. Del resto, La stanza dei fantasmi si concludeva con l’invito a salvare almeno «la speranza nella speranza» per le generazioni che verranno.
L’esperienza individuale è il filo che percorre i libri di Stajano da una quindicina di anni: almeno da Patrie smarrite (2001) fino a Eredità (compreso Destini, che racconta gli incontri di una vita). Ma è un’esperienza singolare che si confronta costantemente con l’esperienza della collettività. Qui e altrove. Non è un caso se l’io narrante con cui si apre Eredità diventa ben presto, quasi uscendo da sé inavvertitamente, il «Figlio della Lupa»: «Ero anch’io un Figlio della Lupa. Nelle feste comandate indossavo la camicia nera, i pantaloncini di panno grigio-verde, un cinturone alla vita di piqué bianco a piegoline minute...». L’io (che Stajano visibilmente non ama) diventa noi, plurale.
Per Stajano è fondamentale l’esperienza fisica dei luoghi, luoghi rivisitati, indagati, riemersi alla memoria, perché i luoghi contengono le tracce della storia e/o i suoi fantasmi: la sua è una sorta di narrazione di geografie che si fanno storia (un’interazione che ricorda Carlo Dionisotti).
 In Eredità si parte da una scuola di Como, dalla sua facciata giallo sporco, dal suo giardino e dal ritratto di Cesare Battisti che dà nome all’istituto: è da lì che cominciano ad agitarsi i fantasmi del passato, quelli che risalgono a un pomeriggio di primavera in cui i figli della lupa, in fila per tre, si muovono per la città, guidati dal maestro in orbace: «Quel giorno di maggio del 1939, di primo pomeriggio, marciavo al fianco di due compagni - Cocconi? Pedretti? - da via XX Settembre alla vicina via Milano e di lì per un centinaio di metri, verso la piazza della Vittoria. Dovevamo allinearci proprio sull’angolo, lungo il marciapiedi». A ognuno verrà consegnata una bandierina, perché è il giorno dell’incontro storico tra Ciano e Ribbentrop, i due ministri degli Esteri.
In Eredità si parte da una scuola di Como, dalla sua facciata giallo sporco, dal suo giardino e dal ritratto di Cesare Battisti che dà nome all’istituto: è da lì che cominciano ad agitarsi i fantasmi del passato, quelli che risalgono a un pomeriggio di primavera in cui i figli della lupa, in fila per tre, si muovono per la città, guidati dal maestro in orbace: «Quel giorno di maggio del 1939, di primo pomeriggio, marciavo al fianco di due compagni - Cocconi? Pedretti? - da via XX Settembre alla vicina via Milano e di lì per un centinaio di metri, verso la piazza della Vittoria. Dovevamo allinearci proprio sull’angolo, lungo il marciapiedi». A ognuno verrà consegnata una bandierina, perché è il giorno dell’incontro storico tra Ciano e Ribbentrop, i due ministri degli Esteri.Da quel lontano pomeriggio si dispiega la narrazione, strutturata sul dialogo mobile e continuo tra quel che vedono gli occhi del bambino e il senso della Storia che gli si agita intorno e che gli si rivelerà, implacabile, in là con gli anni: nel corsivo del commento, che si alterna all’hic et nunc della cronaca vissuta dal ragazzino, si concentrano le domande sul resoconto della tragedia. Il Figlio della Lupa non può sapere che quella giornata «trionfale» prelude al patto d’acciaio del 22 maggio, che sarà l’inizio della guerra, l’inizio della fine. Che cosa ne sa un bambino di nove anni? Niente o quasi, al punto da immaginare quei due sommi gerarchi come «i festosi padroni del mondo». Che ne può sapere il Figlio della Lupa, che è fiero della divisa, sogna di diventare balilla e legge le storie del Signor Bonaventura sul «Corriere dei Piccoli»? Già, e gli altri? Che ne sanno gli adulti? Cosa percepiscono di quel che sta accadendo intorno a loro? Lo sentono l’angelo nero della guerra sulle loro teste? «La vita della città scorre tranquilla senza paure e sospetti». Se il lettore fatica a ritrovarsi nell’alternanza tra i corsivi del dopo e i tondi del prima è perché i tempi si inseguono e si confondono: «la bussola va impazzita all’avventura/ e il calcolo dei dadi più non torna», avverte Montale già in quel 1939.
Como è la città di Alida Altenburger che diventerà Alida Valli, l’attrice di Visconti e poi dei telefoni bianchi: il Figlio della Lupa l’ha vista un giorno sotto il colonnato del liceo Volta. Como è la città di Giuseppe Terragni, il geniale architetto del razionalismo, il teorico del fascismo come «casa di vetro», fedelissimo del «mito vivente» Mussolini, il combattente che ritorna dalla Russia senza forza e senza volontà, e che nel ’43 muore folgorato da una trombosi cerebrale non ancora quarantenne. Como è la città di Margherita Sarfatti, la Maga Circe del fascismo, l’amante ebrea e cantatrice del Dux caduta in disgrazia con gli sgambetti di Farinacci. Seguiamo destini diversi, prima gloriosi, poi precari, incerti, infine, per alcuni, tragici.
Anche lo sguardo infantile sembra aprirsi, diventare più inquieto, avvertire qualcosa nell’aria che gli adulti non sentono. Paura: «L’ansia è una cappa di piombo. La mamma è preoccupata, non riesce a nasconderlo». Tra la gente indifferente, il bambino piange quando, alla stazione di Como, viene a sapere che è scoppiata la guerra. Il padre è in Russia, tornerà ferito e congelato, sarà ricoverato all’ospedale di Imola, dove il Figlio della Lupa vedrà i primi morti della sua vita. Il fiume della narrazione di Stajano trascina tutto con sé: ricordi privati, documenti editi e inediti, poesie, monografie, diari, romanzi, interviste, saggi, memoriali, schede segnaletiche sui sovversivi di Como: nomi sconosciuti alla Storia, un tintore, un pellaio, un venditore, un custode, un falegname... Sconosciuti o quasi, come i tre comaschi che compaiono nella lista dei deportati ad Auschwitz. Destini.
C’è un miracoloso equilibrio tra distanza e partecipazione nel racconto di Stajano. E un buco nero tra la prima e la seconda parte: la guerra, che non viene raccontata. Se ne vedono invece le terribili conseguenze. Nella seconda parte del libro, ritroviamo l’ex Figlio della Lupa, diventato ragazzo, camminare barcollante tra le macerie fumanti di Milano, da cui emergono storie e figure dimenticate o quasi (bellissimi i ritratti del diacono coraggioso Giovanni Barbareschi e di padre Turoldo). Ancora luoghi, nel continuo oscillare del pendolo impazzito tra l’allora e l’oggi: l’Albergo Regina, «fabbrica dell’orrore», via Agnello, gli scheletri di piazza San Fedele, la grattugia di corso Magenta, Santa Maria delle Grazie, il Chiostro, quel che rimane di corso Vittorio Emanuele, il Duomo, San Carlo... È nelle poche pagine dell’ultima parte, la terza, quando il ragazzo viene a sapere che il padre, catturato dai tedeschi al Brennero dopo l’armistizio, è vivo dopo una catena di lager, e quando con sua madre lo raggiunge nella piccola stazione di Pescantina, che sul fiume oscuro e turbinoso delle eredità balugina qualcosa, una piccola arca su cui viaggiare.
* Corriere della Sera, 16 maggio 2017 (modifica il 18 maggio 2017) (senza immagini).
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
-
> MARGHERITA SARFATTI --- Archivi Vaticani, Pio X e la mappa del “mondo modernista” (di Marco Roncalli).22 giugno 2017, di Federico La Sala
Archivi Vaticani, Pio X e la mappa del “mondo modernista”
La ricezione e l’applicazione dell’enciclica “Pascendi Dominici Gregis” nella prima analisi comparata di tutte le relazioni pervenute a Roma dai vescovi e dai superiori degli ordini religiosi di ogni continente
di Marco Roncalli (La Stampa, 21/06/2017)
Città del Vaticano. Passato alla storia come la «sintesi di tutte le eresie», il modernismo conobbe all’alba del ‘900 un momento cruciale della sua storia per la condanna di Pio X. Obiettivo del Pontefice era la chiusura di ogni spazio al movimento che ripensava il messaggio cristiano nel confronto con la società del tempo, opponendo però -ai suoi occhi- fede e storia, Sacra Scrittura ed esegesi biblica, dottrina teologica e scienza. La risposta più forte di papa Sarto arrivò, come è noto, con l’ enciclica Pascendi Dominici Gregis ( 8 settembre 1907), decisa a sradicare con energiche misure antimoderniste quello che a giudizio del gesuita Enrico Rosa de “La Civiltà Cattolica” era «un cristianesimo nuovo che minacciava di sopprimere l’antico».
L’enciclica, nelle sue pagine conclusive, prescriveva che i vescovi inviassero ogni tre anni, a partire dal 1908, una relazione giurata sullo stato del modernismo nelle loro diocesi, confermando quanto richiesto: che fosse posta la filosofia tomista a fondamento degli studi; che i rettori e gli insegnanti dei seminari e delle università cattoliche non fossero infetti da modernismo; che venisse vietata la lettura di scritti modernisti; che venissero nominati i censori per le pubblicazioni; che fossero impediti i congressi di sacerdoti; che venisse stabilito un Consiglio di vigilanza.
Prescrizioni che avrebbero avuto una lunga eco. E non solo per il loro rilancio, tre anni dopo, attraverso un nuovo decreto antimodernista Sacrorum antistitum (1 settembre 1910), noto per la parte con la formula del giuramento imposto al clero e nuove accentuazioni nel testo della Pascendi. Anche dopo la morte di Pio X, infatti, richiami al modernismo avrebbero caratterizzato gli anni successivi nella storia della Chiesa, contribuendo (sempre meno dal pontificato di Giovanni XXIII in poi), alla diffusione di un modello monolitico di Chiesa e di disciplina, segnato dal ruolo centrale delle gerarchie ecclesiastiche.
Ma fermiamoci sulle reali conseguenze della Pascendi Dominici Gregis a partire dalla prima ricognizione che ne ha analizzato ogni direttiva e l’ impatto in ogni angolo del pianeta scandagliando una vasta mole di documenti, in larghissima parte inediti. Si tratta di carte custodite negli Archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, della Congregazione per le Chiese Orientali, della Congregazione “Propaganda Fide” (oggi Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli), nell’ Archivio Segreto Vaticano. Carte valorizzate da una ricerca internazionale sostenuta dal German Research Council (Deutsche Forschungsgemeinschaft) durata diversi anni, con contributi di noti specialisti, ora pubblicata con il titolo “The Reception and Application of the Encyclical Pascendi, The Reports of the Diocesan Bishops and the Superiors of the Religious Orders until 1914”, dagli storici Claus Arnold (Università di Mainz) e Giovanni Vian (Università di Venezia) per le Edizioni Ca’ Foscari, in modalità open access (il volume può essere scaricato liberamente dal sito dell’editore).
Come spiega Alejandro M. Dieguez (Archivio Segreto Vaticano) aprendo il volume, alla pubblicazione dell’enciclica nessuno aveva previsto le conseguenze “operative” delle disposizioni: dall’istituzione «quanto prima» del Consiglio di vigilanza in diocesi all’ invio «alla Santa Sede» entro un anno e poi ogni triennio di una «diligente e giurata esposizione sull’attuazione delle prescrizioni dell’enciclica e sulle dottrine che corrono in mezzo al clero». Nemmeno l’organo deputato a ricevere queste relazioni era stato chiaro, motivo dunque di una dispersione dei primi invii approdati in diverse sedi: dalla Segreteria di Stato al Sant’Offizio, dalla Concistoriale a Propaganda.
E se è vero che le prime relazioni arrivate a quest’ultima sede passarono subito alla Concistoriale, il dicastero guidato dal cardinale De Lai, prelato che godeva la totale fiducia di Papa Sarto (non le successive), altre furono a lungo oggetto di contese tra la Concistoriale e il Sant’Offizio superate solo dall’1 maggio 1912. Da quel momento «fu chiaro che l’esame delle relazioni sul modernismo spettava alla Congregazione Concistoriale», osserva Dieguez, spiegando che «se l’analisi di quanto avvenuto al ‘centro della cristianità’ rivela una certa disorganizzazione curiale riguardo alla ricezione ed elaborazione delle notizie richieste dalla Pascendi» l’esposizione di vari casi “getta” luce sulle incertezze e, più in genere, sullo stato d’animo della “periferia”, ossia delle Chiese locali.
Così, al di là del tasso di assolvimento dell’obbligo, dove le cifre che interessano - spiega qui Vian - sono quelle per il 1908 e il gennaio 1912 (quando la presentazione dei rapporti era dovuta dapprima, fino all’agosto 1910, alla scelta dei vescovi di conformarsi alla norma della Pascendi e poi, dal settembre 1910 a tutto l’anno successivo, al suo rilancio con il Sacrorum antistitum), e pur non dimenticando che dal gennaio 1912 l’obbligo poté essere ottemperato anche rispondendo a due quesiti specifici nelle “relationes ad limina” (non considerate in questa monografia), sono dati più che significativi quelli qui raccolti e interpretati. A maggior ragione vista la piena “copertura” di questa prima analisi comparata degli atteggiamenti dei vescovi innanzi agli obblighi della “relazione Pascendi”. Un’analisi che nonostante l’ esiguità delle risposte solo rispetto alle attese, presenta campioni assai esaurienti al fine di trarre conclusioni. Un’enorme mole di documenti qui suddivisi innanzitutto per aree geografiche, con appositi “focus” dilatati nei capitoli dalle diocesi del Vecchio Continente a quelle del globo.
Un primo approfondimento riguarda la Francia dove la repressione antimodernista toccò di fatto solo un piccolo numero di seminaristi e la minaccia di misure più rigorose bastò a imporre il silenzio. «L’enciclica ha bloccato le ricerche più innovatrici e se sembra aver messo un termine alla crisi modernista, non è senza aver sterilizzato per lungo tempi i differenti tentativi di adattare il discorso ecclesiale alle realtà del momento», nota Louis-Pierre Sardella nel suo contributo, aggiungendo che i vescovi constatavano che «molti fedeli, senza aderire al corpus ideologico modernista» avevano «tuttavia preso l’abitudine -come deplorato dall’enciclica, “di pensare, parlare, scrivere con maggior libertà di quanto convenga a dei cattolici”...». Insomma siamo ad una data e in un luogo in cui la distanza tra l’espressione del Magistero (con le sue norme dottrinali e disciplinari) e la vita reale dei cristiani (con i suoi problemi) aumenta, ma parallelamente anche a una crescente indifferenza, mentre si profilano sfide davanti alle quali è difficile presentarsi con la sola armatura dogmatica difensiva di una istituzione gerarchizzata.
Un secondo meticoloso approfondimento affronta la situazione in Italia. Raffaella Perin, dato conto delle assenze anche di vescovi esemplari nel campione di relazioni ritrovate - forse perché i presuli che avevano già fama di antimodernisti le ritennero superflue - osserva che gli altri presuli meno in linea con Pio X «forse non risposero perché non potendo opporsi apertamente o sollevare perplessità, con il loro silenzio avrebbero almeno evitato di accondiscendere o, al contrario di alimentare ulteriori sospetti con risposte che potevano essere interpretate malevolmente». L’analisi delle relazioni pervenute consente sottolineature sull’accoglimento degli ordini papali quanto alla necessità di vigilare e all’impegno nel continuare a sorvegliare il proprio clero e l’ortodossia dei seminari, ma rileva pure la denuncia dell’ignoranza del clero, che limitava - agli occhi dell’episcopato - la possibilità che il modernismo potesse diffondersi nelle diocesi italiane.
Allo scandaglio della Spagna è dedicata invece l’analisi di Alfonso Botti. Lo storico conferma per l’area iberica la mancanza di un vero movimento modernista e, di contro, la presenza di un antimodernismo che rimarca la curvatura conservatrice e tradizionalista di questo episcopato che, nel disorientamento causato da istruzioni poco chiare, non percependo il problema con la stessa intensità della curia romana, o ritenendolo controproducente, rinunciò persino a segnalare le poche posizioni moderniste nelle varie diocesi.
Non c’è qui lo spazio per continuare a ripercorrere l’ampia ricerca con tratti simili o diversi, in altri Paesi europei: dal Belgio ai Paesi Bassi, dalla Svizzera alla Russia (Giovanni Vian); in Germania (e qui Claus Arnold porta il lettore sul terreno delle eccezioni concesse da Pio X per la situazione politica e religiosa che aveva spinto i vescovi a raccomandare alla Santa Sede di non pubblicizzare le misure previste dalla Pascendi, per evitare di suscitare l’irritazione pubblica verso la Chiesa cattolica e il papato); o in Austria (Michaela Sohn-Kronthaler), o in altre aree non germanofone dell’ex Impero austro-ungarico (Otto Weiß). Né c’è lo spazio per descrivere la situazione in Nord America e in America Latina (terreno d’indagine rispettivamente di Charles Talar e di Maurizio Russo che hanno rilevato come, nelle Americhe, il modernismo fosse una questione europea o legata alla presenza di ecclesiastici originari del Vecchio continente); e neppure nelle Indie Orientali, nei mondi lontani dell’ Indocina o dell’Oceania (laddove - rileva Vian - come in altre aree della cattolicità extraeuropea le sollecitazioni di Pio X furono neglette).
E nemmeno possiamo fermarci sulle interessanti “relazioni Pascendi” degli istituti religiosi (analizzate da Dieguez), i cui superiori - si è detto- erano pure stati invitati a inviare reports sul fenomeno a prefissate scadenze. In realtà è proprio l’intero atlante del modernismo che viene qui ricostruito. Piuttosto proviamo qui a condividere con i curatori le ipotesi che la sintesi di questa iniziativa mondiale suggerisce. «Che nell’ottica di Pio X e dei suoi collaboratori di Curia valesse la pena di operare a 360° contro il modernismo, attraverso strumenti come le relazioni, i consigli di vigilanza, i censori sulla stampa e altre misure disciplinari, e questo anche di fronte a limitate adesioni da parte degli ordinari diocesani, sembrano confermarlo le rare vicende, non scontate, di individuazione di nuovi ‘modernisti’, nelle località più disparate della cattolicità, di cui le ricerche confluite nel presente volume danno notizia», afferma Vian.
E se è vero che Arnold concorda sull’efficacia dell’operazione sul piano della mobilitazione antimodernista, sottolineandone l’impatto al di là di quanto risulti dalle relazioni giunte a Roma, lo stesso giunge a rilevare che Pio X aveva buone ragioni per non essere entusiasta dell’episcopato cattolico nel suo insieme. «L’elevato numero di assenze tra i rapporti attesi a norma della Pascendi - un dato ancora più significativo per gli ordinari di diocesi dell’Europa Occidentale, l’area complessivamente più coinvolta dalla crisi modernista - merita la formulazione di un’ipotesi: accanto a probabili negligenze, mi pare che in quel modo si manifestassero perplessità, che in alcuni casi erano anche più o meno velate riserve, di fronte al criterio ampio e quasi onnicomprensivo dell’antimodernismo proposto da Pio X e dagli ambienti curiali più intransigenti e integristi», afferma Vian.
Insomma diversi contributi del volume rilevano che per non pochi ordinari il modernismo visto in diocesi era assai diverso che visto da Roma. Di qui dubbi, incomprensioni, incertezze, ma anche - per alcuni - distinzioni e non condivisione di giudizi e di modalità di intervento: elementi che contribuirono ad alimentare un graduale distacco di una parte dell’episcopato nei confronti del pontificato di Pio X palesatosi con la scelta del conclave dell’estate 1914 , che -afferma sempre Vian- optò per un candidato portatore di una linea almeno in parte di discontinuità rispetto a quella del predecessore. Questo risultò particolarmente evidente- anche se non fu l’unico aspetto - per il disciplinamento del modernismo.
Non è tutto. Infatti, l’appurata convinzione - espressa da vescovi delle Americhe, dell’Asia e dell’Oceania - che il modernismo costituisse un problema europeo (o di importazione dall’Europa, attraverso riviste, libri e missionari), si manifestò pure come l’ indizio di un cattolicesimo che, mentre nei suoi vertici continuava a essere pensato come romano, tutt’al più, europeo, andava prendendo sempre più consapevolezza della necessità di più ampie prospettive. «La predominante dimensione eurocentrica del cristianesimo non era un fenomeno proprio della sola Chiesa cattolica. Anche le Chiese delle altre confessioni cristiane continuavano a ritenersi caratterizzate dal riferimento a culture e teologie profondamente radicate nel contesto europeo. E, come è noto, più in generale era la stessa percezione dell’opinione pubblica europea - che, attraverso i possedimenti coloniali, era trasmessa anche a gran parte della popolazione del pianeta - che continuava a guardare all’Europa, soprattutto a quella dei Paesi occidentali, come al centro e alla guida della civiltà umana», scrive Vian nelle ultime pagine di The Reception and Application of the Encyclical Pascendi. E conclude: «La Prima Guerra mondiale e il dopoguerra avrebbero reso più evidente come la transizione dall’eurocentrismo alla mondializzazione, sviluppatasi in seguito fino all’odierna globalizzazione, fosse una dinamica ormai in atto. Essa coinvolse anche il cristianesimo, il cui eurocentrismo si avviava gradualmente e in mezzo a non poche resistenze, a cedere il passo a una prospettiva di “World Christianity”».
-
> MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO DELLA ROMANITÀ. -- EREDITA’ (Corrado Stajano). La bella estate di un Figlio della Lupa (di Raffaele Liucci).11 giugno 2017, di Federico La Sala
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
Memorie della seconda guerra mondiale
La bella estate di un Figlio della Lupa
Corrado Stajano rievoca gli anni fascisti della sua infanzia a Como, la guerra e, a Milano, la lotta partigiana
di Raffaele Liucci (Il Sole-24 Ore, Domenica, 11.06.3017)
- Corrado Stajano, Eredità, il Saggiatore, Milano, pagg. 166, € 18
«Ha un senso ricordare più di settant’anni dopo una guerra vista e vissuta da un bambino?», si chiede Corrado Stajano nel suo nuovo libro. Si rischia la sindrome di Pinocchio: «Com’ero buffo, quando ero un burattino!». All’epoca, infatti, Stajano viveva a Como ed era un Figlio della Lupa. Orgoglioso della sua funerea uniforme, già sognava il giorno in cui sarebbe diventato Balilla e poi Balilla moschettiere, con quel fucile adatto a sparare soltanto cartucce di carta, ma in grado di far somigliare chi lo impugnava a un «vero soldato». Il Figlio della Lupa aveva letto con passione i libri di Salvator Gotta. Non soltanto Il piccolo alpino, ambientato nella Grande Guerra, ma anche i capitoli successivi della saga, nei quali Giacomino diventava prima squadrista alle prese con i sovversivi e poi piccolo legionario in Africa Orientale. Pure il «Corriere dei Piccoli» faceva la propria parte, sbeffeggiando il Negus da disarcionare.
Sulle rive del Lario, quella del ’39 fu «una tragica estate mascherata di serena letizia». A maggio il Figlio della Lupa aveva acclamato il passaggio a Como di Ciano e von Ribbentrop, i ministri degli Esteri dell’Asse, in procinto di firmare il Patto d’Acciaio. Quel tardo pomeriggio lui e i suoi compagni di scuola avevano marciato in fila per tre sventolando bandierine con la svastica, agli ordini del maestro, vestito interamente di nero e con uno stiletto fissato alla cintura. Qualche nube s’addensava all’orizzonte, ma il cielo rimaneva terso e il quadro era rasserenante, per un bambino di nove anni. Il placido lungolago, le aiole di azalee, le fragranze della città vecchia, la finestrella del fruttivendolo, con mandarini, noci, datteri. Soltanto gli adulti che si spingevano sino a Chiasso e Lugano s’imbattevano in giornali inaspettati, scritti in italiano, ma non preconfezionati dalle autorità fasciste.
Ritornato sui luoghi della propria infanzia, Stajano li ritrova sonnolenti e dimentichi, sfiorati dalla Storia senza mai esserne diventati parte integrante. Chi si ricorda, per esempio, che la Casa del Fascio di Como firmata da Terragni - oggi sede della locale Guardia di Finanza - non soltanto non divenne la «casa di vetro» grottescamente invocata da Mussolini, ma sotto l’occupazione tedesca ospitò una camera di tortura per partigiani, antifascisti ed ebrei?
Quello di Giuseppe Terragni - architetto antiretorico devoto al duce, che fece della città lariana la capitale del razionalismo modernista - non è il solo fantasma incrociato da Stajano durante queste postreme peregrinazioni. Ce ne sono altri. Alida Valli, «fidanzata d’Italia», giunta a Como da Pola, intravista mentre chiacchierava con le amiche sotto il colonnato del liceo Alessandro Volta.
E Margherita Sarfatti, la «maga Circe del fascismo», proprietaria, non lontano dal lago (a Cavallasca), di una villa di campagna foderata di libri e abbellita dai quadri di Sironi, Boccioni, Funi. All’epoca, i contadini più anziani ricordavano ancora «la Presidenziale», che scortava in quest’alcova l’Alfa Romeo del duce.
Nel ricostruire la tragica parabola di Margherita - donna colta, ambiziosa, trasformista, biografa e amante di Mussolini, poi caduta in disgrazia e costretta all’esilio dalle leggi «razziali» - Stajano ingaggia un amaro corpo a corpo con il fascismo e la sua inquietante «eredità». Viene in mente la definizione datane dallo storico Angelo Ventura: «Un movimento politico che ha inventato e instaurato con la violenza, per la prima volta nella storia, un regime totalitario di destra in un paese civile e industrializzato». Questo primato spetta al fascismo italiano che, alleato della Germania nazista, spingerà il nostro paese «alla catastrofe di una guerra condotta con inefficienza, incompetenza e irresponsabilità senza pari nella storia dell’Italia unita».
Quant’era lontana, anche sul Lario, l’Italia di Cavour, mezzo ginevrino di madrelingua francese innamorato dell’Inghilterra! Una cacofonia di slogan autarchici inondava il Figlio della Lupa: «È vietato parlare di politica e di alta strategia», «Il Duce ha sempre ragione», «credere, obbedire, combattere», l’esercito di «otto milioni di baionette», «il primo ministro Churchillone».
Ogni nuovo libro di Stajano è un parto più autobiografico del precedente. Come se quest’autore - inizialmente restio a esporsi in prima persona, preferendo dedicarsi ad alcuni personaggi esemplari, dall’anarchico Serantini all’«eroe borghese» Ambrosoli - sentisse il crescente bisogno di rivitalizzare con un «io» non debordante i brandelli della propria memoria (una vocazione forse affiorata per la prima volta nel 2001 con Patrie smarrite e proseguita nei successivi libri).
Collaudata è invece la macchina narrativa: amalgama inconfondibile di fonti, stili e registri diversi, capace di fotografare la storia d’Italia con una profondità di campo inconsueta. Come risulta anche nel passaggio dalla prima alla seconda parte del libro.
Siamo nella primavera del ’45. Le rive indolenti e solatie del lago di Como hanno lasciato il posto alle macerie di Milano, su cui si affaccia l’ex Figlio della Lupa. Sono le ultime settimane della Repubblica Sociale. La città, scarnificata dai bombardamenti, è «una caldaia rovente di pece nera». Tanto inconsapevole era il fanciullo nella «bella estate» del ’39 quanto raggelato da un eccesso di lucidità appare l’adolescente cresciuto troppo in fretta, mentre percorre le spossate vie cittadine in una catarsi onirica e visionaria.
L’insurrezione partigiana è ormai alle porte, in Duomo celebra la messa il giovane David Maria Turoldo, frate servita del convento di San Carlo, nonché collaboratore attivo della Resistenza. Nonostante questi lampi nel buio, gli occhi dell’ex Figlio della Lupa si posano soprattutto su androni lugubri e sanguinanti. Villa Triste, dimora dei sadici della Banda Koch. L’Albergo Regina, quartiere generale delle SS, dal quale le urla dei torturati squarciano il silenzio della notte. La Basilica delle Grazie, colpita a morte dai bombardamenti, già sede del Tribunale della Santissima Inquisizione. Il ritiro di Santa Valeria, dove fu murata viva in una cella la monaca di Monza.
Come mai lo sguardo del giovane sembra attratto più dalle tenebre che dalla luce? Forse perché in quella Milano caliginosa intravede non soltanto l’alba della Resistenza, ma anche il cupo futuro che un giorno, da adulto, racconterà egli stesso: la città di Piazza Fontana, delle Brigate Rosse, di Michele Sindona, di Tangentopoli. La città uscita da una tela di Goya, traboccante di relitti del dolore.
La Liberazione del 25 aprile sarà perciò soltanto un pallido raggio di sole calato sull’eterno orfanatrofio della guerra. Non è un caso che la terza e conclusiva parte del libro narri il rimpatrio del padre: «Catturato dai tedeschi al Brennero dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, internato in una catena di lager, liberato a Berlino dall’Armata Rossa nel maggio 1945, portato in Ucraina da dove ora sta tornando». Un’odissea che ricorda quella raccontata da Primo Levi nella Tregua, memoria dal titolo non proprio beneaugurante.
-
> MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO DELLA ROMANITÀ. -- ABY WARBURG E "L’ATLANTE DELLE IMMAGINI". UNA LETTURA DELLE TAV. 78 E 79.30 maggio 2017, di Federico La Sala
ABY WARBURG E I PATTI LATERANENSI. Una lettura delle tavole 78 e 79 di "Mnemosyne. L’atlante delle immagini"
di Giuseppe Capriotti *
Nel corso del suo ultimo soggiorno a Roma, avvenuto tra il 1928 e il 1929, Aby Warburg, insieme alla sua infaticabile collaboratrice Gertrude Bing, assiste alla stipula dei Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio del 1929 da Benito Mussolini e il pontefice Pio XI. Nel diario del 1929 della Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, i due studiosi riferiscono le loro impressioni su diversi eventi, anche legati alla sottoscrizione dei Patti, tra cui una processione del papa a San Pietro e uno spettacolo cinematografico che comprendeva un filmato sulla stessa cerimonia dei Patti.
Tali episodi confluiscono infatti nelle due ultime tavole, la 78 e la 79, di quel monumentale tentativo di studiare, attraverso serie di immagini, la storia dei valori espressivi dell’antichità che sopravvivono e informano l’arte del Rinascimento, ovvero di Mnemosyne, l’Atlante della Memoria.
Mentre nella tavola 78, interamente dedicata alla stipula dei Patti, mancano immagini di opere d’arte e compaiono solo foto dell’evento, nella tavola 79, incentrata sul tema del redentivo sacrificio eucaristico, cuore problematico della cristianità europea, spaccata tra chi lo ritiene una metafora (i protestanti) e chi lo considera una realtà (i cattolici), le immagini di opere d’arte (la Cattedra di San Pietro di Bernini, la Messa di Bolsena di Raffaello, la Speranza di Giotto, l’Ultima comunione di San Girolamo di Botticelli) si affiancano, tra le altre, a foto della processione eucaristica di Pio XI in piazza San Pietro il 25 luglio 1929, ad alcuni ritagli di giornale (un articolo del “Berliner Zeitung” del 1929 con la firma del trattato di Locarno e due pagine del supplemento illustrato dell’“Hamburger Fremdenblatt” del 1929 con immagini di atleti trionfanti e ancora della processione eucaristica pontificia), a una foto di seppuku giapponese (il suicidio rituale dei samurai), a due stampe quattrocentesche con ebrei che profanano l’ostia consacrata.
È l’unica volta in cui l’ebreo Warburg, in realtà profondamente angosciato dagli sviluppi politici del suo tempo, dall’incalzare dell’irrazionalismo e dal riattivarsi di sentimenti antisemiti, che egli sperava di combattere con la sua Kulturwissenschaft, affronta direttamente una tematica antiebraica, ricorrendo a due xilografie prodotte in due diverse città, una tedesca, l’altra italiana, ovvero la Germania e l’Italia, il Nord e il Mediterraneo, i due poli geografici di cui egli cerca perennemente di mostrare il fruttuoso scambio dialettico, ma allo stesso tempo le due nazioni che condurranno l’Europa alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale.
La prima stampa, realizzata a Lubecca e tratta probabilmente dallo Jüdisches Lexicon, raffigura la presunta profanazione di ostie compiuta da ebrei a Sternberg nel 1492; la seconda, pubblicata a Firenze nell’edizione di una famosa sacra rappresentazione del Rinascimento italiano, la Rappresentatione d’uno miracolo del corpo di Christo, mostra, a sinistra, tre ebrei che restituiscono ad una donna l’abito impegnato, in cambio di un’ostia consacrata che gli stessi ebrei stanno profanando a destra.
Il significato che Warburg attribuisce a queste due stampe quattrocentesche sta nel rapporto con tutte le altre immagini della tavola, a partire da quella più grande, che con ogni evidenza risulta essere l’immagine-guida: la Messa di Bolsena di Raffaello. L’affresco raffigura un importante miracolo eucaristico, che ha come protagonista uno scettico prete boemo, i cui dubbi sulla transustanziazione vengono fugati, durante la celebrazione della messa, dall’ostia stessa che comincia a sanguinare e che macchia il suo corporale. Il papa Urbano IV, che assistette personalmente all’evento, introdusse nel calendario cristiano la festa del Corpus Domini, celebrata anche da Pio XI nelle foto che, nella tavola, affiancano il dipinto. La Messa è preceduta in alto dalla Cattedra di San Pietro, immagine del potere simbolico della Chiesa, e seguita in basso dall’Ultima comunione di San Girolamo, allusiva alla condivisione perpetua del sacramento da parte dei credenti.
Il sacrificio eucaristico è comparato in alto col suicidio rituale giapponese che, soppresso a seguito della diffusione della religione buddista, era stato successivamente reintrodotto in Giappone per rafforzare l’identità nazionale moderna. La celebrazione del corpo eccellente è ancora il filo conduttore che Warburg forzatamente individua nella Bildersalat della pagina illustrata dell’“Hamburger Fremdenblatt”, che compare sulla destra della tavola: la foto dello stesso papa in processione, che non è ritagliata, ma è proposta insieme a tutte le altre del giornale, compare affiancata (e in un caso sovrastata) da immagini di atleti che, grazie alla loro eccellenza corporea, hanno trionfato nell’agonismo. È ancora un esasperato culto del corpo, ma di polarità invertita: nella pagina di giornale “l’allegro hoc meum corpus est viene accostato al tragico hoc est corpus meum”, commenta lo stesso Warburg.
Nell’interpretazione storica proposta dalla tavola, è proprio questo hoc est corpus meum, o meglio l’uso in funzione politica e identitaria del corpus mysticum, che si identifica con l’ecclesia nutrita dal corpo sacrificato di Cristo, ad avere stretti rapporti con le accuse di profanazione dell’ostia, inventate in molte città d’Europa per difendere il dogma della transustanziazione, proclamato nel 1215 al IV Concilio Lateranense, e per giustificare le razzie contro le comunità ebraiche e l’incameramento dei loro beni.
La firma del trattato di Locarno tra Francia, Gran Bretagna e Germania nel 1925 (citato in alto a destra), con la quale ci si aspettava la pace in Europa, e la stipula dei patti lateranensi (presente nella tavola precedente), con la quale la Chiesa rinunciava al potere secolare, alla forza fisica del suo esercito e alle pretese nei confronti dello Stato italiano (in cambio del cattolicesimo come religione di stato e di cospicui indennizzi), potevano essere, secondo Warburg, una concreta possibilità di mettere fine allo spargimento di sangue perpetuato anche a fini religiosi, superando finalmente modalità di costruzione identitaria fondate sul sacrificio cruento.
Il ritorno al seppuku nella cultura giapponese è tuttavia in questo contesto contesto un agghiacciante monito per la cultura europea: una conquista di civiltà non è mai garantita per sempre, l’atavismo può essere sempre e ovunque riattivato dal nazionalismo . Secondo George Didi-Hubermann, il montaggio di immagini della tavola arriva addirittura ad avere quasi un valore profetico: ricorda come la proclamazione del dogma della transustanziazione ha dato avvio ad una sistematica persecuzione degli ebrei d’Europa e rivela, prima dell’apertura dei campi di sterminio, il risvolto pericoloso del patto tra dittatore fascista e pontefice romano.
Anche se Warburg non ha scritto alcun saggio sulle immagini antiebraiche, l’insegnamento che si può dedurre dal montaggio della tavola 79, ovviamente attraverso i suoi tentativi di decodificazione, è duplice: uno di ordine metodologico, l’altro prettamente storico. Dal punto di vista del metodo, la considerazione dell’immagine (di ogni tipo di immagine) come fonte storica e il riconoscimento del suo speciale valore di engramma mnemico, ovvero i principi base della Kulturwissenschaft warburghiana, possono essere un valido antidito alla periodica rinascita di derive irrazionalistiche, nel momento in cui aiutano a smascherare i processi di costruzione storica del pregiudizio e le cause che vi sono dietro. Dal punto di vista dell’analisi dei processi storici, la tavola 79 sembra legare sottilmente l’antigiudaismo cristiano ai risorgenti fenomeni di antisemitismo del primo Novecento, di cui lo studioso amburghese andava raccogliendo tracce e documenti che archiviava con preoccupazione.
Il quesito storico messo a tema nell’ultima tavola di Mnemosyne, ovvero il rapporto tra antigiudaismo cristiano e antisemitismo novecentesco, è un astioso problema che è ancora al centro di un vivace dibattito. Molta storiografia cattolica tende infatti a differenziare nettamente i due fenomeni: l’antigiudaismo cristiano, che usa come discrimine l’appartenenza religiosa, è un’ostilità nei confronti degli ebrei di stampo teologico, si manifesta per convertire coloro che negano che Gesù sia il Messia e cessa nel momento in cui l’ebreo diviene cristiano; l’antisemitismo, che si appoggia su teorie classificatorie di matrice positivistica e sulla presunta esistenza delle razze umane, esclude invece la possibilità che la conversione cambi lo status di un ebreo, che resta tale e immutabile per questioni di razza e di sangue. L’antigiudaismo è considerato un fenomeno moderato e marginale, chiuso nella religiosità dell’età medievale e moderna, mentre l’antisemitismo, radicale e violento, sarebbe il frutto della mentalità laica dell’età contemporanea.
Le distinzioni proposte da chi sostiene l’incomparabilità tra i due fenomeni, con evidenti finalità autoassolutorie, è stata pesantemente contraddetta dagli studi sulla Spagna che esce dal 1492, annus horribilis dell’inizio della storia moderna e della cacciata degli ebrei dal cattolicissimo regno di Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona.
Anche se nel 1492 si prescrive l’espulsione di tutti gli ebrei che non accettavano di convertirsi al cristianesimo, passando attraverso il rito del battesimo, ritenuto valido ed efficace nella trasformazione dell’ebreo in cristiano a prescindere dalla volontà del ricevente, nel 1449, a Toledo, erano già comparsi gli Estatudos de la limpieza de sangre, che impedivano l’ingresso nel capitolo canonicale a coloro che non possedevano il sangue puro del vero cristiano perché aveva ereditato quello impuro di un ebreo battezzato, e a partire dal 1454 il francescano Alonso de Espina nel suo ciclo di prediche, condotte in Castiglia, aveva proposto di escludere i conversos da tutti i corpi istituzionali di maggior potere e prestigio della società spagnola, per poi sostenere con fermezza nel suo Fortalitium fidei, risalente al 1459, la “perfidia” del popolo ebraico, “perfidia” che contraddistingueva anche i convertiti: il battesimo dunque non cancellava un carattere negativo radicato nel sangue, ereditario e indelebile, a prescindere dall’appartenenza religiosa.
Nella lunga durata l’effetto di queste idee e delle pratiche che ne conseguirono, specialmente nei confronti dei conversos, spesso sospettati o accusati di criptogiudaismo, non fu la scomparsa di una religione scomoda, ma la trasformazione della differenza ebraica da religiosa a naturale e l’invenzione di una “razza” dal “sangue impuro”.
Oltre a questa precoce elaborazione in chiave “razziale” del problema ebraico, è anche nelle sue manifestazioni più esteriori che l’antigiudaismo d’età medievale e moderna ha preso delle forme che si ritrovano praticamente immutate nel Novecento, dall’imposizione del segno giallo, introdotto già nel Medioevo, alla stella di Davide prescritta dai nazisti ai cittadini di religione ebraica , dall’istituzionalizzazione del ghetto, avvenuta con la bolla papale Cum nimis absurdum promulgata da Paolo IV nel 1555 , alla righettizzazione novecentesca, dall’invenzione medievale del complotto ebraico per lo sterminio dei cristiani, elaborato a seguito delle prime accuse di omicidio rituale, ai Protocolli dei Savi di Sion e alla loro fortuna.
L’antigiudaismo ha dunque avuto un ruolo sostanziale nel costruire i presupposti culturali del pregiudizio contro gli ebrei e l’antisemitismo, falsamente rinnovato da una pseudoimpostazione scientifica, ha potuto grazie ad essi attecchire in maniera efficace nella popolazione civile: i nazifascisti hanno insomma potuto gestire, secondo le proprie istanze politiche, un sentimento di diffidenza costruito attraverso i secoli proprio dall’antigiudaismo cristiano [...].
* Cfr. Aby Warburg, Mnemosyne. L’atlante delle immagini, a cura di Martin Warnke con la collaborazione di Claudia Brink, edizione italiana a cura di Maurizio Ghelardi, Torino, Aragno, 2002, pp. 130-133.
- Mnemosyne Atlas 78
 Roma oggi/1929: dal potere terreno al potere spirituale
Roma oggi/1929: dal potere terreno al potere spirituale
 La Chiesa di fronte allo Stato nella celebrazione ufficiale dei Patti Lateranensi (febbraio 1929): rinuncia al potere secolare in cambio della conservazione della potenza simbolica.
La Chiesa di fronte allo Stato nella celebrazione ufficiale dei Patti Lateranensi (febbraio 1929): rinuncia al potere secolare in cambio della conservazione della potenza simbolica.
- Mnemosyne Atlas 79
 Mangiare dio: il paganesimo nella Chiesa
Mangiare dio: il paganesimo nella Chiesa
 Evoluzione del sacrificio: dal rito cruento arcaico alla sua rappresentazione simbolica nell’atto della Messa.
-Nel rituale eucaristico l’immagine del sacrificio pagano della carne è sublimato nella transustanziazione, ma si perpetua e riemerge nei miracoli (Messa di Bolsena di Raffaello, L’ultima comunione di San Gerolamo di Botticelli) e nelle leggende (la propaganda antisemita sulla profanazione dell’ostia).
Evoluzione del sacrificio: dal rito cruento arcaico alla sua rappresentazione simbolica nell’atto della Messa.
-Nel rituale eucaristico l’immagine del sacrificio pagano della carne è sublimato nella transustanziazione, ma si perpetua e riemerge nei miracoli (Messa di Bolsena di Raffaello, L’ultima comunione di San Gerolamo di Botticelli) e nelle leggende (la propaganda antisemita sulla profanazione dell’ostia).
* Giuseppe Capriotti, , "Lo scorpione sul petto. Iconografía antiebraica tra XV e XVI secolo alla periferia dello stato pontificio", Gangemi editore, Roma 2014, Introduzione - ripresa parziale - e senza note.
- Mnemosyne Atlas 78
-
> MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E --- E GLI EBREI ITALIANI SOTTO IL FASCISMO. “Caro Duce, non dovremmo fare questo agli ebrei” (di Amedeo Osti Guerrazzi).25 maggio 2017, di Federico La Sala
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
Non solo Perlasca: furono molti i fascisti, anche semplici cittadini, che si prodigarono a proprio rischio per mettere in salvo i “nemici razziali”
“Caro Duce, non dovremmo fare questo agli ebrei”
di Amedeo Osti Guerrazzi (La Stampa, 24.05.2017)
«Duce, non dovrebbe essere questo, non può succedere questo! È un brano di una lettera scritta da alcuni fascisti a Mussolini nell’autunno del 1943. È un appello disperato, è la richiesta perché una anziana ebrea sia liberata e salvata dalla deportazione verso i campi di sterminio. Può sembrare pazzesco, ma si tratta di un documento autentico, che racconta una storia poco conosciuta, quella dei fascisti che salvavano gli ebrei.
Nell’autunno del 1943 migliaia di ebrei italiani sono in fuga. Con la grande razzia romana del 16 ottobre 1943 (1022 deportati ad Auschwitz), la caccia ai nemici razziali del Terzo Reich è ufficialmente iniziata anche in Italia. Nei mesi successivi, la Repubblica Sociale di Mussolini darà la sua piena collaborazione alle razzie. Tutto semplice, apparentemente, per i tedeschi. Con le autorità di Salò che si sono assunte la gran parte del lavoro sporco degli arresti, i fascisti sembrano essersi perfettamente allineati alla politica di sterminio voluta da Hitler. Ogni fascista, ogni probo cittadino della Repubblica, quindi, dovrebbe partecipare alla «caccia all’ebreo», o almeno denunciare alle autorità questi nemici della Patria, soprattutto in un momento critico come quello della guerra.
Lo Schindler italiano
Ma la storia non è mai semplice e lineare. Non sono pochi i fascisti che, invece di denunciare gli ebrei, decidono che l’antisemitismo è una aberrazione, che la deportazione di intere famiglie verso i campi di sterminio è un crimine orrendo, che quei «nemici della Patria» devono essere aiutati. Sono fascisti, o almeno lo sono stati, ma questa storia è troppo orrenda per obbedire agli ordini del Duce.
Il caso di Giorgio Perlasca, l’italiano che nel 1944 si finse console spagnolo a Budapest e salvò migliaia di ebrei ungheresi dalla deportazione, è sicuramente il caso più noto di un «Giusto fra le nazioni» fascista. Un fascista, cioè, che mise da parte ogni convinzione ideologica e, rischiando di persona, decise di comportarsi come la sua coscienza di persona perbene gli imponeva. Il caso Perlasca, grazie soprattutto al libro di Enrico Deaglio La banalità del bene (Feltrinelli 1991), e alla successiva fiction televisiva, è diventato giustamente famoso all’inizio di questo secolo, ma non è stato il solo. Furono più di quanti non si pensi quei fascisti che, come Perlasca, decisero di mettere a repentaglio la propria libertà e la propria vita per salvare dalle razzie naziste gli ebrei in fuga.
Uno di questi è il conte Vaselli, un grande imprenditore edile romano che con il fascismo aveva fatto fortuna. Un uomo di fiducia per il regime. Sono passati solo pochi giorni dalla grande razzia del 16 ottobre, e migliaia di ebrei romani sono disperatamente alla ricerca di un rifugio. Alcuni lo trovano nei conventi, altri presso amici cattolici, ma molti non hanno questa fortuna. Soprattutto i maschi sono difficili da nascondere, specialmente quelli in età militare. Sono molto pochi coloro che se la sentono di dargli un rifugio.
Anche Vaselli potrebbe serenamente continuare a fare affari con i nazifascisti e ignorare i loro crimini, ma non lo fa. In via delle Zoccolette, nel pieno centro di Roma, la sua ditta sta costruendo un grande condominio. Vaselli si mette d’accordo con un ex ufficiale del carabinieri, il capitano Jurgens, per nascondere in quell’edificio ancora disabitato una cinquantina di ebrei. Vaselli ci mette lo stabile, cibo e coperte, mentre Jurgens ha il compito di organizzare la vigilanza, con alcune vedette che, ufficialmente, sono state assunte dall’impresa del conte come guardiani notturni.
Il conte se la cava
Tutta l’organizzazione viene smantellata dalla polizia italiana nel gennaio del 1944. Vaselli, interrogato in questura, è costretto ad ammettere di sapere della presenza di persone nel suo stabile, ma si difende dicendo di aver voluto ignorarli per motivi «umanitari». È una dichiarazione palesemente falsa, come testimoniato nel dopoguerra da una famiglia di ebrei che ha trovato rifugio nello stabile di via delle Zoccolette, ma necessaria per evitare di finire nelle galere naziste. Grazie anche alla evidente complicità dei poliziotti italiani, che fingono di credere alle scuse di Vaselli, il conte se la cava, e con lui anche alcuni dei «suoi» ebrei.
Un altro caso è quello di Vittorio Tredici, ex segretario federale del Pnf a Cagliari che, sempre a Roma, nasconde una famiglia ebrea per tutto il periodo dell’occupazione. Sottoposto al procedimento di epurazione, nel dopoguerra, Vittorio Tredici esibisce davanti ai giudici la testimonianza di Rodolfo Funaro, il quale testimonia che: «particolarmente durante una irruzione nella propria abitazione da parte delle SS tedesche fummo ricoverati presso l’abitazione del sig. Tredici, che in tal modo espose sé stesso e la propria famiglia al pericolo gravissimo delle rappresaglie dei militi che si trovavano nello stesso caseggiato». Vittorio Tredici, nel 1997, è stato insignito della medaglia di «Giusto fra le nazioni» dello Stato d’Israele.
Raffaele Paolucci, un ex deputato fascista, non ha avuto invece alcun riconoscimento, eppure anche lui si oppose alle deportazioni rischiando di persona. Era un chirurgo, e nella sua clinica privata, durante l’occupazione di Roma, mise in salvo decine di persone, tra le quali almeno cinque ebrei.
Oltre a questi casi, particolarmente clamorosi, dalle carte d’archivio spuntano ogni tanto documenti davvero singolari, come lettere di fascisti che chiedono a Mussolini di intercedere in favore di ebrei deportati. In una di queste, firmata da un gruppo di fascisti di Alassio, si legge: «Una povera vecchia [ebrea] di 68 anni, senza figli, vedova e con disturbi al cuore, è stata arrestata dai Carabinieri Repubblicani di Alassio sin dal 7 dicembre 1943 e messa in carcere ad Albenga». Dopo aver lungamente sottolineato le benemerenze fasciste della signora, la lettera conclude «Duce, non dovrebbe essere questo, non può succedere questo!». Senso di giustizia
Ha dell’incredibile che nell’autunno del 1943, in piena occupazione tedesca, dei fascisti firmino una lettera di questo genere, così come sembra incredibile che tanti ebrei abbiano dovuto la loro salvezza a dei fascisti. Tuttavia, davanti a tanta sofferenza, all’enormità delle deportazioni degli ebrei dall’Italia, di cui moltissimi sapevano la fine, anche alcuni fascisti, per quanto ideologicamente convinti, trovarono il coraggio di opporsi. Un ventennio di dittatura, e anni di propaganda antisemita, non erano riusciti a cancellare il senso di giustizia di «uomini comuni», ma straordinariamente coraggiosi.
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
-
> LA STELLA DEL DESTINO? "LUCIFERO!". -- Margherita Sarfatti. La donna che inventò Mussolini. Nota di "Archivio Storico".22 maggio 2017, di Federico La Sala
STORIA D’ITALIA. STATO E CHIESA - E STORIA DELLE DONNE (’SCONOSCIUTE’)...
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
SCHEDA *Margherita Sarfatti. La donna che inventò Mussolini
Roberto Festorazzi
Margherita Sarfatti. La donna che inventò Mussolini
Angelo Colla Editore, pagg.432, Euro 22,00
IL LIBRO - Questa biografia di Margherita Sarfatti, letterata di origini ebree veneziane, amante e consigliera politica di Mussolini, si basa su una duplice inedita documentazione: il memoriale autobiografico, retrospettivo e autocritico intitolato My Fault, scritto dalla Sarfatti in lingua inglese nel 1943-44, e le carte dell’archivio privato del barone Werner von der Schulenburg, soprattutto il dossier “Papen Kreis”.
Il libro restituisce alla Sarfatti tutta la sua dimensione di intellettuale mitteleuropea e di figura femminile intrigante e polimorfa, capace sia di garantire al Duce appoggi nell’alta finanza, sia di fornire di lui un’immagine rassicurante all’estero e negli ambienti delle élite culturali. Rivela anche il ruolo da lei svolto, a livello internazionale, nella seconda metà del 1933, per favorire una successione a Hitler alla cancelleria di Berlino.
Infine l’inedito My Fault ci restituisce anche l’esatta figura umana e psicologica di Mussolini e ci rivela aspetti ed episodi della sua vita finora sconosciuti, come, ad esempio, quello della sifilide da lui contratta in gioventù o del precoce, e sembra temporaneo, consumo di cocaina.
DAL TESTO - “Tra il 1928 e il 1929 Margherita Sarfatti si accostò alla religione cattolica. Nonostante questa conversione sia data ormai per assodata dagli storici, più complicato è invece il discorso che riguarda il suo battesimo. Lo scrittore Sergio Marzorati, nel dopoguerra amico della Sarfatti, ritiene che l’amante del Duce avesse ricevuto il sacramento di iniziazione alla fede cristiana da padre Pietro Tacchi Venturi, gesuita e confessore ufficiale di Mussolini. Dopo la svolta della politica concordataria, infatti, l’autocrate di Predappio aveva deciso di procedere a un lifting d’immagine, sposando il regime con l’altare. La confessionalizzazione del fascismo, naturalmente, procedette sotto la spinta della ragion di Stato e anche Margherita Sarfatti volle adeguarsi diventando, con un gesto riservato, cattolica romana. Per la verità, un po’ papista lo era stata, per ragioni familiari, anche a Venezia, dove suo padre, Laudadio Grassini, era stato molto vicino al patriarca Giuseppe Sarto, futuro Pio x.
“Sta di fatto, però, che l’atto di battesimo di Margherita non si trova: né presso il vicariato di Roma, né presso la curia generalizia dei gesuiti di Borgo Santo Spirito, e neppure nella parrocchia di San Marco, vicina a Palazzo Venezia o in quella di San Giuseppe comprendente la via Nomentana dove la Sarfatti abitava. Ci resta solo un indizio per ritrovare la data eventuale del battesimo. Dalle agende di padre Venturi, si evince infatti che il 31 dicembre 1929, alle 11.30, il gesuita varcò la soglia di casa Sarfatti. Potrebbe essere stata quella la circostanza dall’amante del Duce per ricevere, senza alcuna pubblicità, il battesimo?”.
L’AUTORE - Roberto Festorazzi, laureato in Scienze politiche, giornalista professionista, si occupa prevalentemente di storia contemporanea. Consulente storico dell’Istituto Luce e della Televisione svizzera, ha scritto e scrive per numerosi quotidiani e settimanali, tra cui Il «Giornale», «Il Messaggero», «Il Mattino», «Il Riformista», «La Repubblica», «La Stampa, «Panorama», «Liberal», «Gente», «Corriere del Ticino» e «Libero».
INDICE DELL’OPERA - Ringraziamenti - Introduzione - Parte prima - I. Il giardino veneziano - II. Milano, Boccioni, il Soldo - III. Benitouchka - IV. Il mistero del "mal francese" - V. La lue del Duce: genesi di una rimozione - VI. Il sacrificio di Roberto - VII. La nascita di Novecento - VIII. La "Vela" della rivoluzione - IX. Il maestro e Margherita - X. La "signorina Rachele" - XI. Il caso Matteotti - XII. Il re dice "no" - XIII. Al capezzale del presidente - XIV. Il mito del Dux - XV. Il dittatore illuminato - XVI. La conversione di Margherita - XVII. Dittatrice della cultura - XVIII. Il carteggio D’Annunzio-Sarfatti - Parte seconda - I. Entra in scena il barone Schulenburg - II. La Sarfatti antisionista - III. Renzetti, l’ambasciatore ombra - IV. Il Führer visto da vicino - V. «Quel barone è una spia» - VI. Le convulsioni di Weimar - VII. Hitler al potere - VIII. Schulenburg e Schleicher - IX. Le prime misure antisemite - X. Il Patto a Quattro - XI. Il siluro a Balbo - XII. Jabotinsky e il fascismo: un’attrazione fatale - XIII. Le carte del «Papen Kreis» - XIV. La "grande manovra" di von Papen - XV. La diplomazia parallela di Margherita - XVI. Colloqui segreti a Saint Moritz - XVII. La missione esplorativa di Schulenburg a Parigi - XVIII. Intermezzo a Ginevra - XIX. La seconda missione francese - XX. Gli incontri romani - XXI. La spia italiana e la retromarcia di von Papen - XXII. L’agente da Londra - XXIII. La notte dei lunghi coltelli - XXIV. Il crollo delle illusioni - XXV. Un tè con Roosevelt - XXVI. La guerra d’Etiopia - XXVII. Un monumento per Roberto - XXVIII. La madrina dell’Asse - XXIX. L’oro di Suez - XXX. Nerone a Palazzo Venezia - Parte terza - I. Esilio amaro - II. «Cara Margherita, io vorrei ...» - III. "Mea culpa" - IV. Perché non fu pubblicato il memoriale segreto - V. Il flirt con Werner - VI. La leggenda del buonuomo Mussolini - VII. «Quella notte ho conosciuto il demonio» - VIII. Cocaina per il Duce - IX. Ostracismo contro la "socialfascista" - X. Il mistero delle lettere scomparse - XI. L’ultimo giorno di Margherita - Bibliografia
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
-
> LA STELLA DEL DESTINO? "LUCIFERO!". MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO DELLA ROMANITÀ. -- Sarfatti Margherita (1880 - 1961). Nota biografica di Alessandro Campi.17 maggio 2017, di Federico La Sala
Dalla prima guerra mondiale al secondo dopoguerra (1915-1950) »
Sarfatti Margherita 1880 - 1961 *
di Alessandro Campi *
Le donne di Mussolini (non le decine o centinaia oggetto di fugaci appetiti erotici e di effimere frequentazioni mondane, ma quelle che hanno realmente contato qualcosa nella sua esistenza di uomo sessualmente bulimico, sentimentalmente distratto, culturalmente vorace e politicamente ingeneroso), hanno tutte assolto, a ben vedere, una funzione archetipica, come tale essenziale per comprenderne la complessa parabola umana e politica.
Donna Rachele, ad esempio, con i suoi modi solo apparentemente bonari e contadini, con la pazienza rassegnata e complice di un personaggio degno della miglior tragedia greca, ha giocato, agli occhi di un’intera nazione rimasta nel suo fondo tradizionale e conformista a dispetto di futurismi meccanici e superomismi dannunziani, il ruolo esemplare di madre e moglie: ha dunque rappresentato l’ancoraggio ai valori e alle certezze della vita quotidiana per un uomo invece costituzionalmente votato all’irrequietezza, privo di punti fermi, incapace di solidi rapporti affettivi, emotivamente instabile.
Edda, la figlia devota e ribelle, ha duplicato, nella cornice mondana e rutilante di un’Italia incamminatasi a tappe forzate sulla strada della modernità e della potenza, il rifiuto delle convenzioni borghesi, l’immediatezza di carattere, gli slanci ed i colpi di testa, le insoddisfazioni esistenziali, il gusto della trasgressione, di chi, giunto al potere assoluto, aveva comunque mantenuto un fondo anarchico, un’intima insofferenza per i formalismi e l’etichetta, un animo popolare e grossier.
La rivoluzionaria ucraina Angelica Balabanoff è stata, con le sue predicazioni e lezioni, la maestra di vita politica, colei che, per bocca dello stesso Mussolini, di un rivoluzionario della domenica, appassionato ma confusionario, aveva fatto un politico di professione, un pragmatico non insensibile alle idee ed alle credenze.
L’anarchica ed eccentrica Leda Rafanelli, sebbene per una breve stagione, nei tempi difficili della scelta interventista, ha costituito, per Mussolini, una sorta di prezioso rifugio sentimentale e politico, un’evasione all’insegna dell’esotismo, della coerenza a quei sentimenti anticlericali, libertari e nicciani ormai sempre più inconciliabili con la sua scelta per la politica attiva e che tuttavia sarebbero rimasti sempre al fondo dei suoi pensieri, come una sorta di ancoraggio sentimentale, ineffettuale ma rasserenante.
Claretta Petacci, l’amante per eccellenza, ha invece incarnato la passione e la fedeltà estreme, la disponibile procacità delle donne italiane tanto desiderata ed ammirata dal maschilismo fascista, la giovinezza conturbante di chi si concede, senza imbarazzi, per dovere nazionale, al più maschio dei maschi al solo fine di compensarne il talento, la probità e il quotidiano impegno di statista,
Margherita Sarfatti, infine, tra tutte la più importante delle donne di Mussolini, è stata qualcosa a metà strada tra la musa e il demiurgo, colei che per circa un ventennio lo ha guidato (con indubbia intelligenza e non senza calcolo) nel labirinto della modernità culturale: fornendo al fascismo ed al suo capo, entrambi nati, politicamente, tra la piazza e le trincee, un disegno di politica artistico-culturale coerente ed ambizioso, all’altezza della sfida storica da essi rappresentata; inoculando nel Mussolini divenuto ormai duce, passioni, come quella per la romanità, che alla lunga si sarebbero rivelate politicamente assai pericolose; suggerendogli la chiave per fare del suo movimento-regime una realtà non solo politica, ma una vera e propria rivoluzione culturale ed un’alternativa di civiltà; alimentandone, con la biografia Dux (apparsa nel 1926: diciassette edizioni in Italia e traduzioni in diciotto lingue), la retorica agiografica, il mito pubblico ed il culto devozionale; adottando, attraverso salotti letterari, mostre, cenacoli e riviste, strategie di conquista e seduzione del potere intellettuale di una assoluta efficacia (artisti e letterati organici al potere: una delle tante eredità che il fascismo ha lasciato alla repubblica).
Ma non è storicamente ingeneroso fare della Sarfatti, secondo un cliché molto abusato, solo una delle donne del duce? La sua storia intellettuale presenta in effetti un “prima” e un “dopo” Mussolini, comunque ricco di avvenimenti, personaggi, idee e passioni. Giovane ebrea conquistata alla causa del socialismo, la Sarfatti (nata a Venezia l’8 aprile 1880 da una ricca famiglia patrizia, quella dei Grassini), comincia ad esercitare la critica d’arte poco più che ventenne. Sposata nel 1898 con Cesare Sarfatti, avvocato, nel 1902 si trasferisce col marito a Milano, dove frequenta Turati e la Kuliscioff e dove stringe amicizia con Ersilia Majno, all’epoca presidente della Lega femminista milanese.
Qui, forte di una solidissima posizione economica che contrasta non poco con la sua adesione alla causa dei lavoratori, comincia dapprima ad animare un vivace salotto politico-artistico-letterario, e successivamente a scrivere con regolarità, di arte ma anche ben presto di politica, su fogli e giornali d’area soprattutto socialista. Quando, nel dicembre 1912, incontra per la prima volta Mussolini, nel frattempo divenuto direttore dell’Avanti!, è dunque già ben inserita nel dibattito politico-culturale.
Del pari, anche dopo la rottura col suo amante-allievo (databile al 1931) ed il suo obbligato allontanamento dall’Italia (nel novembre 1938 a causa delle leggi razziali), la Sarfatti mantiene comunque un suo profilo intellettuale, seppure declinante e per molti versi volutamente basso.
Durante il suo esilio in Sud America scrive dunque sui giornali (tra l’altro, nel 1945, sulla Critica di Buenos Aires, un reticente Mussolini: comò lo conocì) e pubblica libri. E anche dopo il suo ritorno in Italia, nel luglio 1947, coltiva ancora letture ed amicizie (poche e selezionate, giacché molti dei suoi antichi protetti e sodali le voltano poco elegantemente le spalle), dà alle stampe articoli e volumi (tra i quali, nel 1955, un’autobiografia, Acqua passata, nella quale la parola fascismo ricorre una sola volta e Mussolini è del tutto assente, a dimostrazione di come nella mente di questa intellettuale cosmopolita e raffinata quella accanto al duce potesse davvero essere considerata, in sede di bilancio finale, una parentesi o poco più, un episodio tra gli altri della sua ricca esistenza mondana).
In realtà, senza fascismo e senza Mussolini la Sarfatti non sarebbe assurta, come invece le è capitato, a simbolo non secondario di un secolo pazzo e contraddittorio, non privo di una sua tragica grandezza, durante il quale l’ideale di un’arte non al servizio del potere, ma capace di esprimerne l’essenza spirituale, la natura profondamente innovativa e le ambizioni palingenetiche, ha trovato il modo di concretizzarsi attraverso l’esperienza dei totalitarismi e, nel caso di quel lo italiano, nel modo senz’altro più originale e creativo.
Cosa sarebbe stata l’esperienza del gruppo del Novecento (personalità come Sironi, Funi, Casorati, Wildt) se la Sarfatti non si fosse messa in testa di farne l’espressione di punta di una rivoluzione al tempo stesso estetica e politica, caratterizzata, esattamente come il fascismo (anch’esso, nelle intenzioni, una rivoluzione al tempo stesso estetica e politica), dalla sintesi tra valori tradizionali e spirito d’avanguardia, tra classicità e modernismo?
Cosa sarebbe stata la sua idea di un rinnovamento della tradizione artistica italiana nel segno della modernità post-futurista se essa non avesse incontrato l’ambizione mussoliniana di un rinnovamento della cultura politica italiana nel segno di quella che è stata definita la “modernità totalitaria”?
Questa confluenza d’intenti e di aspirazioni spiega il rango ufficiale riconosciuto a partire dal ‘22 alla Sarfatti: collaboratrice assidua del Popolo d’Italia, direttore dell’influente Gerarchia, ispiratrice di mostre ed eventi culturali (in Italia ed all’estero), tramite, per conto del regime, con la stampa estera (in particolare quella statunitense) e con gli ambienti più accreditati della cultura internazionale. Un ruolo, quello della Sarfatti nel settore artistico, ricoperto attivamente e quasi monopolisticamente sino almeno al 1930-1931, con una singolare somiglianza, cronologica e di funzioni, con il ruolo assolto, sul versante filosofico, da Giovanni Gentile.
Dopo essere stati egemoni nei rispettivi campi, entrambe le loro stelle cominceranno a declinare a partire dai primi anni Trenta, in coincidenza con i nuovi orientamenti mussoliniani, con il mutato clima politico e con il diverso assetto del regime, incamminatosi lungo la strada della militarizzazione della vita civile e dell’irrigidimento totalitario. Dopo un progressivo oblio, reso ancora più acuto dall’ostilità alle sue idee, ottusa e di antica data, mostrata da alcuni gerarchi, Farinacci su tutti, sarà il varo della legislazione antisemita a costringere la Sarfatti (che nel frattempo s’era comunque convertita al cattolicesimo) al passo estremo dell’esilio ed alla conclusione della sua avventura politico-culturale al fianco del fascismo.
Non c’è grandezza senza risvolti che ai posteri appaiono inevitabilmente meschini. Negli ultimi anni della sua vita (sarebbe morta, pressoché dimenticata, il 30 ottobre 1961) la Sarfatti si impegnò - un po’ per spirito di vendetta, un po’ perché oppressa dal fantasma della ristrettezza economica, un po’ a causa di una certa avidità e di uno spirito affaristico che tanto, all’epoca, avevano infastidito il duce - in una estenuante trattativa per la vendita al miglior offerente della sua corrispondenza con Mussolini.
Dopo vari maneggi e annunci sulla stampa, dell’affare non si fece comunque nulla: quelle lettere rimasero inedite. Segno, forse solo involontario e casuale, di un legame, quello tra il dittatore e la sua musa-demiurgo, rimasto segretamente vincolante e quindi tutt’altro che effimero o occasionale, legame che agli occhi degli storici odierni continua ad apparire indicativo di una stagione della storia politico-culturale italiana tra le più drammatiche e, nella sua drammaticità, tra le più esaltanti e controverse.
*
MARGHERITA SARFATTI. Scheda biografica di Alessandro Campi
-
> LA STELLA DEL DESTINO? "LUCIFERO!". MARGHERITA SARFATTI -- I bestseller del ventennio. Il regime e il libro di massa (Gigliola De Donato e Vanna Gazzola Stacchini).17 maggio 2017, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
BEST SELLER IN NERO
di Enzo Forcella *
Da qualche parte, nella cantina dei ricordi rimossi, conservo ancora le emozioni che mi suscitarono i romanzi "erotici" di Guido Da Verona, Mario Mariani, Umberto Notari, Pitigrilli. E quelle dei romanzi "mondani" di Luciano Zuccoli e Lucio D’ Ambra. Senza dimenticare l’oscuro fascino suscitato dal Dux di Margherita Sarfatti o dalle aperture esotiche dei libri di viaggio di Arnaldo Cipolla e Mario Appelius.
Sono i libri, comprensibilmente ignorati da ogni storia della letteratura italiana contemporanea, che per gli uomini della mia generazione (quella che più o meno aveva vent’ anni all’ inizio della guerra) hanno segnato il passaggio dalle letture dell’ infanzia a quelle dell’ adolescenza, l’ ingresso nel mondo dei "grandi". E sono anche i primi libri di successo della nascente industria culturale, con le prime (relativamente) alte tirature, le prime tecniche di diffusione pubblicitaria "all’ americana", le prime copertine "strillate" con una raffinatezza grafica sino allora ignota alla nostra editoria.
Un tormentato eros
Di fronte all’ ampia e succosa antologia che gli hanno dedicato Gigliola De Donato e Vanna Gazzola Stacchini (I bestseller del ventennio - Il regime e il libro di massa Editori Riuniti, pagg. 730, L. 90.000), la prima tentazione è di rileggere queste pagine come un ironico e lievemente nostalgico "amarcord" del tempo fascista. Ma è una tentazione dalla quale le autrici, con un rigore sin troppo accigliato, subito ci distolgono.
Il tentativo di sistemazione di un materiale estremamente vasto ed eterogeneo - spiegano - "ci ha indotto a individuare aspetti e linee di tendenza che fanno emergere, se non una calcolata strategia editoriale, quanto meno l’ intenzione del fascismo di fare del libro di massa, anche di genere inferiore, uno strumento fondamentale di persuasione, di controllo, di propaganda destinato a un pubblico sociologicamente differenziato ma di fatto omologato dalla sostanziale uniformità dei messaggi". (La materia è stata suddivisa in cinque sezioni affidate a Tina Achilli, Silvana Ghiazza, Maria Pagliara oltre che alle due curatrici e a Ermanno Detti che presenta un’ ampia scelta di copertine dell’ epoca).
Per qualche autore la griglia risulterà eccessivamente totalizzante. Il tormentato eros di Mario Mariani, il suo rifiuto dei valori e dell’ universo borghesi sono autenticamente fuori quadro. Anche a prescindere dal suo ribellismo anarchico e dalle incessanti persecuzioni cui lo sottopone il regime, è difficile omologarlo al caramelloso edonismo di Zuccoli, al decadentismo postdannunziano di Da Verona, al frivolo cinismo di Pitigrilli. (Finito, quest’ ultimo, prima spia dell’ Ovra e poi apologeta della più stucchevole ortodossia cattolica). Nel complesso, però, la griglia tiene.
Nella stessa letteratura rosa, strutturalmente metastorica, impermeabile ai diversi regimi politici in cui si trova ad operare, Silvana Ghiazza ha buon gioco a identificare temi e motivi che il fascismo, anche se non inventa, si affretta a potenziare: il nazionalismo, la celebrazione dei fasti italici e romani, l’ esaltazione della maternità come appendice essenziale e obbligata del lieto fine, l’ erotismo sublimato e redento dalla sacralità del matrimonio cui rimane finalizzato. L’ altro versante, solo apparentemente antitetico, è quello delle sezioni dedicate alle biografie del duce, ai romanzi coloniali e a quelli di aperta propaganda fascista. (Non è il caso, di fronte alla modestia dei risultati, di parlare di "ispirazione", neppure per gli autori più dignitosi: il primo Brancati, Malaparte, Marcello Callian, Ugo Ojetti).
Qui, per la verità, ci sarebbe da verificare se questi titoli possano essere davvero classificati nella categoria dei veri bestseller. Più venduti, certo, nel senso che gli si assicurano alte tirature e l’ acquisto da parte di tutte le biblioteche provinciali, dei dopolavoro, delle sedi rionali del Fascio e delle altre istituzioni del regime. Che poi siano stati effettivamente letti e apprezzati, questo è tutto da vedere. Ma hanno ricevuto premi, provocato recensioni e discussioni influendo così, sia pure artificiosamente, nel clima culturale dell’ epoca.
Comunque, nell’ assenza di dati certi sulle effettive dimensioni del mercato editoriale, valeva la pena di indagarne contenuti e intenzioni: come fa, ad esempio, con molta finezza e rigore, Vanna Gazzola Stacchini nella sezione dedicata ai "mille eroi della leggenda", ovvero ai romanzi con protagonisti e ambienti esplicitamente fascisti.
La struttura è sempre la stessa: c’ è un mito da diffondere - quello di un paese dove per merito del fascismo sono scomparsi per sempre tutti i contrasti di natura sociale, la miseria, la violenza, l’ inimicizia - e dei protagonisti che, secondo lo schema ottocentesco delle coppie oppositive, raffigurano la dinamica del passaggio dal vecchio al nuovo, dal disordine all’ ordine, dalla condizione dell’ uomo solo inquieto e senza scopi a quella della adesione alla comunità, della rassicurante immersione nella folla.
Di qui l’ importanza centrale che in tutti questi romanzi assume il rituale dell’ adunata, dai momenti minori che la precedono sino al momento in cui parla Lui, il Duce, il Grande Timoniere. Non importa che spesso non si riesca a cogliere il senso delle sue parole, basta che esse empiano la grande piazza silenziosa a "ondate di sonorità metallica" come scrive la vincitrice di un concorso per il miglior romanzo dell’ età fascista. "Non si vuole l’ appello alla ragione né dunque si richiede la funzione referenziale del linguaggio; si vuole produrre una specie di perdita dei sensi per meglio recepire, e farsi riempire, dal messaggio divino".
La rassegna si ferma alla prima metà degli anni Trenta ed è un peccato perché così rimane fuori quella seconda ondata di bestsellers che segnerà una svolta nella nostra industria culturale e, con essa, negli orientamenti culturali degli italiani. Sono gli anni della "Medusa" e degli "Omnibus" Mondadori, degli einaudiani "Narratori stranieri" e, parallelamente, della scoperta dei "Gialli", della "rivoluzione dei rotocalchi". Persino i "Rosa", con l’ entrata in scena di Liala, si aprono timidamente alle prime avvisaglie della modernizzazione.
Nuovi autori, soprattutto stranieri, nuovi linguaggi, nuove curiosità che penetrano nelle case come frutti proibiti, turbano le apparenti certezze delle masse, aprono inediti orizzonti culturali, mettendo così in crisi l’ edificio della cultura autarchica faticosamente innalzato nel decennio precedente.
Gigliola De Donato, nella introduzione generale, segnala la svolta, ma spiega di averla intenzionalmente lasciata fuori "perché avrebbe reso indecisa la linea della nostra ricerca che vuole essere mirata al rapporto solidale e omogeneo che si era stabilito tra il fascismo e una certa letteratura di successo".
Propaganda martellante
E’ un criterio discutibile perché, come del resto riconosce la stessa De Donato, proprio in quegli anni il rapporto solidale e omogeneo comincia a incrinarsi e si pongono le premesse culturali di quello stato d’ animo di indifferenza, stanchezza, fronda diffusa con cui la società italiana, e in particolare i giovani, vivrà la tragica avventura della guerra. Forse è opportuno, come del resto consiglia ormai anche la maggior parte degli storici, accostarsi al ventennio mussoliniano in un’ ottica non troppo rigidamente "fascistocentrica".
Anche e soprattutto per quanto riguarda la politica culturale. Il regime coglie tempestivamente le potenzialità della nascente industria culturale e fa l’ impossibile per trasformarla in un mastodontico strumento di indottrinamento di massa. I risultati che raccoglie sono tuttavia piuttosto modesti. Controllo assoluto, propaganda martellante, consenso ambiguo e incerto. E’ significativo, oltre alla dubbia accoglienza dei romanzi di aperta esaltazione fascista, il clamoroso insuccesso, come lo definisce Maria Pagliara curatrice dell’ apposita sezione, dei romanzi coloniali. "Passano" soltanto, o soprattutto, i messaggi della ideologia culturale conservatrice piccolo-medio borghese: gli stessi che il fascismo aveva raccolto dalla letteratura di consumo della Terza Italia e che sopravviveranno alla sua fine almeno sino alla seconda metà degli anni Cinquanta.
ENZO FORCELLA
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
-
> LA STELLA DEL DESTINO? "LUCIFERO!". MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO -- Fatima, una storia tra fede e politica (di Marco Roncalli)13 maggio 2017, di Federico La Sala
Fatima, una storia tra fede e politica
Il contesto nazionale, la restaurazione cristiana del Portogallo, il conflitto mondiale, la guerra fredda, il Concilio, la decolonizzazione
di MARCO RONCALLI (La Stampa, 10/05/2017)
Roma. Un culto che prima si afferma a livello nazionale e poi si dilata nel mondo per un secolo conquistando fedeli, vescovi, Papi. E tutto che inizia con tre pastorelli analfabeti - Jacinta, Francisco e Lúcia -e il racconto dell’ apparizione di una “signora vestita di bianco”: che il 13 maggio 1917 li invita a dire il rosario per i peccatori e la fine della guerra; il 13 giugno ripete l’invito ed esorta Lúcia a imparare a leggere; il 13 luglio torna a chiedere preghiere per la fine della guerra, promettendo un miracolo entro tre mesi e rivelando loro un “segreto”; il 13 agosto dice di usare le donazioni per il culto; il 13 settembre insiste sulla preghiera per la fine del conflitto e chiede una cappella a Fatima; il 13 ottobre - ultima apparizione, durante la quale si verifica un fenomeno solare (il miracolo promesso?) - rivela come richiesta della Madonna del Rosario preghiere e penitenze, garantendo un rapido rientro dei soldati a casa.
Fermandosi solo sulle relazioni coeve alle apparizioni del ‘17, con le risposte semplici dei tre bambini, considerando che la guerra cessò solo alla fine del ‘18, non è facile capire la devozione popolare concentratasi subito su Fatima.
 E forse ha ragione José Barreto nel suo saggio “I messaggi di Fatima tra anticomunismo, religiosità popolare e riconquista cattolica” pubblicato da poco su “Memoria e Ricerca” del Mulino, ad allargare lo sguardo anche alla cornice storica e socio-politica. Proviamo a seguirlo.
E forse ha ragione José Barreto nel suo saggio “I messaggi di Fatima tra anticomunismo, religiosità popolare e riconquista cattolica” pubblicato da poco su “Memoria e Ricerca” del Mulino, ad allargare lo sguardo anche alla cornice storica e socio-politica. Proviamo a seguirlo.«Con Fatima - scrive - si aprì un canale di comunicazione con il sovrannaturale in un periodo tormentato della storia contemporanea portoghese, iniziato con la rivoluzione repubblicana del 1910 durante il quale si era verificata la maggiore offensiva contro la Chiesa mai registrata nel Paese». Chiesa che nel precedente periodo del costituzionalismo monarchico (1834-1910), pur con il cattolicesimo come religione di Stato, aveva vissuto una situazione definita da Manuel Clemente «una gabbia e nemmeno dorata».
 È dunque un periodo particolare quello che vede la diffusione dei messaggi di Fatima: di guerra, e in Portogallo di guerra di religione. Con una imperante laicizzazione della società che vede scuole cattoliche chiuse, preti detenuti, beni ecclesiastici nazionalizzati, aule di culto e seminari trasformati in uffici pubblici, e vescovi importanti accusati di comportamenti contrari alle leggi e spediti in esilio persino durante le apparizioni del settembre e ottobre ’17.
È dunque un periodo particolare quello che vede la diffusione dei messaggi di Fatima: di guerra, e in Portogallo di guerra di religione. Con una imperante laicizzazione della società che vede scuole cattoliche chiuse, preti detenuti, beni ecclesiastici nazionalizzati, aule di culto e seminari trasformati in uffici pubblici, e vescovi importanti accusati di comportamenti contrari alle leggi e spediti in esilio persino durante le apparizioni del settembre e ottobre ’17.
 «Il tentativo di connotare politicamente Fatima era inevitabile, e iniziò immediatamente a partire dal 1917», ha scritto Barreto. Aggiungendo: «I repubblicani denunciarono lo sfruttamento della “superstizione” popolare da parte delle forze anti-repubblicane; quest’ultime interpretarono le apparizioni della Vergine come le precorritrici del “miracolo” dello schiacciamento della “serpe giacobina“ riferendosi al colpo di Stato del dicembre 1917 di Sidonio Pais che destituì i repubblicani radicali e instaurò un regime presidenzialista terminato nel dicembre successivo».
«Il tentativo di connotare politicamente Fatima era inevitabile, e iniziò immediatamente a partire dal 1917», ha scritto Barreto. Aggiungendo: «I repubblicani denunciarono lo sfruttamento della “superstizione” popolare da parte delle forze anti-repubblicane; quest’ultime interpretarono le apparizioni della Vergine come le precorritrici del “miracolo” dello schiacciamento della “serpe giacobina“ riferendosi al colpo di Stato del dicembre 1917 di Sidonio Pais che destituì i repubblicani radicali e instaurò un regime presidenzialista terminato nel dicembre successivo».Se si può convenire che, nella regione di Fatima, nei confronti dell’offensiva antireligiosa non ci fu allora una vigorosa resistenza cattolica, né ci fu un immediato consenso del clero sulle apparizioni, così come non è corretto indicare in quel periodo una correlazione tra apparizioni e militanza antirepubblicana, successivamente invece, la trasformazione di Fatima in una “Lourdes portoghese” finì per riflettere nei fatti un’opposizione allo spirito della repubblica atea e massonica. Senza dimenticare che le apparizioni potevano leggersi come un segno di salvezza per un Paese preda di angosce con le sue truppe in trincea a fianco dell’Intesa, preda di incertezze per la scarsità di beni primari e via dicendo.
Detto questo, restando sul fronte politico, è indubbio che è il golpe militare del dicembre ‘17 a riportare la riappacificazione tra il governo e la Chiesa e il riallacciamento delle relazioni diplomatiche con il Vaticano: che avranno pienezza con la dittatura militare (1926-1933) e larga parte dell’ Estado Novo (1933-1968 con Salazar e 1968-1974 con Caetano nel segno delle “tre F”: fado, futbol, Fatima . Ed è solo in questo arco cronologico che pare convincente l’affermarsi di una connotazione anche ideologica - in chiave anticomunista - dei messaggi mariani. Del resto l’ufficializzazione del culto di Fatima passò attraverso tutte le indagini canoniche avviate nel 1922 e concluse ben otto anni dopo con il riconoscimento formale del carattere sovrannaturale dei fatti, mentre in attesa del verdetto si registrarono un impegno del clero nella ricostruzione ufficiale della storia delle apparizioni, una vasta propaganda sulla stampa cattolica, visite importanti, e persino - dopo che Benedetto XV non si era mai pronunciato - la “indiretta approvazione” di Fatima da parte di Pio XI che nel 1929 benedice una statua della Vergine di Fatima arrivata dal Portogallo al Pontificio Collegio Portoghese di Roma. Lo stesso Pio XI di cui il cardinale Confalonieri che era stato suo segretario riportava questa frase a proposito di mistiche che gli inviavano lettere su lettere circa rivelazioni di Maria: «...Se ha qualcosa da farmi sapere, potrebbe dirlo a me».
Quando nel 1930 il vescovo di Leiria-Fatima Correia da Silva dichiara le apparizioni «degne di essere credute», morti Francisco e Jacinta, è Lúcia l’unica testimone di esse: entrata nel frattempo tra le Suore dorotee di Porto e inviata in Spagna, nel monastero di Tuy ha continuato ad avere visioni e locuzioni interiori (nel ’25 la richiesta di diffondere la «comunione dei cinque primi sabati» in riparazione dei peccati) e ha già steso la prima delle sei “Memorie” (1922, 1937, due nel 1941, 1989, 1993, edite in Italia dalla Queriniana con il titolo “Lucia racconta Fatima”, a cura di António Maria Martins) dedicate ai fatti della Cova da Iria e alle rivelazioni. Rivelazioni che, a ben vedere - una volta rese note - palesano intrecci con drammi del XX secolo: dalle guerre mondiali alla parabola della Russia sovietica.
Tra le istruzioni che alla fine del maggio ‘30 Lúcia afferma di aver ricevuto dal cielo - preceduta da un «se non mi sbaglio» - ecco la promessa divina di «porre fine alla persecuzione in Russia se il Santo Padre avesse, insieme a tutti i vescovi del mondo, compiuto un solenne e pubblico atto di riparazione e di consacrazione della Russia ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria». Sino a questo momento, fissato in una lettera al confessore, il gesuita José Bernardo Gonçalves, non si trova alcun riferimento pubblico o privato alla Russia e al comunismo, ma proprio nel febbraio precedente, peggiorate le condizioni di ortodossi e cattolici, congelate le trattative segrete che la Santa Sede aveva provato a tessere con i sovietici, Pio XI pubblicamente aveva chiesto a tutto il mondo cristiano una «crociata di preghiera per la Russia». In ogni caso, come ha osservato Barreto nel saggio citato, «le istruzioni celesti ricevute da Lúcia nel ‘30 non ottennero una grande attenzione dal vescovo di Leiria fino al ‘36, quando il Fronte Popolare prese il potere nella vicina Spagna». E proprio in quel periodo Lúcia accettò la proposta del suo confessore di insistere con il vescovo e il Vaticano sul tema della «consacrazione della Russia», pur rinnovando per scritto il timore di «essersi lasciata illudere dall’immaginazione», o da qualche «illusione diabolica»,come scrisse in due lettere del 18 maggio e 5 giugno 1936.
L’anno dopo, imperversando la guerra civile spagnola, il vescovo di Leiria mette a conoscenza Papa Ratti delle richieste celesti a Lúcia circa la «consacrazione della Russia ai Sacri Cuori di Gesù e Maria» da effettuarsi insieme a «tutti i vescovi del mondo cattolico», e l’approvazione papale della devozione dei «primi sabati», come condizioni per la fine della persecuzione religiosa in Russia. Nella lettera (riportata tra i Novos Documentos de Fátima editi dall’ Apostolado da Imprensa nel 1984), il vescovo ricordava a Pio XI come già nelle raccomandazioni che la Vergine di Fatima aveva fatto nel 1917 fosse chiaro «come Nostra Signora stesse preparando la lotta contro il comunismo», dal quale il Portogallo era stato sino ad allora preservato. Il Pontefice non risponde a questa richiesta (come non rispose ad una analoga richiesta di un’ altra veggente portoghese, Alexandrina da Costa, ai tempi screditata e poi beatificata da Giovanni Paolo II). «Quanto alla consacrazione della Russia al Cuore immacolato di Maria, non è stata fatta nel mese di maggio come lei si aspettava. Si farà certamente, ma non subito», così Lúcia il 15 giugno del ’40 a padre Gonçalves.
Nel frattempo successore di Pio XI è Papa Pacelli. Obbedendo al vescovo di Leiria e di Gurza, Lúcia gli scrive nell’ottobre ’40 collocando per la prima volta la richiesta celeste di consacrazione della Russia nel 1917, come parte del segreto da lei custodito dal 13 luglio di quell’anno (lettera che sarà resa nota pubblicamente solo negli anni ’70).
 Nell’estate del ’41 mentre è in corso l’invasione dell’Urss da parte della Germania, il vescovo di Leiria ordina a Lúcia di redigere una nuova memoria sulla guerra e la Russia. E a questo testo - completato nell’ottobre ’41 - Lúcia affida la versione definitiva delle due prime parti del segreto (la terza parte, redatta nel ’44 e inviata a Roma nel ’57, sarebbe stata divulgata da Giovanni Paolo II nel 2000) che Pio XII rende pubbliche nel ’42, la visione di un pezzo di inferno («un grande mare di fuoco» con immersi «i demoni e le anime») e il messaggio della Vergine sulla consacrazione della Russia («se ascolterete le mie richieste, la Russia si convertirà e avrete pace; diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni....»).
Nell’estate del ’41 mentre è in corso l’invasione dell’Urss da parte della Germania, il vescovo di Leiria ordina a Lúcia di redigere una nuova memoria sulla guerra e la Russia. E a questo testo - completato nell’ottobre ’41 - Lúcia affida la versione definitiva delle due prime parti del segreto (la terza parte, redatta nel ’44 e inviata a Roma nel ’57, sarebbe stata divulgata da Giovanni Paolo II nel 2000) che Pio XII rende pubbliche nel ’42, la visione di un pezzo di inferno («un grande mare di fuoco» con immersi «i demoni e le anime») e il messaggio della Vergine sulla consacrazione della Russia («se ascolterete le mie richieste, la Russia si convertirà e avrete pace; diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni....»).Nel frattempo il testo del “segreto”, integro, per sunto, stralci, con riferimenti alla Russia alterati o tagliati, gira per il mondo. Ed è Pio XII che il 31 ottobre ‘42, data delle nozze d’argento delle apparizioni e della sua consacrazione episcopale, con un radiomessaggio consacra il «genere umano» al Cuore immacolato di Maria, invocata con il titolo di “Regina della pace” (come aveva fatto Benedetto XV). In questa preghiera il Papa si allontanava dalla richiesta precisa della Vergine, ma faceva allusioni alla devozione mariana dei russi «popoli separati dall’errore e la discordia», e alla loro auspicata ricongiunzione «all’unico gregge di Cristo, sotto un unico, vero pastore». Nello stesso testo anche però un riferimento all’intervento celeste grazie al quale la «nave dello stato portoghese «persasi «nella tormenta anti-cristiana e anti-nazionale» aveva ritrovato «il filo delle sue più belle tradizioni che la rendevano una nazione fedelissima» e persino un omaggio anche alla classe politica del cambiamento, definita «uno strumento della Provvidenza». Da non dimenticare che Paolo VI alla chiusura della terza sessione del Vaticano II avrebbe fatto riferimento a questa consacrazione del predecessore inviando con una missione la simbolica rosa d’oro al santuario della Madonna di Fatima.
Non solo. Come ha scritto sulla rivista “Jesus” Alberto Guasco: «Se una rivelazione ex post eventu è manna per critici e avversari, Pio XII mostra invece di prenderla sul serio». Eccolo così promuovere l’istituzione della festa del Cuore immacolato di Maria (1944), far incoronare la Madonna di Fatima regina del mondo (1946), ripetere la consacrazione in una lettera apostolica del 7 luglio 1952. A quella data Pio XII conosce anche la terza parte del segreto ricevuta in busta chiusa dal vescovo di Leiria, ma non ne ha ritenuto opportuna la divulgazione. A quella data le peregrinazioni dell’immagine di Fatima continuano in tutto il mondo e sulla “Piazza Bianca” del santuario si sono già viste scene come quella dell’ottobre 1951: con il noto predicatore americano Fulton Sheen, che davanti a 100mila pellegrini profetizza, come risultato delle preghiere dei milioni di fedeli lì affluiti, la trasformazione del simbolo del martello e della falce in una croce e una luna sotto i piedi dell’Immacolata.
Non tutti però manifestano in quel periodo entusiasmi così accesi. Anzi già dalla fine della guerra, Fatima occupa discussioni fra teologi, avviate da Edouard Dhanis, il gesuita belga che ne ha diviso la storia in due parti - una vecchia sulle testimonianze raccolte nel 1917, una nuova sul corpus originale integrato con i nuovi dati contenuti nelle “memorie”- scrivendo già nel ’44: «Siamo portati a credere che, nel corso degli anni, alcuni eventi esterni e certe esperienze spirituali di Lúcia abbiano arricchito il contenuto originale del segreto». Senza porre in causa la sincerità della veggente, Dhanis osservava che «il modo poco oggettivo in cui nel segreto erano state descritte le cause che avevano provocato la Guerra [mondiale] poteva solo essere spiegato dalla influenza che la Guerra civile spagnola aveva avuto sul pensiero di Lúcia». -In effetti, il segreto imputava alla Russia tutta la responsabilità per le guerre e le persecuzioni verso la Chiesa, seppure all’interno di una concezione non storica e apocalittica di questi flagelli come punizione divina per i peccati del mondo. Le tesi di Dhanis poi rettore della Pontificia Università Gregoriana, sarebbero state duramente dibattute negli ambienti vicini a Fatima costringendolo a toni più concilianti. Lui, membro sino alla morte della Commissione teologica internazionale, a fare da apripista per altri teologi come nel suo caso accusati dai tradizionalisti di essere «nemici di Fatima».
Accuse dalle quali non furono risparmiati Papi come Giovanni XXIII e Paolo VI, invitati più volte a rinnovare in modo completo la consacrazione e a divulgare l’ultima parte del segreto, non disposti in tempi di Ostpolitik e di Concilio, a lasciar passare interpretazioni del messaggio di Fatima ultraconservatrici, anti-ecumeniche, in un quadro rinnovato nel quale la Chiesa tesseva nuove relazioni ad Est, affievolendo le aspettative delle tesi legate all’«ultimo segreto di Fatima» che per molti si sarebbe riferito ad una grave crisi interna alla Chiesa causata dal Concilio. Il resto è noto: nel ‘59 e nel ‘65 Giovanni XXIII e Paolo VI lessero il segreto e decisero di non divulgarlo (facendo alimentare nuove speculazioni).
 Negli anni ’60 la questione coloniale segnò un divario tra Vaticano e governo portoghese già alle prese con una vera opposizione cattolica interna intensificatasi con l’inasprimento delle guerre in Africa e l’esilio forzato del vescovo di Porto nel 1959. Proprio quest’ultimo, Ferreira Gomes, rientrando nel ’70 dal suo esilio in Francia, fu il primo prelato portoghese a formulare aperte critiche nei confronti di Fatima (già da lui definita una «Lourdes reazionaria»), sottolineandone aspetti di «culto magico» e «religione utilitaristica». «Per i cattolici che in questo periodo combattevano il regime in Portogallo, Fatima ebbe un significato molto diverso, se non opposto, a quello che avrebbe avuto per la lotta di liberazione polacca degli ani ’80», ha notato Barreceto. Aggiungendo che: «L’episcopato portoghese, tra la crescente contestazione proveniente dalla Chiesa e le critiche cattoliche internazionali, riuscì, seppur tardivamente, a svincolarsi dal regime poco prima della rivoluzione dell’aprile 1974 che ne decretò la fine». Apparentemente incurante degli sconvolgimenti politici, il santuario di Fatima continuò ad accogliere folle di devoti. Anzi la forza della fede popolare protesse la Chiesa dal potere rivoluzionario del biennio ‘74-‘76.
Negli anni ’60 la questione coloniale segnò un divario tra Vaticano e governo portoghese già alle prese con una vera opposizione cattolica interna intensificatasi con l’inasprimento delle guerre in Africa e l’esilio forzato del vescovo di Porto nel 1959. Proprio quest’ultimo, Ferreira Gomes, rientrando nel ’70 dal suo esilio in Francia, fu il primo prelato portoghese a formulare aperte critiche nei confronti di Fatima (già da lui definita una «Lourdes reazionaria»), sottolineandone aspetti di «culto magico» e «religione utilitaristica». «Per i cattolici che in questo periodo combattevano il regime in Portogallo, Fatima ebbe un significato molto diverso, se non opposto, a quello che avrebbe avuto per la lotta di liberazione polacca degli ani ’80», ha notato Barreceto. Aggiungendo che: «L’episcopato portoghese, tra la crescente contestazione proveniente dalla Chiesa e le critiche cattoliche internazionali, riuscì, seppur tardivamente, a svincolarsi dal regime poco prima della rivoluzione dell’aprile 1974 che ne decretò la fine». Apparentemente incurante degli sconvolgimenti politici, il santuario di Fatima continuò ad accogliere folle di devoti. Anzi la forza della fede popolare protesse la Chiesa dal potere rivoluzionario del biennio ‘74-‘76.Morto Paolo VI e subito dopo Giovanni Paolo I, che da patriarca di Venezia aveva incontrato Lucìa, ecco Giovanni Paolo II: il “Papa di Fatima” nonché «protagonista della terza parte del segreto». Il Papa che a Fatima nel 1982 non esita a riconoscere che la Vergine gli ha salvato la vita, che ripete la consacrazione del mondo (13 maggio ‘82 e 25 marzo ‘84), che beatifica i due pastorelli che ora Francesco canonizza; che ha consentito la divulgazione del terzo segreto con tanto di “guida alla lettura” dell’allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale Joseph Ratzinger. Sì, il futuro Benedetto XVI, che nel 1996 a Fatima, ricordò l’invito vero di Maria che «parla ai piccoli per mostrarci quanto è necessario sapere: cioè, prestare attenzione all’unico necessario: credere in Gesù Cristo» . Quanto al resto ci vengono in mente solo le parole di Paul Claudel che definì Fatima «un’esplosione traboccante del sovrannaturale in un mondo dominato dal materiale».
LEGGI ANCHE: Fatima, mistero e profezia del Novecento
LEGGI ANCHE: Il Terzo Segreto di Fatima: dati certi, dubbi e retroscena
* www.lastampa.it, 10.05.2017.
-
> LA STELLA DEL DESTINO? "LUCIFERO!". -- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.5 maggio 2017, di Federico La Sala
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE.
L’immaginario del cattolicesimo romano.
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! Alcune note - di Federico La Sala
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO. -
> MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO DELLA ROMANITÀ. --- MARGHERITA GRASSINI (di Simona Urso).3 maggio 2017, di Federico La Sala
GRASSINI, Margherita
di Simona Urso *
GRASSINI, Margherita. - Nacque a Venezia l’8 apr. 1880 da Amedeo e Emma Levi.
Era la quarta figlia - dopo Nella, Lina e Marco - di una ricca famiglia ebrea profondamente ortodossa e molto nota in città. Il padre, avvocato e consigliere comunale - personalità di spicco della comunità israelitica e anche amico personale del patriarca G. Sarto, futuro papa Pio X - fondò, insieme con G. Musatti, la prima società di vaporetti della laguna; i due crearono anche un gruppo finanziario che fornì i capitali per avviare la trasformazione del Lido in località a intenso sviluppo urbanistico attrezzata per il turismo. Amedeo Grassini, quindi, oltre a possedere un ingente patrimonio personale, occupava, in città, una posizione di assoluto prestigio, ulteriormente accresciuta quando, nel 1894, la famiglia abbandonò il ghetto ebraico per trasferirsi a palazzo Bembo. Tale posizione gli permise di provvedere nel modo migliore all’istruzione della G. che, intelligente e precoce, fu educata in casa, potendo usufruire, grazie alle conoscenze paterne, di insegnanti d’eccezione quali lo storico dell’arte, e poi direttore della Biennale, A. Fradeletto, il risorgimentista e futuro sindaco e podestà di Venezia, P. Orsi, il letterato P. Molmenti; lo studio delle lingue straniere ne completò la formazione. La posizione del padre le permise, inoltre, di entrare in contatto con molte delle personalità che, in quegli anni, visitarono la città; fra gli incontri più significativi quelli con I. Zangwill - scrittore ebreo inglese che le fece conoscere il sionismo e le fu sempre amico -, G. D’Annunzio e la famiglia Fogazzaro.
La G. visse sempre il proprio ebraismo d’origine con distacco ma anche con orgoglioso senso di appartenenza culturale, cui non corrispose mai l’accettazione del dato religioso in quanto tale. Questa ambivalenza originaria, in bilico tra assimilazione, conflitto con le radici ebraiche e orgogliosa rivendicazione delle stesse, fu sofferta da tutti i fratelli Grassini, con conseguenze gravi, fino al suicidio della sorella Lina nel 1909. Nella G. tale ambiguità e l’attrazione mai pacificata verso la sfera del sacro avrebbero contraddistinto tutto il suo percorso biografico, conducendola, nel 1928, a una tormentata conversione al cattolicesimo e, più tardi, negli anni Trenta, avrebbero avuto un ruolo anche nel suo distacco dal fascismo.
Nel 1899 la G. sposò l’avvocato Cesare Sarfatti, militante socialista che in quegli anni, accanto a Elia Musatti, stava ricostituendo la sezione veneziana del partito; nello stesso periodo fece anche il suo primo apprendistato come giornalista "di cose d’arte" su Il Secolo nuovo, quotidiano socialista locale.
Nell’esercizio di quest’attività, particolare rilevanza ebbe l’insegnamento trasmessole dal Fradeletto, il quale le aveva fornito gli strumenti intellettuali e culturali atti a coniugare una formazione imbevuta di classicità con il romanticismo idealista di J. Ruskin e Th. Carlyle, e il simbolismo francese e tedesco.
La G., nelle sue memorie (ma sta a confermarlo il carteggio conservato nel Fondo Fogazzaro presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza) colloca fra i suoi primi, e importanti, mentori anche Antonio Fogazzaro, da cui fu introdotta alla conoscenza del dibattito culturale e religioso che animava in quegli anni il movimento modernista internazionale. Sempre tramite Fogazzaro la giovane G. conobbe colui che sarebbe stato, in certo modo, il suo padre spirituale e il tramite verso la conversione al cattolicesimo, don Brizio Casciola.
Trasferitasi a Milano nel 1902 con il marito, i due presero a frequentare il gruppo socialista milanese, in particolare la casa di Anna Kuliscioff; Sarfatti esercitava come avvocato, ma fu anche stretto collaboratore di Turati, almeno fino al 1913-14. Alla fortuna come avvocato non corrispose, però, una uguale fortuna politica: a lungo consigliere comunale socialista, Sarfatti non riuscì mai a entrare in Parlamento, obiettivo cui puntava fin dal trasferimento a Milano. Forse anche per avervi intravisto la possibilità di un rilancio della propria carriera politica, egli seguì la moglie nelle sue simpatie per B. Mussolini. A differenza della G., il cui rapporto con l’ebraismo restava conflittuale, Sarfatti era un convinto sionista e partecipò, in qualità di delegato per il gruppo sionista milanese, alla conferenza internazionale di Bruxelles del 1911.
La G. lo accompagnò, ritrovandovi l’amico Zangwill, fondatore della Jewish territorial organization, con il quale non avrebbe mai più interrotto i contatti: nel 1912, per La Voce di G. Prezzolini, ne tradusse il racconto Chad Gadya (in parte ispirato a vicende della famiglia della G.) e, nel 1914, il saggio Le suffragiste inglesi (Firenze).
Ancora una volta il rifiuto della pratica religiosa andava nella G. di pari passo con la volontà di non perdere l’elemento identitario di origine. Forse proprio partendo da queste radici, dove l’ebraismo si era mutato in una sorta di messianismo laico, è possibile comprendere il suo costante interesse per la politica sentita come possibilità di realizzazione di una "città futura" (titolo anche di una rubrica che la G. tenne sulle pagine de La Difesa delle lavoratrici), che ella avrebbe via via identificato prima nel socialismo, poi nella patria risorgimentale sorta a nuova vita dopo la Grande Guerra e, infine, nello Stato fascista.
Dal 1902 al 1915 la G. collaborò, in qualità di critico d’arte, all’Avanti! e a Il Tempo, quotidiano del gruppo socialista milanese; sul primo tenne anche, dal 1908 al 1910, una rubrica culturale, "Le ore della Quindicina", i cui contenuti, permeati di simpatia per l’irrazionalismo e attenti a tutti i movimenti culturali emergenti in area europea, mostrano con evidenza la sua progressiva presa di distanza dalle coordinate culturali del partito socialista.
Di fatto la permanenza a Milano l’aveva messa in contatto con ambienti che confermarono questa sua vocazione a spaziare in territori diversi: grazie alla mediazione di Fogazzaro e di Casciola fu vicina anche alla rivista Rinnovamento, che fu un ulteriore tramite verso lo spiritualismo e l’idealismo filosofico. A consolidare il nuovo indirizzo del suo pensiero valsero anche la conoscenza con Prezzolini e, dal 1908, la già ricordata sporadica collaborazione alla Voce, da cui venne lentamente assimilando una sorta di "nazionalismo modernista" (E. Gentile).
Queste simpatie culturali già dal 1906 avevano messo la G. in sintonia con i futuristi, in particolare U. Boccioni e F.T. Marinetti; frequentò, inoltre, l’ambiente emancipazionista e fu vicina al filantropismo politico dell’Unione femminile, diretta da Ersilia Majno, socialista ma come lei influenzata dallo spiritualismo. Tuttavia la G., benché membro della Pro suffragio dal 1905, non fu di fatto particolarmente sensibile al movimento femminile vero e proprio, anche se fu al fianco della Kuliscioff quando questa fondò, nel 1912, il settimanale La Difesa delle lavoratrici, di cui fu redattrice e corsivista fino al 1915.
Già alla fine del 1912 la G. si era avvicinata a Mussolini, da poco divenuto direttore dell’Avanti!: un primo segnale della loro stretta collaborazione fu la partecipazione della G. a Utopia (1913-14), rivista teorica del socialismo rivoluzionario, da Mussolini fondata e diretta.
Il rapporto con Mussolini con ogni probabilità nacque attraverso la comune amicizia per Prezzolini e venne consolidato dall’adesione di entrambi all’humus vociano in cui convivevano risorgimentismo, spirito pedagogico, individualismo, l’influenza dell’irrazionalismo europeo, nonché un certo pensiero cattolico orientato al misticismo, tutti elementi che già da tempo facevano parte dell’orizzonte culturale della G.; da questo eclettico coacervo ella e Mussolini maturarono alcune idee confluite nel loro interventismo e, infine, nel fascismo.
Intanto, grazie alla costante presenza della sua firma sulle pagine dell’Avanti!, la fama e l’influenza della G. nell’ambito della critica d’arte aumentavano, incrementate anche dal salotto culturale di cui fu animatrice a partire dal 1910, e che tenne aperto per almeno vent’anni: casa Sarfatti era oramai uno dei luoghi nevralgici della Milano culturale e politica. Non più semplicemente critico d’arte, la G. divenne talent scout del gruppo futurista di Nuove tendenze, da cui, nel dopoguerra sarebbe emerso Novecento italiano, il movimento artistico da lei promosso e con cui venne sempre identificata.
Già contraria alla guerra di Libia, nel 1915, la G., dopo alcuni tentennamenti, si schierò per l’intervento, scelta che sancì pubblicando un libretto di propaganda, La milizia femminile in Francia (Milano), in cui portava come esempio di amor patrio le donne francesi e il loro eroismo in guerra. Abbandonò infine il partito socialista schierandosi definitivamente con la corrente mussoliniana; lasciato l’Avanti!, per tutta la durata della guerra fu critico d’arte della rivista di U. Notari, Avvenimenti.
Nel 1918 perse in guerra il figlio diciottenne Roberto, partito volontario fra gli arditi.
Questo evento avrebbe segnato non solo la sua vita privata, ma anche la successiva adesione al fascismo, in cui trovò riscontro al suo culto della patria, fondato sul sacrificio bellico e sul mito del sangue versato, e a un aristocratico antidemocraticismo che vedeva nella Grande Guerra il momento fondante di una nuova compagine statale e di una nuova gerarchia politica. Il mito del capo, incarnato da Mussolini, completò, poi, l’evoluzione ideologica della Grassini.
Dal 1918 fino alla fine degli anni Venti fu collaboratrice fissa de Il Popolo d’Italia, dove, come sempre, si occupò di arte, riservandosi però anche una rubrica di recensioni letterarie, "Le cronache del venerdì". Dal 1922 al 1933 fu condirettrice e poi direttrice di Gerarchia, rivista teorica del fascismo mussoliniano.
La rivista, circoscritta ai mussoliniani di stretta osservanza, proprio in quanto tale rappresenta un utile osservatorio sul "mussolinismo" - in particolare per gli anni Venti, quando la costruzione dello Stato fascista costituiva l’interesse politico prioritario di Mussolini - e sul ruolo personale che la G. ebbe nella elaborazione di questa specifica "ideologia".
La G., comunque, non abbandonò la critica d’arte né l’attività promozionale nei confronti degli artisti emergenti, anche perché, nella sua personale Weltanschauung, agli artisti era destinato un ruolo centrale nell’edificazione dello Stato fascista; tenne così a battesimo, nel 1922, il movimento pittorico cui più è legato il suo nome, Novecento, al quale inizialmente aderirono sette pittori precedentemente legati a Nuove tendenze (A. Funi, P. Marussig, L. Dudreville, E. Malerba, M. Sironi, U. Oppi e A. Bucci).
Il fine di tale movimento, che nasceva dunque da una costola del futurismo più moderato, doveva essere la rifondazione della pittura sulla base di uno stile compatto, scarno, quasi monumentale, in certo senso classico, nei termini in cui tale era stata la pittura italiana del Quattrocento; proprio la classicità, ritrovata attraverso un processo di sottrazione (ragion per cui la G. riteneva che il futurismo avesse costituito una indispensabile pars destruens nella storia della pittura italiana), sarebbe stata un eccellente viatico all’arte della nuova stagione che il fascismo stava aprendo. Con questo richiamo, inoltre, il movimento anticipava l’uso strumentale della classicità e della romanità, cui poi si richiamò costantemente la propaganda fascista; il simbolo stesso del fascio littorio pare sia nato da un’idea della Grassini.
Naufragato rapidamente il gruppo originario per dissidi interni, poco dopo nacque Novecento italiano inaugurato nel 1926 con una mostra inaugurata da Mussolini alla Permanente di Milano. La nuova compagine, che comprendeva quasi tutti i maggiori pittori e scultori italiani del momento (con l’eccezione dei futuristi) non era più un movimento artistico stilisticamente connotato in modo chiaro, ma un polo orientativo che, nell’intenzione della G., avrebbe dovuto raggruppare i migliori talenti dell’arte italiana contemporanea.
I punti fondamentali delle teorie della G. al riguardo sono in Segni colori e luci (Bologna 1925) e in Storia della pittura moderna (Roma 1930): elemento basilare di questa seconda fase era, ancora una volta, la compresenza di modernità e classicità, caratteri stilistici che la G. vedeva ben rappresentati nel cosiddetto "ritorno all’ordine", una corrente di indirizzo restaurativo diffusa nel panorama artistico europeo contemporaneo e alternativa all’astrattismo. La compresenza di classicità e modernità era, del resto, secondo la G., anche caratteristica costitutiva del pensiero fascista.
Per tutti gli anni Venti, il ruolo centrale occupato nell’ambiente culturale più prossimo al regime le permise di organizzare e gestire le più importanti mostre in Italia e all’estero. Grazie a questa sua onnipresenza, ma soprattutto grazie all’enorme successo della biografia di Mussolini di cui fu autrice (Dux, tradotto in 18 lingue), ella finì per essere, all’estero, quasi un simbolo della nuova Italia moderna e fascista.
La biografia, dapprima apparsa in inglese per il mercato anglosassone (Londra 1925), fu poi riscritta appositamente per l’Italia ed edita a Milano nel 1926 da Mondadori. A quest’opera la G. era stata in parte sollecitata da Prezzolini, ma le fonti dimostrano che ella vi pensava già nel 1923 (se ne trova conferma nell’Archivio Mondadori), quando ancora non era in contatto con le edizioni Butterworth. Il libro pone in essere l’esplicita volontà della G. da un lato di cogliere alle origini e, in certo modo, di sistematizzare l’ideologia mussoliniana (di cui chiariva i legami con F. Nietzsche, V. Pareto, G. Le Bon, G. Sorel); dall’altro di costruire ex novo l’immagine pubblica di Mussolini. In quest’immagine forza, energia e vitalismo si sommavano a una sorta di appeal anche erotico, rappresentandolo autorevole ma anche moderno e spregiudicato, quasi un eroe da romanzo d’appendice; anche il termine "dux", fu un’invenzione della G.: "romano nell’anima e nel volto, Benito Mussolini è una resurrezione del puro stile italico, che torna ad affiorare oltre i secoli" (Dux, p. 10); il ricorso alla fisiognomica per sostanziare la dimensione del personaggio acquistava valore aggiunto grazie alla copertina della prima edizione italiana: il busto mussoliniano scolpito da A. Wildt che evidenziava proprio quelle medesime caratteristiche "romane" del volto.
La quantità delle ristampe, ma soprattutto delle traduzioni, sta a dimostrare che il progetto propagandistico-comunicativo ebbe un indubbio successo. Eppure il Mussolini di qualche anno dopo, oramai ingessato nel ruolo del duce infallibile, avrebbe trovato il libro troppo ingombrante. Ma, proprio nel momento del massimo successo della G., la trasformazione di Novecento italiano in un centro di potere dalla struttura rigidamente corporativa, in cui ormai venivano gestite le mostre e sovvenzionati i pittori, ne annullò l’originaria compattezza e provocò, negli anni dal 1926 al 1930, pesanti attacchi al movimento, e di conseguenza alla G., da parte di altre correnti della cultura fascista che intendevano colpire i "novecentisti" per subentrare loro (apparvero in particolare sulla rivista di R. Farinacci Il Regime fascista). In conseguenza di ciò alle biennali del 1928 e del 1930 la G. fu penalizzata ed estromessa dalla commissione selezionatrice.
Negli anni successivi il consolidamento del regime e l’organizzazione del consenso attraverso nuovi canali politici e di comunicazione la scavalcarono ulteriormente; ne risentì anche il suo salotto, nel frattempo trasferitosi da Milano a Roma, che progressivamente perse lustro e si spopolò.
Se Mussolini, a metà degli anni Trenta, si era ormai allontanato da lei, la G. stessa non ne condivideva più la politica: non aveva approvato la guerra d’Etiopia e temeva l’avvicinamento alla Germania nazista, di cui la preoccupava soprattutto la politica antisemita. Nel 1937 diede alle stampe un libretto, L’America, ricerca della felicità (Milano-Verona).
Sotto la veste di cronaca di un viaggio negli Stati Uniti, L’America cela un lucido giudizio sul fallimento politico del regime fascista e forse anche la speranza, da parte della G., di trovare proprio in America la nuova Roma, la "città futura", di cui fu costantemente alla ricerca.
L’anno dopo, in seguito alla emanazione delle leggi razziali, si rifugiò in Sudamerica.
Rientrata in patria nel 1947, morì a Cavallasca, presso Como, il 30 ott. 1961. [...]
* Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 58 (2002)
- PER PROSEGUIRE NELLA LETTURA, cliccare su TRECCANI.
-
>MARGHERITA SARFATTI, RENZO DE FELICE, E IL MITO DELLA ROMANITÀ. -- ""CARDUCCI GIACOBINO". La ricerca di Sanguineti e la Rivoluzione francese secondo i "Wu Ming".13 aprile 2017, di Federico La Sala
- EDOARDO SANGUINETI. "Giovane adepto del Carducci giacobino, e di Campana come protagonista di un salutare «ritorno al disordine», Sanguineti assume presto un costume da «stalinista molto rigido», poi da seguace «filocinese», in seguito è parlamentare eurocomunista; per approdare infine, scomparso il Pci e crollato il muro di Berlino, a una rinnovata forma di ribellismo eslege".
- WU MING: "L’ARMATA DEI SONNAMBULI". La riprova di un omaggio a Carducci, al Carducci cantore della Rivoluzione, oggi del tutto dimenticato, travolto nel generale rifiuto che ha colpito da tempo tutta la produzione del poeta.
Sanguineti, l’erudizione all’avanguardia
di Bruno Pischedda (Il Sole-24 Ore, 12 dicembre 2010)
Poco è trascorso dalla morte improvvisa di Edoardo Sanguineti, e puntualmente, grazie a una curatela precisa (ho notato solo un Finnegan’s wake con il singolare erroneo), Erminio Risso ne raccoglie un’ampia miscellanea di scritti dalla metà degli anni Cinquanta sino a noi. Cultura e realtà è il titolo del volume, ricco di letteratura, arti, musica, teatro: tutte materie che l’artefice di Laborintus affrontava in cataloghi di mostre e riviste come «Marcatrè», «Nuova Corrente», «Il Verri»; quindi da autorevole dispensatore di sapere entro saggi sparsi, convegni, dotte prefazioni. Vi fa spicco, e non poteva essere altrimenti, l’attitudine eversiva della sua parola critica, che particolarmente in letteratura si compiace di anticipazioni anacronistiche e ribaltamenti. Il Satyricon di Petronio, per dare qualche esempio, come forma menippea dell’antiromanzo moderno; Petrarca non già nume fondatore della lirica moderna, ma "sublime epigono", maestro sommo che ricapitola il Medioevo («I Fragmenta sono una pietra miliare. Ma sono tali in quanto pietra tombale»). E ancora, Leopardi filosofo "reazionario", con buona pace di Cesare Luporini; Campana post-continiano, fuori e oltre la deficitaria dicotomia tra poeta visivo e poeta veggente; Pound contro Eliot (lo "schianto" dell’uno in rapporto alla "lagna" dell’altro); Verga dei racconti milanesi riletto con puntiglio sulla falsariga di Brecht e del suo effetto straniante.
Non è senza significato se in un avanguardista d’impegno come Sanguineti il trattamento della poesia e delle poetiche («dico la poetica per intendere l’ideologia») prevale di gran lunga sulla tradizione del romanzo. L’epistolografia, la diaristica, al massimo la forma narrativa breve gli fanno da timone quando si addentra nel territorio della prosa. Eventualmente l’autoriflessione d’autore e gli elementi di consapevolezza programmatica e procedurale, in un arco che appunto dal Petrarca giunge sino a Landolfi e a Petrolini, magistrale saltimbanco e vero campione della "meta-recitazione". Ma soprattutto colpisce nella raccolta il desiderio di ricapitolare esistenzialmente, di fare punto in età matura e di darsi ragione di un tragitto intellettuale che si può ben dire novecentesco.
Fa bene l’editore a mettere in controcopertina il motto forse più istruttivo del volume: «Gli anni di apprendistato continuano per tutta la vita». Così da suggerire che nella sfera del moderno si attenua di molto la circostanza iniziatica a tutto favore di un acquisto sempre inconcluso. Da osservare, se mai, è che in un «tenace razionalista» come Sanguineti (così si definisce) proprio il processo di autocostruzione intellettuale procede tramite un’ininterrotta serie di avventure epifaniche, di lampi improvvisi, utili a rifondere il dato etico e politico nel più ampio mare dell’estetica. A dieci anni l’incontro con Fedele, giovane operaio ed emblema di un’alterità vivente, ossia «la rivelazione che esistevano persone al cui mondo non partecipavo, e che erano, in qualche modo, di un’altra razza». Nel 1947 l’apprezzamento del Dom Juan, giunto a Torino per la resa scenica di Louis Jouvet: «la prima rivelazione di una autentica grandezza teatrale»; le susseguenti e inattese simpatie per gli irrazionalisti maggiori: «da giovane fui incantato da Nietzsche, poi da Kierkegaard, poi da Schopenhauer, poi da Heidegger»; quindi l’approdo entusiasta all’etnologia di Vittorio Lanternari e alla sua opera capostipite, La grande festa, del 1959, «uno di quei testi che bene o male hanno deciso della mia interpretazione del mondo, e anzi, se così posso dire, del mio modo di stare al mondo». Sembrerebbe un percorso noto, generazionalmente condiviso, e solo eccentrico per la quota di circolarità radicale che viene manifestando.
Giovane adepto del Carducci giacobino, e di Campana come protagonista di un salutare «ritorno al disordine», Sanguineti assume presto un costume da «stalinista molto rigido», poi da seguace «filocinese», in seguito è parlamentare eurocomunista; per approdare infine, scomparso il Pci e crollato il muro di Berlino, a una rinnovata forma di ribellismo eslege. «Tutto ciò che nella modernità trascorsa ha avuto senso e peso e rilievo - scrive - si è sempre fondato in qualche modo sopra una pulsione radicalmente anarchica e se non altro anarcoide». Persiste insomma il gusto «del rischioso e dell’imprevedibile», però venato da una screziatura di alacrità pessimista, particolarmente quando si giunge al nodo dell’ideologia. «Io - prosegue - uso la parola positivamente»; e se è pur vero che «a questo mondo non ci sono che false coscienze», il massimo che si potrà fare è agire con tenacia lucida per crearsene una, senza lacune o tradimenti improvvisi.
Diverso in ogni caso è il ragionamento se ci spostiamo sul piano del metodo di analisi (letterario, culturale in genere) e sulla visione complessiva che Sanguineti ne trae. Anche in questo caso non può sfuggire il senso di un percorso: da un momento prioritario nutrito di Brecht, Artaud e di sociologia neomarxista: Goldmann, e magari Escarpit, il nostro Giuseppe Petronio, Hauser, Argan; ecco affiorare i contributi più canonici di Spitzer e soprattutto di Curtius, della critica psicoanalitica, della filologia: Mauron, Roncaglia. L’atteggiamento con cui si dedica a questi scritti è certo diversificato: psicocritico da un lato e attento alle fonti e alla topica generativa dall’altro. Sul terreno dell’interpretazione, osserva, mutuando un celebre motto di Debenedetti, «nessun coltello è da sottovalutare, quando serve ad aprire l’ostrica».
Ma è davvero arduo non vedere il vero collante che tutti questi metodi tiene insieme, ovvero il formidabile e quasi reattivo, polemico eruditismo. Due linee sembrano disegnarsi in definitiva: da un lato l’ampliamento multidisciplinare, come per tanta parte dei letterati impegnati a lui coevi (antropologia, folclore, sociologia, filosofia). E dall’altro una competenza libresca, anche la più minuta, che vale a surclassare qualunque obiezione di ideologismo ristretto. Insomma quel sale enciclopedico e nozionistico che un antico sodale come Eco, uomo in palandrana anche lui, scioglie nello humour accattivante, nel divertissement alla portata di (quasi) tutti, e che invece Sanguineti porge in modo grave, secondo un accademismo accurato e inappellabile.
A colui che intendeva fare dell’avanguardia un’arte da museo, sempre più va sostituendosi l’estimatore del museo e delle opere che vi sono custodite. In uno scritto fondamentale del 2002 annota: «è classico tutto ciò che sopravvive a un medioevo», alludendo con l’articolo determinativo al nostro oggi, che della vecchia barbarie sembrerebbe il duplicato. I classici, prosegue, «ammaestrano, documentatamente, intorno alla dialettica storica, e ci orientano in un autentico storicismo assoluto». Ma il punto, per concludere in battuta, è che di questo storicismo noi non sapremmo cogliere né l’assoluto né eventualmente il dialettico. Soprattutto se poniamo mente a uno dei saggi più ambiziosi e forse più deboli della compagine: lo scritto titolato Per una teoria della citazione (anno 2001), dove è riletta l’intera tradizione d’occidente in forma di recupero intertestuale, senza fasi distinte, articolazioni di merito, modalità accentuate. Un saggio che fa il paio con altra sentenza, o boutade, datata 1997, secondo cui «il sogno di Benjamin di un libro fatto di sole citazioni è un sogno che riassume in sé tutta la modernità, la pulsione della modernità». A un così netto riduzionismo, corrisponde, poi, e pure questo era da aspettarsi, una singolare afasia quando arriviamo alle poetiche del recupero neonarrativo: «Nessuno sa bene - dichiara - che cos’è il postmoderno». Tanto erudito pare insomma Sanguineti, ed è; quanto curiosamente disinteressato, e anzi bizzoso, dinnanzi alle tendenze letterarie delle decadi a noi più vicine. Si capisce la difficoltà, la remora ad affrontare una materia davvero bruciante sotto il profilo post-novecentista e post-sperimentale. Proprio qui, tuttavia, si sarebbe desiderata da una così grande figura di intellettuale e poeta qualche breve parola, magari non assoluta, ma storica.
La rivoluzione francese secondo Wu Ming
Di nuovo storia e finzione per il collettivo
di Ranieri Polese *
Nel 1883, per ricordare la vittoria francese di Valmy (20 settembre 1792) sugli eserciti di Austria e Prussia, Giosuè Carducci componeva i dodici sonetti del Ça ira. In cui, italianizzando nomi francesi (Tuglierì, Ostel di città, Abbadia per Tuileries, Hôtel de Ville e la prigione dell’Abbaye), celebrava la battaglia che aveva salvato la Rivoluzione. E in una nota scriveva: «Oggi è vezzo (...) voler abbassare e impiccolire la rivoluzione francese: con tutto ciò il Settembre del 1792 resta pur sempre il momento più epico della storia moderna». Non aveva paura, Carducci, a esaltare pure il linciaggio della dama di compagnia della regina, la principessa di Lamballe, la cui testa su una picca venne portata sotto la prigione del Tempio. Già dodici anni prima, nella fase più radicale della sua fede giacobina, aveva scritto Versaglia in gloria della grande Rivoluzione. Anche qui, nomi francesi italianizzati (Occhio di bue per l’oeil de boeuf della reggia che, appunto, diventa Versaglia) e la celebrazione degli eventi rivoluzionari come la decapitazione del re, giusto castigo per i secolari delitti di cui si era macchiata la monarchia francese.
All’epoca, all’indomani della sconfitta di Sedan (1870), la Terza Repubblica in Francia operava una drastica revisione della Rivoluzione, condannando senza appello i giacobini, il Terrore, il radicalismo di Robespierre. E il giacobino Carducci protestava con i suoi versi. Oggi, contro le nuove revisioni storiografiche della Rivoluzione, il collettivo di scrittura Wu Ming ci propone un denso romanzo che inizia con l’esecuzione di Luigi XVI (21 gennaio 1793) e si ambienta nei mesi del Terrore, per arrivare, dopo la caduta di Robespierre il 9 Termidoro (27 luglio 1794), alla sconfitta finale del popolo di Parigi nella primavera del 1795. L’armata dei sonnambuli si dichiara subito dalla parte dei sanculotti, dei repubblicani dei grandi sobborghi popolari. Sono loro che appoggiano il governo di Robespierre anche nelle sue estreme decisioni (la messa a morte di Maria Antonietta, Danton, Desmoulins, Hébert), seppure criticando il mancato approvvigionamento di cibo e l’impunità degli accaparratori.
Sanno comunque che quando la ghigliottina smetterà di funzionare, per i sanculotti, gli operai, i miserabili sarà la fine: tornerà lo strapotere dei ricchi. E i Wu Ming si ricordano giustamente di una celebre pagina della Storia della rivoluzione francese di Jules Michelet, quella che racconta come, dopo la morte di Robespierre, le strade si popolano di Incroyables, i muscadins profumati che ostentano lusso e disprezzo e danno man forte alla repressione dei movimenti popolari.
Storia & invenzione Abile combinazione di fatti storici e personaggi di fiction, il romanzo dei Wu Ming segue le vicende di alcune figure d’invenzione: Marie Nozière, operaia del Faubourg Saint Antoine, e suo figlio Bastien; la guardia Treignac; l’attore Léo Modonnet (in realtà è l’italiano Leonida Modenesi, venuto a Parigi per incontrare Goldoni che vi risiede dal 1762); il buon medico Orphée d’Amblanc. Contro questi personaggi positivi spicca la figura di Monsieur Laplace, vera incarnazione del Male. Ospite dell’ospedale di Bicêtre, Laplace è in realtà un nobile, il cavaliere d’Yvers, che aveva tentato di salvare il re prima del suo arrivo sul patibolo. Scoperti, i congiurati vengono catturati o uccisi, ma Yvers si salva e si rifugia sotto falso nome nel manicomio. Dove esercita i suoi poteri magnetici, con la tecnica del dottor Messmer.
Fenomeno di gran moda negli ultimi anni dell’Ancien Régime, il mesmerismo può essere un metodo di cura a fin di bene (il dottor d’Amblanc se ne serve con i suoi malati) ma può anche diventare il mezzo per soggiogare la volontà di singoli individui e pure di gruppi di persone. Yvers, infatti, crea in questo modo una squadra di sonnambuli che invia a seminare il terrore nei faubourg popolari. E quando il governo giacobino viene abbattuto, le squadracce di ipnotizzati si scatenano contro chi prepara l’ultima resistenza sanculotta. Solitario vendicatore, l’attore Modonnet, coperto dalla maschera di Scaramouche, li sfida nel tentativo di frenare la violenza reazionaria.
Linguaggio & feuilleton In contrasto con la lunga tradizione romanzesca che ha narrato gli anni della Rivoluzione con un deciso orientamento reazionario (da Balzac, Les Chouans, ad Anatole France, Gli dei hanno sete, da Dickens, Le due città, alla Baronessa Orczy, La primula rossa; e il cinema non è stato da meno, con i film strappalacrime su Maria Antonietta), i Wu Ming optano per il feuilleton, Sue e Dumas naturalmente. I personaggi popolari - Marie, Bastien, Treignac - ricordano invece I miserabili di Hugo. Una scelta, comunque, quella del feuilleton che, oltre a regalare le migliori pagine del romanzo, ribadisce la scelta di campo dei Wu Ming dalla parte del popolo.
Quanto infine al linguaggio, L’armata dei sonnambuli, fra documenti d’epoca e capitoli avventurosi, dedica largo spazio a una scrittura che vuole imitare (inventare?) un parlato sanculotto. Che è un misto di gergo dialettale infarcito di parole francesi italianizzate con un certo oltranzismo. Tegolerie per Tuileries, Sant’Onorio per Saint Honoré, Ponte Nuovo per Pont Neuf, foborgo per faubourg. E forse in questo pastiche si coglie la riprova di un omaggio a Carducci, al Carducci cantore della Rivoluzione, oggi del tutto dimenticato, travolto nel generale rifiuto che ha colpito da tempo tutta la produzione del poeta.
Ranieri Polese
* FONTE: LA LETTURA - CORRIERE DELLA SERA.
-
> LA STELLA DEL DESTINO? "LUCIFERO!" - IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi.11 aprile 2017, di Federico La Sala
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo):
- DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO.
 LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
Libera Chiesa, in catene di Stato
di Riccardo Chiaberge (il Fatto Quotidiano, 18 dicembre 2010)
Corsi e ricorsi dell’onomastica: si chiamava Gasparri, ma non sedeva in Senato e vestiva la porpora del Segretario di Stato vaticano, l’uomo che nel 1923 aiutò Mussolini a far fuori uno dei suoi avversari più temibili, l’odiato don Sturzo. Il leader dei Popolari era passato all’opposizione e avrebbe votato contro la famigerata legge Acerbo che aboliva la proporzionale istituendo un premio di maggioranza su misura per le ambizioni totalitarie del fascismo. Ma il 10 luglio, senza preavviso, lasciò la guida del suo partito.
Secondo il cardinale questo abbandono era un espresso desiderio del Santo Padre, il quale riteneva che “nelle attuali circostanze in Italia, un sacerdote non può, senza grave danno per la Chiesa, restare alla direzione di un partito, anzi dell’opposizione di tutti i partiti avversi al governo, auspice la massoneria come ormai è risaputo”.
POCHI GIORNI prima, dai muri di Roma, il manifesto di una nuova organizzazione cattolica aveva invitato i fedeli a dare pieno sostegno alle camicie nere, in nome di “quei valori religiosi e sociali che costituiscono la base d’ogni sano reggimento politico” e a combattere le forze antinazionali contrarie a “un durevole ordine sociale cristiano e italiano”. L’avrete notato anche voi, lo stile ricorda in modo impressionante i sermoni di Bagnasco o di Bertone: non diversi gli accenti accorati sulla necessità di superare lo scontro, identico l’appello alla pacifica convivenza e al “bene supremo dell’Italia”.
In realtà, scrive lo storico Emilio Gentile nel suo nuovo libro, Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi (Feltrinelli, pagg. 442, euro 25), il desiderio del Santo Padre corrispondeva a quello del duce, che “aveva minacciato rappresaglie contro le associazioni cattoliche e il clero se la Chiesa non fosse intervenuta a togliere dalla politica il sacerdote siciliano”. L’uscita di scena di Sturzo accelerò la disgregazione interna del Partito popolare, la cui ala più conservatrice si affrettò a correre in soccorso del vincitore.
A dispetto del suo cognome, Gentile non è prodigo di gentilezze nei riguardi del Vaticano: “La costruzione del regime fascista, tra il 1925 e il 1929 - accusa - non incontrò alcuna resistenza da parte della Chiesa di Roma. La Santa Sede assistette da spettatrice silenziosa, ma evidentemente compiaciuta, alla distruzione delle libertà civili e politiche della democrazia parlamentare, rivendicando per sé unicamente l’esercizio della libertà religiosa, in ciò coerente con la dottrina che considerava la libertà di coscienza e le altre libertà politiche e civili il portato diabolico dell’apostasia moderna”.
Quando la dittatura, nel maggio 1928, decide la soppressione di tutte le organizzazioni giovanili che non facevano capo all’Opera Nazionale Balilla, esclusa l’Azione Cattolica, la stampa vicina alla Chiesa reagisce con manifestazioni di giubilo e grandi “inchini e ringraziamenti alla magnanimità del duce”.
Il parroco anticonformista di un paese del mantovano, don Primo Mazzolari, annota nel suo diario: “Oh, poi non è troppo? Dunque vivete per misericordia, per benigna e sovrana concessione di lui? Non c’è più un diritto comune, una libertà comune da rivendicare, entro cui agire, ma il beneplacito del tiranno, che vi ha accantonati, come spazzatura, in attesa che passi per la strada il carretto della nettezza urbana”.
IL VERO CRISTIANO, secondo don Primo, non deve cercare privilegi per sé ma giustizia e libertà per tutti: “Rivendicare un posto per sé soltanto è venir meno alla missione cattolica, senza contare che un privilegio, concesso e accettato a queste condizioni, è piuttosto un capestro e una tremenda responsabilità di fronte all’avvenire”.
La marcia su Roma era stata salutata con sollievo dalla gerarchia, impaurita dai disordini sociali e dal rivoluzionarismo rosso. La bestia fascista, per quanto manesca e brutale anche nei confronti delle organizzazioni cattoliche, sembrava addomesticabile. Ai primi approcci di Mussolini per risolvere la questione romana, nel 1923, papa Ratti manda a dire che il governo del duce “dura da un anno, mentre la Chiesa conta per secoli”. E sei anni più tardi, poco dopo la firma dei Patti Lateranensi, dichiarerà che “per salvare un’anima sarebbe disposto anche a trattare col diavolo in persona”.
Le anime, beninteso, vanno salvate da quelle che Pio XI considera le minacce più gravi che incombono sulla cristianità: il comunismo, “nemico dichiarato della Santa Chiesa e di Dio”, ma anche la democrazia laica, figlia della Rivoluzione francese e della modernità. E questo benché nei Palazzi apostolici siano in molti a chiedersi se “l’idolatria statalista” di Giovanni Gentile e Alfredo Rocco non sia “una brace” peggiore della “padella framassone e demoliberale”.
Più che Contro Cesare, il potente libro di Gentile, denso di retroscena e documenti inediti, dovrebbe intitolarsi Pro Cesare. Come scrive il grande studioso del fascismo, degno erede di De Felice, “all’inizio di un’era di statolatria quale l’Europa non aveva mai conosciuto, neppure nell’epoca del cesaropapismo romano o medievale o nell’era dell’assolutismo e del dispotismo, la Chiesa si trovò schierata, per i privilegi che ne riceveva, con il regime statolatra del nuovo Cesare in camicia nera e con altri dittatori suoi imitatori o ammiratori”.
Il Cesare totalitario del Novecento ha due volti: quello comunista di Stalin che vuole sopprimere la Chiesa e instaurare l’ateismo di stato, e il volto più ambiguo di Mussolini o di Hitler che tentano di asservire la fede di Cristo mescolandola con la propria ideologia, trasformata in religione politica.
Ma i cattolici e i protestanti che, in Italia e in Germania, mettono sullo stesso piano i due totalitarismi, giudicandoli entrambi antitetici al messaggio cristiano, si contano sulla punta delle dita. Tra gli italiani, ai nomi di Mazzolari e Sturzo possiamo aggiungere quelli di Giuseppe Donati e Francesco Luigi Ferrari, morti in esilio a Parigi, e pochi altri.
Comprensibile la rabbia di uno studioso non certo ostile alla Chiesa, Arturo Carlo Jemolo: “Con tutto ciò che da penne cattoliche è stato scritto contro il fascismo si riempirebbe a stento uno scaffaletto di libreria; con quanto è stato scritto nello stesso periodo contro il comunismo, una biblioteca”.
La lista dei capi di imputazione a carico della Santa Sede, secondo Gentile, è molto lunga: le dimissioni e l’esilio di don Sturzo, l’opposizione a un fronte antifascista dopo il delitto Matteotti, la sconfessione del Partito Popolare, l’avallo silente al soffocamento della democrazia italiana, e infine gli accordi del Laterano. Soltanto nel 1931, con l’enciclica Non abbiamo bisogno, e soprattutto dopo le leggi razziali del ’38, papa Ratti comincia a prendere le distanze dalla “statolatria pagana” di Mussolini e dai suoi crimini. Ma non arriva mai a paragonare il fascismo al bolscevismo, che rappresenta per lui il male assoluto. Lascio agli storici colleghi e rivali di Gentile, ben più titolati di me, il compito di confutare la sua ricostruzione, certo non tenera, a tratti perfino ingenerosa nei confronti della Chiesa e di Pio XI.
Mi limito a osservare che a quei tempi, almeno, papi e vescovi avevano qualche fondato motivo per essere prudenti. Adesso che non rischiano di finire in un lager o di essere manganellati, recitano un Te Deum al giorno per il Cesare di Arcore, senza nemmeno aspettare il Tartaglia di turno che gli tiri il duomo in faccia. Viene da domandarsi cosa ci voglia ancora, perché i monsignori aprano finalmente gli occhi e la bocca. Magari che Cesare rottami la Costituzione e trasformi il Quirinale in un bordello? O sono pronti a barattare pure quello in cambio di uno sconto sull’Ici e di qualche aiutino alle scuole cattoliche?
Il comune nemico dei regimi totalitari? La fede cristiana
di Giampietro Berti (Il Giornale, Dom, 23/01/2011)
Il comunismo, il fascismo e il nazismo, i regimi totalitari affermatisi rispettivamente in Russia, in Italia e in Germania, sono stati accomunati dal rigetto della modernità laica ed edonistica prodotta dal capitalismo e dalla società liberale. Anche se in modo difforme, queste diverse espressioni totalitarie hanno soprattutto combattuto un nemico comune, l’individualismo, e, per conseguenza, la società di mercato e l’atomizzazione della vita sociale. Le ideologie totalitarie si sono configurate come surrogati della fede religiosa, venuta meno a causa dal processo di secolarizzazione iniziato con l’illuminismo.
L’impressionante somiglianza strutturale fra comunismo, fascismo e nazismo non è consistita, ovviamente, nell’avere avuto i medesimi fini, ma nell’aver attivato mezzi analoghi, volti a imporre il predominio del potere politico (lo Stato) su tutto il resto. Una supremazia che non poteva lasciare immune anche la vita religiosa, vale a dire il cristianesimo e le Chiese che lo rappresentavano: l’ortodossa, la luterana e la cattolica. Con il totalitarismo si è affermata quindi la supremazia di Cesare su Cristo, il primato dell’immanente sul trascendente. Il progetto totalitario fu proteso a veicolare una medesima idea palingenetica di ascendenza nietzscheana, quella dell’uomo nuovo, tradotta nella divinizzazione del proletariato, della nazione e della razza. Di qui la sua micidiale enfasi statocratica formulata nella gigantesca impresa collettiva rappresentata, per l’appunto, dall’azione statale, volta a realizzare obiettivi di sacralità terrena in radicale contrasto con quella cristiana.
Il nuovo e importante lavoro di Emilio Gentile, Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi (Feltrinelli, pagg. 441, euro 25), affronta questa complessa tematica politico-religiosa, così come si è manifestata nel comunismo, nel fascismo e nel nazismo. Naturalmente la coercizione totalitaria verso il cristianesimo non ebbe nei tre regimi la medesima fenomenologia perché, come è noto, mentre con il comunismo essa si dispiegò in modo completo (l’ateismo di Stato fu esplicito e totale: di fatto la Chiesa ortodossa e ogni forma di vita religiosa vennero spazzate via), con fascismo e nazismo l’atteggiamento verso la religione cristiana si articolò in modo differente.
E ciò perché - questa è la nostra personale convinzione - solo il comunismo fu un sistema compiutamente totalitario (tutto era nelle mani del Partito-Stato), mentre per il fascismo e il nazismo si deve parlare di sistemi totalitari imperfetti, dal momento che i loro presupposti non erano universalistici, dato che le idee di razza e di nazione erano e sono intrinsecamente parziali. Non a caso continuarono a vivere - sia pure con limitazioni - entità separate: in Italia l’economia mercantile, la monarchia e la Chiesa; in Germania l’economia mercantile e le religioni riformate e cattoliche (questo non significa, ovviamente, che i regimi neri fossero meno nemici della libertà e dell’umanità). Ciò spiega perché questa incompiutezza totalitaria generò fra lo Stato e la Chiesa, specialmente nel nostro Paese, un rapporto più complesso e ambiguo.
Per quanto riguarda il nazismo, sebbene il suo razzismo fosse inequivocabilmente anticristiano (si affermava a chiare lettere la superiorità della razza ariana e il suo diritto a dominare il mondo), non furono molti, all’interno del mondo religioso, coloro che ebbero una lucida cognizione di ciò che significava l’avvento vittorioso della croce uncinata. Gentile dimostra che Hitler e i suoi seguaci si presentarono - almeno all’inizio - come un movimento volto a restaurare l’unità e la grandezza tedesca dopo quella che, agli occhi dell’opinione conservatrice, era stata giudicata la decadenza della repubblica di Weimar. Inoltre la radicale e irriducibile avversione nazista al comunismo ingannò la maggioranza dei fedeli, fossero essi luterani o cattolici, i quali vedevano nella Russia dei soviet il trionfo dell’ateismo più abietto.
Va osservato inoltre che il luteranesimo, di gran lunga la confessione cristiana dominante, era fondato su una «tradizione politica» che, in linea di principio, teorizzava l’ubbidienza verso il potere costituito, secondo l’insegnamento dello stesso Lutero, per il quale, riprendendo San Paolo, era doveroso ubbidire al principe, anche che se malvagio (ogni autorità dipende da Dio). E ciò aiuta a comprendere per quale motivo in Germania il consenso al nazismo sia rimasto pressoché intatto fino alla fine.
Più complessa e ambigua, come abbiamo detto, si presentò invece la questione in Italia, dove la Chiesa cattolica aveva ben altro peso e importanza rispetto a quella luterana. Gentile presenta pertanto, giustamente, il caso del nostro Paese come una sorta di «laboratorio» storico-politico. Si deve registrare anche qui, specialmente per i primi anni, un sostanziale appoggio al regime, sfociato, come è noto, nel Concordato del 1929; conciliazione, ovviamente, che non sancì uno svolgimento lineare fra i due poteri, dato che vi furono anche aperti conflitti, come nel 1927, nel 1931 e, soprattutto, nel 1938, quando vennero approvate le leggi razziali. Atteggiamento dunque, questo della Chiesa cattolica, continuamente oscillante fra l’adesione e il plauso, la deprecazione e il silenzio.
All’interno del cattolicesimo non vi fu dunque una convergenza generale di vedute e di giudizi. Già nella seconda metà degli anni Venti, alcuni cattolici antifascisti - in modo particolare i sacerdoti Luigi Sturzo e Primo Mazzolari, unitamente al giornalista Francesco Luigi Ferrari - compresero il pericolo dell’avanzata integralista del fascismo, proteso a sostituire, con la sua religione politica, la fede nel cristianesimo.
Gentile ricostruisce magistralmente il conflitto che questi e altri cattolici ebbero con l’istituzione ecclesiastica e, ancor più, il travaglio interiore che pervase alcuni di loro negli anni amari dell’esilio. Altri importanti spunti del volume si riscontrano infine nella disamina, a livello internazionale, di forme di dissenso ai totalitarismi, rossi e neri, rappresentate dagli incontri svoltisi negli anni Trenta fra sacerdoti, pastori, teologi e intellettuali cattolici e protestanti di diverse nazionalità: francesi, inglesi, tedeschi e americani. Convegni dettati dalla comune volontà di riflettere sul pericolo totalitario per la sua evidente natura di religione politica volta scalzare le basi della civiltà cristiana, creando un pericolo per l’intera umanità.
Possiamo dire che con questo ulteriore contributo di Gentile abbiamo la possibilità di osservare e capire il totalitarismo, vagliandolo sotto uno dei suoi aspetti più profondi: quello di essere stato, prima di tutto, diversamente dall’ethos cristiano, un progetto pervaso da un prometeismo dove era stato perso ogni senso del limite e della finitudine umana.
-
> LA STELLA DEL DESTINO? "LUCIFERO!" - IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO --- Ironia della storia: i Savoia fanno causa alla Repubblica, Falcone Lucifero e i gioielli della Corona (A. De Mattia).27 gennaio 2022, di Federico La Sala
Il caso.
Ironia della storia: i Savoia fanno causa alla Repubblica
I discendenti della dinastia rivogliono i gioielli della Corona custoditi in Banca d’Italia
di Angelo De Mattia (Avvenire, giovedì 27 gennaio 2022)
- [Foto] La regina Margherita di Savoia indossa il diadema in una foto d’epoca - Ansa
L’ironia della storia ha colpito. E ha fatto sì che, mentre si sta progettando un "conclave laico" per arrivare a una candidatura condivisa per l’elezione a presidente della Repubblica (nella speranza ovviamente di una durata inferiore a quella del famoso primo conclave di Viterbo dal 1268 per l’elezione del papa Gregorio X), ha fatto irruzione nelle cronache una questione monarchica, la rivendica, cioè, dei gioielli della Corona da parte dei discendenti di Casa Savoia, depositati presso la Banca d’Italia. La carica elettiva per la più alta magistratura della Repubblica, nata dalla cacciata dei Savoia, da un lato; gli eredi della monarchia all’epoca esiliata, dall’altro (mentre, per di più, l’Unione monarchica lancia Aimone di Savoia come possibile «grande presidente»).
Caduto il regime monarchico, Umberto II incaricò il ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, di costituire le gioie in un deposito vincolato, da restituire a chi ne abbia diritto. Sono trascorsi da allora 75 anni, ma il deposito è rimasto tale e quale e l’avente diritto non è stato materializzato. In questi anni, frequenti sono state le richieste di chiarimenti sul deposito e la necessità di definire finalmente la proprietà dei gioielli, oggetto di stime che vanno dalle centinaia di milioni a solo qualche milione, come rileva un’indagine di Francesco De Leo.
Sussiste, comunque, un valore, innanzitutto storico, che va oltre quello venale. In questi giorni gli eredi Savoia hanno tentato, ma senza risultato, una mediazione con il governo il quale ritiene, invece, che la proprietà sia dello Stato. A questo punto, come annunciato dal legale dei Savoia, la vicenda si trasferirà nelle aule dei Tribunali. È prevedibile che sarà invocato un complesso di norme, interne e internazionali, per sostenere la proprietà "personale" della Casa reale, non dell’"istituto monarchia", e qui non ci si potrebbe meravigliare che si facesse riferimento pure alla Costituzione, nata dopo la cacciata dei Savoia. Il governo sarebbe fermamente convinto della proprietà delle gioie, divenuta ormai pubblica.
Alle sollecitazioni nel tempo la Banca d’Italia correttamente ha sempre risposto che essa è semplicemente depositaria e che attende la dimostrazione di chi ne ha la proprietà per svincolare il deposito. Lo stesso Draghi, all’epoca governatore a Palazzo Koch, sostenne a suo tempo questa linea scrivendo alla Presidenza del Consiglio perché assumesse una decisione. Sono trascorsi circa 16 anni e stiamo ancora al punto di prima.
Ora, però, a Palazzo Chigi c’è proprio Draghi e, pur non essendo questa la principale questione da affrontare - "a fortiori" ora che della sua posizione si discute, tra aspirazioni, autocandidature e ripiegamenti -, resta pur sempre che, per risolvere il problema, sono sufficienti criteri e indirizzi di normale amministrazione.
E, allora, perché non si smette di temporeggiare? Perché non si dice chiaramente, se tale è il convincimento, che le gioie sono beni della Repubblica e che il deposito va cambiato nella forma tecnico-giuridica propria dei beni dello Stato, senza attendere controversie giudiziarie? O si teme che le posizioni avverse possano avere successo (ma non si capirebbe come...)? Intanto, anche per l’immagine e la dignità della Repubblica, si dovrebbe decidere, abbandonando ogni atteggiamento dilatorio o ipotetici conflitti di competenza tra i ministeri: non vi è bisogno in questa vicenda di un Quinto Fabio Massimo. D’altro canto, pure gli italiani avrebbero diritto di conoscere quali sono i beni depositati da chi è stato costretto, dopo la tragedia della guerra, a lasciare l’Italia. E, magari, di vederli esposti al pubblico.
- DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO.