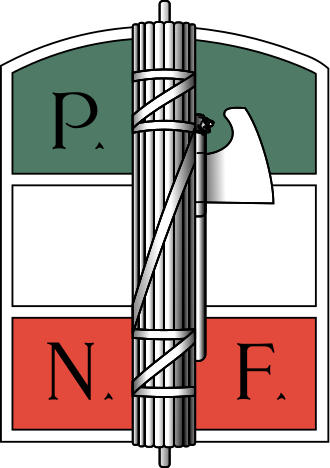
IL LOGO DI MUSSOLINI. Le radici dell’Europa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). Il "gioco" di ogni progetto e "duce" autoritario è stato sempre questo: "AF-FASCInARE" E "AG-GIOGARE" IL POPOLO. NELLO AJELLO ed EMILIO GENTILE fanno il punto.
giovedì 7 dicembre 2006.- [...] I fascisti ebbero sempre una passione per i simboli e i riti: il saluto romano, la camicia nera, il manganello, il giuramento, il culto dei caduti, le parate di massa. Da Gustave Le Bon, precursore della psicologia della folla, Mussolini aveva appreso che «una credenza religiosa o politica si fonda sulla fede, ma senza i riti e i simboli la fede non potrebbe durare». La massa, sentenziava il Duce, è «un gregge di pecore finché non è organizzata», ma per soggiogarla e guidarla occorrevano sia la forza che l’entusiasmo: «Il saluto romano, tutti i canti e le formule, le date e le commemorazioni sono indispensabili per conservare il pathos ad un movimento» [...]
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
FASCIO LITTORIO. IL LOGO DI MUSSOLINI
di Nello AJELLO *
«Il Fascio Littorio è stato adottato come emblema statale», annunzia il 9 dicembre 1926 - ottant’anni fa, esatti - Il Popolo d’Italia, quotidiano di proprietà di Benito Mussolini e diretto da suo fratello Arnaldo. La decisione, promulgata il giorno prima dal governo, mostra «un nuovo segno dello spirito di Roma che torna». Essa sancisce, inoltre, «due perfette identificazioni realizzate» dal regime: «il Partito si identifica con la Nazione, il Partito vive nello Stato».
La solennità dello stile non lascia dubbi sul carattere coercitivo del provvedimento. «Da oggi», precisa il giornale, «il Fascio Littorio, oltre a costituire l’orgoglioso distintivo di ogni camicia nera, ha diritto al rispetto di tutti gli Italiani. Non solo, ma ogni offesa, ogni sfregio al Littorio è un reato che cade sotto la rigorosa sanzione del Codice Penale». Così, «chi distrugge o sfregia» il nuovo simbolo della Nazione «viene punito con la detenzione da tre a venti mesi. Ciò servirà anche di avvertimento perché non si rinnovino certi stupidi tentativi di sfregio al simbolo di Roma e della nostra rivoluzione vittoriosa».
Il concetto di “sfregio” è stato ripetuto a sazietà. Ma adesso il giornale dei Mussolini va sul concreto: di recente, rivela, in provincia di Vicenza «sono state messe in circolazione alcune delle nostre monete da due lire con la falce e il martello incisi sul Fascio Littorio». I colpevoli del sacrilegio non vengono rivelati. Considerando però che in quel 1926 esiste molta gente che ce l’ha a morte con il più imperioso simbolo del regime, ci si può chiedere perché si sia ricorso proprio a quel tipo di dispetto istituzionale, cioè alla provocatoria ammucchiata consistente in fascio più falce e martello. La risposta è insita nella genesi stessa del fascio, nella sua provenienza in quanto emblema o “logo”, e nella disinvoltura mostrata da Mussolini nel farlo suo.
All’epoca del Regio Decreto, insomma, non doveva essere scontato o obbligatorio che il fascio imponesse al pubblico un’immagine di destra. La sua storia induce a dubitarne. In Roma antica, il fascio era l’insegna dell’autorità dei più alti magistrati (consoli, questori, dittatori), di cui simboleggiava l’esercizio del potere e della giustizia. Di origine etrusca, consisteva in una pila di verghe di olmo o betulla, legate insieme da cinghie. In alto veniva inserita una scure: a questa variante, introdotta a partire dall’epoca di Silla, si attribuì una valore di violenza o di morte. Il fascio era portato da ufficiali, chiamati “littori”, davanti ai magistrati quando essi comparivano in pubblico. Nel loro incedere anche le vestali erano precedute da un corteo di littori, che reggevano quel simbolo sulla spalla sinistra; il suo impiego in un contesto muliebre non bastava tuttavia a ingentilire l’emblema, che restava alquanto truce.
Ce n’era abbastanza perché lungo i secoli l’evocazione del fascio venisse utilizzata in contesti retorici. Il pensoso Leopardi accenna in una sua poesia agli «augusti consolari fasci». Assai più incline al patriottismo, Giosuè Carducci figura tra coloro che traghetteranno l’antico simbolo romano fino al Risorgimento: immaginerà, infatti, che l’Italia avesse trovato la sua unità «appoggiandosi con una mano alla croce di Cristo, ma ben presto aveva disteso l’altra a ricercare fra le rovine di Roma i fasci consolari».
Per il fascio cominciava infatti una seconda vita, connessa alle lotte politicosindacali dell’Ottocento. In questa fase esso assunse un significato di unione di forze. Fra i primi a utilizzarne il nome furono, fra il 1870 e il 1880, i Fasci Operai dell’Emilia, capeggiati a Bologna da Andrea Costa. Nel 1883 nacque il Fascio della Democrazia, formato da più di trecento associazioni che si prefiggevano di coordinare la propaganda democratica a sfondo laico e irredentista. Nel decennio successivo usò la dizione di Fasci siciliani quel movimento di contadini poveri che Francesco Crispi energicamente represse nel 1894.
Fascio atto terzo. Esso si svolge all’ombra di Benito Mussolini, legandosi alla variabilità del suo destino politico. Si chiamarono dapprima Fasci di azione rivoluzionaria quelli che il futuro dittatore promosse per sostenere l’intervento dell’Italia nella Grande guerra. Si trattava di attrarre sotto un’unica insegna le forze interventiste di sinistra, e questa intenzione - patriottica ma, insieme, nettamente progressista - avrebbe allarmato i nazionalisti di parte conservatrice. Quando il 23 marzo del 1919 fondò a Milano i Fasci di combattimento - primo nucleo della sua prossima ideologia di potere - Mussolini, come racconta Renzo De Felice, «non aveva per nulla le idee chiare su cosa sarebbero potuti essere».
L’ambiguità delle origini, comunque, non danneggiò il successo popolare del simbolo. Le sue oscillazioni continuarono, al punto da obbligare Alfredo Panzini, autore di un fortunato Dizionario moderno, ad aggiornarne più volte la definizione: nel dicembre del ‘26 (data fondante, come abbiamo visto) registrò il Fascio Littorio come «emblema del nuovo Stato Italiano». L’anno successivo lo definì «obbligatorio accanto all’emblema sabaudo». Nel 1929 avrebbe infine alluso al definitivo accerchiamento della monarchia, registrando la comparsa nell’iconografia pubblica dello «stemma sabaudo fra due fasci».
Il fascio è ormai onnipresente. Figura nel distintivo del partito (la “cimice”, come la gente lo ribattezza) e nelle mostrine delle camicie nere. Invade biglietti di banca, francobolli, copertine di sillabari. Campeggia in ghisa sui tombini di raccolta delle acque. Fasci in rilievo ornano, accanto alla data di costruzione, i nuovi stabili anche privati. Si chiama sinteticamente “Fascio” ogni sezione locale del partito e al fascio s’intitolano le centinaia di bollettini dei gruppi rionali. Il fatto di essere diventato ubiquo fa nascere qualche problema di uniformità: nel 1934, emanando un “Foglio di disposizioni” sul vestiario del perfetto italiano, il regime fascista rac- comanda che sul berretto dei militi il fascio figuri ricamato nella parte anteriore «in oro o metallo d’oro con la scure a destra».
A proposito della scure, una canzone le restituisce l’antico significato punitivo: «Annientato sarà dalla scure / che brandisce la mano littoria / chi si oppone alle mete sicure / che il fascismo ha segnato alla storia». Nel Canto delle bimbe fasciste se ne contempla un uso sentimentale: «Stretti in fascio i nostri cuori / senza ceppi memorandi / senza affanni né dolori / sono come il cuor dei grandi».
In corrispondenza con il frenetico successo che gli è arriso per vent’anni, la decadenza del fascio si rivela brutale all’indomani del 25 luglio 1943. All’esaltazione subentra l’iconoclastia, quasi che l’antico emblema sia responsabile della catastrofe fascista. Come l’Italia s’era stipata di folle osannanti al fascio, così ora sembra gremirsi di scalpellini che vogliono abolirne le tracce. In perfetta consonanza, nei loro diari, registrano il fenomeno due persone assai diverse fra loro: Pietro Nenni e Corrado Alvaro. Usano parole quasi identiche. «I simboli del fascismo», scrive il capo socialista il 6 agosto, «sono stati scalpellati dai pubblici edifici e si direbbe che non abbiano avuto la minima presa nei cuori». E il romanziere calabrese: «I muratori e gli scalpellini della Capitale, per molti giorni, non hanno da fare altro che scalpellare le insegne del fascio». Il risultato? «Tutto buchi», conclude Alvaro, riferendosi - per estensione e con tristezza - al Paese in generale.
In seguito molti italiani si accorgeranno che quell’opera di ripulitura dal fascio, benché provvisoriamente solerte, non poté essere completa. Qua e là si trovano residui, magari sdruciti, dell’antico simbolo. Ormai sembra tardi per fare altri buchi.
Una foresta di simboli per plasmare la folla.
 Nessuna politica ne ha fatto a meno
Nessuna politica ne ha fatto a meno
di EMILIO GENTILE *
«Giù il cappello!», urla il ragioniere Giuseppe D’Amore (Aldo Fabrizi), in divisa fascista, schiaffeggiando il cavaliere Antonio Cocozza (Totò) che assiste indifferente al passaggio del gagliardetto col fascio littorio. Questa scena, tratta da un film di Mario Mattoli, non è un’invenzione polemica. Nel novembre 1926 il Foglio d’ordini del Partito fascista, in una nota intitolata Giù il cappello, dichiarava legittima la consuetudine dei fascisti di «esigere dai passanti durante le nostre sfilate, il saluto ai gagliardetti che sono il simbolo vivo della nostra passione nutrita di sacrificio e della nostra fede nuova italiana e fascista».
L’imposizione dei propri simboli fu una manifestazione peculiare del fascismo, fin dalle origini. Una “guerra dei simboli” accompagnò la violenza squadrista contro gli avversari, la distruzione delle organizzazioni proletarie, la marcia su Roma e la conquista e il monopolio del potere.
I fascisti ebbero sempre una passione per i simboli e i riti: il saluto romano, la camicia nera, il manganello, il giuramento, il culto dei caduti, le parate di massa. Da Gustave Le Bon, precursore della psicologia della folla, Mussolini aveva appreso che «una credenza religiosa o politica si fonda sulla fede, ma senza i riti e i simboli la fede non potrebbe durare». La massa, sentenziava il Duce, è «un gregge di pecore finché non è organizzata», ma per soggiogarla e guidarla occorrevano sia la forza che l’entusiasmo: «Il saluto romano, tutti i canti e le formule, le date e le commemorazioni sono indispensabili per conservare il pathos ad un movimento».
Negli anni del regime questa passione divenne un’ossessione maniacale, per celebrare ovunque, in ogni luogo e in ogni momento della vita degli italiani, il “culto del littorio”. Per oltre due decenni, durante il fascismo, l’Italia fu invasa da una foresta di simboli. Oltre l’onnipresente fascio littorio, erano simboli del regime anche le variegate uniformi delle organizzazioni maschili e femminili del Partito fascista, i monumenti della nuova architettura in “stile littorio”, i riti periodici della “rivoluzione delle camicie nere”, le feste civili, le feste folcloristiche e persino le manifestazioni sportive e le esibizioni ginniche. I massimi eventi simbolici del regime erano gli incontri del Duce con la folla e le adunate oceaniche per celebrare momenti eccezionali, come la proclamazione dell’Impero.
Qualche studioso ha sostenuto che la sovrabbondanza di simboli nel fascismo prova la sua carenza ideologica. Una simile interpretazione sottovaluta la funzione del simbolismo politico. Nella religione, come nella politica, il simbolo è sempre un’interpretazione della vita condensata in un oggetto, in una parola, in un’immagine, in un comportamento, in un luogo o in una persona.
Il simbolo è il linguaggio proprio della credenza e del mito. L’uomo è un animale simbolico, ha affermato il filosofo Ernst Cassirer, uno dei maggiori studiosi del simbolismo. Inoltre, ha spiegato il filosofo Manuel García Pelayo, il simbolo è un mezzo potente per integrare l’individuo nel gruppo, per modellare un’identità collettiva. Per questi studiosi, l’esperienza fascista fu un importante campo di osservazione per elaborare una teoria moderna dei simboli come strumenti del potere.
Il potere ha sempre usato il linguaggio dei simboli e dei miti. Nessuna politica, democratica, autoritaria o totalitaria, ha fatto a meno di simboli e miti, anche quando professava un’ideologia razionalista, come il marxismo. La foresta dei simboli nei regimi comunisti era altrettanto lussureggiante della foresta dei simboli nei regimi fascisti. Il fascismo, tuttavia, è stato l’unico regime che ha esaltato apertamente il primato del mito nella vita collettiva. Il suo simbolismo fu la coerente espressione ideologica di un esperimento totalitario, che soggiogò l’uomo e le masse, eccitandone l’irrazionalità, attraverso miti e simboli, perché negava loro il diritto e la capacità di potersi governare liberamente con l’esercizio della ragione.
 Lo storico Emilio Gentile è autore
di numerosi libri, tra cui “Il culto del littorio
La sacralizzazione della politica
nell’Italia fascista”, Laterza 2005
Lo storico Emilio Gentile è autore
di numerosi libri, tra cui “Il culto del littorio
La sacralizzazione della politica
nell’Italia fascista”, Laterza 2005
* la Repubblica/DOMENICA, 03.12.2006
Sul tema del "fascio", da un punto di vista filosofico, nel sito si cfr.
 Per la rinascita dell’Europa, e dell’Italia. La buona-indicazione del Brasile.
Per la rinascita dell’Europa, e dell’Italia. La buona-indicazione del Brasile.
 SOCIETA’ ARCAICA, NEVROSI OSSESSIVA E FASCISMO.
SOCIETA’ ARCAICA, NEVROSI OSSESSIVA E FASCISMO.
 IL CATTOLICESIMO CON LA CROCE UNCINATA
IL CATTOLICESIMO CON LA CROCE UNCINATA
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
FLS
Forum
-
> IL LOGO DI MUSSOLINI. Le radici dell’Europa e il "fascismo" -- ’Quando c’era Lui’: una guida alle bufale storiche sul fascismo (di Leonardo Bianchi).24 luglio 2017, di Federico La Sala
’Quando c’era Lui’: una guida alle bufale storiche sul fascismo
di LEONARDO BIANCHI *
Il duce ha inventato le pensioni, ci ha regalato la tredicesima, ha reso grande l’Italia e non era razzista. Anche no.
A partire dal caso della "spiaggia fascista" di Chioggia, per poi passare alla proposta di legge di Emanuele Fiano o alle dichiarazioni (fraintese) di Laura Boldrini sui monumenti del regime, questo luglio ci siamo confrontati praticamente ogni giorno sul fascismo e la sua eredità.
Per alcuni commentatori, l’Italia non ha mai fatto veramente i conti con il Ventennio e dunque è destinata a essere perennemente attraversata da pulsioni nostalgiche o antidemocratiche. Dall’altro lato episodi come quello di Playa Punta Canna sono definiti innocue "goliardate," e insieme a derubricazioni di questo tipo continuano a resistere le argomentazioni più o meno revisioniste-del tipo che nel Ventennio, comunque la si pensi, qualcosa di buono è stato fatto; o che comunque non era così malaccio come ci hanno sempre fatto credere.
Quest’ultimi sono dei refrain che si sentono da tempo immemore, ma che con l’avvento dei social stanno vivendo una sorta di seconda epoca d’oro.
- PUBBLICITÀ
In particolare, proprio in concomitanza con le polemiche delle ultime settimane, sul FascioFacebook (e non solo) hanno ricominciato a girare una serie di miti e leggende sulle grandi conquiste sociali ed economiche del fascismo-conquiste che sono contrapposte alla contemporaneità, e servono sostanzialmente a dire: "Vedete? Mentre i politici di adesso non fanno un cazzo, LVI le cose le faceva sul serio!"
Visto che tali bufale riaffiorano di continuo-e dimostrano un’incredibile persistenza proprio perché distorcono verità storiche e le mescolano con la disinformazione-ho pensato di mettere in fila quelle che hanno avuto più successo e risonanza.
- IL DUCE HA CREATO LE PENSIONI
Quella di Mussolini che ha creato da zero il sistema pensionistico di cui godremmo tutt’ora è senza dubbio la bufala più persistente e di successo, al punto tale che un anno fa Matteo Salvini ha dichiarato: "Per i pensionati ha fatto sicuramente di più Mussolini che la Fornero. [...] La previdenza sociale l’ha portata Mussolini."
In realtà, non è proprio così. Come si può agevolmente verificare sul sito dell’INPS, la previdenza sociale nasce nel 1898 con la creazione della Cassa Nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai. Si trattava di un’"assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo anch’esso libero degli imprenditori."
Nel 1919 l’iscrizione alla Cassa diventa obbligatoria e interessa 12 milioni di lavoratori. Vent’anni dopo, il regime promuove varie misure previdenziali, tra cui le assicurazioni contro la disoccupazione, gli assegni familiari e la pensione di reversibilità. La pensione sociale, tuttavia, è istituita solo nel 1969-ossia a 24 anni dalla morte di Mussolini.
- PUBBLICITÀ
- IL DUCE CI HA REGALATO LA TREDICESIMA
Un’altra leggenda che circola molto (soprattutto sotto Natale) è la seguente: se abbiamo un mese di stipendio in più è merito esclusivo della magnanimità di Mussolini. Anche in questo caso, tuttavia, la storia è diversa.
Nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 1937 venne effettivamente introdotta una "gratifica natalizia." La mensilità in più era tuttavia destinata ai soli impiegati del settore dell’industria; e non ad esempio agli operai dello stesso settore, che anzi si videro aumentare le ore di lavoro giornaliero fino a 10, e 12 con gli straordinari non rifiutabili.
Come scritto in questo post, insomma, si trattava di una misura "in piena linea con quelle che erano le normali politiche dell’epoca fascista, in una società [...] bloccata sul corporativismo basato non sul diritto per tutti, ma sul privilegio di pochi gruppi e settori."
La vera tredicesima è stata istituita prima con l’accordo interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946, e poi estesa a tutti i lavoratori con il decreto 1070/1960 del presidente della Repubblica.
- SOLO CON IL FASCISMO L’ITALIA HA RAGGIUNTO IL PAREGGIO DI BILANCIO
- PUBBLICITÀ
Nell’immagine qui sopra, si ricorda enfaticamente che il "Governo Fascista" raggiunse il pareggio di bilancio nel 1924, praticamente grazie alla lotta contro gli sprechi e alla riduzione delle tasse. Morale della favola: con tutte le tasse che ci sono adesso, invece, i conti dello Stato non tornano mai. Ergo: la Casta è inetta, ci soffoca con la pressione fiscale, e dunque si stava meglio prima.
Ora, il pareggio di bilancio fu effettivamente raggiunto (nel 1925, e non nel 1924). Ma come tutte le disinformazioni che si rispettino, si evita accuratamente di dire cose successe prima e dopo il raggiungimento di quel traguardo.
L’artefice fu il ministro delle finanze e dell’economia, Alberto De Stefani. Dal 1922 in poi, l’economista spinse per la liberalizzazione dell’economia, cercò di contenere l’inflazione, ridusse la spesa pubblica e la disoccupazione. La sua politica di "neoliberismo autoritario" era però vista di cattivo occhio sia dalla parte più radicale del fascismo, che soprattutto da latifondisti, industriali e grandi capitalisti.
Non a caso, nel luglio del 1925 venne destituito dopo aver presentato ripetutamente le dimissioni; e da lì in poi iniziò ad assumere posizioni sempre più critiche (non in senso democratico o antifascista, ovviamente) nei confronti del regime e della sua nuova politica economica che-tra la Grande Depressione, l’autarchia e tutto il resto-portò il paese allo sfascio. Per citare un articolo che si è occupato di smontare il messaggio implicito di questo mito, "un modello che è crollato su se stesso non è il miglior modello."
- IL DUCE HA RICOSTRUITO I PAESI TERREMOTATI IN UN BATTER D’OCCHIO
- PUBBLICITÀ
Anche la storia della prodigiosa ricostruzione del Duce dopo il terremoto del Vulture (in Lucania) del 23 luglio 1930 è piuttosto ricorrente.
La fonte primaria, ripresa dai siti di estrema destra e replicata in vari meme, è un articolo del Secolo d’Italia pubblicato dopo il terremoto che l’anno scorso ha colpito il centro Italia. In esso si sostiene che in appena tre mesi si costruirono 3.746 case e se ne ripararono 5.190, e si infila pure il commento agiografico "altri tempi, ma soprattutto altre tempre..."
Il dato è però parziale e decontestualizzato. Come si può verificare dal sito dell’INGV, nell’ottobre del 1930 furono ultimate "casette asismiche in muratura corrispondenti a 1705 alloggi" e "riparate dal genio Civile 2340 case." Solo nel settembre del 1931-a operazioni ultimate-si raggiunge la cifra indicata nell’articolo, che corrisponde a 3.746 alloggi in 961 casette. Insomma: i numeri sono comunque rilevanti per l’epoca, ma non è semplicemente vero che in appena tre mesi fu ricostruito tutto da zero.
- IL FASCISMO HA RESO L’ITALIA UN FARO PER LE SCOPERTE SCIENTIFICHE
In questa immagine, rivolta a tutti quelli che "NON L’AMMETTERANNO MAI," si sostiene con la forza di una bella scritta in maiuscolo che il fascismo avesse reso l’Italia-tra le varie cose-"una nazione faro per scoperte scientifiche."
Nei primi anni del regime però, come ricostruisce dettagliatamente questo articolo sulla Treccani, il governo "aveva sostanzialmente ignorato tutte le questioni connesso con l’organizzazione della struttura di ricerca scientifica," che rimaneva quella dell’Italia liberale ed era carica di problemi. Nel 1923 venne avviato il CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), la prima struttura deputata a svolgere ricerca "su temi di interesse generale." La sua attività fu subito caratterizzata dalla penuria dei finanziamenti, segno della "scarsa fiducia nel nuovo ente che ancora nutriva Mussolini."
Col passare degli anni, nonostante i proclami e la propaganda, il CNR non divenne mai incisivo e non produsse nulla di significativo, soprattutto perché la sua unica indicazione di ricerca era quella per l’autarchia-un’indicazione troppo generica. Lo scoppio della seconda guerra mondiale, poi, "allontanò in modo generalizzato i più giovani tra ricercatori, assistenti, tecnici di laboratorio e, in breve tempo, il lavoro scientifico rallentò fino alla quasi totale paralisi."
- PUBBLICITÀ
Nel 1938, a riprova di quanto al fascismo non fregasse nulla della scienza, l’ambiente scientifico italiano era stato travolto dal più infame e antiscientifico degli atti politici del regime: la promulgazione delle leggi razziali. Il che mi porta all’ultima leggenda che ho scelto per compilare questa lista.
- IL DUCE NON ERA RAZZISTA, E NEMMENO IL FASCISMO ERA UN REGIME RAZZISTA
Con ogni probabilità questa è la mistificazione più odiosa, che fa leva sul radicato stereotipo del "bravo italiano" e del "cattivo tedesco."
Se è vero che in un primo momento i rapporti tra gli ebrei e il fascismo furono "normali," e lo stesso Mussolini-nel libro Colloqui con Mussolini-disse che "l’antisemitismo non esiste in Italia," le cose cambiarono progressivamente con la torsione totalitaria del regime e sfociarono infine nelle persecuzioni.
La maggior parte della storiografia è ormai concorde sul fatto che l’antisemitismo e le leggi razziali non furono introdotte per imposizione della Germania-il Manifesto della razza, ad esempio, pare che sia stato scritto dallo stesso Mussolini.
Piuttosto, come sostiene lo storico Enzo Collotti, la "spinta a una politica della razza nel fascismo italiano" da un lato era "iniziativa e prodotto autonomo" del regime-specialmente dopo il 1933 e l’affermazione del nazismo-e dall’altro era una scelta "connaturata allo stesso retaggio nazionalista, che esaltava la superiorità della stirpe come fatto biologico e non solo culturale."
- PUBBLICITÀ
Lo stesso discorso si può fare con la "civilizzazione" delle colonie, che si pone in perfetta continuità con quanto detto sopra. Secondo Collotti, la guerra d’aggressione contro l’Etiopia nel 1935 è stata "l’occasione per mettere a fuoco una politica razzista dell’Italia fascista"; e dopo la conquista del paese-mai completata fino in fondo-"fu instaurato un vero e proprio regime di separazione razziale, un vero e proprio prototipo di apartheid."
Dire che il fascismo non era un regime razzista è negare una delle sue caratteristiche fondamentali. Se si porta all’estremo questo ragionamento, si finisce col dire che il fascismo non era fascista. E non penso che al Duce farebbe molto piacere, no?
* FONTE. VICE.COM, Jul 24 2017 (RIPRESA SENZA IMMAGINI E SENZA NOTE).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL "LOGO" DI MUSSOLINI. Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). Il "gioco" di ogni progetto e "duce" autoritario è stato sempre questo: "AF-FASCInARE" E "AG-GIOGARE" IL POPOLO. NELLO AJELLO ed EMILIO GENTILE fanno il punto.
ISTITUIRE LA GIORNATA DELLA MEMORIA per 500mila Africani uccisi dalla presenza coloniale italiana in LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA. UNA PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA
-
> IMMAGINARIO E POLITICA. RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI.3 aprile 2017, di Federico La Sala
IMMAGINARIO E POLITICA. ALLE ORIGINI DEL SUPERUOMO DI MASSA E DELL’ITALIA COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DI UN UOMO SUPREMO
 KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE. Materiali sul tema
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE. Materiali sul tema Storiografia in crisi d’identità ...
Storiografia in crisi d’identità ...
 RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO. -
>"LOGO" DI MUSSOLINI. --- Il gesto a noi noto come «saluto romano», lo inventò il cinema. In chiave politica viene usato per la prima volta dai legionari fiumani dello stesso d’Annunzio nel 1919.18 gennaio 2016, di Federico La Sala
Il gesto a noi noto come «saluto romano»
I Cesari non c’entrano
Lo inventò il cinema (ed è finito su Star Trek)
di Livia Capponi (Corriere della Sera, La Lettura, 17.01.2016)
Il gesto a noi noto come «saluto romano», con il braccio destro teso alzato a circa 135 gradi dal corpo, e con le dita della mano unite, adottato dal regime fascista e poi dal nazismo, si presentava esplicitamente come un revival dell’eredità di Roma. Ma esisteva davvero quel gesto specifico di saluto nel mondo antico? La più comune forma di saluto nella Grecia classica era una semplice stretta di mano. A Roma i legionari battevano il palmo o il pugno sul petto, come è stato efficacemente rievocato dal cinema. I gladiatori si afferravano l’avambraccio destro al di sopra del polso.
Sorprendentemente, esisteva anche un saluto militare simile a quello odierno, che a torto si credeva un’invenzione medievale. I soldati romani, i barbari e gli imperatori raffigurati a Roma, sugli archi di Tito e di Costantino e sui fregi di argomento storico delle colonne di Traiano e di Marco Aurelio, si sbracciano in svariati gesti, il cui preciso significato non è sempre chiaro. In molti casi, sia i soldati che l’imperatore salutano alzando la mano aperta, come faremmo noi. Altre volte, l’imperatore alza leggermente anche il braccio, ma, come notano Andrea Giardina e André Vauchez nel libro Il mito di Roma (Laterza, 2008), è un gesto che spesso accompagna un augurio o un discorso rivolto ai legionari, con il palmo della mano verticale e le dita aperte.
Il grande fregio storico che avvolge a spirale, come la pellicola di un film, la colonna Traiana, innalzata per celebrare la conquista della Dacia da parte di Traiano fra il 101 e il 106 d.C., e studiato da Filippo Coarelli in La colonna Traiana (Colombo, 1999), mostra diverse scene di incontro fra l’imperatore, i soldati e i barbari. Nel fregio 65, l’imperatore a cavallo è salutato da alcuni barbari con le braccia stese o piegate in segno di sottomissione. Nel fregio 103, Traiano riceve una delegazione nemica: un Dace leva il braccio verso l’imperatore in segno di supplica. Nel fregio 75, Traiano arriva a un forte romano in Dacia, e viene salutato da un gruppo di legionari e ufficiali romani; il saluto non è sempre uguale ma con il braccio più o meno piegato, mai teso.
Nella monetazione e nella scultura romana ci sono molte scene di arringa, acclamazione, arrivo e partenza, dove il braccio alzato può esprimere benedizione, saluto o potere, e il più delle volte non è ricambiato. Un famoso esempio è l’Augusto di Prima Porta, raffigurato come un generale vittorioso che si rivolge alla folla, il braccio leggermente piegato in un movimento nobile e controllato, il corpo per niente sull’attenti ma, al contrario, bilanciato da una torsione contrapposta delle gambe divaricate e flesse, secondo i canoni derivati dalla Grecia classica. La celebre statua bronzea nota come l’ Arringatore , dedicata al notabile etrusco Aulo Metello alla fine del II secolo a.C. e oggi a Firenze, presenta lo stesso gesto del braccio appena piegato con la mano alzata, nell’atto di chi chiede solennemente l’attenzione del pubblico prima di cominciare a parlare.
Secondo il libro di Martin M. Winkler The Roman Salute. Cinema, History, Ideology (Ohio state university press, 2009), l’archeologia, come pure tutta la letteratura latina, non ci mostra una sola immagine chiara del gesto specifico adottato dal fascismo. Winkler sostiene che il saluto romano fu associato all’antica Roma retrospettivamente e in tempi moderni. Un passaggio cruciale fu il dipinto di Jacques-Louis David Il giuramento degli Orazi, realizzato nel 1784 e oggi al Louvre. Manifesto del Neoclassicismo, l’opera trae spunto da una leggenda romana, di cui parla Tito Livio, secondo cui, durante il regno di Tullo Ostilio (672-640 a.C.) per decidere l’esito della guerra tra Roma e Alba Longa, tre fratelli romani, gli Orazi, sfidarono a duello tre fratelli di Alba, i Curiazi. Dei Curiazi non sopravvisse nessuno, mentre uno degli Orazi riuscì a ritornare, decretando la vittoria dei Romani. La scena rappresenta il padre degli Orazi nell’atto di dare loro le spade, che innalza in un gesto di augurio.
Il gesto dei tre fratelli non è un saluto ma un giuramento di fedeltà a Roma, fatto in due casi con il braccio sinistro. L’atteggiamento dei corpi e i colori delle vesti simboleggiano i valori di libertà, uguaglianza e fraternità della Francia rivoluzionaria. Tuttavia, il dipinto può essere considerato un punto di svolta nel graduale processo che vide la reinvenzione del gesto, progressivamente percepito come un saluto più che un giuramento.
Un altro probabile precedente fu il saluto a braccio alzato alla bandiera, o Pledge of Allegiance, creato da Francis Bellamy nel 1892 e adottato nelle scuole degli Stati Uniti fino agli anni Trenta, e poi copiato dal fascismo. La controversa associazione, come ha messo in luce il ricercatore statunitense Rex Curry, ha poi fatto sì che il gesto fosse sostituito dalla mano sul cuore, per volere di Franklin Delano Roosevelt.
Ma a riportare davvero in vita i Romani per un pubblico di massa fu il cinema del primo Novecento, che reinventò i gesti, oltre che i costumi, degli antichi, prendendo spunto dal repertorio di convenzioni fissato dal teatro preesistente. Il film Cabiria di Giovanni Pastrone (1914), il più grande kolossal del cinema muto italiano, che vantava Gabriele d’Annunzio come sceneggiatore e autore delle didascalie, consacra il gesto come simbolo della romanità: difatti in chiave politica viene usato per la prima volta dai legionari fiumani dello stesso d’Annunzio nel 1919.
In Scipione l’Africano di Carmine Gallone (1937) il saluto ricorre ossessivamente a richiamare l’associazione romanità-fascismo. Il successivo cinema del dopoguerra ha ormai interiorizzato questa visione di Roma, e la popolarità dei grandi kolossal hollywoodiani di argomento religioso conferisce ulteriore credibilità ai dettagli in essi contenuti. Ben-Hur di William Wyler (1959) e Quo Vadis di Mervyn LeRoy (1951) fanno esplicito riferimento a Roma come metafora del fascismo, e agli Ebrei e ai Cristiani come simbolo della libertà degli Stati Uniti. Il saluto romano di Peter Ustinov nei panni di Nerone scimmiotta mostruosamente bene i grandi dittatori. Nei film più recenti, fino alla televisione di Star Trek, il saluto romano non è più esplicitamente associato al fascismo o al nazismo ma è comunque usato per evocare regimi autoritari.
L’assenza di prove inconfutabili sull’esistenza del saluto romano nel mondo antico è l’esempio di come una narrazione potente sia in grado di produrre una storia irreale e di farla accettare come una verità storica dal grande pubblico, incapace o disinteressato a cogliere il paradosso. Mistificare un fatto inventato spacciandolo come realmente accaduto, o riempire il passato di contenuti attuali, d’altra parte, è un vecchio trucco narrativo, quello, sì, utilizzato fin dai tempi dei Romani.
-
>"AF-FASCInARE" E "AG-GIOGARE" IL POPOLO... il punto sul "LOGO" DI MUSSOLINI. -- I diari dimenticati: scaduti i diritti sugli scritti del duce studiosi di destra e sinistra riscoprono le memorie della grande guerra12 gennaio 2016, di Federico La Sala
Mussolini senza copyright tornano i diari dimenticati
Scaduti i diritti sugli scritti del duce studiosi di destra e sinistra riscoprono le memorie della grande guerra
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 12.01.2016)
Tutti pazzi per Mussolini? Parrebbe di sì, solo a guardare gli scaffali delle librerie. Dove sono appena arrivate ben cinque edizioni del diario di guerra di Mussolini, ossia le cronache dal fronte pubblicate sul “Popolo d’Italia” tra il dicembre del 1915 e il febbraio del 1917. Il Mussolini soldato, non ancora duce, ma già sapiente artefice di un’autorappresentazione che gli sarebbe tornata utile.
L’inatteso fenomeno editoriale sembra contagiare geografie culturali ed editoriali molto distanti, dalla sinistra di Mario Isnenghi e Mimmo Franzinelli alla destra postfascista di Alessandro Campi, fino a toccare le sponde eversive e criminali di Franco Freda, sì lui, il terrorista, responsabile insieme a Ventura della strage di piazza Fontana, che incredibilmente sopravvive come editore di Ar (marchio distribuito da una libreria di Avellino). E accanto a questi lavori c’è anche il journal mussoliniano curato da Denis Vidale per la Biblioteca dei Leoni. A tenerli insieme, nella siderale lontananza, la comune riscoperta di un testo ovviamente riproposto più volte nel ventennio nero, poi rimasto sepolto nell’opera omnia mussoliniana e di fatto ignorato dalla storiografia della grande guerra.
Perché questo improvviso interesse per il diario dal fronte? La risposta più semplice è di carattere giuridico ed editoriale: sono appena scaduti i diritti di Mussolini - proprio come quelli di Hitler - , le case editrici possono liberamente riproporre i testi senza passare attraverso la tagliola del copyright.
Spiega Ugo Berti, responsabile del catalogo storico del Mulino che ora pubblica l’opera con la introduzione di Isnenghi (Il mio diario di guerra): «Nel centenario del primo conflitto mondiale siamo andati tutti a riguardarci la bibliografia, scoprendo in questo modo testi dimenticati come il diario di Mussolini. La coincidenza dello scadere dei diritti ha fatto il resto. Da qui il gran fermento dell’editoria, mossa anche da ragioni di mercato: la grande guerra fa vendere». Una spiegazione minimalista, quella di Berti, che seppure fondata non esaurisce la questione.
E allora per capire di più bisogna partire dalla sponda sinistra. E chiedersi perché uno storico come Isnenghi, che nel Mito della Grande Guerra aveva ignorato il diario di Mussolini, oggi decida di firmarne la introduzione. «Ho cominciato a fare i conti con quel lavoro in uno dei convegni animati da Gianfranco Folena a Bressanone », risponde lo studioso dalla sua casa di Padova. «Poi, nel 1989, quando ho ripubblicato Il Mito dal Mulino, decisi di riconoscere pubblicamente il mio errore: il diario di Mussolini è uno dei testi più incisivi della letteratura di guerra. Si era trattato di un’automutilazione, dettata dal clima politico e culturale in cui preparai il Mito». Il suo capolavoro storiografico uscì in prima edizione da Laterza nel 1970, nel pieno dell’antifascismo militante. «Nessuno mi ha mai rimproverato quell’omissione», continua Isnenghi. «La memoria del fascismo era ancora molto viva. Oggi rimuovere il diario di Mussolini non avrebbe senso».
Però ancora oggi c’è chi oppone resistenza. Ed è lo stesso Berti a raccontarcelo, dal suo longevo osservatorio storiografico. «Il nome di Mussolini per qualche storico è tuttora impronunciabile. Ancora Marco Mondini, nel suo bel libro La guerra italiana pubblicato lo scorso anno, nemmeno cita il diario. Gli ho chiesto perché e lui mi ha risposto che gli era apparso inopportuno occuparsene».
Ad alcuni studiosi, al contrario, appare opportuno occuparsene proprio con un intento civile. È il caso di Mimmo Franzinelli, curatore del Giornale di guerra per le edizioni Leg. «Anche nella diversità dei testi, accade con i diari di Mussolini quello che è successo con il Mein Kampf. Anche io mi sono posto il problema dell’opportunità: ho scelto di pubblicare il testo con centinaia di note in cui invito a non prendere per oro colato le parole del soldato Mussolini. In sostanza cerco di demistificare la sua autorappresentazione eroica, mostrando la doppiezza tra il Mussolini politico e il Mussolini militare». Un taglio critico in parte coincidente con la lettura di Isnenghi, che mette in guardia dalla finalità di Mussolini: orientare lo sguardo di chi lo legge - si tratta di un diario pubblico, pubblicato sul suo giornale, non un diario privato - offrendo di sé l’immagine di «protagonista e coro, leader e gregario, attore politico trainante e soldato nella massa». Insomma, ricerca del consenso e prove generali da futuro duce.
Lettura che non convince Alessandro Campi - un passato remoto nelle file del neofascismo, un passato prossimo da protagonista nel laboratorio della nuova destra democratica di Gianfranco Fini, oggi direttore della Rivista di Politica. Tra pochi giorni esce da Rubbettino una sua accurata edizione storico-critica del Giornale di Guerra. «Non mi persuadono quelle interpretazioni che tendono a sovraccaricare il testo di Mussolini di un significato strumentale: il diario segnerebbe l’inizio del suo culto pubblico, con il fine di accreditarlo quale leader politico degli italiani. Tutto questo non tiene conto di vari elementi. Il primo è che Mussolini quando va in guerra può morire, cosa che è accaduta ad altri interventisti. Il secondo è che il diario viene scritto in un una fase magmatica della sua biografia che non prefigura né fascismo né conquista del potere». Questa lettura, secondo Campi, ha finito per svalutare un testo di grande dignità sul piano politico e letterario, un racconto in presa diretta dotato di una freschezza che manca a molta letteratura di guerra, rielaborata in fase successiva. «La sua assenza, nel trionfo memorialistico del centenario bellico, mi ha molto sorpreso. Per questo l’ho proposto a Rubbettino. Era giusto sottrarlo all’area nostalgica neofascista per restituirlo agli italiani in forma critica».
Al di là delle diverse interpretazioni, resta da capire perché oggi Mussolini possa essere al centro della scena editoriale e dunque culturale. La «fascinazione ancora esercitata tra i più giovani», come sostiene Franzinelli? O «il carisma dell’uomo solo al comando, in sintonia con lo spirito del tempo», come dice Isnenghi?
Fa riflettere l’affermazione di Ugo Berti: «Dieci anni fa il Mulino avrebbe avuto dei problemi ad avere Mussolini in catalogo ». Forse oggi c’è maggiore serenità, ormai distanti le aggressioni della destra anti antifascista, il tentativo di riabilitare politicamente il duce («il maggior statista italiano» disse Fini prima della svolta democratica), lo svilimento della Resistenza, l’equiparazione tra partigiani e repubblichini, la proposta di abolire il 25 aprile. Umori che ora avvertiamo lontani, ma in realtà risalgono a un passato recente. «Oggi pubblicare Mussolini è il segno di un paese maturo», dice Campi. O, meglio, la speranza di un paese maturo, che abbia davvero fatto i conti con il passato.
A proposito. In questo nostro girovagare tra i testi mussoliniani ci siamo imbattuti, grazie a Ugo Berti, in una stranezza. L’Istituto Poligrafico dello Stato continua a proporre, in una collana per bibliofili, Scritti e discorsi di Mussolini. Ma non un’edizione critica, bensì la veste originale uscita nel 1939, carta in filigrana con il fascio littorio e la sigla LDS, Libreria dello Stato. Che era quello fascista. Questo, sì, decisamente imbarazzante.
-
> Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). --- "Il cattivo tedesco e il bravo italiano". La falsa innocenza degli italiani durante il fascismo (di Nello Ajello).20 gennaio 2013, di Federico La Sala
La falsa innocenza degli italiani durante il fascismo
di Nello Ajello (la Repubblica, 20.01.2013)
L’umanità dei nostri connazionali - benché fascisti - e la bruta violenza degli scherani di Hitler: assoluzione da un lato, demonizzazione dall’altro. È questo stereotipo, legato alla seconda guerra mondiale, che lo storico Filippo Focardi affronta nel libro che ha firmato per Laterza, Il cattivo tedesco e il bravo italiano.
Una simile generalizzazione - che pure contiene “un forte nucleo di verità” - è servita a rimuovere tante nostre colpe. Un elenco nel quale figurano i crimini dell’imperialismo fascista, la guerra di aggressione contro le “potenze democratiche”, la persecuzione antisemita (non sempre, si precisa, “imposta da Berlino”) e le violenze commesse ai danni di “nazioni inermi” sottomesse all’Asse. Al seguito del proprio assunto l’autore percorre ampi sentieri del Novecento, dagli anni Trenta e Quaranta, esaminando i commenti di osservatori ed esponenti politici non soltanto italiani. A partire dal giudizio emesso da Winston Churchill nel dicembre 1940: l’entrata in guerra dell’Italia fu l’errore di un “uomo solo”, Mussolini.
A questo autorevole precedente si collega, in gran parte, quella distinzione fra italiani e fascismo che ispirerà l’Intelligence e il giornalismo anglosassone: si ricordino, ad esempio, le trasmissioni-radio del “colonnello Stevens”, cui qui da noi arrise durante il conflitto un notevole, quanto clandestino, ascolto. Non meno recise erano le perorazioni propagandistiche che rivolgeva agli italiani, dalla stessa Radio Londra, l’antifascista esule Umberto Calosso.
La requisitoria di Focardi è severa. L’itinerario che egli compie, in cerca di testimonianze, fra discorsi, giornali e riviste, rende vivaci molte pagine del libro, salvandole dalle strettoie di una ricerca accademica. Spicca, tra i personaggi evocati, quel Benedetto Croce che richiamò l’attenzione dei vincitori sull’avversione dei suoi connazionali al regime littorio, e alla «guerra empia accanto alla Germania». Un’oratoria più colorita adoperava Carlo Sforza, nel riferirsi alla «vera Italia silente sotto la pazzesca imbavagliatura del fascismo».
A una visione della Resistenza come “lavacro” di ogni indegnità pregressa si è poi attenuta la sinistra nostrana. Esemplari, in campo azionista, furono Piero Calamandrei - che, nel giudicare impensabile, anche in futuro, la cessazione dell’ostilità mentale fra italiani e tedeschi - definì questi ultimi «Unni calati dai paesi della barbarie», mentre Francesco Flora li qualificava «biechi figlioli d’Arminio e del Barbarossa».
Assai più attento di quanti non fossero gli esponenti del partito d’Azione, al tema della “riconquista”, in un domani, dei fascisti pentiti, Palmiro Togliatti si era richiamato fin dal 1942, dai microfoni di Radio Mosca, alle tradizioni di libertà del Risorgimento - da Mazzini a Garibaldi - invitando il popolo italiano, a partire dagli “ufficiali del regio esercito” a «rivoltarsi contro Mussolini, a chiedere la pace, a porre fine alle angherie tedesche». L’evocazione del Risorgimento sarà poi assai invasiva nella propaganda del Pci, sulle ali di un patriottismo giudicato di sicuro impatto popolare.
Gli antifascisti di destra come Croce, dunque, e quelli di sinistra. A queste categorie, Focardi ne aggiunge una terza: quella degli anti-antifascisti, assai diffusa, nel nostro dopoguerra, fra i conservatori. A capo della consorteria, che farà numerosi proseliti fra gli adepti - illustri e meno illustri - del “revisionismo”, viene eletto Indro Montanelli. Fu lui a inventare l’espressione «il buonuomo Mussolini». (è questo il titolo di un suo saggio del ’47), nella quale si compendiava il senso di una dittatura «all’acqua di rose, roboante ma non crudele », a differenza di quella nazista. Un’invenzione che sarebbe stata adottata con fortuna da certi rotocalchi a forte tiratura.
Sono le varie facce dei quella nostra supposta innocenza storica, che Focardi giudica «un mito autogratificante e consolatorio ». E perciò da rimuovere. Ma forse, a differenza che in Germania, un’elaborazione meno illusoria del nostro passato non sembra, a molti, né opportuna né utile.
-
> Le radici dell’Eu-ropa --- La marcia su Roma: "E fu subito regime". Emilio Gentile: “De Felice aveva torto, il regime fascista iniziò nel 1922", “Fin dal principio Mussolini ebbe una chiara intenzione totalitaria”.27 ottobre 2012, di Federico La Sala
Esce un saggio dello storico che rilegge quello che è accaduto 90 anni fa “Fin dal principio Mussolini ebbe una chiara intenzione totalitaria”
La marcia del dittatore
Gentile: “De Felice aveva torto, il regime fascista iniziò nel 1922
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 27.10.2012)
«La marcia su Roma è stato uno degli eventi più tragici del Novecento, ma a distanza di novant’anni si tende a caricaturizzarla in “opera buffa”. Ma come è possibile che da una goffa kermesse sia scaturita la tragedia del fascismo italiano?». Emilio Gentile è appena rientrato dall’Università di Harvard, dove ha tenuto una lezione sulla marcia che approdò nei dintorni della capitale il 28 ottobre del 1922. Degli storici italiani è il più tradotto all’estero, e tra gli studiosi del regime fascista vanta un indiscusso prestigio. Il suo ultimo lavoro è una ricomposizione insolita di materiali raccolti nel corso di quarant’anni di ricerche, una sorta di narrazione storica dal ritmo incalzante che sin dal titolo - E fu subito regime (Laterza, pagg. 320, euro 18) - enuncia una tesi storiografica in contrasto con quella di molti storici, incluso il suo maestro Renzo De Felice. E ridimensiona il ruolo di Mussolini, ridotto da protagonista a comprimario.
Molti storici fanno nascere il regime con le leggi liberticide del 1925. Lei non è d’accordo.
«No. Fin dal principio Mussolini ebbe una chiara intenzione totalitaria. E il regime s’impose immediatamente dopo la marcia. Basta leggere le testimonianze dei contemporanei - Amendola o Salvatorelli - che da subito cominciarono a usare la parola regime in un’accezione nuova, intendendo la sottomissione dello Stato a un partito armato».
Secondo De Felice, invece, il duce non aveva allora una chiara volontà autoritaria.
«De Felice scrisse anche che il fascismo al principio, pur se contrario alla libertà che aveva contrassegnato lo Stato postunitario, non aveva una nitida alternativa a questo Stato. Anche Alberto Aquarone ne rimarcò “l’incertezza” e Roberto Vivarelli riferendosi al primo anno di governo arriva a definirlo una “nebulosa”. Tesi che mi lasciano molto perplesso. Certo Mussolini non aveva allora un dettagliato programma di trasformazione dello Stato, ma era consapevole della natura irrevocabile del suo regime. Anche nel celebre discorso nell’aula “sorda e grigia” annunciò: questa rivoluzione ha i suoi diritti e sarà implacabile. Qualcuno l’ha voluta liquidare come pura retorica, in realtà rifletteva azioni concrete - l’istituzione della Milizia della Sicurezza Nazionale, la violenza squadrista perpetrata con arroganza - che segnavano la rottura irreversibile con le istituzioni liberali».
Però molti contemporanei non compresero la drammaticità della marcia, liquidata in qualche caso con accenti grotteschi. E la tendenza alla caricatura è stata poi ereditata da alcuni storici.
«Sì, soprattutto dalla storiografia anglosassone ma anche da noi. Salvemini fu tra i primi a definirla “un’opera buffa”. E più di recente Donald Sassoon l’ha ritratta come patetica “adunata di utili idioti”. Il problema è come mai da un evento così ridicolizzato abbiano avuto origine vent’anni di minaccia mortale alla democrazia in Europa. Ma la “storiografia sarcastica” - diciamo così - non è la sola che tende a spegnere la portata di quegli eventi. In un recente lavoro pubblicato dal Mulino, uno studioso sottile come Sabino Cassese finisce per chiedersi se davvero sia esistito uno Stato fascista, o non si tratti d’una versione ancora più autoritaria del vecchio Stato liberale. Ragionamenti sofisticati, ma mi domando perché vengano applicati solo al fascismo».
Colpisce che a distanza di novant’anni gli studiosi facciano fatica a mettersi d’accordo.
«Ancora si esita a riconoscere il carattere totalitario del regime, considerato meno “fascista” del nazismo. Siamo al paradosso: non si vuole ammettere una realtà storica che è documentata dalla stessa consapevolezza dei contemporanei. Nel 1923 Salvatorelli e Amendola, Sturzo e Matteotti parlavano già di “totalitarismo”, identificato nella prevaricazione del fascismo armato sullo Stato. Vaneggiavano? Dobbiamo paragonarli ai bambini della famiglia Darling che credevano nell’isola che non c’è? Peccato che “l’invenzione” abbia portato persecuzione e in taluni casi perfino morte».
Ma lei come spiega questa infinita discussione storiografica?
«C’è difficoltà a prendere sul serio il fascismo italiano, le cui responsabilità vengono alleggerite nel confronto con le dittature segnate dal terrore di massa. Ma il carattere totalitario di un regime non si misura dal numero delle vittime, ma vedendo se l’assetto di quel regime renda possibile o meno fare vittime».
Nell’introduzione del suo ultimo libro, il terzo volume della Storia delle origini del fascismo, Roberto Vivarelli se la prende con quegli studiosi che «discettano di un fenomeno fascista», schiacciando l’esperienza italiana su quella del nazismo tedesco. Secondo Galli della Loggia, che ne ha scritto sul Corriere, il bersaglio è proprio lei, «rappresentante italiano di una imperversante storiografia anglosassone».
«Il libro di Vivarelli non l’ho ancora letto, escludo però che si rivolga a me in quel modo: non credo d’essere sospettabile di “discettare di un fenomeno fascista” senza confrontarmi con le vicende effettive del movimento di Mussolini. Quanto a Galli della Loggia, che devo dire? Evidentemente non ha mai letto un rigo di quel che ho scritto dal 1975 a oggi».
Nella sua ricostruzione delle origini del fascismo Vivarelli attribuisce una grande responsabilità al violento sovversivismo socialista: i primi a cominciare, in sostanza, furono i rossi.
«Ma non c’è alcun rapporto diretto tra la violenza del massimalismo socialista e la violenza fascista. Quando in Italia si afferma lo squadrismo, il pericolo bolscevico non esiste più. La paura del comunismo può essere stata una delle condizioni che hanno dato origine al fascismo, ma finché dura il cosiddetto “biennio rosso” il fascismo è un fenomeno marginale. Esso cominciò ad affermarsi quando il socialismo entra in crisi. E poi non c’è proporzione tra violenza rossa e violenza nera: i socialisti non hanno mai assaltato le case della borghesia né i circoli degli altri partiti; i fascisti applicano alla politica le pratiche da guerra civile. Questi i fatti. Naturalmente l’interpretazione può variare, ma non si può dire - come ha fatto Nolte - che Auschwitz è conseguenza del Gulag. È polemica, e basta».
Tradizionalmente la marcia su Roma viene considerata il capolavoro politico di un uomo solo, Benito Mussolini. Lei ne ridimensiona il ruolo.
«Sì, fu assai meno determinante di quanto solitamente si pensi, sia durante la marcia che nei primi tre anni di governo. Un ruolo decisivo fu esercitato dal quadrumviro Michele Bianchi, che del moto insurrezionale fu il primo e più deciso fautore. Nel mio racconto Mussolini è un leader che tende ad assecondare più che ad anticipare o decidere. E dovrà lottare un bel po’ prima di essere riconosciuto capo indiscusso».
In questo suo lavoro lei insiste molto sull’importanza dell’“attimo fuggente”. La marcia appare come una sequela di “attimi” in cui poteva cambiare il corso della storia.
«Bisogna tornare a raccontare la storia non giudicandola a posteriori, ma facendo parlare i fatti man mano che si svolgono. A decidere non sono mai le grandi strutture, astratte entità o anonime forze collettive, ma gli esseri umani, messi di volta in volta davanti a una scelta. Trovo sbagliato interpretare il fascismo come il risultato della debolezza dello Stato liberale. Che significa? Non è lo Stato liberale che cede, ma gli uomini incapaci di prendere decisioni adeguate. Ministri come Amendola, Taddei, Alessio avrebbero voluto stroncare la violenza fascista con le forze armate, però prevalse un’altra linea. Non è lo Stato liberale che sbaglia, ma alcuni dei suoi uomini che non seppero capire. La storiografia liberale ha sempre visto in azione le grandi idee, io mi concentro sulle individualità. Una sorta di storiografia esistenzialista, se possiamo dir così, che rende più viva e drammatica la storia».
-
> Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). ---- Come il fascismo conquistò il potere. Marcia su Roma, golpe autorizzato. Le cinque cause della dittatura.27 ottobre 2012, di Federico La Sala
 L’anniversario
L’anniversario
 Marcia su Roma, golpe autorizzato
Marcia su Roma, golpe autorizzato di Angelo d’Orsi (il Fatto, 27.10.2012)
di Angelo d’Orsi (il Fatto, 27.10.2012)Novant’anni anni sono un buon tratto di tempo per riflettere su un avvenimento che ha cambiato la storia di un Paese, e ha contribuito a cambiare quella di un continente, e addirittura del mondo. Alludo alla Marcia su Roma, svoltasi negli ultimi giorni dell’ottobre 1922: uno strano evento, presentato spesso come un’allegra scampagnata; nella sostanza, si trattò di una dimostrazione di forza da parte di un movimento politico organizzato in forma di esercito, con il consenso delle autorità militari, nell’inerzia del governo, nel balbettio delle opposizioni, e, soprattutto, nella complicità del sovrano regnante.
L’ascesa al potere di Mussolini fu effetto non della capacità militare dei fascisti, quanto del tradimento dei suoi doveri costituzionali perpetrato dal capo dello Stato, il re Vitto-rio Emanuele III, complice l’inettitudine della classe politica, pronta all’abbraccio, rivelatosi poi mortale, con i fascisti, oppure convinta che si trattasse di un fenomeno transitorio e trascurabile. Fu dunque un atto eversivo, ma con il consenso dell’autorità, dai più alti gradi, fino alle sedi periferiche del potere civile e militare, largamente occupate dagli squadristi, senza incontrare resistenza.
MAI SI ERA vista una mobilitazione insurrezionale di tale portata nella storia nazionale, anche se la Marcia fu poca cosa, anche per la disorganizzazione, la difficoltà dei collegamenti e delle comunicazioni. Verso Roma si diressero, la mattina del 28 ottobre, circa 14 mila camicie nere, che dopo la “vittoria”, il giorno 30, divennero circa il doppio.
La Marcia - che ebbe come ispiratrice quella di D’Annunzio su Fiume del settembre ‘19 - e seguì all’adunata di Napoli, di pochi giorni prima, dove 30-40 mi-la camicie nere occuparono la città, per tre giorni (accolti dai saluti di Enrico De Nicola e dagli applausi di Benedetto Croce), avvenne solo nelle zone centrali del Paese, verso la capitale, a partire da Perugia dove si era installato il “quartier generale”, in un albergo di lusso, il Brufani, dalle cui suites i quattro capi designati (Italo Balbo, Michele Bianchi, Emilio De Bono, Cesare De Vecchi, poi insigniti del titolo di “quadrumviri”), impartivano ordini, più o meno rispettati, mentre consumavano drink. Nessuno di loro prese parte alla camminata, e neppure il “duce”, rimanendo al sicuro a Milano, alla sua scrivania di direttore del Popolo d’Italia, pronto, come notarono non pochi osservatori, alla fuga, essendo Milano a meno di un’ora dal confine svizzero: un tragitto che poi fu costretto a sperimentare nell’aprile del ’45, con gli esiti che sappiamo.
Mussolini aveva espresso chiaramente la propria filosofia opportunista e illiberale, in articoli e discorsi, affermando che il fascismo intendeva giungere al potere, con le buone o le cattive. A nessun magistrato, a nessun ministro venne in mente che si trattava di minacce all’ordine costituzionale, minacce che, da almeno due anni, i fascisti, organizzati in “squadre d’azione”, armate di tutto punto, provviste di mezzi di locomozione, stavano traducendo in pratica, ai danni di socialisti, comunisti e, meno, cattolici. In quelle convulse giornate del 27-30 ottobre ’22, i fascisti, peraltro divisi e in contrasto fra di loro, portarono avanti sia la linea militare ed eversiva, sia quella politica, trattativista.
VOLEVANO arrivare al governo, e davanti all’arrendevolezza delle autorità, nel silenzio della politica, alzarono ripetutamente la posta. Si sarebbero accontentati di qualche ministero, e finirono per avere la nazione, avviando, all’indomani della Marcia, con il famigerato discorso del bivacco (“Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco per i miei manipoli”), la trasformazione dello Stato liberale in regime totalitario. I fatti dell’ottobre furono quindi il punto d’arrivo di una violenza sistematica contro le organizzazioni e le strutture del movimento proletario, nelle campagne e nelle città.
La Marcia segnò il salto di qualità, almeno simbolicamente: attacco diretto allo Stato ma, ecco il paradosso, in nome della sua difesa dal “bolscevismo”, ossia, le lotte operaie e contadine. Interrotta per ben due volte in seguito all’emanazione del decreto di stato d’assedio da parte del Governo Facta, per due volte respinto dal re, la Marcia si risolse in una parata per le vie di Roma, non senza violenza (per esempio nel quartiere “rosso” di San Lorenzo), mentre un telegramma a Mussolini lo invitava a Roma per formare il governo.
VIAGGIÒ in vagone letto, affacciandosi via via dal finestrino per discorsi alla folla, e giunto alla meta si recò in albergo, dove si cambiò d’abito, lasciando quello civile per una divisa militare, al sovrano che lo attendeva al Quirinale, disse che si scusava per gli abiti sporchi e impolverati per la “battaglia”, ma che gli portava “l’Italia di Vittorio Veneto”.
Il “ventennio” cominciava con una tragica pagliacciata, che era l’altro volto del colpo di Stato monarchico; si sarebbe concluso, provvisoriamente, con un’altra buffonata, l’arresto di Mussolini nella notte del Gran Consiglio, il 25 luglio ’43 che, tecnicamente, fu un altro colpo di Stato del re, che tuttavia non pose fine al regime, la cui catastrofe fu accompagnata da quella della nazione nel doloroso biennio ’43-45.
Ma, all’azione eversiva chiamata “Marcia su Roma” i consensi furono ampi, dal Corriere della Sera alla Confindustria. Rispetto al tragico “biennio nero”, la Marcia si concluse senza quasi colpo ferire, un dato tranquillizzante che in realtà poteva significare, come ebbe a notare un osservatore, Luigi Salvatorelli, “scarsezza di serietà morale”. Un dato che non ci lascia molta speranza per il futuro dell’Italia.
 La marcia su Roma
La marcia su Roma
 Le cinque cause della dittatura. Come il fascismo conquistò il potere
Le cinque cause della dittatura. Come il fascismo conquistò il potere
di Giovanni Belardelli (Corriere della Sera, 27.10.2012)
Alle 9 del mattino del 28 ottobre 1922, quando ormai era chiara la dimensione assunta dalla mobilitazione delle squadre fasciste convergenti su Roma, il presidente del Consiglio Luigi Facta si recò dal re per ottenerne la firma in calce al decreto che istituiva lo stato d’assedio. In questo modo, con il passaggio di tutti i poteri dall’autorità civile all’autorità militare, l’azione sediziosa dei fascisti, numerosi ma male armati, avrebbe potuto essere facilmente stroncata. Come è universalmente noto, quella firma non vi fu e lo stato d’assedio, benché già annunciato dai telegrammi inviati ai vari comandi militari, non entrò mai in vigore. In questo modo era aperta la via che di lì a due giorni avrebbe condotto Mussolini a ricevere l’incarico di formare un nuovo governo.
Sì è discusso molto sulle ragioni che indussero il re a quella decisione così gravida di conseguenze: tra esse, ebbe certamente un peso di rilievo il timore che l’esercito potesse rifiutarsi, ove fosse stato necessario, di sparare su dei rivoltosi che erano spesso ex combattenti e proclamavano di difendere la patria minacciata dai socialisti. In ogni caso, al punto in cui erano giunte le cose alla fine di ottobre del 1922, il fascismo era ormai l’attore chiave della scena politica italiana e una sua emarginazione appariva sostanzialmente impossibile.
Le ragioni che in soli tre anni e mezzo dovevano condurre Mussolini dalla fondazione, nel marzo 1919, di un minuscolo raggruppamento politico come i Fasci di combattimento alla presidenza del Consiglio furono varie. Una parte della responsabilità della vittoria fascista va attribuita al ceto politico liberale, soprattutto per l’illusione di poter utilizzare il movimento delle camicie nere al fine di riconquistare un’egemonia politica (e parlamentare). Un’egemonia che nel 1919 le varie e frastagliate forze liberali avevano perso a causa sia della nuova legge elettorale proporzionale, sia della nascita, per la prima volta da che esisteva lo Stato unitario, di un partito cattolico, il Partito popolare. In quella situazione la formazione di stabili maggioranze era resa molto difficile sia dalla diffidenza dei liberali a collaborare con i popolari (una diffidenza, peraltro, ricambiata), sia dall’impossibilità di una loro collaborazione con un Partito socialista nel quale la corrente riformista era di fatto ostaggio di una maggioranza su posizioni nettamente rivoluzionarie.
Una grande responsabilità nel determinare le condizioni che favorirono l’avvento al potere di Mussolini, probabilmente la responsabilità principale, la ebbe appunto il Partito socialista, uscito dalle elezioni del 1919 come la maggiore forza politica per numero di deputati. Fu da quel partito che venne allora il primo attacco allo Stato liberale durante il cosiddetto «biennio rosso» 1919-20, nell’illusione di poter realizzare la «dittatura del proletariato» e la «socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio». Si trattava di un programma sicuramente velleitario. Tuttavia sarebbe sbagliato considerare i socialisti massimalisti come null’altro che dei rivoluzionari da operetta. La minaccia di una rivoluzione di tipo bolscevico, fondata o meno che fosse, alimentò infatti nel Paese un timore ben reale che fu all’origine delle simpatie per le camicie nere di tanti appartenenti ai ceti medi, disposti a considerare la violenza squadrista come una difesa - eccessiva nei modi ma giusta nella sostanza - delle istituzioni.
Proprio una valutazione - o meglio un’illusione - del genere doveva favorire un altro fattore decisivo del successo fascista: la tolleranza verso le azioni illegali dello squadrismo da parte di molti appartenenti alle forze dell’ordine e alla magistratura. Non meno importante nell’alimentare le simpatie per il fascismo fu la durissima campagna socialista contro il conflitto da poco terminato, che a una parte dell’opinione pubblica apparve come un intollerabile insulto ai molti che in quella guerra avevano combattuto, perdendovi spesso la vita.
Alle elezioni del novembre 1919 il movimento di Mussolini si era presentato soltanto a Milano, ottenendo un numero di voti irrisorio, ciò che sembrava annunciare la sua prossima uscita di scena. Due anni dopo raggiungeva invece i 200 mila iscritti (il doppio di quelli di un Partito socialista ormai stremato dalle violenze fasciste) e si affermava sempre più come il principale protagonista della politica italiana: nelle elezioni del 1921 i fascisti, alleatisi con le forze liberaldemocratiche, mandavano alla Camera 35 deputati (e molti rimasero allora colpiti dalla loro età media, 37 anni, che dava concretezza anagrafica alla canzone Giovinezza).
La causa principale di questa impetuosa crescita stava nello squadrismo, cioè nella reazione armata contro le organizzazioni socialiste cui i fascisti diedero vita nelle campagne centrosettentrionali (e in Puglia) a partire dalla fine del 1920. Non a caso lo squadrismo si sviluppò nelle stesse zone del Paese in cui le organizzazioni socialiste utilizzavano forme di coercizione e di violenza ai danni dei proprietari terrieri, spesso piccoli e medi, che ora vedevano nell’azione violenta del fascismo una sacrosanta reazione contro i «rossi». Si trattava di un meccanismo che è stato descritto molto efficacemente, anche nei suoi risvolti psicologici, nel romanzo di Antonio Pennacchi Canale Mussolini; protagonista del libro è infatti una famiglia di mezzadri della Bassa Padana che aderisce al fascismo dopo essere stata fatta oggetto di una violenta azione intimidatoria da parte dei socialisti.
Lo squadrismo fu essenziale nel portare Mussolini al successo non solo perché distrusse gran parte delle organizzazioni socialiste, facendo trasmigrare centinaia di iscritti nei nuovi sindacati fascisti messi in piedi in quattro e quattr’otto. Fu essenziale anche perché gli fornì una risorsa politico-militare che nessun altro possedeva. Veramente decisiva fu però la grande abilità del futuro Duce nello sfruttare politicamente la forza dello squadrismo, giocando per così dire su due tavoli: da una parte dichiarava la propria disponibilità a costituzionalizzare il fascismo, cioè a ricondurre lo squadrismo nell’alveo della legalità, dall’altra continuava invece a lasciare mano libera alle azioni violente. A partire dalla primavera del 1922 queste azioni si fecero anzi più intense arrivando all’occupazione di intere città, come Bologna o Ferrara.
Per mesi, fino al giorno stesso della marcia su Roma, Mussolini condusse trattative segrete con i principali esponenti della classe dirigente liberale, mandò messaggi rassicuranti al re e ai vertici militari, lasciò intendere che si sarebbe accontentato di una partecipazione di qualche ministro fascista al governo. In realtà puntava a una vittoria completa, che lo vedesse alla testa di un nuovo esecutivo. La marcia su Roma (benché in varie località del Centro-Nord comportasse l’occupazione di prefetture, questure, stazioni ferroviarie, poste e telegrafi) doveva servire non a conquistare davvero il potere manu militari, ma a premere appunto sul re e sui maggiorenti del liberalismo perché si arrivasse a un governo presieduto dal leader fascista.
Si trattava di una strategia evidentemente rischiosissima, ma in qualche modo inevitabile. Vero o presunto che fosse, il «pericolo bolscevico» - che tanti consensi aveva portato al movimento dei fasci - ormai non esisteva più, annientato proprio dalla violenza squadrista. Per contro si faceva sempre più probabile una soluzione parlamentare della crisi politica italiana, magari con un ritorno di Giovanni Giolitti al potere. Fu per evitare un rischio del genere che Mussolini decise di troncare gli indugi e di fissare la marcia su Roma per il 28 ottobre.
Se il re non firmò lo stato d’assedio fu anche perché ritenne, come un po’ tutto il vecchio establishment liberale, che fosse inutile arrivare a uno scontro, che rischiava di ristabilire l’ordine al prezzo di molte vittime, quando ormai sembrava matura la soluzione politica della crisi. Una soluzione che avrebbe dovuto consistere nell’inserimento dei fascisti in un nuovo governo presieduto da Antonio Salandra. Naturalmente chi puntava a questo si ingannava. Mussolini, che seguiva l’evolversi della situazione da Milano, fece sapere a tutti quelli che lo contattarono di non essere disponibile a nessuna soluzione che non prevedesse per lui la presidenza del Consiglio. Sapeva infatti che, dopo che lo stato d’assedio non era stato firmato, le carte vincenti stavano tutte nelle sue mani.
La mattina del 30 ottobre gli squadristi, fermi da due giorni nei pressi di Roma, cominciarono a sfilare nella Capitale. La sera dello stesso giorno si costituiva il ministero Mussolini: un governo di coalizione, nel quale però i fascisti avevano una rappresentanza nettamente superiore alla loro forza parlamentare. Non rappresentava ancora la dittatura, ma, per i modi in cui era nato nonché per le decisioni che doveva assumere, metteva il Paese su una china pericolosa che alla dittatura avrebbe presto portato.
-
> Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). ---- E il fascismo sparì dal dizionario (di Emilio Gentile).25 novembre 2011, di Federico La Sala
 E il fascismo sparì dal dizionario
E il fascismo sparì dal dizionario
 Una parola abusata per troppo tempo, che qualcuno ha proposto di abolire.
Una parola abusata per troppo tempo, che qualcuno ha proposto di abolire.
 Ma si può censurare la realtà storica?
Ma si può censurare la realtà storica?Anticipiamo uno stralcio del contributo dell’autore alla raccolta Società totalitarie e transizione alla democrazia. Saggi in memoria di Victor Zaslavsky, a cura di Tommaso Piffer e Vladislav Zubok, Il Mulino, pagg. 543, eur 37,00, in libreria dal 1° dicembre
di Emilio Gentile (Il Fatto Quotidiano, 25.11.2011)
MISONE IL CHENESE, annoverato da Platone fra i sette saggi dell’antica Grecia, era un filosofo contadino che l’oracolo di Delfi aveva detto essere il più saggio fra i Greci. Tuttavia, pochissime tracce del suo pensiero sono state tramandate. Ma fra le pochissime, ve n’è una che conferma la sua saggezza: «Indaga le parole a partire dalle cose, non le cose a partire dalle parole». Più che ai filosofi, la massima di Misone dovrebbe attagliarsi agli storici, che studiano la genesi e lo svolgimento delle esperienze umane del passato, alle quali sono quasi sempre associate parole nuove - qui diremo i concetti - usate da coloro, che quelle esperienze vissero, per denominarle e definirle lasciandole poi in eredità ai posteri. Le cose e le parole tramandate dalla storia sono l’oggetto della ricerca e dell’interpretazione degli storici. Ma gli storici non sono sempre concordi nell’interpretare le esperienze del passato come non lo sono nel definire il significato dei concetti ad esse associati.
Un caso fra i più recenti, universalmente noto, è la parola “fascismo”. La parola ebbe origine in Italia da un movimento politico, la cui esperienza iniziò, si svolse e si concluse fra il 1919 e il 1945. Durante lo stesso arco di tempo, la parola “fascismo” fu applicata ad altri movimenti politici sorti fuori d’Italia negli anni fra le due guerre mondiali, per essere poi ulteriormente estesa, dal 1945 ai giorni nostri, a movimenti, ideologie, regimi, mentalità, costumi e comportamenti i più svariati e i più disparati, disseminati in ogni parte del mondo, e persino in tempi e luoghi precedenti di molti anni la comparsa del fascismo in Italia. Con l’inflazione del termine, anche il suo significato è stato continuamente elasticizzato fino a perdere ogni consistenza propria e ogni attinenza con il fenomeno storico da cui ebbe origine.
La stessa sorte è toccata ad altre due nuove parole, “totalitario” e “totalitarismo”, che fecero la loro comparsa nella storia dopo l’ascesa del fascismo al potere alla fine del 1922. Le due parole furono coniate fra il 1923 e il 1925 per definire la natura e l’originalità del partito fascista, la sua organizzazione, il suo modo di agire e il nuovo regime politico cui esso diede origine. Dopo il 1926, la parola “totalitarismo” fu adoperata per definire altri nuovi regimi politici, che nell’organizzazione e nei metodi del potere avevano somiglianza con il totalitarismo fascista, come il comunismo sovietico e il nazionalsocialismo . Poi, dal 1945 ai giorni nostri, anche l’uso del termine “totalitarismo” ha subito una dilatazione inflazionistica, essendo applicato a movimenti, regimi, ideologie, mentalità e comportamenti i più vari e diversi, al punto da far perdere il significato storico originario del termine e la sua connessione con la “cosa” dalla quale aveva avuto origine.
Quasi novant’anni sono passati dalla comparsa nella storia del fascismo e del totalitarismo. Almeno fino all’inizio degli anni Cinquanta del Novecento, l’associazione fra fascismo e totalitarismo è stata considerata evidente. Invece, a partire dagli anni Cinquanta, ci sono stati studiosi i quali, pur senza avere un’adeguata conoscenza né della storia del fascismo né delle origini del totalitarismo, hanno negato l’associazione fra fascismo e totalitarismo, sostenendo, come fece la filosofa Hannah Arendt nel 1951, che il fascismo non fu totalitario, e che pertanto non aveva senso parlare di “totalitarismo fascista”, riservando l’uso del concetto di totalitarismo esclusivamente per lo stalinismo e il nazionalsocialismo. Altri studiosi hanno invece sostenuto che neppure questi due regimi possono essere definiti totalitari, giungendo quindi alla conclusione che il totalitarismo non è mai esistito, e che pertanto il concetto stesso non ha alcuna utilità. Esempio estremo di questa negazione è stata la proposta, formulata nel 1968 su un’autorevole enciclopedia di scienze sociali, di bandire il concetto di “totalitarismo” dalla storiografia e delle scienze sociali. Un’analoga proposta fu formulata nello stesso anno per il termine “fascismo”, adducendo come motivo l’uso spropositato del termine stesso.
Non mi risulta sia mai accaduto, nella storiografia e nelle scienze sociali, che la controversia su un concetto scaturito dalla realtà storica abbia indotto gli studiosi a concludere con la richiesta della sua messa al bando, cioè ad operare una operazione di censura, solo perché è stato usato a sproposito o perché gli studiosi non sono giunti a darne una definizione unanime. se tale condizione fosse sufficiente per decretare la messa al bando di un concetto storico, dovrebbero essere eliminati dalla storiografia e dalle scienze sociali concetti altrettanto controversi e di uso altrettanto spropositato, come despotismo, dittatura, libertà, rivoluzione, feudalesimo, rinascimento, capitalismo, democrazia, repubblica, bonapartismo, liberalismo, comunismo, socialismo, conservatorismo, radicalismo, e tutti gli altri ismi della storia. Quali conseguenze potrebbe avere un siffatto “negazionismo concettuale” per la storiografia, è facile immaginarlo.
-
> Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). Il "gioco" di ogni progetto e "duce" autoritario è stato sempre questo: "AF-FASCInARE" E "AG-GIOGARE" IL POPOLO. NELLO AJELLO ed EMILIO GENTILE fanno il punto sul "LOGO" DI MUSSOLINI.9 marzo 2007, di Federico La Sala
La cimice dei fascisti
di Nello Ajello (la Repubblica, 9 marzo 2007)
L’ordine venne impartito quasi in sordina, in calce alle direttive che il Gran Consiglio del fascismo emanò nella sua riunione del 9 marzo 1937, indetta per «potenziare sempre più la coscienza imperiale della Nazione». In una dozzina di parole si disponeva che «tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato» fossero «iscritti nelle Associazioni fasciste», delle quali nello stesso comunicato si sintetizzava la potenza numerica. Tra Fasci di combattimento, Fasci giovanili e femminili, Gruppi Universitari Fascisti e vari organismi collaterali il partito poteva contare, in quell’anno XV dell’Era littoria, su oltre nove milioni - per la precisione 9.251.989 - di militanti «inquadrati» con regolare tessera.
Fuori del lusinghiero calcolo restavano, fino a quella mattina di settant’anni fa, solo i «ministeriali». Una categoria che si riteneva attardata su residue posizioni liberali o tutt’al più «opportunistiche», legata a inattuali riti pantofolai: assai più romanesca (si deplorava) che romana imperiale. L’esemplare tipico della specie era appunto quel burocrate di genere eticamente «profano», quell’individuo appartenente al «limbo», che - secondo lo scrittore Emilio Radius, autore nel 1964 di un saggio sugli Usi e costumi dell’uomo fascista - veniva trattato dagli squadristi o dai camerati di antico fusto «come i soldati trattano in caserma i borghesi». Il modo di registrarne la presenza quando qualcuno di loro s’affacciava nei corridoi di un Gruppo Rionale - «c’è qui un borghese» - era già una denuncia. In linguaggio littorio significava: «Eccolo lì, è un non iscritto al partito».
Ora l’anomalia, già da tempo oggetto di segnalazioni e parziali «reprimende», è ufficialmente sanata. Si sa che la gran massa dei tesserati è in realtà estranea all’attività e alla vita fascista. Ma l’inclusione dei ministeriali nei ranghi conta in quanto lezione. Il renitente borghese (è ancora Radius a descriverlo) mette piede «nelle case del fascio come un cristiano entra in una moschea». Dopo una breve attesa viene interrogato con drastica petulanza attraverso una serie di moduli. I questionari indagano sulla sua biografia: «Gradi rivestiti nell’esercito? Campagne compiute? Decorazioni guadagnate? Detenzione di armi, e quali?». Spesso il compilatore dello stampato è pacifico, inerme e tendenzialmente apolitico, e non se la sente di negarlo. Il suo arruolamento, comunque, risponde all’esigenza di «ripulire gli angolini», scovando i potenziali fascisti «deboli» o addirittura «ex democratici». Non sarà mai possibile trasformarli in una falange di arditi; ma essi faranno numero, contribuendo all’espansione di tre elementi cari alla liturgia nazionale: distintivo, camicia nera, saluto romano.
Il primo membro della triade - il distintivo - potrà essere assunto, quando se ne faccia un uso negligente, in funzione disciplinare. Nell’ottobre del ‘41, quattro anni dopo il reclutamento coatto dei «ministeriali», la rivista Gerarchia segnalava con severità: «E’ ora di sfatare la leggenda che taluni fascisti, non portando il distintivo del Partito all’occhiello, compiano un atto di indisciplina o di semplice menefreghismo. Compiono invece un atto di vera e mera viltà, inquantoché nel contempo non rinunciano, e non rinuncerebbero per la pelle, al possesso della tessera che loro serve egregiamente per il posto, per la tranquillità e per ogni opportunissima evenienza». Ed ecco che la segnalazione del malcostume diventa minaccia e sarcasmo. Si ironizza ruvidamente sul fattore-disattenzione. «Quanta brava gente perde involontariamente il suo distintivo! Bisognerà che i sarti si decidano a ridurre le misure delle asole nei risvolti delle giacche. Con queste asole di grosso calibro i distratti vanno incontro a un’infinità di seccature».
Principale sinonimo di distintivo diventò un termine di successo: la cimice. Lo scrittore Alfredo Panzini era stato il primo a registrarne l’uso come «espressione di dileggio con cui i nemici del regime indicano l’emblema fascista che si porta all’occhiello», segnalando che dopo essere stato di forma ovoidale fino al 1926, il distintivo - o cimice - era diventato quadrangolare. In Romagna, segnalava Panzini, si preferiva designarlo con un nomignolo a sua volta sgradevole: «bagherozzo». Più tardi Vitaliano Brancati avrebbe così descritta l’adozione del distintivo da parte di un suo personaggio memorabile, l’impiegato comunale Aldo Piscitello, protagonista del racconto Il vecchio con gli stivali ed emblema dell’italiano piccolo-borghese degli anni Trenta, fascista per necessità alimentare e per estenuazione psicologica: «Sulla sua giacca nera s’era posato come un maggiolino il distintivo col fascio, ed egli di tanto in tanto lo guardava torcendo gli occhi all’ingiù».
Accanto al distintivo principale, che connotava l’iscrizione al Fascio, ne nascevano altri "d’occasione", celebrativi di singole imprese del Regime. Al punto da indurre nel 1930 Giuseppe Bottai, allora ministro delle Corporazioni, ad opporre un suo "no" all’istituzione di un nuovo distintivo in onore dei fascisti feriti negli scontri "squadristici". Al ministro la trovata parve inopportuna. «I fascisti feriti» fece rilevare «sono in numero irrilevante dopo dieci anni!».
E tuttavia la produzione di distintivi non si arrestò. Essi adornavano non solo le giacche ma anche i copricapi che gli atelier governativi andavano inventando e perfezionando senza sosta. In un suo saggio Antonio Spinosa ricorda una vibrante pagina che Piero Calamandrei dedicò a un negozio di capelli ubicato a Roma in corso Umberto: «Una sua vetrina tutta addobbata in nero», raccontava il giurista, mostrava «una ventina e più di cappelli di parata» di cui alcuni erano «grigi, ma i più neri: e su quel nero spiccavano, come coltri funeree, argenti ed ori di galloni e distintivi. Alla base di ogni piolo un cartellino bianco indicava il grado del gerarca al quale era destinato il copricapo fornito di quello speciale distintivo: «segretario generale», «segretario federale», «ministro», «segretario del partito»; col salire delle gerarchie crescevano i luccichii delle lasagne». Al centro della vetrina «una specie di gigantesco tegame» dominava «tra i tegamini satelliti», con in cima un fierissimo uccellone d’oro. E il suo cartello spiegava: DUCE. I passanti guardavano dentro la vetrina in silenzio: e non osavano guardarsi fra loro».
Potevano sottrarsi all’adozione della cimice (bagherozzo, maggiolino o tegamino che fosse) soltanto i possidenti. I quali, in qualche caso specialissimo, formulavano efficaci obiezioni al regime che quegli emblemi imponeva: nel Piccolo Dizionario borghese che lo stesso Brancati pubblicava, insieme a Leo Longanesi, sul settimanale Omnibus, sotto la voce dedicata a Benedetto Croce si leggeva: «Può farlo perché è ricco».
I non benestanti, se in cuor loro avversi all’ideologia ufficiale, venivano dilaniati dal doppio binario sul quale doveva adagiarsi la loro coscienza. Lo storico del medioevo Ernesto Sestan (1898-1986) racconterà più tardi che cosa aveva rappresentato per lui il dover diventare ufficialmente fascista, quando l’obbligo della tessera, già imposto nel 1931 ai docenti universitari di ruolo, venne esteso anche a coloro che volevano diventarlo, figurando fra i requisiti determinanti per partecipare ai concorsi. Allievo di Gaetano Salvemini e di Gioacchino Volpe, collega ed amico di un altro storico di grande avvenire, Federico Chabod, Sestan dedica alla costrizione, cui soggiacque, accenni molto dolorosi nelle sue Memorie di un uomo senza qualità: l’evento, ricorda, «ha inciso in me molto nel profondo e mi lascerà dell’amaro finché vivrò». E subito dopo racconta: «Se ne discusse non so quante serate con Chabod, resi perplessi, angustiati, indecisi. Né lui né io si era sinceramente fascisti: avevamo accettato passivamente il fascismo, perché era il governo che ci governava e ci dava da vivere, e rispetto al quale non si professava nessuna, nemmeno lontanissima alternativa».
La gente semplice associava l’esistenza di molti organismi "di supporto" inventati dal regime alle più umili necessità quotidiane dei cittadini. Per fare un esempio: appena fondato, l’Istituto di Mistica fascista subì a livello popolare una modifica della sua ragione sociale: la parola mistica diventava «mastica». Istituto di mastica fascista. Un motto che può far sorridere. Ma gronda anche desolazione, rinunzia civile.
-
> "FASCInARE" IL POPOLO!!! IL "gioco" di ogni progetto autoritario. IL "fascio littorio". Il "LOGO" DI MUSSOLINI. Riflessioni e note di NELLO AJELLO e di EMILIO GENTILE.7 dicembre 2006, di Federico La Sala
Comunicato stampa
Il 14, 15, 16, 17 dicembre presso il Cinema d’essai Gnomo [MILANO, fls]
il Sindacato Critici Cinematografici in collaborazione con l’Associazione Studium Cartello-Il Lavoro Psicoanalitico
presenta una rassegna di quattro film che trattano di un tema che è lo stesso di cui tratta un testo fondamentale di Freud: Psicologia delle masse e analisi dell’io.
E’ sembrato il modo migliore di rendere omaggio a Freud lo smarcarsi dai consunti luoghi comuni che fanno di Freud lo studioso di oscuri moti a sfondo istintuale, per farne invece un pensatore politico.
Titolo della rassegna è
Omaggio a Freud nel centocinquantesimo della nascita
Masse innamoramento amore
Psicologia delle masse e analisi dell’io è un testo pubblicato nel 1921, anno in cui, in un’Europa non ancora uscita dagli sconvolgimenti della prima guerra mondiale, già si preparano le convulsioni che sfoceranno nella soluzione totalitaria dapprima, e poi in una seconda guerra, altrettanto mondiale e devastante.
Con questo testo Freud acquista tutta la statura di un pensatore politico, sensibile alle tendenze che stanno affermandosi nella società, indagante le ragioni della disponibilità degli uomini a scegliere le forme del regime totalitario, a farsi cioè massa di individui che scelgono di rinunciare a pensare con la propria testa per affidare a un capo, ma anche a un’organizzazione, a un partito, ritenuti onnipotenti e onniscienti, la conduzione della propria vita.
Ma in un punto Freud si smarca dagli altri pensatori politici: ciò che dispone al totalitarismo è una teoria dell’amore, con conseguenze devastanti di odio e vendicatività. La prima massa, una “massa a due”, è, secondo lui, quella dell’innamoramento, in cui appunto si ”perde la testa”, in cui ci si dispone a sacrificare, per cederli a un altro in nome dell’amore, pensiero, giudizio, interessi. Questa tesi freudiana è sicuramente una delle ragioni dell’opposizione a Freud: la letteratura, il cinema, la cultura in genere, propagandano l’idea che l’innamoramento sia amore.
I film scelti da questa rassegna sono tutti, tranne uno, successivi alla seconda guerra mondiale. Solo quello che sarà proiettato per secondo, Il trionfo della volontà, di Leni Riefenstahl, è del 1935. Non si sono ancora viste, a questa data, le conseguenze devastanti della forma politica totalitaria. Ciò che viene rappresentato in questo film, per il godimento delle opinioni pubbliche tedesche, ma certo anche mondiali, è l’ordine e la precisione geometrica con cui si muovono le moltitudini che obbediscono agli ordini dei capi, l’apparente amorosa armonia tra gli individui che ne fanno parte.
Gli altri film sono invece successivi e debitori dell’esperienza della catastrofe su cui sfocia il totalitarismo. Il primo film della rassegna è il Moby Dick di John Huston, del 1956. Vediamo qui una massa di uomini che si sono imbarcati su una baleniera per il proprio interesse anzitutto economico e che poi, strada facendo, scambiando per amore l’innamoramento nei confronti del capitano Achab, si trasformano negli esecutori del suo odio e della sua vendicatività, della sua rivolta nei confronti della balena bianca che incarna la potenza che, a sua volta, lo ha azzoppato. Sarà una strage: moriranno tutti tranne uno. Orwell 1984, di Michael Radford, del 1984, ci parla invece del sadismo dispiegato dal partito che considera psicocrimine qualunque emergenza di un pensiero individuale, giudicandolo una minaccia per una teoria dell’amore, ossia del rapporto sociale, inteso come perfetta obbedienza.
Apparentemente eccentrico, rispetto agli altri è il film Cyrano di Bergerac di Jean-Paul Rappeneau, del 1990, in cui, in nome dell’amore, lo sciocco Cristiano smette di pensare il suo rapporto con una donna con la propria testa, per rivolgersi a lei, in uno pseudo rapporto, con le parole e i pensieri di un altro.
Secondo Freud, ecco la radice della disponibilità all’assoggettamento e al totalitarismo.
COMUNICATO STAMPA
MASSE INNAMORAMENTO AMORE OMAGGIO A FREUD nel centocinquantesimo dalla nascita
dal 14 al 17 dicembre cinema Gnomo
A centocinquant’anni dalla nascita di Freud abbiamo scelto quattro film, quattro classici, il cui tema è quello su cui Freud medita nel suo testo fondamentale Psicologia delle masse e analisi dell’io del 1921: esistono forme di legame sociale il cui costo è l’autosacrificio del pensiero e dell’interesse individuale. Se l’individuo vi si adatta, in virtù del bisogno irrinunciabile di amore, d’ora in poi non potrà che dibattersi, angosciosamente, tra una indissolubile fedeltà e un’avversione implacabile. Di questo vive la “massa”, anche quella “massa a due” che è l’innamoramento.
Giovedì 14 dicembre Ore 18.00 20.30 22.00
Moby Dick, la balena bianca (USA 1956, 116’) di John Huston, con Gregory Peck, Richard Basehart, Orson Welles. Gli uomini dell’equipaggio di una baleniera, ingaggiatisi in vista di un guadagno e di un profitto individuale, un po’ per volta si fanno catturare dalla logica del capitano Achab, se ne “innamorano”: è la logica dell’odio per la “forza oltraggiosa”, la “malizia muta”, incarnata nella balena bianca, cui Achab deve “un’anima devastata e un corpo devastato”. Ore 20.00 introduzione al film a cura della Dott.ssa Giulia Contri , psicoanalista
Venerdì 15 dicembre Ore 18.00 20.30 22.00
Il trionfo della volontà (Germania 1935, 120’) di Leni Riefenstahl. L’odio generato da un ordine imposto dall’esterno, con autosacrificio del pensiero e dell’interesse individuale è, in questo film, totalmente rimosso. Resta in primo piano il godimento, non solo tedesco, ma certo anche dell’opinione pubblica mondiale, alla vista di moltitudini che si muovono con ordine, precisione e uniformità geometrica. Ore 20.00 introduzione al film a cura della Dott.ssa Giulia Contri , psicoanalista
Sabato 16 dicembre Ore 16.00 18.00 20.30 22.00
Orwell 1984 (GB 1984, 115’) di Michael Radford, con John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton. Il film, ricavato dal romanzo di G. Orwell del 1948, è debitore dell’esperienza delle tragiche e sanguinose conseguenze di un totalitarismo che mira a dissolvere il pensiero individuale in una istanza sovrandividuale. L’ordine che ci viene descritto in 1984 è retto da una “psicopolizia” che persegue sadicamente come “psicocrimine” il pensare e giudicare con la propria testa. Ore 20.00 introduzione al film a cura della Dott.ssa Giulia Contri , psicoanalista
Domenica 17 dicembre Ore 16.00 Tavola rotonda con la presenza dei Dottori psicoanalisti: Giacomo Contri e Glauco Genga; dei critici: dott. Morando Morandini e dott. Mattia Nicoletti; modera lo scrittore dott. Giampiero Neri. Ore 18.00 20.00 22.00
Cyrano de Bergerac (Francia 1990, 135’) di Jean-Paul Rappeneau, con Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez. La “forza oltraggiosa”, la “malizia muta”, la violenza è anzitutto quella esercitata sul pensiero dal discorso idealizzante di un altro. Il pensiero è a sua volta disponibile a farsi delegittimare nel proprio giudizio: é’ quel che fa lo sciocco Cristiano nei confronti dell’abile rimatore Cyrano. Ecco l’innamoramento. ore 20.00 introduzione al film della Dott.ssa Giulia Contri, psicoanalista
La rassegna è organizzata da Studium Cartello - Il Lavoro Psicoanalitico, dal Sindacato Critici Cinematografici Italiani - Delegazione Lombarda in collaborazione con il Comune di Milano - Milano Cinema.
Per informazioni:
Dott. Giancarlo Zappoli tel. 02. 36511793
Milano Cinema Tel. 02 88462452 - 51 - 60 fax 02 88462315 email: culturas.cinema@comune.milano.it www.comune.milano.it
Cinema Gnomo Via Lanzone, 30/A (Vicolo Sant’Agostino) 20123 MILANO - Tel. 02. 804125 Mezzi pubblici MM1, MM2, 94, 50, 58, 14, 2
Ingresso valido per tutte le proiezioni della giornata € 4,10 - ridotto € 2,60 Tessera annuale obbligatoria € 2,60
I possessori della tessera Milano Cinema hanno diritto: sconto 50% sull’acquisto dei biglietti al Teatro Franco Parenti sconto 15% sui corsi annuali e del 5% sui seminari di Studio Laboratorio dell’Attore www.studiolaboratoriodellattore.it
-
> "FASCInARE" IL POPOLO!!! IL "gioco" di ogni progetto autoritario. --- Macché antipolitica, è iperpolitica (di Umberto Curi)13 gennaio 2013, di Federico La Sala
Macché antipolitica, è iperpolitica
di Umberto Curi (Corriere della Sera La Lettura, 13.1.2013)
Dietro le polemiche più furibonde rivolte contro i partiti e le istituzioni rappresentative c’è la pretesa assolutamente irrealistica che lo Stato possa risolvere qualsiasi problema P iaccia o meno, è destinata ad essere una protagonista - se non la dominatrice assoluta - dell’imminente campagna elettorale, come già lo è stata nel recente scorcio della vita nazionale.
Detestata o invocata, criticata o esaltata, per riconoscimento unanime l’antipolitica è il nuovo soggetto che sta rubando la scena alle altre maschere della rappresentazione che celebra il suo rito supremo con le elezioni. Ma alla indiscussa centralità del fenomeno non corrisponde affatto una comprensione adeguata di quale ne sia la vera «natura», né di ciò che di essa è a fondamento, dal punto di vista storico e concettuale.
L’equivoco principale scaturisce da quella preposizione, «anti», che suggerisce un’idea totalmente fuorviante, tale per cui essa tenderebbe a negare frontalmente la politica. Mentre un’analisi meno superficiale può far emergere un dato sorprendente, e cioè che ciò con cui abbiamo a che fare non è la negazione, ma al contrario una variante iperpolitica della politica.
Nel libro IX dell’Odissea Omero riferisce un episodio singolare. La nave di Ulisse ha raggiunto un’isola solitaria e sconosciuta. Come è consuetudine, viene inviata a terra una piccola delegazione di uomini, per ottenere informazioni sugli abitanti dell’isola. Passano le ore, ma dei compagni mandati in ricognizione non si ha notizia. Verranno ritrovati - illesi - qualche ora più tardi. A differenza di ciò che si temeva, gli abitanti dell’isola non li avevano accolti in maniera ostile. Al contrario, avevano condiviso il loro alimento abituale, i frutti del loto. «Ed essi - racconta Omero - non volevano più ritornare, e volevano invece restare là, insieme ai Lotofagi, a mangiare loto, dimenticando il ritorno».
Nóstou lathéstai, «dimenticare il ritorno»: questo il pericolo più insidioso, fra le molte avversità affrontate da Ulisse e dai suoi compagni. Lo stesso pericolo, citando precisamente questo passo omerico, è indicato da Platone quale principio di degenerazione dell’individuo, nel passaggio dall’uomo oligarchico all’uomo democratico.
All’origine del processo di degrado, il cui esito più compiuto sarà l’instaurazione della tirannide, vi è una «dimenticanza», non meno esiziale di quella che ha minacciato i compagni di Ulisse. Come costoro, scampati miracolosamente a mille disavventure, rischiano di vedere vanificato il progetto del ritorno in patria per una semplice «dimenticanza», allo stesso modo da una «dimenticanza» trae origine la degenerazione degli individui, e dunque anche degli Stati.
In un altro contesto, Platone spiegherà più chiaramente quale sia il contenuto di un oblio così decisivo. Ciò che siamo irresistibilmente portati a di-menticare (letteralmente: a far «cadere dalla mente»), è quale sia la fonte da cui scaturisce la politica, e quindi anche quale ne sia il fondamento. La politica è un phármakon, e cioè - per rispettare rigorosamente l’irresolubile ambivalenza del termine greco - una medicina che intossica, un veleno che guarisce. Non è dunque, per restare non occasionalmente nel lessico farmacologico, una panacea, un toccasana capace di sanare ogni malattia, senza dar luogo ad alcun fenomeno collaterale. Si tratta, invece, di un rimedio limitato e imperfetto, necessario per fronteggiare la malattia dello Stato, ma al tempo stesso del tutto incapace di garantire una compiuta guarigione.
Ciò che troppo spesso siamo portati a dimenticare - scrive Platone nel dialogo intitolato Politico - è che il mondo in cui attualmente viviamo è un mondo che gira alla rovescia, nel quale tutti i processi fisici, cosmologici e biologici si muovono in senso contrario, rispetto alla direzione originaria. Un mondo, soprattutto, che è caratterizzato dal fatto che Dio ha abbandonato la barra del timone, e perciò non ci conduce più al pascolo, orientando la vita dell’intera comunità. Non siamo dunque più «gregge divino», ma dobbiamo piuttosto «badare a noi stessi», senza più poterci affidare alla guida della divinità.
Nella situazione di abbandono, e dunque di massima incertezza, nella quale attualmente ci siamo venuti a trovare, ci sono stati elargiti alcuni doni - primi fra tutti la tecnica e la politica - mediante i quali cercare di guadagnarci la nostra sopravvivenza. Pur essendo, fra tutte le technai, quella regia, fin dalla sua genesi la politica è solo questo: una medicina che intossica, un rimedio inevitabilmente parziale, un tentativo per compensare l’abbandono da parte di Dio.
Tutto ciò è altresì confermato dall’analisi platonica dello Stato. Illusorio sarebbe immaginare che uno Stato possa dirsi «sano» dopo la «grande catastrofe» che ha invertito il senso di tutti processi biologici e astronomici. Quale che ne sia la forma di governo, è inevitabile che quello in cui viviamo sia uno Stato «rigonfio» e dunque «ammalato». Ed è altresì inevitabile che, assecondando l’impulso che è all’origine dello Stato, compaia nell’orizzonte storico qualcosa che in precedenza era sconosciuto, e che invece da quella fase in poi accompagnerà il genere umano.
Nel passaggio dalla condizione di originaria «salute» dello Stato alla situazione attuale, sulla spinta di una «sconfinata brama di ricchezza», diventerà necessario «fare la guerra». Ancora una volta, il «realista» Platone, intercetta il meccanismo che è storicamente e concettualmente alla base della guerra, senza alcun affidamento esigenziale: «facciamo pure a meno di dire se la guerra sia fonte di male o di bene. Contentiamoci di dire che ne abbiamo scoperto la genesi» (Repubblica, II, 373, d-e).
Da tutto ciò dovrebbe risultare con evidenza che utopistica non è affatto la rappresentazione platonica dello Stato, come per negligenza o conformismo si continua acriticamente a ripetere. Utopistico sarebbe, al contrario, credere che l’uomo possa da sé procurarsi uno Stato nel quale dominino la «pace» (eiréne), il «rispetto reciproco» (aidós), una «buona legislazione» (eunomía) e la «giustizia non invidiosa» (aphtonía díkes), vale a dire ciò che solo la guida del «pastore del mondo» poteva assicurarci. Per la stessa ragione per la quale sarebbe stolto affidare alle capre il governo delle capre, «nessuna natura d’uomo è capace di governare tutte le cose umane con potere assoluto senza riempirsi di tracotanza e di ingiustizia» (Leggi, IV, 713 c-d).
In un contesto e con motivazioni differenti, Thomas Hobbes ribadirà a suo modo l’assunto platonico. Non vi è proprio nulla di «naturale», né ancor meno di «divino», nella politica. Ad essa ricorriamo solo perché ne siamo costretti dalla paura, perché tramite essa vogliamo sottrarci al rischio incombente di subire violenza, preservando la nostra incolumità. Il contratto fra lo Stato e i cittadini non scaturisce da una opzione positiva e non corrisponde ad alcuna prospettiva salvifica. È fondato piuttosto sul realistico riconoscimento che l’unica alternativa alla politica è la guerra, anzi: il bellum omnium contra omnes.
Ecco, dunque, ciò che non si deve «dimenticare», se si vuole evitare di fare la fine degli incauti compagni di Ulisse. Che siamo così lontani dal vivere in un mondo «bene ordinato», da poter perfino affermare di trovarci piuttosto in un mondo in cui tutto gira alla rovescia. Che quella creazione interamente artificiale che è lo Stato riproduce - né potrebbe essere diversamente - tutti i limiti degli uomini che di esso sono artefici, al punto da non poter essere concepito se non come organismo affetto da malattie mai definitivamente estirpabili. Che nella genesi stessa dello Stato è materialmente scritto lo sbocco bellico, come necessità insita nella sua stessa «natura». Che la politica, soprattutto, può agire soltanto come phármakon, come un rimedio imperfetto, come un beneficio che arreca nuove sofferenze.
La radice vera dell’antipolitica, nelle sue formulazioni meno becere, sta tutta in questa «dimenticanza». Consiste nel pretendere che la politica funzioni come rimedio «assoluto», come farmaco senza effetti tossici. L’antipolitico vive ancora nell’«incantamento» dell’età di Crono, si illude che i cittadini possano ancora essere «gregge divino». Esige che la politica sia ciò che non può essere, una panacea, anziché un phármakon. Si sente tradito perché la politica non è accompagnata dalla «buona legislazione» e dal «rispetto reciproco», e ancor meno dalla «pace» e dalla «giustizia». Appassionato amante deluso dal suo amato, l’antipolitico rimprovera alla politica di non corrispondere all’immagine che aveva ingenuamente vagheggiato. E vorrebbe starsene là, su quell’isola, con i Lotofagi, a mangiare loto, dimenticando il ritorno.
-