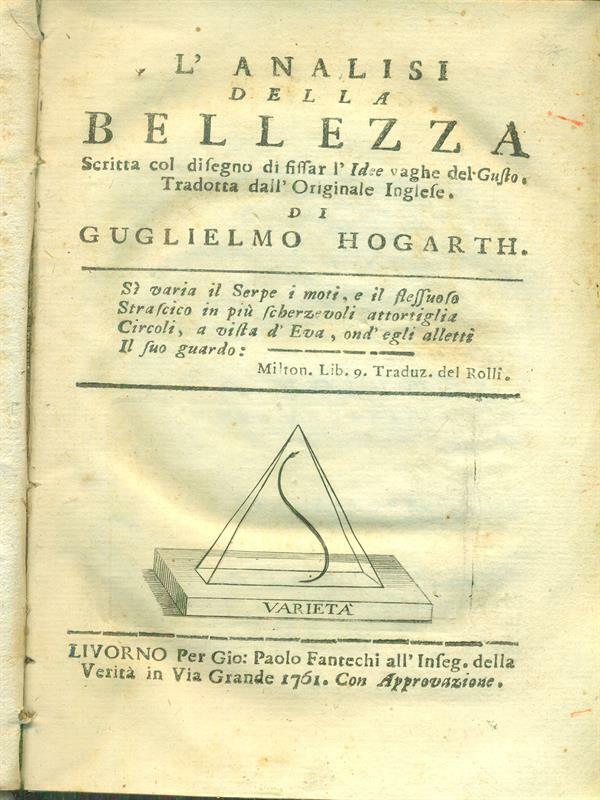LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" - di Federico La Sala
sabato 19 gennaio 2019.Note per una epistemologia genesica
Ai poeti ‘lunatici’ e ai filosofi ‘solari’ - un’indicazione sulla giusta rivoluzione *
di Federico La Sala ("Dismisura", Anno XIX - N. 100/103, Gennaio-Settembre 1990, pp. 16-17; Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 198-200)
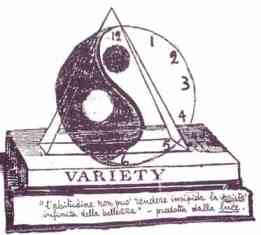 |
A partire dal nostro cielo e dalla nostra terra.
Noi abitiamo, noi siamo - insieme con la Terra, terra e cielo.
Non siamo la luce, e non abbiamo potere sulla luce - ma grazie alla luce siamo. Noi, la Terra: il pianeta vivente.
Da lontano, improvvisa - la luce: la luce del Sole.
È sera ed è mattina: primo giorno. Non più tenebre, non più deserto - comincia il tempo, il tempo della vita.
L’erranza è finita: il pianeta non gira più a vuoto. E noi con lui.
Inaspettata e desiderata - dal di fuori, dall’esterno: la luce.
La terra umile accoglie, il cielo avvolge, custodisce e protegge: insieme si contano i giorni.
Dalla Luce vengono alla luce - dalla terra e sotto il cielo - i viventi.
Il cielo, la terra, e la luce: la luce del Sole.
Da dove? Prima il cielo e la terra, ma è la luce che illuminando separa, trasforma e rende fecondi: cielo-padre, terra-madre, e noi - le creature.
L’azione della luce e lo splendore del mondo: la gioia del tutto. Anche dei mortali.
La terra e il cielo, noi - la luce per l’universo penetra e feconda. È la via della vita: geneSi.
Si viene alla luce, grazie alla luce: niente è stato fatto di tutto ciò che esiste, nelle tenebre.
Dì e notte, sonno e veglia, materia e pensiero, sopra e sotto, destra e sinistra, corpo e mente, maschile e femminile... Tutto è un matrimonio di amore con un patrimonio di luce, in una parte più e meno altrove.
Senza la luce, né l’uno né l’altro dei due. Non c’è né coppia né scoppio: né l’illuminazione e la separazione, né il ricongiungimento, il concepimento e la nascita. E, con la luce, solo se c’è la giusta rivoluzione.
La Luna "sbaglia" - mostra sempre la stessa faccia e, perciò, è l’una e l’una fissamente: ma è sempre graziosa, illumina la nostra notte - la sua luce.
Noi, il cielo e la terra - la Terra, e la Luce.
Questio siamo noi, la Terra: la luce o le tenebre?
La luce è venuta
nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre
alla luce: per sempre?
 La ginestra resiste, radicata alla
terra - protesa verso il cielo, e accoglie la luce.
La ginestra resiste, radicata alla
terra - protesa verso il cielo, e accoglie la luce.
Nelle tenebre, dov’è il dì e la notte?, dove il maschile e il femminile? dove il sopra e il sotto?, e quando il sonno e la veglia? Né l’uno né l’altro dei due - neutralmente. Nemmeno la luna.
Togli via questo astro del Sole che illumina il mondo: dove va il giorno?, dove va la vita - per noi, Terra?
Siamo immersi in un oceano di luce: tanti raggi corteggiano noi, la Terra: cielo e terra, maschio e femmina. Accogliere: femminile... è dell’uomo come della donna, anche il maschile.
Einstein era una-roccia, ma non restò di sasso. Fattosi coraggio, fece un passo avanti e saltò a cavallo di un raggio di luce.
Era ora. Quante pietre avevano bloccato la strada e indurito i cuori. Un uomo - finalmente - ha saputo accogliere un raggio di Sole e ha saputo dar vita con la sua mente e con il suo cuore a un eccezionale brillante new tono.
* Note per una epistemologia genesica:
- Sul simbolo che dà da pensare, si tenga presente - in prima approssimazione - L. Villari, La serpentina di Hogarth ("la Repubblica", 10.06.1989); e, F. Capra, Il Tao della Fisica (Milano, Adelphi, 1982): si ricordi, però, che il simbolo del Tao fu scelto da Niels Bohr come stemma per il suo casato; e, infine, ovviamente, il libro del Genesi.
 Per il resto, si cfr. W. Hogarth, Analisi della Bellezza, Milano, Editrice SE, 1989; F. Menna, William Hogarth. L’analisi della bellezza, Salerno, Editrice 10/17, 1988; J. Piaget, L’epistemologia genetica, Bari, Laterza, 1971; e, E. Fachinelli, La mente estatica, Milano, Adelphi, 1989; e, G. Dorfles, L’intervallo perduto, Torino, Einaudi, 1980. Sui lavori di questi due ultimi Autori, inoltre, cfr. le interessanti riflessioni di P. A. Rovatti (Il tempo della sospensione, "aut aut", 231, maggio-giugno 189, pp. 1-7).
Per il resto, si cfr. W. Hogarth, Analisi della Bellezza, Milano, Editrice SE, 1989; F. Menna, William Hogarth. L’analisi della bellezza, Salerno, Editrice 10/17, 1988; J. Piaget, L’epistemologia genetica, Bari, Laterza, 1971; e, E. Fachinelli, La mente estatica, Milano, Adelphi, 1989; e, G. Dorfles, L’intervallo perduto, Torino, Einaudi, 1980. Sui lavori di questi due ultimi Autori, inoltre, cfr. le interessanti riflessioni di P. A. Rovatti (Il tempo della sospensione, "aut aut", 231, maggio-giugno 189, pp. 1-7).
- EVOLUZIONE DELLA FISICA. «Nel nostro grande romanzo giallo non vi sono
problemi perfettamente risolti e sistemati per sempre.
 Dopo ben trecento anni siamo dovuti tornare sul
problema del moto, rivederne la procedura
investigativa e scoprire indizi rimasti inosservati, per
giungere così ad una nuova rappresentazione del
circostante universo».
Dopo ben trecento anni siamo dovuti tornare sul
problema del moto, rivederne la procedura
investigativa e scoprire indizi rimasti inosservati, per
giungere così ad una nuova rappresentazione del
circostante universo».
 Einstein e Infeld, The Evolution of Physics. The
Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity
and Quanta, 1938 (trad. it., Boringhieri, Torino 1965 e ss.).
Einstein e Infeld, The Evolution of Physics. The
Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity
and Quanta, 1938 (trad. it., Boringhieri, Torino 1965 e ss.).
- EVOLUZIONE DELLA "METAFISICA": IL NODO DELLA NATURA ("DEA ISIDE") E DEL NATURALISMO IN SHAKESPEARE. ENOBARBO che parla di Cleopatra: «L’età non la può avvizzire, né l’abitudine rendere stantia la sua infinita varietà. Le altre donne saziano fino alla nausea gli appetiti che suscitano, ma lei quanto più soddisfa tanto più affama». ("Age cannot wither her, nor custom staleHer infinite variety. Other women cloy The appetites they feed, but she makes hungry Where most she satisfies." -"Antonio e Cleopatra", II. 2. 240-244).
- "Certo, è curioso che «she makes hungry,/ Where she most satisfies» risulti non poco simile a ciò che scrive Dante dopo che Virgilio-Poesia lo ha portato fino a Beatrice-Sapienza (e Teologia cristiana). Quando la vede comparire in trionfo «di qua dal rio» nel Paradiso Terrestre, egli gu-sta infatti quel cibo «che saziando di sé di sé asseta» (II, 31, 129). D’altron-de, in entrambi i casi si tratta di una citazione di ciò che dice la Sapienza di se stessa in Ecclesiastico 24, 20: «Chi mangia di me avrà ancora fame,e chi beve di me avrà ancora sete».(Gilberto Sacerdoti, "Il sogno di Cleopatra", Pacini, 2019).
|
HOGARTH, ANALISI DELLA BELLEZZA |
Sul tema, in rete e nel sito, nel sito, si cfr.:
LA MENTE ACCOGLIENTE - CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
- UNA METODOLOGIA PER L’ANALISI QUALITATIVA: RESA E CATTURA DI WOLFF (di ROBERTO CIPRIANI)
- Sé come un altro ovvero “resa e cattura”: la prospettiva di Kurt Wolff di Roberto Cipriani.
- Mileva Einstein, nata Marić - Милева Марић (Titel, 19 dicembre 1875 - Zurigo, 4 agosto 1948), è stata una scienziata serba compagna di studi di Albert Einstein, di cui divenne anche prima moglie (...) Dal 1990 si è aperta la discussione sulla sua partecipazione ai lavori sulla teoria della relatività di Einstein.
- MICHELANGELO, IL SERPENTE DI BRONZO, Cappella Sistina - Volta.
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
 EU-ROPA ED EU-ANGELO. Lo Spirito d’Assisi..... Dominus Illuminatio Mea (Il Signore è la mia Luce).
EU-ROPA ED EU-ANGELO. Lo Spirito d’Assisi..... Dominus Illuminatio Mea (Il Signore è la mia Luce).
 NATALE: "CHRISTMAS" E "CHARITY". LE CREATURE A SCUOLA DA "MESSOR LO FRATE SOLE". Un omaggio a Oxford, per la sua "Festa della luce invernale"
NATALE: "CHRISTMAS" E "CHARITY". LE CREATURE A SCUOLA DA "MESSOR LO FRATE SOLE". Un omaggio a Oxford, per la sua "Festa della luce invernale"
FLS
Forum
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- GENESI. > LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- L’universo, "per il fisico Alan Guth è «il più grande dei pranzi gratis» (di A. Massarenti).31 marzo 2025, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, FILOLOGIA E TEOLOGIA TEOCRITEA ("CHARITAS), E MEMORIA DEL #CORAGGIO DI #ASSAGGIARE ("SÀPERE AUDE") (ORAZIO - KANT):
- L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI GRATIS».
Una lezione di "recupero" di antropologia filosofica di Armando Massarenti ("Il Sole 24 Ore", 24 aprile 2011):
Sicuri che nessun pasto è gratis?
«Nessun pasto è gratis», fu la risposta che un re ebbe dai suoi consiglieri dopo aver a lungo insistito per sapere, in un sola frase, quale fosse il senso della scienza economica. #Michael #Brooks, già autore del best seller "13 cose che non hanno senso", nel volume sulla #Fisica nella collana "Le grandi domande", diretta da #Simon #Blackburn (Edizioni Dedalo) esordisce con queste parole: «La bellezza della fisica si riassume in un fatto semplicissimo: un #bambino può fare domande cui nessun professore può rispondere».
Una di queste è «Perché non esistono pranzi gratis?». Che, in fisica, ci spinge a dare risposte in termini di «energia, entropia e ricerca del moto perpetuo». #LeonardodaVinci fece un’analisi dettagliata di una famosa macchina che pretendeva di generare il moto perpetuo, e spiegò perché non poteva funzionare. «O ricercatori del moto perpetuo», concludeva, «quante idee sconclusionate avete concepito nel corso di questa ricerca. Sareste pronti per andare a fare gli alchimisti». Cioè a sognare altri pranzi gratis. Eppure un pasto gratis sembrerebbe esistere, ed sarebbe niente meno che il nostro stesso Universo.
Per il fisico Alan Guth è «il più grande dei pranzi gratis», e ciò è dovuto al concetto cosmologico di «inflazione»: «l’Universo e tutta l’energia che contiene si sarebbero sviluppati a partire da un grammo di materiale. Una frazione di secondo dopo il #BigBang, l’Universo era cento miliardi di volte più piccolo di un protone, ma nel giro di 10-34 secondi aveva già raggiunto una dimensione pari a 1025 volte quella di partenza - qualcosa di simile a una biglia» e da lì sì è espanso sempre più fino alle immensità attuali. Nel corso di questo processo l’energia interna dell’Universo è cresciuta di un fattore 1075, il che sembrerebbe violare il principio che impedisce di avere qualcosa in cambio di nulla.
Invece c’è un dettaglio che permette di restare nell’ambito delle leggi fisiche conosciute: una parte dell’energia è negativa, come mostra la teoria della relatività generale. «L’energia associata alla materia è positiva - riassume Brooks -, e la creazione continua di materia fece aumentare l’energia positiva in modo tale da compensare l’aumento dell’energia negativa. In questo modo l’energia totale può rimanere costante. Gli antichi Greci affermavano che nulla può essere creato dal nulla, ma l’inflazione si permette di non essere d’accordo». E di affermare dunque la totale #gratuità dell’Universo.
Sarà proprio così? Di certo, nella nostra vita, ahinoi, continua a vigere la dura legge degli #economisti.
- NOTA:
- UN "SOGNO" DI #TEOCRITO, LE GRAZIE ("#CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE: UNA #DOMANDA DI ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...
- In ricordo di #LorenzoValla e di #GiambattistaVico, una breve nota....
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- RICERCA SCIENTIFICA E"MALOCCHIO": CON KANT, HELMHOLTZ, ED EINSTEIN, USCIRE DALLA CAVERNA DI "POLIFEMO".6 febbraio 2025, di Federico La Sala
RICERCASCIENTIFICA, "MALOCCHIO", PSICOANALISI, E CREATIVITÀ: IL "SAPERE AUDE!" DI KANT, IL PROBLEMA DELL’OCCHIO DI #PLATONE, E UNA QUESTIONE DI #BELLO.
UN INVITO A USCIRE DALLA CAVERNA DI "POLIFEMO" (CON L’ARIETE, "ULISSE", E DANTE ALIGHIERI).
In memoria di Immanuel #Kant, Hermann von #Helmholtz, e Marcel #Proust... un omaggio a Vincent DeLuise
RIAPRIRE IL PROGRAMMA SOCRATICO PLATONICO DELLA "CUPIDITA" ("EROS") DEL VEDERE CON GLI OCCHI E DEL GUARDAR-SI NEGLI OCCHI PER CONOSCER-SI, FORSE, BISOGNA RI-PRENDERE IL CAMMINO PROPRIO DALLA #CRITICA DELLA "RAGIONE PLATONICA". Se è vero, come è vero, che Giorgio Colli inizia il suo cammino di ricerca da una rilettura attenta del "Simposio" e dall’ "Alcibiade primo" e che, poi, giunga a tradurre la "Critica della ragion pura" di Kant (Alfonso M. Iacono, "Giorgio Colli: la dismisura nella misura", "Doppiozero", 04 Febbraio 2025), c’è da pensare che, per realizzare l’antichissimo desiderio «di fare, di due, uno», e così, di «guarire la natura umana» (Platone), probabilmente, voglia "dire" che si dovesse andare a fondo con Kant e reimpostare la questione.
"CHIUDERE UN OCCHIO" O "APRIRE GLI OCCHI"?! CON #FREUD, OLTRE: CREDO CHE SIA UNA OTTIMA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SUL TEMA, RIPARTENDO da alcune domande poste in "An #Inquiry into #Beauty" (cfr. Vincent De Luise, 2 febbraio 2025).
Chiedersi se "La bellezza è negli occhi di chi guarda? O la bellezza è nel cervello di tutti coloro che la guardano?"; e, al contempo, accogliere come validi i dati disponibili, che "suggeriscono la seconda ipotesi" (cit.), da una parte si richiamano antiche questioni che risalgono almeno a Platone (appunto, con tutte le conseguenze del caso) e, dall’altra, si rinvia quantomeno a una rilettura del "Manuale di Ottica fisiologica" di un "discepolo" di Kant: Hermann von Helmholtz).
DUE OCCHI E UNA SOLA "IDEA" ("VISIONE"). Helmholtz, nel varco aperto epistemologicamente da Kant, si porta sia al di là della dimensione euclidea dello spazio e del tempo di Newton (aprendo con #Riemann la via alle geometrie non euclidee e alla fisica di #Mach e #Einstein), e, ancora, sia sulla strada di studi "galileianamente" intesi sulla #fisiologia della #percezione, in #ottica e in #acustica, entro cui si colloca la stessa #neuroestetica.
Già solo capire che #Nietzsche, proprio dalla conoscenza delle ricerche di Helmholtz (mediata dalla lettura dell’opera di Friedrich A. #Lange, "Storia del materialismo e critica del suo significato nel presente"), scrive "#Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali" (1881), sollecita a ripensare meglio il suo rapporto non solo con Kant, ma anche lo stesso #Socrate e Platone (il cristianesimo storico e la tradizione illuministica e scientifica) e il "Crepuscolo degli idoli".
- NOTE:
- COSMOLOGIA #GEOLOGIA E #ANTROPOLOGIA: #PIANETATERRA E #SIDEREUS #NUNCIUS (#GALILEO #GALILEI, 1610). Ma non è il caso di cominciare ad uscire dal "#letargo" (Par. XXXIII, 94), svegliarsi dal #sonnodogmatico (ateo e devoto) della #cosmoteandria planetaria, #apriregliocchi e uscire dall’#inferno platonico-paolino di #bovillus (1510)?
- UN’EPIFANIA STORIOGRAFICA: UN "INVITO" A RILEGGERE "AURORA" (1881) DI #NIETZSCHE E CAMBIARE PARADIGMA ANTROPOLOGICO ED EPISTEMOLOGICO...
- Un omaggio e un augurio di buon lavoro a Vittorio Gallese
- "SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784): ALLA #RICERCA SCIENTIFICA DEL "#TEMPO #PERDUTO" (#HELMHOLTZ, 1850).....
- FILOSOFIA E #SCIENZA. UN #LETARGO "COSMOTEANDRICO" DI MILLENNI SUL PIANO SCIENTIFICO (FILOLOGICO, FILOSOFICO, TEOLOGICO, E ANTROPOLOGICO) E UNA SOLLECITAZIONE A SVEGLIARSI DAL "SONNO SOGMATICO" (#KANT): "QUESTO antropomorfismo psicologico lo riconosciamo nelle idee di #Platone come nella dialettica immanente al processo universale di #Hegel e nella volontà inconscia di #Schopenhauer" (HERMANN VON #HELMHOLTZ, 1877).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR HUGO, 1831): MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO".27 dicembre 2024, di Federico La Sala
CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR HUGO, 1831):
MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO" (O, DIVERSAMENTE, L’INIZIO DEL "CONTRORINASCIMENTO").
- In memoria di #Michelangelo Buonarroti, Marcel #Proust, e Walter #Benjamin
L’ ARCHITETTURA E IL LIBRO: L’INVENZIONE DELLA #STAMPA. Victor Hugo, in "Notre-Dame de Paris 1482", pubblicato nel 1831, in poche pagine sottolinea tutta l’importanza dell’#apertura di infiniti occhi, connessa al grande "occhio" che si apre nel #cielo culturale dell’#Europa #moderna con la invenzione di Gutenberg.
Nel cap. II del L. VII dell’opera, Hugo così inizia:
- "Le nostre lettrici ci scuseranno se ci fermiamo un momento per cercare quale potesse essere il pensiero che si celava sotto le enigmatiche parole dell’arcidiacono: Questo ucciderà quello. Il libro ucciderà l’edificio. A nostro avviso, quel pensiero aveva due facce. Era innanzitutto un pensiero da prete. Era il terrore del sacerdozio di fronte ad un elemento nuovo, la stampa. Era lo spavento e lo sbalordimento dell’uomo del santuario di fronte al torchio luminoso di Gutenberg. Erano la cattedra ed il manoscritto, la parola parlata e la parola scritta, che si allarmavano per la parola stampata [...].
- In effetti, dall’origine delle cose fino al quindicesimo secolo dell’era cristiana compreso, l’architettura è il grande libro dell’umanità, l’espressione principale dell’uomo ai suoi diversi stadi di sviluppo, sia come forza che come intelligenza.
- [...] Così, fino a Gutenberg, l’architettura è la scrittura principale, la scrittura universale. [...]
- [...] a partire dalla scoperta della stampa [...] a partire dal sedicesimo secolo, la malattia dell’architettura è visibile; essa ormai non esprime più in modo essenziale la società; si fa miserevolmente arte classica [...].
- È proprio questa decadenza che prende il nome di Rinascimento. È questo tramonto che noi scambiamo per un’aurora [...]
- Michelangelo, che fin dal sedicesimo secolo aveva senz’altro avvertito la sua morte, aveva avuto un’ultima idea, un’idea dettata dalla disperazione. Questo titano dell’arte aveva eretto il Pantheon sul Partenone e aveva fatto San Pietro di Roma. Morto Michelangelo, che fa questa miserabile architettura che sopravviveva a se stessa allo stato di spettro e di ombra? Prende San Pietro di Roma, lo ricalca, ne fa la parodia. È una mania. È una cosa pietosa. Ogni secolo ha il suo San Pietro di Roma; nel diciassettesimo secolo il tempio di Val-de-Grâce, nel diciottesimo Sainte-Geneviève. Ogni paese ha il suo San Pietro di Roma. Londra ha il suo. Pietroburgo ha il suo. Parigi ne ha due o tre. Testamento insignificante, ultimo vaneggiamento di una grande arte decrepita che rimbambisce prima di morire." (V. Hugo, cit.).
- Nota: "Cupola di San Pietro".
- NOTE:
- PIANETATERRA: UN #PANTHEON DA RIPENSARE E IL #SOLSTIZIO D’#INVERNO. UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "#SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "#TERRA" ALLA #LUCE DEL #SOLE... In memoria di Andrea #Vesalio, Niccolò #Copernico, #Galileo #Galilei ....
- PER LA #PACEPERPETUA. ALLA #RICERCA DEL #TEMPO PERDUTO....
 MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...
"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".
MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...
"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- IL SOLSTIZIO D’INVERNO: UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "TERRA" ALLA LUCE DEL SOLE.22 dicembre 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: UN PANTHEON DA RIPENSARE E IL SOLSTIZIO D’INVERNO. UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "#SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "#TERRA" ALLA #LUCE DEL #SOLE...
- In memoria di Andrea #Vesalio, Niccolò #Copernico, #Galileo #Galilei ...
ARCHITETTURA ECOLOGIA FILOSOFIA E OCULISTICA. Una nota sull’#occhio del Pantheon:
"[...] L’Oculus è un’apertura nel soffitto della cupola, realizzata con un diametro di oltre 8 metri, e rappresenta l’unica fonte di luce naturale all’interno dell’edificio. La sua creazione risale al I secolo d.C., quando l’imperatore romano Adriano fece ristrutturare l’antico Pantheon, che originariamente risaliva al 1 a.C.
Questo misterioso occhio circolare non solo illumina con la luce del sole l’interno del Pantheon, ma ha anche una funzione simbolica e mistica. L’Oculus rappresenta una connessione tra l’edificio e il cielo, come se un raggio di luce divina scendesse in quel santuario dedicato agli dei.
Inoltre, l’Oculus è stato progettato in modo tale da favorire una perfetta distribuzione dei pesi della cupola, che ha contribuito alla straordinaria stabilità e durevolezza di questo monumento. La cupola è in cemento e la sua costruzione fu una straordinaria opera di ingegneria per l’epoca.
L’Oculus del Pantheon offre anche un affascinante spettacolo naturale durante i giorni di pioggia. La pioggia che entra dal foro forma un effetto suggestivo, simile ad una cascata rovesciata, creando un’atmosfera mistica all’interno del tempio. [...]" (cfr. Accademia Studio Italia, "Il misterioso occhio del Pantheon: un buco nel paradiso!").
- AUGURI PER UN BUON #NATALE2024 E UN #BUONANNO2025...
- Note:
- STORIAELETTERATURA #ANTROPOLOGIA E #FILOSOFIA: #SAPEREAUDE (#KANT)! CON #ULISSE E #DANTE, RIPRENDERE IL FILO DALL’OPERA DI ANDREA #VESALIO ("De humani corporis #fabrica, 1543) E DI NICCOLO’ #COPERNICO ("De revolutionibus orbium coelestium", 1543), DALLA RIVOLUZIONE IN #ANATOMIA E IN #ASTRONOMIA, DALLA "LOGICA" DEL "CHIASMA OTTICO".
- ECOLOGIA (#OIKOS - #LOGOS), #COSMOLOGIA, #ARCHITETTURA. Una "#Casa", come lo è per l’intera umanità, e tutti gli altri esseri viventi, il #pianeta "#Terra", concepita "senza porta e senza finestra" (da dove entra la luce e da dove esce il fumo?), diventa una #caverna alla #Polifemo (il #ciclope con uno e uno solo "occhio" , incapace di #visione "#binoculare" - ricordare le ricerche di #Helmholtz), e, infine, una #tomba per un morto (ricordare il luogo di #sepoltura per eccellenza, quello di Gesù, della tradizione evangelica). Da non dimenticare è il "fatto" che #Virgilio sa bene indicare a #DanteAlighieri "la diritta via" per uscire dalla "casa chiusa", riprendere il viaggio interrotto di #Ulisse ed #Enea, e, infine, proseguire la navigazione nell’#oceanoceleste (Keplero, 1611).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA ---LA MEMORIA DI ARTEMIDE (DIANA DI EFESO) E LA "CULTURA" DELLA "AGRICOLTURA" SECONDO LA TEOLOGIA POLITICA "PLATONICA" (E "PLUTONICA")19 dicembre 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA DELL’ARATRO: IL RATTO DI PERSEFONE (PROSERPINA, KORE), LA MEMORIA ETIMOLOGICA DI ARTEMIDE (#DIANA DI #EFESO) E LA "CULTURA" DELLA"AGRICOLTURA" SECONDO LA TEOLOGIA POLITICA "PLATONICA" (E "PLUTONICA"). *
- "#ACHERONTA #MOVEBO" (En. VII, 312). In memoria di #Virgilio, #Dante, e #Freud... **
Nel "#Cratilo", #Platone, nella lezione sulle etimologie dei nomi degli dei e delle dee, così scrive e così fa dire al suo #Socrate, a proposito della #Diana Efesina:
"Ἄρτεμις" δὲ ‹διὰ› τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρθενίας ἐπιθυμίαν· ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν θεὸν ἐκάλεσεν ὁ καλέσας, τάχα δ’ ἂν καὶ ὡς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικί· ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ τιθέμενος ἔθετο τῇ θεῷ.
"Ad Artemide poi sembra che il nome sia stato posto per l’artemes (’l’integrità’) per l’ornatezza e per il suo desiderio di verginità. E probabilmente chi le assegnò il nome volle chiamarla esperta di virtù ("aretes histora") o forse anche perché detesta l’aratura ("ton aroton misesases") del maschio nella femmina: o per uno di questi motivi oppure per tutti questi insieme le pose questo nome colui che pose il nome alla dea" (406b).
- * Foto: "Il ratto di #Persefone da parte di #Plutone (#Ade, lo "Zeus degli inferi": ).
NOTE:
- #STORIA #LETTERATURA E #PSICOANALISI. Chiarimento di Freud sul significato di "Acheronta movebo".
- ARCHEOLOGIA #STORIA #POLITICA ED #ECONOMIA: UNA #IMMAGINE DELL’#ARATRO SU UNA MONETA DI "10 LIRE" (CONIAZIONE 1951-2001) DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
- ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI ("#COSTRUZIONI NELL’#ANALISI, 1937)", E #FILOLOGIA: «GRANDE E’ LA DIANA DEGLI EFESINI» (S. #FREUD, 1911): #EFESO, LA DEA MADRE, IL DIO FIGLIO, E L’#INTERPRETAZIONE PAOLINA DEL #MESSAGGIOEVANGELICO. Alcuni appunti...
- In memoria di #Eraclito e di #Shakespeare e ad #omaggio di #Eleusis2023...
- FILOLOGIA, #FILOSOFIA, E #PEDAGOGIA: UN "INVITO" A USCIRE DAL #LETARGO (Par. XXXIII, 94) E A RILEGGERE IL "CRATILO" DI PLATONE, A RIASCOLTARE "LA #VOCE DELLA SPOLA NEL #TEREO DI #SOFOCLE" (#ARISTOTELE), A #INSEGNARE E #IMPARARE A COME MEGLIO ["FARE LA SPOLA", E, ANTROPOLOGICAMENTE, A CONCEPIRE UN ALTRO MODO DI TESSERE IL RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE E RIPRODUZIONE, IN GENERALE...
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- "IL PROFUMO DELLA MADELEINE" E L’IMMAGINAZIONE QUANTISTICA: SECONDO "L’ORDINE DEL TEMPO" (CARLO ROVELLI).27 novembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #COSMOLOGIA:
"L’ORDINE DEL TEMPO" (ANASSIMANDRO) E "IL PROFUMO DELLA MADELEINE" (CARLO ROVELLI).
- Una nota in memoria di #Helmholtz e di #Proust, in omaggio a Carlo Rovelli...
STRANO, MA VERO: A Carlo Rovelli, PROPRIO NELLA SUA MAGISTRALE INDAGINE SULL’«ORDINE DEL TEMPO» (CITA PROUST E IL PROFUMO DELLA "MADDALENA", APPUNTO), SFUGGE L’IMPORTANZA DELLE RICERCHE DI HELMHOLTZ.
IMMAGINAZIONE QUANTISTICA: LA"PSICOPATOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA" (S. #FREUD) E IL "RITROVAMENTO" DELL’«#UOMO VITRUVIANO» (LEONARDO). Su questa "dimenticanza", forse, è opportuno interrogarsi, perché, a mio parere, è degna di grande interesse, ai fini sia delle ricerca filosofica sia cosmologica sia antropologica:
- "Ci stiamo avvicinando pericolosamente a noi stessi. Sembra già sentire #Tiresia, nell’#Edipo, che gli dice: «Fermati! O troverai te stesso»... O #Ildegarda di Bingen, che nel XII secolo cerca l’assoluto e finisce per trovare l’«uomo universale» al centro del cosmo" (C. Rovelli, "L’ordine del tempo, cit. , p. 134).
SCIENZA E LETTERATURA. Per riprendere il "discorso", e portare avanti la ricerca, degno di molta attenzione è un articolo del 2003 di #MarcoPiccolino, proprio sul tema di «Un “tempo perduto” tra scienza e letteratura: il "temps perdu" da Hermann von Helmholtz a Marcel Proust», che così inizia:
- "E’ da più di un secolo che Sigmund Freud ci insegna che quello che noi facciamo, pensiamo, ciò di cui abbiamo paura e anche quello che ci accade nel corso della nostra vita quotidiana, a volte in un modo apparentemente casuale e inatteso, può essere connesso a eventi distanti della nostra vita passata, eventi di cui apparentemente non serbiamo alcun ricordo, ma che hanno tuttavia lasciato tracce significative nei territori profondi della nostra personalità. La relazione che esiste tra gli avvenimenti passati e il presente della nostra vita non appare a volte in modo chiaro e ovvio, e sono spesso necessari, perché essa emerga, intensi sforzi da parte dell’ «archeologo» dell’inconscio umano, lo psicanalista. A volte ciò vale per il dominio ristretto dell’esperienza individuale, può essere anche vero per l’ambito più vasto della storia. La relazione tra eventi apparentemente lontani può essere allora rivelata attraverso il lavoro dello storico, che scandaglia le tracce profonde delle epoche passate, consultando antichi libri, manoscritti, che in alcuni casi nessuno ha letto per secoli, spesso situati in luoghi distanti e di difficoltoso accesso. [...]" (cfr. Marco Piccolino, Un “tempo perduto” tra scienza e letteratura: il “temps perdu” da Hermann von Helmholtz a Marcel Proust, Medicina audiologica, 1: 261-270, 2003).
LINGUISTICA E #FILOLOGIA: "MADELEINE", "MADDALENA", E "FISICA QUANTISTICA". L’ordine del tempo, incredibilmente, ha portato alla luce dalle profondità storiche del mare culturale mediterraneo il nesso (#nexus") latente tra la "Madeleine" del parigino #MarcelProust (ma anche il "papà Madeleine" di #Victor Hugo) e la Maddalena, l’isola della #Sardegna, e, infine, la "Maria di Magdala", la "Maria Maddalena" del messaggio evangelico (l’«Apostola degli Apostoli») e, con esso, di una sollecitazione antropologica a svegliarsi dal #sonnodogmatico della tradizione della "dotta ignoranza" platonico-paolina e costantiniana (#Nicea 325-2025).
- Nota:
-
>"L’ORDINE DEL TEMPO" (CARLO ROVELLI) E "NEUROBIOLOGIA DEL TEMPO (ARNALDO BENINI). Fisica e biologia, dialogo sul tempo (di Piero Bianucci)2 dicembre 2024, di Federico La Sala
Fisica e biologia, dialogo sul tempo
di Piero Bianucci (La Stampa, 26 Giugno 2017)
Chissà se il fisico Carlo Rovelli e il neurobiologo Arnaldo Benini sapevano l’uno dell’altro mentre scrivevano due libri usciti quasi nello stesso giorno che sembrano nati da un fitto dialogo tra loro. Entrambi, Rovelli dall’università di Marsiglia e Benini da quella di Zurigo, cercano di rispondere dal punto di vista della loro disciplina scientifica alla domanda da cento milioni di dollari “che cosa è il tempo”. Entrambi si avventurano cautamente l’uno sul terreno dell’altro, camminando con piede incerto in un campo minato. Entrambi attribuiscono alla controparte una posizione radicale: i fisici negano l’esistenza del tempo, i neurobiologi la affermano. Entrambi tentano una soluzione che includa l’idea di tempo altrui subordinandola alla propria: sotto il tempo biologico c’è l’assenza di tempo dei fenomeni fisici elementari, dice il fisico; ma non possiamo conoscere davvero la natura fisica sottostante perché il cervello stesso è interno alla natura, dice il neurobiologo. Alla fine, tempo biologico e tempo fisico appaiono inconciliabili, forse incompatibili: o è vero l’uno o è vero l’altro.
Ma c’è qualcosa di condiviso. Sia il fisico sia il biologo, quando arrivano sul limitare dei grandi interrogativi, ricorrono alle stesse parole magiche: il verbo “emergere” e il sostantivo “evento”. Due parole che prima o poi i filosofi della scienza dovranno prendere in serio esame e dirci che cosa in effetti vogliano dire in quei contesti. L’universo emerge dalla schiuma quantistica, emergono energia e particelle, dalla materia inerte emerge la vita, dalla vita emergono l’intelligenza, l’autocoscienza, il linguaggio, il senso del tempo e dello spazio. Fenomeni subnucleari e complessità macroscopiche, vita, coscienza, linguaggio sono “eventi”.
In “Neurobiologia del tempo” (Raffaello Cortina, 120 pagine, 14 euro) Arnaldo Benini analizza due tipi di tempo psichico: il tempo della percezione e il tempo percepito. Fu Hermann von Helmholtz all’età di 28 anni a scoprire e a misurare con esperimenti sulle rane che ci vuole un certo tempo perché uno stimolo si propaghi, e quindi venga avvertito. Di quel tempo non c’è (non può esserci) consapevolezza. E’ un “temps perdu”, un tempo perduto. Non il “temps perdu” di Marcel Proust (figlio di un medico amico di Marey, fisiologo e precursore del cinema), che invece è il tempo percepito e plasmato, deformato, selezionato e ritrovato della memoria.
Quanto è il “tempo perduto”? Helmholtz misurò una velocità di propagazione dello stimolo di circa 27 metri al secondo, un dodicesimo della velocità del suono nell’aria, meno di un decimilionesimo della velocità della luce. Da una estremità all’altra del corpo umano il tempo perduto è di circa un decimo di secondo. Ma è più corretto parlare di un “tempo compresso” perché sottratto alla coscienza. E’ necessaria inoltre una durata minima perché lo stimolo possa diventare consapevole.
A proposito di coscienza e dei meccanismi nervosi della volontà, rivoluzionari sono stati gli esperimenti fatti da Benjamin Libet all’Università di San Francisco negli anni 70 del secolo scorso. Quegli esperimenti dimostrarono che molte delle nostre azioni partono almeno un decimo di secondo prima di averne coscienza e spesso si arriva a più di mezzo secondo. Ecco perché in auto, quando avvertiamo un pericolo improvviso, il piede schiaccia il freno prima ancora il cervello abbia valutato la situazione consapevolmente. Ma i dati di Libet pongono anche il problema del libero arbitrio nelle decisioni, e quindi la questione della responsabilità morale. Non viviamo la vita in diretta ma in differita, sia pure solo di qualche decimo di secondo, e il cervello può comprimere o distorcere il tempo soltanto perché lo crea - conclude il neurobiologo.
Se la compressione del tempo e l’anticipazione della volontà sono meccanismi evolutivi vantaggiosi anche senza scomodare la coscienza, quest’ultima nelle forme di vita più evolute “emerge” per offrire altri vantaggi e sottrarci all’impressione piatta di un eterno presente. Il nucleo soprachiasmatico, un grumetto di appena 20 mila neuroni collocato nell’ipotalamo, è il principale dei nostri orologi biologici, quello che distribuisce il segnale orario circadiano: lo troviamo già nel moscerino della frutta. Nell’uomo entrano in gioco l’ippocampo e zone limitrofe. Grazie ai ricordi e alla loro disposizione, si struttura l’esistenza e, nel breve periodo, sono possibili esperienze come il linguaggio e l’ascolto musicale, che richiede una memoria delle note già ascoltate perché sia possibile interpretare e godere di quelle successive: la musica è essenzialmente un’arte del tempo, dice Benini, il che non toglie che spesso il tempo noi lo rappresentiamo come uno spazio, un andare da qui a là, e il ballo ne è l’espressione più evidente.
La neurobiologia del tempo ci mette di fronte a fenomeni interessanti. Uno è l’illusione della simultaneità tra visione e udito. Quando osserviamo le labbra di una persona che ci parla da un certa distanza - alcune decine di metri - non avvertiamo il ritardo tra il segnale luminoso, praticamente istantaneo, e il segnale acustico, che arriva dopo parecchi centesimi di secondo. Solo quando la distanza è maggiore la differenza di tempo ci sorprende (per esempio la separazione tra lampo e tuono). Altri fenomeni di grande rilievo sono la selezione e fissazione dei ricordi, la creazione di falsi ricordi, la prospettiva a geometria variabile sul passato e sul futuro con il progredire dell’esistenza, il tempo anomalo che sperimentiamo nei sogni o generato da patologie cerebrali.
La conclusione di Benini dopo la sua lucida review delle conoscenze attuali è che “non ci possiamo congedare dal tempo”. Cervello, coscienza e tempo sono inseparabili e innegabili. Ma come si concilia questa certezza intuitiva prima ancora che scientifica con l’inesistenza del tempo che i fisici constatano con i loro esperimenti?
“Il fisico Steven Weinberg - scrive Benini tornando nelle ultime pagine al nocciolo della questione da cui era partito - sostiene che la validità di ogni principio generale della biologia si basa sui principi fondamentali della fisica, di per sé inspiegabili, e su accidenti come l’impatto di un asteroide con la Terra 65 milioni di anni fa. La materia vivente segue gli stessi principi di quella inerte. (...) Giusto, ma se la psicologia è biologia e la biologia è basata sulla fisica, la fisica non può escludere con calcoli matematici la realtà del tempo.”
Il mondo della fisica moderna ha quattro dimensioni, un numero illimitato di “tempi” diversi (anche reversibili), uno spazio curvo ed “eventi” correlati a distanza in un presente totalizzante. Osserva Benini: “Lo spazio tridimensionale in cui la coscienza ci fa vivere è prodotto da meccanismi nervosi congeniti (...). L’evoluzione ha selezionato meccanismi nervosi che trasmettono alla coscienza lo spazio tridimensionale della Terra piatta e del Sole che le gira intorno; in questo spazio, che i meccanismi cerebrali della razionalità hanno dimostrato essere irreale, l’uomo si trova molto più a suo agio di quanto si troverebbe se avvertisse di girare a velocità folle su un frammento di sfera che, in un anno, fa un giro intorno al Sole.”.
 Da qui la tentazione di stabilire una gerarchia tra il tempo dei fisici e il tempo dei biologi: “Il fisico Carlo Rovelli sostiene che ‘è necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali’. Dal momento che i meccanismi del senso del tempo sono distribuiti in gran parte del cervello, e che essi funzionano spontaneamente, per pensare la realtà senza tempo bisognerebbe cambiare il cervello. Impresa tanto più disperata - ecco l’affondo finale di Benini - in quanto dovrebbe essere il cervello a cambiare se stesso.”
Da qui la tentazione di stabilire una gerarchia tra il tempo dei fisici e il tempo dei biologi: “Il fisico Carlo Rovelli sostiene che ‘è necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali’. Dal momento che i meccanismi del senso del tempo sono distribuiti in gran parte del cervello, e che essi funzionano spontaneamente, per pensare la realtà senza tempo bisognerebbe cambiare il cervello. Impresa tanto più disperata - ecco l’affondo finale di Benini - in quanto dovrebbe essere il cervello a cambiare se stesso.”Il riferimento a Rovelli, fisico teorico che guida le ricerche sulla gravità quantistica all’Università di Aix-Marseille, conduce spontaneamente al suo ultimo libro “L’ordine del tempo” (Adelphi, 207 pagine, 14 euro). Anche questa è una rassegna di intuizioni filosofiche e di idee scientifiche che si sono susseguite nei secoli da Anassagora (V° secolo avanti Cristo) ad oggi. Se ne ricava un progressivo sfaldarsi del concetto di tempo, fino alla sua dissoluzione nella fisica contemporanea (ma non nella concezione corrente, un po’ come accade per la rotazione della Terra, non assimilata nella mentalità quotidiana). Sì, perché Il tempo e lo spazio ci appaiono ancora come il palcoscenico sul quale si svolgono i fatti del mondo e dove ognuno di noi interpreta la sua piccola parte, entrando e uscendo da quinte a senso unico: da un lato c’è il passato, dall’altro il futuro. Questo spazio-tempo percepito come un contenitore assoluto, eterno, esistente in sé, risale agli antichi pensatori greci. Isaac Newton lo rileva come teatro dell’universo per collocarvi i moti planetari e le stelle regolati dalla gravità, non senza qualche turbamento per le obiezioni del suo irriducibile rivale Leibniz, contrario a riconoscere allo spazio-tempo le stesse proprietà assolute ed eterne di Dio.
Spazio e tempo newtoniani passano in Kant ma si laicizzano riducendosi a categorie della Ragione, funzioni a priori dell’intelletto, prive di realtà ontologica. Quanto alla principale proprietà del tempo sia fisico sia biologico, Clausius posò una pietra miliare del pensiero nel 1865 introducendo il concetto (e la parola) di entropia, che attribuisce al tempo una direzione ineludibile: le frittate non tornano ad essere uova, ogni essere vivente prima o poi muore, l’universo stesso un giorno si spegnerà. E’ il tempo “termico”, emerge dalla complessità del mondo macroscopico: statisticamente il disordine può solo aumentare e questo fatto rende il tempo a senso unico. L’Ottocento finisce con un tempo assoluto che scorre in una lentissima agonia senza fine.
La crisi del tempo assoluto incomincia nel 1905 con la relatività speciale di Einstein: gli orologi rallentano se viaggiano velocemente, il tempo scorre con un ritmo che dipende dalla velocità del moto relativo, più ci si avvicina alla velocità della luce più si dilata: orologi in volo su aerei e particelle nucleari accelerate ne danno una prova lampante. L’altro colpo fatale arriva con la relatività generale che Einstein pubblica nel 1916: anche la gravità influisce sullo scorrere del tempo quanto più il campo gravitazionale è intenso tanto più il tempo rallenta. La prima dimostrazione si ottiene confrontando un orologio atomico in pianura con un orologio identico portato in alta montagna. Oggi gli orologi atomici sono così diventati così precisi che basta confrontare un orologio su un tavolo con uno sul pavimento.
Il palcoscenico di Newton è svaporato. Il tempo di Einstein non è più assoluto, è un fatto locale. Addirittura, in un buco nero si ferma. Lo spazio-tempo è plasmato dalle masse. Ogni evento ha il suo tempo, perché il tempo localmente scorre a velocità diverse. Non esiste un “presente” comune a tutto l’universo. E come se non bastasse, il microcosmo, regolato dalla meccanica quantistica, ci mostra fenomeni nei quali passato e futuro sono intercambiabili. In definitiva, il tempo non esiste. Dunque, dice Rovelli, Il mondo non è fatto di cose ma di processi e, nel caso di noi viventi, di punti di vista. Viviamo in bolle di spaziotempo tra loro non confrontabili. In queste bolle dall’orizzonte limitato emerge (parola magica!) la freccia del tempo: gli eventi si dispongono in un “ordine”, che tuttavia è solo un punto di vista dovuto alla nostra “ignoranza”. Dalla nostra prospettiva vediamo una minima parte del mondo, e lo vediamo scorrere nel tempo. Emergono passato, presente e futuro, nascita e morte. L’entropia misura in realtà la nostra incertezza, rende misurabile la nostra ignoranza: il tempo della mente ne è un riflesso.
Questo può dire la scienza, la ragione. Ma la ragione stessa ci mostra i suoi limiti. Alla fine, gli eventi che contano si chiamano gioia, sofferenza, amore, paura. Cose irrazionali. Rovelli, in questo che è il suo libro più vero, ci porta fino a una soglia oltre la quale ognuno deve andare avanti da solo. Lui, il fisico, sconfina nella poesia: “A me sembra che la vita, questa breve vita, sia il grido continuo delle emozioni, che ci trascina, che proviamo talvolta a chiudere in un nome di Dio, in una fede politica, in un rito che ci rassicuri che tutto alla fine è in ordine, in un grande grandissimo amore, e il grido è bello e splendente. Talvolta è dolore. Talvolta è canto.”
Strane cose succedono quando due discipline, fisica e neuroscienze, dopo aver viaggiato per tanto tempo su binari diversi, provano a incontrarsi. Il dialogo è appena iniziato.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- COSMOLOGIA ED "ENIGMISTICA": IL "GRANDE GIOCO", IL "SATOR AREPO", E "L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE"24 novembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E COSMOLOGIA.
STORIA STORIOGRAFIA E PROFEZIA: MEMORIA DELLA "PRIMA RINASCITA", DI JAKOB BOEHME, E DEL "CONCILIO VATICANO II". *
Una nota margine di una riflessione del prof. Flavio Piero Cuniberto:
L’ANNO E L’ANELLO
(24 novembre 2024, Solennità di Cristo, Re dell’Universo).
La corona è il coronamento dell’Anno liturgico, che si chiude, come la corona, ad anello, celebrando nella sua preziosità scintillante la perfezione circolare dell’Alfa e dell’Omega, della fine che coincide con l’inizio (l’aprirsi aurorale del nuovo Anno, con l’Avvento, dopo l’ultima domenica del tempo ordinario).
 L’apparente ripetizione - di sempre nuovi anelli - è l’effetto dello strabismo creaturale, che vede come ritorno dell’identico il rampollare delle infinite forme (l’universo) dentro il Cerchio Eterno.
L’apparente ripetizione - di sempre nuovi anelli - è l’effetto dello strabismo creaturale, che vede come ritorno dell’identico il rampollare delle infinite forme (l’universo) dentro il Cerchio Eterno.
 Il Patriarca Enoch, che "camminò con Dio", visse 365 anni e "non conobbe la morte".
Il Patriarca Enoch, che "camminò con Dio", visse 365 anni e "non conobbe la morte".P.S. Lo spostamento della Solennità all’ultima domenica dell’A.L. è tra le pochissime innovazioni del Vaticano II su cui - si direbbe - ha aleggiato lo Spirito della profezia: su quasi tutte le altre ha soffiato, in contrasto drammatico, tutt’altro spirito.
Flavio Piero Cuniberto (Facebook (ripresa parziale - senza immagine)
* MEMORIA DELLA "PRIMA RINASCITA", DI JAKOB BOEHME, E DEL "CONCILIO VATICANO II".
SICCOME CHI GUIDA IL "GRANDE GIOCO" E’ IL FAMOSO "SATOR AREPO" ("L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE"), FORSE, è bene ricordare, chiarissimo prof. Flavio Piero Cuniberto, che la istituzione della "Solennità di Cristo, Re dell’Universo" (nel senso della tradizione paolina e cosmoteandrica), di #oggi, #24novembre 2024, "risale" a Papa Pio XI, all’anno Giubilare 1925.
A PROPOSITO DI #ANELLO, FORSE, E’ IL CASO DI RESTITUIRE "L’ANELLO DEL PESCATORE" A GIUSEPPE (1223).
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- UN "SAUSSURE" DI LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA CHIASMATICA: LA QUESTIONE DEL NOME, A TUTTI I LIVELLI.19 novembre 2024, di Federico La Sala
"COME TI CHIAMI?": LA QUESTIONE DEL NOME, A TUTTI I LIVELLI.
UN "SAUSSURE" DI ANTROPOLOGIA CHIASMATICA ("#CRISTOLOGIA"), #FILOLOGIA, #STORIA, #PSICOANALISI, #PSICHIATRIA, E #LINGUISTICA...
- In memoria di Ferdinand de Saussure e di Tullio De Mauro, di Elvio Fachinelli, e di Franca Ongaro Basaglia...
“Bisogna delirare un po’ per trovare il nome giusto”, scrive Pietro Barbetta nel libro "#Follia e #creazione. Il caso clinico come esperienza letteraria" (Mimesis Edizioni, 2012). #Anna Stefi, nella sua recensione (cfr. "Pietro Barbetta. Follia e creazione", "Doppiozero", 13 marzo 2013 ), muove dal #nodo fondamentale del discorso:
- "La nominazione - scrive [Barbetta] - s’interpone, gesto, tra il corpo e il linguaggio. La nominazione è vista nel suo potere performativo, battesimo: dare un nome, nella scrittura di un caso clinico, non è mero espediente; è scrivere un racconto, suggerire qualcosa di ulteriore, rifiutandosi di credere che il rigore senza immaginazione che pertiene al discorso scientifico non veicoli, con la sua pretesa neutralità, una distorsione, tanto più insidiosa perché celata. La vita non è un’essenza descrittiva piegata sui fatti. [...]" (cit.).
Una indicazione e una sottolineatura formidabile, a mio parere, un segnavia per venir fuori dall’orizzonte della tragedia, della #claustrofilia (Elvio Fachinelli, 1983), e aprire la strada a "una #schizofrenia della #salute" (#Rubina Giorgi)!
#STORIAELETTERATURA E #METATEATRO: "THE #MOUSETRAP" (#SHAKESPEARE). Questo è il problema amletico su cui riflettere: ne va del proprio "essere, o non essere" ("#Amleto").
CREATIVITA’ E #MENTEACCOGLIENTE: #COMENASCONOIBAMBINI? Freud dice: "La psicoanalisi è una mia #creatura". Ma "Chi", #Chi (lettera dell’ alfabeto greco: "X"), ha dato il nome a "#PietroBarbetta": al "#bambino" (a tutti gli "esseri" del "mondo")?!
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- La luce e la vita formano una unità indivisibile (di Albert Hofmann - il manifesto, 1998)..25 ottobre 2024, di Federico La Sala
ELOGIO DEL PURO...
La luce e la vita formano una unità indivisibile
di ALBERT HOFMANN (il manifesto, 08/02/1998)
 E’ opinione largamente diffusa che la visione oggettiva e materiale del mondo sostenuta dalle scienze naturali e l’esperienza mistico-religiosa siano tra loro in contrasto. E’ vero semmai il contrario. Esse si integrano in quella che è la visione comprensiva dell’unica e medesima realtà spiritual-materiale. Ciò può venir colto in maniera particolarmente suggestiva attraverso, ad esempio, l’osservazione di una bella farfalla, come quelle che splendidamente figurano in questo libriccino. Contemplando siffatti gioielli di natura si possono schiudere quei pensieri che concernono la creazione intera e la natura umana ivi racchiusa.
E’ opinione largamente diffusa che la visione oggettiva e materiale del mondo sostenuta dalle scienze naturali e l’esperienza mistico-religiosa siano tra loro in contrasto. E’ vero semmai il contrario. Esse si integrano in quella che è la visione comprensiva dell’unica e medesima realtà spiritual-materiale. Ciò può venir colto in maniera particolarmente suggestiva attraverso, ad esempio, l’osservazione di una bella farfalla, come quelle che splendidamente figurano in questo libriccino. Contemplando siffatti gioielli di natura si possono schiudere quei pensieri che concernono la creazione intera e la natura umana ivi racchiusa.In primo luogo la vista di queste incantevoli creature, ove la bellezza ha la sua dimora, ci rende intensamente felici. Esse sembrano provenire da un altro mondo, più luminoso, più colorato, più gaio, un mondo più spirituale privo di pesantezza. Tutti gli sforzi tesi a raccontar in dettaglio questa bellezza, questi colori di uno splendore cangiante e opalescente, naufragano. Vani sarebbero pure gli sforzi che mirassero a estrarre questi bei colori dalle ali della farfalla. Esse difatti non contengono alcun pigmento. La colorazione è dovuta a piccolissimi cristalli di sostanze incolori di grandezza pari alla lunghezza d’onda della luce, i quali, attraverso la rifrazione luminosa, danno origine, così come accade per l’arcobaleno, a questi meravigliosi effetti cromatici.
Per quale motivo si dà la possibilità di venir sedotti dall’essenza e dalla bellezza delle farfalle? Io credo che ciò derivi dall’esperire la nostra coappartenenza alla creazione.
Quando sosto lo sguardo su di un fiore del prato lungo il margine del bosco, su cui or ora si è posata una farfalla - Sommervogel è il nome in dialetto locale con cui chiamiamo queste meravigliose creature - vivo con essa un "raccoglimento nel mondo", nell’eterno istante del qui e ora, avvolti nell’identica radiosa cupola celeste, entrambi sfiorati dal medesimo sussurrante alito di vento. Siamo l’uno accanto all’altra sopra questo splendido angolino di terra entro lo spazio infinito del tutto; ciascuno con la propria individualità, partecipiamo della vita universale che attraversa il cosmo nell’istante senza fine. Sorretti da questa consapevolezza, si è rapiti da un amore per la vita che ci colma di gioia.
Sono pertanto la luce, la vita, l’amore che tengono uniti tutti noi. Qualora uno dei tre difettasse, non si darebbe alcun essere nell’oscuro vuoto infinito dello spazio interplanetario.
- La luce e la vita formano una unità indivisibile.
Grazie all’irraggiamento della luce, sulla terra inanimata si sono formate le molecole, da cui è nata la cellula primordiale della vita. Dagli esseri viventi unicellulari si è poi sviluppata, sotto gli occhi luminosi dell’amorevole genio creatore, la scala del creato; dalle primitive piante senza fiore a quelle con i fiori, dagli animali primordiali passando attraverso i pesci, i rettili, gli uccelli fino ai mammiferi e infine all’uomo.
In virtù del flusso d’energia luminosa è sorta la vita sulla terra. La verde coltre del regno vegetale può accogliere entro di sé, con sensibilità materna, il torrente di luce che unisce il sole alla terra e usufruendo di questa energia è in grado, dall’acqua della terra e dall’acido carbonico dell’aria, di dar vita a nuove piante, alimento per l’uomo e l’animale. Grazie alla luce proveniente dalla primigenia fonte d’energia cosmica si è sviluppata e si sostiene la vita intera, quella vegetale, quella animale e quella umana.
Lo stesso processo mentale del cervello umano viene alimentato da questa sorgente di energia, per cui anche l’anima umana, la nostra coscienza, rappresenta il più elevato e sublime grado di trasformazione della luce. Noi siamo esseri luminosi; ciò non è soltanto un’apprensione mistica a cui alludono la parola illuminazione e l’importanza accordata alla luce in molte religioni, ma anche un riconoscimento da parte delle scienze naturali.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE ---- ANTROPOLOGIA FILOSOFIA E LINGUISTICA ALLA LUCE DEL SOLE.19 ottobre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOGENESI FILOLOGIA E FILOSOFIA: CHE GRANDE "PREISTORIA" DELL’INTERA #UMANITA’ DEL PIANETA TERRA!
RIPARTIRE DA CAPO, E IMPARARE A #CONTARE, A #CALCOLARE...
INDIVIDUO E SPECIE: "L’ONTOGENESI RICAPITOLA LA FILOGENESI" (ERNST #HAECKEL).
MA QUALE "RICAPITOLAZIONE", COME DA #ANTROPOLOGIA COSMICA, QUALE QUELLA DI #DANTE ALIGHIERI ("L’#AMOR CHE MUOVE IL #SOLE E LE ALTRE #STELLE") O COME QUELLA (DELL’ATTUALE #PRESENTE STORICO) DA #ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DA "#CAVERNA" PLATONICA E PAOLINA)?!
"SAPERE AUDE!" (#KANT, 1784). NON E’ IL CASO DI CORRERE AI RIPARI E, FINALMENTE, uscire dall’orizzonte della #tragedia e dal #letargo epistemologico e #correggere un’operazione #matematica "sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#Franca Ongaro #Basaglia, 1978)!!!
COSMOTEANDRIA E STORIA. LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO:
 "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).
"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).- NOTE:
- MEMORIA, #STORIA, #SCIENZA, #STORIOGRAFIA E #CRITICA: ERNST HAECKEL. "Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (Potsdam, 16 febbraio 1834 - Jena, 9 agosto 1919) è stato un biologo, zoologo, filosofo e artista tedesco.( ...)".
- ELIOCENTRISMO (COPERNICO), "ELIOCENTRISMO" (COSMOTEANDRIA), ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024) E #TEOLOGIA-#POLITICA DEI #DUE SOLI (#DANTEALIGHIERI) ALLA #LUCE DEL #SOLE (NON DEL "RE SOLE")!
- "SÀPERE AUDE" (#ORAZIO). Da sempre ogni #essere umano cammina "#insieme" ("#together"( con #sé stesso (come un #altro), ma dopo la lezione minoica-ateniese (di #Arianna e #Teseo) e millenni di #labirinto edipico (e dopo gli innumerevoli tentativi di chiarimenti di tanti esploratori e tante esploratrici) non è ancora tempo di venir fuori dallo "#stato di #minorità" (#Kant, 1784), uscire dall’#inferno, e arrivare alla #Terra Promessa?
- ARCHEOLOGIA E #ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, #LINGUISTICA, ED #EVANGELOGIA:
- "AMORE E’ PIU’ FORTE DI #MORTE" (Ct. 8.6 - Giovanni Garbini, 1992).
- "La Lode non «elogia» nessuno, è invece teofanica, effusiva: è il manifestarsi del Divino come Canto, nel «corpo» della Lingua. [...] Una Presenza «nuziale»? Sì, perché la Presenza è il luogo delle Nozze Eterne [...]" (Flavio Piero Cuniberto, «Meditazione sulla ’Lode’ e il ’Lodare’»).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E ... LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- Einstein e Lemaître: due amici, due cosmologie... (di Dominique Lambert - "DISF").20 luglio 2024, di Federico La Sala
Einstein e Lemaître: due amici, due cosmologie...
di Dominique Lambert *
Académie Royale de Belgique (Classe des Sciences) Université de Namur, 2016
Georges Lemaître (1894-1966) incontrò per la prima volta Albert Einstein nell’ottobre del 1927, durante il Quinto Congresso Solvay di Fisica a Bruxelles. Questi congressi, come sappiamo, ebbero un ruolo importante nella storia della fisica. A questo congresso del 1927 furono presenti, tra gli altri, Marie Curie, Bohr, Born, Dirac, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg... L’invito di Lemaître a questo congresso fu probabilmente suggerito agli organizzatori da Théophile de Donder della Université Libre de Bruxelles che aveva scritto uno dei primi libri in francese sulla teoria della relatività generale. De Donder conobbe il giovane sacerdote perché fu nella giuria che gli assegnò una borsa per andare a Cambridge (UK) dopo che Lemaître aveva vinto una competizione presentando un manoscritto intitolato The Physics of Einstein. Del resto, per raccomandarlo ad Eddington, De Donder disse che “riteneva il signor Lemaître uno studente molto brillante, straordinariamente veloce e acuto, e di grande abilità matematica”.
Nel 1926, Lemaître aveva appena ottenuto il suo dottorato al MIT e, nel 1927, aveva pubblicato il suo famoso articolo intitolato “Un universo omogeneo di massa costante e raggio crescente che giustifica la velocità radiale delle nebulose extragalattiche” (A homogeneous universe of constant mass and increasing radius accounting for the radial velocity of extra-galactic nebulae) spiegando ciò che oggi chiamiamo “legge di Hubble”. Partendo da una soluzione delle equazioni di Einstein corrispondente a un universo in espansione Lemaître dedusse, rigorosamente e per la prima volta, il fatto che la velocità delle galassie lontane (chiamate allora nebulose) è proporzionale alla loro distanza (la costante di proporzionalità è oggi detta “costante di Hubble”). Questo articolo fondamentale, in cui si può trovare il computo della costante di Hubble (due anni prima della pubblicazione della legge di Hubble!) fu pubblicato da un giornale belga: Les Annales de la Société Scientifique de Bruxelles. Questo giornale era la rivista della Société Scientifique de Bruxelles, un’associazione che riuniva gli scienziati cattolici e che rivestì un ruolo centrale nell’organizzazione dei Congressi Scientifici Internazionali dei Cattolici alla fine del diciannovesimo secolo. Grazie a uno dei suoi amici, Einstein aveva letto l’articolo di Lemaître. Camminando lungo i vialetti del “Parc Léopold” a Bruxelles, vicino all’edificio in cui si teneva il congresso, Einstein e Lemaître discussero dell’articolo del 1927. Einstein non aveva nulla da dire al giovane sacerdote circa la parte matematica dell’articolo, che era tecnicamente perfetta, ma discordava completamente con lui sulla sua interpretazione fisica. Einstein disse molto aspramente: “dal punto di vista della fisica ciò mi sembra abominevole”. Qual è la ragione di una reazione così brutale? Infatti all’epoca Einstein non ammetteva un universo in espansione. Probabilmente influenzato dalla sua filosofia implicitamente spinoziana, non accettava il fatto che l’universo avesse una storia reale. Si ricordi che Einstein aveva mostrato la sua forte opposizione agli articoli di Alexander Friedmann, il matematico e meteorologo russo che tra il 1922 e il 1924 aveva scoperto soluzioni delle equazioni di Einstein corrispondenti a universi in espansione e in contrazione. Secondo Einstein, l’universo come tutto deve restare sempre immutabile. Il primo modello cosmologico di Einstein, pubblicato nel 1917, era infatti un universo sferico e perfettamente statico. È degno di nota il fatto che Georges Lemaître, quando scrisse il suo articolo sulla recessione delle nebulose, non conosceva le scoperte di Friedmann. Nel 1929 Lemaître disse che fu Einstein stesso a informarlo dell’esistenza degli “universi (in espansione e in contrazione) di Friedmann”. [...]
 Nel gennaio del 1933 Lemaître era ancora al Caltech quando vi arrivò Einstein, proveniente da Los Angeles. Questi era molto interessato alle recenti idee cosmologiche di Lemaître nel contesto della sua “Ipotesi dell’atomo primordiale” risalente al 1931. L’11 gennaio Einstein assistette a un seminario tenuto dal sacerdote sui raggi cosmici all’Osservatorio di Mount Wilson, vicino Pasadena, il celebre luogo dove lavorava Edwin Hubble. Sappiamo che Lemaître considerava queste radiazioni come una sorta di “radiazione fossile” che ci poteva dire qualcosa sui primi istanti dell’universo. Dopo questo seminario Einstein sarebbe dovuto andare ad un altro seminario di fisica teorica, ma dimenticandosi di quest’ultimo appuntamento preferì continuare a parlare con Lemaître di cosmologia! Durante questa discussione, Einstein gli fece sapere che non gradiva “l’ipotesi dell’atomo primordiale” perché, egli disse, “suggerisce troppo l’idea (teologica) di creazione”. Curiosamente e forse un po’ ironicamente, dopo una conferenza di Lemaître a Pasadena in cui questi aveva spiegato la sua cosmologia dell’atomo primordiale, Einstein disse: “Questa è la più bella e soddisfacente spiegazione della creazione che io abbia mai sentito”! Lemaître non iniziò mai una vera discussione filosofica con Einstein. Ma, chiaramente, grazie alla sua formazione tomista a Lovanio, Lemaître identificò perfettamente la confusione fatta dal suo amico, e da molti altri cosmologi dopo di lui, tra “creazione” e “inizio”. Secondo Lemaître, la singolarità iniziale non era “la creazione” (nel senso teologico) ma solo “l’inizio naturale”, come disse molte volte. [...]
Nel gennaio del 1933 Lemaître era ancora al Caltech quando vi arrivò Einstein, proveniente da Los Angeles. Questi era molto interessato alle recenti idee cosmologiche di Lemaître nel contesto della sua “Ipotesi dell’atomo primordiale” risalente al 1931. L’11 gennaio Einstein assistette a un seminario tenuto dal sacerdote sui raggi cosmici all’Osservatorio di Mount Wilson, vicino Pasadena, il celebre luogo dove lavorava Edwin Hubble. Sappiamo che Lemaître considerava queste radiazioni come una sorta di “radiazione fossile” che ci poteva dire qualcosa sui primi istanti dell’universo. Dopo questo seminario Einstein sarebbe dovuto andare ad un altro seminario di fisica teorica, ma dimenticandosi di quest’ultimo appuntamento preferì continuare a parlare con Lemaître di cosmologia! Durante questa discussione, Einstein gli fece sapere che non gradiva “l’ipotesi dell’atomo primordiale” perché, egli disse, “suggerisce troppo l’idea (teologica) di creazione”. Curiosamente e forse un po’ ironicamente, dopo una conferenza di Lemaître a Pasadena in cui questi aveva spiegato la sua cosmologia dell’atomo primordiale, Einstein disse: “Questa è la più bella e soddisfacente spiegazione della creazione che io abbia mai sentito”! Lemaître non iniziò mai una vera discussione filosofica con Einstein. Ma, chiaramente, grazie alla sua formazione tomista a Lovanio, Lemaître identificò perfettamente la confusione fatta dal suo amico, e da molti altri cosmologi dopo di lui, tra “creazione” e “inizio”. Secondo Lemaître, la singolarità iniziale non era “la creazione” (nel senso teologico) ma solo “l’inizio naturale”, come disse molte volte. [...]
 Nel 1949 P.A. Schilpp propose al canonico Lemaître si scrivere un capitolo nel libro Albert Einstein Philosopher and Scientist (Albert Einstein filosofo e scienziato) pubblicato per celebrare il 70o compleanno di Einstein. A Pasadena e a Princeton una gran parte delle discussioni tra Einstein e Lemaître erano state dedicate al problema della costante cosmologica. Einstein la voleva eliminare e Lemaître la considerava un elemento molto importante, sebbene forse non ancora ben formulato, del formalismo della cosmologia relativistica. In una lettera del 30 luglio 1947 indirizzata a Einstein, il canonico gli scrisse che riteneva che l’introduzione della costante cosmologica fosse uno dei suoi contributi più grandi alla scienza! Pertanto Lemaître decise di inviare un testo su questa costante, per continuare le discussioni di Pasadena. Oggi, è interessante notare che Lemaître ebbe in effetti un’intuizione molto profonda e corretta. Infatti i dati astronomici recenti mostrano che la costante cosmologica non può essere eliminata poiché è legata all’accelerazione dell’universo osservata e alla famosa “energia oscura”. Per capire chiaramente il significato di questa costante, serve probabilmente qualche teoria di campo quantistico e Lemaître pensava la stessa cosa. Lemaître non riuscì mai a convincere Einstein della sua interpretazione della costante cosmologica. E il canonico ammise perfino di non aver mai capito gli argomenti usati dal padre della teoria della relatività per liberarsi della celebre costante. Fino alla fine della sua vita, Einstein pensò che fosse “abominevole” (come scrisse nella sua risposta alla lettera del 1947 sopra citata) supporre che la gravitazione sia fatta di due termini logicamente indipendenti: uno che è attrattivo (come nel caso classico) e un altro che è repulsivo ed è descritto dalla costante cosmologica. Possiamo enfatizzare qui una differenza tra i due fisici. In fisica teorica, Lemaître non era guidato prima da considerazioni estetiche o logiche. Spesso rifiutò di inoltrarsi troppo in speculazioni matematiche e cercò di restare vicino alle osservazioni, accettando un formalismo incompleto o approssimativo. La posizione di Einstein sulla costante cosmologica è molto importante. Nel 1945, dopo aver assistito a una conferenza di Lemaître a Friburgo (Svizzera), Michele Besso, intimo amico di Einstein, discusse con lui del rifiuto del canonico di porre la costante uguale a zero. [...]" (cfr. DISF.org, ripresa parziale).
Nel 1949 P.A. Schilpp propose al canonico Lemaître si scrivere un capitolo nel libro Albert Einstein Philosopher and Scientist (Albert Einstein filosofo e scienziato) pubblicato per celebrare il 70o compleanno di Einstein. A Pasadena e a Princeton una gran parte delle discussioni tra Einstein e Lemaître erano state dedicate al problema della costante cosmologica. Einstein la voleva eliminare e Lemaître la considerava un elemento molto importante, sebbene forse non ancora ben formulato, del formalismo della cosmologia relativistica. In una lettera del 30 luglio 1947 indirizzata a Einstein, il canonico gli scrisse che riteneva che l’introduzione della costante cosmologica fosse uno dei suoi contributi più grandi alla scienza! Pertanto Lemaître decise di inviare un testo su questa costante, per continuare le discussioni di Pasadena. Oggi, è interessante notare che Lemaître ebbe in effetti un’intuizione molto profonda e corretta. Infatti i dati astronomici recenti mostrano che la costante cosmologica non può essere eliminata poiché è legata all’accelerazione dell’universo osservata e alla famosa “energia oscura”. Per capire chiaramente il significato di questa costante, serve probabilmente qualche teoria di campo quantistico e Lemaître pensava la stessa cosa. Lemaître non riuscì mai a convincere Einstein della sua interpretazione della costante cosmologica. E il canonico ammise perfino di non aver mai capito gli argomenti usati dal padre della teoria della relatività per liberarsi della celebre costante. Fino alla fine della sua vita, Einstein pensò che fosse “abominevole” (come scrisse nella sua risposta alla lettera del 1947 sopra citata) supporre che la gravitazione sia fatta di due termini logicamente indipendenti: uno che è attrattivo (come nel caso classico) e un altro che è repulsivo ed è descritto dalla costante cosmologica. Possiamo enfatizzare qui una differenza tra i due fisici. In fisica teorica, Lemaître non era guidato prima da considerazioni estetiche o logiche. Spesso rifiutò di inoltrarsi troppo in speculazioni matematiche e cercò di restare vicino alle osservazioni, accettando un formalismo incompleto o approssimativo. La posizione di Einstein sulla costante cosmologica è molto importante. Nel 1945, dopo aver assistito a una conferenza di Lemaître a Friburgo (Svizzera), Michele Besso, intimo amico di Einstein, discusse con lui del rifiuto del canonico di porre la costante uguale a zero. [...]" (cfr. DISF.org, ripresa parziale). -
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- IN MEMORIA E IN OMAGGIO DI JEAN PIAGET, UNA NOTA A MARGINE DI UNA FOTO NEL SUO STUDIO IN MEZZO AI LIBRI DEL 1979.24 aprile 2024, di Federico La Sala
UNA NOTA A MARGINE DI UNA FOTO Di JEAN PIAGET NEL SUO STUDIO (1979) RIPRESA NEL PROFILO "IL MESSIA DEI LIBRI" (FACEBOOK, 20 APRILE 2024) *:
#EPISTEMOLOGIA, #GENESI, #BIGBANG, #ANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA. Enza Sim ... geniale commento! Condivido: "Penso che [Piaget] col dito indichi il #thermos" (e che, come #Newton, con la famosa "mela", abbia avuto una ’illuminazione’) In principio era il #calore "thermico" del "big bang": alla #luce della #fotografia (1979), si può ben #osare #pensare (#Kant204) che la #ricerca di Piaget fosse ben intesa a rendere pensabile una "epistemologia #genetica" che chiarisse il tema stesso del biblico "Genesi", che fosse antropologicamente e filosoficamente una "epistemologia geneSica" e, finalmente, rendesse possibile l’#analisi della #bellezza di tutte le cose, prodotte dall’#amore cosmogonico che "move il #Sole e le altre stelle" (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 145).
*
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- EARTHRISE 2024: LETTERATURA, COSMOGONIA E "GIORNATA DELLA TERRA" CON SHAKESPEARE E DANTE.22 aprile 2024, di Federico La Sala
TEATRO (STORIA), #METATEATRO (#METASTORIA), #LETTERATURA, #COSMOGONIA E #SORGERE DELLA TERRA (#EARTHRISE).
- Per la #giornatadellaterra 2024, un omaggio alla memoria letteraria europea e un invito a ri-leggere insieme "#Amleto" (#Hamlet) e "Il #Mulino di Amleto".
USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #CADUTA (E DALL’#INFERNO):
SHAKESPEARE in "gara" con #Omero #Ovidio #Virgilio e #Dante: alla ricerca delle #radici" della "#follia amorosa", dell’#amore #cosmogonico "che muove il #Sole e le altre #stelle".
NOTE:
- Giorgio de Santillana, Hertha von Dechend, "Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, Adelphi, Milano.
- STORIA E LETTERATURA E ANTROPOLOGIA. Harold Bloom, "Shakespeare. L’invenzione dell’uomo", Rizzoli, Milano.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- : LA COMUNICAZIONE DELLA NATURA. IL "MESSAGGIO DELLA "MARGHERITA", E IL PROBLEMA DELLA COSCIENZA.1 aprile 2024, di Federico La Sala
COSMOGONIA COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA (#KANT2024):
LA COMUNICAZIONE DELLA NATURA. Il "messaggio" della "margherita" va ben oltre le #frontiere e le #barriere del #paradigma tragico della #piramide dell’#androcentrismo del "#sapiente" (1510) di #Bovillus (cfr. Stefano Mancuso e Alessandra Viola, "Verde Brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale", GIUNTI EDITORE S.P.A., Firenze, 2015, p. 19).
Il dibattito sulla coscienza: nuova vita per la teoria del panpsichismo
La teoria del panpsichismo, che attribuisce coscienza a ogni cosa, riprende vigore nel dibattito scientifico sulla natura della coscienza, tra sostenitori e scettici.
di Gianluca Riccio ("Futuro Prossimo", 26 Marzo 2024)
Da dove viene la coscienza? È una proprietà emergente del cervello o qualcosa di più fondamentale, intrinseco alla materia stessa? È reale o solo un’illusione creata dai nostri neuroni? Sono domande che assillano filosofi e scienziati da secoli, ma che oggi, grazie ai progressi delle neuroscienze e della fisica quantistica, stanno trovando nuove e sorprendenti risposte. Una di queste è il panpsichismo, la teoria secondo cui la coscienza è ovunque, dalla più semplice particella alle stelle del firmamento. È una provocazione di oggi o una rivoluzione scientifica di domani?
La sedia pensante
Immaginate di sedervi sulla vostra poltrona preferita e di sentirle sussurrare: “fai piano... mi stai schiacciando”. Non vorrei banalizzare, ma secondo il panpsichismo funziona proprio così: ogni oggetto, dai più complessi ai più banali, potrebbe avere un barlume di coscienza. L’idea può far sorridere (o rabbrividire), ma ha radici antiche. Già nel ‘500 il filosofo italiano Francesco Patrizi sosteneva che tutto l’universo fosse pervaso da un’anima cosmica. Una visione romantica, soppiantata nel ‘900 dal trionfo del riduzionismo scientifico. Oggi, di fronte all’enigma ancora irrisolto della coscienza, il panpsichismo sta tornando in auge.
Un neurone non fa Primavera
Il punto di partenza è questo: nonostante i progressi delle neuroscienze, non siamo ancora riusciti a spiegare come un chilo e mezzo di tessuto cerebrale possa generare l’esperienza soggettiva, il “sentire” di essere coscienti. È il famoso “hard problem” della coscienza, che ha fatto consumare montagne di carta e fiumi d’inchiostro ai filosofi della mente. Ma se la coscienza non emerge dal cervello, da dove viene? Il panpsichismo ribalta la prospettiva: e se fosse una proprietà fondamentale della materia, come la massa o la carica elettrica? Se ogni particella avesse un briciolo di “psichismo”, allora la coscienza non sarebbe un miracolo biologico, ma una caratteristica diffusa dell’universo.
Panpsichismo, una questione Italia-USA
A dare credito a questa idea sono soprattutto due neuroscienziati: l’italiano Giulio Tononi e l’americano Christof Koch. Secondo loro, la coscienza emerge ogni volta che c’è un sistema fisico integrato e differenziato, cioè con molte parti interconnesse ma distinte. Come un cervello, certo. Ma anche come un cristallo o un vortice d’acqua. Più un sistema è complesso e organizzato, dicono Tononi e Koch, più è cosciente. Ecco perché un ammasso di neuroni è più “sveglio” di un sasso, ma meno di un gatto o di un essere umano. È la teoria dell’informazione integrata, che misura la coscienza in bit, come fosse un software universale.
Ma c’è chi si spinge oltre. Per alcuni panpsichisti (e per dei ricercatori Microsoft), anche le stelle e le galassie potrebbero essere coscienti, come giganteschi cervelli cosmici. Una suggestione affascinante, che ci riporta alle visioni mistiche dei nostri antenati, quando il cosmo era visto come un organismo vivente e senziente.
panpsichismo
Siamo nel campo della speculazione più audace. Non abbiamo ancora prove empiriche che la coscienza sia una proprietà della materia, né tanto meno che permei l’universo. Se volete il mio parere “poetico”, il panpsichismo ha al momento un unico merito. Quello di farci guardare con altri occhi al mondo che ci circonda, di restituire anima e dignità anche agli oggetti più umili e insignificanti.
La nemesi del Panpsichismo: coscienza o illusione?
Non tutti, ovviamente, seguono la china del Panpsichismo. Per molti scienziati e filosofi, si tratta solo di un disperato tentativo di aggirare il problema della coscienza, una scappatoia metafisica che non spiega nulla. Alcuni, come il filosofo britannico Keith Frankish, arrivano a negare l’esistenza stessa della coscienza, bollandola come un’illusione creata dal cervello. L’eccesso opposto, se vogliamo: secondo questa visione “eliminativista”, ciò che chiamiamo coscienza non è che un trucco della mente, un’allucinazione virtuosa che ci fa credere di essere qualcosa di più di automi biologici. Una prospettiva inquietante, che ci priva del nostro tesoro più prezioso: il senso di essere un io, un soggetto, una scintilla di consapevolezza nell’universo.
L’hard problem rimane hard
Alla fine, l’unica certezza è che la coscienza resta il grande mistero irrisolto della scienza. Nonostante i progressi delle neuroscienze e della filosofia della mente, non abbiamo ancora una spiegazione convincente di come un ammasso di cellule possa generare l’esperienza soggettiva, il “cosa si prova” ad essere coscienti.
Il panpsichismo è un tentativo audace di rispondere a questa sfida, ma solleva più domande di quante ne risolva. Se tutto è cosciente, perché non sentiamo le grida di dolore delle sedie su cui ci sediamo? E come fa la coscienza delle singole particelle a fondersi in quella, unitaria e coerente, di un essere vivente? Sono interrogativi che ci riportano al punto di partenza: l’hard problem della coscienza. Un rompicapo che ha fatto sudare i più grandi pensatori di ogni epoca, da Cartesio a Chalmers, e che ancora oggi ci lascia interdetti e affascinati.
Ma forse è proprio questo il bello della coscienza: il fatto che sfugga a ogni spiegazione riduttiva, che resista a ogni tentativo di oggettivarla e dissezionarla. La coscienza è il mistero che ci abita, che ci rende umani e partecipi del cosmo. È la scintilla divina che ci fa dire “io”, che ci fa sentire vivi e reali in un universo altrimenti freddo e indifferente.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- "LO ZODIACO DELLA VITA": LL’ARTISTICO SPAZIOTEMPO (PENROSE) DEL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO E IL "PRESEPE" NEL GRAN NAVILIO DI GALILEO GALILEI.18 marzo 2024, di Federico La Sala
"LO #ZODIACO DELLA #VITA" E LA #FILOLOGIA DEL #RINASCIMENTO: NELL’ARTISTICO #SPAZIOTEMPO DI #MICHELANGELOBUONARROTI, UNA "RILETTURA" DELLE FIGURE DI "MARIA" E "GIUSEPPE" E DELLA LORO #RELAZIONE CON LE "#SIBILLE" E I "#PROFETI" DELLA "#SACRAFAMIGLIA".
- ARTE, ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA E TEOLOGIA. Una nota a margine di una "scheda" della Galleria degli Uffizi *
DAL #LAOCOONTE (ROMA, 1506) AL #TONDODONI (FIRENZE, 1506-1508). NELLA "STORICA" LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E NELLA "NARRAZIONE" DELLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA), CON DUE PROFETI E #DUE SIBILLE, #MICHELANGELO "INDICA" LA PARADIGMATICA #NASCITA "ETERNA" DEL #FIGLIO DI "MARIA E GIUSEPPE" NEL TEMPO.
*
- "SAPERE AUDE!" (#KANT2024): DOMANDA. Come mai gli esperti della Galleria degli Uffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!. Non è meglio con #Dante, e, con "#Virgilio" e "#Beatrice", proseguire il cammino oltre "#Ulisse", e oltre "Paolo" ed "Enea", e, con le sibille e i profeti, uscire dal tragico LETARGO (Par. XXXIII, 94)?!
- #19MARZO #21MARZO #25MARZO #25DICEMBRE ...
NOTE:
- STORIAELETTERATURA #ARCHEOLOGIA E #ARTE: IL LAOCOONTE.
- ANTROPOLOGIA "BIBLICA", #STORIAELETTERATURA, E #FILOLOGIA "EV-ANGELICA". Per#Dante, il #profeta #ReDavide ("colui che l’arca traslatò di villa in villa", Pd XX 39) e la #SibillaCumana dicono della #Virgo "desponsata viro cui nomen erat #Ioseph, #dedomoDavid et nomen virginis #Maria"(Lc. 1, 27), non altro!
- FISICA E "METAFISICA CONCRETA" (#KANT2024): LA #LEZIONE DI #GALILEO #GALILEI E LA #QUESTIONE DELLO #SPAZIOTEMPO. Sul tema, si cfr. il brillante contributo di Roger Penrose, "LA #STRADA CHE PORTA ALLA #REALTÀ" ("THE #ROAD TO #REALITY. A Complete Guide to the Laws of the Universe", 2005).
- Metaphysics #Mathematics. Galileo (Keplero: "Vicisti, Galilaee") e il "#presepe" del #gran_navilio del "#Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" (1632): "Da quando un #Bambino nacque in una #mangiatoia, è #dubbio che un #Evento di così grande importanza abbia prodotto così poco scompiglio" (A.N. Whitehead).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- UNA "IGNOTA" SVOLTA ANTROPOLOGICA IN CORSO: IL PROGRAMMA DI DANTE E L’INDICAZIONE DI MICHELANGELO.17 marzo 2024, di Federico La Sala
USCIRE DALL’#INFERNO DELLA #RIPETIZIONE E DAL #LETARGO DI MILLENNI (Par. XXX, III, 94).
 Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...
Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...IL PROGRAMMA DI #DANTE ALIGHIERI ALL’ORDINE DEL GIORNO (#25MARZO 2024: #Dantedì).
Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore (#Eros), avido e cupìdo, #figlio nato dalla astuta alleanza (#Metis) dell’#uomo-#Ingegno (gr. #Poros) e della #donna-#Povertà (gr. #Penia). La lezione di Platone appare essere la chiara codificazione di una fenomenologia dello spirito della #tragedia e la sua parola una versione della #Legge del #Figlio di Dio (#Zeus) , #Apollo: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (#Eschilo, #Eumenidi, 657 ss.): : un ’#cattolicesimo’ platonico.
STORIAELETTERATURA, #FILOLOGIA E #CRITICA: #DIVINACOMMEDIA. Gianfranco #Contini: «[...] L’impressione genuina del postero, incontrandosi in Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui» (cfr. "Un’interpretazione di Dante", in Id., G. Contini, "Un’idea di Dante. Saggi danteschi", Torino, Einaudi, 2001, I ed. 1970, pp. 110-11).
ARTE, #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA:
MICHELANGELO BUONARROTI, I PROFETI E LE SIBILLE.
LA "STORICA" #LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E DELLA #NARRAZIONE DELLA #VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA: DUE PROFETI E #DUE SIBILLE "INDICANO" LO #SPAZIOTEMPO DELLA #NASCITA DEL #FIGLIO DI #MARIAEGIUSEPPE. Come mai gli esperti della #GalleriadegliUffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!
-
>"Note per una epistemologia genesica" - Con Einstein e Dante, Carlo Rovelli, al di là dei "buchi neri": "Buchi bianchi, là dove il tempo cambia di segno" (di Patrizia Caraveo).16 febbraio 2024, di Federico La Sala
SE L’UNIVERSO VA INCONTRO ALL’IMBUTO COSMICO
Buchi bianchi, là dove il tempo cambia di segno
- Mentre da un buco nero nulla può uscire, in un buco bianco nulla può entrare: c’è solo l’uscita ed è a senso unico. A queste ipotetiche entità è dedicato “Buchi bianchi. Dentro l’orizzonte ” di Carlo Rovelli, recensito dall’astrofisica Patrizia Caraveo domenica scorsa sul Sole24Ore in questo articolo che vi riproponiamo con il consenso dell’autrice
di Patrizia Caraveo (MEDIA-INAF, 01/06/2023)
- Carlo Rovelli, “Buchi Bianchi. Dentro l’orizzonte->https://www.adelphi.it/libro/9788845937538 ”, Adelphi, 2023, 144 pagine, 14 euro
I buchi neri sono con noi da sempre, praticamente dall’inizio dell’evoluzione dell’universo, eppure abbiamo avuto prove certe della loro presenza solo mezzo secolo fa. In effetti, la loro possibile esistenza era stata sospettata da Karl Schwarzschild quando, nel dicembre 1915, in trincea, lesse il lavoro di Einstein e risolse le equazioni della relatività generale. Dal suo lavoro discende il concetto del raggio di Schwarzschild, altrimenti noto come orizzonte degli eventi. Si tratta della superficie immaginaria che divide lo spazio intorno al buco nero tra il “fuori” ed il “dentro” dal quale nulla, nemmeno la luce, sfugge alla gravità. Einstein ne fu ammirato, ma il concetto di singolarità dovette aspettare mezzo secolo per acquisire credibilità, almeno dal punto di vista matematico, grazie al lavoro di Roger Penrose, negli anni ’60. All’epoca, le singolarità si chiamavano stelle oscure oppure stelle congelate, il termine buchi neri è nato nel 1967 ad opera di John Archibald Wheeler.
Allora erano solo entità matematiche, ma la neonata astronomia X si apprestava a dare loro consistenza osservativa. Avvenne per caso, nel 1964, con il primo volo suborbitale di un contatore X che avrebbe dovuto misurare l’emissione X della Luna. Inaspettatamente, si scoprì un’intensissima sorgente la cui posizione corrispondeva a quella di una stella brillante, ma troppo normale per poter essere responsabile dell’emissione. Osservazioni accurate, però, rivelarono che la stella si muoveva ritmicamente, danzando intorno ad una compagna invisibile. Usando le leggi di Keplero, le stesse che governano il moto dei pianeti nel Sistema solare, si misurò la massa della compagna invisibile che risultò essere 15 volte quella del Sole. Avrebbe dovuto essere una stella molto brillante, invece non emetteva niente. Senza cercarlo, si era scoperto il primo buco nero stellare in un sistema binario. Da allora se ne sono scoperti decine che brillano nei raggi X ma più di recente ne abbiamo visti centinaia attraverso le onde gravitazionali prodotte nel corso di catastrofiche collisioni. Sempre nel genere interazioni catastrofiche, abbiamo più volte assistito alla disintegrazione di stelle che si erano avvicinate troppo alla pericolosa singolarità. La fine della stella produce incredibili fuochi d’artificio.
Ma il buco nero più mediatico è certamente un mostro di 6 miliardi di masse solari che domina la galassia M87. Qualche anno fa, l’immagine dell’ombra del buco nero nel mezzo di una ciambella brillante è andata sulle prime pagine di tutti i giornali. Ora, nuovi dati hanno evidenziato come dalla ciambella abbia origine il getto di particelle di alta energia che è una delle caratteristiche più spettacolari della galassia.
Mentre gli astrofisici, che raccolgono dati sui buchi neri, si devono fermare al muro invalicabile dell’orizzonte degli eventi, i fisici teorici si possono permettere di andare al di là per scoprire cosa c’è (o ci potrebbe essere) dentro un buco nero. È questo il compito che si è prefissato Carlo Rovelli , che nel suo Buchi bianchi. Dentro l’orizzonte propone esperimenti mentali (non potrebbe essere diversamente) per farci entrare nell’orizzonte degli eventi. Schwarzschild ci insegna che si tratta di una linea invalicabile attraverso la quale non c’è scambio di informazioni, ma Rovelli propone un viaggio concettuale ispirandosi ad altri viaggiatori che hanno sfidato l’impossibile, a cominciare da Dante, che viene citato spesso. È un viaggio attraverso un territorio inesplorato, che inizia da una conversazione con un giovane collega. Così nasce un’idea, una scintilla che accende l’entusiasmo del fisico teorico impegnato da anni a cercare di unire relatività generale e fisica quantistica. Visto che si ispira a Dante, anche per Rovelli è essenziale avere una guida: il suo Virgilio saranno le equazioni di Einstein, sulle quali lavora da sempre. Per aiutare a visualizzare concetti non banali, che espone in tono colloquiale con un linguaggio semplice, Rovelli utilizza un imbuto lunghissimo e sempre più stretto. È questa per lui la migliore descrizione dell’interno del buco nero e compare decine di volte nel libro perché è percorrendo l’imbuto che il viaggiatore si avvicina, o pensa di avvicinarsi, alla singolarità, per scoprire che quello che cerca accade dopo e, per andare oltre, il tempo deve essere ribaltato. Non è un processo banale, richiede una capriola gravitazional-quantistica, ma è l’essenza alla base del buco bianco. Le equazioni di Einstein sono sempre le stesse, ma la variabile tempo cambia di segno. Questo significa che, mentre dal buco nero nulla può uscire, nel buco bianco nulla può entrare perché c’è solo l’uscita ed è a senso unico. Il problema è che tutte le scivolate nell’imbuto e le capriole nella gravità quantistica avvengono all’interno dell’orizzonte degli eventi e noi, che per nostra fortuna siamo fuori, non ce ne possiamo rendere conto. In verità, questo semplifica la gestione dello scorrere del tempo che sarebbe molto diverso tra dentro e fuori.
Con grande lucidità, Rovelli fa notare che tutto questo potrebbe essere sbagliato, anche perché non ha neanche lontanamente idea di come potrebbe essere possibile andare a cercare la prova dell’esistenza dei buchi bianchi. Tuttavia, non dobbiamo perdere le speranze. I buchi neri ci hanno messo mezzo secolo per passare dall’essere una realtà matematica a diventare oggetti celesti studiati e osservati. L’universo non ha fretta, ha tutto il tempo che vuole.
-
> Con Einstein e Dante, Carlo Rovelli, al di là dei "buchi neri" --- Carlo Rovelli, "Buchi Bianchi. Dentro l’Orizzonte" (di Emilia Margoni)21 febbraio 2024, di Federico La Sala
Carlo Rovelli, Buchi Bianchi. Dentro l’Orizzonte
di Emilia Margoni (Doppiozero, 6 Marzo 2023)
Nessun oggetto ci appare tanto affascinante quanto quello di cui non si può predicare con certezza l’esistenza. Oggetti puramente ipotetici, la cui presenza al mondo è il presupposto di un quadro che, altrimenti, non tornerebbe. Come fosse una fucina inesauribile di oggetti di tale natura, la fisica non ne lamenta mai la carestia; e chi la pratica, specie in quella zona di confine che è la fisica teorica, partecipa a una sorta di gara senza sosta per rinvenire l’oggetto al contempo più inconcepibile e meno dispensabile. La storia della disciplina è costellata di agnizioni tarde: entità che erano poco più che corollari di grandi teorie, o che persino venivano ipotizzate dai detrattori di queste al solo fine di produrne una smentita, hanno trovato il supporto di una comprova sperimentale solo a decenni di distanza dalla loro genesi speculativa. Il repertorio è ricchissimo, e basterà menzionare fenomeni fisici probabilmente ben noti a chi legge, come l’entanglement quantistico, il bosone di Higgs o le onde gravitazionali. Una di queste entità, che vanta ad oggi un carattere puramente congetturale, eppure si cinge della robusta corazza di esito rigoroso della teoria della relatività generale, è il buco bianco. Nel suo recentissimo libro, Buchi Bianchi. Dentro l’Orizzonte (Adelphi 2023), Carlo Rovelli ne propone un’intrigante apologia.
Come per altre sue opere, Buchi bianchi gode di una struttura tripartita. La sezione iniziale fissa, con un rapido excursus storico, i preamboli della trattazione successiva, ovvero si concentra su quella serie di sviluppi della relatività generale che hanno condotto all’avventizia ipotesi, prima, e all’insperata e infine acclamata osservazione sperimentale, poi, dei cosiddetti buchi neri. In effetti, come ricorda l’autore, l’esistenza di questi oggetti, che pure erano previsti dalla teoria, non era affatto scontata, se è vero che, ancora nel 2000 - allorché egli si trasferì in Francia a seguito delle sue molteplici peregrinazioni d’oltreoceano - il Direttore di Dipartimento dell’Università di Marsiglia ironizzava con un certo grado di scetticismo su una loro possibile rivelazione (p. 27).
Nella seconda sezione si ripercorre l’insieme di considerazioni, tentativi e speculazioni che, dalla collaborazione di Rovelli con il fisico statunitense Hal Haggard, li condusse a tentare di estendere il campo dei possibili, ipotizzando cioè l’esistenza di oggetti fisici con proprietà speculari rispetto ai buchi neri, appunto i buchi bianchi. Ad oggi si tratta di un’affascinante ma pur sempre congetturale proposta, dai tratti fortemente immaginifici, anche perché sotto il profilo osservativo, come vedremo, buchi neri e buchi bianchi sono tra loro indistinguibili.
La terza sezione - tra tutte la più originale, quale marchio di fabbrica rovelliano - affronta alcuni dei temi che hanno reso noto il fisico veronese al grande pubblico (il tempo, l’entropia, il rapporto tra queste nozioni e il concetto di irreversibilità, l’informazione), secondo la declinazione identificata come “relazionale”. Quest’ultima frazione del testo articola il tentativo di avallare, quantomeno sotto il profilo concettuale, la plausibilità di un’ipotesi tanto ardita qual è quella di avanzare l’esistenza di oggetti analoghi ai buchi neri, ma, in sintesi, caratterizzati da un’inversione della variabile temporale. Ed è qui che la prospettiva relazionale si fa dirimente: relativizzare in senso prospettico il tempo, e in particolare la distinzione che nell’accezione comune esso implica tra un passato definito e inoperabile e un futuro aperto e disponibile, è secondo Rovelli la lezione più propria della relatività generale. In tale declinazione, “la differenza tra passato e futuro [...] è un po’ come la differenza fra due direzioni geografiche” (p. 107): non si declina in forma assoluta, ma appunto locativa. Se le equazioni della relatività generale sono simmetriche rispetto alla variabile temporale, e se i buchi neri sono una delle possibili soluzioni di queste equazioni, esse devono contemplare l’esistenza di soluzioni con variabile temporale invertita, che corrispondono appunto ai buchi bianchi. Il punto controverso diventa così la spiegazione del rapporto tra questi due sistemi gemelli, evidentemente connessi, e in particolare il tipo di transizione necessaria per garantire un passaggio dall’uno all’altro - transizione che, aggiunge Rovelli, non sarebbe possibile se non si tenesse conto della teoria che ad oggi meglio sintetizza le interazioni su scala microscopica, la meccanica quantistica.
Prima di provare ad abbozzare una seppur intuitiva descrizione di oggetti tanto esotici quali i buchi bianchi, sarà bene richiamare le proprietà dei loro corrispettivi più prossimi, certo non meno eccentrici eppure più familiari, non foss’altro perché empiricamente osservati e somministrati, a più riprese e su varie piattaforme, al grande pubblico. Appena pochi mesi dopo la pubblicazione, nel 1915, delle equazioni della relatività generale ad opera di Albert Einstein, il matematico e fisico tedesco Karl Schwarzschild avanzò una soluzione volta a descrivere quello che accade allo spazio e al tempo in prossimità di una massa.
Tale soluzione prevedeva che spazio e tempo tendono a incurvarsi in maniera tanto più significativa quanto più essa è rilevante: un sistema flette lo spaziotempo limitrofo in senso proporzionale alla propria massa, e questo fenomeno è responsabile, tra le altre cose, dell’attrazione gravitazionale che tale sistema esercita su altri sistemi a esso adiacenti. Lo spaziotempo di Schwarzschild prevedeva altresì uno scenario molto singolare: se il rapporto tra la massa di un sistema e il volume da esso occupato supera una soglia critica, ovvero se l’oggetto massivo viene particolarmente compresso, la soluzione delle equazioni di Einstein prevede che attorno a esso si formi una sorta di guscio, detto orizzonte degli eventi, che seziona lo spaziotempo in due regioni, tra di loro non connesse in senso causale.
Sotto queste condizioni, la deformazione del tempo è tale da far sì che un orologio posto nelle vicinanze dell’orizzonte degli eventi rallenti sino a fermarsi, là dove lo spazio si incurva a formare una struttura a imbuto estremamente ripida. Tale risultato era a tal punto eccentrico da non incontrare il favore neppure dello stesso Einstein, cui da ultimo si doveva la loro, seppur embrionale, gestazione. Oggi si ha più di qualche motivo per credere che tali oggetti esistano, ed è ciò che identifichiamo come buchi neri, termine coniato dal fisico statunitense John Wheeler nel 1967.
Sebbene la formazione di un buco nero sia resa possibile dal superamento della soglia critica definita da Schwarzschild - quindi, in linea di principio, anche nel caso di un oggetto non particolarmente massivo, purché estremamente compresso - la più parte dei buchi neri sinora rintracciati segue le fasi terminali di stelle “esauste”, stelle che hanno cioè smesso di bruciare. Normalmente, l’enorme peso della stella, che la porterebbe a collassare su sé stessa, viene controbilanciato dal calore prodotto per convertire l’idrogeno, di cui la stella è composta, in elio. Quando l’idrogeno a disposizione si esaurisce, la temperatura inizia progressivamente a diminuire e così il peso a gravare sull’economia della stella. Sotto particolari condizioni, l’evoluzione della stella suddetta segue un collasso, così portando alla formazione di un buco nero.
Per intendere l’ipotetico passaggio da buco nero a buco bianco, è importante precisare la geometria spaziale del primo. Come si diceva, un buco nero può essere inteso come una struttura a imbuto, che via via si allunga, divenendo più stretta e ripida, al cui termine si trova la stella che collassando vi ha dato origine. Nei punti più estremi di tale struttura, là dove la deformazione spaziotemporale risulta particolarmente imponente, ci aspettiamo che le equazioni di Einstein non siano più sufficienti a rendere conto del fenomeno fisico in corso, e devono evidentemente intervenire effetti quantistici. Senza poter qui entrare nei dettagli di un resoconto intricato ma reso sempre accessibile dalla scrittura di Rovelli, regolare e quasi spontanea, è in prossimità di tali condizioni estreme - allorché la teoria della relatività generale perde di pregnanza - che si dà la possibilità di una transizione da buco nero a buco bianco; come se, raggiunta la soglia del regime quantistico, la struttura smettesse di allungarsi e restringersi, e viceversa invertisse, in un ipotetico rimbalzo, la propria evoluzione, così prendendo ad accorciarsi e allargarsi, ripercorrendo tutte le tappe al contrario: questa, in una sintesi che certo non rende giustizia al fenomeno, la genesi e l’evoluzione di un buco bianco.
Ora, pur non volendo considerare il notevole grado di speculazione di una simile congettura, la questione ha da porsi in termini più prosaici. Se è vero che un buco bianco è perfettamente descritto dalle equazioni di Einstein, poiché corrisponde alla stessa soluzione di un buco nero a patto di ribaltare la variabile temporale (“un buco bianco è il modo in cui apparirebbe un buco nero se potessimo filmarlo e proiettare il film al contrario”, p. 65), il problema, invalidante sotto il profilo di una sua eventuale osservazione sperimentale, è che l’esterno di un buco bianco non differisce in alcun modo dall’esterno di un buco nero. Detto altrimenti, osservati da fuori, un buco nero e un buco bianco “si comportano esattamente nello stesso modo: sono entrambi masse che attirano con la forza di gravità” (p. 80). Una delle questioni che andranno chiarite negli sviluppi futuri di tale proposta riguarderà proprio la definizione di una qualche strategia per superare una simile impasse.
Ma si sa, la fisica teorica non intrattiene con la sperimentazione un rapporto subalterno di ipotesi vs. verificazione. Si tratta innanzitutto di uno spazio immaginativo, in cui il linguaggio della disciplina estende le proprie frontiere al di là di ciò che al momento le sue inevitabili sclerosi non rendono dicibile. In questo mestiere, che nell’arte della retorica si direbbe in primo luogo di inventio, ovvero l’imbastitura degli argomenti e la loro organizzazione per l’esposizione di un pensiero formando, Carlo Rovelli è senza dubbio tra i fuoriclasse - tra coloro cioè che non si accontentano di esercitare la propria effervescenza in un solo campo, e il cui esercizio di pensiero è una corrente carsica capace di infiltrarsi, diffondersi ed espandersi senza strepito né clamore. Come nel caso della sua creazione più nota, la gravità quantistica a loop, poco importa che al momento non siano a disposizione strumenti di validazione empirica. Tutto quel che rileva è lo spazio creativo che ha aperto per tratteggiare linee di fuga verso un punto che al momento non è dato a vedersi eppure senza il quale la fisica sarebbe presto da archiviarsi nel faldone della storia della cultura.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- FILOSOFIA E COSMOLOGIA: RIPRENDERE IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" CON GALILEO GALILEI (1632): "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS".18 luglio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, ANDROCENTRISMO, COSMOLOGIA, FILOSOFIA E FILOLOGIA:
RIPRENDERE IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO, TOLEMAICO E COPERNICANO" CON GALILEO GALILEI 1(632), OGGI. "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS"...
- «Finché questo nesso segreto che unisce metafisica e scienza non sarà chiarito, la relazione fra la filosofia e le scienze continuerà a essere problematica. E di questa aporetica situazione la filosofia non potrà venire a capo che a condizione di rinunciare al suo primato per farsi ultima» (Giorgio Agamben, "Filosofia prima filosofia ultima. Il sapere dell’Occidente fra metafisica e scienze", Einaudi, Torino 2023, p. 101).
L’Universo ha un "centro" e una "periferia" o non ha né centro né periferia?!! La questione è mal posta (e trascina nella dinamica della "dialettica trascendentale" e nella logica antinomica del Mentitore: se non si sa col-legare "la filosofia seconda" (fisica matematica) con la "filosofia prima" (antropologia e teologia ), non si riesce a capire nulla né di Dio ("Ecce Homo": "Homo Homini Deus est"), né del Cosmo, né dell’Uomo ("Anthropos", dell’uomo e della donna) e si resta nella "cosmoteandria" tragica della tradizione platonica e della "caduta" biblica e cattolico-paolina. Galileo Galilei ha vinto: meglio risalire a bordo della sua "nave" e riprendere la navigazione nell’oceano celeste (Keplero, 1611).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- "ALLA LUNA NUOVA": "LA TERRA IMPAREGGIABILE" (SALVATORE QUASIMODO)21 giugno 2023, di Federico La Sala
MATURITA’ 2023.
- POESIA, COSMOLOGIA, E ANTROPOLOGIA (NON COSMOTEANDRIA):
CON SALVATORE QUASIMODO, GUARDARE "LA TERRA IMPAREGGIABILE" (1955-1958), DALLA LUNA, DALLA "NUOVA LUNA":
"Alla nuova luna
In principio Dio creò il cielo
 e la terra, poi nel suo giorno
e la terra, poi nel suo giorno
 esatto mise i luminari in cielo
esatto mise i luminari in cielo
 e al settimo giorno si riposò
e al settimo giorno si riposò
 Dopo miliardi di anni l’uomo,
Dopo miliardi di anni l’uomo,
 fatto a sua immagine e somiglianza,
fatto a sua immagine e somiglianza,
 senza mai riposare, con la sua
senza mai riposare, con la sua
 intelligenza laica,
intelligenza laica,
 senza timore, nel cielo sereno
senza timore, nel cielo sereno
 d’una notte d’ottobre,
d’una notte d’ottobre,
 mise altri luminari uguali
mise altri luminari uguali
 a quelli che giravano
a quelli che giravano
 dalla creazione dle mondo. Amen."
dalla creazione dle mondo. Amen." -
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE --- INTUIZIONE E DISCORSO. Essere uno a se stessi: la poesia secondo Franco Loi (di "Storie Sepolte").8 ottobre 2022, di Federico La Sala
Essere uno a se stessi: la poesia secondo Franco Loi
di REDAZIONE "Storie Sepolte"*
- Poetry is the new tweet - III
- Ecco l’ultima puntata della conversazione sulla poesia con Franco Loi. Potete trovare qui e qui le puntate precedenti.
- In quest’ultima parte Loi si spinge ancora più nel profondo: la ricerca verso ciò che non sappiamo, la necessità dell’intuizione come atto primo di conoscenza.
- Ringraziamo sempre Franco Loi, Rudy Toffanetti, Marco Pernich, Luca Sala per le fotografie della serata e Francesca Marini, per la fotografia in apertura di questo articolo.
Franco Loi:
Non crediate che sapendo le regolette si scriva la poesia. C’era un falegname, era lì che segava, con una mano, e intanto parlava con noi. Quando abbiamo smesso di parlare, gli chiedo se posso provare io. Ho preso la sega, non riuscivo neanche a metterla nel legno. Perché? Perché, lui mi diceva, un legno non è sempre lo stesso. In quel caso lì, dovevo mettere la sega non dritta, ma così, quasi piatta. E mi ha detto: «Il mestiere ti fa imparare l’arte». Verissimo. E così è la poesia. Vanno bene le regole, e va bene impararle. Però bisogna anche avere l’esperienza. Amare. E la poesia è così, sei tu che devi trovare le regole.
Dante, quando ad un certo punto uno gli dice: «Ma tu non sei quello girava per le strade di Firenze cantando le sue canzoni?» risponde; «I’ mi son un, - io sono uno a me stesso; mi sono uno - che quando amor mi spira, - quando l’amore mi alita, mi muove - noto, - cioè ascolto, prendo nota - e a quel modo ch’ei ditta dentro, vo’ significando». Vado riempiendo di segni. Perché significato vuol dire segno. Segno di lingua o di costume. Ma un segno, è un segno. Ma ci vuole l’amore, e l’essere uno a se stessi.
- Domanda del pubblico:
- Quest’essere uno a se stessi, lei come l’ha imparato? E come se lo tiene stretto?
Franco Loi:
L’ho imparato da bambino. Perché il bambino è sempre attento a se stesso. Il bambino si ascolta. E ogni piccola cosa... per esempio mio figlio, quando si muoveva. Noi quando vogliamo prendere qualcosa, lo prendiamo. Mio figlio... tac, con la mano, da una parte... tac... tac... a tentoni... e quando lo prendeva, rideva. Ma rideva, veramente, di gioia, come se avesse fatto chissà che cosa. Era riuscito a capire la distanza. E questo, noi adesso, invece, viviamo senza notare quello che succede dentro di noi, passiamo per strada, ci passano vicino le persone, vediamo cose, negozi, fiori, alberi... ma cosa succede dentro di noi, quando li vediamo? E li guardiamo, e hanno una rilevanza su di noi o non ce l’hanno? Come mai abbiamo perso il senso della vita? La vita è fatta dell’ascolto della vita. L’attenzione alla vita. E allora si impara guardando le sensazioni.
Confondiamo il buio con la tenebra. La tenebra è qualcosa che va al di là del vedere la luce, la luna o vedere le stelle. È al di là. È l’assoluta mancanza della luminosità minima. Quando siamo bambini, facciamo delle esperienze importanti, che si dimenticano. Perché poi incomincia la scuola, cominciano i rapporti con gli amici, le ragazze... ma l’esperienza delle cose che passano vicino a noi e che suscitano qualcosa vicino a noi... il nostro corpo è sensibile a tutto. I bambini di solito hanno una grande consapevolezza: il bambino si spaventa nella notte. E allora vuole venire nel letto della madre o del padre, perché è accaduto qualcosa che l’ha scosso profondamente. Lui lo sa. Ma poi quando cresciamo impariamo la logica. Serve, la logica; ma serve per muoverci tra i corpi.
Una volta, è successa una cosa importante. La sera, ho preso il mio autobus, sono sceso in piazza Durante, poi ho preso la via Casoretto e sono arrivato davanti alla chiesa. E mi ricordo che quando sono arrivato davanti alla chiesa - in quel periodo leggevo Feuerbach, e poi studiavo Carlo Marx, e quindi ero molto positivista - camminavo, e poi ho detto: forse Dante ha ragione. Non è così semplice. Può darsi che ci siano cose che avvengono, e che non ci danno modo di capirle, né di intenderle, né di avere delle esperienze.
E mentre dicevo queste cose, c’era una bella serata, con una bella luna, con le stelle... tutto questo l’ho descritto in un poema, che si chiama Strolegh. Nessuno ha capito che questo Strolegh deriva dal ricordo di quell’esperienza. Poi dentro c’è tante cose, c’è la rivoluzione francese, le partite di calcio con gli amici... un’infinità di cose. Quando ho voltato l’angolo della chiesa, improvvisamente dico: ma perché il corpo corre? E invece andavo adagissimo. Perché il corpo corre? E dentro, invece, il tempo si fermava.
Quindi avevo tre tempi. Ho detto: adesso saranno le undici e mezza, mezzanotte. E invece dentro il tempo non c’è più. È fermo. Camminavo, e sentivo una gioia straordinaria. Camminavo con questa possibilità - sentivo - di poter toccare la gente che passav dall’altra parte della strada, di poter toccare le stelle con le mani, di poter fare qualsiasi cosa. E allora questo... la baldanza, e dicevo: ma guarda, tre tempi dentro di me, e il fermarsi di un tempo, mi porta gioia.
Allora non è come sembra. L’orologio è una regola. Entriamo all’ospedale, il tempo non passa mai. Stiamo con la ragazza che amiamo, passa una giornata, e sembra che siano passati cinque minuti. Il bambino queste cose le sa già. Spesso sembra che faccia dei capricci. Il bambino vede e vive cose che noi non siamo più abituati a vivere.
Ho passato la piazza, sono arrivato all’angolo di via Teodosio. Quando ho voltato l’angolo, tutto si è rovesciato: dentro sembrava che dentro andassi ad una velocità incredibile. Io correvo, mi sono messo a correre, perché c’era un’ansia che cresceva dentro di me. E però mi pareva di star fermo. Come nel sogno, capita qualche volta, quando si è bambini, c’è la mano che vuol prenderci, noi scappiamo, e invece sembra di stare fermi. È la stessa sensazione.
Sono arrivato davanti al portone di casa mia, ho aperto il portone, e davanti a me, nell’atrio, c’era una barella con su steso mio padre. Il quale, era con gli occhi chiusi e le braccia lungo i fianchi. E ho guardato, ho guardato la lampada che ballava, dondolava. Ho guardato l’ombra, ho riguardato la lampada ho riguardato mio padre, e ho detto: è impossibile. E sono corso in mezzo all’immagine. Era un’immagine.
Però, due anni dopo, mio padre ha avuto la paresi. Abbiamo dovuto chiamare il medico, di Niguarda. Come l’ha visto, ha detto: è un ictus. E l’ha portato subito all’ospedale. E io sono andato via con gli infermieri. Per fargli strada, sono andato avanti; quando stavo per aprire il portone, ho fatto per tirare fuori la chiave - il portone si è aperto. E una signora che veniva a casa tutte le sere alle sei, quella sera chissà perché è tornata a mezzanotte. Era mezzanotte, quando l’abbiamo portato via. Quando ha aperto la porta, sono uscito, mi sono girato - e ho visto la stessa scena. C’era mio padre disteso sulla barella, con le mani lungo i fianchi, gli occhi chiusi, la lampada che dondolava.
Questa ve l’ho raccontata per dirvi che la vita è fatta di cose che conosciamo e cose che non conosciamo. Dice giustamente Einstein: «non si perviene alle leggi universali per via di logica, ma per intuizione». E l’intuizione non la facciamo noi, con la testa. È possibile nel rapporto simpatetico con l’esperienza. Cioè amoroso con l’esperienza. Perché è il rapporto d’amore con l’esperienza che ci fa raggiungere anche ciò che non conosciamo.
E questo è importante. Bisogna stare attenti. Tutte le chiese fanno una logica - teologia, si chiama - su qualcosa che non abbiamo mai visto, né sappiamo niente, che è Dio. Però questo non vuol dire che Dio non esiste. La nostra conoscenza è relativa alla corporeità, ma non sappiamo cosa c’è oltre. Le teologie e le ideologie ci fanno credere che con la logica siamo riusciti a costruirci un’immagine del mondo. Ma il mondo è sempre al di là della logica. Perfino quando si tratta di noi stessi. E allora bisogna stare attenti a noi stessi. Come Dante, che dice “I’ mi son un”, io sono uno a me stesso. [...].
*Fonte: Storie Sepolte, 25 febbraio 2017 (ripresa parziale).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- Grb 220101A. Il nuovo anno salutato da un lampo di raggi gamma da record: ha viaggiato per oltre 12 miliardi di anni (Ansa).4 gennaio 2022, di Federico La Sala
Il nuovo anno salutato da un lampo di raggi gamma da record
Rilevato anche da strumenti italiani
di Redazione ANSA *
- [Foto] Il lampo di raggi gamma Grb 220101A osservato tra le costellazioni di Pegaso e Andromeda (fonte: L. Tomasella/Inaf) © Ansa
Ha viaggiato per oltre 12 miliardi di anni ed è arrivato sulla Terra all’alba del primo gennaio, uno dei lampi di raggi gamma più potenti e lunghi mai registrati: proveniente da un fazzoletto di cielo tra le costellazioni di Pegaso e Andromeda, è stato denominato Grb 220101A.
Fra i primi strumenti al mondo a intercettarne e caratterizzarne il segnale, quelli a bordo del telescopio spaziale ‘made in Italy’ Agile e quelli dei telescopi dell’Osservatorio di Asiago dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) di Padova.
Il segnale è stato rilevato quando in Italia erano le 6:09 di sabato mattina: a circa 600 chilometri di altezza, il Burst Alert Telescope (Bat) del satellite Swift della Nasa ha registrato un improvviso flusso di fotoni ad altissima energia (nel range 15-350 keV) lungo parecchie decine di secondi, la ‘firma’ inequivocabile di un lampo di raggi gamma, tra i fenomeni più potenti dell’universo. Circa 15 secondi dopo, spiega l’Inaf in una nota, il segnale è stato registrato anche dagli strumenti a bordo di altri due satelliti per le alte energie: dal Large Area Telescope (Lat) del telescopio Fermi della Nasa e dai rivelatori di Agile, un piccolo gioiello per la rilevazione dei raggi gamma interamente made in Italy. Attivo dal 2007, Agile è frutto della collaborazione tra Agenzia spaziale italiana (Asi), Inaf, Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e diverse università italiane, e in passato ha già avuto occasione di osservare altri lampi di raggi gamma da record.
Da un’analisi preliminare dei dati raccolti, emerge che Grb 220101A non è solo il primo lampo di raggi gamma del 2022: è anche uno fra i più energetici di sempre. “È molto raro osservare eventi così lunghi ed energetici”, spiega a Media Inaf il primo autore della circolare (Gcn) che riporta l’osservazione con Agile, Alessandro Ursi dell’Inaf Iaps di Roma. “Il Grb 220101A ha attirato grande interesse da parte della comunità scientifica e in due giorni sono già state pubblicate più di venti Gcn che riportano osservazioni effettuate da missioni spaziali e da osservatori astronomici a terra".
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- "Inseguendo un raggio di luce. Alla scoperta della relatività". Immaginate l’universo (di Chiara Valerio).1 ottobre 2021, di Federico La Sala
Fisica
Immaginate l’universo
Amedeo Balbi ha scritto un libro per spiegare come l’uomo sia in grado di concepire l’impercettibile, a cominciare dalla teoria della relatività
di Chiara Valerio (la Repubblica, 29 Settembre 2021)
- Il libro Inseguendo un raggio di luce. Alla scoperta della relatività di Amedeo Balbi (Rizzoli, pagg. 228, euro 17)
Nel creare la relatività, Einstein non ha solo immaginato di correre dietro alla luce: ha visualizzato con la fantasia treni in corsa, fulmini che cadono, calamite in movimento, persone che precipitano dai tetti, cabine sollevate da una fune, giostre in rotazione, e molto altro».
Amedeo Balbi che da anni, alla sua attività di ricerca affianca - come nella migliore tradizione anglosassone - quella di divulgatore, ha scritto un saggio sull’immaginazione che genera realtà: la teoria della relatività. E, già per questo, è un libro che bisognerebbe leggere. Inseguendo un raggio di luce si legge con passione e con quel senso di attesa che sempre prende quando ci si avvicina alla scienza. Attesa di capire e attesa di avere un risultato.
Leggendo Balbi ci si rende conto che i risultati, quando sono tali, sono parziali, e che da Dante a Liu Cixin, la letteratura, talvolta, ha dato una forma e una possibilità all’universo prima che gli scienziati giungessero a formulare ipotesi. La differenza tra letteratura e scienza, Balbi la segna all’inizio: «Tutto ciò di cui parlerò, quindi, per quanto strano o lontano dall’esperienza comune possa sembrare, è stato messo alla prova sperimentalmente, come sempre deve essere quando si fanno affermazioni scientifiche sulla realtà. Ma una parte del fascino della relatività sta anche nella sua capacità di evocare situazioni ipotetiche o paradossali, e nella possibilità di chiedersi “come sarebbe se?”».
Inseguendo un raggio di luce è una storia analogica della relatività, e una storia degli esperimenti, mentali e fisici, che hanno permesso via via di verificare certi aspetti della relatività, e una storia degli apparecchi (e della loro costruzione) che hanno consentito di misurare certi fenomeni, e in ultimo una piccola ricognizione di fantascienza e di immaginazioni fantascientifiche - potremmo mai trasmettere via onde gravitazionali come trasmettiamo via onde elettromagnetiche?
Se capire la teoria della relatività è ostico e spiegarla complicato, raccontarla deve essere difficilissimo. Scrivo “deve essere” perché non mi è mai venuto in mente di farlo nonostante legga continuamente libri sulla relatività. Mi guarda dalla scrivania anche l’ultimo Relatività generale di Rovelli (Adelphi) che tuttavia, essendo un manuale, va letto con altro spirito.
Raccontare la relatività, con termini più o meno specifici, attraverso illustrazione (come per esempio fa Balbi) o aggiungendo formule al racconto, come pure capita, è un’opera meritoria. La teoria di Einstein infatti, oltre ad averci permesso di dare una immagine e un tempo all’universo, e tracciarne una evoluzione, costringe a scendere a patti con una realtà assai più bizzarra di quanto dica il senso comune. Più vasta e larga. E a confrontarci con l’evidenza, talvolta angosciosa ma sempre eccitante, che le cose siano più precise, ma anche più vaghe, perché per coglierle bisogna progettare e costruire sensori la cui capacità di impressione va molto oltre i nostri sensi. L’unico senso, la cui utilità rimane intatta in questo universo infinitamente più grande e infinitamente più piccolo della scala umana, è l’immaginazione che, ripeto, è il vero e fortunato tema di questo libro di Amedeo Balbi. Una immaginazione alla quale tutti possono contribuire, una sorta di immaginazione di specie.
Con un padre fisico, avevo in casa molti saggi scientifici, ma ricordo con nettezza che il primo tra tutti che ho aperto, adolescente, è stato Relatività, Cosmologia, Astrofisica di Livio Gratton (Bollati Boringhieri), seguito immediatamente da Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo di Stephen Hawking (Rizzoli), uscito qualche anno prima e già un successo editoriale, il libro di Gratton è invece del 1968. Non so cosa avessi capito, ma avevo provato a capire.
Sono stati pubblicati negli ultimi anni, libri sull’universo, sullo spazio-tempo, sull’energia e materia oscura - la forma dell’universo dipende dalla massa - e che aggiungono esattezza e suggestione ad esattezza e suggestione. Penso a Qualcosa di nascosto a fondo di Sean Carroll o a Fino alla fine del tempo di Brian Green, entrambi pubblicati per i tipi di Einaudi, o anche al formidabile Tutto l’universo per chi ha poco spazio tempo di Sandra Savaglio appena messo in tascabile da Mondadori, penso ai libri e al romanzo di Jim Al Khalili (tutti pubblicati per Bollati Boringhieri). Li elenco qui per ricordarmi che non è possibile divulgare la divulgazione, bisogna leggerla. Per rispettare lo sforzo di sintesi e immaginazione (sì, ancora) di chi ha scritto, e per onorare il profondo lavoro scientifico che sta dietro, evidente e innominato.
Rossella Panarese, conduttrice e curatrice di Radio 3 Scienza, ha osservato, nella voce Comunicazione scientifica per l’Enciclopledia Treccani «Colmare questo deficit è il compito di scienziati, insegnanti e naturalmente giornalisti e divulgatori, ma anche delle istituzioni politiche che devono promuovere progetti di formazione pubblica. Questa idea di pubblico è tanto lineare, quanto ottimista. Gli esperti possono parlare un solo linguaggio, convincente in quanto rigoroso, perché il loro pubblico è visto come un insieme di unità omogenee e indistinte, che si chiamino lettori, ascoltatrici, cittadine o elettori. Ma pur individuando una reale carenza conoscitiva da colmare, questo modello non riesce a esaurire, per es., la comprensione delle ragioni di uno scetticismo nei confronti della scienza che è ancora oggi uno dei problemi che ci troviamo a indagare».
Ogni buon libro di divulgazione scientifica, ogni programma e progetto di divulgazione scientifica, che tiene in sé lo sforzo di chiarire senza semplificare o deformare, è un passo opposto al dilagante antiscientismo che, in diciotto mesi di Covid, si manifesta in asserzioni e comportamenti che attentano ai singoli e alla comunità. Antiscientismo dal quale non sono immuni nemmeno gli intellettuali.
-
>LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- Al di là della dualità soffocante, un libro di Ilenia Caleo. Per pensare il vivente il «metodo» è l’amore (di Giovanna Ferrara).7 settembre 2021, di Federico La Sala
Per pensare il vivente il «metodo» è l’amore
ITINERARI CRITICI. «Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista», di Ilenia Caleo per Bulzoni. Dagli studi postcoloniali alla filosofia poststrutturalista, dalle rinnovate riflessioni sul teatro ai femminismi plurali, fuori dai comuni steccati disciplinari
di Giovanna Ferrara (il manifesto, 04.09.2021)
- «Kiss» di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo a Santarcangelo (2019) foto di Sara Lorusso
Quello che è stato scritto è un continente di domande ed esperienze, nel rifiuto dei recinti. Di un andare nel mondo implacabile e ostinato. È la storia unica di intensità diverse (arte e filosofia, teatro e femminismi) che nell’attivismo politico hanno interagito liberandosi della menzogna burocratica delle settorialità di interesse. Il volume di Ilenia Caleo, Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista (Bulzoni editore, pp. 228, euro 20) abita lo spiano di una verità incarnata: tutto è politico e il politico è continua intersezione. La contiguità come metodo, e gli affetti come strada, sono il responso oracolare di questo lavoro, che abbatte tutto quello che interrompe la molteplicità dell’orizzonte: dal margine si vede meglio. Che non può esserci separazione se si intende confezionare uno stare nella vita libero e germogliativo, rispettoso della sua inevitabile irriducibilità.
NON È UN CASO che lo smontaggio degli steccati cominci a partire dalla riflessione sul corpo, massacrato dalla dualità soffocante in cui lo ha respinto chi lo oppone al pensiero. Che idiozia è stato ignorare che il concetto nasce anche da quello che sento quando tocco o quando vengo toccato, dallo spazio che abito a quello che subisco. «Pensare è sempre pensare per concetti, oppure per funzioni, oppure per sensazioni», ci avvertiva Deleuze, dialogando naturalmente con il rifiuto marxista del tranello messianico e di quello accumulativo, entrambi orchestrati per togliere «valore» all’immanenza della vita. Ma di questi avvertimenti la produzione teorica insorgente, il lavoro nelle accademie, quello più ampiamente cognitivo, ne ha tenuto conto?
I «PERFORMANCE STUDIES», di cui Caleo dà conto in maniera ragionata e ampia, superano questa domanda, cosi come fanno i femminismi afroamericani e lesbici, così come le pratiche attoriali che pensano mentre si danno, così come le occupazioni politiche che non sono di nessun mestiere ma di tutti. In questo la performance come centro di pensiero (del corpo, del movimento) ci abitua all’idea che qualsiasi lingua è una lingua straniera, che la conoscenza è esplorazione di altri, che il sapere «immobile» non è altro che il soprammobile sul comò di un passato mummificato.
Grande e soddisfacente è la lettura di un testo quando sa aprire i battenti e fa circolare correnti. Dagli studi postcoloniali alla filosofia poststrutturalista, dalle rinnovate riflessioni sul teatro ai femminismi plurali, ci sentiamo di essere dentro il crocevia dei diversi piani del vivente, lì dove solo si può trovare la leva da agire per avere un mondo nuovo, senza confini concettuali, senza recinzioni da identità fisse. Sembra che scorrendo le pagine l’intuizione della «intersezione» si faccia esistenziale, pratica continua di liberazione. Ogni pagina un vestito in meno, una struttura in meno, una oppressione in meno.
I generi non esistono come agenti isolanti dagli altri tratti che ci riguardano; i diritti non sono mai da pensarsi come scatole chiuse. Sono membrane aperte ad accogliere il non ancora arrivato così come ce la raccontava Rodotà, il giurista stellare che non dava alcuna dignità all’inattaccabile fossato che hanno scavato per dividere la legge dalla non legge, rifiutando la mobilità intrinsecamente permeabile della giustizia.
Viste così le occupazioni smettono di essere anomalie da correggere, le fluidità di genere novità eccentriche, le arti non sono riserve indiane, noi smettiamo di essere un noi pieno di fibrosi che producono impossibilità all’espansione. Tutto questo c’è, ad esempio, nel disorientamento innestato dallo spettacolo di Xavier Le Roy, descritto da Ilenia Caleo come evidenza della sua tesi che l’arte non oggettivizza un pensiero, ma lo «pensa». In quella performance smette di esistere il sopra e il sotto, non c’è lato: il disorientamento fa splendere una nuova riterritorializzazione che non ha niente di automatico e a cui nessuno può dettare regole.
ALLA MANIERA di certi architetti che rifiutano di vivere il passato come feticcio e la teoria come mondo altro, Caleo ci fa stare di continuo sulle soglie di un futuro impellente. E prosegue cambiando sempre il passo, come quando dalla sua prismatica esperienza di esistente (ricercatrice, artista, performer e militante) passa alla trattazione storiografica di come sono state rielaborate le esclusioni del femminile dai dispostivi maggioritari del sapere. Una cartografia dei femminismi, completa di cadute e resurrezioni. Un libro affettivo, infine. Che ragiona su quel manuale di felicità che ci ha regalato Spinoza. E che per questo abbatte anche quella divisione tra pubblico e privato che troppo spesso è stato il burrone dove andavano a finire i nostri sogni. Un libro sull’amore, amore-metodo, amore-soggetto, amore-oggetto. Amore ovunque.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- COME PENSANO LE FORESTE (E. Kohn). Un’indicazione per «“aprire il pensiero” in modo da renderlo accogliente alla visione dell’“oltre”» (di A. Zaccuri - G. Marrone)).27 agosto 2021, di Federico La Sala
Idee.
La foresta parla per segni. Come gli uomini?
Leggere il libro della natura: per l’antropologo Eduardo Kohn l’esperienza maturata presso gli indios ecuadoriani diventa occasione per rivalutare la funzione simbolica del linguaggio
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, venerdì 27 agosto 2021).
La leggibilità del mondo di Hans Blumenberg è stato uno dei libri fondamentali nel panorama del tardo Novecento. In quel saggio, apparso nel 1979, il pensatore tedesco ricapitolava le vicende del liber naturae, la metafora che attraversa per intero la cultura medievale per poi trionfare in età moderna. È Galileo, infatti, a rivendicare la perspicuità del “libro della natura” come criterio decisivo per il suo metodo scientifico. Ma la contemporaneità, si domandava Blumenberg, è ancora in grado di decifrare la scrittura del mondo? La realtà oggi si presenta ancora come un sistema coerente di coerente di segni?
Nella terminologia specifica di cui l’antropologo Eduardo Kohn si serve nel suo Come pensano le foreste (traduzione di Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri, nottetempo, pagine 448, euro 20,00, con una prefazione di Emanuele Coccia) la risposta all’“ancora” di Blumenberg potrebbe essere formulata ricorrendo a una curiosa combinazione di avverbi, “sempre già”. Si tratta, in apparenza, di una nozione specifica dei runa, la popolazione indigena della foresta amazzonica ecuadoriana presso la quale Kohn ha lungamente soggiornato.
Prima di proseguire, andrà subito sottolineato che Come pensano le foreste (edito originariamente nel 2013) è un libro attorno al quale si è sviluppato un ampio dibattito internazionale, che lo candida a diventare uno dei titoli più rappresentativi del secolo che stiamo vivendo. In questo senso, l’accostamento a La leggibilità del mondo non è dovuta solo a all’affinità tematica. Laddove Blumenberg partiva dalla filosofia per delineare un’antropologia, Kohn procede in direzione contraria: l’obiettivo della sua ricognizione etnografica consiste in una ridefinizione delle categorie filosofiche. Per dirlo con le sue parole, occorre “aprire il pensiero” in modo da renderlo accogliente alla visione dell’“oltre”. Che non è un luogo, ma un metodo.
Un sistema di segni, di nuovo. O, a voler essere puntigliosi, una semiosi. Nella struttura di Come pensano le foreste il magistero semiotico di Charles Sanders Peirce riveste un ruolo non meno importante delle ricerche sul campo di Lucien Lévy-Bruhl o Claude Lévi-Strauss. Da Peirce deriva la tripartizione dei segni in icone, indici e simboli, alla quale Kohn fa ricorso per tutta la trattazione, alternando la descrizione di episodi caratteristici della sua permanenza tra gli indios a circostanziati approfondimenti concettuali.
 La tesi portante del libro è che ogni essere vivente agisce all’interno di un sistema di segni, che possono limitarsi a riprodurre l’oggetto (è il caso del’icona) oppure suggerirne la presenza attraverso indizi (questo è il compito dell’indice). A queste due funzioni basilari, nell’essere umano, e solo nell’essere umano, si aggiunge la facoltà di accedere al simbolo, che introduce un elemento di valore, permettendo al linguaggio di accedere a una dimensione morale.
La tesi portante del libro è che ogni essere vivente agisce all’interno di un sistema di segni, che possono limitarsi a riprodurre l’oggetto (è il caso del’icona) oppure suggerirne la presenza attraverso indizi (questo è il compito dell’indice). A queste due funzioni basilari, nell’essere umano, e solo nell’essere umano, si aggiunge la facoltà di accedere al simbolo, che introduce un elemento di valore, permettendo al linguaggio di accedere a una dimensione morale.Insistere sulla pervasività del segno, condivisa secondo modalità specifiche anche da piante e animali, non comporta affatto una mortificazione del pensiero umano. Al contrario, secondo Kohn, questa ulteriore declinazione di “pensiero aperto” permette di affrontare con accresciuta consapevolezza l’enigma che la Sfinge pone a Edipo. Anche in quella circostanza, com’è noto, l’essere umano viene paragonato a un animale: l’unicità della sua condizione di bipede rappresenta una mediazione tra l’iniziale necessità di procedere ferinamente a quattro zampe e la successiva adozione di uno strumento, il bastone, che si configura come protesi tecnologica.
I runa della regione di Ávila, ai quali Kohn si riferisce in modo diretto, si trovano a loro volta in una posizione di crocevia. In quanto indios mansos (letteralmente, “addomesticati”) partecipano sia della connotazione ancestrale del puma, ossia del predatore, sia di quella civilizzata dell’amo, il “signore bianco”. Le storie riportate da Kohl si muovono all’interno di questo triangolo del “sempre già”, riservando molto spazio ai sogni e alla loro interpretazione. Le donne, per esempio, si abituano a riconoscere le diverse articolazioni dei guaiti che i cani emettono durante il sonno, mentre sui cacciatori ricade l’onere di distinguere i presagi fausti dagli infausti. In sogno, racconta Kohn, può anche capitare di addentrarsi nel territorio dell’“oltre”, sul quale regnano i signori della foresta e nel quale si trasferiscono i morti dopo aver lasciato le loro spoglie sulla terra.
Lo studioso si richiama a credenze di tipo animista, che nell’esperienza dei runa convivono con una fede cristiana tutt’altro che superficiale. Non diversamente, viene da osservare, accadeva nelle campagne dell’Europa ancora in età moderna, quando il principio della “leggibilità del mondo” era istintivamente comprensibili per i semplici e per i sapienti. Del resto, insieme al mito della Sfinge, Kohl rievoca spesso l’immagine dantesca della “selva oscura”, quasi a stabilire una continuità dei segni e delle forme a dispetto di ogni eventuale discontinuità storica o geografica.
Pensare la realtà come sistema di segni comporta di per sé la convinzione che la realtà abbia un significato e che questo significato trovi espressione compiuta attraverso il simbolo. Non fosse che per questo, Come pensano le foreste è un libro che non può non chiamare in causa anche la riflessione teologica.
Come pensano le foreste
di Gianfranco Marrone (Doppiozero, 23 Luglio 2021)
Poesia e antropologia: che c’azzeccano? Sempre più spesso questo binomio viene invocato nelle cronache culturali, e ancora di più viene praticato nel loro effettivo svolgimento: dai poeti meno, probabilmente, ma senz’altro da antropologi, etnologi, etnografi o comunque li si voglia appellare. Non senza irritazioni nell’establishment accademico, sempre pronto a difendere i tradizionali steccati disciplinari, accade - con un’insistenza divenuta tendenza - che molte ricerche antropologiche acquisiscano un tono e un linguaggio, e dunque evidentemente dei contenuti, che tracimano nel poetico, o che quanto meno ricordino passaggi, stili e sensazioni che la poesia ha talora prodotto nel corso della sua lunga storia. Non si tratta, per carità, di intuizioni liriche del sentimento, secondo la famigerata lezione crociana che rispunta per ogni dove non appena ci si distrae un attimo; ma, forse, di presagi, accostamenti inconsueti, folgorazioni percettive che la sensibilità poetica sa come, dove e perché trascrivere - trasformare - in specifica testualità. Così per esempio Tim Ingold, il cui stile è già di per sé intrinsecamente lirico, ha fatto del concetto di corrispondenza, esplicitamente ripreso da Baudelaire, uno dei punti chiave della sua teoria, rivelando lo stretto legame fra le sue ricerche sul campo (soprattutto fra le varie etnie sparse nei Paesi artici) e le conclusioni che ne ha tratto, di stampo fortemente fenomenologico, dunque assai vicine a una visione poetica del mondo.
Ma più spesso questo genere di legami fra i mondi abitualmente considerati lontani della poesia e dell’antropologia è sorto, per così dire, dalle cose stesse, e cioè dall’orientamento metodologico che da alcuni decenni a questa parte ha assunto la scienza dell’uomo per antonomasia, l’antropologia appunto, includendo con sempre maggiore convinzione fra i propri oggetti di studio, accanto e insieme agli esseri umani, entità che umane non sono, come gli animali e le piante, ma anche i sogni e gli spiriti, le divinità, gli oggetti, le tecnologie. Le società umane, s’è progressivamente affermato, sono tali perché includono al loro interno anche i non umani, qualunque sia la configurazione che, proprio grazie a esse, assumono. Se, come già sappiamo da Descola a Latour, la dicotomia che - ponendosi alla base delle scienze sociali - oppone natura e cultura va abbandonata, essendo invenzione tutta moderna e occidentale, ne deriva quasi automaticamente che lo sguardo nei confronti del mondo debba essere fortemente trasformato. Di modo che le scienze sociali nel loro complesso, alla ricerca di nuovi fondamenti teorici, hanno finito per acquisire, insieme a un nuovo linguaggio, un nuovo modo di osservare uomini e cose, umani e non umani, considerandoli tutti facenti parte della cultura - o, che è lo stesso (e non importa), facenti parte della natura. Quel che viene meno, molto in sintesi, è ogni pretesa oggettivante (e perciò scientista), ma al tempo stesso ogni accostamento soggettivante (idiosincratico, e perciò sentimentalistico).
Accade cioè che per occuparsi dei meccanismi costitutivi delle società umane non basta studiare, poniamo, le relazioni di parentela, le forme religiose, i rituali di passaggio, il diritto, il costume e simili, ma anche e soprattutto l’ecologia degli esseri viventi nel loro complesso, ossia tutto ciò che solitamente consideravamo entità naturali, sia in quanto tali, sia soprattutto, nelle loro relazioni con gli umani. Così come noi abbiamo una certa idea delle cose del mondo, chiamiamolo così, socio-naturale, e ce ne costruiamo una rappresentazione a partire da precisi punti di vista e schemi mentali, allo stesso modo accade per gli altri esseri viventi, anch’essi dotati di punti di vista e schemi mentali (o comunque li si voglia chiamare) attraverso i quali si fanno una rappresentazione di noi. Lo sguardo antropologico che supera l’opposizione natura/cultura deve rendere conto, insomma, del fatto che nella fitta rete di relazioni fra gli esseri viventi, umani e non umani, tutti quanti si scrutano a vicenda, costituendosi reciprocamente.
Non a caso, uno dei temi privilegiati di questa tendenza dell’attuale antropologia non può che essere quello della caccia, pratica che condividiamo con qualsiasi altro animale, se non in generale con ogni essere vivente. Tutti quanti siamo, prima di ogni altra cosa, prede o predatori, soggetti attivi oppure passivi, e dunque, in fin dei conti, mangianti o mangiati. E in questo gioco al massacro - occorre farsene una ragione - si formano i fragili equilibri anche di una parentela che include i non umani: c’è chi non mangia le scimmie perché le considera alla stregua dei cognati, così come noi non cucineremmo mai un pet, animale di compagnia e dunque parente acquisito ben presente nello stato di famiglia. Lo si vede già dagli assetti linguistici, dove, per esempio, l’uso dei pronomi personali (io/tu oppure egli) è la spia non casuale delle specifiche relazioni fra gli interlocutori in gioco, modificabile di continuo a seconda dei contesti e proprio per questo di basilare importanza, appunto, per l’antropologia - che di contesti non può non trattare. È dunque a partire dalle relazioni, linguistiche come parentali, che si generano i termini in gioco.
Tutto questo per introdurre un libro importante, Come pensano le foreste di Eduardo Kohn (nottetempo, pp. 439, € 20), che già dal titolo vuol essere tanto provocatorio quanto programmatico, indicando a chiare lettere le sfide intellettuali di quella formidabile antropologia contemporanea che, come sottolinea giustamente Emanuele Coccia nell’introduzione, è da qualche tempo in qua diventata, quasi senza volerlo, una sorta di scienza pilota: “il più grande e vivace laboratorio speculativo contemporaneo, il primo e più importante vivaio delle invenzioni morali e culturali che stanno rivoluzionando il pensiero e i costumi del XXI secolo”. Come possono mai pensare le foreste - dirà il nostro buon senso comune -, dato che il pensiero, insegna Cartesio, è prerogativa eminentemente umana, e addirittura ciò che ci fonda come soggetti non soltanto fisicamente estesi ma, appunto, cogitanti?
È possibile, risponde Kohn, se si fuoriesce proprio dal razionalismo cartesiano che ancora surrettiziamente plasma la nostra cultura, e si assume un punto di vista olistico, un atteggiamento onnicomprensivo che, mettendo in parentesi la biblica supremazia dell’uomo sul resto del ‘creato’, prenda seriamente in considerazione l’ipotesi che tutti gli esseri viventi, ognuno a suo modo, abbiano una forma di ragione o, meglio, degli strumenti per interpretare il mondo, per rappresentarsi gli altri esseri viventi, per dare loro un senso e un valore. Guardare in viso qualcuno, ricorda Kohn in apertura al libro, sia esso un uomo o un altro animale, è già un modo per predisporsi verso di esso come soggetto attivo, e se non come eventuale predatore quanto meno come impossibile preda. I giaguari che si sentono guardati, ai quali cioè si dà del tu, perdono molta della loro spavalderia venatoria.
Il libro di Kohn propone una ricca serie di esempi in merito, o se si preferisce una miniera di dati etnografici, ricavati dalla ventennale frequentazione con l’etnia Runa dell’Amazzonia ecuadoriana e precisamente del villaggio di Avila, etnia che mostra molto bene - nei discorsi e nei comportamenti - la necessità di questo rovesciamento teorico: le foreste pensano, se ne ricava, soltanto se si fa propria l’idea che possano farlo. I Runa, in questo, danno preziose lezioni filosofiche. Per nulla ‘selvaggi’ al di fuori dell’ambiente occidentale, ma colonizzati che da secoli interagiscono coi loro colonizzatori, i Runa abitualmente commerciano (in tutti i sensi del termine) con il resto del mondo, vanno per esempio al supermercato per rifornirsi di ogni necessità quotidiana, negoziano regolarmente con le ONG, si spostano nei villaggi vicini per dotarsi di armi e munizioni; ma non appena devono sfamarsi, ecco che guardano alla foresta che sta ai margini dei loro villaggi, e vi si immergono per procacciarsi il cibo, in un ambiente che è al tempo stesso domestico e selvaggio, coltivato e incontaminato. Riattivando la dialettica di base fra lo sfamarsi e lo sfamare, procurarsi selvaggina o esserlo per gli altri, i Runa - spiega Kohn - si mostrano per quel che sono nel profondo: al tempo stesso esseri ‘altro-che-umani’, al pari degli animali della foresta, ma anche ‘troppo umani’, nel senso nietzschiano del termine. “Ottenere il cibo grazie alla caccia, la pesca, la raccolta, la coltivazione e la gestione di una varietà di concatenamenti ecologici, coinvolge intimamente la gente di Avila in uno degli ecosistemi più complessi al mondo - un ecosistema stracolmo di una sbalorditiva varietà di esseri che interagiscono fra loro e che sono reciprocamente costitutivi”. In tal modo i Runa divengono “dèi che parlano attraverso i corpi delle mucche, Indios nei corpi dei giaguari, giaguari abbigliati da bianchi” e chissà quante cose ancora.
Ma come avvengono questi collegamenti tra forme di vita della e nella foresta, come si istituisce questa fitta rete di relazioni fra diversi esseri viventi? La risposta di Kohn è molto precisa: attraverso segni, segni d’ogni tipo che, il più delle volte, non hanno carattere linguistico senza per questo essere meno loquaci. Laddove le lingue umane usano sistemi di simboli convenzionali, dice Kohn riprendendo esplicitamente la teoria semiotica di Charles S. Peirce, gli altri esseri viventi comunicano fra loro, nonché con gli umani, attraverso indici e icone, e cioè mediante segni che hanno una qualche contiguità con ciò che rappresentano oppure che vi somigliano. Così, nella caccia alla scimmia si possono strattonare rampicanti legnosi o altre liane per farle fuggire (dove il movimento dei vegetali dice all’animale che sta accadendo qualcosa di strano, ed è un indice), oppure si pronunciano suoni onomatopeici come ta-ta e pu-oh (i quali rinviano all’immagine del taglio di una palma col machete, ed è un’icona). Così, “la significanza non è un territorio esclusivo degli esseri umani perché non siamo i soli a interpretare i segni. Il fatto che altri generi di esseri usino i segni è un esempio dei modi in cui la rappresentazione esiste nel mondo al di là delle menti umane e dei loro sistemi di significato”. Lungi dallo sclerotizzare le dinamiche ecologiche in codici prefissati, i segni, continua Kohn, permettono le dinamiche stesse della vita, la sua intrinseca plasticità, di qualunque vita si tratti, qualsivoglia forma possa assumere. Da qui l’idea di un pensiero che è tutt’uno con l’esistenza, sganciandosi dal dettato cartesiano che lo vorrebbe prerogativa esclusiva dei soggetti umani. Un pensiero, pertanto, che include al suo interno sensazioni e percezioni, affetti e azioni: motivo per cui, con un lungo giro, finisce per assumere conformazioni di senso e stili linguistici che ricordano quelli della poesia. Così, se per il poeta l’idea che le foreste pensano è una specie di evidenza, per l’antropologo è una conquista teorica da tenere stretta.
Una conquista che, come sempre accade, va argomentata teoricamente e, soprattutto, difesa, protetta, rafforzata. Come pensano le foreste - la cui lettura non può non interessare, al di là dell’ovvia cerchia etnologica, filosofi e sociologi, letterati e storici della cultura - non è allora un punto di arrivo ma uno di partenza, ponendosi come un testo chiave da assimilare, discutere e anche se del caso criticare. Una molteplicità di saperi viene convocata - più o meno implicitamente - nel dibattito. L’etologia, in primo luogo, grande assente tra le pagine di Kohn, eppure di grande utilità per comprendere al meglio il senso di tanti comportamenti animali. Von Uexküll e Lorenz, per esempio, avrebbero sicuramente di che ridire (si veda il capitolo sui sogni dei cani). La linguistica, in secondo luogo, che sulle onomatopee ha parecchio da dire di più incalzante. E la semiotica soprattutto, tirata in ballo a gran voce, ma utilizzata al minimo delle sue forze, riprendendo un Peirce di maniera, assai caricaturizzato, che nessun semiologo serio adopererebbe con questa rigidità. Così, per dirne una (ma occorrerà tornarci), sostenere che gli uomini usano simboli e gli animali indici e icone è un’idea tutto sommato banale, per non dire tradizionale, aristotelica nel senso manualistico del termine. In un libro che prende di petto il razionalismo l’idea di un logos come prerogativa dell’essere umano stride non poco. E poi, ammettiamolo, Verlaine e Mallarmé non sarebbero d’accordo. Se le foreste pensano, occorre ripensare tutto quanto insieme a loro.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- Per gli studi sulle onde gravitazionali, ad Alessandra Bonanno (a capo della divisione di Astrofisica e Relatività Cosmologica dell’istituto tedesco Max Planck).9 agosto 2021, di Federico La Sala
Per la prima volta a un’italiana la medaglia Dirac
Ad Alessandra Bonanno per gli studi sulle onde gravitazionali
di Redazione ANSA *
- [Foto] Alessandra Buonanno è la prima italiana a vincere la medaglia Dirac, per il suo contrbuto alla ricerca sulle onde gravitazionali (fonte: ICTP) © Ansa
Per la prima volta la medaglia Dirac, uno dei principali premi scientifici internazionali, è stata assegnata a una ricercatrice italiana, Alessandra Buonanno, che lavora in Germania, nell’Istituto Max Planck per la Fisica gravitazionale di Potsdam.
Assegnata dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (Ictp), la medaglia Dirac premia Buonanno per le sue ricerche teoriche alla base della rilevazione delle onde gravitazionali. Oltre a essere la prima italiana, Buonanno è la seconda donna in assoluto a ricevere la medaglia Dirac. Con lei sono stati premiati i fisici Thibault Damour, Frans Pretorius e Saul Teukolsky.
Alessandra Buonanno è a capo della divisione di Astrofisica e Relatività Cosmologica dell’istituto tedesco Max Planck. Dopo la laurea e il dottorato di ricerca in Fisica all’Università di Pisa, la ricercatrice ha lavorato al Cern di Ginevra e poi in Francia, nell’Institut des Hautes Etudes Scientifiques (Ihes). Ha inoltre lavorato nel Laboratorio di Astrofisica e Cosmologia (APC) di Parigi (2001), nell’Università del Maryland (2005) e nel 2014 è stata nominata co-direttrice dell’Istituto Max Planck per la fisica gravitazionale di Potsdam.
Tutti e quattro i fisici sono stati premiati per il loro contributo alla ricerca che ha permesso di scoprire le onde gravitazionali, in particolare per avere stabilito le proprietà delle onde gravitazionali prodotte quando due stelle o due buchi neri ruotano uno attorno all’altro per poi fondersi. “Il lavoro teorico delle Medaglie Dirac di quest’anno è stato fondamentale per interpretare le osservazioni effettuate da Ligo, un esperimento estremamente sofisticato”, ha detto il direttore dell’Ictp, Atish Dabholkar, annunciando i vincitori del premio. “Si tratta - ha aggiunto - di una verifica impressionante dell’accuratezza della teoria della relatività generale di Einstein. È un meraviglioso tributo allo straordinario potere della nostra comprensione teorica della natura, che fino a poco tempo fa sembrava troppo bizzarra per la verifica osservativa".
Damour, dell’Istituto francese di alti studi scientifici (Ihes) lavora in Francia, nell’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) e nel 2016 ha vinto lo Special Breakthrough Prize per la fisica fondamentale per la rilevazione delle onde gravitazionali; Pretorius è direttore della Princeton Gravity Initiative dell’Università americana di Princeton, è l’autore del primo codice informatico che simulare la fusione di due buchi neri; anche Teukolsky lavora negli Stati Uniti, presso il California Instituto of Tecnology (Caltech) e la Cornell University.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- GIÀ, DOV’È LA LUCE. «What is Poetry?», si chiede Ferlinghetti nel suo "Poetry as Insurgent Art" (di Maria Anita Stefanelli):25 febbraio 2021, di Federico La Sala
Cultura
Un frenetico giro intorno al mondo tra oggetti, corpi e sensazioni
Il poeta. I versi di Lawrence Ferlinghetti dedicati all’emigrazione. Come Montale, interroga la vita per far luce sull’esistenza umana e decifrarne il mistero. Trapiantare il girasole è il sogno del migrante, il girasole la metafora per la luce come vitalità, cambiamento, visione del futuro, verità. La luce come panorama di culture, linguaggi, identità plurime
di Maria Anita Stefanelli (il manifesto, 25.02.2021)
«Portami il girasole impazzito di luce»: l’omaggio a Montale, in italiano, è l’epigrafe di Lawrence Ferlinghetti a «Surreal Migrations» («Migrazioni surreali», in Blind Poet - Poeta Cieco, Giunti 2003, traduzione italiana di Antonio Bertoli), la poesia contenuta in How to Paint Sunlight (Come dipingere la luce) l’edizione paperback del 2001 pubblicata, come molte sue poesie, da New Directions (New York), sulla costa opposta dell’America rispetto a San Francisco, dove è nata, poi fiorita, l’allora «notoria» (anni Cinquanta) City Lights Booksellers and Publishers. SULLE TRACCE del pittore Edward Hopper, il cui desiderio è «dipingere la luce del sole sulle facciate delle case», Ferlinghetti, come il «romantico irrazionale e visionario» che dipinge la solitudine, costruendo oggetti, corpi e sensazioni con la luce, per il quale «la luce viene prima e l’oscurità non è che un’ombra fugace da eliminare con più luce» («A Word»).
Ed eccolo a compiere, con la leggerezza di un bimbo sulla giostra (light, in inglese, traduce «luce» ma anche «leggero») un frenetico giro intorno al mondo, da Praga (dove Jan Hus ha cercato la libertà dall’oppressione) attraverso fiumi, mari, oceani, sempre in direzione ovest, impaziente e di raggiungere il lontano Oriente, il Medio Oriente, il Nord Africa, l’Ellesponto e il Mediterraneo fino alla penisola italica, dove, incalzato dal tempo come il Bianconiglio nel Paese delle Meraviglie, si fionda in discesa attraverso brevi versetti a scalini, approfittando di una lingua nativa, l’inglese (per la verità, parlava anche francese da piccolo), di cui sfrutta i molti monosillabi sui quali facilmente scivola da un fiume all’altro: «Across the rivers of the world/ Across the Rhine/ Across the Rhone/ Across the Seine/ Across the Thames/ Across Anna Livia’s Liffey/ Across Atlantic/ Across Manhattan/ Across Great Hudson/ into the heart of America» e si chiede «Where is the light?».
GIÀ, DOV’È LA LUCE per gli Europei, gli Italiani (come suo padre, insiste, ma non è dato averne certezza), che emigravano in cerca di lavoro, inseguendo il sogno americano, e che emigrano ancora in America? La poetica del fiume di Ungaretti («Questi sono i miei fiumi», ha scritto emulando l’Italiano), l’immagine del girasole di Montale «che conduce/ dove sorgono bionde trasparenze/ e vapora la vita quale essenza», il Paradiso di Dante dove il viaggio termina (ma il suo Paradiso, di Lawrence, è diverso!), da questi e altri ancora Ferlinghetti assorbe citazioni e motivi, parole e musica: «Surreal migrations of words/ somewhere between speech and song» (Migrazioni surreali di parole/ da qualche parte tra discorso e canzone).
Tra l’ansia (l’artista ne soffre) e lo spasso (il poeta - Shakespeare docet - inventa pun per puro divertimento) Ferlinghetti, come Montale, interroga la vita per far luce sull’esistenza umana e decifrarne il mistero. Trapiantare il girasole è il sogno del migrante, il girasole la metafora per la luce come vitalità, cambiamento, visione del futuro, verità. La luce come panorama di culture, linguaggi, identità plurime.
«What is Poetry?», si chiede Ferlinghetti nel suo Poetry as Insurgent Art (1975): «È qualcosa da invocare in una selva oscura nel mezzo del cammino della vita».
Ciao, Larry, salutaci il tuo Paradiso.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- GIÀ, DOV’È LA LUCE. «What is Poetry?» -- Morto Lawrence Ferlinghetti, si chiude un’era (di Alberto Fraccareta).25 febbraio 2021, di Federico La Sala
Beat Generation. Morto Lawrence Ferlinghetti, si chiude un’era
Il poeta, scrittore ed editore era nato nel 1919. Il suo nome resta legato al movimento letterario degli anni 50 e 60
di Alberto Fraccacreta (Avvenire, martedì 23 febbraio 2021)
- [Foto] Lawrence Ferlinghetti davanti alla sua libreria a San Francisco - Stringer/File Photo
È morto Lawrence Ferlinghetti all’età di 101 anni. L’altro ieri, lunedì 22 febbraio, a San Francisco, città simbolo della controcultura, a causa di una malattia polmonare, secondo quanto ha riferito il figlio Lorenzo. Storico editore e libraio di City Lights (che pubblicò Howl, Urlo, di Allen Ginsberg e si beccò una condanna per oscenità), ultimo baluardo di quel movimento poetico eversivo e disarticolante che è stata la Beat Generation, Ferlinghetti era nato nel marzo del 1919 a Yonkers, nello Stato di New York. Evidenti i geni italiani (per parte di padre; la madre era invece di origini franco-portoghesi).
 Dopo un’infanzia turbolenta trascorsa in Francia, Lawrence fa ritorno con la zia negli Stati Uniti. Studia alla Columbia University, si arruola nella marina (come successivamente farà nientemeno che Thomas Pynchon), dopo la terribile esplosione di Nagasaki diviene convinto pacifista. A seguito di un incontro decisivo (con il poeta Kenneth Rexroth) durante il dottorato alla Sorbona, si reca a San Francisco in California, che sarà il suo regno assoluto fino agli ultimi giorni.
Dopo un’infanzia turbolenta trascorsa in Francia, Lawrence fa ritorno con la zia negli Stati Uniti. Studia alla Columbia University, si arruola nella marina (come successivamente farà nientemeno che Thomas Pynchon), dopo la terribile esplosione di Nagasaki diviene convinto pacifista. A seguito di un incontro decisivo (con il poeta Kenneth Rexroth) durante il dottorato alla Sorbona, si reca a San Francisco in California, che sarà il suo regno assoluto fino agli ultimi giorni.
 Ferlinghetti - little boy simbolo dell’editoria indipendente, voce del disarmo ed emblema del mondo beat assieme a Kerouac, Ginsberg e Corso - è stato innanzitutto un poeta. Forse il più convincente della sua generazione, sicuramente il meno adatto a essere etichettato. Versi attorcigliati e netti, pensieri caustici e dolci, lieta sofferenza: Ferlinghetti è il poeta delle antinomie e di un anarchismo religioso eclettico che considera la figura di Gesù e tiene in serbo le massime orientali.
Ferlinghetti - little boy simbolo dell’editoria indipendente, voce del disarmo ed emblema del mondo beat assieme a Kerouac, Ginsberg e Corso - è stato innanzitutto un poeta. Forse il più convincente della sua generazione, sicuramente il meno adatto a essere etichettato. Versi attorcigliati e netti, pensieri caustici e dolci, lieta sofferenza: Ferlinghetti è il poeta delle antinomie e di un anarchismo religioso eclettico che considera la figura di Gesù e tiene in serbo le massime orientali.
 La sua lirica è impregnata di un misticismo cosmico, universale (molto simile a quello di Gary Snyder) che penetra nei tessuti dell’essere fino a mostrarne i legami. Diversamente dal caos esplosivo di Ginsberg, Ferlinghetti mostra un tono più prudente e controllato nel raggiungere la giusta misura poetica. La sua concezione politica e filosofica si riflette in una assoluta tensione alla libertà, che va al di là di ogni cultura e ogni divisione di genere.
La sua lirica è impregnata di un misticismo cosmico, universale (molto simile a quello di Gary Snyder) che penetra nei tessuti dell’essere fino a mostrarne i legami. Diversamente dal caos esplosivo di Ginsberg, Ferlinghetti mostra un tono più prudente e controllato nel raggiungere la giusta misura poetica. La sua concezione politica e filosofica si riflette in una assoluta tensione alla libertà, che va al di là di ogni cultura e ogni divisione di genere.
 La sua vocazione di editore, peraltro, lo ha portato a considerare le diverse voci della letteratura con una delicatezza e una capacità di scandaglio davvero singolari; l’indipendenza da ogni visione ideologia e prospettica - o, meglio, l’inappartenenza - è il conseguimento di un orizzonte antidottrinario (un po’ come il nostro Eugenio Montale) sono state le cifre uniche della sua attività di letterato tout-court.
La sua vocazione di editore, peraltro, lo ha portato a considerare le diverse voci della letteratura con una delicatezza e una capacità di scandaglio davvero singolari; l’indipendenza da ogni visione ideologia e prospettica - o, meglio, l’inappartenenza - è il conseguimento di un orizzonte antidottrinario (un po’ come il nostro Eugenio Montale) sono state le cifre uniche della sua attività di letterato tout-court.
 Autore di autentici best-seller poetici (A Coney Island of the Mind è stato tradotto in nove lingue) ma anche romanzeschi (ha scritto due novels), amico di Fernarda Pivano che fu anche sua traduttrice, Ferlinghetti è stato variamente tradotto nel nostro Paese: una ventina di titoli in tutto, tra i quali ricordiamo almeno Scene italiane. Poesie inedite (Minimum Fax, 1995), L’amore nei giorni della rabbia (Mondadori, 1999), Il lume non spento (Interlinea, 2008) e la raccolta antologica Poesie (Guanda, 2005).
Autore di autentici best-seller poetici (A Coney Island of the Mind è stato tradotto in nove lingue) ma anche romanzeschi (ha scritto due novels), amico di Fernarda Pivano che fu anche sua traduttrice, Ferlinghetti è stato variamente tradotto nel nostro Paese: una ventina di titoli in tutto, tra i quali ricordiamo almeno Scene italiane. Poesie inedite (Minimum Fax, 1995), L’amore nei giorni della rabbia (Mondadori, 1999), Il lume non spento (Interlinea, 2008) e la raccolta antologica Poesie (Guanda, 2005).
 La sua fortuna non ha subito punti opachi e c’è da credere seriamente che l’opera non scompaia con il personaggio. Soprattutto se i versi sono di questo tenore: «Un sole che tramonta / tiene a bada la notte / tutto questo sospeso nel tempo / l’universo trattiene il suo respiro / c’è silenzio nell’aria / la vita pulsa ovunque / la cosa chiamata morte non esiste».
La sua fortuna non ha subito punti opachi e c’è da credere seriamente che l’opera non scompaia con il personaggio. Soprattutto se i versi sono di questo tenore: «Un sole che tramonta / tiene a bada la notte / tutto questo sospeso nel tempo / l’universo trattiene il suo respiro / c’è silenzio nell’aria / la vita pulsa ovunque / la cosa chiamata morte non esiste».
-
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- i quanti, l’epistemologia e l’interdisciplinarietà. Recensione di "Helgoland" (di G. Mattana).2 gennaio 2021, di Federico La Sala
ROVELLI - i quanti, l’epistemologia e l’interdisciplinarietà
- Helgoland
- Autore: Carlo Rovelli
- Edizioni: Adelphi
- Anno: 2020
di Giorgio Mattana *
“E pensare che oggi qualcuno vede scienze naturali, scienze umane e letteratura come ambiti impermeabili l’uno all’altro ...” (p. 127). Helgoland è un appassionante libretto in cui il fisico Carlo Rovelli espone con leggerezza, adottando la forma del racconto scientifico-filosofico, la sua interpretazione “relazionale” della meccanica quantistica, nonché la visione del mondo a suo avviso più coerente con essa. Nel 1925 il giovane Werner Heisenberg, sulla sperduta isoletta del Mare del Nord Helgoland, detta anche Isola Sacra, in una sorta di ritiro spirituale, concepisce la teoria dei quanti. A definirne il formalismo matematico contribuiranno altri giovani scienziati: Pascual Jordan, Paul Dirac e Wolfgang Pauli. Max Born, quarantenne, è il più anziano del gruppo. Alcuni la chiamano “la fisica dei ragazzi”, ma è una svolta epocale. Si uniranno poi all’impresa Ervin Schrödinger, Louis de Broglie e altri. Padri spirituali ne sono a vario titolo Max Planck, con la sua fondamentale costante, Niels Bohr con il suo modello dell’atomo, e Albert Einstein, che peraltro non ne accetta le implicazioni indeterministiche, con l’idea dei “quanti” di energia.
La teoria dà conto in modo mirabile di una serie di sconcertanti risultati sperimentali che tormentavano i fisici del primo Novecento, ma scuote al tempo stesso dalle fondamenta l’immagine scientifica del mondo. Ancora più della relatività generale di Einstein, che modificava radicalmente la concezione dello spazio e del tempo della meccanica newtoniana e del senso comune, rendendoli dipendenti da masse e movimenti e fra loro inscindibilmente interconnessi.
 Il principio di indeterminazione di Heisenberg, che stabilisce l’impossibilità di accertare contemporaneamente la posizione e la velocità di un elettrone, variabili che nel mondo macroscopico permettono di calcolare la traiettoria di ogni corpo in movimento, sfidava le basi della fisica classica, nella quale Rovelli sembra a tratti includere la stessa relatività, al fine di sottolineare la sconvolgente novità dell’immagine della natura riflessa dalla meccanica quantistica.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg, che stabilisce l’impossibilità di accertare contemporaneamente la posizione e la velocità di un elettrone, variabili che nel mondo macroscopico permettono di calcolare la traiettoria di ogni corpo in movimento, sfidava le basi della fisica classica, nella quale Rovelli sembra a tratti includere la stessa relatività, al fine di sottolineare la sconvolgente novità dell’immagine della natura riflessa dalla meccanica quantistica.La peculiarità del testo non risiede tuttavia nella brillante esposizione dei caposaldi della teoria, già oggetto di numerose trattazioni divulgative incluse quelle dello stesso Rovelli, ma nell’illustrazione della sua interpretazione “relazionale” e delle sue più significative ricadute filosofiche e interdisciplinari. Il principio di indeterminazione, la misteriosa costante di Planck, l’effetto fotoelettrico, la sovrapposizione quantistica illustrata dall’apologo di Schrödinger del gatto sveglio/addormentato, che Rovelli sostituisce a quello vivo/morto, lo sconcertante fenomeno dell’entanglement, per cui due particelle venute a contatto nel passato mantengono una sorta di legame reciproco anche a migliaia di chilometri di distanza, ci fanno gettare lo sguardo su un abisso dove la realtà ordinariamente intesa scompare. Il mondo della fisica classica, erede del meccanicismo settecentesco, fatto di materia e movimento, viene soppiantato da un mondo di relazioni e di eventi che prende forma dalle fondamentali intuizioni di Heinsenberg sulla fisica degli “osservabili”.
Perché cercare di capire cosa fa l’elettrone, e con esso tutte le altre particelle della fisica subatomica, quando non lo osserviamo? E se l’elettrone non seguisse alcuna orbita? E se prendesse forma, assumesse questa o quella caratteristica, per esempio emettere luce, solo nell’interazione con noi? Quello che si profila è un radicale mutamento di paradigma scientifico-filosofico, una nuova visione della natura basata sulla considerazione che l’interazione fra osservatore e osservato codificata da Heisenberg è la regola, non l’eccezione.
 Nulla esiste in assoluto, tutto è in relazione a qualcosa, proprio come l’elettrone esiste nella relazione con noi e assume interagendo con i nostri strumenti di misura posizione, velocità o energia. Non esiste un elettrone “in sé”, con una sua orbita definita che non riusciamo a cogliere per l’imperfezione del nostro sistema osservativo. Non esiste una natura popolata di oggetti con proprietà assolute, nulla esiste in “sdegnoso” isolamento: tutto è in relazione ad altro, tutto interagisce con altro, tutto è in relazione con tutto. Il sasso è in relazione con il suolo a cui si “manifesta” con il suo peso, la velocità è sempre in relazione al sistema di riferimento, l’alto e il basso esistono solo in relazione alla superficie terrestre. È un’ontologia di relazioni, di cui gli oggetti rappresentano i “nodi”, di sistemi fisici che si rispecchiano gli uni negli altri. E tali relazioni non poggiano su nulla di solido, come stabiliva la fisica della materia e del movimento, delle qualità primarie oggettive in sé esistenti e di quelle secondarie. La grammatica del mondo scoperta dalla fisica quantistica non è costituita da semplice materia e movimento. “La relazionalità che permea il mondo scende fino a questa grammatica elementare. Non possiamo descrivere nessuna entità elementare se non nel contesto di ciò con cui è in interazione” (148).
Nulla esiste in assoluto, tutto è in relazione a qualcosa, proprio come l’elettrone esiste nella relazione con noi e assume interagendo con i nostri strumenti di misura posizione, velocità o energia. Non esiste un elettrone “in sé”, con una sua orbita definita che non riusciamo a cogliere per l’imperfezione del nostro sistema osservativo. Non esiste una natura popolata di oggetti con proprietà assolute, nulla esiste in “sdegnoso” isolamento: tutto è in relazione ad altro, tutto interagisce con altro, tutto è in relazione con tutto. Il sasso è in relazione con il suolo a cui si “manifesta” con il suo peso, la velocità è sempre in relazione al sistema di riferimento, l’alto e il basso esistono solo in relazione alla superficie terrestre. È un’ontologia di relazioni, di cui gli oggetti rappresentano i “nodi”, di sistemi fisici che si rispecchiano gli uni negli altri. E tali relazioni non poggiano su nulla di solido, come stabiliva la fisica della materia e del movimento, delle qualità primarie oggettive in sé esistenti e di quelle secondarie. La grammatica del mondo scoperta dalla fisica quantistica non è costituita da semplice materia e movimento. “La relazionalità che permea il mondo scende fino a questa grammatica elementare. Non possiamo descrivere nessuna entità elementare se non nel contesto di ciò con cui è in interazione” (148).Dietro la fisica degli “osservabili” di Heisenberg c’è Ernst Mach, profondamente influenzato dalla lezione humeana, che ha proposto l’empiriocriticismo come la cornice concettuale più adatta a inquadrare l’impresa conoscitiva umana, successivamente adottata dai neopositivisti del Circolo di Vienna. Dell’epistemologia machiana, anche detta fenomenismo, Rovelli sottolinea lo spirito antimetafisico, la scrupolosa aderenza ai dati dell’esperienza e lo smascheramento degli errori e dei paradossi connessi al bisogno di oltrepassarli postulando un mondo di oggetti, cose o enti sussistenti in modo assoluto e dotati di proprietà definite una volta per tutte. Contro Mach si era scagliato Lenin in nome del materialismo attaccandone il portavoce russo Bogdanov, ma dalla disamina di Rovelli è il materialismo che esce sconfitto, in quanto rappresentante della vecchia metafisica, non diversamente dalle idee platoniche e dallo spirito assoluto di Hegel.
L’empiriocriticismo machiano si presta invece ottimamente a fare da sfondo a quel mutamento di paradigma (Kuhn) o a quella rottura epistemologica (Bachelard) che ci propone la meccanica quantistica. La teoria più strana, controintuitiva e sconvolgente che sia mai stata concepita, ma anche la più riccamente confermata: “non ha mai sbagliato”. Non si dimentichi che a non essere prevedibile è il comportamento della singola particella, che le sue leggi sono probabilistiche e che in quanto tali sono state sempre confermate, per non dire delle loro innumerevoli applicazioni tecnologiche. Da essa Rovelli deriva una visione più “leggera” della natura, come trama di relazioni e gioco di specchi, priva di un fondamento assoluto e di un punto di vista privilegiato, così nuova da chiamare in causa un pensiero ancora più radicale e “altro” di quello machiano. La dottrina di Nāgārjuna, pensatore indiano del secondo secolo, asserisce esplicitamente “che non ci sono cose che hanno esistenza in sé, indipendentemente da altro” (p. 150). L’assenza di esistenza indipendente è “vacuità”: “le cose sono vuote nel senso che non hanno realtà autonoma, esistono grazie a, in funzione di, rispetto a, dalla prospettiva di qualcosa d’altro” (p. 151). “La lunga ricerca della ‘sostanza ultima’ della fisica, passata attraverso materia, molecole, atomi, campi, particelle elementari ... è naufragata nella complessità relazionale della teoria quantistica dei campi e della relatività generale” (p. 153).
Le ricadute interdisciplinari dell’interpretazione della realtà proposta da Rovelli sono facilmente intuibili, sia a livello generale sia per quanto riguarda la psicoanalisi, dove non può non trarne alimento la concezione relazionale della mente affermatasi negli ultimi decenni. L’evoluzione della teoria da un modello strettamente unipersonale verso modelli sempre più caratterizzati in senso relazionale, dalla concezione kleiniana delle relazioni oggettuali, alla visione winnicottiana della relazione madre-bambino, al modello bioniano della rêverie e della relazione contenitore-contenuto, fino alla teoria del campo e ai modelli intersoggettivisti e relazionali, sembra ormai un fatto acquisito. Come in fisica il mondo degli oggetti si stempera in un più fluido e cangiante mondo dove la lama di un coltello assomiglia alla spumeggiante cresta di un’onda dell’oceano, dove le cose si palesano le une alle altre nell’interazione, proprio come all’osservatore umano, così in psicoanalisi l’osservazione della mente in interazione con un’altra mente ne ha evidenziato le caratteristiche relazionali. E come non ha senso parlare in assoluto delle proprietà di un oggetto, così non ha senso parlare di un soggetto che non sia in relazione con altri soggetti che ne riflettono l’immagine e ne vengono riflessi, in una complessa trama di relazioni di cui rappresentano i nodi.
Si potrebbe addirittura ipotizzare che l’evoluzione relazionale della psicoanalisi sia consistita nell’abbandonare l’implicito isomorfismo con il mondo della fisica classica, popolato di oggetti, cose o enti concepiti come in sé conclusi e privi di relazione ad altro, per approdare a una visione più fluida, molteplice e interattiva della soggettività, sempre legata a una complessa e mutevole rete di relazioni esterne e interne. Ma l’utilità del punto di vista relazionale riguarda anche il rapporto della psicoanalisi con le altre discipline, riecheggiando le più condivisibili acquisizioni postmoderne sul carattere prospettico e contestuale di ogni attività conoscitiva, senza assecondarne le più radicali e discutibili derive scettiche e nichiliste. Si tratta di una visione relativa e complessa della conoscenza, basata sul lutto della verità unica e della spiegazione definitiva, ma compatibile con l’esistenza di specifici criteri di referenzialità e validazione all’interno di ogni disciplina. La congruenza fra metodo e oggetto permette di vedere la psicoanalisi come una disciplina caratterizzata da uno specifico metodo di indagine e da un altrettanto specifico sistema concettuale e linguistico, adeguati alla conoscenza di un determinato oggetto e irriducibili ad altri metodi e sistemi. Su questa base essa può dialogare con le altre discipline nella consapevolezza della relatività delle proprie conoscenze, ma anche della loro irriducibilità a quelle delle altre scienze, alla ricerca di una descrizione sempre più articolata, complessa e verosimilmente mai definitiva del soggetto umano.
*Fonte: Spi-Web, 12 Novembre 2020
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- Michelangelo una volta suggerì a un suo apprendista: di partire sempre da una figura piramidale entro cui moltiplicare la forma di un serpente “per uno, due, tre” (di A. Massarenti).19 dicembre 2020, di Federico La Sala
William Hogarth
 L’analisi della Bellezza
L’analisi della Bellezza
 a cura di C. Maria Laudando, presentazione di Laura Di Michele
a cura di C. Maria Laudando, presentazione di Laura Di Michele
 pagine 168+2 tavole f. t., euro 20,00, seconda edizione, ISBN 978-88-7726-043-7
pagine 168+2 tavole f. t., euro 20,00, seconda edizione, ISBN 978-88-7726-043-7
 Aesthetica Edizioni Palermo, 2002*
Aesthetica Edizioni Palermo, 2002*William Hogarth (1697-1764), pittore e incisore, autore celebre di stampe satiriche, dipinti di "storia comica" e "moderni soggetti morali", è uno dei più affascinanti rappresentanti della cultura artistica del Settecento. Irrompe sulla scena inglese ed europea, tra il tardo barocco e l’incipiente neoclassico, per smantellare i vecchi confini del "buon gusto" e i canoni classici della bellezza, e fissare con audaci sperimentazioni i nuovi valori della modernità.
Non meno spregiudicato del suo lavoro artistico, in simbiosi con la polemica del suo lavoro artistico, è il saggio L’analisi della Bellezza (1753), singolarissimo classico dell’estetica moderna.
Singolarissimo perché, mettendo in campo competenze uniche, dal basso, Hogarth decostruisce i modelli teorici che la tradizione aveva assegnato al concetto del bello e li sostituisce con gli esiti di una originale analisi formale, che pone la sua cifra dirompente nella sinuosa fluidità della linea serpentina, da lui rappresentata nello stesso frontespizio del volume.
 Testo densissimo di spunti e temi precorritori e tutt’ora vitali (insieme alla concezione dinamica ed organica della forma, l’idea di un sistema grammaticale delle arti visive, le osservazioni sottilissime sul brutto e sul comico...), coniuga felicemente teoria e pratica, affidando la propria validazione a centinaia di icone esemplificatrici, racchiuse con strabiliante maestria in due illustrazioni (La fabbrica delle statue di Cheere e Danza nuziale), qui riprodotte in una tasca esterna.
Testo densissimo di spunti e temi precorritori e tutt’ora vitali (insieme alla concezione dinamica ed organica della forma, l’idea di un sistema grammaticale delle arti visive, le osservazioni sottilissime sul brutto e sul comico...), coniuga felicemente teoria e pratica, affidando la propria validazione a centinaia di icone esemplificatrici, racchiuse con strabiliante maestria in due illustrazioni (La fabbrica delle statue di Cheere e Danza nuziale), qui riprodotte in una tasca esterna.Non stupisce allora il grande influsso esercitato da Hogarth nella costruzione dell’estetica moderna e il favore costante tributatogli da generazioni di studiosi, da Burke a Swift a Sterne a Walpole e Dickens, da Goethe a Lessing e da Diderot a Baudelaire, fino ai nostri giorni, ai Fry, Antal, Gombrich, Argan...
Quest’opera cruciale, non più resa in italiano dopo la sua traduzione settecentesca (1761), viene ora presentata con la puntuale cura di Maria C. Laudando e la limpida presentazione di Laura Di Michele, corredata di esaustivi apparati esegetici, critici e bibliografici.
* Fonte: Aesthetica Edizioni Palermo.
Hogarth, la Bellezza colta in una linea
di Armando Massarenti *
- William Hogarth, L’analisi della Bellezza. Scritta con l’intenzione di fissare le fluttuanti idee del Gusto, trad. it. a c. di C. Caria Laudando, Aesthetica, Palermo 1999
L’analisi della Bellezza di William Hogarth nasce da una sfida e da una provocazione. Nel 1745 il pittore inglese pubblicò nel frontespizio di una raccolta di incisioni un autoritratto ponendovi, in basso, una tavolozza con sopra disegnata una linea, elegante e inusuale, definita senza spiegazioni “La Linea della Bellezza e della Grazia”. L’esca funzionò - racconta lo stesso Hogarth - e “più di qualunque geroglifico egiziano” divertì pittori e scultori che andavano da lui per chiedergli che cosa diavolo significasse. Solo dopo qualche spiegazione alcuni “si resero conto che si trattava di una loro vecchia conoscenza”, e che di tale “linea serpentina”, fonte di ogni bellezza, avevano già parlato, o vi avevano alluso, autori di trattati sulla pittura e di vite di pittori.
Paolo Lomazzo, ad esempio, riferiva ciò che Michelangelo una volta suggerì a un suo apprendista: di partire sempre da una figura piramidale entro cui moltiplicare la forma di un serpente “per uno, due, tre”. “Nel quale precetto - commentava Lomazzo - consiste tutto il mistero dell’arte”. La “somma grazia e vita”, lo “spirito di un quadro”, dipende infatti dalla sua capacità di esprimere il movimento, e niente è più adatto a questo scopo di quella linea già presente in natura nella “fiamma del fuoco”.
Sulla “grazia” espressa dalle linee ondeggianti avevano insistito anche Du Fresnoy, in un altro trattato di pittura, e De Piles, nelle sue vite di pittori. Soltanto che - lamenta Hogarth - per rendere conto di tale grazia non trovavano di meglio che riferirsi a quel “non so che” divenuto allora di moda, che invece di aiutarci a capire le ragioni della bellezza la trasformavano in qualche cosa di misterioso e vago. Per non parlare degli “intenditori”, o dei copisti e degli imitatori di quadri e statue antiche, che in Inghilterra ai tempi di Hogarth andavano per la maggiore e contro i quali egli lancia le sue frecce più velenose, che recisamente negavano l’esistenza - in arte o in natura - di regole per la bellezza.
A tale scetticismo Hogarth rispose con L’analisi della Bellezza, pubblicata nel 1753, nel quale la sua “linea” appariva, insieme alla piramide, come l’elemento principale di un sistema basato su un’idea, dialettica e piena di tensioni, di “varietà”, “intrigo” e “movimento” (contrapposta ai “pregiudizi” correnti della semplicità, della simmetria e della staticità).
Il risultato è un libro unico nel suo genere, ingiustamente trascurato dalle storie dell’estetica, forse a causa della sua difficile collocazione letteraria: trattato di pittura e di scultura, ad uso di apprendisti e artisti, ricchissimo di trucchi del mestiere che ogni vero artista (al contrario dei “copisti” e degli “intenditori”, che Hogarth dispera di convincere) dovrebbero conoscere, ma anche - illuministicamente e democraticamente - manuale per chiunque, esperto o no, voglia imparare a cogliere (o creare), imparando a “vederla con i propri occhi”, la bellezza di ciò che lo circonda. Tutto ciò è intrecciato a un continuo riferimento alle modalità del nostro sistema visivo, attraverso il quale Hogarth anticipa, almeno nello spirito, le analisi percettologiche e di psicologia della visione di questo secolo di un Arnheim o di un Gregory.
La sua è una ricerca che oggi potrebbe piacere ai fenomenologi (visto il rifiuto di sovrapporre al fenomeno della percezione della bellezza sovrastrutture filosofiche o metafisiche) e ai filosofi analitici, non solo perché la parola “analisi” è presente fin nel titolo, ma anche per la capacità di aggredire direttamente, senza troppe mediazioni storiche, un problema che è insieme pratico e filosofico. Che è quello del sottotitolo: come fissare in poche regole comprensibili, prive di allusioni “misteriose”, “le fluttuanti idee del Gusto”?
Il testo di Hogarth è un intrico splendidamente congegnato, una specie di gioco, pieno di ironia, di cattiverie e di sorprese, che si dispiega attraverso i continui rimandi alle due splendide tavole che lo accompagnano.
Merito della nuova edizione, che sarà a giorni in libreria per le edizioni di Aesthetica (la precedente traduzione italiana, riproposta dieci anni fa dalle edizioni SE, risaliva al ’700), è anche quello di renderne agevole la visione durante la lettura, proponendole fuori testo in una tasca esterna del libro.
Nella prima tavola Hogarth riproduce la maggior parte delle sculture, copie di statue famose dell’antichità (fig. 2), di cui erano pieni i giardini e le case aristocratiche inglesi (nelle quali, anche per quel che riguarda i quadri, si privilegiavano le copie dei classici rispetto alle opere originali dei pittori inglesi contemporanei). Nella seconda invece, a mo’ di applicazione dei principi ricavati dalla prima, propone una sua incisione, un ballo nella casa di campagna di un nobile, nella quale convivono il leggiadro e - per contrasto rispetto alle stesse regole da lui esposte sulla bellezza - il grottesco, il parodistico e l’ironico, di cui com’è noto egli era maestro (fig, 3).
Sulle pareti vi è una quadreria che rispecchia i gusti della committenza aristocratica del tempo della quale Hogarth mette alla berlina il cattivo gusto e l’idea statica e ingessata di bellezza cui essa, senza neppure rendersene conto, faceva riferimento. La cornice delle due stampe presenta, in una disposizione che ricorda le regole della mnemotecnica, una miriade di esemplificazioni - volti, candelabri, girarrosti, figure geometriche, sezioni anatomiche ecc. - attraverso le quali Hogarth spiega le sue regole apparentemente semplici, ma ricche di implicazioni sorprendenti e tutte legate a un gusto che fuoriesce dalle stanze chiuse dell’aristocrazia per aprirsi alla vita della città, a una committenza più vasta, al nuovo spirito borghese e alla nuova esigenza di legare il fare artistico-estetico alla produzione industriale e agli oggetti di uso quotidiano. Una ragione in più per riscoprire oggi questo formidabile saggio.
*FONTE: IL SOLE-24 ORE, 04.04.1999 (RIPRESA PARZIALE SENZA IMMAGINI).
-
> "Note per una epistemologia genesica" --- Fisica e Filosofia. Note a margine di “In principio è la relazione: la meccanica quantistica di Carlo Rovelli” (di Emilia Margoni - "Le parole e le cose").25 novembre 2020, di Federico La Sala
LE PAROLE E LE COSE:
"IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS" O IL "LOGO"?! Una questione antropo-logica! *
- Nota a margine dell’articolo di Emilia Margoni, “In principio è la relazione: la meccanica quantistica di Carlo Rovelli” (Le parole e le cose, 17 novembre 2020)
Riprendendo il filo del discorso dalla “Storia universale della natura e teoria del cielo” e dalla "Critica della ragion pura" di Kant, forse, è possibile comprendere che la proposta di interpretazione della meccanica quantistica di Carlo Rovelli è "un’idea della fisica assai lontana da quella boriosa “teoria del tutto” con cui alcuni fisici contemporanei intendono mettere un punto alla storia millenaria della riflessione umana" (Emilia Margoni - cit.).
Anzi, ripensando a Kant e, al contempo, accolta "l’ipotesi che Gesù conoscesse benissimo la meccanica quantistica" (Giovanni Megna - cit.) e ricordate le parole di Ponzio Pilato proprio su Gesù ( «Ecco l’uomo» gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»), si potrebbe riguardare (ripensando meglio anche la "critica dell’economia politica") tutta la questione proprio dalla "quarta" domanda della "Logica" di Kant - quella antropologica!
"Chi abbia avuto la pazienza di giungere sin qui si starà forse chiedendo cosa l’interpretazione relazionale abbia da dire sul destino del gatto nella scatola" (Emilia Margoni - cit.): detto altrimenti, la questione antropologica ("in principio è la relazione" della meccanica ... "andrologica" e "ginecologica") è la questione più importante, rispetto a quella etica, metafisica, e religiosa.
"Come nascono i bambini?" (ricordare non solo Alfred N. Whitehead ma anche Enzo Paci e il suo "relazionismo"). Dopo Copernico, Keplero, Galileo, Newton, Kant, Freud, Einstein, è ancora tanto difficile allontanarsi da "mammona" e uscire dallo "stato di minorità" ?! Boh e bah?!
*
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- TUNNEL QUANTISTICI. Atomi o particelle elementari in grado di muoversi a velocità superiori a quella della luce? (di Natalie Wolchover/ Quanta Magazine).2 novembre 2020, di Federico La Sala
Tunnel quantistici per superare la velocità della luce
di Natalie Wolchover/ Quanta Magazine *
- [Foto] Simulazione al computer di una funzione d’onda intrappolata in una barriera (© Science Photo Library/AGF)
Recenti esperimenti suggeriscono che quando atomi o particelle elementari superano una barriera di potenziale a causa dell’effetto tunnel - uno dei fenomeni più bizzarri, e utili, della meccanica quantistica - potrebbero essere in grado di muoversi a velocità superiori a quella della luce. Tuttavia, le condizioni in cui questo avviene farebbero evitare i paradossi previsti dalla relatività di Einstein [...]
*
Fonte: Le Scienze, 02.11.2020
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- HELGOLAND. Capire il mondo con la fisica quantistica (di Pietro Greco).5 ottobre 2020, di Federico La Sala
Capire il mondo con la fisica quantistica
di Pietro Greco *
Helgoland, il nuovo libro che Carlo Rovelli ha pubblicato con Adelphi (pag. 230, euro 15,00), è forse anche il più ambizioso scritto dal fisico teorico esperto di loop quantum gravity che si divide tra la Francia e il Canada. Pensate: il suo obiettivo è far sì che tutti - ma proprio tutti, fisici e poeti, filosofi e cittadini comuni - discutano dei fondamenti della meccanica quantistica, la teoria fisica più fondamentale, più precisa e, insieme, più bizzarra che loro, i fisici, abbiano mai elaborato.
Il libro parte da un’isola tedesca, Helgoland, appollaiata nella parte meridionale del Mare del Nord: una dimensione geografica che sembra contenere in sé un’ambiguità. In quest’isola nel 1925 un ragazzo tedesco di 23 anni, Werner Heisenberg, inventa la meccanica quantistica. Il che significa che dà, finalmente, una veste formale, matematizzata, alla fisica dei quanti. Che già vanta tre padri fondatori - Max Planck, Albert Einstein e Niels Bohr - e alcuni tratti che sconcertano i fisici.
Era stato Max Planck il primo, nell’anno 1900, a scoprire i quanti. O meglio, il quanto elementare d’azione, che scardinava il concetto di continuo in fisica: l’energia non si trasmette con continuità, ma mediante pacchetti discreti. Per quanti, appunto. La cosa era talmente sconcertante che lui stesso, Max Planck, non ci voleva credere. Pensava di aver scoperto un mero artificio matematico capace di venire a capo di un problema di poco conto e, invece, aveva realizzato una delle scoperte più importante nella storia della fisica e, quindi, del pensiero umano.
Erano poi passati cinque anni quando un altro tedesco, un semplice e giovane impiegato dell’Ufficio Brevetti di Berna, aveva realizzato un’altra scoperta fondamentale: “i quanti di luce”. Oggi li chiamiamo fotoni. Non solo la luce (anche la luce) procede per pacchetti discreti, ma questi pacchetti hanno una duplice natura: di onda e di corpuscolo. E ora manifestano l’una ora manifestano l’altra natura: Il trionfo dell’ambiguità.
Passa ancora qualche anno e il terzo, il danese Niels Bohr, propone che gli elettroni si muovano intorno al nucleo degli atomi seguendo orbite discrete, non una qualsiasi traiettoria. Un ulteriore trionfo della discontinuità in natura accompagnata da un altro fatto sconcertante: gli elettroni possono saltare da un’orbita all’altra istantaneamente, senza che sia possibile seguirne la traiettoria. Semplicemente perché non c’è traiettoria. È come se la Terra potesse muoversi intorno al Sole solo descrivendo la sua attuale traiettoria o quella di Marte o quella di Giove, ma nessun’orbita intermedia. Non solo: è come se la Terra potesse saltare istantaneamente dalla sua orbita a quella di Marte e poi di Giove senza seguire alcun percorso.
Già questi tra mattoni fondamentali della fisica dei quanti creano non pochi problemi a chi crede nella continuità e nella causalità dei fenomeni fisici: ovvero in tutti i fisici del tempo.
Le novità, negli anni della “fisica quantistica antica” non mancano e vanno oltre quelle proposte da Planck, Einstein e Bohr. Emerge, forte, la necessità di mettere ordine, ovvero di formalizzare in termini matematici tutte queste stranezze. È quello che fa Werner Heisenberg nel suo solitario soggiorno a Helgoland nel 1925.
 La formalizzazione è ben strana: intanto perché fa uso di una matematica, quella delle matrici, piuttosto particolare. Ma anche perché spazza via il concetto di visualizzabilità in fisica: è inutile che io cerchi di avere un’immagine tangibile dei microscopici oggetti quantistici, io posso parlare solo degli osservabili, delle cose che posso misurare. Quindi è inutile chiedersi dove sia la Terra quantistica mentre “salta” nell’orbita di Marte, che percorso segua e persino quanto tempo impieghi. Quello che posso dire è solo che ho verificato che la Terra prima era nella sua orbita e poi la trovo nell’orbita di Marte.
La formalizzazione è ben strana: intanto perché fa uso di una matematica, quella delle matrici, piuttosto particolare. Ma anche perché spazza via il concetto di visualizzabilità in fisica: è inutile che io cerchi di avere un’immagine tangibile dei microscopici oggetti quantistici, io posso parlare solo degli osservabili, delle cose che posso misurare. Quindi è inutile chiedersi dove sia la Terra quantistica mentre “salta” nell’orbita di Marte, che percorso segua e persino quanto tempo impieghi. Quello che posso dire è solo che ho verificato che la Terra prima era nella sua orbita e poi la trovo nell’orbita di Marte.Inaccettabile, per molti fisici.
Ecco, però, intervenire un altro fisico, l’austriaco Erwin Schrödinger, ed elaborare un’equazione - ancora oggi nota come equazione d’onda di Schrödinger - che descrive un oggetto quantistico come un’onda, appunto. Almeno la visualizzabilità ma in qualche modo anche la continuità sembrano recuperate. Non dura molto, il maestro di Heisenberg, il tedesco Max Born, insieme al suo al suo allievo Pascual Jordan, dimostrano che quella di Schrödinger non è la funzione di un’onda, ma è una funzione di probabilità. Non ci dice dove sta, in ogni istante, la Terra quantistica, ma qual è la probabilità che io la trovi in un certo punto. È come dire che un elettrone posso trovarlo in un certo istante in orbita intorno a un nucleo, in orbita intorno a un altro nucleo, al bar di Alfredo o su un’altra galassia. Tutto quello che posso dire apriori è la probabilità, senza dubbio diversa, che lo trovi in un dato istante intorno al suo nucleo, al nucleo di un atomo vicino, al bar di Alfredo o di un’altra galassia.
Aggiungete a questo che nel 1927 lo stesso Werner Heisenberg elabora il “principio di indeterminazione”: non solo non posso conoscere con precisione la posizione e la velocità con cui si muove quell’elettrone, ma se aumento la precisione con cui misuro la posizione perdo informazione sulla velocità e viceversa. Il che significa, scrive lo stesso Heisenberg, che il determinismo in fisica è finito, non perché io non posso conoscere con precisione assoluta il futuro - come poteva fare l’intelligenza evocata a inizio Ottocento da Pierre Simon de Laplace nel suo “manifesto del determinismo” - ma perché non possono conoscere con precisione assoluta il presente.
Fermiamoci qui. In quei turbinosi anni ’20 del XX secolo. la fisica mette in discussione tra concetti che non sono solo suoi, ma anche della filosofia e persino del senso comune: la continuità dell’azione, la causalità rigorosa, la stessa realtà. Di più: propone l’azione a distanza tra oggetti quantistici correlati. Cosa significa? Mettiamo che io e il mio gemello abbiamo l’obbligo di indossare calzini di colori diversi. Se io indosso calzini bianchi, lui deve indossare calzini rossi. Se io sto sulla Terra e indosso i calzini rossi mentre lui si è spostato dall’altra parte della nostra galassia, il mio gemello potrà ottemperare al suo obbligo solo dopo aver avuto notizia della mia decisione: almeno centomila anni dopo (le notizie possono viaggiare alla velocità della luce). Ma se io sono un oggetto quantistico e “decido” di indossare calzini bianchi, istantaneamente, fosse pure dall’altra parte della galassia, il mio gemello indosserà calzini rossi.
Se vi si confonde la testa non preoccupatevi, succede anche ai fisici. Che si dividono subito in due scuole: quella di Bohr e di moltissimi altri (Heisenberg compreso) che dicono: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole così è e più non dimandare; e quella che fa capo ad Albert Einstein (e a Schrödinger) che dicono, ok la meccanica quantistica funziona, ma ci devono essere delle variabili nascoste che possono rendere più “realista”, mano bizzarra la teoria.
La fortuna della prima interpretazione - detta “di Copenaghen” - è che è fatta propria dalla gran parte di chi occupa una cattedra di ordinario nei dipartimenti di fisica. Ma negli anni ’50 del secolo scorso ecco che prima Louis de Broglie poi, soprattutto, David Bohm mettono a punto una “teoria dalle variabili nascoste” che funzione bene proprio come l’interpretazione cara a “quelli di Copenaghen”.
 Chi ha ragione?
Chi ha ragione?Passano non molti anni e l’irlandese John Bell dimostra che la teoria “realista” della meccanica quantistica può funzionare e restituirci almeno l’idea di una realtà oggettiva del mondo che non dipende dalla misura di un fisico, a patto che si accetti l’azione istantanea a distanza, perché le connessioni tra particelle quantistiche esistono, sono stati empiricamente dimostrate, e vengono chiamate entanglement.
Resta il problema micro-macro: perché e quand’è che degli oggetti cessano di comportarsi nel modo quantistico assurdo e si comportano come vediamo comportarsi gli oggetti nella nostra quotidianità?
 La fenomenologia macroscopica - rispondono tre italiani, Giancarlo Ghirardi, Alberto Rimini e Tullio Weber - è una proprietà emergente: quando abbiamo un numero congruo di oggetti quantistici, questi interagiscono e statisticamente si comportano come vuole la fisica classica.
La fenomenologia macroscopica - rispondono tre italiani, Giancarlo Ghirardi, Alberto Rimini e Tullio Weber - è una proprietà emergente: quando abbiamo un numero congruo di oggetti quantistici, questi interagiscono e statisticamente si comportano come vuole la fisica classica.Se continuate ad avere il mal di testa non vi preoccupate. La stessa sensazione ce l’hanno anche i più esperti tra i fisici. Anche perché il problema dell’interpretazione dei fenomeni quantistici è molto più complesso di quanto non vi abbiamo detto finora.
È un problema che ha, allo stato, molte proposte di soluzione. Nessuna definitiva.
 Tra queste c’è la meccanica quantistica relazionale, “inventata” proprio da Carlo Rovelli nel 1995 e poi ripresa da altri. L’idea di fondo è che non esiste nulla di assoluto in sé, né i corpuscoli né l’energia. Il mondo non è fatto di cose, ma piuttosto di relazioni. Esistono solo le relazioni tra le cose. Come sostiene Rovelli dobbiamo guardare alla realtà come a un’immagine riflessa in specchi che a loro volta si riflettono in altri specchi.
Tra queste c’è la meccanica quantistica relazionale, “inventata” proprio da Carlo Rovelli nel 1995 e poi ripresa da altri. L’idea di fondo è che non esiste nulla di assoluto in sé, né i corpuscoli né l’energia. Il mondo non è fatto di cose, ma piuttosto di relazioni. Esistono solo le relazioni tra le cose. Come sostiene Rovelli dobbiamo guardare alla realtà come a un’immagine riflessa in specchi che a loro volta si riflettono in altri specchi.Rovelli fonda la sua interpretazione della meccanica quantistica in questa prospettiva relazionale, che, ripetiamo, è una di quelle attualmente in campo per risolvere quello che Karl Popper chiamava “il gran pasticcio dei quanti”. Non sappiamo se avrà successo, certo è un’utilissima ipotesi di lavoro. Ma, in realtà, non sappiamo neppure se mai verremo a capo di tutti i problemi aperti dalla meccanica quantistica.
Ma quello che Carlo Rovelli ci propone nella seconda parte di Helgoland è qualcosa di più. Propone che tutti noi - fisici, filosofi, artisti, persone non esperte- assumiamo la prospettiva relazionale anche per interpretare il mondo, macroscopico, in cui viviamo. Anche in questo caso, anzi ancor più in questo caso, non sappiamo se quella proposta da Rovelli è la chiave giusta per capire il mondo. Non sappiamo se davvero tutto è solo relazione. E tuttavia il suo ambizioso progetto ci sembra convincente: tutti - fisici, filosofi, artisti, cittadini non esperti - possiamo e dobbiamo discutere dei fondamenti della fisica. Perché per capire il mondo non possiamo prescindere da essa, la meccanica dei quanti.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- "Quando all’uomo manca la terra sotto i piedi, diventa un essere libero". Intervista a Carlo Rovelli (di Nicola Mirenzi).4 ottobre 2020, di Federico La Sala
CULTURE
"Quando all’uomo manca la terra sotto i piedi, diventa un essere libero". Intervista a Carlo Rovelli
Il fisico, autore di Helgoland (Adelphi), all’Huffpost: "Ogni cosa esiste solo quando è in relazione. A prima vista, è una visione che fa venire le vertigini"
di Nicola Mirenzi (HUFFPOST, 04/10/2020)
Per prima cosa, il sapere per costruire distrugge: “La scoperta della fisica quantistica, all’inizio del secolo scorso, ha disintegrato il mondo che conoscevamo. La rivoluzione che ne è seguita ha aperto uno strappo nella realtà, frantumando la rappresentazione della natura che l’uomo si era fatto e dissolvendo l’idea che ci sia, almeno con gli atomi, o le particelle elementari, un punto fermo, una materia, seppur piccola, ferma e immutabile, qualcosa di solido a cui aggrapparsi. Ma non è così, anche le particelle elementari non sono che nodi di una rete di relazioni. Questo cambia il nostro modo di vedere il mondo e coinvolge tutta l’umanità, anche la parte dell’umanità che non ha idea di queste idee che nascono in quella porzione piccola della Terra che è l’Europa centrale”.
Mentre Carlo Rovelli - fisico teorico e scrittore di sfrenate avventure concettuali - racconta lo squarcio che la fisica contemporanea ha aperto nella mente dell’uomo contemporaneo, mi torna in mente il romanzo di Michel Houellebecq, Le particelle elementari, nel quale la scomposizione dell’atomo costituiva per Houellebecq il paradigma di un fenomeno più generale che aveva travolto e frantumato tutto il resto della vita contemporanea: la società, i legami, la famiglia, l’amore, il sesso, la fede, la ragione, i valori, tutto sfarinato, fino al punto di lasciare l’uomo solo, disperato, nella sua miseria.
“Detesto quel libro, come tutti gli altri libri di Houellebecq, perché lui gioca sporco. La fisica quantistica sfalda l’architettura del mondo così come l’uomo se l’era rappresentato, ma non distrugge le relazioni di cui è intessuta la realtà. Al contrario, ha scoperto che le cose vivono di connessioni, pervasive, legami estesi, ha mostrato che niente è concepibile di per sé: ogni cosa esiste in relazione a un’altra. La fisica quantistica, eventualmente, parla di una armonia nel mondo, non certo dell’abbattimento di ogni relazione”.
Nel suo ultimo libro, Helgoland (Adelphi), Carlo Rovelli si muove seguendo il secondo movimento del sapere: la ricostruzione. Dopo aver raccontato il prodigio e lo strappo della rivoluzione quantistica, compiendo ancora una volta - dopo Sette brevi lezioni di fisica e L’ordine del tempo - il miracolo di farla comprendere anche a chi come me non sa niente di fisica, Rovelli ne trae una prospettiva innovativa e globale, secondo la quale ogni elemento della realtà è intrecciato a molti altri, nella materia infinitamente piccola, in quella spaventosamente grande, ma anche nel mondo normale. A tutti i livelli, Rovelli mostra connessioni. Per esempio: quelle che ci sono tra le scoperte scientifiche, la letteratura, la poesia, la filosofia, la mistica, la religione, la politica. Di colpo, il mondo prende la forma di un tutt’uno, smettendo di essere diviso in discipline, oppure in monadi che siamo abituati a chiamare individui.
Non è una condanna non poter sfuggire alla relazione?
Perché dovrebbe?
Perché ci condanna a non poter essere più soli.
Anche quando siamo soli siamo in relazione: con i nostri pensieri, con un libro che stiamo leggendo, con l’aria che respiriamo, un film che stiamo guardando, siamo il relazione con la nostra memoria e la nostra immaginazione, con le idee che ci sono arrivate da altri. L’idea che nel mondo niente esista al di là della relazione non è una scoperta recente. La novità che introduce la lettura che io ritengo più coerente della fisica quantistica è che questa struttura di relazioni si estende fin nella profondità più estreme della natura, là dove la fisica classica individuava dei nuclei solidi, dei punti fermi. Le scoperte quantistiche dissolvono l’idea stessa della solidità, dimostrando che non esiste un realtà in sé, incontrovertibile, alla quale ci si possa ancorare. Ogni cosa esiste solo quando è in relazione. A prima vista, è una visione che fa venire le vertigini.
E poi?
Si prova un senso di libertà e di leggerezza, come quando Anassimandro capì che il cielo che è sopra di noi è anche sotto: all’inizio, all’uomo manca la terra sotto i piedi, poi impara a cambiare prospettiva e sentirsi libero di volare nel cosmo sul suo pianeta.
La conseguenza di quel che dice è che, se nulla esiste in sé, allora si disintegra anche l’idea di individuo.
Ci sono tanti filosofi già nel passato che hanno messo radicalmente in discussione la nozione di individuo. L’idea che noi esseri umani avremmo dentro un centro, un’essenza che ci fa esistere come entità, soggetti del pensiero, è fuorviante. Noi esistiamo come processi, siamo l’insieme delle cose che ci accadono, delle concatenazioni che si stabiliscono dentro di noi, tra noi e gli altri. Più che a un punto, assomigliamo alle nuvole, che si formano, si disfano, e si ricompongono.
Allora cos’è che fa di lei Carlo Rovelli e non un’altra persona?
Io sono il mio corpo: fatto di tanti organi in relazione tra loro che, muovendosi insieme, formano un’unità; sono la mia memoria: il racconto che faccio di me stesso, legando quello che è accaduto ieri a quello che mi accade oggi; sono i miei pensieri, che vengono dagli altri e passano attraverso di me. Sono l’immagine di me riflessa negli occhi di chi mi vuole bene. Sono tutto questo insieme di processi, a cui do il nome di Carlo.
Ma dove si trova il Carlo che dice io?
Da nessuna parte. L’avevano già argomentato filosofi diversissimi come Nietzsche e Mach, ed è un’idea esplicita in una parte del pensiero orientale.
Mi sta facendo girare la testa.
Pensi a una coppia di due persone che si amano. L’unione che hanno è reale. Entrambi riconoscono l’esistenza di un ‘noi’. Lo riconosce anche lo stato, se si sposano. Ma dove si trova questo ‘noi’? Come lo si può afferrare? La risposta è: da nessuna parte, è impossibile prenderlo. Esiste nella relazione. Senza i suoi componenti, si dissolve. Così è per l’io. Se lei toglie da me i miei pensieri, la mia memoria, i miei sentimenti, i miei organi, di me non rimane niente.
Dentro di lei, è rimasto qualcosa di sacro?
Tutto! Quando Spinoza identifica Dio con la Natura, sembra che stia uccidendo la sacralità, invece sta riconoscendo la sacralità della Natura. Io sono ateo, non credo nell’esistenza di un Dio persona, né all’anima immortale, alla vita dopo la morte, però non ho esitazione a sentire che la vita e la natura sono sacre. L’assenza di Dio non elimina il mistero, lo stupore, l’incanto, il valore, di trovarsi di fronte all’immensa vastità della natura, sia nella sua grandezza, sia nella sua piccolezza microscopica. Riconoscere il senso terribile del dolore, la gioia, l’amore. Le mie motivazioni nei confronti della materia che studio, per esempio, non sono dettate dalle formule che scrivo: vengono dalle emozioni che provo. Il mondo per noi è pieno di intensità, di valore. Non c’è niente di anti scientifico nel riconoscerlo. La cultura europea ha fatto un’enorme confusione. Ha creduto che, perso Dio, tutto perdesse senso e valore, e che l’umanità non potesse che precipitare in un nichilismo disperato. Che sciocchezza! La sacralità del mondo non risiede fuori di noi: è nella meraviglia, nell’emozione, nella sorpresa con cui guardiamo ciò che è intorno a noi, e nel valore che diamo alle cose. Tutto questo è reale e viene da dentro di noi, non da un ipotetico Dio che starebbe là fuori.
Nel suo libro la natura è ancora indomabile: perché?
L’idea che la scienza riguardi il dominio della natura è una presunzione degli scienziati convinti che ormai il più sia fatto, e dei filosofi - Heidegger in testa - che confondono la conoscenza scientifica con il dominio.
Cosa c’è di sbagliato? Il sapere non è potere?
Quello del potere è un concetto ambiguo: è il potere che consente a un capo di stato di uccidere e torturare, ed è potere anche la conoscenza che ha permesso all’uomo di guarire malattie che hanno ucciso centinaia di migliaia di persone prima di lui. Non c’è nulla di male nel mettersi nelle condizione di poter fare, anzi, è parte di noi il cercarlo.
Lei definisce la conoscenza un “miele velenoso”. Perché, allora, si è avvelenato?
Ho avuto un’adolescenza inquieta, come molti della mia generazione. Ho avuto voglia di conoscere il mondo, di attraversarlo, di contestarlo e anche di sovvertirlo. È dolce leggere, viaggiare, scoprire, essere curiosi, immaginare le cose come potrebbero essere altrimenti, ma può essere pericoloso. Io e la mia generazione abbiamo sognato di cambiare il mondo completamente, poi abbiamo scoperto a nostre spese che il mondo non aveva alcuna voglia di essere cambiato. Molti - schiantandosi contro la realtà - si sono fatti del male. Ho visto amici morire per strada, finire in carcere, consumati dall’eroina. Ne ho visto altri che hanno fatto cose splendide. Il miele e il veleno, appunto.
Allen Ginsberg che sapore aveva?
L’ho conosciuto al festival della poesia di Castel Porziano, nel 1978. Era un grande reading di poesia, con lo stile di un raduno rock. Si è sfaldato nella confusione. Da tutta Italia, erano arrivati gruppi di giovani di ogni tipo, e gli organizzatori si sono spaventati. A un certo punto, in un tentativo di sciogliere la confusione e la tensione, Ginsberg sul palco cominciò a salmodiare la sillaba sacra delle religioni orientali: Om. Io ero con lui, e mi sono trovato a salmodiare accanto a lui, con i capelli lunghi e una fascia rossa per tenerli.
La creatività nasce dal disordine?
La creatività è sempre la rottura di un ordine, e spesso nasce proprio da un momento di rottura, spesso si accende nella divagazione, quando ci si allontana dai pensieri consueti, quando ci si dimentica qualcosa. Heisenberg era andato sull’isola di Helgoland per alleviare un’allergia e lì ha avuto l’intuizione chiave della rivoluzione quantistica. Schrödinger ha trovato la sua famosa equazione durante una fuga d’amore segreta nelle Alpi con un’amica viennese. Ma prima della divagazione c’è un sempre lungo percorso di disciplina: uno studia, lavora, si concentra intensamente, poi, quando va a fare una passeggiata perché non ne può più, ha l’idea. Buddha passò anni a meditare, e ebbe l’illuminazione quando smise. Senza tutta la disciplina e il metodo precedente però non sarebbe arrivato lì.
Perché lei sottolinea sempre la bellezza e l’eleganza di una teoria, non basta che funzioni?
La bellezza è proprio nella sensazione di vedere una grande complessità ridursi dentro un’idea semplice capace di racchiuderla. Nel fatto che funziona. Nella fisica, la bellezza può essere il segno che si è sulla buona strada. Ma una teoria può anche essere bellissima ed essere sbagliata.
Cosa c’è di politico nella fisica quantistica?
Direttamente, niente. Indirettamente, tanto. La rivoluzione quantistica descrive un mondo di relazioni, in cui le cose esistono, si muovono e si accrescono solo se stanno insieme. È l’opzione politica della cooperazione, che è il contrario dell’idea della competizione, del prevalere. Cosa c’è di più politico di questo?
Ma l’idea che tutto è in relazione, non relativizza pericolosamente tutto?
No, perché? Anche quelli che consideriamo i punti fermi - per esempio, la dignità dell’uomo - sono nati da una discussione, un confronto, un’evoluzione, non sono stati calati dall’alto, basandosi su idee assolute. Confrontarsi non vuol dire che tutto è eguale. Al contrario, vuol dire cercare insieme la soluzione migliore, invece che pensare di averla già.
Ora, però, ci sono valori stabiliti, o no?
Ma sono sempre soggetti a discussione. E devono esserlo. Per essere concreti: consideriamo la discussione sull’epidemia in corso. Un principio ripetuto dice che è più importante salvare le vite che l’economia. Ma è davvero assoluto? Perché allora non vietiamo le automobili? Negli incidenti stradali, uccidono decine di migliaia di uomini, donne e bambini ogni anno. Vietarle salverebbe vite. I principi sono sempre in discussione. Niente è semplice. Quando parliamo di ricominciare il confinamento o no, stiamo misurando il prezzo di abbreviare la vita di qualcuno contro il benessere di molti, anche se non abbiamo il coraggio di dirlo apertamente. La complessità è inevitabile.
Il mondo è pronto a concepirsi come un tutt’uno?
La fisica quantistica è solo uno dei movimenti che spinge l’uomo a riconoscere la trama di relazioni senza le quali non esiste. La crisi ambientale ci porta a prendere sul serio il fatto che siamo parte della natura, per esempio. O, almeno, spero che ci porti a farlo, prima che sia troppo tardi.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE --- L’ ATTENZIONE E LA GIOIA DI APPRENDERE. L’intelligenza cresce e porta frutti solo nella gioia (di S. Weil)..19 luglio 2020, di Federico La Sala
L’ATTENZIONE SECONDO SIMONE WEIL *
- Simone Weil, unico grande spirito del nostro tempo secondo Albert Camus, si è espressa sull’attenzione, pratica attraverso cui raccogliere i frutti più profondi della nostra umanità. L’ha fatto nel suo modo incomparabile e con l’eleganza intellettuale che le appartiene: l’attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto.
- La sua vita è stata breve ma scandita da scelte radicali. Dopo la laurea alla Normale di Parigi ha insegnato in alcuni licei. Ma nel 1934, l’esigenza interiore di conoscere la “condizione operaia” l’ha spinta a entrare in fabbrica, alla Renault. Abbandonando la speculazione puramente teorica, Weil si è immersa nella vita. Nel 1936 si è arruolata per combattere - tra le file anarchiche della Colonna Durruti - l’avanzata delle truppe franchiste in Spagna. Con la guerra e le leggi razziali, Weil, ebrea d’origine, viene esclusa dall’insegnamento e diventa contadina, fino alla fuga negli Stati Uniti dove conosce la povertà del quartiere di Harlem. Mai pronta ad abbandonare la lotta, torna in Europa dove muore di malattia a soli 34 anni.
- Simone Weil è stata un’intellettuale sorprendente. Filosofia, religione, politica sono vita, in lei, vita attiva e la sua analisi filosofica, originalissima, sfugge alle correnti tradizionali. La sua riflessione sull’attenzione è utile a tutti noi. L’attenzione, dice la filosofia, è la forma più rara e più pura della generosità. L’attenzione serve a guarire i nostri difetti molto più della volontà.
L’attenzione è il mezzo per trasformarci.
- L’attenzione è al centro degli studi. Formare l’attenzione è ciò che - secondo Weil - la scuola dovrebbe fare. Ma molto spesso viene a crearsi della confusione. Gli studenti si stancano perché il loro sforzo è uno sforzo di volontà. Formare l’attenzione è capire che l’intelligenza non può essere guidata dalla volontà: l’intelligenza si esprime nel desiderio e perché ci sia desiderio devono esserci gioia e piacere.
Da Attesa di Dio (Adelphi):
Molto spesso l’attenzione viene confusa con una sorta di sforzo muscolare. Quando si dice agli allievi: “Ora state attenti”, li si vede corrugare le sopracciglia, trattenere il respiro, contrarre i muscoli. Se qualche istante dopo si domanda loro a che cosa siano stati attenti, non sono in grado di rispondere. Non hanno fatto attenzione ad alcunché. Non hanno fatto attenzione. Hanno solo contratto i muscoli.
Negli studi vi è spesso dispendio di un simile sforzo muscolare. E poiché alla fine ci si sente stanchi, si ha l’impressione di aver lavorato. Ma è un’illusione. La fatica non ha alcun rapporto con il lavoro. Il lavoro è lo sforzo utile, sia o non sia faticoso. Quando si studia, uno sforzo muscolare del genere, anche se compiuto con buona intenzione, è del tutto sterile.
La volontà, quella che, se occorre fa stringere i denti e sopportare la sofferenza, è lo strumento principale dell’apprendista nel lavoro manuale. Ma contrariamente all’opinione comune, nello studio è quasi irrilevante. L’intelligenza può essere guidata soltanto dal desiderio. E perché ci sia desiderio, devono esserci piacere e gioia. L’intelligenza cresce e porta frutti solo nella gioia. La gioia di apprendere è indispensabile agli studi come la respirazione ai corridori. Dove è assente non ci sono studenti, ma povere caricature di apprendisti che al termine del loro apprendistato non avranno neppure un mestiere.
L’attenzione è uno sforzo, forse il più grande degli sforzi, ma è uno sforzo negativo. Di per sé non comporta fatica. Quando questa si fa sentire, l’attenzione non è quasi più possibile, a meno che non si sia già molto esercitati; allora è meglio lasciarsi andare, provare a rilassarsi e cominciare daccapo dopo qualche tempo. L’attenzione è distaccarsi da sé e rientrare in sé stessi, così come si inspira e si espira.
Venti minuti di attenzione intensa e senza fatica valgono infinitamente più di tre ore d’applicazione con la fronte corrugata, che fanno dire, con la sensazione di aver fatto il proprio dovere: “Ho lavorato sodo”.
Ma, al di là delle apparenze, è molto piu’ difficile. Nella nostra anima c’è qualcosa che ripugna la vera attenzione molto più violentemente di quanto alla carne ripugni la fatica. Questo qualcosa è molto più vicino al male di quanto non lo sia la carne. Ecco perché ogni volta che si presta veramente attenzione si distrugge un po’ di male in se’ stessi. Un quarto d’ora di attenzione così orientata ha lo stesso valore di molte opere buone.
L’attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- AL DI Là DEL "MONOMITO"! "Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione" (di Joseph Campbell).27 maggio 2020, di Federico La Sala
"CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT) E DEL "MONOMITO" (JAMES JOYCE). UN OMAGGIO A JOSEPH CAMPBELL
LA METAFORA NEL MITO E NELLA RELIGIONE E I PROLEGOMENI AD OGNI FUTURA METAFISICA CHE SI PRESENTERA’ COME SCIENZA.... *
- IL MITO E IL CORPO. [...] I vecchi dèi sono morti o stanno morendo e dappertutto la gente è alla ricerca di qualcosa di nuovo e si chiede: “Quale sarà la nuova mitologia, la mitologia di questa Terra unificata come un unico essere armonioso?”(Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo, i Nottetempo, Milano 2020, p. 23)
- LA COSMOLOGIA E L’IMMAGINAZIONE MITICA. Un’esperienza sorprendente, per me come certo per molti altri spettatori, è stata offerta dalla trasmissione televisiva del viaggio della navicella spaziale Apollo nel momento precedente lo sbarco di Armstrong sulla Luna. Quando dal Centro di controllo di Houston chiesero: «E ora chi è il navigatore?» la risposta che venne dallo spazio fu «Newton!».
 Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».
Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».
 Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).
Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).
Siamo mito
di Moreno Montanari (Doppiozero, 20 marzo 2020).
“Come fuori, così dentro” si potrebbe riassumere così, parafrasando la celebre massima alchemica, la tesi dell’ultimo libro di Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, Nottetempo, 2020. Si tratta di una raccolta di saggi che amplificano delle conferenze tenute tra il 1981 e il 1984 nello sforzo, consueto per Campbell, di illuminare la transculturalità, ossia gli elementi costanti, nonostante le variabili etnico-culturali, dei miti. Al cuore di ogni narrazione mitologica, che Campbell ha il merito indiscusso di mostrare ancora viva negli aspetti più comuni delle nostre culture, ci sono temi che Adolf Bastian (1826-1905) chiamava “idee elementari” e Carl Gustav Jung (1875-1961) “archetipi” ; si tratta di cristallizzazioni di risposte millenarie che la fantasia e l’immaginazione delle diverse civiltà umane hanno elaborato per affrontare questioni esistenziali che le hanno profondamente interrogate. Naturalmente queste forme archetipiche variano a seconda delle idee etniche che una determinata cultura esprime, ma esiste tra di loro una dialettica che Campbell riassume così : “l’idea elementare è radicata nella psiche ; l’idea etnica attraverso cui si manifesta è radicata nella geografia, nella storia e nella società” (p. 145) ; si accede al punto di vista del mito quando “nelle forme di un ambiente traspare la trascendenza” (p. 28).
Il suo lavoro più celebre sull’universalità del mito è sicuramente quello relativo a L’eroe dai mille volti (1949, tr. it. Lindau, Torino, 2012) figura che, nelle più disparate e diversificate espressioni culturali, lontanissime tra loro nello spazio e nel tempo, passa comunque sempre attraverso i seguenti snodi esistenziali : una nascita misteriosa, una relazione complicata con il padre, ad un certo momento della sua vita sente l’esigenza di ritirarsi dalla società e, in questa condizione, apprende una lezione, o elabora un sapere, che orienterà diversamente la sua vita, poi ritorna alla società per mettere al suo servizio la lezione che ha appreso, molte volte (ma non necessariamente) grazie ad un’arma che solo lui può usare.
In questo libro, invece, l’attenzione si rivolge alle diverse cosmologie e ai miti soteriologici elaborati nel corso dei millenni dalle differenti culture che si sono susseguite, e affiancate, nel nostro pianeta, comprese le attuali, e si organizza intorno alla felice intuizione kantiana che spazio e tempo siano categorie interiori della psiche che vengono applicate alla realtà esterna. Citando Novalis Campbell scrive : “La sede dell’anima è laddove il mondo esterno e il mondo interno s’incontrano”, e aggiunge, “è questo il paese delle meraviglie del mito” (p. 43).
 Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.
Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.
 Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:
Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:- “Le figurazioni mitiche sono metaforiche (...) in due sensi contemporaneamente : in quanto portatrici di connotazioni psicologiche e, allo stesso tempo, metafisiche. Attraverso questa doppia messa a fuoco, le caratteristiche psicologicamente interessanti di ogni ordine sociale locale, di ogni ambiente o di ogni ipotetica storia, possono venire trasformate attraverso il mito in trasparenze rivelatrici di trascendenza.
- Immanuel Kant ci ha fornito una formula straordinariamente semplice per interpretare queste due connotazioni. Compare nei Prologomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza ai paragrafi 57-58. Ci viene offerta una proporzione a quattro termini (a sta a b come c sta a x) che punta non tanto a porre un’imperfetta somiglianza tra due cose, ma definire un’identità perfetta di due rapporti tra cose del tutto dissimili (...). Non “a in qualche modo assomiglia a b”, ma il rapporto tra a e b è perfettamente identico a quello tra c e x, dove x rappresenta una quantità che non è soltanto sconosciuta, ma assolutamente inconoscibile, metafisica” (p. 80).
Mi sembra un esempio realmente illuminante per comprendere il senso di ogni comparazione e di ogni ermeneutica simbolica. Lo ha spiegato bene Jung : il simbolo, centrale in ogni mito, non rimanda a una realtà significata, è esso stesso realtà operante, costituisce la specifica capacità umana di “orientare la coscienza verso ulteriori possibilità di senso”, poiché non è mai del tutto riconducibile ad un significato univoco e definitivo ; per questo non può essere ridotto alla semiotica perché la sua funzione è piuttosto psicagogica, vale cioè per gli effetti che produce nella psiche, per le energie, le immagini, le interpretazioni, i processi psichici che sa evocare, promuovere, mettere in gioco (C. G. Jung, Tipi psicologici, 1921 ; tr. it. Bollati Boringhieri, 1977 e sgg, p. 527). Ecco perché il ricorso a Kant, a quell’x che resta inconoscibile e che apre alla metafisica, a ciò che trascende ogni possibilità di possesso e de-finizione del senso ultimo, appare particolarmente pertinente.
I rapporti che vengono suggestivamente indagati da Campbell, dicevamo, sono quelli che comparano lo spazio interiore e quello esteriore, secondo la celebre analogia tra macrocosmo e microcosmo :
- “la profondità e la sublime maestà della mitologia soppressa può essere apprezzata al meglio attraverso due movimenti a orologeria apparentemente irrelati ; l’uno è il più grande orologio dello spazio esteriore, l’altro appartiene allo spazio interiore. Sono rispettivamente la precessione astronomica degli equinozi e il battito fisiologico del cuore umano” (p. 54).
Attraverso un nutrito numero di calcoli e dati ricavati dagli studi di astronomia, i calendari ideati dalle diverse culture a partire dagli antichi babilonesi, le fonti bibliche, le arcaiche Upanisad induiste e i più remoti testi taoisti, Campbell giunge ad analizzare suggestivi - per un certo tipo di lettore - consonanze tra i cicli biologici del sistema solare (macrocosmo) e quelli dell’individuo (microcosmo). Ma non mi sembra questo il punto cruciale dei suoi sforzi, che consiste piuttosto nel promuovere una diversa prospettiva sul mondo e sulla vita, non più incentrata sulle nostre idee etniche, sui limiti delle nostre culture, ma aperta al riconoscimento di un’unica realtà “il cui centro è ovunque”, della quale dovremmo finalmente farci carico in maniera universale (si pensi agli assurdi sforzi dei singoli stati, in questi difficili giorni, di arginare il coronavirus secondo strategie nazionali, anziché comprenderne la portata globale che richiederebbe interventi condivisi, in tutti i sensi, su scala mondiale e non, addirittura, regionale - per non parlare delle differenti valutazioni a seconda delle fasce di età).
Dopo aver preso in esame i miti cosmologici e soteriologici delle diverse religioni delle nostre principali culture, Campbell giunge a questa conclusione :
- “Il primo passo per partecipare al destino dell’umanità, che non è quello di questo o di quel popolo, ma quello dell’intera popolazione del globo, è riconoscere che ogni immagine locale di un dio non è che una delle molte migliaia, dei milioni, forse anche miliardi di simbolizzazioni limitate di un mistero al di là della vista e del pensiero” (p. 63).
Il pensiero mitologico, quando non viene letteralizzato, promuove dunque un’apertura alla transculturalità, alla trascendenza di ogni appartenenza storico-culturale e si propone, in maniera apparentemente contro intuitiva, come strumento di laicità. Qui incontra l’arte, per la sua capacità di trasformare la coscienza e la visione abitudinarie della realtà in favore di un punto di vista nel quale, “la mente viene fermata e innalzata al di sopra del desiderio e dell’odio” ; sono parole di Joyce che Campbell fa sue e che trova affini all’esperienza ascetica che dovette compiere il Buddha prima di raggiungere l’illuminazione : vincere i tre demoni del desiderio (Kāma), della paura della morte (Māra) e l’identificazione con i vincoli sociali (Dharma), per accedere a una condizione che li sappia trascendere (pp. 201-201).
Un percorso e un’opportunità che, in chiave individuativa, sono poste al centro del lavoro di Giovanna Morelli nel suo Poetica dell’incarnazione. Prospettive mitobiografiche nell’analisi filosofica (Mimesis, 2020). In questo libro - uscito per la collana di Mimesis “Philo-pratiche filosofiche” curata da Claudia Baracchi - l’arte appare lo sfondo dal quale può emergere una rappresentazione mitobiografica della vita di ciascuno di noi, ossia, secondo la lezione di Ernst Bernhard, il modo di riconoscere come ogni singola esistenza si apra, o meglio si riconosca, in alcuni mitologemi (singoli aspetti di un mito) che si prestano a leggerne alcune gesta. Lo sguardo mitobiografico con il quale Morelli invita a osservare la vita, a partire dal racconto della propria, permette di “scoprire e amare l’universale attraverso il particolare, preservando entrambe le dimensioni”, di “narrare la propria vita secondo il disegno di senso che la illumina, la magnifica, la collega a figure universali e pertanto la rende epica, emblematica” (p. 127).
L’arte che indaga l’analista filosofo è dunque quella incarnata, ossia, consapevole che la vita di ciascuno di noi accede al simbolico grazie e attraverso quelle che James Hillman chiamava “metafore radicali” offerte dall’inconscio collettivo, ossia le strutture percettive, gli archetipi, che organizzano l’esperienza umana come già da sempre sovrapersonale.
Lo specifico di ogni vicenda biografica non viene meno se riconosce nel suo sviluppo echi, modalità e variazioni di temi ricorrenti nella storia dell’umanità - di cui la psiche mantiene una traccia in forma, appunto, archetipica - ma procede al contrario verso la sua individuazione, la possibilità di autenticare in modo esclusivo la propria esistenza, “se comunica con se stessa alle più diverse latitudini spazio-temporali, attraverso le tante narrazioni-quadro che si sono avvicendate nella storia” (pp. 38-39).
L’arte è qui poiesis, anzi, mitopoiesi e la vita, vista dall’osservatorio privilegiato della stanza d’analisi, ne costituisce il principale teatro (Giovanna Morelli è anche regista d’opera e critica teatrale), lo spazio in cui s’incontrano e si scontrano le nostre maschere sociali e i nostri doppi impresentabili, ma anche dove si facilita una più profonda espressione di sé che, in una vicenda personale, sa scorgere tracce di qualcosa di universale - il che, osserva Jung, è già di per sé terapeutico :
- “Il mito ha bisogno d’una nuova veste in ogni nuova era, se non vuol perdere la sua virtù terapeutica. (...) gli archetipi inconoscibili sono vivi (...) cambiano nome e veste in una successione infinita, e proprio attraverso questi mutamenti esprimono la loro imperscrutabile essenza” (C. G. Jung, Aion, Ricerche sul simbolismo del Sé, Bollati Boringhieri, Torino, p. 170, cit. in G. Morelli, op.cit., p. 45).
Un’operazione che, in modo diverso, sia Campbell che Morelli, ci invitano a fare per riconoscere nei miti la via maestra alla coltivazione di quella trascendenza che non rimanda a mondi altri e paralleli ma anima l’immanenza, qui ed ora, da sempre.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COME ALL’INTERNO, COSI’ ALL’ESTERNO: "VERE DUO IN CARNE UNA". NOTE SUL PROGRAMMA DI KANT
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaDAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- Nuova conferma del genio di Einstein. L’orbita di un astro attorno al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea.17 aprile 2020, di Federico La Sala
La danza della stella attorno al buco nero, nuova conferma del genio di Einstein
L’orbita di un astro attorno al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea corrisponde ai calcoli fatti grazie alla teoria del fisico tedesco, che resiste a più di un secolo dalla sua formulazione
di MATTEO MARINI (la Repubblica, 16 aprile 2020)
Lì dove le masse si fanno davvero giganti e il tachimetro si avvicina pericolosamente alla velocità della luce, c’è il laboratorio di fisica più estremo che l’uomo ha a disposizione. Siamo al centro della nostra galassia, a circa 26.000 anni luce da noi, e da lì arriva una nuova conferma della teoria della Relatività generale di Einstein. Qui le stelle orbitano attorno al buco nero supermassiccio Sagittarius A*. Gli astrofisici per 30 anni hanno seguito il percorso di una di queste, una giostra vorticosa che la porta a raggiungere il tre per cento della velocità della luce. La sua orbita, distorta dagli effetti relativistici, è stata prevista grazie alla teoria di Einstein, che resta la più elegante e precisa descrizione di come si muovono le cose nell’Universo.
S2, la stella in questione, non descrive infatti una semplice ellisse chiusa durante la sua rivoluzione attorno a Sagittarius A*, ma il suo moto disegna un rosone. Il motivo di questa distorsione riguarda proprio la presenza del buco nero al quale la stella passa piuttosto vicino. Parliamo di circa 20 miliardi di chilometri, 120 volte la distanza che separa la Terra dal Sole. Può sembrare un’enormità, ma l’attrazione del gigantesco buco nero si fa sentire con anche qui con tutta la sua forza.
Quando Newton non basta
Isaac Newton aveva descritto il mondo nella maniera più accurata possibile al suo tempo, la legge di gravitazione universale, assieme ai principi della dinamica, sono pilastri della fisica moderna grazie ai quali, per esempio, possiamo calcolare con ottima approssimazione la caduta di un oggetto o le orbite della Terra e di tutti gli altri pianeti. Tranne Mercurio. Dove il campo gravitazionale si fa davvero molto intenso, le formule di Newton infatti non bastano più. Bisognò aspettare un paio di secoli, fino a quando Einstein, con la Relatività generale, non ideò la teoria più precisa mai ottenuta per calcolare anche quello che succede vicino a grandi masse, come quella del Sole o, appunto, di un buco nero.
- [Video] La danza della stella attorno al buco nero supermassiccio
Mercurio, insomma, non si comporta come Newton aveva previsto, la sua orbita subisce una precessione molto più marcata rispetto a Venere o la Terra. Questo perché è molto più vicino al Sole che curva lo spaziotempo. Allo stesso modo si comporta una stella come S2, che danza attorno a un buco nero che ha una massa stimata di circa quattro milioni di volte quella dello stesso Sole.
La sua orbita, come quella di Mercurio, subisce quella precessione che, ogni volta che si avvicina, la modifica leggermente. La stella S2, è una osservata speciale da almeno 30 anni. Ce ne impiega infatti 16 per compiere un’orbita completa attorno a Sagittarius A*. Ora, un team internazionale di astrofisici, usando gli strumenti del Very large telescope dell’Eso, in Cile, ne ha ricostruito il percorso in questi tre decenni. E il risultato, pubblicato oggi su Astronomy & Astrophysics, è stato quello atteso, perché corrisponde all’orbita calcolata grazie alla Relatività generale di Einstein.
La conferma della teoria di Einstein
In più di un secolo (lo studio della Relatività generale è del 1916) è stata testata e messa alla prova moltissime volte. La prima evidenza empirica di questi effetti relativistici fu quella dell’eclissi del 1919, quando la posizione delle stelle osservate vicino al bordo del Sole oscurato dalla Luna, fu misurata con uno spostamento atteso. Perché anche la luce viene piegata da un oggetto molto massiccio, come aveva descritto Einstein. Lo scienziato divenne una rockstar e la Fisica non fu più la stessa. Questa bizzarria della luce che devia e prende diversi percorsi crea molte stranezze nel cielo. Per esempio le ’’croci di Einstein’’, immagini diverse dello stesso oggetto (molto luminoso, una supernova o una galassia) che dalla Terra vediamo riprodotte più volte grazie alla interazione di un altro oggetto molto massiccio che sta in mezzo. L’effetto è noto come lente gravitazionale.
Nel 2016, addirittura, fu osservato il ’’replay’’ dell’esplosione di una stella, la cui luce aveva viaggiato per diverse vie, arrivando fino a noi in tempi diversi. Anche questa predizione fu fatta grazie ai calcoli della Relatività.
- Quattro immagini della stessa Supernova, la gravità scherza con la luce
S2 e le altre stelle che orbitano attorno a Sagittarius A* sono state a lungo oggetto di analisi, sempre per trovare misure sempre più precise per testare la Relatività generale. Nel 2017 ancora la sua orbita fu misurata per testare i calcoli e la Relatività passò l’esame. Attorno a Sagittarius A*, che si conferma straordinario laboratorio di Fisica con masse estreme, adatte a mettere alla prova le formule che descrivono il movimento degli oggetti, nel 2018 il test riguardò l’effetto sulla luce di una stella sempre da quella regione, con uno spostamento verso il rosso, un redshift, che si manifesta in presenza di masse enormi.
Fino ad arrivare alla prima immagine di un buco nero, realizzata grazie ai radiotelescopi sparsi in tutto il mondo. Anche in quel caso, tutto era spiegabile (per esempio la sua forma) con i calcoli elaborati dalla Relatività. Come sempre, si continuerà a provare e riprovare, per cogliere in fallo, per trovare quello che la Relatività non riesce a spiegare. A quel punto saremo di fronte, forse, alle porte di una nuova Fisica, che potrebbe, chissà, aprirsi sulla strada della “Teoria del tutto” che unifichi la spiegazione della gravità descritta dalla Relatività, con la descrizione delle altre forze fondamentali (elettromagnetismo, interazione nucleare debole e forte della fisica quantistica).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- ASTROFISICA. «Sembra un modo di dire, ma è vero: siamo tutti polvere di stelle!» (Maria Branchesi)12 gennaio 2020, di Federico La Sala
ASTROFISICA
Marica Branchesi, la signora delle onde. Con lei il Big Bang è più vicino
La scienziata è stata la prima a rilevare le onde gravitazionali, confermando quanto predetto da Einstein. E Time l’ha inserita tra le 100 persone più influenti del mondo
di Alessia Cruciani (Corriere della Sera, 10 gennaio 2020)
«La più amabile, la più nobile tra le Fisiche scienze ella è senza dubbio l’Astronomia», scriveva Giacomo Leopardi nel suo volume Storia della Astronomia dalla sua origine sino all’anno 1811. Aveva solo 15 anni. Era addirittura più giovane Marica Branchesi quando con gli amici, nel suo piccolo paese di campagna alle porte di Urbino, guardava il cielo di sera nella speranza di veder una stella cadente. «Eppure non sono mai stata un’astrofila. Non conosco le costellazioni, mi limito a Grande e Piccolo Carro, stella Polare e poco altro», ammette ridendo l’astrofisica, 42 anni, che nel 2017 è stata inserita da Nature nella top ten dei ricercatori più importanti e nel 2018 da Time tra le 100 persone più influenti al mondo.
 Infatti, la ricercatrice del Gran Sasso Science Institute, a L’Aquila, ha partecipato alla rilevazione delle onde gravitazionali tra il 2015 e il 2017, esattamente cento anni dopo che Albert Einstein ne aveva predetto l’esistenza. Una scoperta che ha consegnato il Premio Nobel per la fisica agli scienziati Rainer Weiss, Barry C. Barish e Kip S. Thorne, creatori dell’interferometro Ligo per registrarle.
Infatti, la ricercatrice del Gran Sasso Science Institute, a L’Aquila, ha partecipato alla rilevazione delle onde gravitazionali tra il 2015 e il 2017, esattamente cento anni dopo che Albert Einstein ne aveva predetto l’esistenza. Una scoperta che ha consegnato il Premio Nobel per la fisica agli scienziati Rainer Weiss, Barry C. Barish e Kip S. Thorne, creatori dell’interferometro Ligo per registrarle.Ma la burocrazia italiana ha i suoi tempi anche davanti a scoperte che ci porteranno oltre il Big Bang, e la scienziata che il mondo ci invidia è ancora ricercatrice di tipo B, che anticipa lo scatto a professore associato.
 E non si lamenta?
E non si lamenta?«No, al Gssi è possibile fare ricerca a livello internazionale con una burocrazia meno pressante. È un ambiente stimolante, l’istituto è nato dopo il terremoto da un progetto che intende ricostruire la città attraverso la cultura, così ho studenti d’eccellenza da tutto il mondo. Oggi siamo sedici ma nel 2017 eravamo in tre a studiare le onde gravitazionali: il rettore, io e il mio compagno (il fisico Jan Harms, papà dei suoi due bimbi, ndr)».
Da anni ripete cosa sono le onde gravitazionali. Stavolta proviamo a farlo noi: si tratta di perturbazioni dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce, come quando si lancia un sasso in un lago e si creano onde che si espandono. Nello spazio a creare le onde sono oggetti molto massivi, come buchi neri o stelle di neutroni, che si scontrano provocando increspature, che si propagano nell’universo. Le onde gravitazionali ci permettono di vedere quello che è invisibile.
Nel 2015 un sms la informa che c’è appena stata una fusione tra due buchi neri che ne ha formato uno più massivo capace di produrre un segnale che ci ha raggiunto dopo 1,2 miliardi di anni. L’universo ha usato lo smartphone per far rilevare le prime onde gravitazionali?
«Oggi mi ha mandato un messaggio mentre facevo la doccia! Abbiamo interferometri che osservano sempre il cielo e i dati vengono analizzati con tecniche complicate quasi in real time. Se ci sono segnali di onde gravitazionali, un alert sul telefono è il modo più veloce per correre al computer e parlare con gli altri ricercatori in tutto il mondo».
Ha detto che le onde gravitazionali erano più belle di quanto si aspettasse. Perché?
«Sapevamo di essere di fronte a eventi rari, ci aspettavamo un segnale debole e stavamo facendo gli ultimi controlli degli interferometri. Ci ha sorpresi un segnale così presto e così bello: si vedeva già nei dati sporchi. Una scoperta epocale che ha cambiato l’astronomia. Come quando Galileo puntò per la prima volta il telescopio».
Il 17 agosto 2017 arriva il segnale più importante: a una distanza di 130 milioni di anni luce (sulla Terra c’erano i dinosauri), due stelle di neutroni si sono fuse propagando onde gravitazionali . Ma questa volta non sono sole.
«Virgo, l’interferometro che abbiamo a Cascina, nel pisano, è riuscito a registrarle insieme alle antenne negli Usa. Avevamo una posizione più precisa in cielo e satelliti e telescopi hanno visto anche la luce. Un segnale fantastico che ha dato vita alla nuova astronomia multimessaggera: abbina la luce alle onde gravitazionali. Ora rileviamo fusioni di buchi neri con stelle di neutroni. E serviranno strumenti più avanzati, come l’Einstein Telescope: un rivelatore che potrà vedere tutto l’universo osservabile, si andrà vicino al Big Bang. Si sta decidendo il sito che lo ospiterà, Olanda o Sardegna: dovrebbe osservare il cielo dal 2035 ».
Si troveranno altre forme di vita?
«Sarà una delle grandi scoperte che probabilmente l’astronomia ci darà nei prossimi anni. Ci sono missioni, satelliti per studiare pianeti, trovarne simili alla Terra».
Non avrebbe voglia di andarci fisicamente nello spazio?
«L’esplorazione dell’astronauta è limitata a un universo vicino, le distanze degli oggetti astrofisici sono troppo lontane a parte quelli del nostro sistema solare. E la mia esplorazione è attraverso i segnali che osserviamo dall’universo».
Grazie alle onde gravitazionali abbiamo capito che l’oro nasce dalla fusione di stelle di neutroni. Quanta poesia se l’avesse saputo Leopardi.
«Sembra un modo di dire, ma è vero: siamo tutti polvere di stelle!».
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- USCIRE DALL’ORIZZONTE DELL’IMMAGINARIO "COSMOTEANDRICO".3 gennaio 2020, di Federico La Sala
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-257181)
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200101_omelia-madredidio-pace.html)
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- I 150 anni della tavola degli elementi di Mendeleev e la necessità di una una visione antropologica che risalga ai fondamenti della conoscenza.25 ottobre 2019, di Federico La Sala
SCIENZA, FILOSOFIA, E ANTROPOLOGIA. Non è il caso di ripensare i fondamenti?! *
Chimica.
I 150 anni della tavola di Mendeleev, il rivoluzionario degli elementi
Lo scienziato russo inventò la Tavola periodica degli elementi grazie alla sua passione per i giochi: la sua scoperta ha qualcosa di incredibile. Mendeleev scoprì anche l’origine minerale del petrolio
di Franco Gàbici (Avvenire, mercoledì 27 febbraio 2019)
- [Foto] Dmitrij Ivanovič Mendeleev nel 1890 circa (WikiCommons)
Il primo giorno di marzo del 1869, e dunque 150 anni fa, il chimico russo Dmitrij Ivanovic Mendeleev (1834-1907) presentava la sua famosa "Tavola periodica degli elementi", che oggi sotto forma di poster campeggia in tutte le aule di scienze del mondo e in omaggio a questa straordinaria invenzione l’Onu ha dichiarato il 2019 "Anno internazionale della tavola periodica degli elementi".
Per la creazione di questa ’tavola’ lo storico della scienza John D. Bernal definì Mendeleev «il Copernico della chimica» e in effetti il chimico russo fornì ai ricercatori uno strumento efficacissimo che non solo catalogava gli elementi fino allora conosciuti ma consentiva soprattutto di fare delle previsioni.
Al tempo di Mendeleev erano conosciuti 63 elementi e gli scienziati si erano posti il problema di dar loro una sistemazione secondo uno schema logico. Anche Mendeleev, ovviamente, stava studiando la questione e la scoperta della sua tavola è legata a una storia che ha dell’incredibile.
Come Mendeleev sognò la Tavola periodica degli elementi
Mendeleev, infatti, era un appassionato giocatore di carte e il gioco che maggiormente preferiva era il cosiddetto "solitario". E proprio inventando un "solitario chimico" gli venne l’idea che gli avrebbe dato fama e prestigio. Mendeleev trascrisse su cartoncini il simbolo degli elementi conosciuti e il loro peso atomico, vale a dire il numero che si ottiene facendo la somma dei neutroni e dei protoni contenuti nel nucleo di ogni atomo, e si mise a giocare con quei cartoncini ordinandoli e organizzandoli proprio come si usa fare con le carte da gioco.
Quello strano "solitario", però, non gli indusse nessuna soddisfazione e così dopo tre giorni e tre notti trascorsi davanti al tavolo gettò la spugna e se ne andò a dormire. E qui accadde il miracolo, perché in sogno ebbe la visione di quella "tavola" che stava cercando. In quella tavola gli elementi, ordinati in colonne, e raggruppati in gruppi di elementi simili, presentavano «una evidente periodicità di proprietà» e proprio a causa di questa particolarità chiamò la sua tavola con l’appellativo «periodica». Ed era talmente convinto che la sua idea fosse giusta che proprio pensando a questa periodicità lasciò nella sua tavola alcuni spazi vuoti che, secondo le sue previsioni, sarebbero stati occupati da elementi ancora da scoprire.
Una Tavola profetica
La tavola periodica degli elementi all’inizio non fu però accolta molto benevolmente ma sei anni dopo quanti nutrivano dubbi dovettero ricredersi. Nel 1875, infatti, esaminando un metallo proveniente dai Pirenei, il chimico Paul Émile Lecoq de Boisbaudran scoprì il Gallio, un metallo che andò a occupare, accanto all’alluminio, la casella vuota che Mendeleev gli aveva riservato e per il quale aveva pensato il nome di "Eka-alluminio". Il peso atomico del Gallio (69.7) era molto simile a quello previsto da Mendeleev (68) e ciò dimostrava che la tavola funzionava. Successivamente altri tre posti vuoti previsti dalla tavola furono occupati dall’Elio, dal Neon e dall’Argon e ribadirono la geniale intuizione di Mendeleev.
Ovviamente le moderne tavole contengono più elementi perché ora gli elementi conosciuti hanno superato il centinaio. Gli ultimi inseriti, che completano il "settimo periodo" della tavola, sono quattro. Si tratta però di elementi creati in laboratorio e non rintracciabili in natura: il Nihonio (113), il Moscovio (115), il Tennesso (117) e l’Oganesson (118).
- [Foto] Alcune visualizzazioni grafiche alternative della Tavola periodica degli elementi
Nel corso del tempo la tavola di Mendeleev ha subito una sorta di restyling che, pur lasciando integra la sostanza, ne ha cambiato invece la forma. Moltissime le versioni, secondo alcuni sarebbero addirittura 800 e dalle forme più svariate: circolari, cubiche, a elica, piramidali, a spirale, a triangolo... Una versione curiosa ha disposto gli elementi secondo uno schema che segue il tracciato della metropolitana di Londra! Insomma, come si dice, ce n’è per tutti i gusti.
I rivali di Mendeleev
Non è infrequente, sfogliando la storia della scienza, imbattersi nell’annosa questione della priorità di una scoperta e Mendeleev e la sua tavola non fecero eccezione. Già Johann Wolfgang Döbereiner, un autodidatta garzone di una farmacia, aveva raggruppato a tre a tre gli elementi che avevano proprietà chimiche simili, insiemi conosciuti come le "triadi di Döbereiner", e che in qualche modo possiamo considerare i progenitori della tavola periodica. Anche John Dalton e John Newlands si interessarono al problema e altri ancora si aggiunsero all’elenco dei presunti scopritori della tavola come John Newlands che dopo aver notato il ripetersi di certe proprietà a intervalli di 8, paragonò la periodicità alle ottave musicali formulando la "Legge delle ottave".
L’unico, forse, che potrebbe a ragione rivendicare un diritto di priorità è Julius Lothar Meyer che nel 1864, e dunque cinque anni prima della presentazione di Mendeleev, dopo aver pubblicato una tavola nella quale aveva sistemato 28 elementi col criterio del peso atomico crescente, presentò una tavola periodica molto simile a quella di Mendeleev. E secondo Van Spronsen, dunque, Mendeleev e Meyer si possono considerare scopritori indipendenti della stessa legge.
Le due tavole erano molto simili. In entrambe, infatti, gli elementi erano sistemati in righe e colonne seguendo l’ordine del peso atomico crescente, ma alla fine fu adottata quella di Mendeleev perché risultava più precisa, ma anche e soprattutto per quegli spazi vuoti inseriti che ipotizzavano elementi ancora da scoprire.
Va infine ricordato che Mendeleev non va identificato tout court con la sua tavola. Il chimico russo, infatti, scoprì l’origine minerale del petrolio e si dedicò allo sviluppo dell’industria petrolifera e anche carbonifera. Credeva, inoltre, nel grande significato sociale e culturale della scienza e, come si legge nella voce che gli ha dedicato la grande enciclopedia Scienziati e tecnologi (Mondadori, 1975), «considerò il progresso della scienza come una condizione assolutamente indispensabile di sviluppo dell’economia e della cultura», un tema a lui molto caro e al quale dedicò numerosi articoli e saggi.
Idee.
La scienza ha bisogno della filosofia
Senza una visione umanistica che risalga ai fondamenti della conoscenza il rischio è la dispersione. Ma l’attività delle scienze trova il suo presupposto nella dimensione personale del ricercatore
di Giuseppe Tanzella-Nitti (Avvenire, giovedì 24 ottobre 2019)
La formulazione della tavola periodica degli elementi chimici, scoperta 150 anni or sono dal chimico russo Dmitrij Ivanovic Mendeleev, ha suggerito al Festival della scienza di Genova di dedicare l’edizione dell’anno 2019 al tema degli “Elementi”. La scelta è senza dubbio opportuna. Il metodo scientifico, infatti, deve gran parte del suo successo alla capacità di “ridurre” i fenomeni a modelli matematizzabili, in base ai quali poter predire il comportamento di un sistema nel tempo. Tale processo consiste nello “scomporre” il suo oggetto di studio per cercare gli elementi e le proprietà elementari del reale fisico.
L’implicita persuasione che orienta questo metodo è l’idea che per conoscere davvero una cosa occorra saperla scomporre nei suoi elementi e capire come e perché funziona... È ciò che facciamo quando esaminiamo una scatola di costruzioni... Il ricercatore, tuttavia, si imbatte spesso in qualcosa di inaspettato. Nell’operare questa “scomposizione” e procedere lungo il suo cammino di comprensione dei fenomeni, si accorge talvolta che, per comprendere e rappresentare un fenomeno, occorre partire da alcuni presupposti, che non appartengono, in senso stretto, al metodo scientifico. Così facendo la scienza spinge la sua analisi fino al fondamento stesso del conoscere. Il tentativo rappresentarlo, al confine fra scienza e filosofia, viene chiamato il problema dei fondamenti.
Le discipline scientifiche colgono questo stato di cose in diversi ambiti della loro ricerca. La cosmologia contemporanea lo fa quando cerca di tematizzare l’universo come un “tutto”, in particolare la sua origine. La fisica e la chimica, quando si interrogano sul motivo delle specifiche formalità dei componenti della materia, sulla loro universalità, sui loro criteri di ordinamento e di simmetria. La biologia si chiede se a fondare il suo oggetto di studio siano gli elementi che compongono il vivente o non, piuttosto, l’organismo nel suo insieme. Anche la matematica e la logica si interrogano sui loro fondamenti, quando ricercano la completezza dei sistemi assiomatici e dei linguaggi formali in genere.
 In sostanza, per comprendere la realtà non basta conoscere gli elementi che la compongono (particelle elementari, elementi chimici), ma è necessario conoscere anche i processi di cui tali elementi sono oggetto e i loro rapporti con l’ambiente circostante. Si affacciano all’analisi delle scienze le nozioni di relazione e di informazione, proprietà che riguardano la totalità del sistema in esame e, grazie ad essa, aiutano a comprendere il comportamento delle parti che lo compongono. Ne risultano interessate, in particolare, la fisica (sistemi complessi, meccanica quantistica), la chimica (proprietà molecolari) e la biologia ( system biology). In questi fenomeni si converge ormai sulla conclusione che “il tutto è maggiore della somma delle parti”. Imbattersi nel problema dei fondamenti suggerisce che l’articolazione fra scienze e filosofia non sia solo quella del “limite” - immagine alla quale siamo abituati soprattutto nelle questioni di carattere etico - ma piuttosto quella dell’apertura e del trascendimento.
In sostanza, per comprendere la realtà non basta conoscere gli elementi che la compongono (particelle elementari, elementi chimici), ma è necessario conoscere anche i processi di cui tali elementi sono oggetto e i loro rapporti con l’ambiente circostante. Si affacciano all’analisi delle scienze le nozioni di relazione e di informazione, proprietà che riguardano la totalità del sistema in esame e, grazie ad essa, aiutano a comprendere il comportamento delle parti che lo compongono. Ne risultano interessate, in particolare, la fisica (sistemi complessi, meccanica quantistica), la chimica (proprietà molecolari) e la biologia ( system biology). In questi fenomeni si converge ormai sulla conclusione che “il tutto è maggiore della somma delle parti”. Imbattersi nel problema dei fondamenti suggerisce che l’articolazione fra scienze e filosofia non sia solo quella del “limite” - immagine alla quale siamo abituati soprattutto nelle questioni di carattere etico - ma piuttosto quella dell’apertura e del trascendimento.La riflessione filosofica non limita la scienza, impedendole di procede- re nella sua conoscenza, ma piuttosto la fonda e la trascende, offrendole i presupposti che la rendono possibile. Lungo questi percorso, la domanda dello scienziato sui fondamenti del conoscere può diventare apertura al mistero del Fondamento dell’essere. Nel suo volume La mente di Dio, Paul Davies scriveva: «Per quanto le nostre spiegazioni scientifiche possano essere coronate dal successo, esse incorporano sempre certe assunzioni iniziali. Per esempio, la spiegazione di un fenomeno in termini fisici presuppone la validità delle leggi della fisica, che vengono considerate come date. Ma ci si potrebbe chiedere da dove hanno origine queste leggi stesse. Ci si potrebbe perfino interrogare sulla logica su cui si fonda ogni ragionamento scientifico. Prima o poi tutti dobbiamo accettare qualcosa come dato, sia esso Dio, oppure la logica, o un insieme di leggi, o qualche altro fondamento dell’esistenza».
 Molti scienziati - nel passato come nel presente - hanno condiviso la visione che la natura fosse effetto di un Logos creatore. A motivare la loro ricerca è stata la convinzione che esistesse una verità oggettiva, riflesso di un Fondamento increato e meritevole di essere cercata con passione. Francis Collins dichiara di averlo compreso studiando il Dna e restandone tanto colpito da convertirsi da posizioni agnostiche ad un cristianesimo convinto, fino a fondare l’importante Fondazione Bio-Logos per studi su scienza e fede. Non sappiamo se Mendeleev, già cristiano ortodosso, osservando la sua Tavola degli elementi chimici abbia provato un sentimento analogo. Dobbiamo però a lui l’opportunità, 150 anni dopo, di poterlo provare noi.
Molti scienziati - nel passato come nel presente - hanno condiviso la visione che la natura fosse effetto di un Logos creatore. A motivare la loro ricerca è stata la convinzione che esistesse una verità oggettiva, riflesso di un Fondamento increato e meritevole di essere cercata con passione. Francis Collins dichiara di averlo compreso studiando il Dna e restandone tanto colpito da convertirsi da posizioni agnostiche ad un cristianesimo convinto, fino a fondare l’importante Fondazione Bio-Logos per studi su scienza e fede. Non sappiamo se Mendeleev, già cristiano ortodosso, osservando la sua Tavola degli elementi chimici abbia provato un sentimento analogo. Dobbiamo però a lui l’opportunità, 150 anni dopo, di poterlo provare noi.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. - CREATIVITÀ. "Perché l’uomo ha due occhi?" (Ernst Mach).).13 ottobre 2019, di Federico La Sala
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico...
- PERCHÉ L’UOMO HA DUE OCCHI?: «Se ora dunque mi riperete la domanda perché l’uomo ha due occhi, io vi risponderò così. Perché possa osservare attentamente la natura, e comprenda che egli stesso con le sue opioni vere o false con la sua alta ideologia, non è altro che un piccolo e fugace fenomeno della natura. E che, per dirla con Mefistofele, non è che "una parte di una parte". E che è cosa assai assurda "che l’uomo, piccola parodia del mondo,/ si illuda di essere un mondo egli stesso" (Goethe)»(Ernst Mach: cfr. Carlo Rovelli, "In principio c’era Ernst Mach", Corriere della Sera - La Lettura, 13.10.2019, pp. 14-15).
- CREATIVITÀ: «Cominciamo da noi stessi, esseri umani dotati di due mani, di due piedi, due occhi, due orecchi, una testa (con due emisferi cerebrali), una bocca ...
- Limitiamoci a considerare la questione partendo dagli organi della vista, dagli occhi. E’ esperienza comune vedere, ma non è affatto comune - né nella vita culturale né nella vita quotidiana degli esseri umani - pensare nel pieno senso della parola che noi vediamo ciò che vediamo grazie all’azione unitaria e combinata di tutti e due gli occhi; e continuiamo a vedere e a pensare come se - avendo una sola testa (e una sola bocca) - avessimo un solo occhio (un solo orecchio, una sola mano e un solo piede)!» (cfr. Federico La Sala, Creatività: Kant e la critica della società dell’uomo a "una" dimensione. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico).
SCHEDA EDITORIALE*
Ernst Mach
Perché l’uomo ha due occhi?
Nella seconda metà dell’Ottocento, il grande fisico e filosofo Ernst Mach, allora giovane professore alle università di Graz e Praga, organizza una serie di lezioni di «scienza popolare» rivolte a un pubblico non specialistico né accademico, perlopiù femminile.
Tra i temi proposti, spiccano per interesse e originalità le riflessioni sui concetti di simmetria, armonia e prospettiva, considerati secondo una lettura epistemologica in cui le intuizioni filosofiche si confrontano con l’osservazione empirica dei processi naturali. Attraverso esempi presi non solo dall’arte, dalle scienze e dalla storia, ma anche dalla vita quotidiana, Mach riesce a spiegare con ragionamenti scorrevoli e un linguaggio chiaro e diretto questioni classiche della tradizione filosofica e scientifica legate alla percezione visiva e all’esperienza spazio-temporale.
L’uomo, insegna Mach, deve tendere a una comprensione razionale della realtà che lo circonda, senza mai perdere la consapevolezza, però, di essere una piccola parte del tutto.
Ernst Mach
 (Brno-Chrlice, 1838 - Monaco di Baviera, 1916) Fisico e filosofo, insegna prima a Graz e a Praga per poi trasferirsi a Vienna, dove sarà docente di Filosofia della scienza fino al ritiro nel 1901. Sostenitore di un’indagine storico-critica delle idee scientifiche, sviluppa una filosofia empirica in cui i concetti servono a dare ordine ai dati dell’esperienza. La sua critica allo spazio assoluto di Newton ha anticipato la teoria della relatività di Einstein. Ha influenzato un’intera generazione di filosofi e scienziati, e le sue teorie sono state oggetto della tesi di laurea di Robert Musil.
(Brno-Chrlice, 1838 - Monaco di Baviera, 1916) Fisico e filosofo, insegna prima a Graz e a Praga per poi trasferirsi a Vienna, dove sarà docente di Filosofia della scienza fino al ritiro nel 1901. Sostenitore di un’indagine storico-critica delle idee scientifiche, sviluppa una filosofia empirica in cui i concetti servono a dare ordine ai dati dell’esperienza. La sua critica allo spazio assoluto di Newton ha anticipato la teoria della relatività di Einstein. Ha influenzato un’intera generazione di filosofi e scienziati, e le sue teorie sono state oggetto della tesi di laurea di Robert Musil. Prezzo 8.5
Prezzo 8.5
 Anno 2016
Anno 2016
 Pagine 64
Pagine 64* CASTELVECCHI EDITORE
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" ---- Un manuale di nuova botanica: "La mente delle piante. Introduzione alla psicologia vegetale" (U. Castiello).11 ottobre 2019, di Federico La Sala
La coscienza senza cervello
Nella mente delle piante
di Maurizio Corrado (Doppiozero, 11.10.2019)
Il barone rampante è tornato. Questa volta è apparso su di un platano del boulevard Saint-Germain di Parigi, vicino al Ministero della Transizione ecologica, si fa chiamare Thomas Breil e protesta contro l’abbattimento di 25 alberi a Condom, nel Gers. Dopo secoli in cui di Cosimo Piovasco di Rondò si erano perse le tracce, negli ultimi anni è stato avvistato in diversi punti del globo e con nomi diversi, Miranda Gibson su di un eucalipto in Tasmania, Julia Butterfly Hill su una sequoia in California, ma sempre con lo stesso intento: far capire al mondo non solo che le piante sono esseri viventi, ma che sono le uniche che potrebbero aiutarci a non estinguerci miseramente. Quel piccolo meraviglioso trattato di botanica allegra scritto da Calvino nel 1957, molto doveva alla madre di Italo, Eva Mameli Calvino, botanica e naturalista che a lui e all’altro figlio Floriano, poi divenuto geologo, aveva trasmesso la passione e il rispetto per le meraviglie della natura.
Viviamo in tempi in cui i campanelli di allarme non si sentono più perché hanno finito di suonare già da un pezzo, siamo passati alle sirene che urlano che il tempo è scaduto e nel comprensibile panico che precede ogni catastrofe ognuno lancia soluzioni. In questi mesi va molto l’idea di piantare foreste, abbiamo capito che non basta chiedere al sistema industriale di inquinare meno, va anche trovato un modo per eliminare i gas nocivi già presenti e così, mentre le industrie si affannano a trovare sistemi artificiali per sfruttare fino all’ultimo anche questa occasione, altri si ricordano che le piante lo fanno da sempre e lanciano campagne per difendere e aumentare alberi e foreste.
 Con un perfetto tempismo, le più grandi foreste del pianeta vanno letteralmente in fumo. Al primo posto l’Africa, con il 70 % del totale degli incendi, poi l’Amazzonia, la Siberia, la Groenlandia. Ma mentre si discute cercando colpe, parlando di complotti e polmoni verdi, il vero problema sta altrove. Prendo a prestito le parole di un post di Matteo Meschiari: “stanno bruciando ecosistemi irripetibili, epopee botaniche e zoologiche, misteriose biblioteche biochimiche, società complesse di non-umani, regni di senza-nome, tassonomie non registrabili, romanzi indios mai scritti, saggi orali conservati nel permafrost, leggende preverbali, vite. Sarebbe come se bruciasse la Biblioteca Vaticana e si parlasse unicamente di "cellulosa", "pergamena", "inchiostro", "pelle", "schedari", "scaffali", "estintori".” Anche il sonnolento mondo della letteratura si è finalmente accorto dell’importanza delle piante e nel 2019 il Pulitzer è andato a un romanzo che parla di foreste.
Con un perfetto tempismo, le più grandi foreste del pianeta vanno letteralmente in fumo. Al primo posto l’Africa, con il 70 % del totale degli incendi, poi l’Amazzonia, la Siberia, la Groenlandia. Ma mentre si discute cercando colpe, parlando di complotti e polmoni verdi, il vero problema sta altrove. Prendo a prestito le parole di un post di Matteo Meschiari: “stanno bruciando ecosistemi irripetibili, epopee botaniche e zoologiche, misteriose biblioteche biochimiche, società complesse di non-umani, regni di senza-nome, tassonomie non registrabili, romanzi indios mai scritti, saggi orali conservati nel permafrost, leggende preverbali, vite. Sarebbe come se bruciasse la Biblioteca Vaticana e si parlasse unicamente di "cellulosa", "pergamena", "inchiostro", "pelle", "schedari", "scaffali", "estintori".” Anche il sonnolento mondo della letteratura si è finalmente accorto dell’importanza delle piante e nel 2019 il Pulitzer è andato a un romanzo che parla di foreste.- [Foto] Incendio in Siberia.
“Società complesse di non-umani.” Questa può essere una maniera scientificamente corretta di immaginare il mondo vegetale. Negli ultimi decenni si sono moltiplicati gli studi sulle piante e in particolare su quella che potremmo definire la loro “coscienza”. Il dato interessante è che ormai è innegabile che possiedano una qualche forma di intelligenza anche se non sono dotate di un organo centralizzatore come il cervello, cosa che fa scaturire una serie di domande e considerazioni. -Primo, non è necessario avere un cervello per possedere una coscienza. Questo dato apre una girandola di possibilità che, spingendo solo di poco l’acceleratore dell’immaginazione, apre la facoltà di pensiero ad altri sistemi organizzati non dotati di cervello.
 L’altro è che probabilmente dovremmo considerare le piante come portatrici di una vera e propria intelligenza aliena, senza doverla andare a cercare in fantascientifiche ipotesi extraterrestri.
L’altro è che probabilmente dovremmo considerare le piante come portatrici di una vera e propria intelligenza aliena, senza doverla andare a cercare in fantascientifiche ipotesi extraterrestri.Tra gli ultimi lavori che affrontano la sensibilità del mondo vegetale, c’è La mente delle piante, di Umberto Castiello, professore ordinario di Psicobiologia e Psicologia fisiologica nel Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova. Il libro, uscito nel luglio 2019 per Il mulino, ha come sottotitolo Introduzione alla psicologia vegetale, e si potrebbe definire un piccolo manuale di nuova botanica, dove vengono riassunte le ultime ricerche sulla sensibilità delle piante, dai loro sistemi di percezione alla vita sociale.
 Veniamo così a sapere che, in un modo ancora non totalmente chiaro, le piante non solo possiedono facoltà analoghe ai nostri cinque sensi, ma che la loro sensibilità è a volte molto più acuta e precisa. Le piante non solo si muovono ma vedono e hanno preferenze musicali, il canto degli uccelli per esempio determina un aumento dei germogli della zucchina, la rosa cinese fiorisce meglio e allunga i rami quando ascolta musica classica indiana, mentre sembra non gradire la musica rock, anche se lo studio non specifica se le abbiano fatto ascoltare i Motorhead o i Pink Floyd. Hanno un senso del tatto dieci volte maggiore del nostro e anche con l’olfatto non scherzano, il gas etilico ad esempio ha la capacità di far maturare qualsiasi frutto.
Veniamo così a sapere che, in un modo ancora non totalmente chiaro, le piante non solo possiedono facoltà analoghe ai nostri cinque sensi, ma che la loro sensibilità è a volte molto più acuta e precisa. Le piante non solo si muovono ma vedono e hanno preferenze musicali, il canto degli uccelli per esempio determina un aumento dei germogli della zucchina, la rosa cinese fiorisce meglio e allunga i rami quando ascolta musica classica indiana, mentre sembra non gradire la musica rock, anche se lo studio non specifica se le abbiano fatto ascoltare i Motorhead o i Pink Floyd. Hanno un senso del tatto dieci volte maggiore del nostro e anche con l’olfatto non scherzano, il gas etilico ad esempio ha la capacità di far maturare qualsiasi frutto.- [Foto] Copertina di La mente delle piante, di Umberto Castiello, Il mulino, Bologna 2019.
Una delle capacità che le piante hanno dimostrato di possedere è la memoria. Possono conservare informazioni e riattingervi dopo un tempo variabile. Ma tra le proprietà più straordinarie c’è la capacità di interagire non solo con le altre piante, ma con gli animali. Sono in grado di mettere in atto delle vere strategie di sopravvivenza chiamando in causa soprattutto gli insetti. Il melo, ad esempio, quando viene attaccato dagli acari è in grado di mandare messaggi aerei che attraggono acari di una specie nemica di quella che li sta distruggendo, provocando una vera guerra fra insetti. Ma è sottoterra che si svolge la vera vita segreta delle piante. Una rete di funghi collegata alle radici fa in modo che queste possano chimicamente comunicare a distanza e aiutarsi o distruggersi a vicenda. Dimentichiamoci della bucolica visione delle pianticelle tutte fiorelletti e sorrisi che formano l’immagine di una natura armoniosa e in pace. Specialmente fra specie simili, la lotta è aspra e combattuta con armi chimiche. Se a una pianta non va bene una vicina, farà in modo di emettere sostanze che faranno morire la malcapitata senza tanti complimenti.
Sembrano comportamenti umani, ma forse sarebbe più corretto dire che sono i comportamenti umani a essere simili a quelli vegetali. Anche solo considerando l’ordine temporale, non c’è paragone fra la comparsa della vita vegetale e quella umana. Ci sono comportamenti vegetali che hanno milioni di anni. Un esempio. Tra la pianta di manioca e una specie di farfalla c’è un patto che dura da 40 milioni di anni. La manioca può essere impollinata solo da quel tipo di farfalla e la farfalla deposita le uova unicamente nei semi della manioca. Nessuno dei due sopravvive senza l’altro. Ma nessuno dei due può esagerare. Se una farfalla deposita troppe uova, la pianta farà morire il fiore che contiene i semi. Patti chiari, amicizia lunga. Lunga quaranta milioni di anni. Almeno fino al prossimo incendio.
-
> LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" - Kant, il mito delle Danaidi, e l’Alzheimer (di Francesca Rigotti).22 settembre 2019, di Federico La Sala
Fili di pensiero e buchi di memoria. Immanuel Kant e l’Alzheimer
Nell’ultimo decennio della sua vita il filosofo fu affetto da confusione mentale e perdita di memoria: l’intervento di Francesca Rigotti per l’Alzheimer Fest
di FRANCESCA RIGOTTI *
- A Treviso dal 13 al 15 settembre si svolge la terza edizione dell’Alzheimer Fest. Dal dolore nasce una festa, che coinvolge persone affette da demenza, famigliari, medici, operatori, artisti, liberi cittadini. Gli eventi previsti sono circa 150, tutti gratuiti (info su alzheimerfest.it). Qui pubblichiamo un estratto dell’intervento che la filosofa Francesca Rigotti terrà domenica 15 alle 11.30. Sul numero 405 del 1° settembre, «la Lettura» ha anticipato l’originale componimento in versi a staffetta realizzato per l’occasione da Vivian Lamarque, Roberta Dapunt, Flavio Pagano, Stefano Scateni, Giovanna Baglione e altri poeti (con un articolo di Michele Farina). Nel supplemento #406 in edicola fino a sabato 14 settembre, è disponibile l’intervento Donatella Puglia, docente di Lingua e letteratura latina all’università di Siena (anche lei ospite dell’evento).
Parleremo di Alzheimer e di filosofia concentrandoci sulla figura di un filosofo che fu presumibilmente colpito da questa sindrome. Un filosofo che alcuni hanno studiato a scuola, altri solo orecchiato: Immanuel Kant, che nell’ultimo decennio della sua vita fu affetto da confusione mentale e perdita di memoria.
Kant visse tra il 1724 e il 1804, ottant’anni giusti tutti trascorsi a Königsberg, allora nella Prussia orientale, ora Kalinigrad, enclave russa. Alla locale università seguì le lezioni di filosofia, matematica, fisica e dogmatica. È l’autore delle tre critiche (della Ragion Pratica, della Ragion Pura, del Giudizio). Nel campo della morale ha elaborato una dottrina deontologica molto rigorosa basata sul dovere di comportarsi in modo tale che il proprio agire possa diventare massima dell’agire universale (in contrasto con l’utilitarismo e con la dottrina del male minore, capolavoro etico di Tommaso d’Aquino, quella che consiglia di ingoiare tu il rospo piccolo prima che il rospo grande ingoi te). Nel campo teorico-conoscitivo, la dottrina di Kant ha messo al centro della conoscenza il soggetto e le peculiarità del suo apparato conoscitivo categoriale attraverso il quale viene letto e interpretato il mondo.
Un grandissimo filosofo insomma, che proprio perché tale non sfugge allo sport preferito dai piccoli filosofi, che è quello di sparare al grande filosofo. È uno sport di tutti i tempi e di tutte le età, che ai nostri tempi è stato praticato contro Platone (trasformato in fautore dello stato autoritario); Marx (unisono o quasi: «in soffitta, in soffitta!»); Hegel e l’idealismo tedesco (che alcuni professori tedeschi vorrebbero cancellare dal programma di filosofia); Heidegger (ancora quasi un unisono: il bersaglio è facile data l’indulgenza di Martin verso il nazionalsocialismo). Ultimamente ci si è accaniti contro Kant, dapprima attaccando i suoi scritti gnoseologici cui si è voluto dare un bel «good bye», ora rivolgendosi anche alla roccaforte dei suoi scritti etici, troppo rigorosi per la nostra edonista società. Io però sono convinta che lassù, nel cielo dei filosofi, a Platone, Hegel, Marx, Kant, Heidegger e compagni quelle cannonate facciano il solletico.
Anche Kant, dicevo, è oggetto proprio in questi giorni di pesanti bordate che mirano a demolire nientemeno che il suo apparato etico, rigoroso e cogente, non adatto a un’epoca di grandi opportunisti e edonisti di bassa lega pronti a chinarsi a soluzioni di comodo. Ma che cosa c’entra tutto questo con l’Alzheimer? C’entra, c’entra, o almeno vorrei farcelo entrare io mostrando come, se un vero nemico di Kant ci fu, esso fu proprio questa malattia subdola e strisciante che venne a guastare gli ultimi anni di vita del grande pensatore di Königsberg.
Conosciamo bene la biografia di Kant e in particolare gli anni della vecchiaia grazie a ben tre biografie scritte da suoi conoscenti e amici, Borowski, Jachmann e Wasianski, e a un testo letterario del 1827 di Thomas de Quincey, Last days of Immanuel Kant, da cui è stata tratta la suggestiva versione cinematografica, del 1993, del regista francese Philipp Collin, Les derniers jours d’Emmanuel Kant, che purtroppo non posso mostrarvi, neanche un pezzettino. Se siete interessati potete guardarla integralmente su YouTube. Vedrete un anziano signore con parrucca, redingote e scarpini con la fibbia, dagli occhi azzurrissimi (che si possono soltanto immaginare perché il film è in bianco e nero), a volte ancora splendenti di intelligenza, più spesso offuscati dalla malattia che quell’intelligenza si stava portando via. Vedrete un uomo minuto e segaligno, anche se meno magro di come viene descritto nel libro (non portava mai calze nere per non far apparire i polpacci ancora più secchi), vittima del proprio rigore di abitudini di vita, che si autocostringeva a seguire rituali rigidissimi quanto ridicoli per quanto riguarda il dormire (impacchettato strettissimamente tra lenzuola e coperte), il vestirsi, il mangiare, lo scrivere, il fare le passeggiate...
Ma torniamo al Kant filosofo. Oltre che del pensiero critico Kant si interessò, tra l’altro, di estetica, di cosmologia, di antropologia. In relazione a quest’ultimo ambito scrisse nel 1798 una Antropologia dal punto di vista pragmatico, l’ultima opera pubblicata in vita anche se redatta nel corso di anni precedenti . Un’opera senile nella quale Kant tratta, forse non a caso, di memoria e oblio (e qui apro una parentesi per mandare un saluto ossequioso al grande Harald Weinrich, lo studioso autore del più bel libro sull’oblio che sia mai stato scritto e che qui mi ha molto aiutato: Lete. Arte e critica dell’oblio, chiusa parentesi).
Ebbene Kant, che aveva sempre goduto di ottima memoria, trattandone egli stesso teoricamente scriveva che la memoria è importante per prendere parte alle vicende della cultura e della scienza, e per questo la si deve esercitare fin dalla più tenera età. La collega poi ai principi della ragione, soprattutto quella che definisce la terza forma della memoria. La prima infatti, (memoria meccanica), è una specie di facoltà minore, quasi animalesca, con la quale si immagazzina materiale e basta; la seconda (memoria ingegnosa), è un metodo per ricordare attraverso associazioni che non hanno nulla a che fare con il concetto da memorizzare; al gradino più alto sta la memoria giudiziosa, che permette di esercitare scelte opportune e ragionate sui contenuti di memoria, tramite sistemi di classificazione, per es. dei libri delle biblioteche come delle specie naturali; scelte giudiziose perché basate su principi di ragione.
Eppure al teorico della memoria verranno a mancare, paradossalmente, tutte le forme di memoria, condizione che il suo maggior biografo, Wasianski, diacono della chiesa di Tragheim a Königsberg e amico personale e devoto di Kant, tentò di minimizzare e giustificare: «a poco a poco lo colsero le debolezze della vecchiaia, tra cui la mancanza di memoria...». E così continua la descrizione che l’amico diacono effettua delle trasformazioni del filosofo: cominciò a ripetere i suoi racconti più volte nello stesso giorno; vedeva le cose più lontane del suo passato vive e precise davanti a sé, ma il presente, come avviene nei vecchi, gli restava meno impresso; sapeva recitare lunghe poesie tedesche e latine, brani dell’Eneide, senza intoppo, mentre gli sfuggivano le cose apprese un momento prima. Si era accorto anche lui che la memoria gli si affievoliva, sicché annotava le cose su foglietti, buste usate, informi pezzetti di carta. Oltre alla perdita di memoria incominciò a elaborare teorie strampalate, per esempio attribuendo la morìa di gatti a Basilea, Vienna e Copenhagen, a una particolare elettricità dell’aria. Si sentiva debole, astenico. Si addormentava per fiacchezza sulle seggiole, fuori orario; non era in grado di badare al suo denaro, perse la nozione del tempo, talché un minuto gli sembrava esageratamente lungo; l’appetito era sregolato e degenerato (ingollava avidamente bocconi di pane spalmati di burro e premuti su formaggio inglese grattugiato). Si esprimeva in modo sempre meno adeguato e divenne incapace di scrivere il suo nome né riusciva più a figurarsi la forma delle lettere. Il suo linguaggio diventò improprio anche se cercava di spiegarsi con affinità e analogie (parlava di mare e scogli per intendere minestra e bocconi di pane); non riusciva a farsi capire su cose comunissime, poi cominciò a non riconoscere chi gli stava intorno. Non si raccapezzava e allora gridava con voce stridula. Si consumò, e morì il 12 febbraio 1804. La diagnosi di Alzheimer per la «debolezza senile» di Kant venne proposta da Alexander Kurz nel 1992, e poi ripresa e descritta da altri, in particolare Fellin, nel 1997.
Nella sua Antropologia, a proposito della smemoratezza, che Kant chiama obliviositas, il filosofo usa una immagine, per descriverla, con la quale sembra parlare di sè: la smemoratezza è lo stato in cui la testa è come «una botte piena di buchi» (ein durchlöchertes Fass). Per quanto la riempi, rimane sempre vuota, e questo è un grandissimo male (ein größeres Übel). I contenuti versati nella testa scorrono fuori dai buchi come fili d’acqua da un setaccio, e questa perdita rende la mente vuota, sterile.
 Come il vaso che nel mito greco delle Danaidi le spose assassine erano condannate a riempire nell’al di là. E ora racconterò un meraviglioso mito che spiega molte cose di ora e di allora perché il mito tratta di ciò che non è mai e fu sempre.
Come il vaso che nel mito greco delle Danaidi le spose assassine erano condannate a riempire nell’al di là. E ora racconterò un meraviglioso mito che spiega molte cose di ora e di allora perché il mito tratta di ciò che non è mai e fu sempre.Le Danaidi erano le cinquanta figlie di Danaos, re dell’Argolide, regione a nord del Peloponneso, che il padre aveva destinato spose, contro la loro volontà, ai cinquanta figli di Aigyptos, Egitto. Ma durante la prima notte di nozze le ragazze, tranne una, uccisero i loro sposi prima che il matrimonio venisse consumato. Nell’al di là le Danaidi dovevano riempire continuamente d’acqua un recipiente dal fondo bucherellato.
 Io vi leggo un mito di infertilità, desiderata dalle fanciulle ma punita dalla società. Vedo fili d’acqua che escono dai buchi del corpo come vedo, nella metafora kantiana, fili di pensiero che escono dai buchi della mente rendendola sterile e improduttiva come non riproduttivo fu il ventre delle Danaidi.
Io vi leggo un mito di infertilità, desiderata dalle fanciulle ma punita dalla società. Vedo fili d’acqua che escono dai buchi del corpo come vedo, nella metafora kantiana, fili di pensiero che escono dai buchi della mente rendendola sterile e improduttiva come non riproduttivo fu il ventre delle Danaidi.Nel caso del filosofo sono fili di ragionamento che il vecchio professore (Kant aveva insegnato Logica e metafisica nell’Università di Königsberg), non riesce più a annodare, a intrecciare, nemmeno a districare, come si si esprime Kant in un’altra metafora per parlare dello stesso problema. Scrivendo nel 1794 all’allievo Sigismund Beck, Kant così scriveva: «Neppure io riesco a capire...me stesso, e le farò le mie congratulazioni se sarà in grado di mettere in chiara luce uno a uno questi esili fili della nostra facoltà conoscitiva...Districare fili così sottili non fa più per me».
 Con queste parole Kant fornisce almeno due indicazioni; che la sua facoltà di ragionare è carente già nel 1794, e che i pensieri sono fili, nel suo e nel nostro immaginario, che pensa alla mente come a una matassa ingarbugliata (lo «gnommero» del commissario Ingravallo nel Pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda), come a un ciuffo di lana di pecora infilato sulla rocca che attende di essere dipanato e filato dalla mano del pensiero in forma di fili continui, filati, lineari, pronti per essere intrecciati in un tessuto-testo (teXtus).
Con queste parole Kant fornisce almeno due indicazioni; che la sua facoltà di ragionare è carente già nel 1794, e che i pensieri sono fili, nel suo e nel nostro immaginario, che pensa alla mente come a una matassa ingarbugliata (lo «gnommero» del commissario Ingravallo nel Pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda), come a un ciuffo di lana di pecora infilato sulla rocca che attende di essere dipanato e filato dalla mano del pensiero in forma di fili continui, filati, lineari, pronti per essere intrecciati in un tessuto-testo (teXtus).Che cosa succedeva nella mente bucherellata di Kant, da cui uscivano fili che non potevano più essere razionalmente intrecciati? Che essa continuava a lavorare e a pensare, ma in maniera bizzarra. Lo mostra l’episodio del licenziamento del domestico Lampe, Martin Lampe (Lampe è la lampada in tedesco), che aveva seguito e servito il filosofo per quarant’anni, assistendolo in tutte le occasioni, dalla sveglia al mattino alle 5 con il lume a candela, al servizio del pranzo (preparato da una cuoca), all’accompagnamento nelle sue passeggiate ossessive sulle quali la gente di Königsberg regolava le sue attività. Non che Kant fosse molto interessato alla vita privata di Lampe, tant’è che ignorava che fosse stato sposato per diversi anni, e il giorno che il domestico indossò la marsina gialla invece della livrea bianca (e Kant si arrabbiò moltissimo) era perchè andava a risposarsi.
 Ebbene nel 1802 Kant decise di separarsi da questo servo a causa del suo cattivo contegno insorto negli ultimi anni: esigeva supplementi di salario, litigava con la cameriera, e poi commise qualcosa di grave che non ci è dato sapere e su cui Kant così sentenzia: «Lampe ha commesso una tale mancanza che mi vergogno di nominarla». Lampe fu dunque dimesso e al suo posto venne assunto un tale Johann Kaufmann, con il quale il filosofo entrò in
sintonia - dopo un po’ di attrito perché le cose dovevano essere disposte e porte dal domestico sempre nello stesso modo, la teiera/caffettiera, la tazza di caffé/tè, la pipa. A questo punto, decide Kant, «il nome di Lampe va assolutamente dimenticato». E per dimenticarlo meglio che cosa fa? Lo annota su un foglietto di appunti: «dimenticare Lampe». Ma a differenza di quei pensieri che scappavano dai buchi della mente, il nome Lampe non riusciva a uscirgli dalla testa. Weinrich prova a interpretare questo imperativo categorico come un esercizio dell’arte dell’oblio, non dell’arte della memoria, dal momento che proprio le cose che si scrivono (si registrano, si mettono nella memoria, nostra o del computer) possono essere dimenticate. In qualche modo lo scrivere le cose, l’immagazzinarle nella memoria, le consegna all’oblio. Una volta scritte, possiamo anche dimenticarle e di fatto le dimentichiamo. Lo pensava del resto anche Platone, che definisce la vecchiaia l’età della smemoratezza (τό ληθης γηρας, to létes ghêras).
Ebbene nel 1802 Kant decise di separarsi da questo servo a causa del suo cattivo contegno insorto negli ultimi anni: esigeva supplementi di salario, litigava con la cameriera, e poi commise qualcosa di grave che non ci è dato sapere e su cui Kant così sentenzia: «Lampe ha commesso una tale mancanza che mi vergogno di nominarla». Lampe fu dunque dimesso e al suo posto venne assunto un tale Johann Kaufmann, con il quale il filosofo entrò in
sintonia - dopo un po’ di attrito perché le cose dovevano essere disposte e porte dal domestico sempre nello stesso modo, la teiera/caffettiera, la tazza di caffé/tè, la pipa. A questo punto, decide Kant, «il nome di Lampe va assolutamente dimenticato». E per dimenticarlo meglio che cosa fa? Lo annota su un foglietto di appunti: «dimenticare Lampe». Ma a differenza di quei pensieri che scappavano dai buchi della mente, il nome Lampe non riusciva a uscirgli dalla testa. Weinrich prova a interpretare questo imperativo categorico come un esercizio dell’arte dell’oblio, non dell’arte della memoria, dal momento che proprio le cose che si scrivono (si registrano, si mettono nella memoria, nostra o del computer) possono essere dimenticate. In qualche modo lo scrivere le cose, l’immagazzinarle nella memoria, le consegna all’oblio. Una volta scritte, possiamo anche dimenticarle e di fatto le dimentichiamo. Lo pensava del resto anche Platone, che definisce la vecchiaia l’età della smemoratezza (τό ληθης γηρας, to létes ghêras).
 Nel dialogo Fedro infatti, a proposito dell’invenzione della scrittura da parte del dio egiziano Theuth, che presenta la sua invenzione come medicina per la memoria e per la sapienza, così commenta il saggio re Thamus, le cui opinioni riflettono quelle di Platone: «Ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di dar vita alle arti e chi invece di giudicare quale danno o quale vantaggio comportano per chi se ne servirà. E ora tu, che sei il padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa infatti, (la scoperta della scrittura) produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l’avranno imparata, perché fidandosi della scrittura non fanno esercitare la memoria. Infatti, facendo affidamento sulla scrittura, essi trarranno i ricordi dall’esterno, da segni estranei, e non dall’interno, da se stessi».
Nel dialogo Fedro infatti, a proposito dell’invenzione della scrittura da parte del dio egiziano Theuth, che presenta la sua invenzione come medicina per la memoria e per la sapienza, così commenta il saggio re Thamus, le cui opinioni riflettono quelle di Platone: «Ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di dar vita alle arti e chi invece di giudicare quale danno o quale vantaggio comportano per chi se ne servirà. E ora tu, che sei il padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa infatti, (la scoperta della scrittura) produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l’avranno imparata, perché fidandosi della scrittura non fanno esercitare la memoria. Infatti, facendo affidamento sulla scrittura, essi trarranno i ricordi dall’esterno, da segni estranei, e non dall’interno, da se stessi».Se consegno la nozione allo scritto, insomma, la tolgo dalla memoria, la dimentico, e in più indebolisco la memoria stessa. Dimentico, faccio cadere fuori dai buchi della testa, dalla mente, de-mente, demente.
Cent’anni dopo la morte di Kant il medico dei pazzi Alois Alzheimer diagnosticò il morbo che da lui prese il nome: un morbo preciso dunque, una malattia da curare. Non di generica debolezza senile soffriva Kant, quanto di una malattia specifica. Probabilmente qualcuno lo sospettò già prima, ma soltanto nel 1992 il sospetto venne scritto e assunse la forma di certezza. Cosa che apre un altro quesito filosofico riguardante l’attacco innescato pochi anni fa dai filosofi newrealisti contro i pensatori postmodernisti. Alcuni di questi (v. Bruno Latour) hanno sostenuto che il faraone Ramsete non potè morire di tubercolosi (come avrebbero provato alcune moderne autopsie) perchè il bacillo di Koch non era ancora stato isolato. Il che filosoficamente corrisponde a sostenere che «sapere che x» equivale a «essere costitutivo dell’essere x», ovvero afferma che Kant non potè soffrire di Alzheimer perché la malattia non era stata ancora individuata e battezzata. Argomento che secondo alcuni discenderebbe direttamente dalla «rivoluzione copernicana» introdotta da Kant, il quale pose il soggetto/sole al centro della conoscenza/sistema solare, affermando che il soggetto comprende la realtà attraverso le proprie categorie e assegnando dunque al nostro intelletto un ruolo fortemente attivo nel metodo conoscitivo; sono i nostri schemi mentali che determinano il modo in cui un oggetto viene percepito. Ma mentre la prima conclusione (Kant non potè soffrire di Alzheimer perché la malattia non era stata ancora inventata/scoperta), è assurda, non lo è per nulla la seconda conclusione (la centralità del soggetto nella comprensione dei fatti e l’idea che le proposizioni scientifiche in grado di ampliare il nostro sapere sul mondo non si limitano a recepire passivamente dei dati, ma sono di natura critica e deduttiva). Non possiamo però occuparci a fondo della diatriba perchè il discorso ci porterebbe troppo lontano. La lasciamo lì, insieme al marasma senile del povero Kant, e alle sue occupazioni delle ultime settimane di vita, quali togliere e riannodare continuamente la cravatta, abbottonare e sbottonare la veste, in uno stato di continua agitazione, finché, come scrive un altro biografo, Jachmann, «svanì a mano a mano il vigore del più grande filosofo fino alla sua completa impotenza intellettuale».
-
>LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- Teologia e cosmologia in dialogo seguendo Teilhard de Chardin. L’astrofisico Piero Benvenuti rilancia l’eredità del gesuita.20 settembre 2019, di Federico La Sala
Scienza e fede.
Teologia e cosmologia in dialogo seguendo Teilhard de Chardin
L’astrofisico Piero Benvenuti rilancia l’eredità del gesuita: «Suo il merito di avere intuito il valore rivoluzionario dell’evoluzione del cosmo. Ora serve una nuova teologia della natura»
di Piero Benvenuti (Avvenire, giovedì 19 settembre 2019)
- [Foto] Il gesuita Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) in India negli anni Trenta
Nel novembre 2017, durante la prima sessione dell’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, il cui tema era “Il futuro dell’umanità”, il nome di Teilhard de Chardin venne evocato più volte, tanto che lo spirito del gesuita sembrava aleggiasse nell’aula. Forse fu proprio lui a darmi l’ispirazione di proporre ai partecipanti, dopo la pausa caffè del pomeriggio, di scrivere a papa Francesco perché considerasse la possibilità di revocare il Monitum del 1962 che ancora grava sulle sue opere.
In fondo, non solo gli autorevoli membri del Consiglio ritenevano l’intuizione profetica di Teilhard quanto mai attuale e rilevante nel discutere il futuro dell’Uomo e del Cosmo, ma anche gli ultimi pontefici avevano più volte citato il suo pensiero nelle loro Encicliche. La proposta fu accolta con entusiasmo, manifestato da un estemporaneo caloroso applauso, e il giorno seguente la lettera, approvata dall’Assemblea, venne firmata da più di quaranta partecipanti e inviata al Santo Padre attraverso i canali ufficiali.
La risposta, arrivata qualche tempo fa a firma del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, riporta il parere della Congregazione per la Dottrina della Fede che non ritiene opportuna la rimozione del Monitum in quanto «...non ha perso il suo significato come ammonimento per una valutazione serena di alcune discutibili proposte filosofico-teologiche negli scritti di padre Pierre Teilhard de Chardin».
Nonostante il parere negativo, la risposta precisa il significato del Monitum, aggiornandolo: innanzitutto commenta positivamente gli sforzi del gesuita nel riavvicinare costruttivamente i progressi della scienza con la fede cristiana e conclude esortando gli studiosi «...ad approfondire lo studio delle ambiguità presenti negli scritti dell’autore, con l’auspicio di poter giungere ad ulteriori chiarificazioni».
Quest’ultima importante esortazione - si legge nella risposta - è condivisa da papa Francesco ed è significativo che coincida temporalmente con la pubblicazione della costituzione apostolica Veritatis gaudium, il cui proemio rappresenta un possente invito al rinnovamento degli studi teologici.
Questa coincidenza stimola alcune riflessioni sulla relazione tra la moderna cosmologia (ovvero la filosofia della natura) e la teologia. Non c’è dubbio infatti che, al di là di alcuni aspetti controversi del pensiero di Teilhard, il suo merito principale consista nell’avere intuito il valore rivoluzionario dell’inattesa caratteristica fondamentale del cosmo, ovvero la sua evoluzione unitaria e globale.
Intuizione doppiamente meritoria tenendo conto che all’epoca eravamo appena agli albori della nuova cosmologia, nata nel 1927 per opera di un altro sacerdote cattolico, il belga George Lemaître. Infatti, risolvendo le equazioni della relatività generale di Einstein applicate a tutto l’universo, Lemaître dimostrava teoricamente e verificava sperimentalmente che il cosmo si espandeva ed era quindi «in divenire».
A riprova che il fatto fosse totalmente inatteso, basti ricordare l’istintiva reazione di Einstein che, pur riconoscendo la correttezza della soluzione matematica di Lemaître, gli disse senza mezzi termini: «La sua ipotesi fisica è abominevole»... per poi ricredersi quando gli ulteriori dati osservativi sgombrarono ogni dubbio sulla natura evolutiva dell’universo.
Non c’è da meravigliarsi quindi che anche in campo teologico le conseguenze di questa rivoluzione cosmica fossero a prima vista difficili da accettare, ma oggi non è più così: la storia dell’universo che si dipana per quasi 14 miliardi di anni attraversando fasi diversissime, con accelerazioni e rallentamenti temporali, diversificandosi in una trama di strutture e organismi imprevedibili, fino a raggiungere la coscienza, tutto questo richiede con forza una revisione radicale della filosofia della natura, sinora erede della tradizione greca.
Per usare un termine caro a Thomas Kuhn, siamo di fronte a un cambio di paradigma, simile a quello che precede le grandi rivoluzioni scientifiche, e come in quei casi, l’abbandono di schemi mentali consolidati, come la suddivisione netta tra materia inanimata, vita vegetale, vita animale e infine - essenzialmente diverso - l’essere cosciente, può essere traumatico e richiede coraggio e onestà intellettuale.
Di fronte a questa nuova situazione la teologia non può più rimanere inerte: è già positivo aver recuperato, grazie agli stimoli della nuova cosmologia, il concetto di Creazione che Tommaso d’Aquino aveva lucidamente individuato già nel XIII secolo: «Risulta con chiarezza l’incongruenza di chi ricerca la creazione con argomenti desunti dalla natura dell’universo o dalla sua evoluzione... La creazione infatti non è una mutazione, ma è la dipendenza stessa dell’essere creato in rapporto al principio che lo fa esistere. Essa appartiene quindi alla categoria di relazione» (Summa contra Gentiles, II, 18).
Se per Tommaso la Creatio continua è quindi un atto a-temporale che sostiene in esistenza tutta la realtà, oggi sappiamo che essa possiede anche la caratteristica di essere in divenire, di non essere ancora giunta a compimento: come una sorgente vivace il cosmo evolvente ci ha stupito nel corso di 13,8 miliardi di anni facendo emergere strutture sempre più diversificate e complesse, inattese e imprevedibili, ma tutte parte della stessa unica narrazione.
Cosa ci riserva l’evoluzione/ creazione nel futuro? Ecco la domanda che affascinava Teilhard e alla quale ha cercato con passione di dare una sua personale risposta che non poteva allora, come non può oggi, essere disgiunta dalla rivelazione cristiana che apre la speranza all’avvento della basileia ton ouranon, del Regno dei Cieli.
Domanda ancor più attuale per l’uomo d’oggi che non solo ha conosciuto il carattere evolutivo dell’universo di cui è parte, ma sta apprendendo anche i meccanismi della sua evoluzione e li può controllare e indirizzare. La nostra chiamata in causa come co-creatori è sempre più impellente e richiede a sostegno una adeguata Teologia della Natura.
Quest’ultima potrebbe essere uno dei primi risultati dell’accorato appello della Veritatis gaudio per un rinnovamento degli studi teologici. Purtroppo la seconda parte della Costituzione apostolica, pur scontando lo stile necessariamente più formale di una normativa universitaria, non sembra recepire in pieno lo slancio innovativo del proemio. Si parla indubbiamente della necessità di una maggiore interdisciplinarietà negli studi, ma il riferimento è generico ad «...altre scienze, in primo luogo le scienze umane» e comunque non si riferisce alle Facoltà propriamente teologiche per le quali la massima attenzione, per quanto riguarda l’interdisciplinarietà, rimane ancora concentrata sullo studio della filosofia.
È sintomatico che la Cosmologia e la Filosofia (o Teologia) della Natura non siano mai nominate, come se la prima fosse equiparabile a una qualunque altra disciplina scientifica e la seconda non più materia di studio della Filosofia, ma unicamente della Scienza.
 Il cambio di paradigma intuito da Teilhard è oggi così evidente che andrebbe approfondito con determinazione in almeno alcune Facoltà teologiche, che potrebbero specializzare i propri studi verso una nuova Teologia della Natura, anche seguendo i molti spunti contenuti nell’enciclica Laudato si’.
Il cambio di paradigma intuito da Teilhard è oggi così evidente che andrebbe approfondito con determinazione in almeno alcune Facoltà teologiche, che potrebbero specializzare i propri studi verso una nuova Teologia della Natura, anche seguendo i molti spunti contenuti nell’enciclica Laudato si’.In questa prospettiva sarebbe auspicabile e sicuramente accolta con entusiasmo una stretta collaborazione con le Facoltà scientifiche laiche che si occupano di Cosmologia e di materie correlate, sgombrando così il campo da ogni artificiale separazione tra Scienza e Fede. Se tale ipotesi non si realizzasse, l’ormai ineludibile sviluppo di una nuova Teologia della Natura avverrà comunque, ma si concretizzerà al di fuori delle Università Cattoliche con immaginabili spiacevoli conseguenze che sarebbe opportuno evitare a ogni costo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Gioacchino da Fiore ... e Teilhard de Chardin
 IL PATRONO DELLA "RETE" E IL TEORICO DEL "DISEGNO INTELLIGENTE": Teilhard de Chardin (1881 - 1955)
IL PATRONO DELLA "RETE" E IL TEORICO DEL "DISEGNO INTELLIGENTE": Teilhard de Chardin (1881 - 1955)
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!)
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- Dove sono le finestre? La costruzione del racconto secondo Richard Yates (di Francesca de Lena).6 settembre 2019, di Federico La Sala
Il racconto secondo Yates
Dove sono le finestre? La costruzione del racconto secondo Richard Yates
di Francesca de Lena (osservatorio-cattedrale, july 27, 2017)
“Costruttori” di Richard Yates ha tutte le cose che non sopporto trovare in un racconto. Ha una ’voce fuori campo’ che introduce la storia. Ha uno scrittore sfortunato e senza soldi per protagonista. Si chiude con una domanda. Eppure.
Eppure, “Costruttori” - uno dei racconti di Undici solitudini pubblicato in Italia da minimum fax - è per me il padre e la madre di qualsiasi cosa c’entri con la letteratura, con la bellezza di leggere, con la bellezza di scrivere, con la perfezione della forma racconto, con le mie idee sulla vita e con il mio lavoro. Conoscevo Carver, conoscevo Cheever e, naturalmente, conoscevo Hemingway e Flannery ‘O Connor, e li amavo.
 Ma Yates. Avete mai letto un racconto come “Costruttori” di Richard Yates?
Ma Yates. Avete mai letto un racconto come “Costruttori” di Richard Yates?La voce fuori campo è la voce di Yates che non riesce a restarsene fuori e lasciar parlare la storia per sé, e che non riesce a far esordire un protagonista scomodo senza avvisare: “guardate che questo protagonista è scomodo”. La maggior parte delle storie non ha bisogno del proprio autore che si metta in mezzo e le rovini e infatti anche “Costruttori” non è che ne avesse proprio bisogno, narrativamente parlando. Però Yates lo fa lo stesso. In sedici righe scrive un’analisi intima e lucidissima sul mal di scrivere di scrittori e aspiranti scrittori, e così facendo vivacizza tutto il racconto, che si trasforma in una visione ironica e malinconica di queste due categorie di persone che a vicenda non si sopportano e che però continuano a vivere insieme, a cercarsi e a farsi compagnia nella speranza che il mal di vivere passi.
Lo scrittore sfortunato e senza soldi si chiama Bob Prentice, un ventiduenne che nel 1948 è già stato in guerra, ha già una moglie di nome Joan e deve già sbarcare il lunario scrivendo nella redazione finanziaria della United Press, cose di cui non capisce niente per cinquantaquattro dollari la settimana. La sera Bob torna a casa e si rintana dietro un paravento con l’idea di scrivere finalmente le sue cose. Invece perde tempo, si guarda intorno, legge il giornale, e una di queste sere trova l’annuncio di Bernard Silver. Bernie non è uno scrittore e neanche un aspirante scrittore, è solo un tassista che cerca qualcuno che gli scriva un libro in cui lui è il protagonista delle storie da tassista che ci sono scritte dentro. E questa strana aspirazione di Bernie rientra nell’insofferenza del mal di scrivere come molte altre cose del racconto, cose che si potrebbero definire ’elementi sulla narrazione’ oppure la ’visione poetica’ dell’autore o anche ’le cose che Richard Yates vuole dire sulla questione dello scrivere’, e di cui si potrebbe fare una lista in 9 punti:
 1. l’incipit: “Gli scrittori che scrivono di scrittori possono produrre facilmente il peggior genere di aborti letterari”
1. l’incipit: “Gli scrittori che scrivono di scrittori possono produrre facilmente il peggior genere di aborti letterari”
 2. l’adesione all’onestà nello scegliere le parole: un cappello è cincischiato, non consunto dall’uso
2. l’adesione all’onestà nello scegliere le parole: un cappello è cincischiato, non consunto dall’uso
 3. il parallelo che ogni scrittore cerca con Hemingway e la cosa importante di scrivere che è: cominciare
3. il parallelo che ogni scrittore cerca con Hemingway e la cosa importante di scrivere che è: cominciare
 4. la consapevolezza che non devi perdere: quando tua moglie definisce il tuo racconto meraviglioso e tu sai che non vale niente
4. la consapevolezza che non devi perdere: quando tua moglie definisce il tuo racconto meraviglioso e tu sai che non vale niente
 5. il disprezzo degli scrittori per quelli che di scrivere non ne capiscono niente ma vogliono per forza parlarne
5. il disprezzo degli scrittori per quelli che di scrivere non ne capiscono niente ma vogliono per forza parlarne
 6. il fatto che dietro a ogni storia non vera ci sia almeno un granello di verità
6. il fatto che dietro a ogni storia non vera ci sia almeno un granello di verità
 7. la consuetudine di tutti i tempi a non retribuire la scrittura: «Ah, ma non mi fraintenda Bob. Non ho mai chiesto a nessuno scrittore di scrivermi una sola parola solo sulla base di ipotetici guadagni futuri».
7. la consuetudine di tutti i tempi a non retribuire la scrittura: «Ah, ma non mi fraintenda Bob. Non ho mai chiesto a nessuno scrittore di scrivermi una sola parola solo sulla base di ipotetici guadagni futuri».
 8. la celebre citazione da Pascal: «Supponga che qualcuno le scriva una lettera dicendo: “Bob, oggi non ho avuto tempo di scriverti una lettera breve, perciò ho dovuto scrivertene una lunga”».
8. la celebre citazione da Pascal: «Supponga che qualcuno le scriva una lettera dicendo: “Bob, oggi non ho avuto tempo di scriverti una lettera breve, perciò ho dovuto scrivertene una lunga”».
 9. l’inclusione dello storytelling nelle forme di narrazione: «Ma Bernie, non vedo come potrà funzionare. Non si può scrivere un “racconto” spiegando perché qualcuno è l’uomo di cui abbiamo bisogno al Congresso». «Chi dice che non si può?»
9. l’inclusione dello storytelling nelle forme di narrazione: «Ma Bernie, non vedo come potrà funzionare. Non si può scrivere un “racconto” spiegando perché qualcuno è l’uomo di cui abbiamo bisogno al Congresso». «Chi dice che non si può?»E poi c’è il punto 10. Ed è il dialogo con cui Yates costruisce l’immagine più universale che sia mai stata pensata per definire la forma racconto:
Una casa, cioè, bisogna che abbia il tetto. Ma ci troveremmo nei pasticci se cominciassimo a costruirla dal tetto, no? Prima del tetto si devono costruire le mura, no? E prima delle mura si devono gettare le fondamenta, no? E così via. Prima delle fondamenta si deve scavare nel terreno una bella fossa, vero? Ho ragione?» [...] E allora? Qual è la prima domanda che deve porsi a opera compiuta?
E qui arriva la perla, che Yates regala a Bernie (il non scrittore) piuttosto che a Bob (lo scrittore) e che per questo diventa ancora più lucente:
Dove sono le finestre?
La domanda a cui Bob non sa rispondere alla fine del racconto è dove siano le finestre nella storia che ha appena finito di costruire e che riguarda l’illuminazione nella sua vita, ed è la stessa che noi lettori di racconti ci poniamo ogni volta che apriamo un libro, e che noi esseri umani ci poniamo ogni volta che ci svegliamo al mattino: da dove entra la luce? Perché se il mal di scrivere colpisce scrittori e aspiranti tali, e anche persone come Bernie che con la scrittura c’entrano poco, il mal di vivere colpisce davvero chiunque e chiunque lo comprende, ed è in quella universalità che s’annida la letteratura.
L’idea che ha Yates della letteratura prende sempre la forma di racconto. Anche quando scrive romanzi, e anche nel suo romanzo migliore e più conosciuto, “Revolutionary Road”, resta un autore di forme brevi, che chiude su scene casalinghe e prive di enfasi, su elementi che, fino a un attimo prima, parevano di secondo piano. Perché? Perché Yates non vuole solo raccontare una storia, e non vuole solo dire la sua, e non vuole neanche oggettivare un’idea, un’ossessione. Lui vuole fare una cosa difficilissima ma che gli è indispensabile e questa cosa è: dire la verità. La verità che è, certo, quella e solo quella per una specifica storia e per i suoi personaggi, ed è innanzitutto la sua verità. Ma è anche - lo diventa: deve diventarlo - la verità per chi legge. Il lettore di racconti non vuole solo capire cosa narra la storia che ha di fronte, e non gl’interessa più di tanto commuoversi o arrabbiarsi o parteggiare per qualcuno. Il lettore di racconti vuole assolutamente credere in qualcosa: vuole credere che quella che sta leggendo sia la verità - e che sia tutta lì, e che non ci sia nient’altro da dire.
La parte migliore di “Costruttori” non sta nella trama o nelle perle sulla narrazione. Non sta neanche nella lucida ricostruzione della propria biografia, con l’esperienza di guerra, il matrimonio fallito, la costante ricerca di un lavoro che gli consenta di scrivere. La sua illuminazione sta in un punto che con la scrittura e l’essere scrittori non c’entra proprio nulla. -In quel punto c’è solo la fotografia di un trombettiere, un giovanissimo e fiero Bernie sull’attenti che si preme contro la bocca la sua semplice ed eloquente tromba. Un’immagine da copertina alla quale Bob stenta a credere, lui che in guerra ci è stato proprio come ci è stato Bernie, come ci è stato Hemingway e come, in un modo o nell’altro, ci siamo stati tutti noi. -Un’immagine che gli fa venire in mente: come si può vivere così? E alla quale, per fortuna, e per una volta, Yates risponde con una verità che tenta di salvarci: “Dio lo sa, Bernie, Dio lo sa che una finestra ci dovrebbe essere da qualche parte, per ciascuno di noi”.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE - Il Politecnico di Zurigo sta valutando la proposta: una laurea postuma per la moglie di Einstein, Mileva Maric (di Gabriella Greison).13 luglio 2019, di Federico La Sala
Una laurea postuma per la moglie di Einstein, la scienziata dimenticata
Il Politecnico di Zurigo sta valutando la proposta. Mileva Maric abbandonò gli studi dopo il matrimonio. Ma fu una collaboratrice fondamentale del marito
di GABRIELLA GREISON (la Repubblica, 13 luglio 2019)
- [Foto] Mileva Maric e i figli
QUESTA è una storia bellissima. Una storia che non ha ancora una fine. E proprio come in tutte le storie senza ancora una fine, siamo noi i protagonisti della vicenda, che con le parole, il linguaggio, la diffusione, possiamo cambiare le cose per come sono sempre andate. Perché il linguaggio è potere, e le idee non si possono cancellare.
Per raccontarvi questa storia devo partire da lontano. 1896, Politecnico di Zurigo, Svizzera. Mileva Maric aveva un sogno nella vita: diventare fisica. A quei tempi per le donne non era facile realizzarsi nella scienza, venivano ostacolate in tutte le maniere. Marie Curie doveva autofinanziarsi il lavoro, quando con Pierre faceva gli esperimenti sul radio; Lise Meitner poteva solo siglare i suoi articoli, per non mostrare al mondo che era una donna; Rosalind Franklin doveva entrare dal portone posto sul retro, e non da quello principale, per raggiungere il laboratorio. Mileva però si iscrive al Politecnico, riesce nell’impresa, e inizia il suo percorso come fisica. Inizia anche la storia d’amore con Albert Einstein, che conosce tra i banchi. Studiano insieme, e passano i primi esami.
Mileva ne sa molto più di Einstein, ma non è questo il punto. Mileva resta incinta. Mileva e Albert hanno il primo figlio (illegittimo, una femmina, Lieserl, muore pochi mesi dopo di malattia). Mileva riprende i corsi, si sposa con Einstein, resta incinta di nuovo, e poi di nuovo. Viene bocciata. Si iscrive di nuovo, per riuscire a finire l’ultimo anno, ma alcuni professori e la società sessista del tempo le impediscono di andare avanti. Figuriamoci: una donna, una donna perdippiù con due figli, una donna perdippiù sposata con Einstein (a quei tempi non veniva visto di buon occhio dai professori vecchio stampo, quelli che lui chiamava ’paludati cattedratici’), ma dove voleva andare... Una laurea e, oltraggio maximo, un dottorato non potevano che essere un miraggio. La storia tra Mileva e la scienza finisce così.
Ora arrivo alla notizia di questi giorni. Io sono divulgatrice, con un passato da fisica sperimentale. Mi sono laureata a Milano e ho lavorato due anni all’Ecole Polytechnique, tra le varie cose. Ma non siamo qui per parlare di me. Ma del fatto che la fisica, da sempre, è considerata una disciplina per uomini. La fisica nel secolo XIX era lo svago degli uomini della ricca borghesia. Gli svaghi per le donne erano altri: curare i malati, accudire i figli, tenere in ordine la casa. In particolare, ho scritto due libri su Mileva, e in generale le donne nella scienza: “Einstein e io” (Salani editore) e “Sei donne che hanno cambiato il mondo” (Bollati Boringhieri), da cui ho tratto uno spettacolo teatrale “Einstein & me” (produzione Teatro Brancaccio di Roma) in cui faccio rivivere le vicende di Mileva in prima persona. Quest’anno ho fatto quasi un centinaio di repliche, e l’autunno scorso l’ho portato anche a Zurigo, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura. Quando sono tornata a Zurigo (le mie ricerche per scrivere il romanzo e il monologo sono partite proprio da lì) ho fatto una proposta al Politecnico: attribuire una laurea postuma a Mileva. Come segnale che le cose adesso stanno cambiando. Un simbolo, per dare conforto alle nuove generazioni.
La notizia è che proprio qualche giorno fa mi hanno risposto ufficialmente dal Politecnico di Zurigo: mi hanno detto che la proposta è sul tavolo delle discussioni, e entro fine luglio mi arriverà la risposta (parole sottoscritte dal Presidente della facoltà). Oggi il quotidiano Tages-Anzeiger in tedesco ha diffuso e appoggiato l’iniziativa, con una lunga intervista.
La battaglia delle donne a perseguire il coinvolgimento nelle arene della scienza continua, è una battaglia molto dura. Nella storia della scienza (e non solo) alcune donne vengono cancellate. Alcune un po’ alla volta, altre di colpo. Alcune ricompaiono. Alcune ricompaiono grazie ad altre donne che le tirano fuori e le raccontano. Ogni donna che appare, lotta contro le forze che vorrebbero farla sparire. Lotta anche contro le forze che vorrebbero raccontare una storia al posto suo. O depennarla dalla storia. Ma oggi ho una consapevolezza in più, malgrado la fatica, tutto questo non sta andando indietro. E tutto questo sarà di buon auspicio per le nuove generazioni.
Ps: Devo aggiungere una postilla, a questo racconto. L’idea di questa domanda di una laurea postuma a Mileva al Politecnico di Zurigo è nata a una ragazza che frequenta la quarta liceo a Schio. Autunno scorso avevo fatto il monologo nel loro teatro, e alla fine mi ha fermato nel foyer una ragazza che si chiama Arianna, per chiedermi di portare avanti questa proposta. Io l’ho presa sul serio, come sempre vanno presi sul serio i ragazzi. Ed ecco che siamo arrivati a oggi. Con la proposta che deve essere discussa, e che mi daranno la loro risposta appena ne avranno formulata una. Aspettiamo la fine di luglio allora. Con una convinzione in più: non sto camminando da sola. Perché il linguaggio è potere, e le idee non si possono cancellare.
-
>LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" - “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”. IN MEMORIA DI ENRICO FILIPPINI E DI MICHEL SERRES.6 giugno 2019, di Federico La Sala
PER UN NUOVO CNR ....
NOTE A MARGINE DELLA LETTERA "Al CNR la storia è una scienza? Una risposta all’intervento di Gilberto Corbellini"
- Recensendo un volume dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa. [...] (ALFABETA-2, 26 MAGGIO 2019)
1. PER LA STORIA DELLLA SCIENZA E PER LA SCIENZA DELLA STORIA, FORSE, E’ MEGLIO RI-DISCENDERE “SOTTO COVERTA DI ALCUN GRAN NAVILIO” E RIPRENDERE IL LAVORO GALILEANO DELLA CONVERSAZIONE E DELLA CONOSCENZA 29 Maggio 2019 :
- «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. (..)
 Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
2. STORIA, SCIENZA, ED ECLISSI. Da Galileo Galilei ad Albert Einstein 30 maggio 2019...
Al di là delle pretese “mitideologiche” (atee e devote) del “post-positivismo” contemporaneo (Paolo Fabbri) di dare il via a un’ epoca in cui la storia del mondo dev’essere riscritta secondo l’indicazione rosenberghiana!), ricordiamo che il 29 maggio 1919 Arthur Eddington provò sperimentalmente la teoria della relatività (cfr. : Franco Gabici, “Cento anni fa l’eclissi che diede ragione a Einstein” - https://www.avvenire.it/agora/pagine/cento-anni-fa-leclissi-che-diede-ragione-a-einstein). Buon lavoro!
3. COSTITUZIONE E CNR. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO (SCIENTIFICO) DI LUNGA DURATA 31 Maggio 2019...
CONDIVIDO LA PREOCCUPAZIONE E, AL CONTEMPO, LA CONSAPEVOLEZZA dei firmatari della lettera. La “provocazione” - da parte di chi dirige il Dipartimento del CNR, “al cui interno operano decine di storici, storici della filosofia, giuristi e altri ricercatori nel campo delle scienze umane e sociali” - evidenzia il sintomo non tanto e non solo “di un profondo problema culturale e scientifico”, ma anche e soprattutto di un problema politico-filosofico (metafisico), costituzionale, di CRITICA della “ragion pura” (di questo parla il “principio della relatività galileiana”, condensato nel “Rinserratevi” del “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”)!,
DOPO GALILEI, DOPO KANT, DOPO EINSTEIN, DOPO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA... UNA “PROVOCAZIONE” al CNR DA ACCOGLIERE!
Strana “coincidenza”, oggi!:
- A) Il 9 Aprile 2019, in una nota (dal titolo
“CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. A che gioco giochiamo?!: https://www.alfabeta2.it/2019/03/31/marcel-detienne-memorie-felici-e-concetti-indelebili/#comment-639227), così scrivevo:
 “La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
“La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
- B) Il 12 maggio 2019, “recensendo un volume - come scrivono gli studiosi e le studiose del CNR - dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa”.
Prima che sia troppo tardi, che fare?! Alle studiose e alle studiose di scienze umane e sociali (del CNR e non solo), consiglierei (mi sia permesso) la ri-lettura del “Dialogo sopra i due massimi sistemi iolemaico e copernicano” di Galileo Galilei, la ri-lettura dei “Sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica” di Immanuel Kant, e, infine, la rilettura dei “Principi” della Costituzione della Repubblica Italiana - e, alla luce della “ferocissima” provocazione, ri-prendere il lavoro storiografico-scientifico con più grande entusiamo e responsabilità di prima!
VIVA IL CNR,
VIVA L’ITALIA!
4. PER UN NUOVO CNR! ALL’INSEGNA DI ERMES: “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”. IN MEMORIA DI ENRICO FILIPPINI E DI MICHEL SERRES 3 Giugno 2019 ...
“[...] all’insegna di Ermes, che per me è il simbolo della scienza contemporanea”.
 In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
 Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
 In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
 Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
 L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
 (cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).
(cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).5. STORIA E SCIENZA: “VICISTI, GALILAEE” (KEPLERO, 1611) 5 Giugno 2019.
La rotazione della Terra rimescola le acque del lago di Garda ... http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2019/06/05/la-rotazione-della-terra-rimescola-le-acque-del-lago-di-garda-_8cbe9d78-1459-4088-a0a4-12016cd675b9.html.
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA -- Fotografato un buco nero. L’esistenza prevista dalla teoria della relatività generale proposta da Albert Einstein proprio cento anni fa, nel 1919.12 aprile 2019, di Federico La Sala
Astrofisica.
Fotografato un buco nero: «Abbiamo visto l’invisibile»
A rivelare il buco nero è stata la sua ombra, che appare come una sorta di anello rossastro. Quello fotografato è al centro della galassia Virgo A (M87), distante dalla Terra 55 milioni di anni luce
di Piero Benvenuti (Avvenire, mercoledì 10 aprile 2019)
- [Foto] Quella del buco nero è stata definita la "foto del secolo"
«Abbiamo visto l’invisibile!»: questo il paradossale annuncio fatto ieri alla National Science Foundation dai portavoce di un gruppo internazionale di astronomi che, dopo anni di pazienti e caparbi sforzi, sono riusciti a fotografare un buco nero (con una massa equivalente a 6,5 miliardi di masse solari, che si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra, al centro della galassia Messier 87) o, più correttamente, la sua ombra cosmica. Infatti un buco nero, per sua propria natura, non può essere visto. -L’esistenza di questi incredibili oggetti celesti era stata prevista dalla teoria della relatività generale proposta da Albert Einstein proprio cento anni fa, nel 1919, secondo la quale lo spazio non poteva più essere considerato indifferente alla presenza di materia, ma da questa poteva essere curvato. Le conseguenze sembrarono allora assurde e molti scienziati si dimostrarono inizialmente scettici, ma le osservazioni compiute durante l’eclissi totale di sole del 1919 dimostrarono che Einstein aveva ragione: lo spazio vicino al disco del sole oscurato era curvo e la luce delle stelle, passando nei pressi, non seguiva più una linea retta, ma una traiettoria curva.
Il fenomeno è oggi visibile e a alla portata di tutti: molte immagini ottenute con il telescopio spaziale Hubble mostrano come la forma di lontane galassie venga distorta quando la loro luce attraversa una cosiddetta lente gravitazionale, ovvero un ammasso di galassie più vicine che con la loro massa deformano lo spazio circostante.
La conseguenza più estrema della teoria è senza dubbio il buco nero: quando la massa di un oggetto è talmente concentrata da superare un limite chiamato raggio di Schwarschild, lo spazio si curva talmente da non permettere alla materia e persino alla luce di uscire. Non solo, ma tutto ciò che si avvicina temerariamente entro tre volte il raggio citato, spiraleggia cadendo nel buco nero per sempre.
Anche in questo caso il fenomeno sembrava inizialmente solo una ipotesi teorica, non corrispondente ad oggetti reali, ma con il passare degli anni e la disponibilità di strumenti di osservazione sempre più potenti e sofisticati, l’esistenza dei buchi neri venne confermata anche se non direttamente, ma dagli effetti visibili della loro presenza. Ci si accorse allora che esistevano almeno due categorie di buchi neri: quelli con una massa una decina di volte superiore a quella del nostro sole e quelli "super", con una massa equivalente a centinaia di migliaia e forse milioni di soli. Questi ultimi albergano al centro di tutte le galassie, anche della nostra, e la loro presenza è rivelata dal moto vorticoso delle stelle vicine (è il caso della nostra Via Lattea) o da getti di gas ad altissima temperatura che fanno parte del fenomeno di accrescimento del buco nero a spese del gas circostante.
Quindi, se da un lato gli astronomi hanno verificato ormai da molti anni la presenza nel cosmo di questi strani oggetti, nessuno era stato ancora in grado di fotografare da vicino il bordo di un buco nero, cioè il cosiddetto orizzonte oltre il quale il gas e la luce, una volta entrati, non possono più uscire. La difficoltà consisteva nel fatto che il diametro di un buco nero massiccio, di quelli che si trovano al centro delle galassie, è molto piccolo, dell’ordine dell’orbita di Saturno, che visto alla distanza di milioni di anni luce della galassia ospite diventa impercettibile anche al più grande telescopio terrestre.
Come sono quindi riusciti nell’impresa gli astronomi che ieri ne hanno mostrato la fotografia? Con un lavoro durato una decina d’anni hanno consorziato una decina di radiotelescopi terrestri sparsi in tutti i continenti, compresa l’Antartide. Impresa non facile, perché ogni telescopio ha caratteristiche proprie e per collaborare all’impresa doveva essere equipaggiato con strumentazione identica e soprattutto corredato di orologi atomici in grado di sincronizzare con altissima precisione le osservazioni contemporanee di tutti i telescopi. La tecnica, chiamata Large Baseline Interferometry, è ben nota ai radioastronomi, ma mai era stata utilizzata con un numero così grande di telescopi e a distanze così grandi: il risultato è equivalente ad osservare il cielo con un radiotelescopio delle dimensioni della Terra! Proprio a causa dell’estensione geografica dell’esperimento, uno dei problemi da superare, solo apparentemente banale, è stato quello di riuscire ad avere contemporaneamente condizioni metereologiche favorevoli in tutte le zone ospitanti i telescopi.
Un secondo formidabile problema è stato quello di gestire una quantità di dati veramente "astronomica": migliaia di milioni di milioni di byte! Per trasportarli dai singoli osservatori ai centri di calcolo che dovevano analizzarli si è ricorsi ad un metodo che sembrerà un ritorno al passato: una valigia caricata su un aereo... alla fine molto più veloce che trasmetterli attraverso la Rete!
Per comprendere quando sia stato difficile arrivare al risultato mostrato ieri, basti dire che le osservazioni sono state fatte due anni fa: questo il tempo necessario per analizzare i dati e confrontarli con le previsioni teoriche. Alla fine però il risultato è entusiasmante: abbiamo visto il bordo del buco nero, l’ombra scura generata dalla luce che lo sfiora e che ne delinea il contorno. Un’immagine al negativo che conferma in modo inequivocabile le previsioni di Einstein: il miglior modo per celebrare il grande genio e i primi cento anni della sua relatività generale.
Ordinario di Astrofisica all’Università di Padova e Commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- Il lato oscuro dell’universo: «serve un’enorme immaginazione per figurarsi com’è fatto davvero il mondo» (Richard Feynman).13 marzo 2019, di Federico La Sala
Serve un’enorme immaginazione per figurarsi il mondo
Il lato oscuro dell’universo
di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 13.03,2019)
L’oscurità ha un fascino innegabile. Nell’oscurità si entra con timore ed eccitazione per scoprire un mistero, per sapere e capire. Paradossalmente ci spinge ad avventurarci nelle tenebre il desiderio di farvi luce. E quando, alla fine, l’enigma si scioglie, insieme all’entusiasmo c’è la preoccupazione che ormai tutto sia noto e non rimanga più niente da scoprire. L’universo se ne ride della nostra ingenuità presuntuosa e quando siamo tentati di pensare di averne quasi capito ogni cosa, ci rilancia una sfida. Emblematico esempio è l’affermazione attribuita a lord Kelvin, fisico tra i più eminenti del secolo scorso, il quale, attorno al 1900, quando si riteneva che l’elettromagnetismo e la fisica newtoniana potessero spiegare tutta la realtà, sentenziò: «Non c’è più nulla da scoprire in fisica, resta solo da fare misure sempre più precise». E dopo soli cinque anni Albert Einstein pubblicò la teoria della relatività ristretta e nel 1915 quella della relatività generale rivoluzionando completamente la cosmologia.
Da allora gli scienziati si sono fatti più prudenti e, nonostante le straordinarie scoperte degli ultimi decenni attorno alla natura intrinseca della realtà e alle dinamiche del cosmo, nessuno ha avuto l’ardire di esprimersi con la sicumera di lord Kelvin. E giustamente, perché ultimamente sull’orizzonte della scienza si sono affacciate due grandi nuove entità, ancora ben lungi dall’essere chiarite. La prima è la materia oscura (dark matter), espressione dal duplice significato che ben le si attaglia: si tratta, infatti, di un argomento oscuro, perché complesso e ancora ignoto, e, allo stesso tempo, di una sostanza oscura, perché non riflettendo la luce è assolutamente inosservabile, ma produce degli effetti sulla materia visibile. La seconda, ancora più misteriosa della prima, è l’energia oscura, una forza della cui esistenza gli scienziati hanno prova certa, però non ne sanno assolutamente nulla. A causa loro l’universo, che ormai ci sembrava quasi a portata di mano (almeno intellettualmente), c’è sfuggito di nuovo.
Il tema, benché non proprio elementare, è intrigante anche per i profani e sono usciti di recente molti libri che ne trattano. Tra questi ne segnalo due in particolare. Il primo, L’altra faccia dell’universo (il Mulino) è scritto da Luca Amendola, docente di Fisica Teorica in Germania presso l’Università di Heidelberg. In esso l’autore vuole raccontare lo stato attuale delle conoscenze in materia spiegando anche come sono state acquisite e quali prospettive teoriche e applicazioni pratiche ne possano derivare. Del secondo, L’universo oscuro (Carocci), è autore Andrea Cimatti, professore di Fisica e Astronomia all’Università di Bologna. Egli intende «offrire a un pubblico di non esperti un quadro introduttivo e aggiornato sulle attuali conoscenze dell’universo», o meglio sarebbe dire, come subito precisa, sulle attuali non conoscenze. Si tratta di due saggi brevi che grazie alle competenze degli autori e alla loro scrittura chiara e divulgativa interessano certamente a fisici e cosmologi, però sanno catturare l’attenzione anche di chi è semplicemente curioso di sapere qualcosa dell’incredibile realtà in cui siamo immersi.
Se la materia oscura non emette né assorbe radiazione elettromagnetica (luce) ed è perciò totalmente invisibile agli occhi e agli strumenti, come mai si è arrivati a immaginarne e poi a provarne l’esistenza, per di più senza sapere di che cosa sia fatta? Il primo scienziato a parlarne, negli anni Trenta del secolo scorso, fu il fisico svizzero Fritz Zwicky, il quale fu anche il primo ad analizzare il moto delle galassie anziché quello delle singole stelle. Per effetto dell’attrazione gravitazionale, le galassie tendono a raccogliersi in ammassi più grandi «muovendosi come molecole in un gas» (Amendola).
Studiando il moto dell’ammasso di galassie chiamato Chioma di Berenice, Zwicky giunse a un risultato che definì - con un certo aplomb, va detto - «piuttosto inaspettato»: la massa necessaria a tenere insieme le galassie nell’ammasso doveva essere di circa centocinquanta volte maggiore di quella rappresentata dalle stelle visibili. Diversi anni dopo, nel 1974, grazie a nuovi strumenti, in particolare al telescopio di Mount Palomar in California, Vera Rubin, astronoma americana la cui famiglia era originaria dell’Europa dell’Est, osservando il moto di altre galassie a spirale come la nostra, notò che le stelle esterne «ruotavano molto più velocemente di quanto predetto dalla legge kepleriana, come se fosse presente molta più massa di quella visibile nel bulge», cioè nel massiccio rigonfiamento che sta al centro delle galassie (Amendola). Trovò così una prima importante conferma l’osservazione di Zwicky, e a partire dagli anni ’80 del secolo scorso un numero crescente di scienziati si convinse della sua esistenza, fino ad arrivare all’odierna quasi unanimità.
Si stanno facendo diverse ipotesi su cosa sia la materia oscura, ancora nessuna sufficientemente testata. Ad ogni modo, si sa che «le galassie sono distribuite in una struttura che assomiglia a una ragnatela cosmica», afferma Andrea Cimatti, che assomiglia molto alle reti neuronali del cervello - il che non significa niente, ma è molto suggestivo. Le galassie e gli ammassi di galassie si trovano al centro di una immane sfera di materia oscura, il cui compito potrebbe essere proprio quello di tenerle insieme impedendone la disgregazione. «La nostra visione un po’ naïve di un universo composto da oggetti luminosi - avverte - viene quindi stravolta... gli oggetti luminosi sono solo punte di iceberg che nascondono grandi quantità di materia non direttamente osservabili».
Nell’universo, la materia ordinaria, composta di particelle note, rappresenta circa il 5% della materia esistente; quella oscura, dotata di massa ma invisibile, ne rappresenta circa il 25%. E il restante 70% cos’è? Energia oscura, rispondono gli scienziati. Qualcosa di ancora più grande e misterioso della materia oscura. Se ne cominciò a ragionare diversi anni fa quando, in seguito alle osservazioni di Georges Lemaître, Edwin Hubble e altri, si comprese che l’universo, fino ad allora considerato statico, si sta espandendo e da circa cinque miliardi di anni lo sta facendo a una velocità crescente e francamente impressionante: le misure attuali, precisa Andrea Cimatti, parlano di un’espansione di 70 km al secondo per ogni megaparsec (un Mpc=3,086x1019km, cifra incomprensibile per i più ma utile per farci un’idea dell’immensità dell’universo!). Per spiegare l’espansione accelerata, attraverso calcoli e considerazioni che sia Amendola che Cimatti riferiscono con dovizia di particolari, si è arrivati a postulare l’esistenza di una forza repulsiva che, come in un gioco alla fune, contrasta la forza di gravità causando un’accelerazione dell’espansione e impedendo che «quattordici miliardi di anni dopo la sua nascita, l’universo non [sia] né svuotato né collassato» (Amendola). E questa potrebbe essere una risposta parziale, ma comunque soddisfacente alla domanda: a cosa serve l’energia oscura.
Se ci si chiede, invece, cosa sia, il buio è assoluto: la natura di questa componente determinante e maggioritaria dell’universo per ora è del tutto ignota. Tra le ipotesi fatte è che possa essere l’energia intrinseca dello spazio vuoto, il quale non è, come si tende ancora a pensare tra profani, uno spazio senza niente dentro. Infatti, anche togliendo da una porzione di spazio particelle, radiazioni e campi elettromagnetici e gravitazionali, quello che resta è comunque uno spazio quantistico in cui particelle e antiparticelle virtuali - un tipo di particelle dalle caratteristiche peculiari - fluttuano vorticosamente annichilendosi istantaneamente; «l’energia collettiva di queste particelle è chiamata energia del vuoto» (Cimatti). Dunque, in realtà, in natura il vuoto assoluto non esiste. Quello che chiamiamo così è il vuoto quantistico, ed è pieno di particelle e di campi (manifestazioni diverse di una stessa realtà materiale) che vibrano, si muovono velocissime, interagiscono, scompaiono o si trasformano.
Ed è interessante notare, senza spingerci oltre in una materia che si fa decisamente difficile, come scrutare il cosmo infinitamente grande sia possibile soltanto attraverso la conoscenza dell’infinitamente piccolo, ossia della costituzione fondamentale della materia. Di questo si occupa la meccanica quantistica che, mostrando la trama del tessuto di cui è fatto il mondo, rivela una realtà completamente diversa da quella percepita dai sensi, governata da leggi surreali, controintuitive, che contraddicono la nostra esperienza o ne esulano. Gli scienziati considerano la meccanica quantistica una stupenda descrizione del funzionamento di ogni cosa; per quanto ancora nessuno sia in grado di dire esattamente perché, essa funziona talmente bene che le sue applicazioni pratiche -trasmissioni satellitari, internet, computer e medicina nucleare - hanno cambiato radicalmente la nostra vita.
Insomma, l’universo è un luogo molto strano e siamo ben lontani dall’averne chiariti i misteri. Soprattutto quello che Albert Einstein considerava il più grande di tutti, l’unico vero mistero dell’universo: la sua comprensibilità. Come mai la mente dell’uomo lo capisce e lo può descrivere perfettamente con la matematica? Qualcuno tra gli scienziati più inclini alla poesia, suggerisce che l’essere umano stia all’universo come la mente sta al corpo; in questa prospettiva potremmo essere l’autocoscienza di sé dell’universo. Chissà se lo sapremo mai. Certo è che, come disse il grande fisico Richard Feynmann, «serve un’enorme immaginazione per figurarsi com’è fatto davvero il mondo» (Le battute memorabili di Feynman, Adelphi).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- UNIVERSO. VISTA LA MATERIA OSCURA. La materia oscura esiste, scoperta enorme "ragnatela"
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E -- LA LUNA (“LA SCIANA”): IL DESIDERIO (“LU SPILU”), E IL FILO DI ARACNE, DI FILOMELA, E ATENA. Note.12 marzo 2019, di Federico La Sala
MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA...
LA LUNA (“LA SCIANA”), IL DESIDERIO (“LU SPILU”), E IL FILO DI ARACNE.
Quanti millenari pregiudizi ... *
CONSIDERATO CHE “SCIANA”, sinonimo di “umore”, «è in uso in locuzioni del tipo “osce sto ti sciana” (oggi “sto di umore giusto”, ho voglia di fare) ma anche in unione all’aggettivo che ne definisce esplicitamente il valore positivo (“sto ti bona sciana”) o negativo (“sto ti malesciana”). Il derivato “scianaru” (prevalentemente e, come dirò, non a caso, usato al femminile “scianara”) come sinonimo di “volubile” [...]» (cfr. Armando Polito, “Dialetti salentini: sciàna”, Fondazione Terra d’Otranto, 10.03.2019); E CHE “SCIANA” è «deformazione dell’italiano “Diana”, dea della luna e della prima luce del mattino oltre che della caccia, dal latino “Diàna(m)”, da dius=divino, connesso con dies=giorno e con Iùppiter=Giove [da Iovis=Giove (a sua volta dal greco Zeus/Diòs)+pater=padre]» (cfr. Armando Polito, “Lu spilu e la sciàna”, Fondazione Terra d’Otranto, 16.12.2011).
E’ BENE RICORDARE CHE «Diana, com’è noto era gemella di Apollo, entrambi figli di Zeus e Latona ...» (op. cit.).
MILLENARI PREGIUDIZI. Per non scivolare nel “terreno viscido” e perdersi nell’aria nebulosa di ingegnosi labirinti e, al contempo, riuscire a districarsi tra millenarie “incrostazioni irrazionali” , forse, è opportuno tenere ben aperti gli occhi dinanzi ai bagliori emessi “dalla rete dell’oro” del SOLE dell’OLIMPO (“Dalla rete dell’oro pendono - così epigrammaticamente Salvatore Quasimodo - ragni ripugnanti”). e riguardare con attenzione gli ARAZZI tessuti da Atena, da Aracne, e da Filomela (cfr. Ovidio, “Metamorfosi”: La tela di Aracne apre il libro sesto, la storia di Filomela lo chiude ... Prima che la dea adirata Atena (Minerva) stracci la stoffa tessuta da Aracne, la tessitrice, donna mortale, racconta su di essa una storia molto particolare).
FORSE solo così si potrà uscire dal labirinto, senza perdere il filo, senza abbandonare Arianna, e tornare ad Atene con le vele bianche - non nere!
*
-
> LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" - La Luna e un piccolo grande passo. Ora credo di avere capito. Per immedesimazione, mettendomi nei panni di Armstrong (di Roberto Mussapi).7 marzo 2019, di Federico La Sala
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”.... *
Un piccolo grande passo
di Roberto Mussapi (Avvenire, mercoledì 6 marzo 2019)
«Solo un piccolo passo per un uomo, ma un passo da gigante per l’umanità!». Si avvicina il cinquantenario di uno dei più grandi trionfi umani: lo sbarco sulla Luna. Mentre avveniva compivo diciassette anni: non male come regalo di compleanno.
La frase che sarebbe rimasta leggendaria di Neil Armstrong mi commosse, come commosse il mondo, ma confesso che non la compresi bene. La seconda parte chiara: evidente che quel momento siglava un passo enorme per l’umanità, che dalla sua nascita scruta e interroga il nostro satellite notturno, custode e ispiratore del sogno. Ma non comprendevo perché definire "piccolo", per un uomo, quel primo passo sulla nuova terra sognata.
Ora credo di avere capito. Per immedesimazione, mettendomi nei panni di Armstrong, come fa un attore.
La terra vista dall’alto... E la mia gamba, che piccola cosa! Il mio piedino, dopo questo viaggio nello spazio immenso... Che esserino io sono, qui nell’infinità dell’universo. Il mio passo è piccolo perché io sono piccolo. Ma io non sono solo io, io sono l’umanità. Io sono parte del coro e degli atomi di tutti gli uomini, dal primo apparso sulla terra a tutti quelli che si susseguono, in ogni parte del mondo e in ogni tempo. Il mio piccolo passo è un grande passo dell’umanità, a cui appartengo.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
RIVOLUZIONE COPERNICANA. "Vicisti, Galileae" (Keplero, 1611).
 UNESCO: IL 2009 ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA. Che farà l’Italia? Galileo di nuovo al confino!?!
UNESCO: IL 2009 ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA. Che farà l’Italia? Galileo di nuovo al confino!?!LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. - I compiti delle Nazioni (di Roberto Mussapi).9 febbraio 2019, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE.... *
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità".
- La Terra vista dalla Luna: "Se il programma spaziale non avesse dato alcun frutto (e spesso io faccio mólta fatica a discernere che cosa ci abbia dato), gli dobbiamo essere grati per aver prodotto tale fotografia" (M. Konner, L’ala impigliata. I condizionamenti bilogici dello spirito umano, Milano, Feltrinelli, 1984).
I compiti delle Nazioni
di Roberto Mussapi (Avvenire, sabato 9 febbraio 2019)
«Spesso si è discussa l’utilità delle spedizioni polari. Se si considera solo il vantaggio morale che si ricava da tali spedizioni, io lo credo sufficiente a compensare i sacrifici che per esse si fanno. Come gli uomini, che nelle lotte quotidiane, col superare le difficoltà, si sentono più forti per affrontarne delle maggiori, così è delle Nazioni, che dai successi riportati dai propri figli si devono sentire maggiormente incoraggiate e spinte a perseverare nei loro sforzi per la propria grandezza e prosperità».
Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, tra il 1899 e il 1900 guida una spedizione, Stella Polare, con lo scopo di portarsi con una nave lungo una terra il più a settentrione possibile, e dal sito di sverno procedere con le slitte verso il Polo. La meta non fu raggiunta, ma lo scopo fu conseguito. Lo scopo della sua e di ogni altra spedizione, scrive Amedeo di Savoia, è di offrire un conforto e un modello all’uomo che nelle sue «lotte quotidiane», col superare le difficoltà si sente più forte per affrontarne altre maggiori. Così devono fare le Nazioni, «che dai successi riportati ai propri figli si devono sentire maggiormente incoraggiate.» Figli non mandati in guerra, ma all’avventura della conoscenza del mondo.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo.
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Tracce per una svolta antropologica
 OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.
OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- SUL FILO DI FACHINELLI E DI GALILEO. Una "vecchia" lettera di commento (di Gennaro Forlenza).25 gennaio 2019, di Federico La Sala
“La mente accogliente”. Una "vecchia" lettera di commento*
- IN MEMORIA E IN ONORE di GENNARO FORLENZA, sindaco di Contursi Terme (SA) prima e dopo gli anni del terremoto del 1980, morto il 21.01.2019 (Addio a Gennaro Forlenza, il sindaco «storico» di Contursi): RICORDO qui il SUO GENEROSO commento a caldo (cfr. lettera autografa del 10 dicembre 1991) sul mio lavoro "LA MENTE ACCOGLIENTE. Tracce per una svolta antropologica" (pubblicato a Roma nel 1991, e presentato poi con l’editore Antonio Pellicani anche nella stessa città di Contursi).
- Una chiarezza degna di un Cittadino e di un Intellettuale di "altri" tempi. Mille miglia più in là della palude degli opportunismi "politici" e "filosofici" correnti: il riferimento finale al "Vicisti Galilaee" di Keplero (del 1991) lo mostra pienamente attento al dibattito culturale del tempo e strutturalmente consapevole della giustezza della posizione di Galileo. L’anno successivo, a fine anno (il 31 ottobre 1992), durante il pontificato di Giovanni Paolo II, “Il Vaticano cancella la condanna di Galileo". (Federico La Sala)
Caro Federico,
mi trovo nelle stesse condizioni di E. Fachinelli in un pomeriggio ventoso di settembre (1985) sulla spiaggia di S. Lorenzo a mare, quando ebbe l’intuizione fondamentale del suo filosofare: rovesciare la prospettiva; si tratta di ristrutturare la coscienza, trasformandola da coscienza chiusa in una coscienza aperta; passare da una monade con porte e finestre sbarrate ad una monade con porte e finestre aperte; per la salvaguardia del pianeta azzurro o la fondazione di una nuova città.
Potrei anche aver detto di trovarmi nelle stesse condizioni tue quando hai avuto chiara, per intuizione o per deduzione dalle ipotesi di E. Fachinelli, la teoria della “mente accogliente”.
Cosa da far tremare i polsi e forse per questo l’hai decodificata in “tracce per una svolta antropologica”! Fuor di metafora e... fuori dal campo di ricerca, devo esprimerti i miei più sinceri complimenti per l’assoluta padronanza del linguaggio e dei concetti che le parole vogliono esprimere; una raffinatezza stilistica voglio dire e una profondità ideo-logica (come vedi riprendo anche il tuo vezzo cesorio!) che non lascia adito a dubbi: sei un vero filo-sofo del pensiero pensata da Eraclito a Marx, da Parmenide a Nietzsche e così via.
La perfezione la raggiungi nell’ultimo pezzo (un brillante new tono): due pagine di assoluta bellezza stilistica e concettuale, dalle quali partire, io auspico e auguro, per una sistematica trattazione dell’argomento della “mente accogliente”, dove ci siano meno padri (altrimenti il mito edipico permane!) e dovrai cavalcare il raggio di luce. Fuori dal cerchio, rompere il cerchio!
Solo così meriterai il “Vicisti Galilaee” di Keplero. Definitivo e inappellabile.
Roma, lì 10 dicembre 1991
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. -- La Cina batte gli Usa e conquista la Luna. Il resto del mondo fa finta di non vedere (di P. Buttafuoco).14 gennaio 2019, di Federico La Sala
La Cina batte gli Usa e conquista la Luna. Il resto del mondo fa finta di non vedere
Se fossero stati gli americani a lanciare la missione Chang’e 4, ci sarebbero già film, speciali tv e omaggi pubblici
di Pietrangelo Buttafuoco (il Fatto, 14 Gen 2019)
La Cina è sull’altra faccia della Luna, quella che nessuno vedrà mai. Per la prima volta nella storia, la ricerca astronomica dell’uomo - più specificatamente l’Agenzia spaziale cinese - arriva laddove fino a oggi solo Cyrano de Bergerac, Astolfo e Giacomo Leopardi erano riusciti, far propria la luna.
I primi due - entrambi uomini d’arme - arrivano lì, sopra la nostra testa, con i loro viaggi. Per incantarsi d’amore, vi vola, il nasuto spadaccino; per recuperare il senno d’Orlando paladino - in groppa all’Ippogrifo - vi galoppa il secondo. E tutti e due sostano, il tempo che ci vuole, nella parte a tutti noi buia: the dark side of the moon, per come cantano i Pink Floyd.
Il poeta di Recanati, nelle Operette Morali, la fa scivolare lungo la manica della galabia del Profeta (su di Lui la Pace), per così baloccarsi di delicata malia e ruotarne il verso, sia ponente che crescente, affinché ella, la signora luna, segni il tempo delle donne, degli uomini e dei popoli tutti, accostandosi alla punta dei minareti.
La Cina, dunque, riesce a far allunare il lander Chang’e-4 nell’emisfero nascosto di Selene. La terra della Muraglia - l’unica opera dell’uomo visibile a occhio nudo dalla luna - fa quindi un passo in più rispetto ai russi che nel 1959, con la sonda Luna3, scattarono le prime immagini. Da quel marchingegno volante, dopo l’assestamento, oggi ne sta venendo fuori un rover, ossia un robot, per perlustrare l’ambiente circostante e seminarvi patate, cavoli e, perfino, collocarvi uova di baco da seta eppure - come fosse una quisquilia buona al più per allunati - di questa impresa immane non se ne parla.
Fosse un fumetto - già solo l’idea di piantarvi tuberi e broccoli, ararla come terra fertile, - sarebbe già faccenda di Archimede Pitagorico, invece è scienza vera. E siccome è una realtà fatta di ricerca, analisi, tecnica e ingegno se ne parla poco in Occidente, anzi, niente, perché prevale - ahinoi - la necessità di minimizzare la portata epocale dell’impresa giusto per non mancare di rispetto al riflesso condizionato. Va da sé che se fosse stata la Nasa, ossia gli Usa - presso l’informazione più autorevole e pregiata - non ci sarebbe stata altra narrazione che l’epica, con relativo omaggio al genio a stelle e strisce, magari già con un trattamento hollywoodiano e con speciali tivù, anzi, con serie televisive fichissime per fare di ogni facente parte della missione, fosse pure lo stagista addetto alle fotocopie, come minimo un Argonauta.
Il riflesso condizionato che ci fa volgere all’omertà del sorvolare sull’avventuroso cammino del lander Chang’e-4 è quello di un nostro disagio mentale. È la difficoltà di accettare che una civiltà di cui a malapena riusciamo a comprendere gli involtini primavera primeggi, oggi, nella gara di conquista delle stelle. E non se ne parla, appunto. Col risultato che un miliardo e mezzo di cinesi sanno di essere nella parte nascosta della luna, dove la Cina vola. La restante parte di mondo - la minoranza - sul fatto in sé, restando indietro, sorvola.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E ... LA "STORIA" DELLA LUNA E DEL SOLE. 24 NOVEMBRE 2018: "Maschi/femmine. La parità (non) si insegna a scuola" (di Paola Zanca).25 novembre 2018, di Federico La Sala
EDUCARE AL GENERE UMANO. La "storia" della Luna e del Sole...
- "DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
Maschi/femmine. La parità (non) si insegna a scuola
di Paola Zanca (Il Fatto, 25.11.2018)
La storia della Luna e del Sole è in un sussidiario di quarta elementare. Un mito della tradizione orale africana che diversi editori hanno inserito nei libri di testo della scuola pubblica italiana. Il racconto spiega come mai la Luna e il Sole, marito e moglie, non stiano mai insieme in cielo: hanno litigato perché lei non gli ha fatto trovare la cena pronta. Una “infame pigraccia” che si è perfino permessa di mangiare la polenta che il marito si era poi cucinato da sé. Il lieto fine: il Sole lancia il tagliere con la cena bollente in faccia alla Luna che “dolorante e vergognosa corse a nascondersi”.
La “dimensione di genere”,spiega bene Cristina Gamberi in Educare al genere (Carocci), influisce sulle nostre vite “da quando nasciamo fino alla terza età, e specie nell’adolescenza, quando si gettano le basi del divenire uomini e donne”.
Secondo il rapporto Eurydice, tutti i Paesi europei hanno messo in atto politiche di educazione di genere in ambito didattico: tutti tranne Estonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. E Italia. “Nella società italiana - notano le associazioni delle Donne in Rete contro la violenza - gli stereotipi e pregiudizi di genere, i ruoli tradizionali assegnati a uomo e donna, sono riprodotti sin dai primi testi scolastici”.
E se “l’educazione è sessista”, per parafrasare il titolo della ricerca di Irene Biemmi sugli stereotipi di genere nei libri delle elementari, c’è poco da stupirsi se, per la metà degli intervistati da Ipsos per conto del dipartimento Pari Opportunità, le donne non dovrebbero lavorare a tempo pieno se hanno figli piccoli, sono le principali responsabili della cura della famiglia e si sono avvalse del proprio aspetto fisico per la loro realizzazione professionale.
È l’humus in cui nasce e prolifera la mentalità che è alla base della violenza. Ecco perché - spiega Biemmi, ricercatrice all’università di Firenze - è “scorretto associare l’educazione di genere alle misure di contrasto alla violenza” perché, piuttosto, l’educazione è lo strumento attraverso cui “costruire dinamiche relazionali sane e paritetiche tra maschi e femmine”. Quelle, quindi, in cui la violenza - né esercitata né subìta - ha diritto di cittadinanza.
Uscire dalla “logica emergenziale” è il passo fondamentale. E solo dalla scuola si può provare a farlo: con la formazione obbligatoria degli insegnanti e con un intervento sui libri di testo che escano dai “binari rosa/azzurro” - spiega Biemmi -. “La femmina buona e mansueta, il maschio brillante anche se vivace”.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PER L’ITALIA, "DUE SOLI". Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò i mosaici" dei "faraoni"...
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva di Federico La Sala Studio europeo nelle scuole, ma il Ministro "censura" la domanda sui metodi contraccettivi (la Repubblica/Salute, 14.02.2008, p. 19).
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- SOCRATE, LEDA, E IL CIGNO: POMPEI A LUCI ROSSE. Note.21 novembre 2018, di Federico La Sala
AL DI LA’ DEL PARTO MASCHIO (O FEMMINA) DEL TEMPO. La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica... *
- L’EROS SENZA "FEMMINA" DI SOCRATE: "Si narra che Socrate abbia sognato di avere sulle ginocchia un piccolo cigno che subito mise le ali e volò via e dolcemente cantò e che il giorno dopo, presentatosi a lui Platone come alunno, abbia detto ch e il piccolo uccello era appunto lui" (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III 5, cfr.: Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma, 1991, pp.182-183)
- Leda e il cigno, Pompei a luci rosse
- ESCLUSIVA ANSA/ Osanna, "Ritrovamento eccezionale e unico"
Mitologia
L’eros senza maschio di Leda e il cigno
Il dipinto ripropone il simbolo della donna che dall’antichità ai grandi artisti del Rinascimento afferma la propria indipendenza
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 20.11.2018)
Ed ecco che a Pompei la sempre imponderabile cabala dei crolli e dei controlli fa riemergere una variante ancora più antica, pittorica, di un episodio amoroso da sempre simbolo, nella storia della pittura e della letteratura, dell’autoerotismo femminile: del piacere che la donna può darsi senza la cooperazione del maschio, anzi, di alcun umano. Nella scultura adrianea, copia di un originale ellenistico, il corpo di Leda, completamente nudo, è contratto nell’amplesso, la mano celata nel grembo premuto alle piume, stretto fra le unghie di un onirico cigno dotato di doppio fallo, dove quello proteso nel lungo collo, cui le labbra si accostano in un’appena dissimulata fellatio, prevale sull’altro che si insinua fra le cosce tremanti - per citare i versi di Yeats - della ragazza che è in piedi e barcolla. Nell’altrettanto esplicito erotismo dell’affresco pompeiano, Leda, i drappeggi dell’abito appena scostati, ancora cinta di diadema e calzari, è abbandonata su una sedia ed è al seno scoperto che si protende il becco del bianco fantasma erotico avvinghiato alle sue cosce.
Nelle grandi Lede della storia dell’arte successiva c’è sempre qualcosa di ineffabile dipinto sul viso della donna da cui non a caso nascerà Elena, e con lei la guerra di Troia, e dunque Roma, con la fuga di Enea. Perfino il sorriso leonardesco del dipinto della Galleria Borghese è solo uno dei tanti misteriosi, allusivi, indecifrabili sorrisi che Leda, moltiplicata nel suo sogno in infinite immagini pittoriche, regala prima, durante o spesso dopo l’amplesso all’empatia dei pittori.
Del resto, della meno censurata tra le Lede dei grandi maestri, quella di Michelangelo, non sopravvive l’esecuzione finale, smarrita o censurata in un giro di corti che dalla committenza estense si arenerà in quella di Francia, ma la copia di Rosso Fiorentino della National Gallery dà un’idea di quanto meno pudica della Leda post coitum di Leonardo fosse l’idea che Michelangelo aveva di quell’amplesso.
Il cigno non è una bestia. È la figurazione simbolica dei desideri repressi e insieme delle paure erotiche femminili. Tutta l’imponderabilità e irrefrenabilità dell’erezione maschile è richiusa e dischiusa in quelle grandi ali frementi, che nell’iconografia assumono, come sempre le immagini dei sogni, proporzioni vertiginosamente variabili, ora ridotte alla sensualità del passer della Lesbia di Catullo, ora talmente gigantesche da far intravedere nel corpo a corpo erotico delle Lede avviluppate nelle loro piume qualcosa di simile alla lotta di Giacobbe con l’angelo. In effetti, se a qualcosa la loro tradizione iconografica può essere accostata, è quella di una vertigine del volo - pensiamo allo slancio di Icaro - che il mondo greco, attingendo alla tradizione orientale, consegnerà all’angelologia cristiana e islamica.
Che siano di chimera, di fenice o di cigno, che richiamino Eros o Ermes dal piede alato, e con lui la natura stessa del sogno, le ali, tipico oggetto di fobia sessuale femminile, sono un altro potente simbolo di hybris fallica. Creato dalla fantasia, dalla forza del sogno, dall’urgenza del simbolo, il cigno di Leda è quanto di più lontano da una concreta presenza animale.
Nulla a che fare con gli accoppiamenti bestiali della mitologia greca, come quello di Pasifae col nero, potente toro dall’immenso membro, che non a caso farà sorgere alle fondamenta dell’edificio psicologico greco una creatura - il Minotauro - che simboleggia nella mitologia l’assoluto irrazionale, la parte bestiale che è in noi, tanto avida quanto sapiente, tenuta a guardia del grande labirinto dell’inconscio.
Ma neanche quel figlio, per i greci, è il male, anzi. Sarà la sua uccisione da parte dell’infido eroe Teseo a produrre la combinazione di eventi che porterà a un’ancora più potente compensazione simbolica: a consegnare Arianna, sorella del Minotauro e suo esatto contrario, sacerdotessa della razionalità della dea Atena, a farsi sposa, abbandonata a Nasso, di Dioniso, il dio della natura scatenata e dell’ebbrezza.
Il prodotto dell’accoppiamento di Leda non sarà meno inquietante. Elena incarnerà la femminilità più potente di tutto il mito greco, quella cui non si resiste, capace di addormentare con il suo nepente il cuore degli uomini, di scatenare le loro guerre, di disseminare, con la sua forza di donna creata dal puro piacere di una donna, il massimo disorientamento nel mondo dei maschi. Elena dalle bianche braccia, candida e onirica come "il bianco tumulto" che la fa nascere, sarà la femme fatale per eccellenza, la splendida strega capace di scardinare ognuno degli aspetti dell’egemonia maschile.
Il mito di Leda è dunque il mito d’origine dell’autonomia femminile, del suo desiderio sessuale emancipato dal maschio, delle sue non solo erotiche ma anche concrete paure - poiché certo essere ingravidate da un sogno è da sempre nelle donne uno dei più irrazionali e archetipi timori, non a caso esorcizzato nelle storie di maghe e di streghe. È forse questo solo, nel mito di Leda, l’intervento di Zeus.
 Per una volta assolviamolo dalla sua fama di stupratore. Quello di Leda è il contrario di uno stupro. E la vasta fortuna della sua iconografia è uno dei tanti segni nascosti, sotterranei, carsici che la psiche femminile ha lasciato, indecifrati dai molti, còlti dagli artisti e dai poeti, serbati e sussurrati nel segreto delle corti, della sua indipendenza e della sua libertà.
Per una volta assolviamolo dalla sua fama di stupratore. Quello di Leda è il contrario di uno stupro. E la vasta fortuna della sua iconografia è uno dei tanti segni nascosti, sotterranei, carsici che la psiche femminile ha lasciato, indecifrati dai molti, còlti dagli artisti e dai poeti, serbati e sussurrati nel segreto delle corti, della sua indipendenza e della sua libertà.
*
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
"PARTORIRE CON LA TESTA. Alle origini della maieutica" (Dorella Cianci, Marsilio, Venezia, 2018).
SOCRATE, "LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA ... - Quaggiù come lassù, su Marte. Jennifer Macalady racconta i suoi studi nelle viscere della terra, dalle Bahamas a Frasassi.26 settembre 2018, di Federico La Sala
"Nelle grotte cerco il segreto della vita"
Jennifer Macalady racconta i suoi studi nelle viscere della terra, dalle Bahamas a Frasassi
di Rosita Rijtano (la Repubblica, 26.09.2018)
Nelle viscere della Terra, dove non arriva luce né ossigeno, arriva lei. Ha tempra e aspetto di una roccia Jennifer Macalady, microbiologa della Pennsylvania State University che da vent’anni percorre il mondo di sotto, in largo e in lungo. Fino a centinaia di metri di profondità, dalle Bahamas all’Italia, in provincia di Ancona. È nelle grotte di Frasassi che preleva i campioni da studiare per afferrare il mistero in cui è avvolta l’origine della vita.
Quaggiù come lassù, su Marte. Una signora delle grotte, "curiosa e coraggiosa". Anche se paura ne ha avuta tanta, come all’inizio: « A volte sono stanca e infreddolita - racconta - ma alla fine prevale sempre l’adrenalina: in ogni discesa so che imparerò qualcosa di nuovo, mi sento fortunata».
Una storia risalita in superficie grazie a The most unknown, documentario in onda su Netflix che coinvolge nove scienziati per rispondere a grandi quesiti universali irrisolti: esiste davvero la materia oscura? Come si forma la coscienza? In che modo nasce la vita? Macalady ha scelto di scoprire come si sono formati i primi organismi facendo luce sugli anfratti più bui.
Immagina le grotte come macchine del tempo in cui si possono trovare condizioni ambientali simili a quelle che hanno caratterizzato la Terra miliardi di anni fa. « Studiarle ci fa capire l’evoluzione dei microrganismi e l’esistenza di trilioni di specie di microbi, di cui conosciamo solo l’1%».
Un amore particolare la lega a Frasassi, dove torna dal 2002. Scende in un silenzioso mondo sulfureo popolato da organismi che sfruttano acido solfidrico come fonte d’energia. Qui ha speso anni in pazienti analisi e qualche sorprendente scoperta. Come quella pubblicata su Astrobiology lo scorso aprile, quando Macalady e colleghi hanno individuato tracce di vita a 400 metri di profondità. «Nella composizione del gesso c’erano alcuni isotopi di atomi compatibili con la presenza e l’azione di microrganismi. Una firma biologica che nelle missioni spaziali potrebbe essere usata per sapere se c’è stata o c’è vita su Marte», spiega la scienziata.
Un grande punto di domanda è come i microrganismi riescano a sopravvivere anche nelle falde acquifere più profonde, dove l’energia chimica è talmente bassa da rendere in teoria impossibile l’esistenza. Non in pratica. Una resilienza che Macalady ha fatto propria. «Avere pazienza e lavorare sodo», sono le due lezioni che le hanno insegnato le scarse risorse finanziarie e i tempi della natura. «Adesso studieremo la vita che si forma molto al di sotto della superficie dell’acqua, quindi quasi senza ossigeno. Credevo che la morfologia delle grotte ce l’avrebbe impedito, invece ci stiamo riuscendo. L’ecosistema analizzato finora è paragonabile a ciò che c’era sulla Terra tra i 2,5 e i 0,5 miliardi di anni fa, mentre così potremo risalire a epoche ancora più antiche » .
Un ulteriore balzo indietro che ci avvicina alla comprensione dell’origine della vita. Ci riusciremo mai? «Sì, abbiamo già tecnologie e conoscenze necessarie».
-
> LA LUCE, LA TERRA. "Note per una epistemologia genesica" --- Le periodiche variazioni dell’orbita terrestre influiscono sul clima. La prova dell’esistenza di questo fenomeno è ’scritta’ in antichi sedimenti.11 maggio 2018, di Federico La Sala
Il clima ’ritmato’ da variazioni periodiche dell’orbita terrestre
Causate da venere e Giove, sono rimaste impresse nelle rocce
- Le periodiche variazioni dell’orbita terrestre influiscono sul clima © ANSA/Ansa
di Redazione ANSA *
Il clima sulla Terra è influenzato dalle periodiche variazioni dell’orbita terrestre, che ogni 405.000 anni diventa un po’ più ellittica a causa dell’attrazione gravitazionale esercitata dal pianeta più vicino, Venere, e dal ’gigante’ del Sistema solare, Giove. La prova dell’esistenza di questo fenomeno è ’scritta’ in antichi sedimenti risalenti ad oltre 200 milioni di anni fa e ritrovati nel cuore del deserto dell’Arizona. Descritti sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas) da un gruppo di ricerca coordinato dalla Rutgers University del New Jersey, potranno essere usati come un ’orologio geologico’ per ricalcolare con maggiore precisione la storia del nostro pianeta e delle sue forme di vita.
"Si tratta di un risultato sorprendente - spiega il primo autore dello studio, Dennis V. Kent - perché questo lungo ciclo, che finora era stato previsto per un periodo di 50 milioni di anni sulla base dei movimenti planetari, viene così confermato per almeno 215 milioni di anni". Questo significa che era attivo già prima della comparsa dei dinosauri e che lo è ancora oggi: secondo i calcoli saremmo a metà del ciclo, nella fase in cui l’orbita è meno ellittica. Fra 202.500 anni, quando l’eccentricità tornerà ad essere massima, diventeranno più evidenti le differenze tra le stagioni, con le estati più calde, gli inverni più freddi, i periodi di secca più siccitosi e i periodi umidi più ricchi di precipitazioni.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA -- C’è tempo. La cronobiologia ci cambierà la vita. Il fattore “momento giusto” diventa sempre più importante (di Nicla Panciera).27 aprile 2018, di Federico La Sala
Psicologia
C’è tempo
Il fattore “momento giusto” diventa sempre più importante. Per prendere decisioni sagge. Per essere apprezzati dagli altri. Per ammalarci di meno. E per riuscire nella vita
di Nicla Panciera *
Indovinare il momento giusto per compiere un’azione può voler dire stabilirne l’esito. A volte decidiamo quando agire basandoci sull’intuizione del momento, in altri casi proviamo a ragionarci su. Per quanto la vita sia un flusso continuo di scelte - quando cambiare lavoro, dare una cattiva notizia o semplicemente andare a correre al parco - in pochi sanno che la tempistica è un’arte. E una scienza. Ne è convinto Daniel Pink, autore di When: the scientific secrets of the perfect timing, titolo appena uscito negli Usa, nel quale il prolifico autore di bestseller passa in rassegna i risultati di discipline diverse, dalla cronobiologia alla psicologia fino all’economia, senza approfondirne nessuna, per spiegare l’importanza di tenere in considerazione la quarta dimensione, quella temporale, spesso sottovalutata. Perché, scrive Pink, “gli scaffali delle librerie sono pieni di pubblicazioni su come realizzare una certa cosa. Ma nessuno spiega mai quando farla”.
Come tutti i processi fisiologici, che si ripetono regolarmente nelle 24 ore, anche le capacità cognitive variano nel corso della giornata. Le ricadute sulle nostre prestazioni sono evidenti e le fluttuazioni sono più ampie di quanto gli scienziati non avessero immaginato agli inizi. È passato oltre un secolo, infatti, da una delle prime misurazioni oggettive, eseguita dallo psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus, che dimostrò come ricordare elenchi di sillabe senza senso sia più facile al mattino che alla sera. Oggi si pensa che «la variazione tra il picco più alto e quello più basso nelle prestazioni sia l’equivalente dell’effetto sulle nostre capacità cognitive di un bicchiere di alcol», per dirla con Russell Foster, direttore dell’istituto Sleep and Circadian Neuroscience dell’Università di Oxford. Certo, il momento migliore per un certo compito dipende dalla sua natura.
 Uno studio, apparso sulla rivista PNAS e condotto dalla Harvard Business School su oltre 2mila studenti danesi, ha mostrato la forte correlazione tra l’orario dei test scolastici e i risultati che, con il passare delle ore, peggiorano inesorabilmente. «La mattina il sistema cognitivo funziona meglio nei compiti di memoria di lavoro, di pomeriggio entra in gioco la memoria a lungo termine e, infatti, siamo facilitati nell’apprendimento», spiega Vincenzo Natale, direttore del dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. «Le informazioni acquisite di pomeriggio sono ricordate meglio».
Uno studio, apparso sulla rivista PNAS e condotto dalla Harvard Business School su oltre 2mila studenti danesi, ha mostrato la forte correlazione tra l’orario dei test scolastici e i risultati che, con il passare delle ore, peggiorano inesorabilmente. «La mattina il sistema cognitivo funziona meglio nei compiti di memoria di lavoro, di pomeriggio entra in gioco la memoria a lungo termine e, infatti, siamo facilitati nell’apprendimento», spiega Vincenzo Natale, direttore del dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. «Le informazioni acquisite di pomeriggio sono ricordate meglio».
 «Studi recenti mostrano gli effetti del passare delle ore, i cosiddetti time-of-the-day effects, su vari processi cognitivi: l’attenzione, le capacità decisionali, addirittura le scelte morali. C’è una generale, progressiva riduzione delle nostre capacità di controllo cognitivo e di auto-controllo», spiega il neuroeconomista Giorgio Coricelli dell’Università of Southern California a Los Angeles, responsabile di un gruppo di ricerca presso l’Università di Trento. Tale inibizione delle reti neurali frontali dell’attenzione esecutiva consente l’attivazione delle aree cerebrali di default (dette default mode network), attive quando la mente è libera di vagare e coinvolte nel pensiero creativo. L’intuizione geniale è più probabile a pomeriggio inoltrato e, paradossalmente, in condizioni di stanchezza mentale.
«Studi recenti mostrano gli effetti del passare delle ore, i cosiddetti time-of-the-day effects, su vari processi cognitivi: l’attenzione, le capacità decisionali, addirittura le scelte morali. C’è una generale, progressiva riduzione delle nostre capacità di controllo cognitivo e di auto-controllo», spiega il neuroeconomista Giorgio Coricelli dell’Università of Southern California a Los Angeles, responsabile di un gruppo di ricerca presso l’Università di Trento. Tale inibizione delle reti neurali frontali dell’attenzione esecutiva consente l’attivazione delle aree cerebrali di default (dette default mode network), attive quando la mente è libera di vagare e coinvolte nel pensiero creativo. L’intuizione geniale è più probabile a pomeriggio inoltrato e, paradossalmente, in condizioni di stanchezza mentale.
 Da cosa dipendono queste differenze? «Dall’interazione, detta effetto di sincronia (synchrony effect), tra il ciclo circadiano, gli stati fisiologici come l’eccitazione (arousal) e “l’energia mentale” che variano durante la giornata, e i processi omeostatici, ovvero la tendenza naturale a mantenere stabili, autoregolandoli, i parametri interni, come la temperatura corporea», risponde Coricelli. Giornata facendo, la propensione al sonno aumenta, l’energia mentale diminuisce per effetto del sistema omeostatico ma, contemporaneamente, l’arousal cresce nel giorno per ridiscendere la sera.
Da cosa dipendono queste differenze? «Dall’interazione, detta effetto di sincronia (synchrony effect), tra il ciclo circadiano, gli stati fisiologici come l’eccitazione (arousal) e “l’energia mentale” che variano durante la giornata, e i processi omeostatici, ovvero la tendenza naturale a mantenere stabili, autoregolandoli, i parametri interni, come la temperatura corporea», risponde Coricelli. Giornata facendo, la propensione al sonno aumenta, l’energia mentale diminuisce per effetto del sistema omeostatico ma, contemporaneamente, l’arousal cresce nel giorno per ridiscendere la sera.Tuttavia, questi effetti dipendono anche dalla preferenza individuale circadiana, il noto cronotipo, che fa di noi allodole mattiniere o gufi amanti della notte. Nella popolazione la distribuzione dei profili è normale: 20% di gufi puri, 10% di allodole pure e un picco di intermedi. La conoscenza della propria “identità circadiana” è accessibile, basta rispondere a un questionario scientificamente validato, il MEQ (dall’inglese morningness-eveningness questionnaire). Le preferenze individuali «si sviluppano con la crescita, cambiano con l’età, possono essere modificate con l’alimentazione, l’esposizione alla luce e altri sincronizzatori sociali», spiega Vincenzo Natale. «Si pensi all’esigenza di essere in piedi alle 7 per andare a scuola o di rimanere svegli la notte per chi lavora su turni». «Per quanto riguarda le decisioni morali, le allodole mentono e tradiscono di più di sera, mentre i gufi riducono gli standard morali all’inizio della giornata», rivela Coricelli. In genere, le allodole hanno una maggior propensione al rischio dei gufi e mettono in atto comportamenti rischiosi di sera: «Conoscendoci, dovremmo capire a che ora è meglio prendere decisioni importanti». Coricelli spiega che tutto ciò è noto agli economisti, i quali sanno che «scelte in condizioni di rischio possono essere condizionate dalla nostra capacità di valutare correttamente la rischiosità delle opzioni e che potremmo sottovalutare le conseguenze delle nostre azioni. Una riduzione delle capacità cognitive potrebbe condizionarci nelle relazioni interpersonali e favorire il conflitto rispetto alla cooperazione. Evitiamo le scelte importanti in momenti sbagliati per la nostra biologia interna: rispettiamo i tempi delle nostre cellule». L’appello alla prudenza viene anche da Natale, che invita a «non trarre dai cronotipi regole comportamentali valide per ogni individuo ». Difficile tradurre il biologico in cognitivo: «Con l’aumentare della difficoltà del compito crescono le strategie messe in atto dal singolo: arduo distinguere quanto dipende dal tempo e quanto da fattori individuali e contingenti».
Un extra di dopamina
La rotazione della Terra su se stessa e la rivoluzione intorno al Sole hanno scandito il ritmo alla vita, che si è evoluta adattandosi a queste fasi che continuano ancora oggi a darci il tempo. Le funzioni fisiologiche, sensoriali, percettive e cognitive dell’uomo e degli altri animali sono governate dalla dimensione temporale. A occuparsene è una disciplina antica ma di recente rinascita, la cronobiologia, che studia il ticchettio degli orologi interni e di quello principale che tutti li governa, il grande direttore d’orchestra nel nucleo soprachiasmatico, appena 20mila neuroni nell’ipotalamo. Per garantire il perfetto funzionamento degli organismi, migliaia di geni devono essere accesi e spenti; enzimi, ormoni, proteine e altri composti devono essere prodotti, metabolizzati e assorbiti all’interno di precisi intervalli temporali. Senza un orologio che scandisca, regnerebbe il caos.
 «Il vantaggio evolutivo di un simile sistema consiste nell’anticipare le variazioni nelle condizioni dell’ambiente esterno che sono ricorrenti, e quindi prevedibili, adattandosi a esse», spiega Roberto Manfredini, direttore del Dipartimento di scienze mediche dell’Università di Ferrara e massimo esperto di cronobiologia. «Le alterazioni del funzionamento fisiologico programmato, come le prolungate e continue rotture e disallineamenti dei ritmi circadiani, hanno conseguenze che possono sfociare nella patologia. L’esempio classico è il lavoro su turni, che comporta un costo di adattamento del sistema circadiano ancora difficile da quantificare ».
«Il vantaggio evolutivo di un simile sistema consiste nell’anticipare le variazioni nelle condizioni dell’ambiente esterno che sono ricorrenti, e quindi prevedibili, adattandosi a esse», spiega Roberto Manfredini, direttore del Dipartimento di scienze mediche dell’Università di Ferrara e massimo esperto di cronobiologia. «Le alterazioni del funzionamento fisiologico programmato, come le prolungate e continue rotture e disallineamenti dei ritmi circadiani, hanno conseguenze che possono sfociare nella patologia. L’esempio classico è il lavoro su turni, che comporta un costo di adattamento del sistema circadiano ancora difficile da quantificare ».
 Per anni si è ritenuto che le periodiche oscillazioni delle varie funzioni fisiologiche fossero solo una risposta alle variazioni quotidiane dell’ambiente fisico, come l’alternarsi del dì e della notte. Non è così. Nel 1700, l’astronomo d’Ortous de Mairan scoprì che le foglioline della mimosa pudica si aprono e si chiudono ciclicamente, anche quando la pianta è tenuta al buio. Lo stesso accade all’uomo, come hanno visto gli studi anni ’80 su soggetti in isolamento nelle grotte. La lunga permanenza a condizioni ambientali costanti ha rivelato che «il nostro organismo possiede un ritmo endogeno, il free running, che funziona senza sincronizzatori esterni, come la luce e il buio, e che si assesta su una giornata di 25 ore, un po’ superiore a quella astronomica di 24 ore».
Per anni si è ritenuto che le periodiche oscillazioni delle varie funzioni fisiologiche fossero solo una risposta alle variazioni quotidiane dell’ambiente fisico, come l’alternarsi del dì e della notte. Non è così. Nel 1700, l’astronomo d’Ortous de Mairan scoprì che le foglioline della mimosa pudica si aprono e si chiudono ciclicamente, anche quando la pianta è tenuta al buio. Lo stesso accade all’uomo, come hanno visto gli studi anni ’80 su soggetti in isolamento nelle grotte. La lunga permanenza a condizioni ambientali costanti ha rivelato che «il nostro organismo possiede un ritmo endogeno, il free running, che funziona senza sincronizzatori esterni, come la luce e il buio, e che si assesta su una giornata di 25 ore, un po’ superiore a quella astronomica di 24 ore».
 Questo spiega perché per il nostro fisico è meglio spostare le lancette indietro, come quando viaggiamo verso ovest, e non l’opposto: stiamo allungando le giornate, assecondando un elemento che è già nel nostro timer interno. Ma gli orologi biologici interni si sincronizzano (e si possono desincronizzare) anche sulla base dell’alimentazione, della vita sociale, dell’attività fisica, della luce.
Questo spiega perché per il nostro fisico è meglio spostare le lancette indietro, come quando viaggiamo verso ovest, e non l’opposto: stiamo allungando le giornate, assecondando un elemento che è già nel nostro timer interno. Ma gli orologi biologici interni si sincronizzano (e si possono desincronizzare) anche sulla base dell’alimentazione, della vita sociale, dell’attività fisica, della luce.
 «L’illuminazione elettrica nelle case ha provocato uno sconvolgimento che dura da due secoli», conferma Manfredini. «L’esposizione alla luce nel corso della notte altera la biosintesi della melatonina, ormone fondamentale nel funzionamento dei ritmi circadiani». Più in generale, la luce è cruciale per il nostro adattamento all’ambiente e ai suoi ritmi giornalieri e stagionali. E influisce sul tono dell’umore. A fare da interfaccia tra i livelli di luce esterna e il funzionamento del nostro organismo, c’è il nucleo soprachiasmatico, il principale orologio circadiano del cervello dei mammiferi. Esso, adattando la sua attività alle variazioni di illuminazione, muove l’attivazione delle altre aree del cervello per le quali funge da master clock.
«L’illuminazione elettrica nelle case ha provocato uno sconvolgimento che dura da due secoli», conferma Manfredini. «L’esposizione alla luce nel corso della notte altera la biosintesi della melatonina, ormone fondamentale nel funzionamento dei ritmi circadiani». Più in generale, la luce è cruciale per il nostro adattamento all’ambiente e ai suoi ritmi giornalieri e stagionali. E influisce sul tono dell’umore. A fare da interfaccia tra i livelli di luce esterna e il funzionamento del nostro organismo, c’è il nucleo soprachiasmatico, il principale orologio circadiano del cervello dei mammiferi. Esso, adattando la sua attività alle variazioni di illuminazione, muove l’attivazione delle altre aree del cervello per le quali funge da master clock.
 I lavori di Davide Dulcis dell’Università della California a San Diego hanno mostrato che il livello della nostra esposizione quotidiana, il photoperiod, modula la produzione di un potente neurotrasmettitore, la dopamina, in grado di inibire le cellule che regolano l’ormone dello stress nell’ipotalamo. «Una pausa sotto il sole», spiega Dulcis, che studia la luce come ansiolitico e antidepressivo, «avrebbe quindi un effetto acuto, inducendo un fenomeno di neuroplasticità nel cervello, ossia la produzione del trasmettitore del buonumore».
I lavori di Davide Dulcis dell’Università della California a San Diego hanno mostrato che il livello della nostra esposizione quotidiana, il photoperiod, modula la produzione di un potente neurotrasmettitore, la dopamina, in grado di inibire le cellule che regolano l’ormone dello stress nell’ipotalamo. «Una pausa sotto il sole», spiega Dulcis, che studia la luce come ansiolitico e antidepressivo, «avrebbe quindi un effetto acuto, inducendo un fenomeno di neuroplasticità nel cervello, ossia la produzione del trasmettitore del buonumore».La svolta nella comprensione di quest’ingranaggio dalla precisione svizzera è avvenuta con l’avanzare delle conoscenze di genetica. Tanto che il Premio Nobel per la medicina del 2017 è stato assegnato a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young per i loro studi sui meccanismi molecolari dei ritmi circadiani e sui geni che li governano. Non solo i nostri ritmi dipendono da alcuni “geni del tempo”, ma oggi sappiamo che l’espressione di moltissimi geni è circadiano-dipendente.
 È apparso su Science il più completo studio, condotto sui primati, che collega i ritmi circadiani e la trascrizione genica. Secondo questo primo atlante dell’espressione genica, opera di Satchidananda Panda del Salk Institute for Biological Studies a La Jolla in California, 8 geni su 10 seguono ritmi circadiani in molti tessuti e organi del nostro corpo. Agendo sui “geni del tempo” negli animali, gli scienziati hanno bloccato i loro ritmi circadiani. Conseguenze? Elevata mortalità cardiovascolare e rapido invecchiamento. Perché? «Non lo sappiamo veramente. Molti fattori vi contribuiscono», spiega Katja Lamia del dipartimento di fisiologia chimica del The Scripps Research Institute a La Jolla. «Per esempio, l’orologio circadiano regola sia la produzione che la risposta agli ormoni dello stress, come il cortisolo, che può alterare l’invecchiamento e la salute cardiovascolare. Inoltre, la pressione sanguigna ha un forte ritmo circadiano e le persone con inadeguato calo pressorio notturno (i non-dippers) hanno maggiore mortalità associata all’ipertensione»
È apparso su Science il più completo studio, condotto sui primati, che collega i ritmi circadiani e la trascrizione genica. Secondo questo primo atlante dell’espressione genica, opera di Satchidananda Panda del Salk Institute for Biological Studies a La Jolla in California, 8 geni su 10 seguono ritmi circadiani in molti tessuti e organi del nostro corpo. Agendo sui “geni del tempo” negli animali, gli scienziati hanno bloccato i loro ritmi circadiani. Conseguenze? Elevata mortalità cardiovascolare e rapido invecchiamento. Perché? «Non lo sappiamo veramente. Molti fattori vi contribuiscono», spiega Katja Lamia del dipartimento di fisiologia chimica del The Scripps Research Institute a La Jolla. «Per esempio, l’orologio circadiano regola sia la produzione che la risposta agli ormoni dello stress, come il cortisolo, che può alterare l’invecchiamento e la salute cardiovascolare. Inoltre, la pressione sanguigna ha un forte ritmo circadiano e le persone con inadeguato calo pressorio notturno (i non-dippers) hanno maggiore mortalità associata all’ipertensione»Tutto ha un ordine
Non è tutto cronobiologia. Perché anche la tempistica conta moltissimo, nelle strategie comportamentali e nel successo delle nostre imprese. Bisogna quindi saper sfruttare il tempo a proprio vantaggio. Chi ben comincia è a metà dell’opera. Abbiamo tutti la sensazione che un buon inizio sia molto importante. Ora la scienza dimostra che lo è anche di più. Poter nascere in un paese ricco, in pieno boom economico, per esempio, spiega bene il senso del detto “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. Ma come rimediare a passi falsi iniziali che ci condizionano? La buona notizia è che ognuno di noi ha a disposizione tanti nuovi inizi che possono diventare punti di riferimento temporali importanti. Saperli sfruttare aiuta ad avere una visione globale e a “pensare lentamente”, termine con cui il premio Nobel per l’economia Daniel Kahneman indicava i processi decisionali radicati nel ragionamento e guidati da attenta deliberazione. I candidati migliori? Sono l’inizio di un nuovo anno, il proprio compleanno, una data speciale o il primo giorno del mese o della settimana. Scrive Daniel Pink nel suo When: “Una campagna in favore di un’alimentazione sana avrebbe più successo se partisse dal primo giorno della settimana: come dire, meglio il Lunedì senza carne che il Giovedì vegetariano”.
La produttività dell’ultimo minuto. A volte le false partenze ci condizionano più di quanto vorremmo. Per rinnovare lo slancio e l’impulso motivazionale anche a metà dell’opera, i singoli individui e intere aziende possono fissare obiettivi intermedi, come sanno bene i maratoneti. Una mossa ulteriore per guadagnare in convinzione e impegno è quella di rendere pubblici questi traguardi. Infine, a metà di un percorso potremmo venire allertati da una sirena mentale interna, che ci ricorda che il tempo sta per scadere, provocando una transizione nelle nostre strategie e facendoci vincenti.
 L’ordine conta. Quando dobbiamo dare un esame universitario o superare una selezione lavorativa, è meglio essere i primi? Già, perché anche se la vita non è sempre una competizione, a volte lo è addirittura in modo seriale. In questo caso, brillare non basta, bisogna fare meglio di chi ci ha preceduto e di chi ci seguirà. E, così, spiega Pink, meglio essere i primi quando i competitori sono pochi e si può sfruttare la tendenza delle persone a ricordare il primo elemento di una serie, il cosiddetto primacy effect. Ma anche quando gli avversari sono forti, per cui gli esaminatori potrebbero prendere decisioni sulla base del narrow bracketing, l’errore cognitivo “delle parentesi anguste” che li porta a valutare i candidati successivi più severamente, confrontandoli con quelli, forti, già visti. Infine, anche in presenza di elenchi o liste: chi figura al primo posto è quasi sempre il vincente.
L’ordine conta. Quando dobbiamo dare un esame universitario o superare una selezione lavorativa, è meglio essere i primi? Già, perché anche se la vita non è sempre una competizione, a volte lo è addirittura in modo seriale. In questo caso, brillare non basta, bisogna fare meglio di chi ci ha preceduto e di chi ci seguirà. E, così, spiega Pink, meglio essere i primi quando i competitori sono pochi e si può sfruttare la tendenza delle persone a ricordare il primo elemento di una serie, il cosiddetto primacy effect. Ma anche quando gli avversari sono forti, per cui gli esaminatori potrebbero prendere decisioni sulla base del narrow bracketing, l’errore cognitivo “delle parentesi anguste” che li porta a valutare i candidati successivi più severamente, confrontandoli con quelli, forti, già visti. Infine, anche in presenza di elenchi o liste: chi figura al primo posto è quasi sempre il vincente.
 Vai avanti tu. In altri casi è conveniente attendere. Ciò è vero quando gli avversari sono numerosi ed essere gli ultimi conferisce un vantaggio di visibilità. Ma anche quando gli altri sono deboli e la competizione è bassa: infatti, in genere, man mano che i candidati si susseguono i valutatori abbandonano lo standard di eccellenza iniziale in favore di un’idea più aderente alla realtà. Conviene aspettare anche in contesti di incertezza, per capire meglio le dinamiche in gioco.
Vai avanti tu. In altri casi è conveniente attendere. Ciò è vero quando gli avversari sono numerosi ed essere gli ultimi conferisce un vantaggio di visibilità. Ma anche quando gli altri sono deboli e la competizione è bassa: infatti, in genere, man mano che i candidati si susseguono i valutatori abbandonano lo standard di eccellenza iniziale in favore di un’idea più aderente alla realtà. Conviene aspettare anche in contesti di incertezza, per capire meglio le dinamiche in gioco.La cronobiologia ci cambierà la vita
Tra i primi a interessarsi alle applicazioni pratiche della cronobiologia furono i ricercatori della Nasa. Dallo spazio si è presto passati allo sport, dove «ormai ogni team ha il suo cronobiologo, che segue gli atleti almeno un anno prima delle competizioni e personalizza le tabelle degli allenamenti», ci racconta Roberto Manfredini, cronobiologo ufficiale degli atleti italiani alle Olimpiadi invernali del 1998, a Nagano, Giappone. Dove tali conoscenze non sono ancora sufficientemente routinarie è nella clinica. Eppure i dati epidemiologici evidenziano chiare regolarità, come la maggior frequenza di infarti, ictus, dissezioni dell’aorta o embolie polmonari al mattino quando «aumentano la temperatura corporea, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca; le coronarie sono più strette dell’8% rispetto alla sera e si verificano una serie di condizioni, perfettamente fisiologiche, che tuttavia», spiega Manfredini, «in soggetti vulnerabili possono spiegare il perché del prevalente esordio mattutino di queste patologie». Anche le funzioni immunitarie variano nel corso della giornata, e nei momenti di minor attivazione è maggiore il rischio di contrarre infezioni. Inoltre, uno studio pubblicato su Science mostra che anche il microbioma, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, è in grado di influenzare l’orologio circadiano dell’apparato digerente, condizionando la quantità di grassi assorbita e immagazzinata nel corpo.
 Infine, la diversa capacità di recupero dei tessuti fa sì che, come spiega la rivista Lancet, gli interventi cardiochirurgici eseguiti nel pomeriggio vadano incontro a minori complicanze, rispetto a quelli avvenuti di mattina. Dove, invece, si sono fatti molti passi avanti è nella somministrazione delle terapie. «Dare una compressa o eseguire un trattamento come la radioterapia in concomitanza di una certa fase del ciclo cellulare, magari quando le cellule sane sono meno attive e non in fase di replicazione, può dare minori effetti collaterali e maggior efficacia». Risultati promettenti esistono già per il trattamento non solo delle malattie oncologiche ma anche di quelle autoimmuni, cardiovascolari, reumatiche e respiratorie.
Infine, la diversa capacità di recupero dei tessuti fa sì che, come spiega la rivista Lancet, gli interventi cardiochirurgici eseguiti nel pomeriggio vadano incontro a minori complicanze, rispetto a quelli avvenuti di mattina. Dove, invece, si sono fatti molti passi avanti è nella somministrazione delle terapie. «Dare una compressa o eseguire un trattamento come la radioterapia in concomitanza di una certa fase del ciclo cellulare, magari quando le cellule sane sono meno attive e non in fase di replicazione, può dare minori effetti collaterali e maggior efficacia». Risultati promettenti esistono già per il trattamento non solo delle malattie oncologiche ma anche di quelle autoimmuni, cardiovascolari, reumatiche e respiratorie.di Nicla Panciera
* LA REPUBBLICA-D, 20 Aprile 2018 (ripresa parziale senza immagini).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" - Una Teogonia moderna: l’astrofisica (di Guido Tonelli).18 marzo 2018, di Federico La Sala
Versi e scienze
Una Teogonia moderna: l’astrofisica
di Guido Tonelli (Corriere della Sera, La Lettura, 18.03.2018)
Ben prima che la seconda ondata di Sapiens, i nuovi migranti, arrivassero dall’Africa, i Neanderthal, frutto evolutivo di una migrazione più antica, già 50-70 mila anni fa popolavano molte zone dell’Europa. Organizzati in piccoli clan di una dozzina di individui, abitavano anfratti che oggi ci restituiscono prove inequivocabili di un complesso universo simbolico. Pareti affrescate con simboli e disegni di animali, cadaveri sepolti in posizione fetale, ossa e grandi stalattiti disposte in cerchi rituali. Sono innumerevoli le testimonianze di una civiltà che aveva, con tutta probabilità, un linguaggio sofisticato che non conosceremo mai.
Ed ecco che immagino il racconto delle origini del mondo che riecheggia già in quelle caverne, alla luce fioca delle fiaccole, con gli anziani che tramandano ai piccoli, potenza della parola e magia della memoria, l’eco di un mondo che sovrasta la realtà quotidiana, da cui tutto ha preso forma.
Occorrerà attendere migliaia di generazioni prima che Esiodo, o chi per lui, con la Teogonia, ci lasci la prima testimonianza scritta di questo legame fra poesia e cosmologia.
Quel grande racconto delle origini continua oggi con la scienza moderna. Le equazioni che usiamo non hanno la potenza evocativa del linguaggio poetico, ma i concetti della moderna cosmologia, un universo che nasce da una fluttuazione del vuoto o l’inflazione cosmica, ci lasciano ancora senza fiato, come accadeva ai nostri progenitori.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. -- Con il gene Clock, l’orologio biologico controlla anche l’evoluzione del cervello10 dicembre 2017, di Federico La Sala
L’orologio biologico controlla anche l’evoluzione del cervello
Con il gene Clock
di Redazione ANSA *
L’orologio biologico non controlla solo fame e sonno, ma ha un ruolo importante anche nell’evoluzione del cervello. Lo fa attraverso il gene Clock, già noto per essere il regista dei ritmi biologici (ritmi circadiani) . Lo ha scoperto lo studio coordinato dal Southwestern Medical Center dell’università del Texas (UT), pubblicato sulla rivista Genes & Development.
E’ un risultato che permette di capire come alcune proteine prodotte dal gene Clock influenzano i processi attraverso i quali i neuroni trovano il loro giusto posto nel cervello. "Ora abbiamo la prova che Clock regola molti geni al di fuori dei ritmi circadiani, quindi possiamo collocarlo come un punto chiave nella gerarchia di importanti percorsi molecolari per lo sviluppo e l’evoluzione del cervello umano", ha spiegato Genevieve Konopka, del Peter O’Donnell Jr. Brain Institute della UT Southwestern.
Il risultato ha sorpreso gli stessi ricercatori: "Una nuova funzione del gene Clock nel cervello, non direttamente correlata ai ritmi circadiani, era inaspettata e il suo possibile ruolo nell’evoluzione della neocorteccia umana è molto eccitante", ha commentato Takahashi della UT Southwestern, tra gli autori dello studio.
Il cervello umano è notevolmente più grande del cervello del nostro parente più prossimo, lo scimpanzé, ma la dimensione da sola non basta a giustificare le abilità cognitive, basti pensare a quei mammiferi come le balene e i delfini, che hanno cervelli ancora più grandi. I ricercatori hanno quindi cercato di capire cosa rende più intelligente il cervello umano.
Per farlo si sono concentrati su quell’area del cervello legata allo sviluppo del pensiero superiore, sede della memoria e dell’apprendimento, chiamata neocorteccia. Hanno così scoperto che il gene Clock, come un regista, regola l’attività di un insieme di geni importanti per l’evoluzione del cervello, alcuni dei quali legati a disturbi cognitivi e che hanno un ruolo nel processo mediante il quale i neuroni nati in alcune zone del cervello migrano per raggiungere la loro sede definitiva.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. -- L’ESPLORAZIONE DELL’UNIVERSO. Mappare l’universo per resistere al nulla.27 novembre 2017, di Federico La Sala
Mappare l’universo per resistere al nulla
di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 27.11.2017)
Come nasce una nuova teoria scientifica? In che modo si sviluppa e si diffonde fino a essere accolta dalla comunità scientifica anche quando scardina certezze e visioni consolidate del mondo? Sono questi gli interrogativi a cui vuole rispondere l’astrofisica e cosmologa Priyamvada Natarajan, nel saggio L’esplorazione dell’universo (Bollati Boringhieri). Lo fa, avverte, partendo da due osservazioni: la prima è che la più antica tra le discipline scientifiche, la cosmologia, dà forma alla nostra idea del mondo e del posto che occupiamo nell’Universo; la seconda è che, come ogni attività umana, la scienza «non è priva di soggettività», pertanto è soggetta a errori, pregiudizi, ambizioni personali, amicizie e inimicizie.
Richard Feynman, Nobel per la fisica nel 1965, affermava che ogni grande scoperta scientifica «comporta sempre una sorpresa filosofica» e per Priyamvada Natarajan questo è vero soprattutto per la cosmologia e le sue scoperte. In poche migliaia di anni, siamo passati dal credere che il mondo poggi su una tartaruga che a sua volta poggia su un’altra tartaruga, e così via all’infinito, a un progetto di mappatura dell’Universo, cui partecipa Priyamvada Natarajan insieme a scienziati di tutto il mondo, allo scopo di «mappare la materia oscura con un livello di accuratezza mai raggiunto prima». Come ci siamo arrivati?
Il prezzo da pagare ogni qualvolta la scienza cambia la mappa del cosmo e, di conseguenza, la collocazione e il senso della presenza dell’essere umano nel mondo, è molto alto in termini filosofici e psicologici.
Riferendosi al carattere dell’Età Moderna, ad esempio, Sigmund Freud riteneva che fosse il risultato di tre ferite narcisistiche. La prima, è stata la perdita della centralità e immobilità della Terra, intuita da Copernico e confermata da Galileo, dopo quattordici secoli in cui aveva dominato la visione tolemaica con la Terra immobile al centro dell’Universo; fu un tale rivolgimento che da allora l’espressione rivoluzione copernicana definisce, anche nel linguaggio comune, un cambiamento irreversibile e radicale di un sistema consolidato e immutabile. Della seconda ferita, dice Freud, è responsabile Charles Darwin, il quale ci ha spodestati dal vertice della creazione scoprendo che siamo solo una specie tra molte altre (benché, va detto, veramente molto in gamba). Della terza ferita Freud, con autostima invidiabile e non infondata, si riteneva personalmente responsabile poiché la sua scoperta delle pulsioni e del loro ruolo sulla mente ce ne aveva sottratto il pieno controllo.
Seguendo il lungo cammino di alcune idee rivoluzionarie dal primo emergere per la straordinaria immaginazione di un singolo scienziato, al riconoscimento generale, Priyamvada Natarajan racconta una storia in cui tra intuizioni geniali, lavoro collettivo, persecuzioni, entusiasmi, gelosie e trionfi, oltre alle tappe del progresso scientifico emergono gli effetti della dimensione emotiva, psicologica, personale e sociale sulla «pura ricerca intellettuale della conoscenza».
I grandi cambiamenti di paradigma e i conseguenti quesiti esistenziali, sono riferiti dall’autrice naturalmente con grande competenza scientifica - Natarajan, tra l’altro, insegna astronomia e fisica alla Yale University ed è esperta sul tema della formazione dei buchi neri supermassicci - ma anche con un’evidente sensibilità per gli aspetti umani delle diverse vicende. Sappiamo, così, quanto sia stato, e sia sempre difficile per chi ha un’idea nuova o compie una nuova scoperta ammetterla, quando comporta un cambiamento radicale di una visione consolidata. E come il peso delle passioni umane, talvolta nobili talaltra meschine, sia stato, e sia fondamentale nel facilitare o ostacolare il riconoscimento di nuove teorie o osservazioni.
Ad esempio, Edwin Hubble fu il primo a scoprire che le galassie si allontanano a velocità crescente più sono lontane ma faticò molto ad accettare l’idea, conseguente dalla sua stessa scoperta, di un Universo in espansione. L’idea, in verità, riferisce Natarajan, fu esposta molto tempo prima e da un personaggio insospettabile, lo scrittore Edgar Allan Poe, in una conferenza nel 1848, che non riscosse alcun successo, intitolata Sulla cosmogonia dell’universo, in cui descriveva la sua personale convinzione che l’Universo sia in costante movimento ed evoluzione. Anche Albert Einstein, d’altra parte, lottò parecchio con se stesso prima di rassegnarsi all’idea che il cosmo non fosse immutabile ed eterno.
A volte, invece, un’idea fatica a trovare consenso semplicemente per l’invidia o la disonestà intellettuale di qualche figura eminente e autorevole del momento. Come fu il caso della teoria sui buchi neri del fisico indiano Chandra, osteggiata in modo scorretto dal famoso Arthur Eddington, lo stesso che aveva dato prova di grande rettitudine e intelligenza comprovando sperimentalmente per la prima volta la teoria della relatività di Einstein. Eddington sostenne Einstein mentre era in corso la prima guerra mondiale, cosa che gli attirò critiche e attacchi molto duri in Inghilterra, il che dimostra la sua integrità scientifica e il suo coraggio (questa storia è raccontata in un bel film, Il mio amico Einstein, in cui emergono molto bene gli aspetti scientifici, politici e psicologici dell’intera vicenda). Ciò nonostante, lo stesso Eddington si comportò in modo meschino nei confronti di un altro scienziato, appunto l’astrofisico indiano Chandra, il quale nel 1930 aveva risvegliato con il suo lavoro l’interesse per i buchi neri.
Detto per inciso - e il saggio di Natarajan è molto ricco di informazioni di questo genere che contribuiscono a renderne piacevole la lettura - l’espressione buco nero deriva dal nome di una cella minuscola famosa a Calcutta chiamata appunto black hole, in cui in una notte del 1756 morirono per asfissia 123 prigionieri occidentali. Tornando a Chandra, la sua ipotesi «creava un terribile conflitto d’interessi per Eddington, che aveva sviluppato una propria teoria», per questo lo boicottò pur essendo stato suo esaminatore durante il dottorato a Cambridge e pur avendolo incoraggiato a proseguire il suo lavoro.
Eddington contestò duramente e inaspettatamente il collega più giovane in pubblico, durante il convegno annuale della Royal Astronomical Society nel 1935, senza avere mai prima espresso personalmente a Chandra le sue obiezioni e soprattutto senza dargli possibilità di replica. Per Chandra fu un vero colpo, ma nel 1942 la sua tesi fu sostenuta pubblicamente da alcuni tra i più importanti scienziati del tempo, tra i quali Paul Dirac, considerato il più grande genio del Novecento dopo Einstein (si deve a lui l’equazione che ha formalizzato la struttura della meccanica quantistica e previsto l’esistenza dell’antimateria). Nel 1983 Chandra ha vinto il premio Nobel per la fisica. E giustizia è stata fatta.
Mappare l’Universo, adesso che ne conosciamo l’immensità e l’espansione continua, può sembrarci come il tentativo di vuotare l’oceano con un bicchiere. Eppure non possiamo farne a meno, lo abbiamo sempre fatto. Infatti, anche se noi associamo l’idea di mappa ai viaggi per mare e per terra, in realtà, ricorda Natarajan, le prime mappe mai disegnate dall’uomo sono mappe del cielo. E pure oggi scrutiamo il cosmo, percorrendolo con gli occhi di immensi telescopi, come gli esploratori antichi scrutavano l’orizzonte e lo spazio attorno per decifrarlo, per non perdersi.
La nostra condizione è la stessa, il nostro oceano è il cosmo, la nostra nave la terra. «Per loro natura i progressi della cosmologia ci lasciano senza ormeggi», afferma Priyamvada Natarajan. Ed è così che siamo, oggi ancor più che nel passato: disancorati, senza un centro fuori di noi e forse neppure più dentro di noi - ma questo non è colpa dell’Universo. Ad ogni modo, conclude, «Negli ultimi cento anni la nostra visione del mondo è cambiata drasticamente, riscrivendo il senso stesso di chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo».
Oggi sappiamo di vivere in un Universo meraviglioso, ma non eterno. È nato in un certo momento e in un altro che non sappiamo, e in un modo che non sappiamo ma siamo in grado di ipotizzare, finirà o diventerà qualcosa di totalmente diverso. Un Universo, ha affermato Carlo Tonelli, fisico del Cern e grande divulgatore scientifico, fragile e precario, come ha rivelato la scoperta del bosone di Higgs - la particella che tiene insieme la materia ma di cui nulla ci può garantire che continuerà a farlo -, che condivide in qualche modo la nostra stessa situazione di fragilità. Col che, negli ultimi tempi, è stato scardinato ogni appiglio, fino all’ultimo, fino all’idea che almeno l’Universo potesse costituire una certezza, qualcosa che si poteva immaginare sarebbe durato per sempre. Insomma, un posto in cui la vita avrebbe sempre avuto una possibilità.
La situazione in cui ci ha messi la conoscenza è duplice e ambigua, eccitante, ma disorienta e confonde, perché ci insegna che siamo allo stesso tempo unici, grandiosi e insignificanti. Siamo riusciti a scoprire le dinamiche che governano il mondo, persino le più contro-intuitive, dall’infinitamente piccolo all’incommensurabilmente grande, e abbiamo capito di essere un nulla rispetto all’immensità che ci circonda. Siamo costretti a rimettere in discussione concetti sui quali per migliaia di anni abbiamo costruito civiltà ed elaborato filosofie e religioni: il tempo, l’eternità, la distinzione tra spirito e materia...
Dobbiamo ripensare molte cose per trovare nuove risposte a domande antiche e ineludibili: chi siamo, dove andiamo e, soprattutto, perché. Per la prima volta nella storia umana sappiamo con certezza che, a prescindere da noi, l’esistenza della Terra, dell’intero sistema solare e dell’Universo, forse l’esistenza in se stessa finirà, e tutto questo, anche se non ce ne accorgiamo, segna lo spirito del nostro tempo e noi stessi.
La morte di Dio aveva aperto la strada alle utopie escatologiche laiche, come il marxismo, lasciando intatta la speranza che l’umanità potesse realizzare con le sue forze e i suoi progressi una società e una vita migliori per tutti.
Ma il limite che le scienze ci fanno intravedere, per quanto lontano, rende il sogno una sorta di palliativo per combattere un’insensatezza che si è insinuata come una nebbia a offuscare il sole di qualunque avvenire.
E così la metafisica e le sue domande sull’essere, il nulla e il senso del mondo che le scoperte scientifiche avrebbero dovuto - pensavano alcuni - mettere a tacere per sempre, proprio grazie alla scienza si stanno pian piano riaffacciando sulla scena del pensiero.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA. AL DI LA’ DI NEWTON, CON KANT - E ARTHUR S. EDDINGTON ...
 ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!).
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!). -
> LA LUCE, LA TERRA -- Telefonini e orologio biologico. Nonostante l’illuminazione artificiale e gli impegni sociali, è ancora il Sole a scandire i ritmi biologici dell’uomo22 novembre 2017
Telefonini diventano la ’spia’ dell’orologio biologico
Le chiamate scandite da alba e tramonto
Redazione ANSA 22 novembre 2017
- Nonostante l’illuminazione artificiale e gli impegni sociali, è ancora il Sole a scandire i ritmi biologici dell’uomo (fonte: Daniel Monsivais) © Ansa
Nonostante la vita sempre più urbanizzata con i suoi ritmi prestabiliti e il buio impossibile con le luci artificiali della città, è ancora la natura a scandire i ritmi dell’orologio biologico, attraverso il sorgere e calare del Sole. Lo dimostrano i telefonini, che si sono rivelati un utile diario dei bioritmi umani, attraverso l’analisi della loro attività. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta nella finlandese University School of Science, di Espoo, e pubblicata sulla rivista Plos Computational Biology.
Guidati da Daniel Monsivais, i ricercatori hanno dedotto i periodi di veglia attraverso l’inizio e la fine delle chiamate sulla base dei dati di un milione di utenti di telefonia mobile raccolti nell’arco di un anno in un Paese del Sud Europa, il cui nome non è stato reso noto.
E’ emerso in questo modo che, nonostante l’illuminazione artificiale, sono ancora albe e del tramonti a scadire l’inizio e la fine delle attività della giornata. Nel corso di tutto l’anno, inoltre, il cambiamento dell’orario delle attività giornaliere segue le variazioni del del sorgere e calare del Sole.
E’ emerso inoltre che le donne tendono a dormire più degli uomini (un dato che conferma i risultati di altri studi) e che la durata del sonno varia a seconda dell’età. Più ci si avvicina all’età adulta, più si tende a dormire, mentre si dorme leggermente meno verso la mezza età e le ore di sonno aumentano di nuovo durante la vecchiaia.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
ONU: 2015, ANNO DELLA LUCE. Nobel per la Medicina 2017 alla scoperta dei meccanismi che regolano l’orologio biologico ...
 LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" -
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. -- L’esploratore di esopianeti Michael Gillon: «Cari ragazzi, una rivoluzione vi aspetta».22 novembre 2017, di Federico La Sala
L’esploratore di esopianeti Michael Gillon:
«Cari ragazzi, una rivoluzione vi aspetta»
di Nicla Panciera (La Stampa, 22.11.2017)
«Ci sono innumerevoli Soli e innumerevoli terre, tutte ruotanti attorno ai loro soli, esattamente allo stesso modo dei sette pianeti del nostro Sistema Solare», scriveva Giordano Bruno nel 1584. Per dare conferma scientifica a quest’ipotesi visionaria sull’esistenza di pianeti orbitanti intorno a stelle come il Sole ci sono voluti tre secoli. Ma sono bastati 20 anni dalla scoperta del primo esopianeta extrasolare, 51 Pegasi b, per arrivare a contarne oltre 3 mila.
«Queste cifre suggeriscono che quasi tutte le stelle della nostra galassia e, quindi, dell’intero Universo ospitano un sistema planetario. Nei vari mondi fin qui osservati è emersa un’inaspettata diversità e ora ne stiamo studiando le diverse architetture, la loro formazione ed evoluzione», ci spiega Michael Gillon dell’Università di Liegi in Belgio. Per i suoi contributi alla fondazione della disciplina che studia gli «altri mondi», l’esoplanetologia, gli è stato assegnato il Premio Balzan 2017, riconoscimento di 750 mila franchi svizzeri.
È suo il primo nome sul lavoro pubblicato da «Nature» sulla scoperta di sette pianeti simili alla Terra intorno alla nana rossa Trappist-1. Cacciatore di pianeti fin da quando ha deciso di volgere lo sguardo al cielo, il giovane ricercatore ha già incontrato molti studenti intelligenti e brillanti. A loro dice di non farsi spaventare dai piccoli ostacoli iniziali, ma di concentrarsi sulla magia dell’astrofisica: «Imbarcarsi in quest’avventura non li deluderà, viviamo in un momento entusiasmante in cui c’è spazio per grandi scoperte. La passione deve, però, essere così dirompente da sovrastare gli altri bisogni»: parola di un ex militare che ha trascorso sette anni in fanteria prima di decidere di riprendere gli studi e di dedicare il suo rigore e la sua tenacia alle battaglie scientifiche.
È molto riconoscente verso l’amata Wendy e i figli Amanda e Lucas per il supporto ricevuto e ammette di non rappresentare la norma: «Dopo il post-dottorato, a Ginevra, sono tornato a Liegi, ma la maggior parte degli scienziati si sposta per acquisire competenze da un ateneo all’altro, di continente in continente, e spesso finisce per stabilirsi molto lontano dal proprio Paese e dai propri cari».
L’astrofisica - conferma - sta vivendo un momento di grande fermento. Sta per partire il progetto che Gillon ha nominato come i celebri biscotti belgi, «Speculoos» e, nel 2019, Esa e Nasa lanceranno il gigantesco telescopio spaziale «James Webb». Intanto, in Cile, è in via di installazione il telescopio europeo E-Elt, il più grande mai realizzato finora. Assistiamo poi ad un moltiplicarsi di missioni per la ricerca di nuovi mondi: «Tess» della Nasa, al via la prossima primavera, e «Cheops» e «Plato» che l’Esa lancerà rispettivamente nel 2019 e 2025.
Le aspettative sono pari agli sforzi messi in campo: «Ci stiamo attrezzando per esplorare una terra incognita, dove mai abbiamo messo piede e neppure gettato lo sguardo», assicura il cacciatore di esopianeti e, muovendo le mani davanti a sé come afferrando una torcia, ribadisce: «Illuminiamo i territori bui con i nostri telescopi, che ci restituiranno un sacco di sorprese». Come accadde a Galileo con il suo cannocchiale: «È difficile dire che cosa otterremo dai vari programmi in partenza, in pratica tutto è possibile. A guidarci non è solo la teoria ma l’osservazione. Non puntiamo solo, come un tempo, alla conferma sperimentale delle ipotesi fisiche. Stiamo spingendo al massimo le capacità tecnologiche, che costituiscono, di fatto, i limiti delle nostre conoscenze».
E, infine, la grande questione che affascina da sempre l’umanità: la vita. «Cercando tracce chimiche di attività biologica, vogliamo scoprire la prevalenza della vita nello spazio, non avendo alcuni a priori sulla frequenza di questo evento. Questo ci aiuterà a capire meglio le nostre origini e a mettere la nostra esistenza in una prospettiva galattica. Le implicazioni vanno oltre la scienza e invadono i reami della filosofia. Sono gli aspetti sociali e culturali a rendere questo interrogativo fondamentale».
Quanto ci vorrà? «Potrebbero bastare uno o due decenni. Il meglio deve ancora venire. Una rivoluzione scientifica è alle porte». La generazione di giovani scienziati che dichiarerà l’eppur c’è vita, dall’impatto travolgente come l”eppur si muove” galileiano, è già nata.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
- Oggi, gli uomini e le donne non solo hanno appreso come nascono i bambini e le bambine sulla Terra, ma, portatisi e portatesi fuori - nell’oceano cosmico, hanno visto la sfera in cui abitano: la nostra Terra è illuminata dal Sole ed è piena di vita e di brillante colore.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E - LA MENTE ACCOGLIENTE - EINSTEIN, RELATIVITA’ GENERALE, ONDE GRAVITAZIONALI, E NOBEL PER LA FISICA.3 ottobre 2017, di Federico La Sala
Nobel per la Fisica a Kip Thorne, Barry Barish e Rainer Weiss
Menzionate le collaborazioni internazionali Ligo e Virgo. Gli Applausi e i brindisi dei fisici italiani
di Redazione ANSA *
l Nobel per la Fisica 2017 è stato assegnato alla scoperta delle onde gravitazionali. Il Nobel è stato assegnato a Kip Thorne, Barry Barish e Rainer Weiss. Sono state menzionate le collaborazioni internazionali Ligo e Virgo.
Una metà del premio va a Rainer Weiss, mentre l’altra metà è stata assegnata congiuntamente a Barry C. Barish e Kip S. Thorne "per il contributo decisivo al rivelatore Ligo e all’osservazione delle onde gravitazionali". Per tutti e tre i premiati la Fondazione Nobel ha indicato come affiliazione le collaborazioni Ligo-Virgo.
Weiss (85 anni), è nato nel 1932 a Berlino. Ha preso il dottorato nel 1962 negli Stati Uniti, nel Massachusetts Institute of Technology (Mit), dove ha continuato a insegnare.
Barish (81 anni) è nato nel 1936 negli Stati Uniti, a Omaha. Dopo il dottorato nell’Università della California a Berkeley, ha insegnato nel California Institute of Technology (Caltech).
Thorne (77 anni) è nato negli Stati Uniti, a Logan. Ha studiato nell’università di Princeton e ha avuto la cattedra di fisica teorica nel California Institute of Technology (Caltech). E’ diventato celebre per il grande pubblico dopo la sua consulenza scientifica per il film Interstellar.
Emozione e commozione, un grande abbraccio all’Infn
Un grandissimo applauso e un brindisi ha accolto, nella sede dell’Infn a Roma, la notizia del Nobel per la Fisica 2017 alla scoperta delle onde gravitazionali, "Questa volta è stata premiata la globalità della scienza", ha detto il direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego), Federico Ferrini, dedicando il brindisi al papà del rivelatore Virgo, Adalberto Giazotto.
D’Amico, apre nuovi orizzonti studio cosmo
Un riconoscimento che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo e i telescopi italiani sono già all’opera per catturare le prime fotografie delle sorgenti di onde gravitazionali. Così il presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Nichi D’Amico, commenta l’assegnazione del Premio Nobel 2017 per la Fisica alla scoperta delle onde gravitazionali. ’’Un grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo’’ ha detto D’Amico. I telescopi dell’Inaf ha aggiunto ’’sono già all’opera per produrre le prime ’fotografie’ delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio’’.
Ferrini, grande successo per Europa ed Italia
"E’ una giornata storica, è meraviglioso": il direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego), Federico Ferrini, è entusiasta del Nobel alla scoperta delle onde gravitazionali. "E’ stata un’attesa trepidante e piena di speranze, che alla fine non sono andate deluse", ha detto subito dopo il brindisi e gli abbracci con gli altri protagonisti italiani della collaborazione Virgo, riuniti a Roma, nell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Il Nobel assegnato oggi "è un grandissimo successo per l’Europa: Virgo - ha aggiunto - è il risultato della collaborazione fra sei Paesi europei, che ha sviluppato una tecnologia in modo indipendente dal punto di vista tecnologico rispetto a quella del rivelatore americano Ligo, anche se in modo parallelo. Tanto - ha rilevato - da arrivare a suggerire a Ligo delle scelte tecnologiche e a prendere dati insieme".
Le collaborazioni Ligo e Virgo
Le due collaborazioni Ligo e Virgo menzionate nel premio Nobel per la Fisica 2017 sono il risultato corale di una ricerca che nasce dalla partecipazione di 1.500 fisici di tutto il mondo, almeno 200 dei quali sono italiani. Da un’idea italiana, del fisico Adalberto Giazotto, è nato il rivelatore Virgo, costruito nella campagna alle porte di Pisa, a Cascina. Nato dall’idea lanciata a meta’ degli anni ’80 da Giazotto e Alain Brillet, Virgo fa parte dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego), fondato nel 2000 dall’Italia, con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dalla Francia, con il Consiglio nazionale della ricerca scientifica Cnrs.
La sensibilità del rivelatore è stata aumentata grazie alla nuova versione di Virgo (Advanced Virgo), che ha appena concluso la prima fase congiunta di osservazione con Ligo: i due rivelatori hanno lavorato insieme come un unico, potentissimo strumento. Le due antenne di Virgo si trovano negli Stati Uniti sono entrati in funzione nel 2004 negli Stati Uniti (ad Handford, nello Stato di Washington, e a Livingston, nella Louisiana). Recentemente sono stati potenziati ed e’ stata questa nuova versione, chiamata Advanced Ligo, ad ascoltare per la prima volta le vibrazioni dello spazio-tempo. Diretta da Gabriela Gonzales, la collaborazione Ligo (Laser InterferometerGravitational-WaveObservatory) e’ condotta congiuntamente dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) e dal California Institute of Technology (Caltech), insieme ad altri centri di ricerca e universita’ degli Stati Uniti, e comprende oltre 900 ricercatori di tutto il mondo.
Che cosa sono le onde gravitazionali
Previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, le onde gravitazionali sono state scoperte da due grandi collaborazioni internazionali, l’americana Ligo e l’europea Virgo, alla quale l’Italia collabora con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Le onde gravitazionali sono le ’vibrazioni’ dello spazio-tempo provocate dai fenomeni più violenti dell’universo, come collisioni di buchi neri, esplosioni di supernovae o il Big Bang che ha dato origine all’universo.
Viste per la prima volta nel settembre 2015, la loro scoperta è stata annunciata l’11 febbraio 2016 e adesso è stata finalmente premiata da un Nobel molto atteso. Come le onde generate da un sasso che cade in uno stagno, le onde gravitazionali percorrono l’universo alla velocità della luce creando increspature dello spazio-tempo finora invisibili. Poiché interagiscono molto poco con la materia, le onde gravitazionali conservano la ’memoria’ degli eventi che le hanno generate.
La scoperta delle onde gravitazionali è stata anche la conferma definitiva della teoria della relatività generale. Erano infatti l’unico fenomeno previsto da questa teoria a non essere stato ancora osservato.
* ANSA 03 ottobre 2017 (ripresa parziale).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E - RITMO CIRCADIANO. IL COMPORTAMENTO DELL’OROLOGIO BIOLOGICO. Nobel Medicina 2017 a a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young.2 ottobre 2017, di Federico La Sala
Nobel della Medicina ai ’papà’ dell’orologio biologico
Premiati gli americani Hall, Rosbash e Young
di Redazione ANSA *
- Il Nobel per la Medicina 2017 alla scoperta dei meccanismi che regolano l’orologio biologico © Ansa FOTO
Il Nobel per la Medicina 2017 è stato assegnato congiuntamente a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young per aver scoperto il meccanismo molecolare che controlla il ritmo circadiano, ossia il comportamento dell’orologio biologico.
Hall, Rosbash e Young sono riusciti a scoprire il meccanismo con il quale tutti gli esseri viventi, dalle piante agli esseri umani, riescono a regolare i loro ritmi biologici in sintonia con l’ambiente, ad esempio con l’alternarsi di giorno e notte conseguenza della rotazione della Terra.
L’orologio biologico anticipa e adatta la nostra fisiologia alle diverse fasi del giorno, regolando attività come il sonno, la fame, il rilascio di ormoni, la pressione del sangue e la temperatura corporea (fonte: Fondazione Nobel)
Negli anni ’80, studiando il Dna degli organismi più semplici e più studiati dai genetisti, i moscerini della frutta (Drosophila melanogaster), Hall e Rosbash hanno isolato il gene chiamato Period (o semplicemente Per) che regola questo comportamento universale e hanno dimostrato che controlla la produzione di una proteina che si accumula nelle cellule durate la notte e che viene degradata durante il giorno, sempre nello stesso intervallo di tempo. Restava da capire in che modo la proteina Per riuscisse a penetrare nel nucleo e la risposta è arrivata nel 1994, quando Young ha identificato un secondo gene chiamato Timeless (o Tim), che produce la proteina che ha lo stesso nome e che, legandosi alla proteina Per, la aiuta a penetrare nel nucleo delle cellule.
Schema del funzionamento del gene alla base dell’orologio biologico. L’immagine ricostruisce la sequenza di eventi nell’arco di 24 ore (fonte: Fondazione Nobel)
- CHI SONO I PREMIATI
Jeffrey C. Hall, 72 anni, è nato nel 1945 a New York e si è laureato nell’università di Washington a Seattle. Dal 1971 al 1973 ha lavorato nel California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena. Nel 1974 si è trasferito nella Brandeis University di Waltham in 1974 e nel 2002 in quella del Maine.
Michael Rosbash, 71 anni, è nato a Kansas City e si è laureato nel 1970 nel Massachusetts Institute of Technology (Mit). Nei tre anni successivi ha lavorato in Europa, nell’università scozzese di Edimburgo, e nel 1974 è rientrato negli Stati Uniti e da allora ha lavorato nella Brandeis University.
Michael Young, 68 anni, è nato nel 1949 a Miami e si è laureato nell’università del Texas ad Austin nel 1975. Da allora fino al 1977 ha lavorato nell’università di Stanford e dal 1978 nella Rockefeller University di New York.
Le foglie della mimosa sono un esempio di orologio biologico: si aprono verso il Sole durante il giorno e si chiudono al tramonto; continuano a seguire questi ritmo anche quando sono costantemente al buio (fonte: Fondazione Nobel)
- I COMMENTI
Glauco Tocchini Valentini, una scoperta fondamentale
E’ una scoperta di "importanza fondamentale", quella dei meccanismi che controllano l’orologio biologico che ha spesso portato in Italia uno dei tre neo-premiati con il Nobel per la Medicina, Michael Rosbash. "E’ stato ripetutamente qui da noi, nel Campus Internazionale ’A. Buzzati-Traverso’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), ha detto il direttore del laboratorio, Glauco Tocchini Valentini.
Dopo aver studiato i meccanismi alla base dell’orologio biologico nei moscerini della frutta, Rosbash veniva in Italia per studiare lo stesso fenomeno in organismi più complessi, come i topi, utilizzando l’archivio dei topi mutanti del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (Embl) attivo fin dagli anni ’90 a Monterotondo. "Probabilmente - ha aggiunto - quando in dicembre andrà a Stoccolma - passerà in Italia, per salutarci ancora in laboratorio".
A Rosbash, del quale Tocchini Valentini ricorda divertito le battute di spirito, e ai suoi colleghi Jeffrey C. Hall e Michael W. Young, va il merito di "avere aperto e reso percorribile una nuova, importantissima strada per la ricerca, che è alla base di meccanismi importanti per la determinazione di alcune malattie. Quello che i tre Nobel hanno scoperto - ha concluso Tocchini Valentini - è l’importanza del ciclo biologico per tutti gli organismi, compreso l’uomo e i batteri che vivono nell’uomo".
Valter Tucci (Iit), premiata una scoperta fantastica
E’ stata premiata una scoperta "fantastica" perché l’orologio biologico è essenziale per l’adattamento di tutti gli esseri viventi alla Terra: lo ha detto il direttore della linea di ricerca su Genetica ed epigenetica del comportamento dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), Valter Tucci, commentando l’assegnazione del Nobel per la Medicina agli americani Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young.
"I ritmi circadiani sono importantissimi per regolare molti processi biologici e i tre Nobel - ha osservato Tucci - hanno dimostrato qual è il meccanismo molecolare che li controlla in tutto il regno vivente, dalle piante agli animali unicellulari, dal moscerino della frutta ai mammiferi". Sono, ha aggiunto, "meccanismi fondamentali per l’adattamento degli esseri viventi alla Terra, per adattarci all’ambiente in cui viviamo". Dal jet lag ai disturbi più gravi del sonno, i meccanismi che regolano i ritmi circadiani rivestono un ruolo di primo piano, ma hanno voce in capitolo anche in altri aspetti importanti, come i ritmi ormonali, il metabolismo e in generale tutti i meccanismi che regolano lo sviluppo e che entrano in gioco nella vita embrionale fino ai primi momenti dopo la nascita: "è un corredo - ha rilevato - che ci portiamo dietro per tutta la vita". Si deve all’orologio biologico anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti stagionali e "soltanto ora - ha osservato Tucci - cominciamo a scoprire che i meccanismi che regolano i ritmi circadiani ci permettono una plasticità di adattamento all’ambiente".
Se i tre Nobel hanno scoperto i geni che regolano l’orologio biologico, "la prossima frontiera è spiegare esattamente i meccanismi epigenetici, ossia i meccanismi molecolari che non riguardano la sequenza del Dna , ma che ne modificano il prodotto".
E’ un passo che permetterà di comprendere i problemi dello sviluppo neurale, come quelli che portano al ritardo mentale, disturbi psichiatrici e malattie del metabolismo, fino ai tumori e al controllo della temperatura, che oscilla periodicamente nelle 24 ore, fornendo all’organismo segnali essenziali per facilitare il sonno e il risveglio. Si calcola, ha concluso, che tra il 15% e il 20% dei geni noti abbiano un’oscillazione circadiana e che gli altri siano controllati direttamente o indirettamente dall’orologio biologico.
* Redazione ANSA, 02 ottobre 2017 (ripresa parziale)
Nobel Medicina, come funziona il metronomo della vita
Boncinelli, una grande lezione sulla ricerca di base
di Redazione ANSA *
Una grande lezione sul valore della ricerca di base, "per un Paese che non finanzia le ricerche sui moscerini perché sono troppo lontane dall’uomo": così il genetista Edoardo Boncinelli ha commentato il Nobel per la Medicina 2017 alla scoperta del meccanismo alla base dell’orologio biologico.
La scoperta, ha proseguito Boncinelli, è stata possibile dopo avere individuato dei moscerini della frutta (Drosophila melanogaster) mutanti, ossia il cui orologio biologico non andava a tempo oppure non esisteva affatto. "E’ stata un’operazione piuttosto lunga: una volta individuato il gene alla base dell’orologio biologico, chiamato ’period’ (o Per), è stato isolato e solo allora si è visto che il suo funzionamento era semplicissimo e che la proteina prodotta da quel gene impiegava un un certo tempo per andare dal nucleo della cellula all’ambiente che circonda il nucleo, chiamato citoplasma, e che solo dopo questo percorso veniva degradata. Una sorta di tempo fisso, una specie di metronomo della vita".
Naturalmente il gene Per da solo, ha proseguito Boncinelli, non avrebbe potuto far funzionare l’intero meccanismo, e in seguito sono stati scoperti altri geni, il più importante dei quali si chiama ’Timeless’: la proteina che produce si lega a quella del gene Per, rendendo possibili tutte le variazioni che derivano dall’ambiente esterno. "I nostri orologi sono legati all’alternarsi di giorno e notte perché siamo sensibili alla luce. Sappiamo che il metronomo va adattato e che, quando facciamo un viaggio al di là dell’oceano il nostro orologio si sfasa, ma si rimette a posto perché i nostri occhi vedono l’alternarsi di giorno e notte". Molti anni fa, ha concluso, "si pensava all’esistenza di un cosiddetto ’terzo occhio’, ma adesso sappiamo che una sottopopolazione di cellule della retina è specializzata nel misurare la lunghezza dei periodi di luce e buio".
* Ansa, 02.09.2017 (ripresa parziale).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E ... LE ALTRE TERRE. Il 2018 è l’anno del telescopio della Nasa “James Webb”. Individuerà nuovi esopianeti e studierà le loro atmosfere.23 agosto 2017, di Federico La Sala
Andremo a esplorare le altre Terre in cerca degli alieni
Il 2018 è l’anno del telescopio della Nasa “James Webb”. Individuerà nuovi esopianeti e studierà le loro atmosfere. E altre missioni si preparano a svelare i misteri della vita
di Amedeo Balbi (La Stampa, 23.08.2017)
Non tutti ne sono ancora consapevoli, ma proprio in questi anni stiamo vivendo una rivoluzione scientifica che potrebbe avere profonde conseguenze per la comprensione del nostro posto nell’Universo, paragonabili a quelle prodotte dalle idee di Copernico o di Darwin. Da poco più di 20 anni abbiamo trovato le prove che esistono altri pianeti intorno ad altre stelle. Non solo, ma molti di questi pianeti sembrano avere caratteristiche fisiche che potrebbero potenzialmente renderli adatti alla presenza di forme di vita.
Se ci si ferma a riflettere sui numeri, c’è da rimanere a bocca aperta: le stime attuali ci dicono che molto probabilmente ognuna dei circa 200 miliardi di stelle della nostra galassia ha almeno un pianeta che le orbita attorno. Quelli potenzialmente abitabili (non da noi, naturalmente, ma da qualche forma di vita «autoctona», magari microscopica) potrebbero essere decine di miliardi. Quando guardate il cielo in una notte d’estate, provate a pensare all’incredibile vastità di ambienti alieni che state abbracciando con un solo sguardo.
Quelle precedenti sono estrapolazioni basate sulle osservazioni di esopianeti (pianeti che orbitano attorno ad altre stelle), compiute negli ultimi due decenni grazie a una serie di sofisticati strumenti astronomici. Attualmente il numero di esopianeti noti supera di poco quota 3500.
La maggior parte è stata scoperta da una missione spaziale di grande successo, il satellite Kepler della Nasa. Kepler è un telescopio relativamente modesto (ha uno specchio di 95 cm, poca cosa rispetto ai più grandi telescopi terrestri che ormai toccano la decina di metri di apertura), ma il fatto di trovarsi nello spazio lo mette in una posizione di vantaggio. Kepler ha potuto osservare la minuscola diminuzione di luminosità causata dal transito di un pianeta di fronte alla propria stella, con una sensibilità che al momento è preclusa agli strumenti terrestri. Alcune centinaia di esopianeti sono stati scoperti con una tecnica differente, basata sull’osservazione del piccolo spostamento periodico della stella indotto dall’interazione gravitazionale con uno o più pianeti.
Dopo la valanga di scoperte recenti, ora stiamo entrando in una seconda fase nello studio degli esopianeti, in cui si esamineranno più in dettaglio i candidati più interessanti, in particolare quelli che sembrano più promettenti dal punto di vista della potenziale abitabilità. Il futuro prevede una serie di nuovi progetti osservativi, alcuni dei quali vedranno la luce a breve. Due nuove missioni spaziali, una dell’Esa e l’altra della Nasa, dovrebbero essere lanciate entro l’anno prossimo. Si tratta, rispettivamente, di Cheops e di Tess. Il primo, un piccolo telescopio spaziale di appena 30 cm di apertura, osserverà il transito di esopianeti già noti per provare a determinarne la densità e quindi la composizione fisica. Il secondo cercherà di incrementare il bottino di pianeti di dimensioni simili alla Terra messo insieme da Kepler, concentrandosi soprattutto su stelle brillanti e relativamente vicine alla nostra. Ciò preparerà la strada per le osservazioni del James Webb Space Telescope, il successore del telescopio spaziale Hubble che la Nasa dovrebbe mettere in orbita verso la fine del 2018.
Le aspettative per questa missione sono altissime (anche visto l’enorme impegno economico profuso per la sua realizzazione) e prevedono la possibilità di studiare le atmosfere di esopianeti già noti, determinandone la natura e la composizione. Capire come è fatta l’atmosfera di un pianeta è uno degli ingredienti cruciali per stabilirne le condizioni climatiche e l’effettiva propensione a ospitare organismi viventi. Non solo, ma la presenza stessa della vita può alterare in modo misurabile la composizione dell’atmosfera, come è avvenuto sul nostro pianeta con la comparsa degli organismi fotosintetici, che hanno rilasciato enormi quantità di ossigeno.
Investigare mondi lontanissimi dal nostro, fino addirittura a cercarvi le possibili tracce della vita, è un obiettivo difficile, che non sarà raggiunto nel giro di pochi anni, e che richiederà uno sforzo congiunto e l’applicazione di molte tecniche diverse. Non solo osservazioni dallo spazio, ma anche con telescopi terrestri: quelli di prossima generazione, come lo European Extremely Large Telescope, o Elt, di cui è iniziata la costruzione in Cile, avranno dimensioni imponenti (lo specchio sfiorerà i 40 metri di diametro) e potrebbero persino ottenere le prime immagini dirette di pianeti simili alla Terra. Se i passati 20 anni sono stati quelli in cui abbiamo capito che esistono altri mondi oltre a quelli del sistema solare, i prossimi 20 saranno quelli in cui proveremo a capire una volta per tutte se siamo davvero soli nell’Universo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA -- "Nell’occhio del pittore. La visione svelata dall’arte"(G. Di Napoli). Rec. di Maria L. Ghianda.11 agosto 2017, di Federico La Sala
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA. AL DI LA’ DEL NARCISISMO E DELLA FASCINAZIONE MORTALE DELLO SPECCHIO ...*
L’occhio è visionario
di Maria Luisa Ghianda *
“Il nostro occhio è portato a vedere le cose e non ciò che le rende visibili, vede oggetti illuminati dalla luce ma non la luce che li illumina, né il tono delle ombre che avvolgono la loro superficie, né quello dei riflessi che rimbalzano su di esse; vede che l’erba è verde, le ciliegie sono rosse e il cielo è azzurro, ma non isola il fenomeno cromatico dalla cosa in cui si manifesta, vede cioè cose colorate e non il colore delle cose.”
Con queste parole Giuseppe Di Napoli ci introduce al suo studio: “Nell’occhio del pittore. La visione svelata dall’arte” stabilendo fin da subito che l’uomo comune non guarda il mondo alla stessa maniera del pittore.
Nonostante l’evoluzione della specie umana, il nostro occhio, infatti, guarda ancora come faceva ai primordi, selezionando rapidamente gli elementi che sono utili per la sopravvivenza (distinguere in fretta le cose nocive o pericolose da quelle innocue; quelle velenose da quelle commestibili; i predatori dalle prede etc.) lasciando in secondo piano tutto il resto. I pittori, invece, con il loro “sguardo straniero”, tendono ad isolare i dettagli, a cogliere i colpi di luce su un oggetto, su un volto, o su paesaggio, si occupano delle ombre (sarà Delacroix il primo a scoprire che le ombre sono colorate e quelle da lui colte nei suoi “Diari” sono strepitose) ma soprattutto indagano la forma e sono maestri nel metterla in relazione con il suo intorno. Già, perché il pittore, anche se dipinge scene verosimili, non “riproduce” mai in modo pedissequo il vero visibile, anzi, per dirla tutta, non lo riproduce affatto, almeno non secondo l’assioma di Paul Klee, che recita: “L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”. Ecco dunque in cosa consiste il lavoro del pittore, guardare il mondo per rendere visibile ciò che esiste ma che non cade necessariamente sotto il senso della vista; e se invece l’oggetto da lui selezionato e indagato risultasse già visibile, egli ce lo mostra in un modo in cui non avremmo mai saputo vederlo. Lo studio di Giuseppe Di Napoli si occupa proprio di questo: “portare il lettore a guardare le cose con gli occhi dei pittori”. E così l’avventura dello sguardo ha inizio.
Che la rappresentazione della realtà offerta dalla pittura occidentale, soprattutto dopo la messa a punto del sistema prospettico, sia illusoria, concettualistica e dunque per nulla simile al vero visibile è un dato acclarato. Non si deve infatti dimenticare che la prospettiva centrale piana come sistema di ‘messa in scena’ del reale, si fonda su dei paradossi che ne stigmatizzano l’intellettualismo: a) innanzi tutto la realtà è supposta immobile (cosa non veridica, perché attorno a noi e sotto i nostri piedi tutto si muove, la terra gira su se stessa e ruota attorno al sole); b) in secundis il pittore fa conto che la scena da lui osservata e che vuole riprodurre sia immersa nel vuoto, in una sorta di camera pneumatica ben lontana dalla realtà atmosferica che ci circonda; c) egli poi guarda il mondo stando perfettamente immobile, quasi senza respirare perché persino il più impercettibile dei movimenti disequilibrerebbe il meccanismo-quadro; d) non soltanto egli guarda il mondo stando immobile, ma lo osserva addirittura con un occhio solo (visione monoculare).
Nulla dunque di più dissimile dall’osservazione della realtà che ci circonda e che caratterizza la nostra esperienza visiva quotidiana. La prospettiva, questa tecnica messa a punto nel Rinascimento, consente al pittore di osservare la realtà nel modo in cui egli desidera e vuole, un modo che non è per nulla ‘realistico’, ma è anzi frutto di una raffinata costruzione intellettuale.
- Albrecht Dürer, Il velo dell’Alberti, 1538, dedicato alla visione monoculare e statica del pittore, dove è ben visibile il miraglio a forma di obelisco consigliato per rendere ancora più immobile la posizione dell’occhio che scruta la scena da dipingere.
Il saggio di Di Napoli prosegue ragionando sui confini dell’immagine pittorica, che sono costituiti dai limiti oggettivi della tavola, della tela o della parete su cui essa è dipinta e affronta il problema dell’inquadratura (l’origine etimologica di questo termine, tra l’altro, risale al XIX secolo e significa proprio ‘collocare nel quadro’) e disquisisce sul ruolo della parola nella pittura, ovvero sul titolo delle opere, la cui esigenza ha una nascita piuttosto recente, in quanto comincia ad essere ritenuto indispensabile solo a partire dalla seconda metà del secolo scorso, non escluso il paradosso dell’incongruenza fra titolo e immagine dipinta operato da René Magritte ne “L’uso della pipa”, o quello provocatorio dei ready made di Marcel Duchamp.
Proseguendo nella lettura del libro si incontrano poi sapienti disamine di particolari opere d’arte in cui lo sguardo erra (nel duplice senso di vagare e di sbagliare), come ad esempio quella dedicata alla tela di Velázquez del 1657 “Las hilanderaso Il mito di Aracne”. Qui l’autore lungamente si sofferma a proporre le molteplici possibilità di lettura dell’opera, in quella che lui stesso definisce “visione stratificata” offerta dal Maestro spagnolo che in questo, come in molti altri suoi quadri, “mette in scena un vertiginoso slittamento di piani interpretativi”.
Chi poi fosse convinto che le prime rappresentazioni pittoriche di oggetti in movimento siano ascrivibili al Futurismo, non ha fatto i conti con Keplero, con Descartes e con Velázquez, naturalmente. I primi studi del matematico e astronomo tedesco sui processi della visione oculare datano infatti al 1604 fornendo a Descartes preziosi elementi per perfezionare la propria ricerca in merito. Che Velázquez conoscesse o meno le teorie dei due scienziati poco importa, visto che ne ha comunque messo in pratica gli esiti. Lo scopriamonel guardare il dettaglio ingrandito delle “hilanderas”, in cui si vede chiaramente che la ruota dell’arcolaio sta girando.
“Eppur si muove”, verrebbe da esclamare; nonostante non si tratti del nostro pianeta, il curioso effetto visivo desta in noi una grande sorpresa, perché siamo perfettamente coscienti che si tratta di un’immagine bidimensionale e dunque giocoforza statica essendo solo una superficie dipinta.
- Diego Velázquez, Las hilanderas o il mito di Aracne, 1657, Madrid, Prado; a destra: dettaglio della ruota dell’arcolaio, ritratta in modo che ne suggerisca il movimento rotatorio.
Nel suo studio, Di Napoli sfata in seguito un altro mito: non spetta infatti ai Realisti francesi dell’Ottocento, Gustave Courbet in testa, poi emulati dai più famosi Impressionisti, il primato della pittura en plein air, esso tocca invece a Velázquez, che lo segnò ben due secoli prima (e con le oggettive difficoltà del non avere a disosizione il colore a tubetti- inventato solo nell’Ottocento - ma le scomode vesciche di bue in cui era prima contenuto e che ne rendevano arduo e rischioso, se non addirittura impossibile, il trasporto fuori dall’atelier).Questo primato di dipingere all’aria aperta “il pittore dei pittori”, come ebbe a definirlo Edouard Manet, lo segnò a Roma nelle due splendide tele il cui soggetto principale non è quello enunciato dal titolo, “L’entrata della grotta a Villa Medici” e “Il padiglione di Arianna nel giardino di Villa Medici”, bensì il vibrare della luce su pareti bianche incorniciate da una tremolante vegetazione che lascia dardeggiare tra le sue fronde i raggi del sole.
Non si tratta di semplici paesaggi, questi dipinti, che sono di una modernità sconcertante, costituiscono invece una vera e propria “lezione di pittura pura”. Si deve intendere per pittura pura la pittura in quanto tale, che esiste indipendentemente dalla scena che raffigura, una pittura che non è riproduzione-duplicazione del reale, ma viene a costituire una nuova realtà, narrata solo nella pittura medesima, che per il suo tramite si fa verità. Si pensi ad esempio al trompe l’oeil bramantesco in Santa Maria presso San Satiro, a Milano, un alto saggio di “pittura pura”, che, non imitando alcuna realtà ma creandone una nuova la reifica solo in virtù della materia e della forma con cui è dipinta. Essa è artificio ma è anche artefatto, arte factus, nel suo significato primario di fatto ad arte. O ancora si pensi ai quadri di Malevic’ e a tutta la Pittura Concreta cui essi hanno dato il là, che porta ad affermare che il vero contenuto figurativo della pittura risiede nell’atto stesso del dipingere.
È soprattutto lo sguardo del pittore,e dopo di essoquello dell’osservatore, a fare di un quadro (di una superficie coperta in fin dei conti soltanto di macchie colorate) un’opera d’arte. “I quadri li fanno coloro che li guardano” ha affermato Marcel Duchamp, e quindi dapprima il pittore e poi il suo pubblico.
È ancora un’opera di Velázquez, la sua più nota, “Las Meniñas”, a confermare questa verità. In essa il Maestro moltiplica gli spunti visivi, invitando così lo sguardo dell’osservatore a viaggiare al suo interno, declinando “punti di vista collocati in differenti ambiti spazio temporali: sguardi contigui ma cronologicamente distanti”. Anche qui il pittore spagnolo ci propone, come spesso accade nelle sue opere, immagini dentro l’immagine, “aporie percettive della stessa visione”, inducendocosì lo sguardo dell’osservatore a peregrinare all’interno del quadro, come farebbe se guardasse il mondo reale, sollecitato dalla sua multiformità e non come se stesse osservando una superficie, immobile per definizione, ricopertadi strati di colore. Come già ne“Las hilanderas”, non è soltanto la ruota dell’arcolaio a muoversi ma è soprattutto l’occhio dell’osservatore che si muove all’interno della scena, sollecitato dall’artista a “distinguere la veridicità della realtà che l’immagine riproduce dalla verità della pittura”.
Nel dipingere, tutti i pittori, Velázquez compreso, mettono poi in campo un “duplice sguardo”, che, per il solo effetto della visione, fa sì che quando si guarda il dipinto damolto vicino esso appaia tal quale è, ovvero una superficie ricoperta di materia colorata, fatta di rapidi tocchi di pennello, di macchie, di puntini, di tratti o di grumi, ma se visto da lontano svela dettagli precisi e minuziosamente definiti, come, ad esempio, il riverbero della luce su una superficie metallica, magari quella di un’armatura; la lucentezza della seta; la morbidezza di un velluto; la leggerezza di un tulle; lo scintillio dell’oro, o la foschia di un’ombra, etc. Questa peculiarità dell’opera dipinta induce anche l’osservatore ad esercitare la stessa duplicità di sguardo, avvicinandolo e allontanandolo dalla superficie dipinta, come se andasse alla ricerca della differenza che esiste tra la verità offerta da ciò che vede dipinto e la verità di ciò che vedein natura. “Perché il mistero della pittura non è là dove lo cerchiamo, ma nei nostri occhi che lo indagano”, ci conferma Di Napoli.
- Diego Velázquez, Las Meniñas, 1656, Madrid, Prado; a destra in alto: macchie di colore che,se osservate da lontano, danno origine alla visione dei colpi di luce sulla seta della manica della veste dell’infanta Margherita.Diego Velázquez, L’acquaiolo di Siviglia, 1620, Londra, Victoria and Albert Museum; a destra, dettaglio del bicchiere con striature e macchie bianche che simulano i colpi di luce.
Sono molte le pagine che l’autore dedica poi alla pittura di paesaggio e al tipo di sguardo di cui essa necessita per essere percepita non esclusivamente come realtà fenomenica dipinta ma anche, e forse soprattutto, come visione interiorizzata, come espressione di uno stato d’animo proiettato sul luogo riprodotto, sia da colui che lo dipinge, che da colui che lo guarda dipinto. Si tratta di pagine liriche e non soltanto perché alla poesia fanno diretto riferimento, soprattutto a Petrarca, la cui lettera, datata 1336, dove racconta la sua ascesa al Monte Ventoso, segna la data di nascita della visione/descrizione del paesaggio, ma per gli orizzonti, non solo metaforici, che ci dischiude portandoci per mano a scoprire la pittura di paesaggio cinese e la sua tradizione millenaria. Ci narra di quei paesaggi osservati da molto lontano e da un punto di vista molto elevato e riprodotti con l’assonometria cavaliera e non già con la prospettiva centrale piana diffusa in Occidente, costruiti quindi con linee parallele sovrapposte, che consentono all’osservatore di “percepire la lontananza come una dimensione psichica e spirituale piuttosto che come una condizione ottica”.
C’è un artista occidentale che costruisce i propri quadri facendo preferenzialmente ricorso a fasce cromatiche parallele tendenti all’infinito, quasi alla stregua della pittura orientale (pur senza conoscerla ma per una sorta di “consonanza percettiva e spirituale”), si tratta del pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich. Rinunciando alla costruzione prospettica, che obbligherebbe l’osservatore ad assumere l’unicità del punto di vista del pittore, egli lascia invece che l’occhio di questi sia libero di fluttuare all’interno del quadro inducendolo a ricercavi non soltanto ciò che vede davanti a sé bensì a mettere in moto anche il proprio sguardo interiore.
“Chiudi il tuo occhio fisico - con queste parole Friedrich esorta il pittore - così da vedere l’immagine principalmente con l’occhio dello spirito. Poi porta alla luce quanto hai visto nell’oscurità, affinché si rifletta sugli altri, dall’interno verso l’esterno.”
Tale invito alla bifocalità costituisce la cifra poetica di questo straordinario artista,che nelle sue opere inserisce assai di frequente figure di schiena (sul tema delle Figure di schiena nell’arte europea dal XIV al XVII secolo si legga anche il saggio di Luigi Grazioli). I personaggi guardanti di Friedrich (le Rückenfiguren, le figure viste da dietro), che guardano al di là (oltre) la scena dipinta, in cui essi stessi sono inseriti, suggerendo un altro punto di vista del tutto differente da quello dell’osservatore esterno, costituiscono l’espediente visivo messo in campo dal pittore per creare un collegamento tra ciò che ha dipinto e il riguardante, offrendogli la possibilità di ‘entrare’ metaforicamente nel quadro, assumendone non soltanto la profondità spaziale ma facendo propria anche quella spirituale da esso evocata.
Scrive Di Napoli: “La superficie della tela dipinta viene quindi vissuta come un’interfaccia tra interno ed esterno, tra l’infinito dello spazio esterno in continuità con l’infinito dello spazio interiore” a sottolineare la solitudine umana, comeaccade nel famosissimo quadro: “Monaco in riva al mare”. Lo sguardo delle figure di schiena di Friedrich, che guardano verso l’al di là del quadro costituisce una traslazione semantica dall’interno all’interiore, “dove lo sguardo interiore del soggetto vedente ha il suo corrispettivo figurato nello sguardo interno del quadro”.
- Caspar David Friedrich, Monaco in riva al mare, 1808, Berlino, Altenationalgalerie; Il viandante sul mare di nebbia, 1818, Amburgo, Kunsthalle.
Keplero ritorna nel saggio di Di Napoli, associato ad Apollonio di Perga e al suo famoso trattato sulle Coniche, a proposito della costruzione di molti paesaggi del pittore tedesco che si reggono su “una struttura compositiva basata sui due rami contrapposti della stessa iperbole, uno che delimita la forma del cielo, l’altro quella della terra”. Queste due realtà, contigue ma separate, alludono simbolicamente ai due ambiti della conoscenza umana: la terra, ovvero la prossimità, è riferibile alla conoscenza sensoriale; mentre il cielo, ovvero la lontananza, rimanda invece alle esperienze estetiche e mistiche e quindi a una conoscenza di tipo spirituale. Quest’impiego costruttivo dell’iperbole nei quadri di Friedrich risulta il modo più efficace per tradurre visivamente la sua poetica della “bifocalità”, ovvero della convivenza tra uno sguardo fisico ed uno sovrannaturale, facendo convivere nel luogo della sua pittura l’esperienza terrena con quella che la trascende.
- A sinistra: Caspar David Friedrich, La grande riserva, 1831-32, Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister. A destra: Tullio Pericoli, Senza cielo, 2008.
Un frammento di infinito è poi il titolo evocativo che l’autore assegna al paragrafo dedicato alle opere di Tullio Pericoli, unico artista vivente da lui citato nel libro. Lo definisce “pittore terrestre”, perché nei suoi paesaggi è la terra l’assoluta protagonista (il cielo vi è eliso); la terra che oggi l’artista marchigiano guarda dall’alto ma che fino a qualche tempo fa osservava dal sottosuolo, in quelle Geologie di cui descriveva le stratificazioni: “sezioni di rocce effusive, frammenti di faglia e movimento del magma vulcanico ”.
Lo sguardo dall’alto di Tullio Pericoli non fa che confermare che “il vero medium della visione è la distanza: si vede solo ciò che non è contiguo all’occhio”. Questo moderno maestro del paesaggio, nel suo disegnare crittogrammi che svelano le fenditure del suolo o ancora i dorsali collinari, oppure le trame cromatiche generate dal susseguirsi degli appezzamenti dei coltivi, coglie e ci mostra frammenti di infinito nel finito,e nel mentre induce emozioni in chi li guarda, rende omaggio alla bellezza, perché “L’arte del pittore è l’arte di vedere il bello” (Gaston Bachelard).
- Giovani Antonio Canal (il Canaletto), Il Canal Grande da Palazzo Balbi, 1728, collezione privata; Joseph Mallord William Turner, Braccio superiore del Canal Grande con san Simeone Piccolo al crepuscolo, 1840, Venezia, Museo Correr
Dopo aver messo a confronto i differenti procedimenti costruttivi di quadri che hanno come identico soggetto il Canal Grande di Venezia, opera rispettivamente del Canaletto (la cui visione ci sembra realistica ma che, in realtà, è scientemente e scientificamente composta in atelier) e da Turner (che ci appare vago nelle sue dissolvenze e sfocature ma che invece è prossimo al processo di visione umana), Di Napoli dedica pagine appassionate alla disamina dell’opera del pittore romantico inglese,così stimato da John Ruskin da aver elaborato su di lui una monumentale trattazione critica, cui ha atteso per diciassette anni.
[continuazione nel post successivo]
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA -- "Nell’occhio del pittore. La visione svelata dall’arte"(G. Di Napoli). Rec. di Maria L. Ghianda.11 agosto 2017, di Federico La Sala
"Nell’occhio del pittore. La visione svelata dall’arte"...
- [continuazione e conclusione]
Il saggio si conclude con un omaggio a Cézanne, che “più di ogni altro ha dipinto la visione del pittore: cosa ben diversa dal dipingere ciò che il pittore vede o ha visto.”
A proposito di Cézanne, vorrei segnalare uno dei più bei libri di storia dell’arte che io abbia mai letto, che ne traccia una trasversale, vista con gli occhi di un talent scout ante litteram, Ambroise Vollard, vero artefice della fortuna critica di molti artisti, soprattutto tra gli Impressionisti: “Ricordi di un mercante di quadri” (Einaudi, 1978)
Su Cézanne egli vi scrive pagine incredibilmente rivelatrici della sua indole misantropa e saturnina che ben si coniuga con la sua metodica (da alcuni definita ossessiva) ricerca formale. Un altro testo che, se pure in modo ‘particolare’ trovo illuminante per capire le difficoltà incontrate dall’artista di Aixnel fare comprendere e accettare il suo lavoro creativo soprattutto all’amico d’infanzia (poi, ahimè, nemico dopo la pubblicazione del libro) Emile Zola è L’Opera.
In questo romanzo Zola sembra cogliere, purtroppo senza capirle, le ricerche di Cézanne, trasponendole nella figura del protagonista, l’artista fallito Claude Lentier, nel quale Paul finisce per riconoscersi ponendo drasticamente fine al sodalizio intellettuale ed affettivo con Emile, nato sui banchi del liceo e durato una vita. Forse oggi potremmo dire che Cézanne non ha per nulla equivocato identificandosi in Lentiere nella sua tormentosa ricerca; ricerca che Zola non poteva capire ma che si conferma evidente anche leggendo le pagine di Di Napoli: “in questo periodo Cézanne perviene ad una sorta di astrattismo cromatico anticipatore delle tendenze del Blaue Reiter, che passano da Kandinskij e Klee e arrivano fino a Mondrian”.
Dunque Cézanne era troppo moderno per il suo tempo, persino per Zola che pure era stato capace di intuire la rivoluzione impressionista, datata e databile ad ogni buon conto all’Ottocento, secolo al quale egli appartiene appieno. Cézanne, invece, nella sua intrinseca classicità è un artista assolutamente fuori dal tempo, perché è moderno e antico all’unisono, uno dei più grandi che siano mai esistiti, la cui carica rivoluzionaria è paragonabile solo a quella di Giotto.
L’opera di Cézanne ha veramente una portata innovativa sconvolgente. Scrive Di Napoli: “il pittore non si accontenta di dipingere quello che il suo occhio vede o ha già visto, ma vuole dipingere quello che potrebbe vedere portando il suo occhio a concentrare l’attenzione su ciò che della natura può diventare pittura.”
Joachim Gasquet, scrittore, poeta e critico d’arte, ma soprattutto intimo amico di Cézanne ce ne tramanda le riflessioni e le confidenze nel libro a lui dedicato, uscito appena pochi mesi dopo la sua morte. Così diceva Cézanne:
 “Chiuda gli occhi, attenda, non pensi a niente. Li apra [...] che dice? Non si vede che un immenso ondeggiare colorato, no? Un’iridescenza, dei colori, una ricchezza di colori. Questo deve darci il quadro in primo luogo [...]un abisso dove l’occhio sprofonda, una sorda germinazione. Uno stato di grazia colorato. Tutti questi toni vi penetrano nel sangue, vero? Ci si sente rianimati. [...] si diventa se stessi, si diventa pittura.”
“Chiuda gli occhi, attenda, non pensi a niente. Li apra [...] che dice? Non si vede che un immenso ondeggiare colorato, no? Un’iridescenza, dei colori, una ricchezza di colori. Questo deve darci il quadro in primo luogo [...]un abisso dove l’occhio sprofonda, una sorda germinazione. Uno stato di grazia colorato. Tutti questi toni vi penetrano nel sangue, vero? Ci si sente rianimati. [...] si diventa se stessi, si diventa pittura.”- Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire vista da Lauves, (1902-1904), Basilea, Kunstmuseum, particolare.
“L’occhio per vedere e per comunicare con la visione dell’artista deve a sua volta comportarsi da visionario” (Georges Salles, “Le Regard”, Parigi 1939) ed è proprio quel che ci insegna a fare lo studio di Giuseppe Di Napoli.
* DOPPIOZERO, 11.08.2017 (RIPRESA PARZIALE SENZA IMMAGINI).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica
AL DI LA’ DEL NARCISISMO E DELLA FASCINAZIONE MORTALE DELLO SPECCHIO. A MILANO, LA GRANDE LEZIONE DI RENE’ MAGRITTE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA - "Note per una epistemologia genesica" - Leopardi. Frammenti di una cosmologia poetica (di Antonio Prete).10 agosto 2017, di Federico La Sala
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”....*
Nel giorno in cui cadono le stelle /
Leopardi. Frammenti di una cosmologia poetica
di Antonio Prete *
- “Una casa pensile in aria sospesa con funi a una stella”: un frammento dello Zibaldone (256, 1 ottobre 1820).
Un’immagine, un’apparizione: nel fitto meditare del giovane Leopardi lungo i margini di una biblioteca affollata di voci. Voci di antichi e di moderni, parole dell’epos e della filosofia, convivio di idee convocato dall’Encyclopédie e dai nuovi saperi. Una casa pensile, che è sospesa nell’ aria, ed è legata con delle funi a una stella. Un’immagine che pare il resto figurabile di un sogno che subito è disperso con la prima luce del giorno. O il ricordo fulmineo di un disegno infantile: la stella in alto, e giù la casa, priva di terreno, sospesa nel bianco della pagina, ma qualcosa deve legare la casa alla stella, ecco allora le funi che impediscono che la casa precipiti, e la fanno oscillare nel vento, casa di carta e stella di carta, casa dipinta e stella infiammata. Non ha rapporto con la terra la casa: è sollevata, come se fosse portata via da una forza - da una carrucola - che ha in una lontanissima stella il suo sostegno. Non è trasportata, la casa. Non è la casa di Nazareth che gli angeli portano in volo, come racconta una popolare credenza, per deporla a Loreto, proprio nei pressi di Recanati. Non è stata neppure sradicata dalle fondamenta, questa casa, è lì, sospesa in aria, sospesa nell’immaginazione: è la pura sospensione del terrestre, del domestico, del quotidiano. Non sappiamo se è abitata, la casa pensile, ora appare nella sua fisica figurazione di casa sospesa nel vuoto e tuttavia sostenuta da un principio, non più attratta dalla terra ma appartenente ai simulacri che abitano l’aria e che di solito non vediamo.
Ma l’immagine è anche una lampeggiante abbreviazione, o persino un compendio metaforico, del pensiero leopardiano, o forse un presagio inconsapevole - disegnato nella “camera oscura” dell’immaginazione - di come quel pensiero si svolgerà, del cammino che avrà lungo diverse stagioni, ma anche di alcune esperienze poetiche fino a quel momento vissute. Una figura dei modi conoscitivi e insieme poetici che saranno trama e respiro di un pensiero. Ecco la leggerezza, e con essa il senso della elevazione - annuncio della élévation baudelairiana -, cioè sguardo che dall’alto si volge verso il linguaggio del mondo, ascolta il silenzio delle cose, ma osserva anche l’intorpidimento dei sensi fatti opachi dall’“incivilimento”, atrofizzati dalla progressiva “spiritualizzazione delle cose umane e dell’uomo” in cui consiste la pretesa perfezione della civiltà (l’operetta Elogio degli uccelli opporrà a questa atrofia dei sensi umani la libertà vigorosa delle creature alate, la loro armonia, il movimento e la vista dall’alto).
Una stella: figura della presenza cosmografica che è tessitura assidua del pensare leopardiano, ed è sorgente di interrogazione costante sul rapporto tra finitudine e infinito, percezione della sospesa condizione umana in un universo che è nascita e morte, costruzione e distruzione incessante, orizzonte sconfinato nel quale il fiore e il deserto, il fiore del deserto, sono emblemi dell’esistenza, e la terra non è che un “granello” perso negli spazi infiniti. La stella è anche principio che sostiene ciò che è più familiare, una casa: è una lontananza assoluta, intransitabile, e tuttavia luminosa, che sostiene quel che ci si presenta come proprio, prossimo, domestico. E c’è un legame tra quel che è sovranamente altro e quel che invece appartiene alla terra, c’è un legame tra l’oltretempo proprio dell’elemento stellare e l’esperienza della propria condizione.
Questo legame, gli scorci - di teoresi e di immaginazione - su questo legame, fanno della poesia di Leopardi la lingua di un’interrogazione aperta, ogni volta, a scrutare l’esistenza, il suo ritmo, sullo sfondo metafisico di un altro ritmo, quello che fa pulsare il cosmo, la sua energia, il suo consumarsi e il suo divenire.
Le considerazioni cosmologiche del Cantico mattutino del gallo silvestre, la rappresentazione della fisica - origine e fine dell’universo - come prende forma nella prosa del Frammento apocrifo di Stratone, le domande sul senso e sul vuoto di senso che il pastore errante rivolge alla luna, ai suoi silenzi, al suo enigmatico sapere dell’universo, l’azzardo della poesia di voler dire l’infinito nella impossibilità di dirlo e, nel naufragio del pensiero, e della poesia stessa, il soccorso all’io dato da quel “m’è dolce” che è nel cuore dell’ultimo verso -prossimità corporea e sensibile nell’impossibile esperienza dell’assoluta lontananza -, tutto questo ha qualcosa che è come compendiato e messo in figura in questa frase isolata che interrompe i pensieri dello Zibaldone: “Una casa pensile in aria sospesa con funi a una stella”. Quasi iconica impresa da porre sul frontespizio del Liber di una vita, e di una incessante ricerca, che è lo Zibaldone. Ho detto interrompe i pensieri: non è proprio così, l’interruzione è già avvenuta con l’immagine che precede nella stessa pagina del 1 ottobre 1820 e che qui di seguito riporto come secondo momento di questo margine.
*
- “Si mise un paio di occhiali fatti della metà del meridiano co’ due cerchi polari” (Zibaldone, 1 ottobre 1820).
Il frammento narrativo può a questo punto essere letto anche come orizzonte fantastico nel quale appare la casa pensile. Con la nuova cosmografica data dai singolari e sconfinati occhiali si può vedere anche la casa pensile, tra le innumerevoli altre presenze che trascorrono nel cielo, che abitano il cielo. Ma può anche darsi che le due proposizioni fantastiche abbiano tra di loro solo il legame invisibile, indescrivibile, dell’immaginazione, un legame insondabile, subito nascosto, per lasciare scoperto solo l’altro fisico legame, quello dell’appartenenza alla stessa pagina dello smisurato manoscritto che è lo Zibaldone. Una prossimità che ha solo la scansione di uno spazio tra un frammento e l’altro. E tuttavia, se la casa pensile si accampa nell’aria come un’apparizione - infatti ha dell’apparire l’elemento dell’inatteso e dell’inspiegabile - il paio di occhiali appartiene a un tempo narrativo, suppone infatti un personaggio, il cui volto e la cui identità - umana, sovrumana, animale, celeste, terrestre? - non è rivelata, è lasciata per dir così alla discrezione e all’energia dell’immaginazione di colui che legge, ma anche dello stesso che scrive, il quale non vuole configurare il personaggio, tanto meno nominarlo. Ma il lettore è autorizzato a chiedersi: chi può essere colui che “si mise” lo stravagante paio di occhiali?
Certo, l’immensità dello strumento non può che far pensare a un personaggio immenso, o a un corpo celeste trasformato in figura gigantesca dalle fattezza umane - con occhi e mani, dunque - che compie il gesto di sollevare gli occhiali per porgerli a cavallo dell’incavo nasale o persino appoggia le stanghette sterminate (ma invisibili e innominate) nell’attaccatura delle orecchie. E quel passato remoto - “si mise” - a quale tempo si riferisce? Forse a un tempo senza tempo, un’era in cui la terra, non ancora abitata da animali e da uomini, ha già preso la sua forma e gravita nella sua orbita priva di presenze che non siano angeliche, ed è appunto una di queste presenze - emanazioni della divinità, declinazioni e manifestazioni dei suoi poteri - che fa dei due poli due cerchi tenuti insieme dalla metà di un meridiano (un meridiano celeste?) e guarda attraverso di essi l’opera della creazione, guarda i mondi che roteano seguendo le loro ellissi, oltre la via lattea, fino ad altre galassie in fuga nello spazio infinito. Per raccontare questo gesto non c’è che da ricorrere a un’immagine antropomorfica e a un gesto usuale per scorgere meglio i corpi celesti: guardare attraverso delle lenti speciali. Una sorta di cannocchiale che ha un’altra forma, una forma in cui le lenti - anche queste innominate e invisibili - hanno un potere ben superiore a quello delle lenti che Galileo mise nel suo formidabile strumento, raddoppiando e rovesciando le lenti usate dagli olandesi.
Oppure, semplicemente, questi occhiali sono solo una raffigurazione di quegli altri occhiali che ciascuno di noi possiede nel bagaglio delle sue facoltà, gli occhiali dell’immaginazione, quelli di cui Leopardi disporrà ogni volta che si volgerà a scorgere gli oggetti lontani - quella torre, quella campagna - con l’altra vista. Ecco, gli occhiali “fatti della metà del meridiano co’ due cerchi polari” sono lo strumento - l’interiore disposizione - che permette l’altra vista. E colui che se li mise, e continua a metterli, è proprio l’autore. O il lettore. E insomma quanti, dal limite corporeo e sensibile del loro terrestre stato, sentono la necessità di scrutare con un nuovo sguardo il mondo che è di là dall’orizzonte visibile, l’universo di stelle che nascono e deflagrano, di comete in fuga, di nebulose e galassie che corrono e si dilatano in uno spazio che non ha confini, in un tempo che non ha tempo. Perché scorgere il nesso tra il visibile e l’invisibile, tra il qui e l’altrove, tra il limite e lo sconfinato può essere la sfida estrema dei sensi, e della poesia.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
KANT, NEWTON, E POPE. Note (di avvio) per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. -- Nell’era senza confini rimane una sola patria che si chiama Terra (di Mauro Bonazzi).18 luglio 2017, di Federico La Sala
Nell’era senza confini rimane una sola patria che si chiama Terra -
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 16.07.2017)
L’acqua di Talete, il fuoco di Eraclito; l’aria e la terra: gli elementi da cui tutto proviene, per i presocratici; teorie ingenue per noi moderni, impegnati nel compito quasi impossibile di capire la meccanica quantistica. Ma non del tutto inutili, forse, se non nel campo della scienza almeno in quello della politica. L’ambizione di quei primi filosofi era quella d’individuare princìpi capaci di fare ordine nella trama dell’universo, di mostrare l’unità che si nasconde dietro alla molteplicità caotica degli eventi. Vale per la realtà fisica, e vale per il mondo degli uomini, che non è certo meno complesso.
Carl Schmitt, quasi un allievo tardivo dei presocratici, aveva avuto l’intuizione che si potessero spiegare le vicende umane proprio partendo dalla coppia terra/ acqua. Dalla terra, in cui gli uomini hanno mosso i primi passi, all’acqua: le grandi esplorazioni che inaugurano la modernità, la conquista degli oceani e del Nuovo Mondo - spazi liberamente contendibili, illimitatamente sfruttabili - aprono prospettive inedite nelle relazioni umane. Delineano un nuovo modello politico, rappresentato dall’impero britannico, in cui il controllo delle vie di comunicazione è di gran lunga più importante dell’inviolabilità dei confini. «Chi governa il mare, governa il commercio, chi governa il commercio dispone della ricchezza del mondo, e di conseguenza governa il mondo stesso». Così parlava Walter Raleigh, corsaro inglese al servizio della regina Elisabetta I.
Ma questa coppia ormai non basta più, spiega Matteo Vegetti nel saggio L’invenzione del globo, appena pubblicato da Einaudi. Sigmund Freud se ne accorse il 25 luglio 1909. L’aviatore Louis Blériot aveva appena compiuto la traversata della Manica, da Calais a Dover, e in Europa si festeggiava, pregustando la nascita di un nuovo mondo in cui tutti avrebbero comunicato con tutti, senza più barriere. Più lucidamente, Freud notò che da quel momento a essere senza confini sarebbe stata la guerra, non la pace.
Un’osservazione di cui gli americani avrebbero compreso la verità il 7 dicembre 1941, mentre l’aviazione giapponese distruggeva la loro flotta a Pearl Harbor. Ad affondare non erano state solo le navi, ma un modo secolare di rappresentarsi il mondo. Anche per questo, mentre allestiva una forza aerea imbattibile, il presidente Franklin Roosevelt invitò tutti i suoi connazionali a dotarsi di un mappamondo, possibilmente il modello che ruotava in tutte le direzioni («Questa guerra è un nuovo tipo di guerra», avrebbe spiegato. «È differente da ogni guerra del passato non solo nei suoi metodi e mezzi, ma anche nella sua geografia»).
C’è uno spazio uniforme sopra alla terra e al mare: lo spazio aereo, trasparente e vuoto, privo di ostacoli, facile da attraversare, che si espande ovunque. Non si trattava solo del volo degli aerei; altrettanto importanti sarebbero state le onde radio e le trasmissioni elettroniche, che avrebbero contratto le distanze ancora di più, fino ad annullarle quasi del tutto. Non era più il tempo di Walter Raleigh, ma di un generale italiano tanto oscuro quanto geniale, Giulio Douhet, autore (nel 1921!) di un libro intitolato Il dominio dell’aria: a controllare il mondo sarebbe stato chi avrebbe controllato i cieli. Il secolo dell’America e dell’ American way of life è il secolo dell’aria.
Studioso appassionato delle tradizioni arcane, Carl Schmitt aveva anche trovato un riferimento biblico-talmudico per rappresentare il nuovo stato di cose. Il regno del Leviatano (il mostro marino che in Thomas Hobbes esprime la potenza dello Stato) è ormai alla mercé di Ziz, un uccello gigantesco, capace di spostarsi continuamente da un posto all’altro della Terra. Un simbolo quanto mai appropriato per descrivere un mondo in cui i confini nazionali non funzionano più, perché quello che importa non sono le sostanze, ma i flussi. A essersi globalizzato è stato il borghese (e dunque l’economia), per così dire, non il cittadino. Questa rivoluzione spaziale non è certo la panacea di tutti i mali, come qualcuno (tra cui Karl Marx) ha creduto. Ma è un fatto da cui non si può prescindere: non sarà qualche muro a riportarci al bel (?) mondo che fu, né possiamo continuare a credere che basti riprodurre su scala mondiale la forma dello Stato nazione per superare tutte le difficoltà. Servono nuove idee politiche per organizzare questo spazio e le sue tensioni.
Perché poi c’è anche il fuoco, o meglio l’etere, un fuoco finissimo di cui erano composti, per Aristotele, le stelle e pianeti che ruotavano intorno alla terra, irraggiungibili. Quando Jurij Gagarin volò nello spazio e Neil Armstrong camminò sulla Luna, anche quest’ultima frontiera fu sfondata. È così conosciuta che quasi non ci si presta più attenzione: ma la prima foto scattata da un satellite lunare, tre anni prima dell’allunaggio, immortala il compimento della globalizzazione. Finalmente l’occhio umano vedeva la Terra come un globo, un tutto finito, senza più punti vuoti e senza più centro, di cui disponiamo completamente. Il Sole è grande come un piede umano, diceva Eraclito irridendo i sapienti del suo tempo: vista dallo spazio, ora è la Terra ad apparire sempre più piccola, in un universo che si scopre immenso.
«Per un’ora un uomo visse al di fuori di ogni orizzonte, intorno a lui tutto era cielo o, più precisamente, tutto era spazio geometrico»: così Emmanuel Levinas commentava i viaggi dei primi astronauti. Ma davvero siamo entrati nell’era della «demondizzazione», dello sradicamento definitivo dalla Terra, come annunciava, profetico e cupo, Martin Heidegger, guardando la solita foto della Terra presa dallo spazio? Certo, l’impulso di Ulisse a spingersi oltre, staccandosi dalla «cara patria», protesi verso nuove mete, è inestinguibile negli uomini. Ma in realtà mai come oggi, proprio perché la vediamo da distanze crescenti, possiamo apprezzare la bellezza e l’unicità irripetibile della nostra casa. Ed è sempre quella stessa foto a spiegare perché. Questo minuscolo pianeta perso in un universo infinito e indifferente è come un’oasi, in fondo: un piccolo miracolo, il pianeta blu, in un deserto spaventosamente immenso e silenzioso. Solo chi è partito può provare il piacere ambiguo della nostalgia. Dal fuoco e dall’etere torniamo alla Terra: e il problema, ora, è quello di coltivare questa piccola oasi, prima che diventi anch’essa un deserto inospitale.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA -- COSÌ VA IL MONDO: NOAH CHOMSKY, KANT, E LA CREATIVITÀ.8 giugno 2017, di Federico La Sala
COSÌ VA IL MONDO: NOAH CHOMSKY, KANT, E LA CREATIVITÀ.
Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico (e un omaggio a G.B. Zorzoli): *
- Non è facile portare a sintesi il pensiero politico di Noam Chomsky [...] "Così va il mondo" è composto da ben settantaquattro interviste, raggruppate in modo spesso arbitrario [...] Tutti temi di grande spessore, ridotti in pillole [...] Insomma, brevi cenni sull’universo [...] Nei vecchi libri dell’editore Bompiani era inserito un foglietto con un breve messaggio: non prestare questo libro: se ti è piaciuto, fai un torto all’editore; se non ti è piaciuto, lo fai a chi l’hai dato. "Così va il mondo" non lo presterò a nessuno. Anche perché il torto maggiore lo farei al pensiero di Chomsky (G. B. ZORZOLI)
[...] Kant è il punto di svolta: le condizioni di possibilità della conoscenza non vengono “più ricercate in qualcosa di preesistente, in un modello ontologico ideale, o in un luogo di modelli ideali, che - soli - consentono di parlare del mondo reale come appare e come è conosciuto”. Ciò che ancora non abbiamo capito è che Kant va alla radice e ci porta fuori del vecchio programma centrato sul “come conosciamo”: il suo problema - come è possibile la conoscenza scientifica (e non)? - è la risposta più radicale, e più adeguata, all’altezza della nuova Terra e del nuovo Cielo, scoperti dalla nuova fisica, e alla navigazione dell’umanità nell’“oceano celeste” (Keplero a Galilei, 1611).
[...] Compresa con Chomsky tutta l’importanza della distinzione tra la creatività sotto un codice dato (la “rule-governed creativity”) e la creatività “nel senso pieno del termine” (la “rule-changing creativity”), si rende - sulla spinta dei contributi di Antonucci e De Mauro - di quanto e di come sia necessario portare il problema oltre la chomskiana “struttura profonda”, “in quanto struttura già linguistica”, in una struttura intesa “non più come qualcosa di linguisticamente omogeno, quanto piuttosto come un dispositivo eterogeneo, linguistico e non-linguistico, per esempio anche intellettuale e psicologico”, e così scrive e precisa: “In altre parole, si tratta non di una presa di posizione antichomskiana, o più in generale antigenerativa, ma di un suo approfondimento ulteriore, che tende a portare al di là del linguaggio. (Si intende al di là del linguaggio, non nell’aldilà della speculazione)”. E a questo punto, con il conforto e e la spinta del contributo di Hogrebe, la via a e di Kant è riaperta e ripresa! Non è che l’inizio: Kant è ancora tutto da rileggere, a partire dalla “Storia universale della natura e teoria del cielo” e dai “Sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica”.
* SI CFR.: "CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico".
Federico La Sala
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA - Superare il concetto secondo cui la Terra sarebbe la culla dell’umanità; in questo momento ne è anche la gabbia e a nessuno piace vivere in cattività (Luca Parmitano - "Wired").21 maggio 2017, di Federico La Sala
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
- MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA ( - e ROCCO PETRONE). Un ’ricordo’
- 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!!
- "voglio superare il concetto secondo cui la Terra sarebbe la culla dell’umanità; in questo momento ne è anche la gabbia e a nessuno piace vivere in cattività" (Luca Parmitano).
INTERVISTA *
Luca Parmitano, astronauta: “Il futuro Cristoforo Colombo lo stiamo già addestrando”
Secondo il primo astronauta italiano protagonista di una passeggiata spaziale, nel futuro non sarebbero da escludere cosmonauti mutanti. E no, non è fantascienza
Di una cosa Luca Parmitano sembra davvero orgoglioso. Ma è difficile scovarla. E non perché l’astronauta catanese, protagonista della prima missione di lunga durata dell’Agenzia spaziale italiana, non vada fiero di quello che fa, anzi. È che complici il suo contegno militare - è Maggiore Tenente Colonnello pilota dell’Aeronautica - e soprattutto il suo carattere. Mai, nei suoi occhi o nelle sue parole, traspare l’ombra del vanto.
Per Parmitano il successo è sempre della squadra. Ogni traguardo, foss’anche Marte, diventa raggiungibile solo grazie alla collaborazione.
E questo, nonostante di risultati personali potrebbe sfoggiarne un elenco: come collaudatore ha accumulato 2mila ore di volo su oltre 40 tipi di velivoli; nel 2005 è stato decorato con la medaglia d’argento al valore per aver portato a terra il suo Amx dopo che l’impatto con una cicogna l’aveva compromesso. Selezionato dall’Agenzia spaziale europea nel 2009 è diventato il sesto astronauta italiano, il quarto ad abitare la Stazione spaziale internazionale (nel 2013, per 166 giorni) e il primo ad averci passeggiato attorno, in due attività extraveicolari, o Eva, portate a termine nonostante una grave avaria della tuta nella seconda occasione.
Nel 2014 è stato comandante della spedizione Caves, con cui l’Esa prepara gli astronauti alle missioni spaziali facendo loro trascorrere sette giorni sottoterra nella diaclasi Sa Grutta, vicino Olbia.
L’anno successivo ha partecipato, sempre come comandante, alla spedizione della Nasa, Neemo20, due settimane vissute dentro Aquarius, una stazione 19 metri sotto la superficie marina al largo della Florida.
Eppure, si diceva, è di un’altra cosa che Luca Parmitano sembra orgoglioso: è il primo europeo a fare da regista a due Eva. Il che significa comunicare direttamente con gli astronauti fuori dalla Iss per guidarli nelle procedure.
Perché, dice lui, “la conquista spaziale non è un’impresa di qualche eroe solitario. E al futuro ci si prepara insieme“.
A proposito, in che modo Neemo e Caves c’entrano con il nostro futuro nello Spazio?
“Entrambe rimandano alla componente esplorativa dei viaggi spaziali, le sono complementari. Consistono in un addestramento in condizioni estreme, come quelle che affronteremo nei prossimi lanci.
“Sottacqua abbiamo un habitat che, per molti aspetti, è come quello di un’astronave sommersa: non solo consente di simulare gravità diverse, implica anche la componente scientifica di ogni missione, con gli esperimenti nel laboratorio, e quella esplorativa grazie alle uscite nello scafandro.
“Che cosa c’entra l’esperienza sottomarina con quella cosmica? Tutto. Lo scafandro è immerso in un ambiente alieno, che consente di testare ingegneria e design degli strumenti che utilizzeremo.
“In Caves ci sono altre componenti: spostarsi dentro grotte sotterranee implica affrontare posti inesplorati e inadatti al nostro soggiorno. Senza supporto, isolati, dove tutto quello che ti serve te lo devi portare appresso. È un contesto in cui sperimentare la dimensione fisica e logistica delle missioni spaziali.
“In sintesi, Neemo e Caves insegnano come addestrare gli astronauti nel futuro. Non è un caso se a breve continuerò la preparazione a Lanzarote, nelle Canarie; quelle zone sono come un pezzo di suolo marziano sulla Terra”.
È plausibile che in tempi brevi colonizzeremo il Pianeta Rosso?
“Al momento prevediamo di raggiungerlo negli anni Trenta [a fine marzo la Nasa ha pubblicato il suo piano in 5 fasi per arrivarci nel 2033, ndr]. Ma meglio non parlare di tempi brevi quando c’è il cosmo di mezzo”.
È pessimista?
“Tutt’altro, ci arriveremo. Mi riferivo al dopo: voglio superare il concetto secondo cui la Terra sarebbe la culla dell’umanità; in questo momento ne è anche la gabbia e a nessuno piace vivere in cattività. A parte la curiosità innata, è per una questione di sopravvivenza ed espansione nel tempo. In questo senso non abbiamo fatto che un primo passo: siamo in orbita in modo continuativo.
“Ce ne sarà presto un secondo, costituito da una probabile permanenza nel sistema Terra-Luna. Questo almeno vorrebbe l’Esa, creare un ambiente adatto alla colonizzazione e allo sfruttamento locale delle risorse. Quindi procedere verso Marte. Il che imporrà si riesca ad affrontare un viaggio interplanetario.
“Non mi azzardo a parlare di terraforming, di trasformazione a nostro uso e consumo di un ambiente extraterrestre. Siamo ancora lontani da questa eventualità, ma molto prossimi a vedere da vicino com’è l’ambiente marziano”.
Poi?
“Poi la prospettiva andrebbe estesa: oggi siamo in grado di confermare la presenza di pianeti abitabili intorno a quasi tutte le stelle, miliardi di mondi in cui la vita è possibile, in cui c’è acqua, con un’atmosfera simile alla nostra. E allora credo sia il caso di pensare al futuro.
“Ecco perché il concetto di tempi brevi, se non altro inteso come un periodo compreso nell’arco della vita umana, andrebbe rivisto.
“I passaggi per effettuare un viaggio interstellare sono esponenzialmente più complessi del volo interplanetario, ma come ricordava Lao Tzu anche il cammino più lungo inizia con un passo.
“Tanto che c’è già chi parla di come inviare un microchip oltre il nostro sistema solare, lambendo frazioni decimali della velocità della luce. Come non intravedere la possibilità di arrivare prima o poi a un’astronave, ovviamente attraverso tutte le tappe intermedie, dai robot ai lander fino all’uomo?”.
L’attività sulla Stazione spaziale rientra in questa progressione?
“Come non potrebbe? Si pensi al Beam, anagramma di Bigelow Expandable Activity Module, installato sulla Stazione nell’aprile del 2016. È un modulo gonfiabile, un esperimento per verificare la resistenza fuori dall’atmosfera terrestre di un ambiente espandibile composto da vari strati, fra cui uno in Vectran, un materiale due volte più resistente del Kevlar.
“È fondamentale comprenderne l’importanza se parliamo del nostro futuro nel cosmo, visto che sarà molto difficile affrontare un viaggio interplanetario con un veicolo di grandi dimensioni.
“L’idea è allora di lanciare masse ridotte per poi espanderle, costruire in volo l’astronave di 2001: Odissea nello spazio con moduli gonfiabili in progressione”.
Adesso mi sembra troppo fiducioso. Eppure visse in prima persona gli imprevisti dello Spazio. Come affrontò l’incidente durante la sua seconda passeggiata fuori dall’Iss? E come lo concilia con il suo entusiasmo attuale?
“Ricordando che nello Spazio non c’è posto per gli individualismi. Se non capissimo noi per primi l’importanza inestimabile del lavoro di squadra, a terra e a bordo, commetteremmo un errore grave. Di quelli che possono costare cari”.
Che cosa intende?
“Il 16 luglio 2013, poco dopo l’inizio della mia seconda attività extraveicolare, l’Eva 23, per un malfunzionamento il mio casco ha cominciato a riempirsi d’acqua. In tutto l’emergenza è durata 35 minuti e per circa 8 l’avaria è stata grave, tanto da costringermi al rientro: in quel frangente ho perso ogni contatto radio oltre che sensoriale. Avevo acqua negli auricolari, nel naso, mi aveva coperto gli occhi. Faticavo a respirare, non potevo sentire né parlare, perché i sistemi di comunicazione, microfoni compresi, si erano bagnati.
“In più, una volta nell’airlock della Stazione, ho dovuto sopportare per 15 minuti la pressurizzazione con il sistema di Valsalva compromesso. È un apparato di compensazione che permette, tappando il naso, di pressurizzare le orecchie, ma essendo spugnoso e zuppo d’acqua si era strappato. Non una bella sensazione: è come scendere di colpo da 3mila metri al livello del mare senza contrastare la spinta sui timpani. Un dolore lancinante cui non ci si può opporre.
“Bene, non voglio sminuire le difficoltà di una situazione critica, fingerei. Sono momenti in cui la tua vita è a rischio. Quello che voglio ridimensionare è il merito dell’individuo.
“Oltre agli astronauti, un’Eva coinvolge numerosi collaboratori a Terra, persone che hanno scelto e curato l’addestramento, selezionato gli strumenti e concordato le procedure. Questo insieme è quello che ti permette di avere il battito cardiaco invariabile durante un’avaria, quello che ti concede l’opportunità di pensare...
“Quel 16 luglio, fuori dall’Iss e con un litro e mezzo di acqua nel casco, non ero solo: portavo con me un bagaglio di esperienze costruitomi, per mesi, da una squadra“.
Sta dicendo di non aver avuto paura?
“Certamente ne ho avuta. Ma la differenza tra una persona senza addestramento e chi è preparato consiste nella gestione dello stress. Fino a un certo livello ha effetti fisiologici positivi: il cuore pompa più forte per preparare i muscoli, l’aumento di adrenalina nel sangue stimola la reattività del cervello, la velocità di ragionamento cresce. È fondamentale imparare a utilizzare queste risposte come uno strumento e non permettere siano loro a controllarci. Proprio a questo obbiettivo punta l’addestramento”.
Qual è il problema maggiore nell’evoluzione dei viaggi spaziali?
“L’essere umano”.
Cioè?
“I nostri limiti fisiologici”.
Si riferisce, per esempio, all’esposizione alle radiazioni cosmiche durante viaggi lunghi?
“Focalizzarsi su un problema non serve. Se non ha soluzione, è un dato: saremo di certo esposti alle radiazioni. Possiamo solo aggirare l’ostacolo”.
Come?
“Tralasciamo per un momento le implicazioni etiche e chiediamoci se sia possibile stimolare un’evoluzione mirata. Sappiamo che il dna umano contiene geni di cui non si conoscono ancora proprietà o funzioni. Per esempio, condividiamo quella parte di corredo cromosomico che permette all’orso bruno di andare in letargo. È possibile attivare quel gene in modo da mandare anche l’uomo in ibernazione?
“In questa condizione il metabolismo rallenta fino quasi ad arrestarsi ed è bene ricordare che le radiazioni hanno effetto sugli esseri umani solo durante meiosi o mitosi, vale a dire quando le cellule si duplicano. Se quindi, durante un viaggio interplanetario, si è in ibernazione, il rischio che si verifichi una mutazione cellulare può essere ridotto di molto”.
Astronauti in letargo?
“Esatto. A questo punto la questione si sposta in ambito eto-biologico: è lecito intervenire sul dna degli esseri umani? O, di contro, fino a che punto è sensato escludere un’evoluzione mirata per una parte di umanità, che possa destinarla all’esplorazione del cosmo e farne il nostro prossimo gradino evolutivo: i viaggiatori interstellari.
“Ricordiamoci che l’etica è flessibile e che trattandosi di evoluzione le questioni da soppesare sono più grandi del singolo individuo.
“Detto altrimenti, se mi trovassi fra mille anni a osservare una parte evoluta della razza umana, capace di andare in letargo, quadrumane e con coda prensile - caratteristiche perfette per l’habitat spaziale -, perché dovrei pensare che è un male?“.
Insiste tanto sulla dimensione esplorativa dei viaggi spaziali.
“Perché è la sintesi di scienza e tecnologia, è l’ampliamento delle nostre conoscenze. Ripercorrendo i tempi, è bene ricordare che siamo andati sulla Luna negli anni ’60. Quel decennio costituì una breve parentesi di stimoli straordinari, capaci di spingere l’uomo a fare cose incredibili. Ma pensiamoci, che cosa abbiamo fatto? Siamo stati come i vichinghi che hanno attraversato la Danimarca, l’Oceano Atlantico, il Circolo polare artico. E arrivati in un nuovo Continente, sono tornati indietro. Un passaggio epocale, un salto nell’ignoto senza precedenti, ma anche un evento a sé stante.
“Poi, per quanto nessun vichingo si sia più avventurato attraverso l’Atlantico, nel Mediterraneo le grandi repubbliche marinare hanno sviluppato enormemente la tecnologia delle proprie imbarcazioni, migliorandone la capacità di navigazione, stoccaggio e anche la strumentazione di bordo. Ecco perché, secoli dopo, si è arrivati in America.
“Cristoforo Colombo ha contrassegnato un altro passaggio, proprio come faremo noi nei prossimi anni con la Luna e Marte. Ecco, probabilmente saremo un po’ come Colombo, nel senso che non riusciremo a rimanere per lungo tempo dove andremo. Non subito, almeno.
“Il vero salto evolutivo sarà quando, come con il Mayflower, diventeremo coloni. E per farlo, avremo bisogno di un balzo non solo tecnologico, ma anche sociale. Chi diventa colone? Quelli che in inglese sono chiamati misfits”.
Reietti?
“Piuttosto persone che non tollerano l’essere costretti in un ambiente. Uomini che hanno un bisogno quasi fisico delle difficoltà, che sono addirittura attratti dalla scomodità.
“Oggi molti vorrebbero rendere il volo spaziale più simile a quello terrestre. Si tende a un ambiente ergonomico, confortevole. Ma quelli che diventeranno i nostri coloni lunari o marziani cercheranno tutt’altro: si imbarcheranno perché hanno bisogno del Far West, di orizzonti aspri, di esperienze ruvide, di una bellezza che non è quella del design raffinato. Ma molto, molto più spartana”.
Ce la faremo a vederli?
“Una parte: forse non vedremo salpare il Mayflower, ma Cristoforo Colombo sì. Lo stiamo già addestrando“.
* WIRED, 19.05.2017 (Ripresa parziale - senza immagini).
-
>LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- "Wir sind ein-Stein!": Mileva Mariç e il patto osceno con l’ex marito Albert Einstein21 maggio 2017, di Federico La Sala
LA MENTE ACCOGLIENTE. TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA...
- Einstein era una-roccia, ma non restò di sasso. Fattosi coraggio, fece un passo avanti e saltò a cavallo di un raggio di luce. (Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991, p. 200).
- Siamo una sola pietra, afferma Mileva, giocando sul cognome ora anche suo: Wir sind ein-Stein!, per questo non mi importa che ci sia solo il suo nome nelle pubblicazioni (che cominciano a attirare l’attenzione del mondo scientifico), siamo noi, siamo “gli Einstein” [...] Era lui che aveva detto che “è più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio” (Maria Tilde Bettetini, "Mileva Mariç, genio della matematica. E il patto osceno con l’ex marito Albert Einstein", "Corriere della Sera/La 27 Ora", 17.05.2017).
PERFETTE SCONOSCIUTE
Mileva Mariç, genio della matematica
E il patto osceno con l’ex marito Albert Einstein
di Maria Tilde Bettetini *
Non ci sono certezze, è inutile accanirsi. Però è davvero improbabile che sarebbe andato avanti negli studi, riuscendo con tanto successo senza di lei, Mileva Mariç. Stiamo parlando di Albert Einstein, un nome che nel parlare comune ha preso il significato di “genio”, “sono l’Einstein delle parole crociate”. Il premio Nobel per la fisica del 1921, si sa, aveva problemi con la matematica, non è una novità che le due materie presuppongano lo sviluppo di modalità differenti dell’intelligenza, ora più immediate e intuitive, ora più immaginifiche. E si sa che questi problemi non si sono risolti semplicemente col passare del tempo, come è sottinteso quando si incoraggia un bambino a scuola, anche Einstein da piccolo non era bravo in matematica!
Che ruolo abbia avuto dunque la sua amica, poi amante, poi prima moglie, genio precoce della matematica, non è difficile immaginare, anche se nessuno ne fa parola. Lo fa il romanzo in questi giorni in libreria di Marie Benedict, La donna di Einstein (Piemme), che racconta le due vite prima legate e poi parallele di Albert e Mitza, o Mileva, o Milena.
 Si erano conosciuti a Zurigo, entrambi studenti al Politecnico, se pur con bagaglio assai diverso: Albert è tedesco, la famiglia in Italia, ha ripetuto due volte l’esame di ammissione; Mileva è serba, ha girato col padre militare il suo paese e l’Austria-Ungheria, parla tre lingue, ha fatto la maturità a Berna. Li accomunano caratteri ombrosi, solitari; la passione per le scienze; una notevole bruttezza fisica, in lei accentuata da zoppia congenita. Mileva è la quinta donna in assoluto a riuscire a entrare al Politecnico di Zurigo, l’unica del suo anno a matematica e fisica. Agli esami finali Albert passa per un pelo (e infatti non riceve alcuna proposta di lavoro, a differenza dei colleghi), Mileva è bocciata due volte.
Si erano conosciuti a Zurigo, entrambi studenti al Politecnico, se pur con bagaglio assai diverso: Albert è tedesco, la famiglia in Italia, ha ripetuto due volte l’esame di ammissione; Mileva è serba, ha girato col padre militare il suo paese e l’Austria-Ungheria, parla tre lingue, ha fatto la maturità a Berna. Li accomunano caratteri ombrosi, solitari; la passione per le scienze; una notevole bruttezza fisica, in lei accentuata da zoppia congenita. Mileva è la quinta donna in assoluto a riuscire a entrare al Politecnico di Zurigo, l’unica del suo anno a matematica e fisica. Agli esami finali Albert passa per un pelo (e infatti non riceve alcuna proposta di lavoro, a differenza dei colleghi), Mileva è bocciata due volte.La seconda, forse non l’agevola essere evidentemente incinta. La famiglia Einstein non approva: “Quella zoppa ti rovinerà la vita, non vedi che è già vecchia?”, scrive la mamma tedesca, riferendosi ai quattro anni di differenza. Mileva partorisce Lieserl a fine gennaio 1902, a casa. Né il padre né altri vedranno la bambina, forse morta di scarlattina, forse data in adozione, ma nel frattempo Albert proprio a Berna trova lavoro, lì il 6 gennaio 1903 si sposano. Tra le mille incertezze, questo è certo, perché Mileva ha sempre conservato con cura i documenti del matrimonio.
 Dalle loro lettere, pubblicate in italiano nel 1993 (Bollati Boringhieri), apprendiamo che lui si sente capito da lei come da nessun altro, che sarà felice e orgoglioso di portare a una conclusione certa “il nostro lavoro sul movimento relativo”. Ancora non ha affermato, come farà poi, che “non avrebbe mai consentito a una sua figlia di studiare fisica”.
Dalle loro lettere, pubblicate in italiano nel 1993 (Bollati Boringhieri), apprendiamo che lui si sente capito da lei come da nessun altro, che sarà felice e orgoglioso di portare a una conclusione certa “il nostro lavoro sul movimento relativo”. Ancora non ha affermato, come farà poi, che “non avrebbe mai consentito a una sua figlia di studiare fisica”.Mileva a tale lavoro dedica la sera e spesso la notte, dopo aver sbrigato le faccende domestiche e aver messo a dormire i due bambini nati nel frattempo. Siamo una sola pietra, afferma Mileva, giocando sul cognome ora anche suo: Wir sind ein-Stein!, per questo non mi importa che ci sia solo il suo nome nelle pubblicazioni (che cominciano a attirare l’attenzione del mondo scientifico), siamo noi, siamo “gli Einstein”.
 Ma nel volgere di pochi anni, il tempo le avrebbe dato torto. Fino al 1910 Einstein è un impiegato dello Stato, che dedica alla scienza tutto il tempo libero. Dal 1910 ha una cattedra di Fisica a Praga, tutta la famiglia lascia Berna per Praga, poi Berlino e poi - Albert solo - per tutta l’Europa, dove contesti scientifici e mondani richiedono a gran voce la presenza del piccolo geniale scienziato.
Ma nel volgere di pochi anni, il tempo le avrebbe dato torto. Fino al 1910 Einstein è un impiegato dello Stato, che dedica alla scienza tutto il tempo libero. Dal 1910 ha una cattedra di Fisica a Praga, tutta la famiglia lascia Berna per Praga, poi Berlino e poi - Albert solo - per tutta l’Europa, dove contesti scientifici e mondani richiedono a gran voce la presenza del piccolo geniale scienziato.La relazione con la cugina di primo grado, poi seconda moglie, Elsa Einstein in Löwenthal, incrinò definitivamente i rapporti tra marito e moglie. In questo periodo Albert iniziò a provare fastidio per lei, a “trattarla come un’impiegata che non posso licenziare”, evidentemente preso dal fascino di Elsa (comunque più grande di lui, due anni invece di quattro).
 Arrivò a scrivere alla moglie le sue condizioni, un documento raccapricciante (riportato per noi, tra altre cose, in Donne pazze, sognatrici, rivoluzionarie, di Milton Fernandez, Rayuela Edizioni). In cambio del suo impegno a trattarla con cortesia (“come faccio di solito con tutti gli estranei”), lei avrebbe dovuto: preoccuparsi dei suoi vestiti, di tre pasti regolari, dell’ordine nelle sue cose senza però toccare la scrivania.
Arrivò a scrivere alla moglie le sue condizioni, un documento raccapricciante (riportato per noi, tra altre cose, in Donne pazze, sognatrici, rivoluzionarie, di Milton Fernandez, Rayuela Edizioni). In cambio del suo impegno a trattarla con cortesia (“come faccio di solito con tutti gli estranei”), lei avrebbe dovuto: preoccuparsi dei suoi vestiti, di tre pasti regolari, dell’ordine nelle sue cose senza però toccare la scrivania.Tranne quando richiesto dalle apparenze sociali, avrebbe evitato di sedersi accanto a lui anche a casa, non avrebbe atteso alcuna manifestazione d’affetto né avrebbe rinfacciato questo comportamento, sarebbe dovuta correre a ogni richiamo e andarsene appena così comandata, non avrebbe mai denigrato il padre davanti ai bambini.
 Un patto osceno? Non più di tanti che si consumano in case normali, oggi come allora (meno, forse). Mileva, con la stessa forza che la aveva portata a studiare come gli uomini, prende i bimbi e se ne va, torna a Zurigo. I documenti del divorzio, firmati nel 1919, riportano che Albert Einstein si impegnava a darle l’ammontare di eventuali premi futuri. Pensava al Nobel, che infatti arrivò nel 1921.
Un patto osceno? Non più di tanti che si consumano in case normali, oggi come allora (meno, forse). Mileva, con la stessa forza che la aveva portata a studiare come gli uomini, prende i bimbi e se ne va, torna a Zurigo. I documenti del divorzio, firmati nel 1919, riportano che Albert Einstein si impegnava a darle l’ammontare di eventuali premi futuri. Pensava al Nobel, che infatti arrivò nel 1921.A Mileva e ai figli andarono i denari, ma lei poteva spostarne solo una percentuale, sufficiente comunque a vivere e a curare il figlio Eduard, malato di schizofrenia; il grande invece, Hans Albert, divenne ingegnare e poi raggiunse il padre negli Stati Uniti, dove si era stabilito nel 1933 in fuga dalle persecuzioni naziste. -Vicissitudini economiche e malattie accompagnano gli ultimi anni di Mileva Mariç, non del tutto abbandonata economicamente da quello scienziato famoso ormai nel mondo, simbolo di ogni genialità, non tanto bravo, però, in matematica. Era lui che aveva detto che “è più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio”.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. -- "STORIA, GIOIA": EMANUELE SEVERINO, NEI MEANDRI DELLA FANTASIA.3 febbraio 2017, di Federico La Sala
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
- CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Emanuele Severino: Storia, gioia
di Francesco Roat *
- Emanuele Severino, Storia , gioia, Adelphi, 2016, pp248, Euro 32,00
Le tematiche affrontate nell’ultima opera di Emanuele Severino ‒ “Storia, gioia” ‒ sono sempre le stesse su cui, fin dall’inizio della sua riflessione speculativa, s’incentra il pensiero del più noto filosofo italiano contemporaneo. A fondamento della sua teoresi permane dunque l’idea che il divenire non esista, stante il convincimento ‒ di derivazione parmenidea ‒ che: l’essere è e non può non essere; mentre il non essere non è, e non può essere. Da questa premessa, per Severino, gli essenti (ogni cosa, pensiero, animale o persona) risultano eterni, giacché non è possibile che quanto è ‒ divenendo ‒ si annichili: passando così dall’essere al non essere. All’obiezione dell’uomo della strada secondo il quale invece appare chiaro che ‒ ad esempio ‒ un ciocco di legna a cui è stato dato fuoco si trasforma in altro da sé, Severino risponderebbe che, coerentemente alla propria premessa di fondo (a suo dire indubitabile/ineccepibile), tale ciocco non si è davvero trasformato, bensì ha solo smesso di evidenziarsi nel “cerchio dell’apparire”. Ovvero è scomparso dal nostro scenario percettivo, pur rimanendo essente nel “cerchio originario del destino”.
In tale visione del mondo la “storia” risulta l’infinito e vasto apparire degli eterni immortali (ad onta dell’illusoria loro mortalità, vista qui come mera fuoriuscita dalle quinte del teatro mondano); non essendo costituita da res gestae: da cose che son fatte esistere e che poi escono dall’esistenza. Pertanto il ritenere che ciò che è possa trasformarsi in nulla ‒ ribadisce in ogni suo scritto Severino ‒ è quella che lui chiama la “follia estrema” dell’Occidente e l’errore che sta alla base della filosofia quale è oggi concepita nell’era del nichilismo e della tecnica. Follia che fa credere/temere la morte come “annientamento”, rispetto alla quale vanamente il sapere e l’operare tecnocratico cercano di opporsi tramite una pseudo-potenza che però “sa di essere estrema impotenza”.
Credo risulti evidente al lettore la tendenza severiniana alla rigida/astratta formulazione concettuale, che non gli consente di uscire dai formalismi della logica classica (aristotelica), tutta giocata sul principio di non contraddizione e del terzo escluso. Logica messa peraltro in crisi non solo da Nietzsche ma dalla fisica quantistica, laddove essa ritiene che un quanto può venire espresso da due rappresentazioni opposte che dicono d’una medesima realtà (onda e/o particella). Ma oltre Parmenide e Aristotele sembra proprio che Severino non intenda, né abbia mai inteso procedere. Persuade comunque assai poco la sua ipostatizzazione di ogni “essente”, cristallizzato in una forma immutabile. Questa visione appare davvero frutto di un’ottica filosofica che si auto-costringe in una teorizzazione concepita/concepibile appena tramite assiomi sedicenti incontestabili.
Dire, infatti, che un essente è e che non può mai tramutarsi in ciò che non è (negazione del divenire) significa definire o congelare in modo del tutto arbitrario un aspetto/fenomeno senza tener conto che tale operazione è possibile solo astraendolo dal suo contesto esistenziale. Si pensi solo ad un atomo qualsiasi, impossibile da immobilizzare, è la cui immagine statica dunque è virtuale, giammai reale. Il mutar configurazione da parte dell’atomo (e delle particelle subatomiche che lo compongono) è costante e, per dirla con Severino, la sua essenza sta giusto nel non avere una forma definibile una volta per tutte. Non parliamo poi d’un qualcosa denotato da maggiore complessità, tipo un organismo animale, che eguale a se stesso non è praticamente mai, cangiando di continuo la conformazione/interazione delle sue cellule.
Ben altro sarebbe il discorso di Severino se egli, dismessa la saccenza assertoria del logos, recuperasse la saggezza del mythos. Se egli si facesse filosofo-poeta, con altro sguardo coglieremmo questo suo ultimo scritto; magari finendo per apprezzarne la felice poiesis, la intuizione creativa d’un linguaggio avente il coraggio di parlarci della “storia autentica” di una terra non più isolata/destinata all’annichilazione, ma che ai suoi occhi risulta storia “infinita” ed è al contempo “il dispiegamento senza fine della Gloria”. Accompagnata dalla Gioia, intesa come “la manifestazione infinita del Tutto”.
Bello sarebbe il racconto del Nostro se egli concepisse il suo dire nel segno della metafora, dell’allusività e del simbolo; in una parola: all’insegna di un dire poetico. Allora forse apprezzeremmo l’estrema e misteriosa liricità di una frase come questa, altrimenti irricevibile: “nemmeno un filo d’erba può essere trasformato, fatto diventare altro”. O di quest’altra: “i cerchi del destino non hanno più da temere la morte e il dolore (...) Essi sono semplicemente aperti al sopraggiungere sempre più concreto della Gioia”.
Che nostalgia di assoluto, che fame di eternità, che sete di infinito, in tali espressioni! Sì, Severino ‒ nella seconda parte dell’opera ‒ talvolta dismette i panni sussiegosi del loico assumendo veste e toni mistico-poetici che destano stupore se non ammirazione; come quando descrive gli uomini odierni avvolti pur dalle tenebre, ma che “nella loro vera essenza essi sono innanzitutto eterne luci infinite. Ogni luce, un infinito. Una costellazione infinita di luci infinite”. O altrove, quando scrive: “L’essenza dell’uomo è la manifestazione finita del Tutto”. O, ancora, sembrando avere indossato le vesti d’un maestro Zen, egli nota, a mio parere condivisibilmente, “per quanto ampio e profondo, il dolore finito è pur sempre un «punto rispetto all’infinità della Gioia”. O infine, allorché trova la forza di ammettere: “il dolore è tale solo in quanto è rifiutato”. A quando un Severino mistico a tutto tondo?
*
A Modena un tema suggestivo affrontato da pensatori e artisti
Nei meandri della fantasia
 Uno strumento di verità della terra che l’uomo imprigiona nel sentirsi mortale
Uno strumento di verità della terra che l’uomo imprigiona nel sentirsi mortale
 Sulla forma originaria della fantasia si fondano religioni e miti, filosofia, arte, scienza: tutte opere morte dei mortali
Sulla forma originaria della fantasia si fondano religioni e miti, filosofia, arte, scienza: tutte opere morte dei mortalidi Emanuele Severino (Corriere della Sera, 14.09.2008)
La fantasia è l’insieme delle «immagini originarie», delle «forme di rappresentazione più antiche e più generali dell’umanità»: gli «archetipi» (ad esempio il divino). «Diffusa dappertutto», la fantasia «appartiene ai misteri della storia dello spirito umano». Così scrive Carl Gustav Jung. Platone vede nelle «idee» le immagini originarie di tutte le cose, gli archetipi; così originarie da essere le stesse cose originarie. Ma per lui la conoscenza delle idee non appartiene ai «misteri» dello spirito umano, bensì alla scienza della «verità» a cui solo il filosofo è capace di sollevarsi e che dunque è l’opposto della «fantasia» intesa come evocazione misteriosa, e quindi da ultimo oscura e arbitraria, di mondi.
Eppure è necessario risalire molto più indietro di ogni archetipo a cui l’uomo si sia rivolto lungo la propria storia. Ci si imbatte nella forma originaria della fantasia, di cui tutti quegli archetipi sono derivazioni. Da tempo chiamo «terra» la storia dell’uomo e delle cose che gli si fanno incontro. Infatti si può pensare che la più antica origine di questa parola indichi il venire e l’andare, l’insieme di ciò che va e viene: il seno e la voce materna, la luce e la casa, uomini e dèi, il dolore e il piacere: cose terrestri e celesti, giacché anche il divino raggiunge i mortali a un certo punto della loro vita e poi da molti di essi si allontana. La terra: gli stormi delle cose che vengono e vanno.
Da che cosa è accolta la terra? Da che luogo si allontana? I mortali appartengono alla terra: nascono e muoiono. Ma l’uomo non è un mortale. Egli è il luogo eterno in cui appare ciò che da sempre la verità è destinata ad essere: il «destino della verità del Tutto»; essenzialmente diversa da ciò che i mortali hanno inteso con le parole «destino» e «verità». Nell’uomo sopraggiunge la terra. Ma insieme ad essa sopraggiunge e si fa dominante, la convinzione che l’uomo sia un mortale, e con lui tutte le cose; ed egli vive come se in verità lui e le cose lo fossero. Ma in verità ogni cosa è eterna. Non solo le «anime», come invece pensa Platone, ma anche i «corpi», e tutti gli stati delle une e degli altri. Anche la terra è eterna; e anche quella ingannevole convinzione che separa la terra dal destino della verità.
Com’è lontano questo discorso da tutto ciò di cui sono convinti i mortali! La sua inevitabilità non può essere, qui, neppure lontanamente indicata. Qui si tratta solo di mostrare, da lontano, in che senso è necessario risalire molto più indietro di ogni archetipo evocato dai mortali. Tanto indietro da poter scorgere che sia la «verità» dei mortali sia la loro «fantasia» hanno la stessa anima e che quest’anima è la forma originaria della fantasia.
In una delle sue accezioni più comuni, la fantasia è la capacità di portare alla luce mondi diversi da quello quotidiano o da quello che è ragionevole ritenere esistente. Ma questi due tipi di mondi, cioè di andirivieni, entrambi evocati dai mortali, appartengono alla terra. Essa è il fondamento non solo della sapienza di questo mondo e della sapienza di Dio, ma anche della fantasia. E la terra si inoltra nel luogo eterno del destino della verità. Ma non basta. La maggior parte di coloro che leggono queste righe stanno pensando che esse non abbiano nulla a che fare con la «realtà» e la «serietà della vita».
Fantasie, appunto. Ma anch’essi sanno infinitamente di più di quanto credono di sapere. Sono l’apparire del destino. L’autentica fantasia originaria è cioè la convinzione che la «realtà » con cui noi abbiamo sicuramente a che fare sia, appunto, le cose che vengono e vanno, terrestri o celesti, le cose della terra; e ormai si pensa che tutte le cose vengano dal nulla e vi vadano. Tutto è avvolto dalla morte. Chiudendosi in questa persuasione i mortali vivono nella terra separata dal destino della verità, nella terra che appare sfigurata, irretita, trascinata in basso. La terra dei morti. La fantasia originaria è la separazione della terra dal proprio destino. Una metafora può forse aiutare a comprendere queste affermazioni- purché non si dimentichi che la filosofia autentica non è metafora, ma il pensiero più radicale, essenzialmente più radicale e inevitabile di ogni altra forma di sapere, scienza compresa.
Quando i cacciatori vedono gli stormi di uccelli attraversare il cielo, non è che il cielo non lo vedano più. Non si produce in essi qualcosa come un «oblio» del cielo e del più alto dei cieli - quale invece secondo Platone si spalanca nelle anime che hanno perduto le ali e non riescono più a vedere gli archetipi che appaiono nella «pianura della verità». Quei cacciatori, il cielo, lo vedono ancora, ma son tutti presi dal volo degli uccelli e se qualcuno parlasse loro del cielo direbbero che le sue son fantasie e che sono gli uccelli le cose con cui essi hanno sicuramente a che fare. Son tutti presi dal volo degli uccelli perché non mirano ad altro che a prenderli, gli uccelli; ed effettivamente li prendono, e gettan loro addosso le reti e li sfigurano e, separandoli dal cielo, li trascinano giù in basso e li uccidono.
La fantasia originaria è il volo irretito degli uccelli. L’arte tenta di rievocare il libero volo, ma, per quanto splendente, rimane anch’essa all’interno della rete, mostrando il volto sfigurato della terra. Giacché ora si può capire che, nella metafora, il volo degli uccelli corrisponde alla pura terra, il cielo al destino della verità.
La rete dei cacciatori corrisponde dunque alla volontà di potenza che isola la terra dal destino della verità. Tale isolamento è la forma originaria della fantasia. Su di essa si fondano le forme derivate: religioni e miti, filosofia, arte, scienza: tutti i morti pensieri e le opere morte dei mortali.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. -- EMANUELE SEVERINO. È scomparso il 17 gennaio scorso, l’annuncio a funerali avvenuti ( di Mauro Bonazzi)21 gennaio 2020, di Federico La Sala
1929-2020
Morto il filosofo Emanuele Severino
Addio al filosofo Emanuele Severino: nato il 26 febbraio 1929 a Brescia, stava per compiere 91 anni. È scomparso il 17 gennaio scorso, l’annuncio a funerali avvenuti
di Mauro Bonazzi *
Citando un verso di Archiloco, Isaiah Berlin ha una volta provato a distinguere i pensatori in volpi e ricci, tra chi «sa molte cose», inseguendo la realtà in tutte le sue diramazioni, e chi invece «sa una sola cosa, ma grande». Emanuele Severino - scomparso il 17 gennaio a quasi 91 anni - appartiene a pieno titolo al secondo gruppo, in compagnia di un altro riccio per eccellenza, Parmenide, al quale aveva dedicato il saggio Ritornare a Parmenide («Rivista di filosofia neoscolastica», 1964).
Nei tanti libri pubblicati e nelle tante conferenze tenute (Severino era tra le altre cose un ottimo oratore), la sua riflessione si è sviluppata intorno a un unico problema, quello del divenire e della morte. Con un solo, grandioso, obiettivo: negarne l’esistenza. Il problema degli uomini è la credenza del nulla, l’illusione che tutto ciò che esiste, prima non ci fosse e poi non ci sarà. Dal non essere all’essere e ancora al non essere: è il ciclo della vita che diviene. Questa certezza nell’esistenza del divenire è una forma estrema di «nichilismo» tragico: è nichilismo perché il divenire presuppone il non essere e dunque il nulla (L’essenza del nichilismo, Paideia, 1972); ed è tragico perché di fatto riduce la vita ad una corsa verso la morte (il non essere).
La storia del pensiero occidentale in tutte le sue declinazioni, religiose, scientifiche, filosofiche, è un tentativo di eludere la paura di questo nulla. Per Severino non c’è spazio per tutta questa «follia», per una ragione semplicissima. Il divenire non esiste. L’essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere, affermava Parmenide. Dire che l’essere è non essere, o che l’ente è niente, ammettere il divenire insomma, è contraddittorio. L’unica conclusione coerente è, allora, che ogni ente - tutte le cose, ciascuno di noi - è in quanto è ente: e se è, è eterno, non viene all’essere (non nasce) e non finirà nel nulla (non muore).
La morte non esiste, è solo un abbaglio di chi non ha capito che cosa vuol dire «essere». Si pensa alla vita come a un film, in cui fotogrammi scorrono verso una conclusione, senza rendersi conto che tutti i singoli fotogrammi sono sempre lì e niente passa o si perde. Illusi dai loro errori gli uomini si angosciano per la morte e non si accorgono che sono già da sempre salvi, «nella Gloria e nella Gioia» (La gloria, Adelphi 2001; Storia, gioia, Adelphi 2016).
Nel 1970 la Congregazione per la dottrina della fede dichiarò che la filosofia di Severino era incompatibile con la rivelazione cattolica, costringendolo a lasciare l’Università Cattolica di Milano e trasferirsi a Venezia. C’era del vero nella condanna: il pensiero di Severino è un pensiero del qui e ora, che non demanda a un improbabile aldilà il momento della salvezza. Rinnova il confronto secolare tra religione e filosofia, prendendo le parti della seconda. La filosofia, quando è veramente filosofia, è il tentativo di spiegare - su basi razionali, senza bisogno di rivelazioni o illuminazioni - cosa sia la realtà e quale sia il suo senso. La filosofia è conoscenza e la conoscenza salva, perché ci aiuta a capire come stanno le cose: che non vi è nulla oltre agli enti (le cose, noi), che la morte non esiste, che il paradiso (la Gloria) è qui e ora.
Severino è davvero l’ultimo dei Greci. Anche per questo un altro controverso filosofo del Novecento, Martin Heidegger, s’interessò al suo pensiero (o meglio alle critiche che Severino gli aveva rivolto nella sua tesi di laurea), riconoscendone l’importanza. È una notizia recente, che però non sorprende, vista la convinzione di entrambi che l’Occidente avesse preso una strada «folle» nel momento in cui aveva deciso di sostituire a Dio la tecnica, credendo di poter risolvere in questo modo i problemi del nostro tempo (Il destino della tecnica, Rizzoli, 1998). Del resto, al netto delle pur fondamentali differenze (per Severino neppure Heidegger è stato capace di uscire dal nichilismo: anche lui, insistendo sulla dimensione temporale dell’essere, è rimasto intrappolato nelle secche del divenire), il suo pensiero va incontro a difficoltà analoghe a quelle di Heidegger.
Nel mondo di Severino non c’è spazio per la politica, intesa come cambiamento dell’esistente (Il tramonto della politica, Rizzoli, 2017). Quello che serve è uno sguardo capace di contemplare l’eternità. Tutto è, eternamente - un bacio, il terremoto di Lisbona, la pioggia che cade. Sono tesi radicali, oggetto di grandi discussioni, ma coerenti con l’impianto di fondo del suo sistema, e un grande pensatore non rinuncia mai alla coerenza. Del resto non è proprio il compito della filosofia mostrarci che le cose stanno diversamente da come siamo abituati? «Non si tratta di rassicurare il mortale, ma di mostrare la verità del destino». E la verità, osservava Leopardi (di cui Severino ha vigorosamente difeso la profondità filosofica nel libro In viaggio con Leopardi, Rizzoli 2015), non è necessariamente buona o bella, ma non per questo va respinta. Di sicuro lui l’ha cercata per tutta la vita.
* Corriere della Sera, 21 gennaio 2020 (ripresa parziale).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA -- Telescopi puntati sul ’fratello’ della Terra, per aprire la via alla futura flotta di vele solari12 gennaio 2017, di Federico La Sala
- IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo.
Telescopi puntati sul ’fratello’ della Terra
Si osserva Proxima b per aprire la via alla futura flotta di vele solari *
Il progetto per inviare una flotta di vele solari a caccia di vita nel pianeta scoperto nel sistema stellare Alpha Centauri, trova l’alleanza con i telescopi dell’Osservatorio Meridionale Europeo (Eso), che si trovano in Cile.
Per preparare il viaggio delle vele solari previsto dal progetto Breakthrough Starshot, rende noto l’Eso, il Very Large Telescope (Vlt) verrà modificato in modo da fotografare i dettagli del pianeta ’gemello’ della Terra scoperto recentemente attorno alla stella più vicina a noi, Proxima Centauri e che potrebbe ospitare forme di vita.
"Da poco tempo - ha spiegato Giancarlo Genta, del Politecnico di Torino e unico italiano membro del comitato scientifico di Breakthrough Starshot - sappiamo con certezza che lì esiste un pianeta, e sembrerebbe avere caratteristiche simili alla Terra, ma niente di più. Prima di mandare una sonda servirebbe saperne di più".
Per questo è nato un’accordo tra Eso, l’osservatorio che ha scoperto l’esistenza di Proxima b, e Breakthrough Starshot, il progetto che prevede di inviare una flotta di mini-sonde capaci di viaggiare a velocità altissime per raggiungere Alpha Centauri in appena 20 anni.
Il progetto Breakthrough Starshot è nato dalle idee di alcuni dei più importanti ricercatori del mondo, tra i quali l’astrofisico Stephen Hawkings, è finanziato dal magnate russo Yuri Milner ed è previsto nel 2069, ma i ricercatori sono già al lavoro.
Dopo l’annuncio della realizzazione di una Google Map dello spazio interstellare, grazie ai dati del telescopio spaziale Hubble, fondamentale per guidare il viaggio delle sonde, arriva adesso l’accordo con uno dei più potenti telescopi al mondo.
"Le sonde - ha spiegato Genta - non potranno essere telecontrollate, ma dovranno essere autonome, quindi maggiori informazioni potremo avere più facile potrà essere il loro lavoro". Per questo si è concordato di fare di miglioramenti allo strumento Visir installato su Vlt, il maxi telescopio di oltre 8 metri di diametro che si trova nel deserto di Atacama, e di trasferire i miglioramenti anche su E-Elt (European Extremely Large Telescope), il super telescopio da 40 metri dell’Eso, ancora in fase di costruzione.
*Ansa, 11 gennaio 2017 (ripresa parziale).
-
> LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" - Milena Einstein, nata Marić, e la teoria della relatività. L’universo a cavallo di un raggio di luce.12 dicembre 2016, di Federico La Sala
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!).
- Mileva Einstein, nata Marić - Милева Марић (Titel, 19 dicembre 1875 - Zurigo, 4 agosto 1948), è stata una scienziata serba compagna di studi di Albert Einstein, di cui divenne anche prima moglie (...) Dal 1990 si è aperta la discussione sulla sua partecipazione ai lavori sulla teoria della relatività di Einstein.
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> LA MENTE ACCOGLIENTE. -- LA "COPPIA FREUDIANA". L’OPERA DI CHRISTOPHER BOLLAS "disegna il limite al quale si può spingere oggi l’analisi reciproca".25 dicembre 2016, di Federico La Sala
LA "COPPIA FREUDIANA". L’OPERA DI CHRISTOPHER BOLLAS "disegna il limite al quale si può spingere oggi l’analisi reciproca":
Prenderli al volo prima che precipitino
di Pietro Barbetta ( "Doppiozero", 22 ottobre 2016)
Il giovane Holden ha un momento di tenerezza davanti alla domanda della sorellina. Phoebe, questo il nome della piccola, gli chiede che cosa vuol fare da grande. Holden risponde che ci sono tanti ragazzi: “e intorno non c’è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in piedi sull’orlo di un dirupo pazzesco. E non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere nel dirupo... io devo saltar fuori da qualche posto e acchiapparli”.
È la parte più tenera del romanzo, quella che gli dà il titolo in lingua inglese il suo cuore: The Catcher in the Rye (l’intraducibile: Acchiappatore nella segale). Holden Caulfield prosegue: “Non dovrei far altro tutto il giorno. Sarei solo l’acchiappatore nella segale e via dicendo. So che è una pazzia, ma è l’unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia” (Salinger, Il giovane Holden).
Una delle ultime opere di Cristopher Bollas s’intitola Catch Them Before They Fall, prendili prima che precipitino. Prima che cadano nel dirupo. Ciò che Il giovane Holden racconta alla sorellina Phoebe, sembra rispecchiare la missione di Bollas nel suo lavoro con gli schizofrenici.
Cristopher Bollas nasce il 21 Dicembre del 1943 a Washington. Negli Stati Uniti riceve formazione umanistica e letteraria, con predilezione verso gli studi storici. Bollas conosce l’opera di Sigmund Freud come pochi e sviluppa, nel corso della sua vita, una pratica clinica intensa. È il più noto esempio vivente di umanista che, fin da giovane, è immerso nel flusso della clinica, ricevendo - nel tempo, col suo trasferimento a Londra - la formazione psicoanalitica. È un’epoca in cui, nel Regno Unito, non si fanno distinzioni tra medici e laici, conta la passione clinica.
La sua vita si svolge tra gli Stati Uniti e Londra. Nell’ultimo libro Se il sole esplode. L’enigma della schizofrenia, uscito per Raffaello Cortina, Bollas racconta il suo lavoro con persone schizofreniche e la sua formazione clinica, come se le due cose andassero in parallelo.
Bollas sembra sostenere che per lavorare con la psicosi, in particolare con la schizofrenia, l’essere psicoanalisti, o psicoterapeuti di qualunque scuola, non basta. Bisogna riconoscere che questo lavoro è una pazzia. Che il terapeuta ha bisogno di condividere la pazzia, di liberarsi dal terrore di venire contaminato, di essere, anche lui, un po’ schizofrenico, folle, delirante; al punto da considerare il delirio nient’altro che un sistema complesso di libere associazioni. Un esempio di sovra-determinazione freudiana.
Autore prolifico - le opere di Bollas hanno avuto particolare successo in Italia, grazie a Raffaello Cortina, Astrolabio, Borla e Antigone - è tra i massimi psicoanalisti viventi e attivi. Mentre qui da noi ci sono ancora psicoanalisti che si chiedono se sia corretto usare la lampadina elettrica, dal momento che ai tempi di Freud si usavano le lampade a gas, Bollas, senza alcuna inibizione da psicoanalista, scrive delle sedute che fa per telefono, via Skype; lasciandoci surplace.
Durante le mie lezioni di psicologia dinamica, propongo a un gruppo di studenti un seminario su Cristopher Bollas. Gli studenti intitolano il paper, scaturito dal lavoro collettivo: Alla scoperta dei temi controversi nella psicoanalisi. Ne nasce un animato dibattito tra il gruppo degli studenti coinvolti, il resto della classe e me. Il gruppo dà questo titolo al seminario per sottolineare come una serie di argomenti di Bollas si sviluppi a partire da riferimenti critici, addirittura di rottura, rispetto alla psicoanalisi. Evocano Ronald Laing e, più in generale, l’idea di psichiatria democratica.
Altri sottolineano che la cultura di Bollas è ricca di elementi storici, letterari, filosofici, che il libro sulla Mente orientale ricorda lo Zen e le considerazioni di Bateson su Bali.
Altri ancora sostengono che il transfert in Bollas è il contrario dell’idea di neutralità nella psicoanalisi classica, che per molti aspetti Bollas somiglia a un terapeuta rogersiano, a un terapeuta narrativo sistemico, a uno psicoanalista della relazione.
C’è chi, infine, dice che tutte queste tematiche sono recepite da buona parte dei membri della società psicoanalitica freudiana (la famosa IPA) e che oggi non si può più definire chi sia eretico in psicoanalisi. Chi, tra gli studenti, è già in terapia, dichiara che il suo terapeuta è come Bollas, ha lo stesso stile.
Forse Bollas dà voce a un modo accogliente difare terapia che è già diffuso in campo psicoanalitico, transazionale, sistemico, gestaltico. Non fa che descrivere la terapia, distinguerla da quel guazzabuglio di interventi coatti e autoritari che hanno dominato l’inizio del millennio e che - finalmente! - stanno tramontando. Se così, dobbiamo dire che la sua voce è efficace, è un autentico metodo basato sull’evidenza; evidenza che la psicoterapia è, come la follia: creazione.
I racconti dei casi clinici, così come li scrive Bollas - in quello stile elegante tipico della letteratura anglosassone - sono opere letterarie, lontane dai gerghi psicoanalitici. Racconti didascalici, chiari, privi di espressioni tecniche. Bollas non usa la scolastica psicoanalitica in modo diretto. Quando la usa, come nel caso del termine inconscio collettivo, non dà mai per scontato che cosa significhi per lui e come mai, in quella circostanza, ha usato quel termine junghiano.
Il lettore che legge i suoi libri non sente sul collo il fiato della psicoanalisi seria, di quella cosa che Foucault chiamerebbe pratica discorsiva. Mi capita spesso di leggere in parallelo un testo letterario e dei saggi. Mentre leggo Bollas, non mi accorgo della differenza, non sento il salto tra saggistica e narrativa. I suoi scritti partono sempre dal soggetto Christopher, piuttosto che dal dottor Bollas.
Bollas non ha dunque alcuna pretesa teoretica astratta, nessun modello filosofico/antropologico definitivo da proporre. Scrive partendo dalla vita e la vita è vita di relazione tra sé e i suoi casi clinici, casi della vita. Nel libro Il mondo dell’oggetto educativo, Bollas insiste in maniera singolare su un termine: coppia freudiana. Non si tratta di un nuovo concetto da inserire nel lessico psicoanalitico, si tratta di un lemma che riguarda la relazione terapeutica.
Che cos’è la coppia freudiana? La coppia freudiana è un evento. Accade quando l’inconscio del soggetto che frequenta la terapia tocca l’inconscio del terapeuta. Questa definizione della traslazione in psicoanalisi non può non ricordare un autore che sta sullo sfondo del pensiero di Bollas, un po’ come Nietzsche sta sullo sfondo del pensiero di Freud: Sandor Ferenczi.
Il termine coppia freudiana evoca l’analisi reciproca di Ferenczi. L’opera di Bollas disegna il limite al quale si può spingere oggi l’analisi reciproca. Il coraggio di parlare di sé alle persone che frequentano le sedute e di scrivere di sé ai suoi lettori, non va scambiato con il narcisismo. È semmai il contrario. È immerso in un orizzonte di ironia e di curiosità terapeutica. È la maniera di mettere in comune le proprie esperienze con quelle del soggetto in terapia, di condividere le passioni, di reagire agli eventi, di riconoscere gli errori del terapeuta, di entrare in relazione.
Insomma, la traslazione del terapeuta non è contro-transfert, semmai co-transfert, se vogliamo usare il gergo della psicoanalisi.
Il terapeuta non è istruttore, interpretante, riparatore, è la parte di un incontro, non sempre dialogico, non senza conflitti. Ma la terapia è anche un mondo in cui i conflitti si gestiscono insieme.
Vorrei infine sottolineare l’uso diagnostico del termine psicosi per definire il periodo storico di una nazione: le tendenze psicotiche interne agli Stati Uniti negli anni Sessanta, secondo capitolo del suo ultimo libro, nome del capitolo: “La follia di una nazione”.
Mi è capitato di recente di scrivere su doppiozero.com alcune note sull’epoca psicotica che stiamo attraversando in Europa - sto persino cercando di scriverci sopra un libro - e mi conforta sapere che le mie riflessioni sono corroborate da un autore ben più importante. Dall’assassinio di Kennedy alla guerra del Vietnam, venti psicotici hanno pervaso gli Stati Uniti così come oggi questi venti pervadono l’Europa; dai comportamenti delle banche e dei più potenti manager alle incursioni dello Stato Islamico, dal risorgere di venti fascisti e nazionalisti all’insorgenza dei massacri della crescente sociopatia. Come i bimbi dell’East Bay Activity Center di Oakland, in California, negli anni Sessanta sentivano la patologia della nazione dentro la pelle, così gli adolescenti che mi capita di incontrare nel mio lavoro quotidiano sentono i venti psicotici dell’Europa contemporanea.
-
> LA LUCE, LA TERRA. "Note per una epistemologia genesica" -- Nell’universo primordiale, una luce più veloce. L’ultimo sviluppo di una teoria quasi ventennale, elaborata da Magueijo e Afshordi5 dicembre 2016, di Federico La Sala
Una luce più veloce nell’universo primordiale? *
-*** L’indice spettrale, un parametro misurabile della radiazione cosmica di fondo, potrebbe dimostrare che la velocità della luce aveva un valore diverso nell’universo primordiale. Lo afferma l’ultimo sviluppo di una teoria quasi ventennale che mette in dubbio l’invariabilità delle costanti fondamentali della natura e sfida il modello dell’universo inflazionario, formulato per rendere conto dell’uniformità della densità media del cosmo osservabile (red) *
Le costanti della natura sono veramente costanti? È un dubbio che ha tolto il sonno a più di un fisico teorico, perché se certi parametri variassero nello spazio e nel tempo, anche a grande distanza da noi, la descrizione che le leggi fisiche fanno dell’universo sarebbe decisamente differente.
È il caso per esempio della velocità della luce che, secondo la teoria della relatività speciale di Einstein, non cambia con il sistema di riferimento utilizzato per misurarla, come dovrebbe essere se continuassero a valere le leggi della relatività galileiana. In altre parole, la velocità della luce è una costante assoluta, oltre a essere una velocità limite, non superabile né da particelle dotate di massa né dall’informazione.
Si tratta di un postulato che è servito per costruire altre importanti teorie, come la relatività generale dello stesso Einstein, una teoria della gravitazione che spiega la struttura a larga scala del cosmo, l’evoluzione dell’universo a partire da una catastrofica esplosione iniziale, il big bang, e l’esistenza di oggetti estremi come i buchi neri.
Le previsioni della teoria della relatività generale sono state confermate innumerevoli volte; eppure ci sono ricercatori che ora sollevano qualche dubbio sui suoi fondamenti: e se nell’universo primordiale, pochi secondi dopo il big bang, le cose fossero state diverse?
Alla fine degli anni novanta, João Magueijo, dell’Imperial College di Londra, e Niayesh Afshordi del Perimeter Institute, in Canada, ipotizzarono che per esempio la velocità della luce potrebbe essere stata decisamente maggiore appena dopo il big bang. Ora gli stessi ricercatori hanno formulato una previsione verificabile sperimentalmente che dovrebbe consentire di capire se si tratta di un’ipotesi plausibile.
Le strutture presenti nell’universo, come le galassie, si sono tutte formate da fluttuazioni nell’universo primordiale, cioè da differenze di densità da una regione all’altra. Una registrazione di queste fluttuazioni primordiali è impressa nel fondo cosmico a microonde, la radiazione “fossile” che è ciò che resta della prima luce propagatasi nell’universo.
Secondo la teoria elaborata da Magueijo e Afshordi, ora pubblicata sulla rivista “Physical Review D”, se la velocità della luce fosse variata nell’universo primordiale, le fluttuazioni di densità ne avrebbero risentito. E una traccia ne sarebbe rimasta in un parametro fisico associato alla radiazione cosmica di fondo: l’indice spettrale, che in tal caso dovrebbe essere pari a 0,96478, contro un valore attualmente noto di 0,968, con un certo margine di errore.
“La teoria che abbiamo proposto per la prima volta negli anni novanta ha ora raggiunto la piena maturazione, perché ha prodotto una previsione verificabile sperimentalmente: se le osservazioni nel prossimo futuro dovessero confermare questo valore, si potrebbe arrivare a una modifica della teoria della gravitazione einsteiniana, e significherebbe che le leggi dalla natura in passato potevano non essere le stesse di oggi”.
Se l’idea degli autori fosse verificata, a farne le spese potrebbe essere anche un’altra teoria molto accreditata: quella dell’universo inflazionario. Quest’ultima prevede che l’universo, in una fase primordiale della sua esistenza, conobbe una fase di espansione estremamente rapida, chiamata inflazione, che consente ai cosmologi di risolvere il “problema dell’orizzonte”.
In sostanza, l’universo come lo osserviamo nella nostra epoca ha una densità relativamente uniforme, e questo è possibile solo se in una fase primordiale tutte le regioni dell’universo abbiano potuto influenzarsi reciprocamente. Per fare questo, o l’universo in una certa fase era molto piccolo, come previsto dalla teoria inflazionaria, e iniziò l’espansione solo dopo che l’uniformità della massa era stabilita, oppure la velocità della luce era elevatissima, tanto da permettere la comunicazione tra le diverse parti dell’universo anche quando era in una fase di espansione.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
AL DI LA’ DELLA TEORIA DELLA RELATIVITA’. I neutrini battono la luce di 60 nanosecondi sulla distanza di 730 km, tra Ginevra, sede del Cern, e il Gran Sasso, sede del laboratorio dell’Istituto di Fisica Nazionale (Infn).
-
> LA LUCE, LA TERRA. "Note per una epistemologia genesica" -- 7 dicembre 1676: Ole Rømer e la determinazione della velocità della luce..7 dicembre 2016, di Federico La Sala
Velocità della luce, com’è stata calcolata?
Dobbiamo all’astronomo danese Ole Rømer la determinazione della velocità della luce. Che non è infinita (nel vuoto è pari a 299 792 458 metri al secondo), ma è sempre relativa.
di FOCUS *
- Ole Rømer. È a questo grandissimo scienziato danese che dobbiamo la prima determinazione della velocità della luce. Il Doodle del 7 dicembre 2016 spiega l’ingegnoso metodo che Rømer usò per calcolare la velocità della luce.
Si è ritenuto a lungo che la luce avesse una velocità infinita. L’esperienza quotidiana sembrerebbe confermarlo: appena si accende una lampada, la luce inonda all’istante lo spazio. Tuttavia, già nel XVII secolo l’astronomo danese Ole Rømer ipotizzava che la luce avesse una velocità enorme, ma non infinita.
Fu proprio Rømer a determinare la velocità della luce nel 1676 mentre lavorava all’osservatorio reale di Parigi diretto al tempo da Giovanni Domenico Cassini.
I tentativi di Galileo Galilei. Prima di lui si era cimentato anche Galileo Galilei, ma senza successo. L’esperimento di Galileo prevedeva di porre due lanterne a una distanza di un miglio e di calcolare il tempo che la luce impiegava ad arrivare da un punto all’altro: insieme a un assistente prese una lanterna schermata e andò sulla cima di due colline che distavano un miglio. Galileo scoprì la sua lanterna, e l’assistente sull’altra collina, non appena vide la luce, scoprì a sua volta la lanterna.
- L’esperimento di Galileo Galilei |
Lo scienziato pisano avrebbe quindi dovuto misurare il tempo necessario per vedere la luce dall’altra collina e a quel punto sarebbe stato sufficiente dividere la distanza per il tempo per ottenere la velocità della luce.
L’esperimento non portò a nessun risultato: per percorrere un miglio, la luce impiega circa 0,000005 secondi, un valore immisurabile con gli strumenti a disposizione di Galileo.
La misurazione di Ole Rømer. Se però le distanze da far percorrere alla luce diventano più ampie, una misurazione è possibile anche con strumenti meno sofisticati. È proprio quanto fece Rømer nel 1676 osservando il moto di Io, una delle lune di Giove.
Io compie un’orbita completa intorno a Giove in 1,76 giorni. Rømer, però, si accorse che il tempo impiegato dalla luna non era sempre lo stesso. In certi periodi dell’anno, quando la Terra era più lontana da Giove, ci metteva più tempo; al contrario, quando Terra e Giove erano più vicini, la luna Io sembrava anticipare la sua rivoluzione.
La tesi di Rømer era semplice ma geniale: la differenza era dovuta alla velocità della luce: se questa non è infinita, allora deve impiegare un certo tempo per giungere da Giove alla Terra; quando la Terra è più lontana, ci mette più tempo.
Io, Giove e la terra. L’ipotesi di Rømer non era ben vista dal direttore dell’osservatorio, Gian Domenico Cassini. Allora Rømer, per convincere il proprio capo, annunciò che l’eclissi di Io, prevista per il 9 novembre 1676, sarebbe avvenuta 10 minuti prima dell’orario che tutti gli altri astronomi avevano dedotto dai precedenti transiti della luna.
La previsione si verificò puntualmente e Cassini dovette convincersi. Rømer spiegò che la velocità della luce era tale che aveva impiegato 22 minuti per percorrere il diametro dell’orbita terrestre. Rømer, che aveva un valore impreciso del diametro dell’orbita terrestre, calcolò la velocità della luce in 220.000 km al secondo, una misura non corretta (la velocità precisa è 299.792,458 km/s), ma certamente la più prima mai misurata fino ad allora.
- L’eclissi di Io e la velocità della luce. Quando la Terra si allontana da Giove, la luce che proviene da Io (è la luce del Sole, riflessa dalla luna) impiega più tempo a raggiungerci. L’orbita di Io sembra rallentare. Ma in realtà non è così, e Rømer utilizzo questo effetto per calcolare con una certa precisione la velocità della luce nel vuoto. |
L’anniversario del 7 dicembre. Rømer comunicò la sua scoperta alla Accademia delle Scienze e la notizia venne poi pubblicata il 7 dicembre 1676, data che viene oggi comunemente ricordata come quella della prima determinazione della velocità della luce.
Nel 1790 il matematico olandese Christiaan Huygens utilizzo l’idea di Rømer per calcolare il maniera più precisa la velocità della luce e riuscì a ricavare un valore numerico molto vicino a quello accettato oggi.
In seguito la velocità della luce è stata misurata dai fisici con precisione assoluta: un raggio luminoso viaggia nel vuoto a 299.792.458 metri al secondo. In un secondo potrebbe compiere sette giri e mezzo della Terra seguendo la linea dell’equatore.
- Leggi anche: 20 fisici +1 che hanno cambiato la visione del mondo
Che fine ha fatto Rømer. Dopo il soggiorno parigino, nel 1681 fece ritorno in Danimarca, dove si mise a insegnare astronomia all’Università di Copenhagen. Degli scritti scientifici prodotti in quell’epoca non è rimasto quasi nulla: furono distrutti nel grande incendio divampato in città nel 1728. La sua passione per le unità di misura riguardò anche il quotidiano: in qualità di matematico reale fu il principale responsabile dell’introduzione di un sistema nazionale per i pesi e le misure in Danimarca nel 1683 (inizialmente basato sul "piede del Reno": ma nelle intenzioni di Rømer, si sarebbe dovuto riferire a costanti astronomiche, un risultato che si raggiunse solo dopo la sua morte).
Ideò inoltre una scala delle temperature che porta il suo nome: oggi non è più in uso, ma il fisico tedesco Daniel Gabriel Fahrenheit l’avrebbe usata come base per elaborare l’omonima scala. Negli ultimi anni della sua vita fu nominato capo della polizia di Copenhagen, e mentre riformava quell’organo dall’interno (perché ritenuto corrotto) non perse l’occasione di inventare qualcos’altro: i primi lampioni stradali - a olio - della città.
- Invenzioni e inventori che hanno cambiato il mondo
 VAI ALLA GALLERY (11 foto)
VAI ALLA GALLERY (11 foto)
Più veloce della luce? In realtà non c’è cosa più veloce nell’universo della luce. Anzi, non può esserci nulla di più veloce, anche in linea teorica, come ha postulato Albert Einstein nella sua celebre teoria della relatività speciale. Dalle sue formule si deduce che in natura esiste un limite massimo di velocità. Ciò ha a che fare con la massa delle cose: ogni oggetto, secondo Einstein, aumenta la sua massa quanto più velocemente si muove (ovvero, oltre un certo limite, l’energia che spinge un oggetto si trasforma quasi tutta in massa e soltanto per una frazione sempre più piccola in velocità).
Questo diventa evidente solo a velocità elevate: se si potesse sparare nello spazio una palla da tennis della massa di 55 grammi a una velocità di 500 milioni di chilometri all’ora, la massa dell’oggetto aumenterebbe a 62 grammi. Se la velocità raggiungesse 1.079 milioni di km/h - corrispondente a circa il 99,98 per cento della velocità della luce - la massa della palla sarebbe di ben 2,5 chilogrammi.
Ogni ulteriore approssimazione alla velocità della luce farebbe aumentare la massa della palla, e al 99,9999 per cento sarebbe di 1,2 tonnellate. A quel punto, però, per imprimere un incremento di velocità sarebbe necessaria una forza immane. Per accelerare una grande massa, infatti, ci vuole più spinta di quanta ne occorra per una massa piccola.
In pratica: quanto più veloce è la palla, tanto maggiore diventa la massa, e di conseguenza più dispendiosa in termini di energia una sua ulteriore accelerazione. Fino alla situazione limite, in cui qualsiasi aumento di velocità richiederebbe un’energia maggiore di quella disponibile nell’universo: il non plus ultra della velocità che un corpo può raggiungere.
- Leggi anche: Onde e particelle, la doppia natura della luce
* FOCUS, 07 Dicembre 2016 (ripresa parziale).
-
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- Alziamo muri tra noi e gli altri perché temiamo la nostra ombra (di Haruki Murakami) .3 novembre 2016, di Federico La Sala
- INFANZIA E STORIA. In memoria di Vladimir Jakovlevič Propp, di Italo Calvino, e di Gianni Rodari...
- FIABA, COSTITUZIONE, E SOCIETA’.
Quei muri tra noi e gli altriMurakami: vi insegno a vivere con le ombre
Alziamo muri tra noi e gli altri perché temiamo la nostra ombra
La letteratura non evita gli angoli bui degli individui e delle società, non allontana i nostri lati oscuri: li affronta e illumina le nostre paure
di Haruki Murakami (la Repubblica, 03.11.2016)
- Pubblichiamo il discorso che lo scrittore giapponese Haruki Murakami ha pronunciato ricevendo il premio Andersen Il riconoscimento intitolato all’autore di fiabe è il più importante premio letterario danese Fra gli ultimi romanzi di Murakami tradotti in Italia da Einaudi, figurano Sonno (2014), La strana biblioteca (2015), Vento & Flipper (2016)
SU suggerimento di Mette Holm, la mia traduttrice danese, ho letto solo recentemente L’Ombra, storia scritta da Hans Christian Andersen: era sicura che l’avrei trovata interessante. Prima di leggerla, non avevo proprio idea che Andersen avesse scritto storie simili. Leggendo la traduzione giapponese de L’Ombra, ho trovato la trama intensa e spaventosa. La maggior parte dei giapponesi pensa che Andersen abbia scritto solo fiabe per bambini. Invece, sono rimasto sbalordito nello scoprire che avesse scritto un racconto così cupo e senza speranza.
La domanda mi è sorta spontanea: «Perché ha sentito la necessità di scrivere una storia del genere?». Il protagonista è un giovane, che lascia la madrepatria nel nord del paese e va verso una terra straniera a sud. Lì succede qualcosa di inatteso: perde la propria ombra. È turbato e confuso ma, alla fine, riesce a ricreare una nuova ombra e torna a casa sano e salvo. In seguito, però, l’ombra perduta torna da lui: nel frattempo era diventata più saggia, più potente e anche indipendente; da un punto di vista finanziario e sociale era ora molto più affermata del suo vecchio padrone. In altre parole, l’ombra e il suo ex padrone si erano scambiati di posto. Ora l’ombra era il padrone e il padrone l’ombra.
A questo punto, l’ombra si innamora di una meravigliosa principessa proveniente da un’altra terra e diventa il re di quella terra. Il suo vecchio padrone, l’unico a conoscenza del suo passato di ombra, viene assassinato. L’ombra gli sopravvive e ottiene un grande successo, mentre il suo vecchio padrone, l’essere umano, si estingue tristemente.
Non ho idea di quali fossero i lettori che avesse in mente Andersen quando scrisse questo racconto. Penso però che in esso sia percepibile come Andersen, scrittore di fiabe, decise di abbandonare l’ambito nel quale aveva lavorato fino ad allora e cioè le fiabe per bambini, e aveva preso a prestito lo schema dell’allegoria per adulti e tentato audacemente di riversarvi il suo cuore di individuo libero.
E a questo punto vorrei parlare di me. Io non pianifico la trama mentre scrivo un romanzo. Quando scrivo un romanzo, il mio punto di partenza è sempre una singola scena o un’idea. Poi, a mano a mano che scrivo, lascio che questa scena o idea si sviluppi da sola. Mentre scrivo, sono il testimone di ciò che accade. Dunque, per me scrivere un romanzo è un viaggio di scoperta, proprio come dei bambini che ascoltano una storia e che, impazienti, si chiedono come andrà a finire.
Mentre leggevo L’ombra, la prima impressione che ho avuto è stata che anche Andersen scriveva per “scoprire” qualcosa. Ho l’impressione che gli fosse venuta l’idea della tua ombra che ti lascia e ha usato tale idea come punto di partenza per scrivere la storia e l’ha scritta senza sapere come sarebbe andata a finire.
La maggior parte dei critici moderni e anche molti lettori hanno la tendenza a leggere le storie in maniera analitica. Vengono formati dalla scuola, o dalla società, che fa credere loro che questo sia il metodo di leggere più corretto. La gente analizza e fa recensioni dei testi da un punto di vista analitico, o sociologico o anche psicoanalitico. Il fatto è che, se un romanziere dovesse tentare di scrivere una storia in modo analitico, l’intrinseca vitalità della storia andrebbe perduta. Non si creerebbe nessuna empatia tra lo scrittore e i lettori. Spesso succede che i romanzi che mandano i critici in visibilio non piacciono molto ai lettori, ma altrettanto spesso i lavori che i critici ritengono eccellenti dal punto di vista analitico non riescono a conquistare la naturale empatia dei lettori.
Ne L’ombra di Andersen, si vedono tracce di un viaggio alla ricerca di sé stesso che respinge quel tipo di facile analisi. Questo non può essere stato un viaggio agevole per Andersen, dato che si trattava di scoprire e di vedere la propria ombra, il lato oscuro di sé stesso che avrebbe voluto evitare di guardare. Ma da scrittore onesto e accurato, Andersen ha affrontato quell’ombra in modo diretto, nel bel mezzo del caos, ed è andato avanti senza paura.
Quando scrivo un romanzo, mentre attraverso l’oscuro tunnel della narrazione, incontro una visione totalmente inaspettata di me stesso, che deve essere la mia ombra. A questo punto, ciò che mi viene richiesto è di descrivere questa ombra nel modo più accurato e sincero possibile, senza distogliere lo sguardo da es- sa, senza analizzarla in maniera logica; piuttosto, la devo accettare come una parte di me stesso. Tuttavia, non sarebbe giusto arrendersi al potere di questa ombra. La devi assorbire questa ombra e, senza perdere la tua identità di persona, la devi interiorizzare come una parte di te stesso. Devi condividere con i tuoi lettori tale procedimento, tale sensazione.
Nel Diciannovesimo secolo, quando è vissuto Andersen, e nel Ventunesimo, il nostro, dobbiamo, quando necessario, affrontare le nostre ombre, sfidarle e, a volte, anche lavorare con esse. Ciò richiede il giusto tipo di saggezza e coraggio. Certo, non è compito facile. A volte sorgono dei pericoli. Ma se le persone evitano le ombre, potrebbero non crescere e maturare nel modo corretto. Oppure, ancora peggio, potrebbero finire come lo studioso nella storia L’ombra, distrutte dalla propria ombra.
Non devono essere solo gli individui ad affrontare le proprie ombre. Proprio come gli individui, anche le società e le nazioni hanno le loro ombre. Se da una parte vi sono gli aspetti luminosi, come contraltare, vi saranno quelli oscuri. Se vi è un lato positivo, ci sarà anche quello negativo.
A volte tendiamo a distogliere gli occhi dall’ombra, cioè da quelli che sono i nostri aspetti negativi. Oppure tentiamo di eliminare quegli aspetti a tutti i costi. Ciò perché le persone vogliono evitare il più possibile di guardare al proprio lato oscuro, ai propri difetti. Tuttavia, affinché una statua sembri solida e tridimensionale, le ombre sono necessarie: eliminare le ombre conduce solo a una piatta illusione. Una luce che non genera ombre non è una vera luce.
Per quanto alto sia il muro che tiriamo su per tenere fuori gli intrusi, per quanto escludiamo gli estranei, per quanto riscriviamo la storia adattandola ai nostri desideri, non riusciamo a fare altro che danneggiare e ferire noi stessi. Con pazienza dobbiamo imparare a vivere con la nostra ombra. E a osservare il nostro lato oscuro. A volte, in un tunnel buio, sei costretto ad affrontare i tuoi aspetti negativi. Se non lo fai entro breve, la tua ombra crescerà sempre più forte e, una notte, tornerà a bussare alla tua porta e ti sussurrerà: «Sono tornata». Le storie eccezionali possono insegnarci molte cose. Ci insegnano lezioni che vanno oltre il tempo, le varie epoche e culture.
Traduzione di Assia Rosati
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- E nella cellula arrivò la luce. Intervista a Martin Chalfie30 ottobre 2016
Il Nobel Martin Chalfie
E nella cellula arrivò la luce
intervista di Matteo Marini (la Repubblica, 30.10.2016)
Se oggi riusciamo a guardare dentro a una cellula, a vedere la vita nel momento in cui accade, lo dobbiamo anche a Martin Chalfie, biologo statunitense della Columbia University, che assieme ai colleghi Osamu Shimomura e Roger Y. Tsien ha scoperto la Green fluorescent protein. Ricavata dalla medusa Aequorea victoria, è una sostanza usata come marcatore per osservare i processi che avvengono all’interno delle cellule.
 Al Festival della Scienza il 5 novembre il biologo racconterà la sua rivoluzione luminescente, che gli ha fatto vincere il premio Nobel per la chimica nel 2008.
Al Festival della Scienza il 5 novembre il biologo racconterà la sua rivoluzione luminescente, che gli ha fatto vincere il premio Nobel per la chimica nel 2008.Quali progressi ha favorito la Gfp?
«Ci ha permesso di osservare la vita in tessuti sani e viventi: come le cellule interagiscono l’una con l’altra, in che modo i virus e i batteri o le cellule tumorali interagiscono con i tessuti nel tempo e non, come prima, facendo congetture su campioni morti, preparati in laboratorio. L’Hiv, per esempio, si propaga internamente alla cellula e gli anticorpi non possono attaccarlo. Ora possiamo osservare tutto questo mentre succede. Se puoi vedere qualcosa, puoi anche studiarla».
Quali innovazioni si aspetta in biologia e medicina?
«Roger Y. Tsien, una delle persone che ha diviso il Nobel con me, è morto lo scorso agosto. Stava lavorando su una proteina per identificare le cellule tumorali. Se anche piccoli numeri di cellule tumorali fossero marcati con la fluorescenza e si potessero vedere, il chirurgo potrebbe rimuoverli. Spero che il lavoro di Tsien sia portato avanti. Inoltre stiamo assistendo a una sorprendente rivoluzione basata sulla sequenza genetica che, penso, sarà fondamentale nella comprensione della biologia umana e per lo sviluppo di medicine “personalizzate” anche per pazienti affetti da sindromi rarissime. Temo però che per le case farmaceutiche queste cure non siano abbastanza remunerative per giustificarne lo sviluppo».
A che punto è la ricerca su sviluppo e funzioni delle cellule nervose?
«Noi studiamo le cellule nervose del tatto in alcuni animali, come interagiscono col mondo. La nostra è biologia di base, non lavoriamo su malattie specifiche ma speriamo possano essere utili nel futuro. La Gfp ha condotto a risultati che nemmeno potevo immaginare».
Uno studio pubblicato su “Nature” fissa a 122 anni il limite di vita per l’uomo. È una soglia superabile?
«Molti problemi che abbiamo oggi riguardano un’età molto precedente ai 122 anni: parlo del fumo, dell’obesità in alcune parti del mondo e della malnutrizione in altre. E poi di due miliardi di persone che soffrono delle cosiddette “malattie tropicali neglette”. Una volta risolti questi problemi potremo preoccuparci se possiamo arrivare a 122 anni».
Qual è la sua opinione riguardo all’eutanasia?
«Ci sono tante persone che soffrono di malattie orribili e non vogliono vedere se stessi percorrere una strada di decadimento inevitabile. Penso che una persona debba essere in grado di morire con dignità».
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE -- "Per Monstra Ad Sphaeram": Warburg e la "Sphaera Barbarica" (di Mario Cobuzzi).28 ottobre 2016, di Federico La Sala
- ORIENTARSI, OGGI - E SEMPRE. LA LEZIONE IMMORTALE DI KANT, DALLA STIVA DELLA "NAVE" DI GALILEI. Invito alla rilettura dell’opera del 1786, "Che cosa significa orientarsi nel pensiero" - e della "Critica della ragion pura" (1781/1787).
- KANT, NEWTON, E POPE. Note (di avvio) per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
Warburg e la "Sphaera Barbarica"
di Mario Cobuzzi *
- Uomo zodiacale, Livre d’ Heures Chantilly
Per Monstra Ad Sphaeram è un volume pubblicato da Abscondita e curato da Davide Stimilli e Claudia Wedepohl, che raccoglie un corpus notevole di lettere, appunti, scritti di vario genere di Aby Warburg, risalenti ai suoi ultimi anni di vita. E’ un libro curato in maniera eccelsa, ricco di note esplicative e con una utilissima postfazione di Stimilli; se quella di Warburg è una figura che vi affascina, non potete perderlo: addirittura, basterebbe la sola presenza del saggio di cui voglio parlarvi in questo post per giustificare ampiamente i 20 euro spesi.
Infatti L’effetto della “Sphaera Barbarica” sui tentativi di orientamento cosmici dell’occidente, che lo studioso scrisse nel 1925 come conferenza in onore del suo amico recentemente scomparso, Franz Boll, è un saggio straordinario, affascinante oltremodo; soprattutto, esso si presenta come summa del pensiero warburghiano, di quel problematico e fondamentale metodo di studio che ha segnato la nascita dell’iconologia.
In queste poche pagine si affacciano infatti i problemi principali della biografia intellettuale dello studioso: come da titolo del saggio, l’ Orientamento; l’astrologia e la migrazione delle immagini; la rinascita degli antichi dèi e quindi, di conseguenza, il tema del Nachleben (Sopravvivenza); in ultimo, il non meno fondamentale e affascinante Spazio del pensiero.
- F. Del Cossa, Mese di Marzo, 1467-70, Palazzo Schifanoia, Ferrara
L’apertura ricorda quella del saggio su Schifanoia del ’12, perché anche qui Warburg sembra giustificarsi[1]: «A una linea di ricerca che si occupa di arte e di Rinascimento italiano [i corsivi sono di Warburg], nulla sembra più estraneo che la discesa nelle oscure regioni della superstizione tardo-antica. Il bello in sé, e l’antico che emerse per gli italiani nell’epoca della rinascita come guida verso una formazione ideale più elevata, sembrano avere nel fatalismo astrologico addirittura il loro più riottoso avversario.- Ma si tratta di un’osservazione solo superficialmente azzeccata!»
Il Nostro dunque rivaluta l’astrologia come pratica positiva per lo sviluppo del Rinascimento, «poiché se si intende l’illuminismo che la riscoperta dell’antichità classica portò all’Europa [...], allora proprio l’antico che si impose, demonicamente deformato nell’astrologia, come oggetto di culto, offre allo storico della cultura l’opportunità di comprendere chiaramente la restaurazione dell’antichità classica come il risultato di un tentativo di liberazione della personalità moderna dall’incantesimo della pratica magico-ellenistica».
Importante e problematico quest’ultimo passaggio: l’antichità classica si scinde in due fazioni; da un lato l’autentica classicità umanistica e razionale ripresa nel Rinascimento, dall’altra quella ellenistica, irrazionale e mostruosa. Infatti «è la stessa scienza matematica della Grecia, che venne ripristinata nel corso del Rinascimento alle sue forme originarie, a offrire all’uomo europeo l’arma per lottare contro i demoni provenienti dalla Grecia, o meglio dalla Grecia asiatica».
- F. del Cossa, Particolare del mese di Aprile: il secondo decano del toro
Ecco dunque (e qui veniamo a uno dei motti più affascinanti e famosi di Warburg[2]) che «l’Atene greca vuol sempre di nuovo essere liberata dall’Alessandria arabizzante».
L’astrologia diventa quindi determinante sia perché «nel caso della dottrina del cielo si ha a che fare con il più ampio problema dell’orientamento spirituale di contro all’universo», sia perché, per quanto riguarda gli affreschi di Palazzo Schifanoia a Ferrara, «la curiosità del fatto che un astrologo arabo del IX secolo, 600 anni più tardi, dettasse ancora il programma iconografico a un pittore del Rinascimento, non ci esime dall’obbligo di intendere questo processo come un anello organico nell’evoluzione stilistica complessiva della cultura del Rinascimento»; inoltre «tutto ciò che appare stasera [nella conferenza, cioè] in testimonianze, note e ignote, in parola e immagine, mostra l’uomo che osserva in lotta per lo spazio del pensiero».
Così, come dicevo prima, il tema dell’astrologia permette a Warburg di riprendere i fili principali del suo ampio affresco teorico: l’Orientamento, la cultura rinascimentale, lo Spazio del Pensiero.
E non solo: «oscillando tra posizione di causa figurativa mitologica e numericamente calcolabile, le costellazioni hanno per lui [l’Uomo] [...] un carattere ambivalente, polarizzato, che da un lato esige venerazione cultuale nella pratica magica, e dall’altro ha il valore di una determinazione di estensione distaccata e oggettiva per gli oggetti rilucenti nello spazio dell’universo, nella volta del cielo».
Qui, chiaramente, Warburg mette in campo l’altro suo grande tema, quello della Polarità.
- Raffaello, Scuola di Atene, Stanza della Segnatura, 1508-11
Polarità riscontrabile, come è noto, a Schifanoia: se infatti in «Francesco Cossa si fa avanti una specie di umanità emancipata sotto il segno dell’ antichità autentica, [...] i restanti affreschi, grazie alla troppo erudita ispirazione del consigliere Pellegrino Prisciani, vengono ostacolati nell’ascesa alla divinità olimpica dalla mostruosità demonica».
Ma queste oscillazioni, nella visione del Rinascimento di Warburg, sono destinate a risolversi: «Nella Scuola di Atene di Raffaello non vi è più traccia di un tale valore d’espressione simbolico del complesso agonale mostruoso [riscontrabile, per lo studioso, nella cultura della Firenze medicea]. La profonda calma dell’Accademia greca pervade la sala. La dea Atena si cela nell’ombra della nicchia e tuttavia sporge dallo sfondo. Per monstra ad sphaeram! Dalla terribilità del monstrum alla contemplazione nella sfera ideale della meditazione paganamente dotta. E’ questo il percorso nella evoluzione culturale del Rinascimento».
E non è finita qui: una tale razionalizzazione umanistica riguarda anche le pratiche religiose, nel momento in cui esse passano dal sacrificio umano a pratiche «più semplici»- qui è evidentemente ripreso uno dei temi cardine de Il rituale del serpente [3].
Insomma, spero che questi pochi e riduttivi accenni possano avervi fatto capire quanto questo saggio sia ricco, complesso, affascinante: è una lettura di cui non vi pentirete! Per concludere, vi lascio con un accenno al programma metodologico su cui si basa la ricerca di Warburg, per come lo stesso studioso la espone (forse in termini un po’ semplicistici ed eccessivamente “umili”) al termine della conferenza: -«L’orientamento cosmico per immagini dell’uomo europeo nel XV secolo: un capitolo di storia della cultura nell’epoca della rinascita dell’antichità, così si potrebbe designare lo schizzo che stasera ci è passato davanti in rapida successione. [...] Il procedimento quivi seguito tecnicamente non è nuovo: presupposta molta pazienza, abbiamo bisogno solo nel buon vecchio stile di una fidata esegesi filologica - ermeneutica more majorum -, per guadagnare un orizzonte più ampio».
 [1] Per un discorso generale sullo stile di scrittura di Warburg vi segnalo questo bel saggio di Katia Mazzucco pubblicato su Engramma - un sito che vi consiglio caldamente di visitare!
[1] Per un discorso generale sullo stile di scrittura di Warburg vi segnalo questo bel saggio di Katia Mazzucco pubblicato su Engramma - un sito che vi consiglio caldamente di visitare!
 [2] Già presente, in forma diversa, in almeno un altro saggio, Divinazione antica pagana in testi ed immagini dell’età di Lutero, del 1920.
[2] Già presente, in forma diversa, in almeno un altro saggio, Divinazione antica pagana in testi ed immagini dell’età di Lutero, del 1920.
 [3] Adelphi 1998
[3] Adelphi 1998* Appunti di storia dell’arte, 8 ottobre 2012 - ripresa parziale, senza foto.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA -- CRUCIVERBA ed ENIGMISTICA: ANAGRAMMA. Un omaggio a Edipo.9 ottobre 2016, di Federico La Sala
CRUCIVERBA ed ENIGMISTICA.
"Dal metodo non nasce niente": un omaggio a Edipo, "Il mancino zoppo" (Michel Serres)
Pur sapendo a quali "pericoli" ("So benissimo...") andava incontro, il prof. Polito, ha aggiunto CORAGGIOSAMENTE al "mosaico sempre in fieri" (vale a dire, in cammino!) una "tessera" e, pur sapendo di ERMETE TRISMEGISTO, ha aperto - SENZA VOLERLO - non solo (come ha fatto alla fine dell’articolo) la porta della CATTEDRALE DI SIENA, ma anche la porta della CAPPELLA SISTINA (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5195)!!!
CON un semplice ANAGRAMMA ("Serpente? Presente!": http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/10/04/serpente-presente/) ha sollecitato a riconsiderare e a riguardare tutte le tessere del MOSAICO. A questo punto, però, non è più solo un "gioco di parole"! Ora, non si sono solo Apollo, Pitone, le Sibille, e le Muse, c’è anche MOSÈ e MICHELANGELO - e FREUD ("Mosè e la religione monoteistica": http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829).
C’è il richiamo a tutto l’immaginario biblico e, in particolare, alla interpretazione di Michelangelo della vicenda del SERPENTE DI BRONZO, racchiuso nel "pennacchio" della Volta della Cappella Sistina - https://it.wikipedia.org/wiki/Serpente_di_bronzo_(Michelangelo): il richiamo a un ALTRO serpente, "all’amico serpente" - "al sulfureo amico" -"all’amico ritrovato"!!!
ENIGMI: CRUCI-VERBA!!! A MEMORIA, e ad evitare EQUIVOCI, è BENE ricordare che i "verba volant"!!! Se, e solo se, le parole, i "VERBA" sono agganciati alla croce ("CRUCI"), al "palo", al "bastone" - alla "colonna vertebrale" della propria persona, diventano "scripta", parole scritte, parole degne di essere ricordate - scrittura, Scrittura!!! Altrimenti, sono solo parole al vento di serpenti impazziti - in un mare di sabbia!!!
Federico La Sala
-
> LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- "SERPENTE? PRESENTE!" UNA NOTA A MARGINE DI UN RICCO E BRILLANTISSIMO LAVORO.4 ottobre 2016, di Federico La Sala
"SERPENTE? PRESENTE!"
UNA NOTA A MARGINE DI UN RICCO E BRILLANTISSIMO LAVORO*
SERPENTE? PRESENTE! Proprio un brillantissimo (http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/10/04/serpente-presente/) excursus!!! In segno di ringraziamento, mi permetto di rendere onore a Ermete Trismegisto (cfr. note al seguente art.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/06/10/iapige-fantomatico-progenitore-salentini/) e di aggiungere - a questa del prof Polito - un’altra tessera al "mosaico sempre in fieri".
RICORDANDO CHE "l’abitudine non può rendere insipida la varietà infinita della bellezza" - prodotta dalla LUCE - e, RENDENDO OMAGGIO alla "Analisi della Bellezza" di Hogarth, metto a disposizione della riflessione alcune note di "epistimologia geneSica" (dove la "S", maiuscola, sta a dire proprio della "serpentina" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5794) e della necessità di aprire gli occhi e saper distinguere (cfr. note all’art.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/09/26/la-terra-dotranto-mappa-delleuropa-del-secolo-xvi/) tra la "serpentina" di Salomone" e le "serpentine" di salsicce di "Salamone".
*
I MIEI PIù VIVI COMPLIMENTI ALL’AMICO SERPENTE, AL PROF. ARMANDO POLITO, E AL LAVORO DELLA FONDAZIONE!!!
Federico La Sala
-
>"Note per una epistemologia genesica" --- Perché Einstein non portava i calzini. Il cervello di Einstein «fuori scatola» (di Giorgio Dell’Arti)20 settembre 2016, di Federico La Sala
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
Il cervello di Einstein «fuori scatola»
di Giorgio Dell’Arti (Il Sole-24 Ore, 19.09.16
Cranio. Albert Einstein desiderava essere cremato. Quando morì, invece, il patologo Thomas Harvey, in gran segreto, operò un taglio sopra la fronte, asportò il cuoio capelluto, prese un seghetto e gli aprì il cranio. Il cervello fu poi riprodotto in 240 pezzi di un centimetro cubo.
Cervello. Il cervello di Einstein, 145 grammi in meno rispetto a quello di un uomo di pari corporatura.
Gravità. Einstein iniziò a pensare a una teoria della gravità il giorno in cui si mise a riflettere sul fatto che una persona, in caduta libera, non avverte il proprio peso.
Espressioni. L’uomo può dare forma a diecimila espressioni facciali.
Felicità. «A volte la tua felicità è l’origine del tuo riso, altre volte il contrario» (Thích Nh?t H?nh, maestro di buddismo).
Rallegriamoci. In Israele si pratica uno speciale tipo di danza in cerchio detta Hava Nagila, che tradotto significa “rallegriamoci”. A migliorare l’umore dei partecipanti sono i movimenti in verticale e i salti verso l’alto. Questa tecnica è stata anche sperimentata dalla psicologa Sabine Koch per curare i pazienti malati di depressione.
Battito. Il battito cardiaco dei coristi tende a sincronizzarsi con la musica e a raggiungere la stessa frequenza.
Temperatura. La temperatura del volto di due persone che casualmente si toccano aumenta da 0,1 a 0,3 gradi.
Freddo. Due psicologi dell’Università di Toronto avvalendosi di 65 studenti hanno dimostrato che la solitudine fa sentire “freddo”: «Chi aveva ripensato a un’esperienza di esclusione sociale sentiva la stanza notevolmente più fredda di chi aveva evocato delle esperienze positive. Il solo pensiero di essere tagliati fuori aveva raffreddato la percezione soggettiva degli interessati».
Memoria. Nella sua autobiografia lo scrittore austriaco di origini ebree Stefan Zweig descrive così la memoria: «Quello che un uomo ha assorbito durante l’infanzia dell’aria del suo tempo rimane in lui [...]. Anche dagli abissi dell’orrore nel quale noi oggi ci muoviamo, semiciechi, a tastoni, con l’animo sconvolto e dilaniato, io torno pur sempre ad alzare lo sguardo verso le antiche costellazioni che scintillavano nel cielo della mia infanzia e mi conforto con la fede innata che un giorno questa nostra ricaduta debba apparire soltanto un intervallo nel ritmo eterno del continuo progredire».
Sport. Alle ragazze sono sufficienti 12 minuti al giorno di sport per trarre benefici nel rendimento scolastico, soprattutto nelle materie scientifiche. Ai ragazzi ne servono 17, cinque in più. Idea. Secondi necessari alla mente umana per formarsi un’idea su una situazione: duecento millisecondi (Maja Storch)
Scatola. Per verificare la fondatezza dell’espressione outside the box, cioè pensare fuori dal comune, fu chiesto a un gruppo di persone di sedersi dentro uno scatolone di un metro e mezzo per un metro e mezzo e ad altri di restarne fuori. «Il risultato confermò la fondatezza dell’espressione inglese: [...] chi pensava “fuori dalla scatola” proponeva delle soluzioni molto più creative di chi stava dentro».
Cammino. «Se osserviamo bene una persona che cammina», scrive lo scrittore austriaco Thomas Bernhard, «sapremo anche come pensa. Se osserviamo bene una persona che pensa, sapremo anche come cammina. Se osserviamo a lungo e attentamente una persona che cammina, ci avvicineremo sempre di più al suo pensiero, alla struttura della sua mente».
*
Notizie tratte da: Christian Ankowitsch, Perché Einstein non portava i calzini. Come dettagli (apparentemente) insignificanti influenzano il nostro pensiero, Vallardi, Milano, pp. 238, 14,90 euro.
-
> LA LUCE, LA TERRA... AI POETI "LUNATICI" E AI FILOSOFI "SOLARI"--- NOTE SUL PROBLEMA MENTE-CORPO. Perché Einstein non portava i calzini. Che cosa potete aspettarvi da questo libro (di Christian Ankowitsch)20 settembre 2016, di Federico La Sala
Estratto dal libro “Perchè Einstein non Portava...
Foglietto illustrativo: che cosa potete aspettarvi da questo libro e che cosa potete (o non potete) fare con il suo aiuto
DI CHRISTIAN ANKOWITSCH *
Quando andate in farmacia e comprate una scatola di compresse, al suo interno troverete il bugiardino, dove c’è scritto a che cosa servono le pillole e quali effetti collaterali possono avere.
Perché non lo mettono anche nei libri? È un’ottima domanda. Così ho deciso di rompere il ghiaccio, anche se il mio foglietto illustrativo non si basa su approfonditi studi clinici, ma è il semplice tentativo dello scrittore di informare il lettore sulle proprie intenzioni.
Dunque, che cosa potete aspettarvi da questo libro? Esso vi offrirà una sorprendente spiegazione su come noi esseri umani sentiamo, pensiamo, decidiamo e agiamo.
La teoria centrale è la seguente: il nostro cervello non lavora in modo indipendente e autoreferenziale, come si è sempre affermato. Viceversa, è influenzato in modo determinante dal nostro corpo, dall’ambiente esterno e da situazioni concrete (e a sua volta il cervello influenza questi elementi in uno scambio continuo).
Concretamente significa, per esempio, che troviamo soluzioni migliori se gesticoliamo o che abbiamo idee vincenti quando ci troviamo in una stanza con il soffitto alto.
Questo libro vi offre inoltre numerosi spunti per migliorare la vostra vita grazie a strategie semplici, di facile attuazione, efficaci, rapide ed eleganti. Si potrebbero anche chiamare «astuzie», anche se questo termine non suona bene.
Molti di questi suggerimenti riguardano il corpo; per esempio, se ridete senza motivo vi sentirete più felici e se avete una postura eretta vi sentirete più sicuri di voi stessi. Possono sembrare suggerimenti banali e persino scontati, e un po’ lo sono. Eppure funzionano e sono scientificamente provati.
Sicuramente non sono frutto della mia fantasia, ma sono documentati da fonti sicure e attendibili. Da parte mia, ho cercato di presentare l’argomento nel modo più divertente possibile. Nelle note sono specificate le fonti delle teorie e dei consigli dati. Ma non preoccupatevi: non sarete costretti a leggere pagine e pagine stampate in caratteri microscopici per poter seguire il filo del discorso. Le note sono solo una garanzia di autenticità, se avete qualche dubbio in merito. Vale comunque la pena dar loro un’occhiata perché possono contenere informazioni interessanti.
Voglio dire ancora una parola ai lettori, che tante volte ho immaginato di trovarmi di fronte durante la stesura di questo libro: me li figuravo mentre si divertivano a capovolgere le loro convinzioni intuitive, provando e riprovando, e mentre abbandonavano l’idea che l’intelligenza dipendesse da un cervello ben allenato. Questa convinzione, pur essendo molto diffusa, è assolutamente falsa, per il semplice fatto che il nostro cervello non è un muscolo che possiamo allenare in palestra.
Il nostro cervello è un organo altamente complesso, un maestro delle connessioni, il cui lavoro è enormemente influenzato dal nostro corpo. Per compiere un simile miracolo valgono leggi diverse da quelle che funzionano per un semplice bicipite.
I suggerimenti forniti in questo libro sono concepiti per lettori in buona salute. Non bastano invece per risolvere problemi più seri! Per esempio, anche se ho dimostrato che saltando dal trampolino si possono ridurre gli stati depressivi, sarebbe assurdo sperare di curare definitivamente la malattia in questo modo. Per riuscirci, è necessario l’intervento di un professionista: i libri non bastano, è meglio rivolgersi a uno psicoterapeuta con esperienza o a un medico.
A questo punto, non mi resta che augurarvi una spassosa e proficua lettura.
Il vostro dottor Ankowitsch
P.S.: Qualcuno potrebbe chiedersi come mi è venuta l’idea di scrivere questo libro. Ebbene, molti anni fa lessi un breve articolo sulla «Neue Zurcher Zeitung»,- in cui si diceva che la nostra intelligenza non dipende soltanto da quanto siamo bravi a far di conto, ma anche dalla posizione delle nostre braccia, e che il nostro corpo la dice lunga su come ci sentiamo, pensiamo e agiamo.
Da allora quell’idea non mi ha più abbandonato. Senza rendermene conto, ho iniziato a fare delle ricerche raccogliendo articoli di giornale, studi e libri che affrontavano la questione del rapporto fra il corpo e la mente. Ancora oggi conservo articoli sull’argomento e salvo pagine Internet che promettono risposte stupefacenti. Lo faccio anche se il libro è finito, chissà, non si può mai sapere. Perchè Einstein non Portava i Calzini
Perchè Einstein non portava i Calzini
Lo sapevate che può bastare una breve passeggiata per favorire l’attenzione e sviluppare idee originali? Che chi ride, anche senza motivo, diventa di fatto più allegro? Che le idee vincenti ci vengono più facilmente in una stanza con il soffitto alto e che, se abbiamo in mano una tazza calda, siamo più bendisposti verso le persone intorno a noi?
Questo succede perché il nostro cervello non lavora in modo indipendente e autoreferenziale, come si è sempre affermato, ma è influenzato in modo determinante dal nostro corpo, dall’ambiente esterno e dalle situazioni concrete.
* CHRISTIAN ANKOWITSCH nato in Austria, dopo gli studi universitari e il PhD, è stato redattore del settimanale tedesco «Die Zeit». Attualmente vive a Berlino, dove è giornalista e scrittore di successo. Dal 2011 conduce la trasmissione letteraria «les.art» alla televisione austriaca e dal 2013 presenta il prestigioso Premio Ingeborg Bachmann.
* FONTE: MACROLIBRARSI
-
>LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- Il buon uso dell’incertezza: "La scienza sa di non sapere: per questo funziona" (di Vincenzo Barone)31 luglio 2016, di Federico La Sala
SCIENZA E FILOSOFIA
Il buon uso dell’incertezza
di Vincenzo Barone (Il Sole-24 Ore, 31 luglio 2016)
Lungi dall’essere sintomi di una qualche forma di insufficienza, dubbio e incertezza rientrano nella normale fisiologia dell’impresa scientifica. Lo ricordava, con la consueta incisività, il fisico teorico Richard Feynman in una conferenza del 1955, citata dall’immunologa Maria Luisa Villa in un suo recente saggio, il cui titolo non potrebbe essere più esplicito, La scienza sa di non sapere: per questo funziona [Guerini e Associati, Milano, pagg. 144, e. 12,50]: «Quando lo scienziato - diceva Feynman - non sa la risposta a una domanda, è ignorante. Quando ha una vaga idea del probabile risultato, è incerto. E quando è sicuro del risultato, maledizione, gli rimane ancora qualche dubbio. [...] La conoscenza scientifica è un insieme di dichiarazioni a vari livelli di certezza, alcune quasi del tutto insicure, altre quasi sicure, ma nessuna assolutamente certa. Noi scienziati ci siamo abituati, e diamo per scontato che sia perfettamente coerente non essere sicuri [...]. Non so però se tutti ne siano consapevoli».
Come spesso capita, la scienza ha tramutato un apparente elemento di debolezza in un punto di forza, e una proprietà negativa in «un fascio di qualità neutrali o decisamente positive». Lo ha fatto innanzitutto sviluppando potenti metodi di valutazione quantitativa dell’incertezza (ne parla diffusamente Marco Li Calzi in un libro divulgativo appena uscito per il Mulino, La matematica dell’incertezza); e poi ideando delle procedure efficaci per ottenere risultati e previsioni «ragionevolmente certi», cioè tali che il loro grado di incertezza, comunque non nullo, sia ridotto al minimo e segni il confine dei dominî dell’esperienza temporaneamente inesplorati.
Feynman nel 1955 sospettava che non tutti fossero consapevoli di questi aspetti - come al solito controintuitivi - della conoscenza scientifica. Sessant’anni di rapporti sempre più intensi e spesso conflittuali tra scienza e società ci hanno insegnato che il suo sospetto era fondato e persino ottimistico: la maggioranza del pubblico continua a ritenere che la scienza debba fornire certezze assolute e, constatando che non lo fa, la giudica difettosa. La mancanza di certezza si traduce allora perversamente nella facoltà di dubitare di tutto. Ma se è vero che la scienza si nutre di disaccordi, è altrettanto vero che essa tende a raggiungere un consenso basato su una valutazione critica delle prove, perché l’unica autorità che ammette è «quella della conoscenza convalidata dalle conferme fattuali».
Lo scetticismo, che fa parte del bagaglio intellettuale dello scienziato, non va dunque confuso con la negazione dell’evidenza, e le teorie scientifiche non possono essere messe sullo stesso piano delle opinioni o delle credenze personali. La confusione al riguardo - abilmente sfruttata da quelli che gli storici della scienza Naomi Oreskes e Erik Conway hanno chiamato in un loro libro (Merchants of Doubt, Bloomsbury Press, 2010) «mercanti del dubbio» - alimenta molte delle cosiddette «controversie scientifiche» di cui sentiamo parlare e che il più delle volte sono pseudocontroversie, dispute fittizie che contrappongono conoscenze e saperi consolidati a punti di vista minoritari, o addirittura isolati, di soggetti portatori di precisi interessi. Si pensi al confronto di qualche anno fa tra creazionisti ed evoluzionisti, alle ricorrenti polemiche sugli OGM e sul cambiamento climatico, o, per stare alla stretta attualità, alla questione del presunto legame tra vaccini e autismo, su cui personaggi incompetenti e litigiosi sono messi di fronte a esperti veri per pura convenienza giornalistica (le provocazioni, come è noto, fanno più audience dei ragionamenti pacati).
Giustamente Villa sottolinea che l’alfabetizzazione scientifica, da molti invocata, non deve essere intesa come l’acquisizione di conoscenze approfondite in merito a tutte le questioni scientifiche - e sono tante - su cui, da semplici cittadini, siamo sempre più spesso chiamati a formarci un’opinione e a pronunciarci.
Ciò che davvero conta è comprendere che «lo sviluppo della scienza ha al suo centro una cultura dell’evidenza e della fiducia critica, codificata nel controllo reciproco tra i membri della comunità scientifica». Solo questa consapevolezza può fornire alla società gli anticorpi per combattere non soltanto le persistenti forme di oscurantismo antiscientifico, ma anche le retoriche di chi usa una scienza dimezzata e distorta per propagandare ideologie.
-
>LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- L’indagine riguarda tutti. Siamo liberi? Yes, Edipo, we can (di Mauro Bonazzi)3 luglio 2016, di Federico La Sala
Siamo liberi? Yes, Edipo, we can
Il vero complesso non è quello indagato dalla psicoanalisi e definitivamente entrato nel nostro immaginario con Freud
Il vero complesso è quello dell’uomo di fronte a se stesso e alla storia: ciò che ci fa grandi non sono le risposte che troviamo ma le domande che ci poniamo
Al di là delle scoperte delle neuroscienze
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 03.07.2016)
Perché Edipo, subito dopo che si è strappato gli occhi con le sue proprie mani, accusa Apollo, lo incolpa di tutto quello che gli è successo? Sono lontani i tempi in cui il romanzo giallo era considerato un genere minore. Di sicuro è quello più adatto alla filosofia: in entrambi i casi si tratta di ricomporre una trama, di cercare il disegno che si cela dietro al disordine apparente. L’ordine magari non sarà quello auspicato ma comunque esiste, come ne Il giorno della civetta di Sciascia, in cui il commissario Bellodi riporta alla luce il sistema di corruzione e connivenze che permette ai tanti don Mariano Arena di prosperare sul «bosco di corna» dell’umanità.
A volte invece il giallo serve a mettere in crisi l’illusione dell’ordine, rivelando che il mondo è dominato dalla confusione. Come ne La promessa di Friedrich Dürrenmatt: paziente, meticoloso, ostinato il commissario Matthäi ha capito tutto, sa dove l’assassino colpirà la prossima volta: si apposta, ma l’attesa durerà tutta la vita (il commissario si licenzia e si mette a fare il benzinaio in una sperduta piazzola di servizio perché sa che è lì che tutto deve accadere), inutilmente, perché la sua preda, l’assassino in viaggio per il delitto, è morta in un banale incidente automobilistico. Era tutto giusto, il commissario aveva compreso, il disegno era quello, ma la realtà è governata dal caso: ogni tentativo di controllo razionale del disordine, ogni progetto di riduzione del caos a cosmo, è destinato allo scacco. Matthäi però continua ad aspettare, mentre la luce del sole si dispiega su un mondo sempre più incomprensibile.
Il dio della luce, in Grecia, era Apollo. Edipo, invece, è l’archetipo del detective, e la tragedia di Sofocle che racconta la sua vicenda, l’ Edipo re, è il modello ineguagliato del romanzo giallo. Un investigatore, intelligente, caparbio, implacabile, è sulle orme di un assassino. Laio, il re di Tebe, è stato ucciso, e Edipo, il nuovo re, vuole fare giustizia. Raccoglie gli indizi, ascolta i testimoni, ricostruisce i fatti. Alla fine scopre che il colpevole è lui stesso. È la trama più semplice, quella perfetta. L’investigatore è l’assassino: tutto si concentra in un unico personaggio, il resto non conta, fa da contorno.
Ma Sofocle non si accontenta, vuole di più. I romanzi gialli si reggono sull’incertezza. L’ Edipo re invece non fa nulla per nascondere l’identità dell’assassino, fin dall’inizio: il pubblico lo sapeva prima ancora che la tragedia cominciasse (il mito era noto) e Tiresia lo rivela subito allo stesso Edipo. L’oracolo di Delfi aveva predetto a Edipo che avrebbe ucciso il padre e sposato la madre; Edipo era subito fuggito da Corinto, ignorando che Polibo e Merope non erano i suoi veri genitori. E durante la fuga aveva prima ucciso il suo vero padre e poi sposato la madre, Laio e Giocasta, i sovrani di Tebe.
La tragedia - l’indagine del commissario Edipo - svela una storia che conoscevano tutti. Come si spiega allora quella suspence che inchioda al testo qualunque lettore, che impedisce di distogliere lo sguardo dal palcoscenico? Perché Edipo non sta cercando soltanto un assassino. E noi stiamo cercando con lui. Sperando che abbia successo, ma allo stesso tempo terrorizzati da quello che lo attende in fondo al tunnel in cui si è addentrato, come in un vortice, lento all’inizio e poi sempre più impetuoso, che avvolge tutto.
Edipo è definitivamente entrato nell’immaginario collettivo nel 1900, con L’interpretazione dei sogni . Freud aveva visto bene: le vicende di Edipo ci appassionano perché in lui vediamo qualcosa di noi. Ma nella tragedia c’è molto di più che la semplice scoperta delle pulsioni (desiderio della madre, conflitto con il padre) che si annidano dentro di noi. Edipo era partito alla ricerca di un assassino e si era poi messo a indagare sui suoi genitori. Ma il vero obiettivo dell’indagine è un altro ancora, più profondo: come Diogene (quello che girava con la lanterna in pieno giorno), Edipo è in cerca dell’uomo, della sua libertà.
L’indagine riguarda tutti.
Quando era arrivato a Tebe, la città era oppressa da un mostro terribile, la Sfinge, che uccideva chiunque non rispondesse al suo enigma. Edipo aveva trovato la soluzione, salvando la città. Il mondo, quello degli antichi non meno del nostro, è opaco, oscuro, ambiguo, sempre rischioso: questo significa la Sfinge. Edipo è colui che porta la luce, con la forza della sua intelligenza. È l’eroe dell’età di Sofocle, dell’illuminismo trionfante ad Atene, «la scuola della Grecia». Come Protagora sa che l’uomo è misura di tutte le cose, come Pericle sa che possiamo rispondere alle sfide dell’esistenza. Ha insegnato che la nostra vita e la nostra felicità dipendono da noi, dalla nostra capacità di comprendere la realtà, di metterla in ordine. È un «modello» per tutti, riconosce il coro. Quando si mette in cerca dell’assassino è questo che vuole dimostrare, una volta di più.
Il momento decisivo è in uno scambio di battute con Giocasta. Edipo ha finalmente trovato un testimone decisivo. Il testimone parla e Giocasta inizia a capire: che Edipo è l’assassino di Laio; che Laio era il padre di Edipo e che lei ha sposato suo figlio. Che niente è come sembrava. Prega Edipo di smettere con le indagini, di fermarsi prima che sia troppo tardi. Scappa. Edipo si irrita, non comprende la reazione di Giocasta. Equivoca: pensa che provi vergogna all’idea di aver sposato il figlio di uno schiavo. Ma a lui questo non importa. Lo grida gonfio d’orgoglio: non era nessuno ed è diventato il re di Tebe, grazie alla sua pazienza, alla sua intelligenza, al suo coraggio. Lui è «figlio del destino», le sue origini non contano. We can . Ha mostrato di cosa è capace un essere umano.
Non ha capito nulla. Infaticabile e ostinato, Edipo, l’uomo più intelligente, per tutta la tragedia non capisce mai nulla, ha sempre vissuto nel buio dell’ignoranza. Poi, finalmente capisce: precipita nella verità come in un abisso, è stato detto. L’indagine è conclusa. Maledice Apollo. Dopo non resta che l’orrore, e il dolore.
Il figlio del destino: Edipo credeva di essere libero, padrone e responsabile per le sue scelte. Credeva che la sua vita dipendesse da lui. Ha scoperto che un destino più grande incombeva sulla sua testa, dominandolo. La libertà è un’apparenza; la vita di Edipo, il «modello» degli uomini, era già da sempre costretta in un disegno su cui lui non aveva nessuna possibilità di controllo. Si è scoperto ingranaggio di un meccanismo: un meccanismo, imperscrutabile ma implacabile, che ha il sorriso beffardo di Apollo - i Greci scolpivano le statue dei loro dèi con un sorriso enigmatico - il dio che illumina, che mostra come stanno le cose. Sul tempio di Apollo, a Delfi, campeggiava una scritta celebre: «Conosci te stesso». Edipo ha seguito l’esortazione del dio, ha indagato se stesso. Quello che ha trovato riguarda tutti.
In effetti, i problemi con cui ci confrontiamo oggi non sono diversi. Che cos’è l’uomo? Quale controllo abbiamo sulle nostre azioni, decisioni, scelte? Quanto di ciò che ci accade è dovuto a cause che non dipendono da noi - eventi del passato, condizionamenti sociali, situazioni impreviste, predisposizioni del carattere? Tanto più conosciamo, di noi e delle cose che ci circondano, tanto più le domande si fanno pressanti.
Il parallelo più interessante è con le neuroscienze. Conosciamo come non mai il funzionamento del nostro cervello: e quello che sembra emergere è che non abbiamo un controllo effettivo, consapevole e razionale, delle nostre decisioni e azioni. «Il tuo senso d’identità personale e di libero arbitrio in realtà non sono niente più che il comportamento di un’ampia organizzazione di cellule nervose e delle molecole loro associate»: questo è Francis Crick, scopritore del Dna e premio Nobel.
Tutti i nostri stati mentali sono epifenomeni, spiegano altri scienziati, non esercitano alcun impatto causale sulla realtà. Che senso ha allora parlare di libertà o responsabilità? Sarà incredibile, ma è così. E poi, a pensarci bene, non è neppure incredibile. La rivoluzione scientifica, fin dal Seicento, ha rivelato che tutto l’universo si muove secondo leggi necessarie di cause ed effetto.
E Kant aveva posto il problema, con la consueta chiarezza: per quale ragione gli esseri umani non dovrebbero essere vincolati a queste stesse leggi di natura? Cambiano i modi per dire le cose, ma l’ironia è la stessa: tanto più conosciamo tanto più ci pensiamo grandi; fino a scoprire la nostra irrilevanza. Come tutto il resto siamo parte di un meccanismo, di cui ci sfugge il senso, fuori dal nostro controllo.
Ma proprio dove maggiore sembra la miseria, lì è la nostra grandezza. È vero: ci crediamo forti e non lo siamo, pensiamo di vedere e non capiamo nulla. Ma non per questo ci arrendiamo. Siamo sempre in cerca. E in questa continua ricerca di un significato, nel coraggio con cui affrontiamo le domande più scomode, costi quello che costi, emerge qualcosa che è nostro e solo nostro, che ci distingue e ci fa unici nell’universo immenso che ci circonda. L’uomo, l’animale che fa domande, che vuole capire.
Fino a che come Edipo non smetteremo di interrogarci su quello che ci circonda senza accontentarci delle apparenze; fino a che come Matthäi e Bellodi continueremo a stare lì, in una piazzola abbandonata, su un pianeta insignificante, in attesa, cercando di capire e cercando la giustizia: fino ad allora dimostreremo che siamo qualcosa di speciale. È buffo, forse folle, ma è così. Ciò che ci fa grandi non sono le risposte che troviamo, ma le domande che poniamo. È questo il vero complesso di Edipo.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- ANCHE LA TERRA, CORPO CELESTE (Anna M. Ortese).20 giugno 2016, di Federico La Sala
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE
CORPO CELESTE. Memoria e conversazione (storia di un piccolo libro)
di Anna Maria Ortese *
Col nome di corpi celesti venivano indicati, nei testi scolastici di anni lontanissimi, tutti quegli oggetti che riempiono lo spazio intorno alla Terra. E anche il nome oggetto, riferendosi a quello spazio, allora incontaminato, purissimo, si colorava pallidamente di azzurro. Noi - che sfogliavamo quei testi e ammiravamo quelle carte della volta celeste - eravamo invece sulla Terra, che non era un corpo celeste, ma era data come una palla scura, terrosa, niente affatto aerea.
Perciò, durante tutta una vita, poteva accadere che, guardando di sera, nella luce tranquilla della campagna, quel vasto spazio sopra di noi, pensassimo vagamente: «Oh, potessimo anche noi trovarci lassù!». Le leggende e i testi scolastici parlavano di quello spazio azzurro e di quei corpi celesti quasi come di un sovramondo. Agli abitanti della Terra essi aprivano tacitamente le grandi mappe dei sogni, svegliavano un confuso senso di colpevolezza. Mai avremmo conosciuto da vicino un corpo celeste! Non eravamo degni!, pensava l’anonimo studente.
Invece, su un corpo celeste, su un oggetto azzurro collocato nello spazio, proveniente da lontano, o immobile in quel punto (cosi sembrava) da epoche immemorabili, vivevamo anche noi: corpo celeste, o oggetto del sovramondo, era anche la Terra, una volta sollevato delicatamente quel cartellino col nome di pianeta Terra. Eravamo quel sovramondo.
Quando ho compreso questo, non subito, a poco a poco, nel continuo terremoto del cresce,ell’amarezza di scoperte inattese (della infelicità, del passare delle cose), sono stata presa da un senso di meraviglia, di emozione indicibile. L’emozione si faceva reverenza, diveniva la sorpresa e la gioia di una più grande scoperta, quella di un destino impareggiabile. Mi trovavo anche io sulla Terra, nello spazio, e il mio destino non era molto dissimile da quello degli oggetti e corpi celesti tanto seguiti e ammirati. Dove avrebbe portato non sapevo: forse su, forse giù, forse nel buio, forse nella luce.
Una cosa era certa, era nozione ormai incancellabile: tutto il mondo era quel sovramondo. Anche la Terra e il paese dove abitavo; e la collocazione, o vera patria di tutti, era quel sovramondo!
* Anna Maria Ortese, Corpo Celeste, Adelphi, Milano 1997.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA MENTE ACCOGLIENTE. --- UN CAMBIO DI PARADIGMA ANTROPOLOGICOLE: LE SCOPERTE DI "KEPLER". C’è vita nell’universo, molta vita (di Guido Tonelli)27 giugno 2016, di Federico La Sala
- LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
C’è vita nell’universo, molta vita
Gli scienziati di Kepler, un grande telescopio lanciato in orbita nel 2009, hanno da poco annunciato di avere scoperto 1.284 nuovi pianeti extra-solari (o esopianeti), cioè pianeti che ruotano attorno a una stella diversa dalla nostra. Tutto fa immaginare che ce ne siano miliardi, alcuni «ospitali». Il mondo sta entrando in una nuova epoca
di Guido Tonelli * (Corriere della Sera, La Lettura, 26.06.2016)
Stiamo entrando in una nuova epoca e nessuno sembra rendersene conto. Di tanto in tanto giornali e televisioni riportano qualche notizia; se ne parla per un paio di giorni poi tutto viene macinato dal tritacarne dell’attualità. L’ultima, di qualche settimana fa, riguarda Kepler, una sonda della Nasa che prende il nome dal grande astronomo tedesco. La sua missione è la scoperta di esopianeti, o pianeti extra-solari, che orbitano cioè attorno ad altre stelle; il fine ultimo è quello di identificare pianeti abitabili, simili alla nostra Terra.
Le primissime ricerche risalgono addirittura agli anni Quaranta, ma utilizzavano tecniche di osservazione piuttosto grossolane. Usando i migliori telescopi allora disponibili si cercavano nuovi sistemi solari sperando di osservare una perturbazione periodica nella posizione della stella-madre. È ben noto che, per le leggi della gravitazione, in presenza di un pianeta la stella-madre non sta ferma, ma compie anch’essa una piccola rotazione intorno al centro di massa del sistema.
Tanto più massiccio è il pianeta tanto maggiore è lo spostamento periodico della stella. Il metodo, detto astrometrico, non ha portato a risultati di rilievo; sono stati identificati un gruppo di potenziali candidati ma nessuno è mai stato confermato. Risultati molto più interessanti si sono avuti con il metodo della misura della velocità radiale. Il principio è lo stesso, si cerca di osservare il minuscolo spostamento periodico della stella-madre, ma la tecnica è basata su misure spettroscopiche che consentono maggiori precisioni. Si analizza lo spettro di emissione luminosa della stella e si controllano nel tempo le righe corrispondenti alle varie frequenze. Se la stella presenta un piccolo movimento orbitale causato dalla presenza di un pianeta, si misura una piccola variazione periodica in frequenza della sua emissione luminosa dovuta all’effetto Doppler.
Quando la stella ha una velocità radiale positiva - cioè si avvicina al nostro punto di osservazione sulla Terra - le righe di emissione si spostano verso il blu, per poi passare dal lato opposto, verso il rosso, quando la stella si allontana. È lo stesso metodo che ci permette di riconoscere, dal suono della sirena, se un’ambulanza si sta avvicinando o si sta allontanando. Con la misura della velocità radiale della stella possiamo calcolare il periodo del moto orbitale del pianeta e la sua massa. I primi pianeti extra-solari sono stati scoperti, con questo sistema, negli anni Novanta. Si trattava di enormi corpi celesti, simili al nostro Giove. Giganti caldi, per lo più gassosi, che gravitavano molto vicini alle loro stelle-madri e avevano quindi una temperatura superficiale spaventosa.
Il metodo della velocità radiale è limitato dal fatto che si deve osservare una stella per volta ed è efficace solo per stelle relativamente vicine a noi, si fa per dire, entro una distanza di circa 160 anni luce, mentre la stragrande maggioranza delle stelle della nostra galassia sta a distanze maggiori.
La vera rivoluzione nella caccia ai pianeti extra-solari è venuta da quando è stato messo a punto il metodo dei transiti. È una tecnica basata sulla fotometria di precisione, cioè si tiene sotto controllo la luminosità della stella e si misura la lievissima attenuazione della luce prodotta dal pianeta che le transita davanti. Anche in questo caso si richiede che la perturbazione, il segnale di transito, abbia carattere periodico. La forma caratteristica del disturbo permette di misurare le dimensioni del pianeta e questa informazione, combinata con la misura della velocità radiale che dà la massa, permette di conoscerne la densità. In questo modo, da alcuni anni, la ricerca di nuove «Terre» ha ricevuto un impulso incredibile e si sono identificati i primi pianeti rocciosi simili al nostro.
Il grande vantaggio del metodo dei transiti è che si possono tenere sotto osservazione, in contemporanea, centinaia di migliaia di stelle e la sensibilità raggiunta dagli strumenti più moderni è tale che il campo d’azione si può estendere fino a distanze di migliaia di anni luce. La sensibilità del metodo è talmente spinta che si possono identificare pianeti addirittura più piccoli di Mercurio. Occorre poi considerare che, nel caso che il pianeta abbia una atmosfera, la luce della stella-madre giunge fino a noi dopo averne attraversato gli strati superiori. Misure accurate della polarizzazione della luce emessa dalla stella permettono quindi di ricavare informazioni essenziali sulla presenza di atmosfera nel pianeta.
L’unico problema del sistema dei transiti è che, per produrre segnali il punto di osservazione deve appartenere al piano delle orbite, cosa che statisticamente avviene solo per una frazione delle stelle osservate. Se poi si cercano pianeti simili alla Terra, che hanno una massa compresa fra metà e due volte quella del nostro pianeta, e che compiono una rivoluzione completa intorno alla loro stella in circa un anno, occorre aspettare molti anni per essere sicuri di avere visto un transito periodico.
Kepler è un grande telescopio lanciato in orbita nel 2009, che sorveglia da anni una piccola zona del cielo compresa fra le costellazioni del Cigno e della Lira. L’apparato tiene sotto controllo circa 150 mila stelle della nostra galassia, distribuite in una regione di dimensioni paragonabili a quella che copriamo con il palmo della nostra mano, se tendiamo il braccio verso il cielo.
La zona di osservazione copre un cono di circa duemila anni luce intorno al nostro Sole che si trova in Orione, un piccolo braccio secondario della spirale che costituisce la nostra Via Lattea. Il telescopio è ottimizzato per misure di fotometria e utilizza un sistema di camere fotografiche molto sofisticate, da 95 milioni di pixel, ma concettualmente simili a quelle che usiamo nei nostri cellulari.
Un mese fa gli scienziati di Kepler hanno annunciato di avere scoperto 1.284 nuovi pianeti extra-solari. La maggior parte dei nuovi corpi celesti sarebbero posti assolutamente inospitali, caratterizzati da atmosfere molto dense, composte essenzialmente da elio e idrogeno, e temperature torride alla superficie. Ma la novità davvero eclatante è la scoperta che pianeti simili alla Terra sono corpi celesti molto comuni fra quelli che orbitano intorno alle stelle.
Fra i nuovi venuti almeno nove dovrebbero essere pianeti rocciosi che si trovano nella fascia cosiddetta abitabile, cioè a una distanza dalla stella-madre tale da consentire temperature simili a quelle che abbiamo qui da noi. Se un pianeta roccioso si trova nella fascia abitabile e contiene acqua, questa potrebbe formare laghi e oceani come quelli che sono così diffusi sulla nostra Terra. Ecco che, di colpo il numero dei nostri potenziali cugini è quasi raddoppiato.
 E la cosa sorprendente è che Kepler ha osservato soltanto una piccola porzione della nostra galassia. Si stanno già preparando nuove missioni e nuove campagne di osservazioni e nel prossimo futuro si costruirà una mappa sempre più dettagliata delle «nuove Terre». Nel giro di un paio d’anni sarà lanciato un nuovo telescopio per tenere sotto osservazione le 200 mila stelle più vicine a noi fra le quali ci si aspetta di scoprire 500 pianeti rocciosi simili al nostro.
E la cosa sorprendente è che Kepler ha osservato soltanto una piccola porzione della nostra galassia. Si stanno già preparando nuove missioni e nuove campagne di osservazioni e nel prossimo futuro si costruirà una mappa sempre più dettagliata delle «nuove Terre». Nel giro di un paio d’anni sarà lanciato un nuovo telescopio per tenere sotto osservazione le 200 mila stelle più vicine a noi fra le quali ci si aspetta di scoprire 500 pianeti rocciosi simili al nostro.La nostra Via Lattea contiene circa 200 miliardi di stelle ed è soltanto una fra cento miliardi di galassie che popolano il nostro universo. I numeri fanno impressione: se soltanto una stella su diecimila ospitasse pianeti rocciosi nella fascia abitabile dovremmo accettare l’idea che il numero di «Terre» della nostra galassia, quindi astronomicamente vicine a noi, potrebbero essere decine di milioni. Se si considerano i 100 miliardi di galassie dell’Universo intero si potrebbe raggiungere la cifra fantastica di miliardi di miliardi. Insomma c’è pieno di pianeti abitabili intorno a noi ed è molto probabile che ci sia abbondanza di forme di vita nell’universo. Non c’è alcun motivo di credere che acqua e materia organica siano componenti ultra rari.
Fra qualche tempo saremo in grado di analizzare la composizione dell’atmosfera dei nuovi pianeti che orbitano nelle fasce abitabili per cercare eventuali composti organici, chiari indizi della presenza di forme di vita simili a quelle che ci sono familiari. Non mi interessa qui discutere il problema delle distanze e neanche la tecnologia con cui potremo stabilire una comunicazione o un contatto. Sarebbe sciocco argomentare oggi intorno a questioni che, ne sono sicuro, faranno sorridere gli scienziati del futuro.
Vorrei invece sottolineare la necessità di prepararsi a quello che sarà sicuramente un grosso choc culturale. Un’umanità che fa fatica a convivere con se stessa, sarà in grado di superare la crisi di valori legata alla scoperta di altre forme di vita? Che rapporti instaureremo fra noi, per prepararci a queste prime forme di contatto con «gli altri»? Noi che nella colonizzazione della terra non siamo stati capaci di praticare altro che depredazione e spoliazione delle popolazioni con cui siamo venuti in contatto, accetteremo di essere «i primitivi» al cospetto di civiltà che si sono sviluppate qualche milione di anni prima di noi?
E viceversa, quali relazioni saremo in grado di instaurare con forme di vita, magari simili alle nostre, ma che ci potranno apparire a un livello di sviluppo primordiale? È pensabile che si cominci a ragionare dei problemi etici connessi a questo passaggio? Noi che non siamo in grado di gestire l’integrazione di alcuni milioni di rifugiati o di emigranti che sfuggono la guerra o precarie condizioni di vita, con quali strumenti culturali arriveremo a questo appuntamento che ci chiama a un salto di civiltà?
I nostri pronipoti vedranno un mondo che noi, oggi, possiamo solo immaginare. Riusciremo ad attrezzarci nel giro di qualche generazione a questo cambio di paradigma sul piano antropologico?
-
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- UN BRILLANTE "NEW-TONo". Un Natale nel nome di Isacco.6 dicembre 2015, di Federico La Sala
Un Natale nel nome di Isacco (Newton)
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 29.12.2013)
Lo scorso mercoledì una parte del mondo occidentale ha meditato sulle parole del Vangelo secondo Giovanni (I, 6-7): «Venne un uomo mandato da Dio», e «venne come testimone per rendere testimonianza alla luce». E ha festeggiato quell’uomo, che cambiò la storia dell’Occidente, e nacque il giorno di Natale: ma non dell’anno 0, bensì del 1642. Quell’uomo aveva un nome biblico, ma non si chiamava Giovanni o Gesù: bensì, Isacco, o meglio, Isaac.
In realtà, quell’uomo nacque il giorno di Natale solo in Inghilterra, dove la riforma del calendario non era ancora stata adottata: nel resto d’Europa, si era ormai già al 4 gennaio 1643. Ciò nonostante, in Inghilterra il 25 dicembre continua a esser chiamato non solo Christmas, ma anche Newtonmas.
Perché è appunto di Newton che stiamo parlando: un uomo che “rese testimonianza alla luce” in un libro chiamato Ottica, nel quale spiegò al mondo che la luce bianca in realtà è un miscuglio di luci colorate, nelle quali si può decomporre facendola passare attraverso un prisma, e che si possono ricomporre facendole ripassare attraverso un prisma invertito. Solo la mela che ispirò allo stesso Newton la legge di gravitazione universale può competere con il suo prisma nell’immaginario scientifico collettivo, come simbolo del colpo di genio in grado di cambiare la storia del pensiero e dell’uomo.
È per questo che, quando Newton morì, Alexander Pope compose un epitaffio che paragonava la sua nascita non solo a quella di Cristo, ma addirittura alla creazione del mondo: «God said: Let Newton be, and all was light», ossia “Dio disse: Sia fatto Newton, e la luce fu”. Ed è per questo che il 25 dicembre molti si sono augurati, invece che un religioso Merry Christmas, un laico “Merry Newtonmas”!
-
>LA MENTE ACCOGLIENTE --- Le frontiere aperte dell’Universo. Il «tutto» lasciamolo perdere. Intervista a G. Amelino-Camelia (di A. Capocci)27 novembre 2015, di Federico La Sala
FISICA E METAFISICA. "La «teoria del tutto» mi ricorda le tavole della legge della religione, più che la scienza. Io mi accontenterei: la materia che abbiamo conosciuto finora rappresenta solo il 4% della densità di energia dell’universo. Il resto è ancora da capire. Siamo lontani anche da una «teoria del molto». Il «tutto» lasciamolo perdere" (Giovanni Amelino-Camelia).
Le frontiere aperte dell’UniversoIl 2 dicembre del 1915 veniva pubblicata la versione definitiva della teoria della relatività.
Intervista con Giovanni Amelino-Camelia, fisico dell’università La Sapienza. «Di Einstein ce ne sono almeno tre: c’è il divo che fa le smorfie sulle magliette, il giovane che compie scoperte straordinarie e quello della maturità, che dà contributi trascurabili e perde la bussola»
intervista di Andrea Capocci (il manifesto, 27.11.2015)
Cento anni fa, Albert Einstein spediva all’Accademia Prussiana delle Scienze l’articolo Feldgleichungen der Gravitation («Le equazioni di campo della gravità»), in cui veniva presentata la versione «definitiva» della teoria della relatività generale, pubblicata poi il 2 dicembre del 1915. Era la conclusione di un percorso iniziato nel 1905, e che proseguirà ancora nei primi mesi del 1916. Dieci anni prima, Einstein aveva contribuito anche alla fondazione della meccanica quantistica e delle particelle. Grazie alla teoria della relatività generale, il fisico tedesco si conquistò un ruolo indiscutibile nella cultura non solo scientifica del ventesimo secolo.
Secondo molti, la vicenda di Einstein è irripetibile: la dimensione industriale della scienza attuale impedisce che un singolo scienziato dia un contributo così rilevante al progresso delle conoscenze. D’altra parte, Einstein continua a rappresentare un riferimento per generazioni di studenti e per l’immagine della scienza veicolata dai media.
Solo qualche anno fa, la rivista americana Discover individuava sei possibili nuovi «Einstein» in grado di rivoluzionare la fisica andando anche oltre Einstein stesso: unificando, cioè, la teoria della relatività e la meccanica quantistica. T ra loro anche un italiano: Giovanni Amelino-Camelia, cinquantenne fisico dell’università La Sapienza di Roma. Un ottimo interlocutore, dunque, per comprendere l’eredità scientifica di Einstein e i futuri sviluppi delle sue teorie.
«Prima però dobbiamo metterci d’accordo. Di Einstein non ce n’è uno solo: ce ne sono almeno tre». In che senso, professore?
C’è il divo, quello che fa le smorfie e va sulle magliette, che nasce ufficialmente nel 1919. È l’anno in cui Eddington conferma la validità della teoria della relatività generale. Einstein finisce sulle prime pagine e la stampa lo trasforma in un personaggio di fama mondiale. Quello è lo scienziato-icona che piace molto ai media, svampito e stravagante come ormai immaginiamo che debba essere uno scienziato. Ma è un Einstein che fa comodo a tutti. È simpatico, fa vendere, quando compare sulla copertina di una rivista funziona sempre. È un’icona dotata di un valore economico.
E gli altri?
C’è l’Einstein giovane, quello che tra il 1905 e il 1916 compie alcune delle scoperte più straordinarie della storia della scienza. Sarebbero tante anche per un’intera generazione di scienziati, figuriamoci per un uomo solo. Infine, c’è l’Einste della maturità che, dopo il 1919, dà un contributo scientifico trascurabile. Non si tratta di vecchiaia, perché nel 1919 ha solo quarant’anni. Eppure contraddice completamente il suo modo di lavorare. Perde la bussola, attacca la meccanica quantistica come un crociato. Secondo Wolfgang Pauli, un altro grande fisico poco più giovane di lui, le ricerche di Einstein di quel periodo sono «terribile immondizia». Solo il peso scientifico del personaggio costringe gli altri a prenderlo sul serio. Però così riesce anche ad avere un ruolo politico importante, a cavallo della seconda guerra mondiale.
A lei quale Einstein interessa di più?
Quando me lo chiedono, a me piace parlare del giovane scienziato, anche se è quello più difficile da raccontare. Ma se ci ricordiamo lo scienziato spettinato o quello pacifista, è grazie al giovane Einstein.
È lo scienziato delle grandi intuizioni...
Anche il suo intuito certe volte ci azzeccava e altre no, come tutti. La grande forza di Einstein fu piuttosto la adesione totale al metodo scientifico, che ci aiuta a liberarci dai pregiudizi. Einstein studiò i risultati di esperimenti che nessuno riusciva a interpretare. Ipotizzò per primo che la luce potesse comportarsi come una particella, il fotone, il primo mattone della meccanica quantistica. E fu ancora Einstein a sviluppare la teoria atomica della materia, studiando il moto casuale di un granello di polline in un liquido. Quegli undici anni sono un perfetto manuale del fare scienza confrontandosi con i dati e solo con loro, senza pensare alla teoria più «elegante» o più «bella». Studiandoli da vicino si impara molto più che la relatività o la meccanica quantistica.
A lei cos’altro hanno insegnato?
Ad esempio, che anche senza microscopio si può indagare i componenti più piccoli della realtà. Quando Einstein teorizzò atomi e molecole non c’erano gli strumenti di oggi, che riescono persino a fotografarli. Ma gli atomi, se esistevano, collettivamente dovevano produrre effetti visibili. Fu proprio studiando gli effetti macroscopici che Einstein scoprì i costituenti più piccoli della materia.
Oggi però i microscopi in cui misurare gli effetti quantistici esistono, sono gli acceleratori di particelle...
Ma persino al Cern non arrivano ad osservare le distanze più piccole, laddove la teoria della gravità e meccanica quantistica devono ancora essere comprese. Allora anche io, come Einstein, cerco di studiare sistemi più grandi. Fortunatamente, ce n’è uno grande abbastanza: è l’Universo. Gli effetti quantistici della gravità sono invisibili su scala planetaria. Ma su una particella che viaggia abbastanza a lungo nell’Universo gli effetti accumulati possono lasciare tracce osservabili. Se il nostro modello di gravità quantistica funziona, deve essere in grado di prevedere gli effetti che essa ha su queste particelle.
E dove troviamo queste particelle?
Per esempio, c’è un esperimento in Antartide chiamato IceCube, «cubetto di ghiaccio». In realtà, è un cubo di ghiaccio di un chilometro e mezzo di lato pieno di sensori. IceCube riesce a rilevare i neutrini, particelle di massa piccolissima provenienti dall’universo lontano, ben al di fuori dalla nostra Galassia. Per ora ne ha intercettati qualche decina. Se riuscissimo a capire da dove arrivano e quanta strada hanno fatto, potremmo confrontare i dati e i modelli. Ma c’è ancora molto da fare prima di mettere d’accordo gravità e meccanica quantistica.
Questa è la strada verso la «teoria del tutto»?
Non parlerei di «teoria del tutto». Il primo nemico di questa idea fu proprio Einstein. Già a fine Ottocento, quando Einstein era uno studente, le leggi di Newton sulla gravità e alle equazioni di Maxwell sull’elettromagnetismo sembravano aver spiegato l’intero universo. Anche a Max Planck, vent’anni prima, era stato sconsigliato di intraprendere studi di fisica, perché non c’era più niente da scoprire. Un paio di decenni dopo, quando Einstein aveva quarant’anni, quella fisica era stata rasa al suolo e sostituita da meccanica quantistica e relatività. La «teoria del tutto» mi ricorda le tavole della legge della religione, più che la scienza. Io mi accontenterei: la materia che abbiamo conosciuto finora rappresenta solo il 4% della densità di energia dell’universo. Il resto è ancora da capire. Siamo lontani anche da una «teoria del molto». Il «tutto» lasciamolo perdere.
-
> LA LUCE, LA TERRA. "Note per una epistemologia genesi-ca" --- La Relatività e Mercurio. La teoria einsteiniana celebra uno straordinario connubio tra vero e bello (di Vincenzo Barone).18 novembre 2015, di Federico La Sala
Vuoi capire la Relatività?
Un buon inizio è spiare Mercurio
di Vincenzo Barone (La Stampa - TuttoScienze, 18.11.2015)
- Sempre di corsa contro il tempo Albert Einstein arriva alla conferenza del 18 novembre del 1915, a Berlino, con le palpitazioni. Ma in serbo ha i nuovi calcoli dell’orbita di Mercurio che confermano - in modo clamoroso - le ipotesi racchiuse nella Relatività Generale: a raccontarlo in questa pagina è il fisico Vincenzo Barone (...) - a c. di Gabriele Beccaria e Francesco Vaccarino
«Il fine della scienza - diceva Einstein - è, da una parte, la comprensione più completa possibile della connessione fra le esperienze sensoriali, dall’altra il raggiungimento di questo fine mediante l’uso di un numero minimo di concetti e di relazioni primarie». La Relatività generale rappresenta la realizzazione concreta di questo programma, scientifico e filosofico al tempo stesso.
La teoria è infatti strutturata analiticamente attorno a un principio universale, il principio di relatività generale, il quale stabilisce che le leggi fisiche debbano essere le stesse per tutti gli osservatori, qualunque sia il loro moto (cioè, matematicamente, che debbano avere la stessa forma in tutti i sistemi di coordinate spazio-temporali). L’equazione fondamentale - l’equazione del campo gravitazionale -, che descrive la gravità come curvatura dello spazio-tempo in presenza di masse e di sorgenti di energia, è la più semplice equazione compatibile con il principio di relatività. Si è quindi di fronte a un vero capolavoro di unità concettuale e di economia logica. Ma questa meravigliosa, e insuperata, eleganza formale non deve far dimenticare che la Relatività generale è sostenuta da un’enorme mole di evidenze sperimentali - ed è per questo, in definitiva, che la riteniamo valida.
La prima conferma empirica della teoria fu trovata dallo stesso Einstein, e presentata all’Accademia prussiana delle Scienze il 18 novembre 1915. Einstein decise di leggere personalmente quella comunicazione, perché conteneva un risultato di grande importanza, che lo aveva convinto della correttezza dell’edificio teorico che stava costruendo. Il risultato riguardava la rotazione dell’asse orbitale di Mercurio, con il conseguente spostamento del suo perielio. Questo fenomeno era noto fin dall’Ottocento ed era in larga misura spiegabile con l’attrazione degli altri pianeti. Ma rimaneva un piccolissimo scarto, di poco più di un centesimo di grado al secolo, che la teoria newtoniana non era in grado di spiegare: la Relatività generale riproduceva esattamente tale valore. Einstein raccontò di aver avuto le palpitazioni al cuore ottenendo quel risultato: «Ero fuori di me per la gioia e l’eccitazione», scrisse in seguito all’amico Paul Ehrenfest.
Un altro test cruciale della teoria, proposto da Einstein nella stessa conferenza del 18 novembre, è la deflessione gravitazionale della luce. Il Sole incurva lo spazio circostante e fa sì che i raggi luminosi provenienti da stelle lontane e passanti in prossimità della sua superficie siano deviati di un angolo piccolissimo. Lo si può verificare osservando la posizione apparente delle stelle attorno al Sole durante un’eclissi totale, quando l’intensa luce solare, che impedirebbe la loro visione, è schermata dalla Luna. Einstein predisse l’angolo di deflessione, ma per osservare l’effetto si dovette aspettare l’eclissi totale del 1919. La misura, sebbene non precisissima, risultò in accordo con la predizione relativistica, decretando così l’affermazione della teoria (e la fama mondiale di Einstein). Oggigiorno, la deflessione gravitazionale delle onde radio, che sono onde elettromagnetiche come la luce, è confermata con una precisione di gran lunga superiore.
Il terzo test della Relatività generale che Einstein immaginò è lo spostamento gravitazionale verso il rosso, cioè la diminuzione della frequenza della luce (il rosso, nello spettro visibile, corrisponde alla frequenza più bassa) che risale un campo gravitazionale - qualcosa di analogo a ciò che accade a un corpo che, muovendosi verso l’alto nel campo gravitazionale terrestre, perde velocità. Einstein non ebbe la soddisfazione di assistere alla conferma di questo effetto, che fu osservato solo nel 1960, cinque anni dopo la sua morte.
Allo spostamento verso il rosso è connesso un altro sorprendente fenomeno: un orologio soggetto a un campo gravitazionale rallenta. Sulla Terra, per esempio, un orologio posto in basso (a livello del mare, diciamo), dove la gravità è più intensa, va più lento di un orologio posto in alto (in montagna). L’effetto è molto piccolo e per verificarlo si è dovuto aspettare l’avvento degli orologi atomici.
Nel 1976, in uno degli esperimenti più importanti nella storia della relatività generale, i torinesi Luigi Briatore e Sigfrido Leschiutta confrontarono i tempi misurati da due orologi al cesio, uno a Torino (250 metri di altitudine), l’altro sul Plateau Rosa (3500 metri), trovando una differenza di circa 30 nanosecondi al giorno, in ottimo accordo con la teoria einsteiniana.
Gli ultimi prototipi di orologi atomici sono talmente accurati (sbagliano di non più di un secondo ogni 10 miliardi di anni - pressappoco l’età dell’Universo) da permettere di osservare il rallentamento gravitazionale del tempo su dislivelli di appena qualche decina di centimetri: in pratica, si è arrivati al punto di evidenziare la minuscola differenza tra il tempo misurato da un orologio sul pavimento e quello misurato da un orologio su un tavolo.
Fin dall’inizio, 100 anni fa, la Relatività generale apparve come un capolavoro di bellezza teorica. Ma nessuno, neanche Einstein, poteva immaginare che le sue verifiche osservative e sperimentali avrebbero raggiunto un tale grado di precisione. Quello che la teoria einsteiniana celebra sotto i nostri occhi è dunque uno straordinario connubio tra vero e bello, che non smetterà mai di incantarci.
-
> LA LUCE, LA TERRA. "Note per una epistemologia genesi-ca" --- La Relatività non ha nulla di soggettivo! Storica confusione (di Vincenzo Barone).27 dicembre 2015, di Federico La Sala
Storica confusione
Relatività solo di nome
Fin dalla sua nascita, 110 anni fa, il grande pubblico (tra cui anche Mussolini) fraintese questa teoria, che nulla ha di soggettivo. Anzi...
di Vincenzo Barone (Il Sole-24 Ore, Domenica, 27.12.2015)
C’è un problema che affligge le due relatività (la relatività ristretta del 1905 e la relatività generale del 1915, di cui abbiamo festeggiato in queste settimane il centenario) fin dal loro apparire. Un problema non di natura scientifica, beninteso - perché, da questo punto di vista, le due teorie hanno solo mietuto successi -, ma piuttosto fastidioso: il nome. Come Einstein non si stancava di ripetere, il termine “relatività” è connesso esclusivamente al fatto che «il moto appare sempre come moto relativo di un oggetto rispetto a un altro», e non è mai osservabile come «moto assoluto». Il termine, tuttavia, diede subito adito a fraintendimenti, che si trascinano ancora oggi.
Il fisico teorico americano Richard Feynman derideva quei filosofi «da salotto» - l’espressione è sua - che ritenevano che il contenuto della relatività fosse sintetizzabile in due formule verbali: «I fenomeni fisici dipendono dal sistema di riferimento», e «Tutto è relativo». La prima di queste proposizioni è banale: che un fenomeno fisico (per esempio il moto) dipenda dal sistema di riferimento, cioè che appaia diverso a seconda dell’osservatore, è cosa evidente e nota da sempre, e non c’era bisogno di aspettare la relatività per accorgersene (un passeggero su un treno è in quiete rispetto a un altro passeggero, ma è in moto rispetto a qualcuno che si trovi ai lati del binario).
La seconda proposizione, la più diffusa - «Tutto è relativo» -, è invece falsa. Ciò che la relatività afferma è semmai l’opposto. È vero che un fenomeno fisico è descritto diversamente da osservatori diversi, e che molte grandezze (intervalli di tempo, lunghezze, velocità, frequenze, ecc.) sono relative, cioè dipendono dal sistema di riferimento, ma le leggi fisiche che governano i fenomeni sono le stesse per tutti gli osservatori. La relatività non dice affatto che queste leggi sono relative, ma, al contrario, che sono “assolute”, per così dire, perché valgono nella stessa forma per tutti. È questo il significato genuino del principio di relatività, che Einstein enunciò nel 1905 per gli osservatori in moto uniforme, ed estese, con la relatività generale del 1915, a tutti gli osservatori.
Un altro classico equivoco è l’identificazione (sulla base solo della comune etimologia) della relatività con il relativismo, inteso in senso epistemologico come la dottrina secondo cui non esistono conoscenze oggettivamente valide. Anche questo elemento di confusione - fonte di innumerevoli insensatezze - risale agli albori della teoria.
Nel 1922, per fare un esempio nostrano, apparve il libello Relativisti contemporanei, dello scrittore e critico Adriano Tilgher, in cui si celebrava Einstein - accomunato a Hans Vaihinger, il filosofo del finzionalismo, e a Oswald Spengler, l’autore de Il tramonto dell’Occidente - come il «duce del formidabile assalto relativista che, irraggiando dalla Germania in tutto il mondo civile, tende a rinnovellare le basi stesse del nostro sapere». Il merito del fisico tedesco, scriveva Tilgher, era quello di «aver introdotto per via di argomentazioni fisico-matematiche il soggettivismo nella scienza della natura», cosicché la relatività si inseriva in un più ampio movimento di pensiero ispirato a un’«intuizione attivistica del mondo e della vita», che in campo politico trovava espressione nel fascismo. «Esattissimo! Con questa affermazione Tilgher immette il fascismo nel solco delle più grandi filosofie contemporanee: quelle della relatività» - commentò sul «Popolo d’Italia» Benito Mussolini, il quale ovviamente non sapeva nulla di relatività, ma non disdegnava di attribuire al proprio movimento un’etichetta intellettuale di moda (questa e molte altre perle sulla ricezione della relatività nel nostro paese si possono trovare in un vecchio ma prezioso saggio di Roberto Maiocchi, Einstein in Italia, Franco Angeli, 1985).
Vale la pena di ricordare che, originariamente, Einstein aveva parlato solo di «principio di relatività» (Relativitätsprinzip). Fu Max Planck, il padre della meccanica quantistica, a battezzare la teoria einsteiniana Relativtheorie, espressione modificata poi in Relativitätstheorie, il nome con cui la teoria divenne universalmente nota.
Rovesciando il termine, il matematico Hermann Minkowski, cui si deve l’idea dello spazio-tempo, preferiva chiamare il principio di relatività «Postulato del mondo assoluto». Un altro grande matematico, Felix Klein, uno dei fondatori della geometria moderna, suggerì il nome di «teoria degli invarianti», che individuava giustamente nel requisito di invarianza delle leggi fisiche il fulcro della relatività. Ma era ormai troppo tardi, e la proposta di Klein (che a Einstein piaceva) non prese piede. Non ci resta che pensare a quanti discorsi insulsi si sarebbero evitati se il nome della teoria fosse stato diverso.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA MENTE ACCOGLIENTE. --- Se il Gps è “relativo”, led e laser sono figli di una nuova idea della luce. Einstein è anche uno dei padri (quasi sconosciuto) del nostro mondo high tech.11 novembre 2015, di Federico La Sala
Se il Gps è “relativo”, led e laser sono figli di una nuova idea della luce
Einstein è anche uno dei padri (quasi sconosciuto) del nostro mondo high tech
di Guglielmo Lanzani (La Stampa - TuttoScienze, 11.10.2015)
Se orientarsi in terra e in mare non rappresenta più un problema, lo dobbiamo anche alla Relatività. Il sistema Gps, infatti, non può prescindere da questa teoria per il suo funzionamento.
La velocità relativa di spostamento rispetto alla Terra rallenta il tempo sul satellite di circa 7 microsecondi al giorno, mentre il potenziale gravitazionale, minore sull’orbita del satellite rispetto alla Terra, lo accelera di 45 microsecondi. Pertanto, il bilancio è che il tempo sul satellite accelera di circa 38 microsecondi al giorno. Senza queste correzioni (oltre a quelle dovute alla propagazione di segnale in atmosfera o ai ritardi dell’elettronica di bordo), il Gps genererebbe errori nell’ordine di km oppure di miglia marine, con le prevedibili conseguenze per il traffico terrestre e marittimo.
Moltissime ricadute tecnologiche che dobbiamo ad Einstein non derivano però dalla Relatività. Dalla sua mente, infatti, scaturirono molte altre idee nel campo della fisica della materia che hanno avuto un impatto ancora maggiore sulla nostra vita quotidiana. Proprio nell’anno in cui scrisse la Relatività ristretta, il 1905, Einstein diede alla luce anche un altro lavoro - che gli fruttò il Nobel nel 1921 - sulla spiegazione dell’effetto fotoelettrico, cioè come la luce induce corrente elettrica in alcuni materiali. Scoperto decenni prima, l’effetto fotoelettrico era un rompicapo per i fisici.
Nella sua spiegazione Einstein aveva pensato alla luce come costituita da pacchetti di energia, «i quanti di luce», anziché come un flusso continuo di radiazione elettromagnetica, come si era abituati a intenderla. L’interazione tra luce e materia avveniva quindi come un gioco di biglie: l’energia dei quanti di luce veniva trasferita agli elettroni del materiale. Se sufficiente, questi potevano essere emessi dalla superficie, altrimenti restavano all’interno del materiale ma liberi di muoversi.
Si tratta di una delle pietre miliari nel cammino che ha portato al superamento della fisica classica in favore della meccanica quantistica. Lo sviluppo di una teoria in grado di descrivere l’interazione della radiazione con la materia portò a nuove soluzioni tecnologiche quali laser, telecamere, tubi catodici, fotocellule e celle fotovoltaiche. Esistevano, allora, già diversi tipi di celle fotovoltaiche, le più note a silicio. Il fotovoltaico ha infatti una lunga storia.
Nel 1876 R. E. Day e William G. Adams scoprono che, illuminando una giunzione di selenio e platino, si genera una differenza di potenziale e la prima cella fotovoltaica al selenio viene realizzata un anno dopo. Inizialmente il dispositivo non riceve però molta attenzione, è considerato solo una curiosità. Le cose cambiano con l’avvento del silicio, utilizzato già nel 1940. Ai Bell Labs, all’epoca un punto di riferimento della scienza e della tecnologia, Gerald Pearson, fisico, costruisce per caso, una cella fotovoltaica al silicio che ha un efficienza di conversione molto maggiore di quella ottenuta con il selenio. La cella fotovoltaica al silicio dei Bell Labs raggiunge il record del tempo, 6% in una giornata di sole.
La teoria di Einstein spiega la relazione tra il tipo di materiale (il semiconduttore) e i colori della luce solare che possono essere assorbiti, rendendo conto dell’energia che può essere estratta. Con questi strumenti teorici, assieme allo sviluppo della fisica dello stato solido, è quindi possibile l’ingegnerizzazione del dispositivo e il miglioramento delle prestazioni. Intanto il dispositivo attira l’interesse di molti, tra cui gli ingegneri di Usa e Urss. Entrambi hanno un’idea in mente: l’alimentazione dei satelliti, cruciali per la conquista dello spazio in tempi di Guerra Fredda.
Sulla Terra, però, il primo cliente di questa tecnologia emergente è l’industria del petrolio. Le celle fotovoltaiche sono utilizzate nei pozzi di estrazione del Golfo del Messico per alimentare le lampade accese la notte. Le applicazioni si moltiplicano rapidamente, attirando anche organizzazioni no-profit per creare sorgenti di energia nelle aree più povere del Pianeta e non raggiunte dalle reti elettriche. Durante la siccità nel Sahel, in Africa negli Anni 70, padre Bernard Verspieren, un missionario, inizia un programma di estrazione dell’acqua dalla falda acquifera mediante pompe alimentate proprio da celle fotovoltaiche. Nel 1977 verrà installato il primo impianto. Ora ce ne sono decine di migliaia nel mondo.
Il processo inverso - la trasformazione di una corrente elettrica in luce - è invece l’elettroluminescenza. E anche in questo caso Einstein ha dato alcuni contributi fondamentali, combinando la nascente meccanica quantistica e l’idea di interazione quantizzata con la luce insieme con la termodinamica.
Sembra che di quest’ultima disciplina Einstein dicesse: «È la sola teoria fisica di contenuto universale di cui sono convinto che, nell’ambito di applicabilità dei suoi concetti di base, non verrà mai superata». Anche questa ha oggi molte applicazioni, ma una ci accompagna quotidianamente. Sono gli schermi a Led o Oled che guardiamo continuamente e che da qualche tempo portiamo in tasca.
Dagli emettitori di luce, poi, il passo è breve per arrivare al laser, un’altra applicazione dei pensieri originali di Einstein, con applicazioni estese, dalla medicina alla ricerca, dall’industria alla metrologia, fino allo spettacolo. Sono altre prove di come le sue teorie si siano concretizzate su tempi lunghi, in sinergia con altre teorie e con lo sviluppo della tecnologia. È un esempio perfetto di come la conoscenza abbia un valore assoluto. Anche quando non ne vediamo un ritorno immediato.
-
>LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- Nel novembre 1915 Albert Einstein presentò all’Accademia Prussiana delle Scienze la teoria rivoluzionaria alla quale stava lavorando dal 1905.1 novembre 2015, di Federico La Sala
I 100 anni della relatività generale
Un capolavoro in tre atti
Nel novembre 1915 Albert Einstein presentò all’Accademia Prussiana delle Scienze la teoria rivoluzionaria alla quale stava lavorando dal 1905
di Vincenzo Barone (Il Sole-24 Ore, Domenica, 1.11.2015)
In una lettera del 10 dicembre 1915 indirizzata all’amico Michele Besso, Einstein disse di sentirsi «elice, ma un po’ distrutto». Ne aveva tutte le ragioni: con un incredibile tour de force era riuscito in poche settimane a completare il suo capolavoro, la relatività generale, universalmente considerata la più bella teoria della fisica. «Chiunque la comprenda non può sfuggire al suo fascino», si spinse a dire lui stesso, abbandonando la consueta riservatezza, il 4 novembre di quell’anno, nella prima delle comunicazioni inviate all’Accademia Prussiana delle Scienze (ne seguirono altre tre), in cui espose la teoria nella sua forma finale.
La creazione della relatività generale fu una gigantesca impresa intellettuale, che combinò, in un modo e in una misura che non si sarebbero mai più ripetuti, intuizione fisica, potenza matematica e solidità epistemologica. Essa rappresentò il culmine di un lungo lavoro, cominciato con la formulazione della relatività ristretta nel 1905, l’annus mirabilis in cui Einstein, «esperto tecnico di terza classe» all’Ufficio Brevetti di Berna, aveva sconvolto la fisica, concependo anche la teoria dei quanti di luce (tappa decisiva per lo sviluppo della meccanica quantistica) e la teoria dei moti molecolari (che contribuì alla definitiva affermazione dell’tomismo).
La teoria del 1905 era basata su un principio di simmetria, il principio di relatività, secondo il quale le leggi di natura hanno la stessa forma per tutti gli osservatori in moto uniforme. Venivano, in tal modo, spazzati via l’etere e i concetti di movimento e di quiete assoluti. Ma la restrizione agli osservatori in moto uniforme disturbava Einstein. «Ogni mente portata alla generalizzazione - scrisse sentirà la tentazione di azzardare il passo verso il principio generale di relatività», cioè verso un principio di invarianza delle leggi fisiche per tutti gli osservatori, indipendentemente dal loro moto, uniforme o accelerato. Ci volle quasi un decennio - costellato di idee geniali, ma anche di tentativi a vuoto e di delusioni - per raggiungere questo obiettivo.
Come ha fatto notare lo storico della scienza John Stachel, la costruzione della relatività generale è un’opera in tre atti. Il primo atto ha inizio nel 1907, quando Einstein concepisce quello che definirà poi il pensiero più felice della sua vita: l’idea che un osservatore in caduta libera non avverte alcun campo gravitazionale (perché la forza inerziale dovuta all’accelerazione del sistema annulla la gravità). In altri termini, accelerazione e gravità sono intercambiabili, nel senso che l’una simula o compensa l’altra. Questo “principio di equivalenza” mostra come l’estensione della relatività ai sistemi accelerati prenda la forma di una nuova teoria della gravitazione, e ha un notevole potere predittivo.
Grazie a esso, Einstein scopre che la gravità deflette la luce. Nel 1911 quantifica l’effetto, calcolando la deviazione dei raggi luminosi provenienti da stelle lontane e “piegati” dalla gravità solare, ma, a causa dell’incompletezza della teoria, ottiene un valore sbagliato - come scoprirà in seguito (fortunatamente per lui, una spedizione organizzata per osservare il fenomeno in occasione dell’eclissi totale di Sole in Crimea nell’estate del 1914 viene bloccata dallo scoppio della Prima guerra mondiale).
Il secondo atto dell’impresa einsteiniana si svolge negli anni 1912-1913. Einstein intuisce allora il profondo legame tra gravità e geometria, e comprende che bisogna superare lo spazio-tempo piatto e statico della relatività ristretta per passare a uno spazio-tempo curvo e dinamico, un vero e proprio campo fisico il campo gravitazionale. È un cambiamento cruciale, ontologico: da semplice palcoscenico degli eventi, lo spazio-tempo diventa attore protagonista, in dialogo con gli altri attori, la materia e la luce. Ma per dar corpo a questa idea serve una matematica più sofisticata di quella del 1905: una matematica che, in quel momento, Einstein non possiede.
Di ritorno a Zurigo, dopo una parentesi a Praga, si rivolge a un suo vecchio compagno di studi, il matematico Marcel Grossmann. Questi gli consiglia di studiare la geometria di Riemann, che permette di descrivere spazi curvi con un numero qualsiasi di dimensioni, e gli segnala i lavori di due studiosi italiani, Gregorio Ricci Curbastro e Tullio Levi-Civita, che hanno sviluppato una tecnica - l’analisi tensoriale - per effettuare calcoli su uno spazio curvo. Armato di questi nuovi strumenti matematici, Einstein si mette alla ricerca dell’equazione che governa la dinamica del campo gravitazionale (cioè dello spazio-tempo) e le sue interazioni. Adotta inizialmente un approccio basato su considerazioni di carattere fisico, ma la teoria che ne viene fuori ha seri difetti ed è presto abbandonata.
Si arriva così al fatidico novembre del 1915 - il terzo e conclusivo atto. Dopo due anni di stallo, Einstein opta per una strategia di ricerca diversa, più matematica. È la scelta giusta. Nell’arco di poche settimane, con un sforzo straordinario - stimolato dalla competizione con uno dei più grandi matematici dell’epoca, David Hilbert, che ha cominciato a lavorare sullo stesso problema -, arriva alla teoria definitiva.
Ne dà notizia all’Accademia berlinese in una serie di quattro comunicazioni settimanali, nell’ultima delle quali, il 25 novembre 1915, presenta l’equazione fondamentale della nuova teoria: un capolavoro di essenzialità e di eleganza, scritto nel linguaggio di Ricci e Levi-Civita. L’equazione mette in relazione la curvatura dello spazio-tempo con la densità di materia e di energia: in presenza di masse e di sorgenti di energia, lo spazio-tempo si deforma, ed è questa deformazione che chiamiamo gravità. Geometria e fisica sono dunque legate inestricabilmente e si influenzano a vicenda.
Rifacendo i calcoli della deflessione della luce sulla base della nuova teoria, Einstein ottenne un angolo doppio rispetto a quello previsto qualche anno prima. Per osservare il fenomeno si dovette però aspettare l’eclissi totale di Sole del 1919, visibile nella fascia equatoriale. Due spedizioni britanniche, organizzate dall’astrofisico Arthur Eddington, diedero il risultato tanto atteso: la piccolissima deviazione misurata era in accordo con la predizione relativistica. “Rivoluzione nella scienza”, “Newton spodestato”, “Svolta epocale”, titolarono i giornali di mezzo mondo, segnando l’inizio della fama planetaria di Einstein. Il quale fu ovviamente molto soddisfatto del risultato. Ma, com’era nel suo stile, a una studentessa che gli chiedeva come avrebbe reagito se le osservazioni avessero contraddetto la teoria, rispose semplicemente: «Mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio, perché la teoria è corretta».
-
> LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica" --- La svolta dal calcolo tensoriale. Einstein salvato dalle formule di un prof italiano (di Giovanni Bignami)18 novembre 2015, di Federico La Sala
La svolta dal calcolo tensoriale
Einstein salvato dalle formule di un prof italiano
di Giovanni Bignami (La Stampa - TuttoScienze, 18.11.15)
La Relatività generale è difficile da capire perché va al di là della nostra intuizione. Ma, prima di affrontarla, nel centenario della scoperta, proviamo a capire che uomo fosse Albert Einstein nell’Europa del secolo scorso, così vicina (mio nonno era del 1879, come Einstein) e pur così lontana (due guerre mondiali e un Muro fa).
Einstein aveva 36 anni nel 1915, e già una vita ricca ma complicata alle spalle. Dieci anni prima, nel tempo libero dal suo lavoro di impiegato all’Ufficio Brevetti di Berna, aveva scritto in un sol colpo tre lavori rivoluzionari, con uno dei quali prese poi il Nobel nel ’21, e avrebbe potuto prenderne altri due. Prima ancora, a 17 anni, aveva rigettato la cittadinanza tedesca per diventare svizzero, aveva convissuto nel peccato con una ragazza serba, genio della matematica, l’unico studente donna del Politecnico di Zurigo, dalla quale aveva avuto una bambina, poi scomparsa.
Gregorio Ricci Curbastro
Nel 1902, finalmente, la sposò (ma lei era stata già espulsa dal severo Politecnico) e ci fece due figli maschi, prima di separarsi da lei e tornare in Germania, come prof all’Università di Berlino, riprendere la cittadinanza tedesca e diventare membro della Accademia e direttore dell’Istituto di fisica. Sorprendente la Germania del 1915, da più di un anno in una guerra terribile. Grandi onori ad un ebreo, che aveva ripudiato la patria, era violentemente antimilitarista (gli altri maschi della sua classe erano già al fronte...) e di dubbia moralità: aveva anche, da anni, una relazione con la cugina Elsa (che poi sposerà), pur vivendo da solo in modo trasandato, mangiando poco e male e suonando molto il violino.
Ma quest’uomo difficile stava lavorando alla sua più grande teoria fisica, una teoria che lo consumava, anche perché era convinto di sapere poco la matematica. Alla fine chiese aiuto ad amici, in Svizzera ed in Italia, e capì che lo strumento matematico del quale aveva bisogno era il calcolo tensoriale appena inventato da un matematico italiano, Gregorio Ricci Curbastro.
Grazie a questa nuova matematica, Albert (che allora aveva i capelli neri) dà una costruzione formale alla «idea più brillante della sua vita», come chiamava la teoria della Relatività generale. I tensori di Ricci descrivono la geometria dello spazio-tempo, che si deforma, o meglio si incurva con eleganza, in presenza di un massa. Si va al di là (non contro) Newton: la mela non cade perché attirata dalla massa della Terra, ma perché scivola sulla curvatura spazio-temporale che la Terra, con la sua massa, genera intorno a sé. E questo è vero per tutto ciò che ha massa, compresa l’energia, secondo la rivoluzionaria e famosissima equazione (di Einstein) E=mc2.
La massa, con la gravità ad essa associata, è quindi al centro della teoria della Relatività generale perché influenza la metrica dello spazio-tempo. Alla base Einstein pose il principio di equivalenza: la massa inerziale e la massa gravitazionale sono equivalenti. Quando dò un calcio a un sasso, il male che mi faccio al piede dipende dalla massa del sasso, che è definibile, quindi, come l’inerzia che il corpo oppone all’essere messo in moto. Questa massa «inerziale», però, potrebbe essere diversa dalla massa che viene attratta dalla Terra, o meglio che fa scivolare il sasso nella curvatura dello spazio generata dalla Terra, insomma, la massa «gravitazionale» del sasso stesso. Einstein postulò che le due masse fossero equivalenti e tutti noi ancora oggi ci crediamo, anzi cerchiamo di provare questo principio di equivalenza con esperimenti sempre più sofisticati, nello spazio come a Terra.
Ai primi di novembre di 100 anni fa la teoria era pronta e Einstein la presentò in alcune lezioni nella maestosa biblioteca dell’Accademia di Berlino. Il 18 novembre venne data la prima conferma osservativa. La nuova teoria spiegava perfettamente alcune «anomalie» dell’orbita di Mercurio. Einstein annota quanto sia grato alla precisione di quegli astronomi che avevano osservato il moto del piccolo pianeta, annotandone le posizioni anche senza riuscire a spiegarle.
La prova regina
E ancora dalla astronomia venne, anni dopo, la prova regina della curvatura della luce nel campo gravitazionale. Durante un’eclisse, nel 1919, la posizione di una stella, davanti alla quale transitava il Sole, risultò «spostata», rispetto alla sua solita posizione, giusto della quantità prevista dalla attrazione della massa del Sole sui fotoni in arrivo dalla stella. Sempre dalla astronomia verranno le più importanti conferme, come il fenomeno della «lente gravitazionale», che rende visibile galassie lontanissime, e molte altre. Tra pochi giorni, invece, con i nostri migliori auguri, partirà una missione spaziale europea, con cuore italiano, destinata proprio a controllare se, anche nello spazio, massa inerziale e massa gravitazionale sono equivalenti.
-
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE ---- Riflessioni di Gramsci dal "Del genere e della specie. Francesco e Nanni" (di Giuseppe Panissidi)30 aprile 2015
- CON MARX, OLTRE. PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
 RELAZIONI CHIASMATICHE E POTERE: UN NUOVO PARADIGMA. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
RELAZIONI CHIASMATICHE E POTERE: UN NUOVO PARADIGMA. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
Del genere e della specie. Francesco e Nannidi GIUSEPPE PANISSIDI *
I recenti interventi di Papa Francesco e l’ultimo film di Nanni Moretti aiutano a ripensare la questione della differenza di genere, intrecciandola alla dimensione dell’ordine simbolico e dell’ordine sociale entro cui questa differenza si inscrive. L’importanza della partecipazione diretta delle donne ai grandi movimenti progressivi dell’umanità. *
[...] Sull’Avanti! del marzo del 1917, in una recensione a una rappresentazione di “Casa di bambola” di Ibsen, Gramsci si interroga e ci interroga sulle ragioni dell’apparente insensibilità degli spettatori - uomini e donne - di fronte al dramma di Nora Elmer, la quale “abbandona la casa, il marito, i figli, per cercare se stessa”. E non esita a ricondurre un comportamento siffatto alla morale borghese più retrograda, incapace di comprendere che “la famiglia non è più un istituto economico, ma è specialmente un mondo morale in atto, che si completa per l’intima fusione di due anime che trovano l’una nell’altra ciò che manca a ciascuna individualmente; per il quale la donna è una creatura umana a sé, che ha una coscienza a sé, che ha dei bisogni interiori suoi, che ha una personalità umana tutta sua e una dignità di essere indipendente”.
 Lucida ed acuta in Gramsci la consapevolezza della necessità storica e politica della formazione di una nuova personalità femminile, una questione di alto spessore morale e civile. “Finché la donna, scrive nelle “Note su Machiavelli”, non avrà raggiunto non solo una reale indipendenza di fronte all’uomo, ma anche un nuovo modo di concepire se stessa e la sua parte nei rapporti sessuali, la questione sessuale rimarrà ricca di caratteri morbosi e occorrerà esser cauti in ogni innovazione legislativa”. Quella fase di storia e di cultura non permetteva a Gramsci di allargare il suo campo di riflessione a una visione più avanzata delle specifiche questioni agitate dai movimenti femministi e dalle loro rivendicazioni dell’emancipazione, in un quadro di completa auto-affermazione. Precondizione irrinunciabile a una nuova e più autentica dimensione di genere, abitata - questo il lontano auspicio di F. Engels, nell’aurora del socialismo moderno - da “una generazione di uomini i quali, durante la loro vita, non si saranno mai trovati nella circostanza di comperarsi la concessione di una donna con il denaro o mediante altra forza sociale, e una generazione di donne che non si saranno mai trovate nella circostanza né di concedersi a un uomo per qualsiasi motivo che non sia vero amore, né di rifiutare di concedersi all’uomo che amano”.
Lucida ed acuta in Gramsci la consapevolezza della necessità storica e politica della formazione di una nuova personalità femminile, una questione di alto spessore morale e civile. “Finché la donna, scrive nelle “Note su Machiavelli”, non avrà raggiunto non solo una reale indipendenza di fronte all’uomo, ma anche un nuovo modo di concepire se stessa e la sua parte nei rapporti sessuali, la questione sessuale rimarrà ricca di caratteri morbosi e occorrerà esser cauti in ogni innovazione legislativa”. Quella fase di storia e di cultura non permetteva a Gramsci di allargare il suo campo di riflessione a una visione più avanzata delle specifiche questioni agitate dai movimenti femministi e dalle loro rivendicazioni dell’emancipazione, in un quadro di completa auto-affermazione. Precondizione irrinunciabile a una nuova e più autentica dimensione di genere, abitata - questo il lontano auspicio di F. Engels, nell’aurora del socialismo moderno - da “una generazione di uomini i quali, durante la loro vita, non si saranno mai trovati nella circostanza di comperarsi la concessione di una donna con il denaro o mediante altra forza sociale, e una generazione di donne che non si saranno mai trovate nella circostanza né di concedersi a un uomo per qualsiasi motivo che non sia vero amore, né di rifiutare di concedersi all’uomo che amano”. - CON MARX, OLTRE. PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- FISICA E BIOLOGIA. Il tempo ha ripreso a scorrere (di Sandro Modeo)25 gennaio 2015, di Federico La Sala
Il tempo ha ripreso a scorrere
Un fisico sovverte le teorie di Einstein, una psicologa e un neurobiologo sembrano descrivere il fluire delle ore come un’illusione del cervello. Ma una convergenza è possibile
di Sandro Modeo (Corriere della Sera - La Lettura, 25.01.2015)
Fino a poco tempo fa, le prospettive della scienza sul «mistero del tempo» si diramavano in due direzioni alternative. Da una parte avevamo la fisica, tendente a presentarlo come un’illusione dei sensi e quindi a negarlo: se per Einstein e Minkowski il tempo non è altro che una dimensione del palcoscenico cosmico (la quarta, inseparabile dalle tre dello spazio), alle invisibili scale quantistiche - a maggior ragione - non esistono direzioni spaziotemporali: l’euritmica «danza delle Ore» del mito greco si frange qui nel brulichio casuale degli atomi. Dall’altra parte, avevamo la biologia, surrogata dall’esperienza, in cui il tempo scandisce le sequenze degli organismi (nascita-sviluppo-riproduzione-morte) in un senso irreversibile: la sequenza retrograda è possibile solo in certe fiction, come nel Philip K. Dick di In senso inverso , dove i morti («bussando» dall’interno delle bare) regrediscono in adulti, bambini e poi feti accolti da ventri materni a loro volta in regressione temporale, fino all’implosione completa.
Ma adesso il quadro sembra complicarsi e - in apparenza - capovolgersi. Un fisico teorico autorevole e originale come Lee Smolin propone un libro «militante» ( La rinascita del tempo ) in cui sovverte il paesaggio della fisica, reimmettendovi il fluire del tempo come svolta metodologico-filosofica; mentre le scienze cognitive e le neuroscienze (pensiamo a un libro recente della scrittrice-psicologa Claudia Hammond, Time Warped , tempo «piegato» o «distorto» e a uno prossimo del giovane neurobiologo Dean Buonomano, The Brain Is a Time Machine ) sembrano descrivere il «senso del tempo» nel cervello come uno spettro di variazioni illusorie nella nostra rappresentazione del mondo esterno.
Per argomentare la sua ambiziosa proposta-break, Smolin costruisce il libro in due «movimenti». Nel primo (più breve) riassume forza e suggestione della visione dominante: quell’«universo-blocco» in cui le leggi fondamentali - dal moto alla gravitazione - preesistono alla materia istruendone le dinamiche. È un universo simile a una rete astratta e immutabile, dove il tempo è traducibile in geometria atemporale e dove (seguendo la cosmologia quantistica di Julian Barbour, l’autore della Fine del tempo ) ogni oggetto o evento è simile a un’istantanea in una «vasta collezione di momenti congelati», dissolvendo - col prima e il dopo - anche i nessi causali tra i fenomeni. Nel secondo movimento (risalendo a intuizioni di Dirac, Wheeler e Feynman), Smolin mostra invece le leggi fisiche soggette allo stesso processo evolutivo («temporale») degli organismi viventi, e in quanto tali inseparabili dalla materia e dalle sue proprietà fisico-chimiche.
In questo modo, le leggi si mutano da fondamentali in «approssimate» ed «emergenti», sempre penultime rispetto ad altre «più» fondamentali: al punto che la loro efficacia, paradossalmente, consiste nell’applicarsi a dinamiche locali (Smolin parla di «troncamenti di natura»), a porzioni perimetrate di universo piuttosto che all’universo intero.
Non tutto, in questo re-ingresso del tempo in fisica, è convincente. Per esempio, l’analogia tra evoluzionismo biologico e cosmologico appare, al momento, sfocata e spericolata: vedi il paragone tra la selezione naturale nelle specie (per mutazioni-variazioni genetiche) e quella tra universi in competizione attraverso i buchi neri e le loro «discendenze» (ce ne sono, nell’universo conosciuto, un miliardo di miliardi), anche se proprio quest’ipotesi è stata di recente vagliata dallo zoologo di Oxford Andy Gardner. Si tratta però di sfocature, sia chiaro, in un libro che ha il merito non trascurabile di riportare nella disciplina una ventata di realismo adulto, dopo lunghe infatuazioni metafisiche, dalle «teorie del Tutto» al multiverso.
Come si diceva, i libri della Hammond e di Buonomano sembrano invece inquadrare il «senso del tempo» nel cervello come configurazione illusoria, fitta di distorsioni e autoinganni. «Sembrano», perché in realtà il loro obiettivo è mostrare come quel «senso» - innegabile - sia tutt’altro che oggettivo; se lo fosse, non avremmo bisogno di orologi e cronometri.
Tutto parte dal fatto che il «tempo interno» è un’applicazione particolare di schemi mentali adattativi (consci e inconsci) più generali e flessibili, selezionati dall’evoluzione per l’orientamento, la fuga/predazione e la riproduzione.
A rigore, in effetti, l’unico vero «orologio biologico» di cui disponiamo è la regolazione del rapporto sonno/veglia rispetto alla luce e alla temperatura, la cui base neurale è nell’ipotalamo: orologio peraltro non esclusivo dei mammiferi, dato che lo posseggono anche piante, fiori e persino batteri (certe proteine-orologio che si autoregolano su cicli di 24 ore).
Per sotto-orologi più specifici, ricorriamo a un patchwork funzionale prelevato da un ventaglio di aree e circuiti neurali adibiti ad altre funzioni, spesso linkati tra loro: il cervelletto (che presiede al movimento) per valutare i millisecondi; il lobo frontale (memoria di lavoro) per i secondi; i gangli basali (funzioni motorie ed emotività) per discriminare ritmi e affetti della musica; e soprattutto, di nuovo, l’ipotalamo (coinvolto nella memoria a lungo termine) per visualizzare il futuro e predisporre strategie predittive; anche qui, senza particolari privilegi di specie, come mostra il minuscolo colibrì rosso, capace di valutare i 20 minuti necessari a un fiore per caricarsi di nettare prima di affondarvi il becco.
Decisive, nella modulazione di questo patchwork (che intreccia senso dello spazio e del numero, memoria ed emozione) sono le variabili ambientali-culturali: a popolazioni come gli amazzonici Amondawa (che non hanno parole per le unità di tempo, né calendari) si oppongono le nostre società iper-cronometrate, dove tutti siamo come il Bianconiglio di Alice; mentre la rappresentazione mentale di passato e futuro segue le direzionalità del metodo di scrittura: gli occidentali da sinistra a destra, gli arabi e gli ebrei al contrario, i sinofoni in senso verticale, col passato in alto e il futuro in basso.
E altrettanto contano le variabili soggettive oscillanti tra fisiologia e patologia, che si traducono in una vera fantasmagoria di fattori distorsivi del tempo. Alcuni sono immediati: la paura e la malattia lo rallentano, l’euforia o l’attenzione lo accelerano. Altri sono più sorprendenti, come le visioni sinestetiche, in cui i giorni si associano ai colori, i mesi a cerchi anti-orari o a spirali, gli anni a ellissi imperfette. Altri ancora, sono perturbanti: è il caso delle crono-alterazioni nell’isolamento o in certe lesioni cerebrali, dell’«eterno presente» nei bambini iperattivi, del non-tempo negli psicotici.
Del resto, che il tempo abbia una «forma» lo ricorda anche il codice Morse, dove l’alternanza di punti e linee con i relativi intervalli fa emergere le frasi un po’ come i puntini fanno emergere volti o alberi nei quadri di Seurat.
Alla fine di questo percorso incrociato - tra soluzioni aperte e domande inevase - è possibile almeno reimpostare la rotta concettuale. Condividendo la cerniera evoluzionistica, la prospettiva di Smolin e quella di Hammond-Buonomano convergono anche nel descrivere quella dialettica fluida tra cervello e ambiente (esteso dalla stanza in cui siamo alle vastità dell’universo) di cui l’ordine temporale è solo un aspetto, anche se tutt’altro che secondario. Se, come scrive Putnam, «la mente e la realtà costruiscono insieme la mente e la realtà», anche il tempo deve rientrare in questa costruzione. Separati solo per convenzione - in quanto unica e contigua è la materia che li veicola - il tempo «esterno» della fisica e quello «interno» del cervello cercano una difficile sincronia: ma pensare che il primo possa scorrere senza passare per il filtro del secondo, questa sì è un’illusione, se non un’allucinazione.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- 2015. Fiat lux. Dio? È soprattutto luce. Dal microscopio alle stelle: L’informazione corre su una ragnatela scintillante.18 gennaio 2015
L’Unesco ha dichiarato il 2015 l’anno della luce
Un lungo viaggio attraverso la luminosità: dal microscopio alle stelle
di Piero Bianucci (La Stampa, 18.01.2015)
Le parole che state leggendo hanno percorso migliaia di chilometri sotto forma di impulsi di luce imprigionati in sottili fili di vetro. Il pianeta intero è avvolto in una ragnatela di questi fili che chiamiamo Internet. Gli impulsi corrispondono a due soli segni: 0 e 1, l’alfabeto digitale. Parole, musica, fotografie, filmati, finanza, giornali, programmi radio e tv, sms, twitter, tutto oggi è scritto con questo semplice codice di minuscoli lampi e scavalca montagne e oceani correndo a 200 mila chilometri al secondo.
Nel 1870 il fisico irlandese John Tyndall dimostrò con uno zampillo luminoso che un raggio di luce poteva essere incanalato nel percorso di un getto d’acqua. Fu quella la prima fibra ottica, poco pratica perché allo stato liquido, ma carica di promesse all’epoca insospettabili. In attesa di meglio, la scoperta fu applicata a giochi d’acqua nelle fontane di epoca vittoriana. Amico di Faraday, un ex rilegatore di libri autodidatta, pioniere nello studio dei fenomeni elettrici, Tyndall fu anche il primo scienziato a dimostrare sperimentalmente l’effetto serra. Due contributi che sarebbero stati compresi nella loro importanza solo un secolo dopo.
La prima applicazione delle fibre ottiche arriva nel 1956 in un gastroscopio: servì ai medici per guardare dentro lo stomaco dei pazienti. Nello 1965 Charles Kao, premio Nobel per la fisica nel 2009 (meglio tardi che mai), perfezionò le fibre ottiche e suggerì la loro applicazione nelle telecomunicazioni.
I tempi non erano maturi: Laser e Led - tecnologie necessarie per ottenere impulsi luminosi brevi, puri e potenti - erano ai loro inizi, l’optoelettronica quasi non esisteva, le fibre erano ancora troppo poco trasparenti e flessibili, non si sapeva come saldarle e come piegarle in curve strette. Così trovarono applicazione in lampade che ebbero una effimera fortuna, zampilli di luce sotto vetro che nei salotti degli Anni 60 e 70 imitavano i getti di acqua luminosi di Tyndall.
Le fibre ottiche sono fatte di vetro o di polimeri plastici tirati in filamenti dal diametro di un capello (125 millesimi di millimetro). Nella sezione di questi esili cavi trasparenti l’indice di rifrazione varia dal centro alla periferia in modo tale che la luce venga deviata e trattenuta dentro la fibra anziché sfuggire dalla «buccia» del filamento. La luce che percorre una fibra ottica subisce quindi continue riflessioni che la mantengono incanalata, con perdite minime, su percorsi che possono essere lunghissimi.
La luce utilizzata non è quella visibile ma appartiene a particolari bande dell’infrarosso, con lunghezze d’onda comprese tra 850 e 1550 milionesimi di millimetro. I nostri occhi non percepiscono questo genere di luce ma certi serpenti, insetti e altri animali che hanno occhi sensibili all’infrarosso potrebbero vederla.
Scavalcare l’Oceano Atlantico senza amplificazioni intermedie è alla portata di questa tecnologia. A questo punto «basta» avere una sorgente di luce pura e rapidamente pulsata (appunto i Laser o i Led) come trasmettitore, la fibra ottica come mezzo trasmissivo e un sensore di luce al punto di arrivo, e il gioco è fatto: abbiamo un sistema di telecomunicazione su fibra ottica. E poiché la quantità di informazioni caricabile su un’onda elettromagnetica aumenta al diminuire della lunghezza delle onde utilizzate, o se volete all’aumentare della frequenza, e gli impulsi luminosi durano miliardesimi di secondo, la luce può veicolare una quantità di dati enormemente maggiore delle onde radio, microonde incluse.
Su una singola fibra, per intenderci, può viaggiare l’intero traffico telefonico tra due continenti. Il primo cavo ottico transatlantico entrò in servizio nel 1988. I cristalli fotonici segnarono nel 1996 un ulteriore miglioramento delle fibre e da allora i progressi non si sono mai fermati.
Trattandosi di cosa nuova e costosa, furono i militari americani i primi utilizzatori della comunicazione su fibra ottica. Incominciò la Marina statunitense sulla nave ammiraglia della Sesta Flotta, seguì nel 1976 l’Aeronautica militare cablando i propri aerei. La trasmissione di un segnale televisivo su fibra era già stato esibito nel 1971 alla regina Elisabetta d’Inghilterra, nel 1980 toccò al popolo in occasione delle Olimpiadi invernali di Lake Placid (Usa). Da allora la tv su fibra non ha fatto che crescere, e ancora più la trasmissione dati. Senza le autostrade ottiche non esisterebbe Internet, non esisterebbe questo mondo, questa società. La tecnologia è cultura, costume, politica.
Fiat lux
Dio? È soprattutto luce
2015, anno della luce promosso dall’Unesco
Domani a Parigi, tra i relatori, ci sarà il cardinale Ravasi. Un brano in anteprima
di Gianfranco Ravasi s.j. (Il Sole-24 Ore, Domenica, 18.01.2015)
In tutte le civiltà la luce passa da fenomeno fisico ad archetipo simbolico, dotato di uno sterminato spettro di iridescenze metaforiche, soprattutto di qualità religiosa. La connessione primaria è di natura cosmologica: l’ingresso della luce segna l’incipit assoluto del creato nel suo essere ed esistere. Emblematico è l’avvio stesso della Bibbia, che è pur sempre il «grande codice» della cultura occidentale: Wayy’omer ’elohîm: Yehî ’ôr. Wayyehî ’ôr, «Dio disse: "Sia la luce!" e la luce fu!» (Genesi 1,3). Un evento sonoro divino, una sorta di Big bang trascendente, genera un’epifania luminosa: si squarcia, così, il silenzio e la tenebra del nulla per far sbocciare la creazione.
Anche nell’antica cultura egizia l’irradiarsi della luce accompagna la prima alba cosmica, segnata da una grande ninfea che esce dalle acque primordiali generando il sole. Sarà soprattutto questo astro a diventare il cuore stesso della teologia dell’Egitto faraonico, in particolare con le divinità solari Amon e Aton. Quest’ultimo dio, con Amenofis IV-Akhnaton (XIV sec. a. C.), diventerà il centro di una specie di riforma monoteistica, cantata dallo stesso faraone in uno splendido Inno ad Aton, il disco solare: tale riforma, però, passerà come una meteora di breve durata nel cielo del tradizionale politeismo solare egizio.
Similmente l’arcaica teologia indiana dei Rig-Veda considerava la divinità creatrice Prajapati come un suono primordiale che esplodeva in una miriade di luci, di creature, di armonie. Non per nulla, in un altro movimento religioso originatosi in quella stessa terra, il suo grande fondatore assumerà il titolo sacrale di Buddha, che significa appunto «l’Illuminato».
E, per giungere in epoche storiche più vicine a noi, anche l’Islam sceglierà la luce come simbolo teologico, tant’è vero che un’intera "sura" del Corano, la XXIV, sarà intitolata An-nûr, «la Luce». Al suo interno un versetto sarà destinato a un enorme successo e a un’intensa esegesi allegorica nella tradizione "sufi" (in particolare col pensatore mistico al-Ghazali nell’XI-XII sec.).
È il verso 35 che suona così: «Dio è luce in cielo e sulla terra. La sua luce è come quella di una lampada collocata in una nicchia. La lampada è rinchiusa in un cristallo, è come una stella dallo splendore abbagliante ed è accesa dall’olio di un ulivo benedetto ... Luce su luce è Dio. Egli guida chi ama verso la sua luce».
Si potrebbe continuare a lungo in questa esemplificazione passando attraverso le molteplici espressioni culturali e religiose di Oriente e di Occidente che adottano come cardine teologico un dato che è alla radice della comune esperienza esistenziale umana. La vita, infatti, è un «venire alla luce» (come in molte lingue è definita la nascita), ed è un vivere alla luce del sole o guidati nella notte dalla luce della luna e delle stelle.
Dati anche i limiti della nostra analisi, noi ora ci accontenteremo di due sole osservazioni essenziali, destinate soltanto a far intuire la complessità dell’elaborazione simbolica edificata su questa realtà cosmica. Da un lato approfondiremo la qualità "teo-logica" della luce per cui essa è un’analogia per parlare di Dio; dall’altro lato, esamineremo la dialettica luce-tenebre nel suo valore morale e spirituale. Avremo come punto di riferimento esemplificativo la Bibbia che ha generato per la cultura occidentale un "lessico" ideologico e iconografico fondamentale. Essa può offrirci un paradigma sistematico esemplare generale, dotato di una coerenza interna significativa.
Le Scritture ebraico-cristiane sono state, per altro, un rimando culturale capitale per interi secoli, come riconosceva un testimone ineccepibile e alternativo come il filosofo Friederich Nietzsche: «Tra ciò che noi proviamo alla lettura di Pindaro o di Petrarca e a quella dei Salmi biblici c’è la stessa differenza tra la terra straniera e la patria» («materiali preparatori» per Aurora).
A differenza di altre civiltà che, in modo semplificato, identificano la luce (soprattutto solare), con la stessa divinità, la Bibbia introduce una distinzione significativa: la luce non è Dio, ma Dio è luce. Si esclude, perciò, un aspetto realistico panteistico, e si introduce una prospettiva simbolica che conserva la trascendenza, pur affermando una presenza della divinità nella luce che rimane, però, «opera delle sue mani».
Si devono intendere così le affermazioni che costellano gli scritti neotestamentari attribuiti all’evangelista Giovanni. In essi si dichiara: ho Theòs phôs estín, «Dio è luce» (1Giovanni 1,8). Cristo stesso si auto presenta così: egô eímì to phôs tou kósmou, «io sono la luce del mondo» (Giovanni 8,12). In questa linea va quel capolavoro letterario e teologico che è l’inno che apre il Vangelo di Giovanni ove il Lógos, il Verbo-Cristo, è presentato come «luce vera che illumina ogni uomo» (1,9).
Quest’ultima espressione è significativa. La luce viene assunta come simbolo della rivelazione di Dio e della sua presenza nella storia. Da un lato, Dio è trascendente e ciò viene espresso dal fatto che la luce è esterna a noi, ci precede, ci eccede, ci supera. Dio, però, è anche presente e attivo nella creazione e nella storia umana, mostrandosi immanente, e questo è illustrato dal fatto che la luce ci avvolge, ci specifica, ci riscalda, ci pervade. Per questo anche il fedele diventa luminoso: si pensi al volto di Mosè irradiato di luce, dopo essere stato in dialogo con Dio sulla vetta del Sinai (Esodo 34,33-35).
Anche il fedele giusto diventa sorgente di luce, una volta che si è lasciato avvolgere dalla luce divina, come afferma Gesù nel suo celebre «discorso della Montagna»: «Voi siete la luce del mondo ... Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini» (Matteo 5,14.16).
Sempre in questa linea, se la tradizione pitagorica immaginava che le anime dei giusti defunti si trasformassero nelle stelle della Via lattea, il libro biblico di Daniele assume forse questa intuizione ma la libera dal suo realismo immanentista trasformandola in una metafora etico-escatologica: «I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre» (12,3).
E nel cristianesimo romano dei primi secoli - dopo che si era scelta la data del 25 dicembre per il Natale di Cristo (quella data era la festa pagana del dio Sole, nel solstizio d’inverno che segnava l’inizio dell’ascesa della luce, prima umiliata dall’oscurità invernale) - si inizierà nelle iscrizioni sepolcrali a definire il cristiano là sepolto come eliópais, «figlio del Sole». La luce che irradiava Cristo-Sole era, così, destinata ad avvolgere anche il cristiano.
Anzi, nella successiva tradizione cristiana, si stabilirà una sorta di sistema solare teologico: Cristo è il sole; la Chiesa è la luna, che brilla di luce riflessa; i cristiani sono astri, non dotati però di luce propria ma illuminati dalla luce suprema celeste. Che si tratti di una visione squisitamente simbolica destinata a esaltare la rivelazione e la comunione tra la trascendenza divina e la realtà storica umana appare evidente in un passo sorprendente ma coerente dell’ultimo libro biblico, l’Apocalisse, ove nella descrizione della città ideale del futuro escatologico perfetto, la Gerusalemme nuova e celeste, si proclama: «Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà» (22,5). La comunione dell’umanità con Dio sarà allora piena e ogni simbolo decadrà per lasciare spazio alla verità dell’incontro diretto.
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. --- “Il vero Bach si chiamava Magdalena”. Martin Jarvis: “Lei era un genio e le partiture sono sue. Ho le prove certe: c’è anche la firma”.10 gennaio 2015, di Federico La Sala
“Il vero Bach si chiamava Magdalena”
Il direttore d’orchestra Martin Jarvis: le “Suites” le ha composte la moglie
“Lei era un genio e le partiture sono sue. Ho le prove certe: c’è anche la firma”
di Roberto Brunelli (la Repubblica, 09.01.2015)
ANNA Magdalena era giovane, forse bella. Era devota a suo marito. Suo marito era tutto, suo marito era un genio, suo marito era il Kapellmeister Johann Sebastian Bach. Lo accompagnava in concerto. Lei cantava, lui suonava il clavicembalo. Ma ancora più spesso la ragazza se ne stava in casa, a Köthen, china sulle carte. A trascrivere partiture. Copie su copie, centinaia di pagine di suoni. Musica assoluta, rivolta a Dio. Fin qui la storia, quella conosciuta: lui il creatore, lei la fedele copista.
Ora, però, c’è un signore di nome Martin Jarvis, riverito professore alla Charles Darwin University in Australia e direttore d’orchestra, il quale se ne esce con una teoria - lui parla di “prove” - che mette sottosopra non solo quella storia ma anche gli ultimi trecento anni di conoscenza musicale. Eccola: le “Suites per violoncello solo”, monumento dell’ingegno umano come lo sono la Cappella Sistina per l’arte o le Piramidi nell’architettura, non le ha scritte Johann Sebastian Bach. Le ha scritte Anna Magdalena, sua seconda moglie. Lui, Jarvis, esibisce prove grafologiche, una serrata ricostruzione storica e analisi approfondite sul manoscritto realizzato dalla giovane sposa (l’originale autografo del Kapellmeister è andato perduto - o non esiste, appunto): insomma quelle pagine sono Written by Mrs Bach, come dice il titolo del libro di Jarvis e anche di un documentario che sta facendo furore in vari festival europei. Ovvio che le teorie del professore e musicista - nonché figlio di un commissario di polizia gallese - incontrano molta fiera ostilità e discreto sconcerto, soprattutto in ambito accademico: ma sono critiche alle quali lui contrappone un’intera vita di studioso nei meandri della “galassia Bach”, compresi saggi, lezioni universitarie, articoli scientifici.
Scusi, professor Jarvis, ci spieghi bene: è come se qualcuno oggi ci dicesse “non è stato Leonardo a dipingere la Gioconda”...
«Quel che dico io è che le Suites per violoncello sono l’opera di un genio: e questo è Anna Magdalena Bach! Dunque, noi accettiamo senza problemi che Mozart a cinque anni fosse un fenomeno musicale, ma ci sembra impossibile dare lo stesso credito ad una giovane ragazza, una ventenne di cui già sappiamo che fosse un grande talento. Johann Sebastian era suo insegnante e mentore, indubbiamente, ma lei era un genio. Il che appare in tutta la sua evidenza a qualsiasi musicista che esamini da vicino la relazione armonica tra i due minuetti e la sua progressione nel secondo minuetto nella prima Suite».
Ma com’è giunto a questa scoperta?
«Sin dal primo momento in cui ho suonato il preludio della prima Suite, nel 1971, da studente alla Royal Academy of Music, il mio istinto mi disse che questa non era musica di Johann Sebastian. Il mio professore di viola Winifred Copperwheat mi raccontò che non esiste un manoscritto originale di Bach delle Suites. M’insospettii subito: c’è qualcosa di sbagliato in questa storia, pensai. Dopodiché, io capovolgo il ragionamento: da un punto di vista strettamente musicale, non c’è alcuna prova che sia stato Johann Sebastian il compositore delle Suites: mancano, per così dire, le “impronte digitali” del suo stile. In altre parole, se venissero alla luce adesso, niente le identificherebbe come musica di Bach».
Lei si è rivolto anche ad esperti calligrafi forensi, che hanno analizzato i manoscritti di Bach e di sua moglie, giusto?
«Sì. Le prove dimostrano la presenza della grafia e della scrittura musicale di Anna Magdalena anche in manoscritti in cui per tradizione non dovrebbero essere presenti, ossia in partiture che risalgono al 1713, ben sette anni prima di quando i libri di storia dicono che lei sia entrata nella vita di Bach. Uno degli esperti da me interpellati, Heidi Harralson, dichiara esplicitamente che vi è “un ragionevole grado di certezza scientifica” che sia stata Anna Magdalena a comporre le Suites. E infine c’è quella “firma” che appare su uno dei due manoscritti attraverso i quali l’opera è giunta a noi: “Ecrite par Madame Bachen, son Epouse”, ossia “scritto da madame Bach, sua sposa”. Fu il colpo di fulmine sulle mie lunghe e intense ricerche».
Ma sono un’opera rivoluzionaria, che ha ridefinito completamente il suono del violoncello...
«Certo, e non sorprende che Rostropovich le abbia suonate davanti al Muro di Berlino quando crollò. Anzi, le dico che sono ben più rivoluzionarie di altre pagine similari di Bach, per esempio le Sonate e Partite per violino solo: ogni singolo aspetto delle Suites è innovazione pura. Lo ripeto: sono state composte da un genio, Anna Magdalena, “messe insieme” ( composee) con l’assistenza di suo marito, Johann Sebastian, come indicato nel manoscritto di cui le dicevo prima».
I suoi critici però dicono che le Suites non possono esser state composte da Anna Magdalena perché aveva troppi figli a cui badare: ben tredici. Cosa risponde?
«Un argomento miserevole che ho sentito così spesso da musicisti maschi che chiaramente non sanno quanti compositori donna con bambini ci siano stati nella storia. Vi sono compositrici sin da quando esiste quella forma d’arte che si chiama musica, solo che queste non sono state riconosciute. A parte questo, casa Bach aveva molti domestici, e la prima cognata di Johann Sebastian ha vissuto con loro fino alla sua morte nel 1729, molti anni dopo che le Suites erano state composte. E poi non ci sono mai stati tutti quei bambini contemporaneamente in quella casa, molti purtroppo morirono prematuri ».
Ritiene che anche altri capolavori di Bach si possano attribuire ad Anna Magdalena?
«Sì, ritengo che lei abbia composto anche diverse pagine del primo e del secondo libro del Clavicembalo ben temperato, l’Aria delle Variazioni Goldberg e che ci sia qualche suo inserto nelle Sonate e Partite per violino solo. E forse anche molto di più».
Casals, Fournier, Yo Yo Ma, Rostropovich, Brunello... per i grandi violoncellisti della storia le Suites rappresentano più o meno l’apice di una carriera. Qual è l’interpretazione che lei ama di più?
«Io veramente adoro la versione del violoncellista inglese Stephen Isserlis: anche se lui proprio si rifiuta di credere alla mia teoria...».
Che tipo di persona era Anna Magdalena?
«Era una musicista estremamente dotata, probabilmente assai ambiziosa e guidata da un profondo desiderio di comporre musica. Penso anche che fosse molto bella: Bach fece realizzare un suo ritratto dopo il 1730 e lo teneva sempre con sé. La loro è una storia di vera passione amorosa. Purtroppo, quel ritratto è andato perduto. Ma lei, Anna Magdalena, finalmente l’abbiamo ritrovata».
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- Dalla «Genesi» alla tradizione francescana. La luce è la prima creatura anzi s’identifica con Dio9 gennaio 2015, di Federico La Sala
La luce. È la prima creatura anzi s’identifica con Dio
Dalla «Genesi» alla tradizione francescana
di Piero Stefani (Corriere della Sera, La Lettura, 04.01.2015)
San Francesco compose il Cantico di frate Sole quando aveva gli occhi cauterizzati e fasciati. Fu dunque nel buio più impenetrabile che il santo pronunciò le parole volte a lodare il Signore per il Sole, l’astro grazie al quale Egli ci illumina. Francesco lo loda per quanto benefica altri. Basterebbe ciò a indicare l’altezza di un’anima. Il Cantico si riferisce a fonti di luci visibili, senza fare alcun cenno a realtà invisibili. In un tempo in cui la corrente ereticale dei catari scorgeva nella materia il sigillo del demiurgo cattivo, Francesco celebra la bontà del Dio invisibile partendo dal mondo materiale.
Nel Cantico la spiritualità della luce è tutta legata al mondo osservato con gli occhi. In quel testo le realtà materiali non sono colte come il primo gradino di una scala che ci porta alla sfera dei beni spirituali. La lode celebra piuttosto la volontà dell’Altissimo di preoccuparsi delle sue creature. Il Sole è simbolo del Signore perché è attraverso di esso che Dio si prende cura di noi: «Et allumini noi per lui». Gesù l’aveva detto nel «Discorso della montagna»: il Padre fa sorgere il suo Sole sui cattivi e sui buoni (Matteo 5,45). La luce solare illumina e riscalda tutti senza eccezione.
Nelle sue prime righe il libro della Genesi parla di tenebre estese sull’abisso. L’oscurità è però sconfitta dalla prima parola uscita dalla bocca di Dio. Essa ci è tuttora familiare nella sua formulazione latina: «Fiat lux» (Genesi 1, 3). La parola invisibile crea la luce. La precedenza della parola ci comunica che la luce è creatura di Dio. Nessun linguaggio verbale umano riesce a trasmettere appieno quest’ idea. La musica, forse, è in grado di fare un po’ di più: l’accordo in maggiore che squarcia il «preludio del caos» nella Creazione di Franz Joseph Haydn è luminoso. Tuttavia neppure da quel suono sorge la luce.
Si tratta di pura luce, priva di fonti luminose. Il Sole, la Luna e le stelle, definite semplicemente lumi (me’orot), saranno create solo il quarto giorno (Genesi 1, 14-19): la luce, da primaria, diviene secondaria. Tra i biblisti, nell’epoca della secolarizzazione, si amava dire che il Sole, da divinità (si pensi all’Egitto), è stato trasformato in lampada. Non si tratta soltanto di desacralizzare. Il Sole è presentato come creatura di Dio perché dona luce e calore agli altri. Al quarto giorno siamo così arrivati al punto in cui il Cantico di Francesco inizia: «Et allumini noi per lui».
«Yehi ’or», «fiat lux»; era inevitabile che questa luce primordiale che precede ogni sorgente luminosa suscitasse tra gli ebrei e i cristiani una serie quasi infinita di speculazioni mistiche. Ritenere la luce la prima fra le creature comporta che tutte le altre dipendano da essa. Nella prima metà del XIII secolo il francescano Roberto Grossatesta non si limitò alla lode scritta dal fondatore del suo ordine. Per il filosofo inglese la luce è la forma prima di ogni materia creata. La speculazione metafisica, quando affronta il tema della luce, fa risuonare in lui anche corde poetiche: «La prima parola del Signore creò la natura della luce e disperse le tenebre, e dissolse la tristezza e rese immediatamente ogni specie lieta e gioiosa. La luce è bella di per sé». Per Grossatesta la luce causa nelle creature un senso di felicità.
Si può fare un passo ulteriore. Nella «civiltà del commento» la domanda del perché Dio abbia iniziato la sua opera creativa con la luce trova una risposta: «Perciò Dio, che è luce, giustamente ha cominciato l’opera dei sei giorni dalla luce stessa, di cui tanto grande è la dignità » (Grossatesta). Dalla creatura si passa così al Creatore. Dio è luce incorporea. Il termine, associato più di ogni altro al vedere, viene ora riconsegnato al mondo invisibile. Ci si inabissa addirittura, con Dante Alighieri, oltre al «ciel ch’è pura luce /luce intellettual piena d’amore» (Paradiso XXX, 39-40). Si giunge infatti nel seno stesso di Dio uno e trino.
Nella prima lettera di Giovanni si legge che «Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna» (1,5). Questa pura luce senza contrasti attesta la radicale diversità divina rispetto alle realtà create, nell’ambito delle quali la luce deve risplendere sempre tra le tenebre (Giovanni 1,5). Quando nel Credo si parla del Figlio lo si definisce «Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero». La luce, come l’amore, per sua intima natura, si espande. Ciò vale anche all’interno della vita di Dio. Un inno vespertino della liturgia cattolica esclama: «O lux, beata Trinitas et principalis Unitas» - O luce, Trinità beata e Originaria Unità. Se alla parola lux sostituissimo il termine amore, il significato non muterebbe. La prima lettera di Giovanni afferma non solo che Dio è luce, ma che Egli è anche amore (1 Gv 4,8).
La luce non la si vede, essa fa vedere. È soprattutto per il suo essere rivolta verso l’altro da sé che la luce, nella vita spirituale, è associata all’amore. Ciò vale anche per il Sole che il Padre fa sorgere sui cattivi e sui buoni. È pressoché certo che oggi quella radiosa materialità voluta dal Signore sia spiritualmente più eloquente delle speculazioni dirette all’inaccessibile vita intradivina. Il Sole non sa che ci sta illuminando, tuttavia chi lo guarda con gli occhi spirituali di frate Francesco loda Dio per il suo illuminarci attraverso l’astro che dell’Altissimo «porta significatione». Piero Stefani
-
> LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA --- 2015 l’anno della luce, per decisione dell’Onu. È questo l’anno che svelerà tutti i poteri della luce.9 gennaio 2015, di Federico La Sala
2015 l’anno della luce, per decisione dell’Onu
È questo l’anno che svelerà tutti i poteri della luce
di Gabriele Beccaria (La Stampa TuttoScienze, 07.01.2015)
Confessatelo: il 2014 era stato dichiarato l’«Anno della cristallografia» e non ve ne eravate nemmeno accorti. Pazienza. Ci saranno altre occasioni per scoprire come si organizza la materia. In Natura e in laboratorio.
Ora, però, è arrivato il 2015 e l’Onu ha pensato di trasformarlo nell’«Anno della luce». Il tema è decisamente più accattivante e potrebbe attirare l’attenzione di tanti. Sono previsti 12 mesi di mostre, convegni e iniziative. In 85 nazioni.
Qual è il motivo della mobilitazione? Non è solo un fatto di autopromozione degli scienziati. La luce e le tecnologie che la sfruttano e la manipolano - ha spiegato il presidente del comitato organizzatore John Dudley - rappresentano un’occasione unica per risolvere un’infinità di problemi: energetici e climatici, medici e agricoli. Senza dimenticare il carburante del mondo globalizzato: le comunicazioni.
L’esempio di vita quotidiana che cita Dudley è questo: con l’high-tech della fotonica si minimizzeranno i consumi in bolletta e allo stesso tempo si ridurrà l’inquinamento luminoso che ha quasi cancellato la bellezza dei cieli notturni (e la possibilità di esplorarli con i telescopi).
La promessa di Dudley è che chiunque - studente di liceo, dilettante con manie da piccolo ingegnere, pensionato curioso - troverà un motivo per appassionarsi. Oltre la classica luce dei poeti, infatti, ad abbagliarci c’è l’altra luce, quella vista, studiata e trasformata dalla scienza. Luce significa fotosintesi (e quindi un meccanismo-base della vita) e anche Big Bang (e quindi debutto dell’Universo come lo conosciamo).
La luce, d’altra parte, è stata essenziale per formulare la Teoria della Relatività, mentre quella prodotta dai laser è alla base di applicazioni a cascata, dalle misurazioni di precisione alle diagnosi mediche fino alle onnipresenti telecomunicazioni. Più luce, quindi, significherà anche più ricerca avanzata e più sviluppo sostenibile.
L’obiettivo è rendere consapevoli non solo le opinioni pubbliche, ma i «policymaker», vale a dire le stesse élite politiche che dall’Italia all’Europa (e non solo) tagliano le spese per la scienza e dimostrano una straordinaria indifferenza per il ruolo che ha e avrà nell’affrontare le questioni collettive.
Intanto la macchina degli eventi si sta mettendo in moto. In Italia si comincia il 26, a Torino, con il convegno organizzato dall’istituto di metrologia Inrim diretto da Massimo Inguscio, dalla Società di Fisica e dal Comune. E, mentre si parlerà di futuro, saranno tanti gli anniversari da celebrare. Una vera rincorsa nella storia. Meglio i lavori sull’ottica di Ibn Al-Haytham del 1015 o la nozione di luce proposta da Fresnel nel 1815? La teoria elettromagnetica della propagazione della luce di Maxwell del 1865 o l’interpretazione dell’effetto fotoelettrico di Einstein del 1905? O la scoperta della radiazione cosmica di fondo da parte di Penzias e Wilson del 1965? Stavolta sarà molto più difficile restare indifferenti.
-