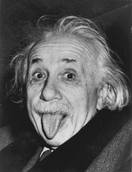
2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - a cura di Federico La Sala
martedì 19 giugno 2007.- [...] Personalità complessa e curiosa, Isaac Newton era mosso da una grande passione per la faccia misteriosa della realtà, quella che la scienza ha sempre bollato di ’superstizione’: l’alchimia come il millenarismo, la possibilità di trasformare i metalli più vili in oro lucente e il calcolo matematico per prevedere il giorno dell’Apocalisse. E questa inquietudine scientifica si è accompagnata a un amore per lo studio dei testi sacri che ha fatto dello scienziato anche un discusso teologo (considerato eretico negli ambienti ufficiali). Così, studiando i versi del libro di Daniele, proprio l’autore dei Principia mathematica ha calcolato che il mondo sarebbe scomparso esattamente 1260 anni dopo la fondazione del Sacro Romano Impero d’Occidente. Il calcolo si basa sulla durata presunta della corruzione della Chiesa, calcolata a partire dall’inizio del potere temporale del papa [...]
 Per il padre della scienza moderna il 2060 è l’anno del giudizio universale.
Per il padre della scienza moderna il 2060 è l’anno del giudizio universale.
 Il lato oscuro dello scienziato inglese: razionalismo e superstizione.
Il lato oscuro dello scienziato inglese: razionalismo e superstizione.
 L’Apocalisse secondo Isaac Newton
L’Apocalisse secondo Isaac Newton
 La lettera che predice la fine del mondo *
La lettera che predice la fine del mondo *
GERUSALEMME - Era un razionalista sir Isaac Newton. La leggenda, si sa, lo vuole sdraiato sotto un albero quando, colpito da una mela elaborò la teoria della gravità dei corpi. E se Newton è considerato il padre della scienza moderna è proprio perché le sue teorie sono nate dall’osservazione empirica della realtà.
Ma è di mano sua la lettera che viene esposta a Gerusalemme in questi giorni. Una lettera che, sulla base delle sole scritture bibliche, preannuncia la fine del mondo. E, con precisione scientifica, ne fissa la data nell’Annus Domini 2060. La lettera - Yahuda MS 7 - datata 1704, appartiene a un ricco collezionista di manoscritti scientifici e non veniva esposta al pubblico dal 1969. Oggi è il pezzo forte di una mostra allestita presso la Jerusalem’s Hebrew University dal titolo accativante, "Newton’s Secrets".
E infatti il fondatore della fisica e dell’astronomia classiche - almeno fino a quando l’avvento della teoria della relatività non ha stravolto le fondamenta scientifiche di queste discipline - coltivava un suo lato oscuro. Personalità complessa e curiosa, Isaac Newton era mosso da una grande passione per la faccia misteriosa della realtà, quella che la scienza ha sempre bollato di ’superstizione’: l’alchimia come il millenarismo, la possibilità di trasformare i metalli più vili in oro lucente e il calcolo matematico per prevedere il giorno dell’Apocalisse. E questa inquietudine scientifica si è accompagnata a un amore per lo studio dei testi sacri che ha fatto dello scienziato anche un discusso teologo (considerato eretico negli ambienti ufficiali).
Così, studiando i versi del libro di Daniele, proprio l’autore dei Principia mathematica ha calcolato che il mondo sarebbe scomparso esattamente 1260 anni dopo la fondazione del Sacro Romano Impero d’Occidente. Il calcolo si basa sulla durata presunta della corruzione della Chiesa, calcolata a partire dall’inizio del potere temporale del papa - che nell’800 d.C. incorona Carlomagno Imperatore del Sacro Romano Impero - e per un periodo indicato dal profeta Daniele in 7-25 e 12-7, dove si legge: "per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, e quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, allora tutte queste cose si compiranno". Da tali parole Newton estrasse la cifra 1260, equivalente a un anno (1), due anni (2) e la metà di un anno (6 mesi).
Una fascinazione, quella per la fine del mondo e per le teorie escatologiche, che l’ha accompagnato durante tutta la sua vita di scienziato: pare che in 50 anni di attività il professore di Cambridge abbia scritto più di 4500 pagine sul tema delle profezie.
Una questione etica lo muoveva: l’idea che anticipare il futuro ci avrebbe consentito di evitare errori, guerre e disastri. Che la profezia avrebbe salvato il bene, insomma, almeno fino all’ultimo giorno. E così si accumulavano i fogli fitti di calcoli e congetture sulla data più probabile del giorno del Giudizio.
Senza che mai, però, arrivasse a fissare un anno preciso. Ragioni di prudenza, di responsabilità o forse semplicemente di corenza scientifica. Fatto sta che a un certo punto, proprio pochi anni prima di morire, si convinse che la data poteva essere ricostruita con esattezza a partire dalle parole del profeta Daniele. Informazioni di diretta provenienza divina - almeno secondo Newton - messe nero su bianco.
Lo scienziato scrisse quella data, 2060, nella lettera che oggi viene mostrata a curiosi ed esperti. Un testo che già qualche anno fa suscitò l’interesse del mondo scientifico e, soprattutto, dei mass-media, ma che solo oggi è possibile vedere e leggere coi propri occhi. Dopo un lungo viaggio che portò le carte - quelle teologiche, profetiche ed eretiche - dagli archivi della famiglia Newton agli uffici londinesi di Sotheby’s, nel 1936, fino alle lontane sale della Jewish National and University Library.
* la Repubblica, 18 giugno 2007
Sul tema, nel sito, si cfr.:
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!).
FLS
Forum
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI - UN "BAMBINO" SULLA SPIAGGIA DELL’OCEANO CELESTE: : ISAAC NEWTON (1643 - 1727).1 settembre 2024, di Federico La Sala
UN "BAMBINO" SULLA SPIAGGIA DELL’#OCEANOCELESTE (KEPLERO A #GALILEO, 1611): ISAAC NEWTON (1643 - 1727).
ANTROPOLOGIAFILOSOFICA), #RIVOLUZIONECOPERNICANA, E #IMMAGINAZIONE SCIENTIFICA E TEOLOGICO-POLITICA...
- Una nota in memoria di #Elvio Fachinelli, #Umberto Eco #Gianni Vattimo...
“If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants.” (Isaac Newton). A ben riflettere, nel trecentesimo anniversario della #nascita di #Kant (1724 -2024), è bene anche ripensare all’intera opera di Newton ("Trattato sull’Apocalisse") e, dalle sue stesse parole, a un possibile "sottile" richiamo "cristologico", a sé stesso come un "#bambino" (#Cristo), portato sulle spalle dal #gigante "#Cristoforo" (che a sua volta diventa un altissimo "#Cristofaro", come da parola di #Alexander #Pope, poeta amatissimo da Kant).
NOTA. #Filologia #Antropologia #Teologia e #Pedagogia. "On The #Shoulders Of #Giants" (#OTSOG). "Senza di loro non vedremmo nulla, su di loro vediamo più lontano di questi San Cristoforo" (cfr. #Umberto #Eco, Introduzione all’edizione italiana: "Dicebat Bernardus Carnotensis" del libro di Robert K. #Merton, "Sulle spalle dei giganti", Società editrice il Mulino, Bologna1991).
- Note:
- Note:
 TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA" ("LA #MENTE ACCOGLIENTE, ROMA, 1991).
TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA" ("LA #MENTE ACCOGLIENTE, ROMA, 1991).
- STORIA DELLA SCIENZA E SOCIETA’. «DIO DISSE: SIA NEWTON, E TUTTO FU LUCE» (ALEXANDER #POPE): "[...] La legge di gravitazione universale, che risolveva in modo apparentemente semplice l’enigma fino allora inviolato della meccanica celeste, fu respinta da alcuni come un’ennesima qualità occulta, accettata da altri come l’idea di una mente sovrumana. «Non è lecito ai mortali emulare gli dei più di Newton»: così si conclude l’ode latina premessa da Edmond Halley alla prima edizione dei Principi. Il poeta Alexander Pope alluse in un distico alle scoperte dell’attrazione e della scomposizione della luce solare nel prisma come una seconda creazione, voluta da Dio attraverso Newton: «La natura e le sue leggi erano immerse nella notte/ Dio disse: sia Newton, e tutto fu luce». Nella metafora non manca un’allusione agli studi biblici, teologici, storici di cui Newton era profondo cultore. Nella sua biblioteca, accanto alle opere antiche e moderne di matematica, fisica e scienze naturali c’erano tutti i classici antichi e un’ampia messe di libri moderni di filosofia, storia, geografia, viaggi. [...]" (Paolo Casini, Treccani, 2006).
- MEMORIA E #STORIA: ISAAC NEWTON.
- Nature and nature’s laws lay hid in night; God said: «Let Newton be!», and all was light.
- «La Natura e le sue leggi giacevano nascoste nella notte; Dio disse; «Sia Newton!», e la luce fu.
 Versi di Alexander Pope.
Versi di Alexander Pope.
- Sibi gratulentur mortales tale tantumque exstitisse humani generis decus.
- Si rallegrino i mortali che sia esistito un tale onore per il genere umano.
 Epitaffio sulla tomba.
Epitaffio sulla tomba.
 La fama di Newton era già enorme al tempo della sua morte.
La fama di Newton era già enorme al tempo della sua morte.
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - a cura di Federico La Sala8 marzo 2024, di Federico La Sala
Newton’s Temple
A brilliant scientist as well as a prophet of doom counting down to the End of Days. A gifted physicist and a messianic mystic. Isaac Newton was a man of many contradictions. *
" [...] Albert Einstein, who understood the significance of these manuscripts, sent a letter to Avraham Shalom Yahuda which answers this very question:
- “My Dear Yahuda,
- Newton’s writings on biblical subjects seem to me especially interesting because they provide deep insight into the characteristic intellectual features and working methods of this important man. The divine origin of the Bible is for Newton absolutely certain, a conviction that stands in curious contrast to the critical skepticism that characterizes his attitude toward the churches. From this confidence stems the firm conviction that the seemingly obscure parts of the Bible must contain important revelations, to illuminate which one need only decipher its symbolic language. Newton seeks this decipherment, or interpretation, by means of his sharp systematic thinking grounded on the careful use of all the sources at his disposal.
- While the formative development of Newton’s lasting physics works must remain shrouded in darkness, because Newton apparently destroyed his preparatory works, we do have in this domain of his works on the Bible drafts and their repeated modification; these mostly unpublished writings therefore allow a highly interesting insight into the mental workshop of this unique thinker.
- Einstein. September 1940, Saranac Lake
- P.S. I think that it is wonderful that the writings will all be kept together and made available for research.
And so, without any further delay, let’s examine some of these documents...
The text below dates back to 1710 and, like other writings from this collection, contains content from two seemingly unrelated fields. At the top of the page are calculations for Queen Anne’s currency tax. Newton was appointed Master of the Royal Mint in 1700, a post he held until his death in 1727. The lower part of the page contains commentary on the concept of the Trinity. Newton first discusses Sabellianism - a doctrine that argues that divinity is embodied in one entity, alternating between the Father, the Son, and the Holy Spirit.
 Newton believed that the Hebrew Scriptures and the New Testament present God as one entity (the Father). He was of the opinion that men and women do not possess souls and that eternal life could only be achieved with the resurrection of the dead. Newton believed that Jesus was the son of God in the literal sense, not an embodiment of God himself. In his eyes, Jesus was not mortal, as he was not born to a human father.
Newton believed that the Hebrew Scriptures and the New Testament present God as one entity (the Father). He was of the opinion that men and women do not possess souls and that eternal life could only be achieved with the resurrection of the dead. Newton believed that Jesus was the son of God in the literal sense, not an embodiment of God himself. In his eyes, Jesus was not mortal, as he was not born to a human father.
 The denial of the Holy Trinity and the existence of the eternal soul were considered heresy by the Catholic Church and the Church of England, under whose auspices Newton lived and worked. Therefore, he was forced to keep his views secret, managing to evade the watchful eye of the Church. [...]"
The denial of the Holy Trinity and the existence of the eternal soul were considered heresy by the Catholic Church and the Church of England, under whose auspices Newton lived and worked. Therefore, he was forced to keep his views secret, managing to evade the watchful eye of the Church. [...]"* Cfr. https://blog.nli.org.il/en/newtons-temple/ (21.07.2019).
-
> CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! ---- CON DANTE (2021), NEL CIELO DI MARTE. Un successo il volo del drone-elicottero Ingenuity: "questo è solo il primo grande volo"(MiMi Aung).20 aprile 2021, di Federico La Sala
IN "PARADISO" (CON DANTE - 2021), NEL CIELO DI MARTE.... *
MISSIONE DI INGENUITY. “Questo è solo il primo grande volo" (MiMi Aung).
Marte, un successo il volo del drone-elicottero Ingenuity
La prima immagine, in bianco e nero
di Redazione ANSA *
- [Foto] L’ombra di Ingenuity su Marte nella prima foto del volo arrivata a Terra. E’ stata scattata dallo stesso drone-elicottero (fonte: NASA/JPL-Caltech) -
E’ stato un successo il volo su Marte del drone-elicottero Ingenuity della Nasa: è la prima dimostrazione della possibilità del volo controllato su un pianeta diverso dalla Terra e apre nuovi scenari per il futuro dell’esplorazione marziana.
Nella notte gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa avevano inviato i comandi per il volo al drone-elicottero per le 9,31 italiane di oggi e più di tre ore più tardi i dati sono arrivati a Terra.
Il centro di controllo ha ricevuto anche la prima immagine, in bianco e nero. L’ha scattata lo stesso drone, catturando la sua ombra sul suolo marziano durante il volo di circa 40 secondi nel quale si è sollevato di tre metri. L’immagine è stata scattata dalla telecamera di bordo che in modo autonomo ha tracciato il suolo durante il volo. Anche il rover Perseverance ha ripreso il volo di Ingenuity, in un breve video inviato al centro di controllo della missione.
- [Foto] Le prime immagini del volo del drone-elicottero Ingenuity ripreso dal rover Perseverance (fonte: NASA/JPL-Caltech)
Il segnale è stato trasmesso da Ingenuity al rover Perseverance, che il 3 aprile scorso aveva rilasciato il drone sulla superficie marziana, dopo averlo portato con sé nel lungo viaggio dalla Terra; dal rover il segnale è stato trasmesso alla sonda della missione Mars 2020 che si trova nell’orbita marziana, che poi lo ha inviato sulla Terra.
- [Foto] Il test dei rotori del drone-elicottero Ingenuity (fonte: NASA/JPL-Caltech)
Il volo di Ingenuity è avvenuto in modo completamente automatico. Come previsto è durato circa 40 secondi e il drone si è sollevato di circa tre metri, per atterrare sulle sue quattro zampe. Quindi il veicolo si è messo a riposo per ricaricare le batterie.
Altri voli in programma
“Questo è solo il primo grande volo", ha detto la responsabile della missione di Ingenuity, MiMi Aung, paragonando la portata del primo volo di un drone-elicottero su un altro pianeta a quella del primo volo dei fratelli Wright. Un’analogia che la Nasa ha sottolineato da subito, considerando che a bordo del drone c’è un piccolo frammento di tela dell’ala dell’aereo dei fratelli Wright.
Ulteriori dati e nuove immagini del primo volo di Ingenuity sono attesi nell’arco dei prossimi tre giorni marziani, ognuno dei quali dura circa 40 minuti in più rispetto al giorno terrestre. Sulla base di questo materiale, rileva la Nasa, si prevede di organizzare un secondo volo sperimentale non prima del 22 aprile. Se il drone elicottero supererà anche questo secondo test, il gruppo di lavoro responsabile della missione metterà a punto le caratteristiche ottimali per ulteriori voli.
* ANSA, 20 aprile 2021 (ripresa parziale).
*Nota:
- PER LA BIRMANIA!!! EMERGENZA MYANMAR: RIASCOLTARE IL SUONO DELL’ARPA BIRMANA. Rimeditare la lezione di Kon Ichikawa, "The burmese harp" (film del 1956).
#PianetaTerra #DANTE2021. #DivinaCommedia: nel V #Cielo, quello di #Marte (Paradiso XIV, 101-123: "Come distinta da minori e maggi /lumi biancheggia tra ‘ poli del mondo / Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi; / sì costellati facean nel profondo /Marte quei raggi il venerabil segno/ che fan giunture di quadranti in tondo.. E come giga e arpa, in tempra tesa /di molte corde, fa dolce tintinno / a tal da cui la nota non è intesa, /così da’ lumi che lì m’apparinno /s’accogliea per la croce una melode / che mi rapiva, sanza intender l’inno").
FLS
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. -- “Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni” (di Niccolò Guicciardini - Intervista).8 gennaio 2021, di Federico La Sala
“Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni” di Niccolò Guicciardini *
Prof. Niccolò Guicciardini, Lei è autore del libro Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni, edito da Carocci, che rivela l’ampissimo spettro degli interessi dello scienziato inglese: profondamente coinvolto in studi alchemici, erudito studioso della Bibbia, della storia della Chiesa e delle antiche civiltà, svolse anche un ruolo di primo piano nella politica e nell’economia britanniche. Di quale importanza è l’opera di Newton?
Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni, Niccolò GuicciardiniUna ricerca di “Newton” su Google - questa è la misura oggi dell’importanza di un autore - restituisce milioni e milioni di pagine. Effettivamente, la scienza è ancora basata su leggi e equazioni attribuite a Newton. La “meccanica newtoniana” con le “tre leggi della dinamica di Newton” è alla base di gran parte della fisica e della tecnologia che oggi usiamo con successo per scopi molto diversi fra loro, come costruire un ponte, inviare un satellite in orbita, prevedere i moti delle maree. L’esperimento con i due prismi che Newton elaborò da giovane è ancora oggi proposto come prova della natura composta della luce bianca. Certo, la grande rivoluzione novecentesca della nuova fisica, quantistica e relativistica, ha rovesciato molte concezioni della fisica e dell’ottica newtoniana, ma quest’ultime sono ancora teoria insegnate e applicate. Come storico sono interessato a capire come sia stata possibile questa affermazione, questa attribuzione di priorità, a volte frutto di una ricostruzione agiografica. E poi: chi era Newton? Che cosa ha veramente scoperto e sostenuto? Lo sviluppo recente della storiografia newtoniana si intreccia al destino dell’archivio dei manoscritti che Newton lasciò alla sua morte. Nelle carte private di Newton, infatti, si cela un Newton segreto, per certi versi inaspettatamente lontano dall’immagine dello scienziato celebrato dagli Illuministi e ricordato nei nostri manuali di fisica.
 I manoscritti del Newton, diciamo così, “segreto” vennero alienati in un’asta pubblica negli anni Trenta del Novecento, per la precisione nel 1936. Lo smembramento e la dispersione dell’archivio possono solo essere deplorati, eppure proprio tale vendita rese infine disponibili le carte newtoniane agli studiosi. I due principali acquirenti, che si aggiudicarono vari lotti a prezzi stracciati, furono il semitista Abraham Yahuda e l’economista John Maynard Keynes. Yahuda acquistò manoscritti relativi alla cronologia, alla teologia, alla storia della Chiesa e allo studio sulle profezie. È facile immaginare quale fascino questi aspetti dell’opera newtoniana abbiano potuto esercitare sull’animo di uno studioso di origine ebraiche, dato che non sono poche le risonanze fra la cultura ebraica e le convinzioni religiose di Newton. I manoscritti Yahuda sono oggi conservati presso la biblioteca dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Keynes invece donò i manoscritti in suo possesso, prevalentemente relativi all’alchimia e a ricordi biografici, al King’s College di Cambridge.
I manoscritti del Newton, diciamo così, “segreto” vennero alienati in un’asta pubblica negli anni Trenta del Novecento, per la precisione nel 1936. Lo smembramento e la dispersione dell’archivio possono solo essere deplorati, eppure proprio tale vendita rese infine disponibili le carte newtoniane agli studiosi. I due principali acquirenti, che si aggiudicarono vari lotti a prezzi stracciati, furono il semitista Abraham Yahuda e l’economista John Maynard Keynes. Yahuda acquistò manoscritti relativi alla cronologia, alla teologia, alla storia della Chiesa e allo studio sulle profezie. È facile immaginare quale fascino questi aspetti dell’opera newtoniana abbiano potuto esercitare sull’animo di uno studioso di origine ebraiche, dato che non sono poche le risonanze fra la cultura ebraica e le convinzioni religiose di Newton. I manoscritti Yahuda sono oggi conservati presso la biblioteca dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Keynes invece donò i manoscritti in suo possesso, prevalentemente relativi all’alchimia e a ricordi biografici, al King’s College di Cambridge.
 Keynes è autore di un saggio intitolato “Newton the Man” (1945) che fece scalpore. Dallo studio dei manoscritti in un suo possesso Keynes era arrivato alla conclusione che Newton non era stato il primo scienziato moderno ma piuttosto “l’ultimo dei maghi, l’ultimo dei Babilonesi e dei Sumeri, l’ultima grande mente che ha guardato al mondo visibile e intellettuale con gli stessi occhi di coloro che cominciarono a costruire la nostra eredità intellettuale un po’ meno di diecimila anni or sono”. In effetti i manoscritti Keynes non mancano di destare stupore: qui Newton parla in simboli ed emblemi alchemici, di uno spirito vegetativo che pervade la Natura, di trasmutazioni di metalli, di miti egizi e caldei, della sapienza di Ermete Trismegisto. Chi era dunque Newton? Il matematico che calcola le orbite dei pianeti sposando una visione deterministica della natura spogliando così con la “fredda filosofia” il “terribile arcobaleno” di ogni “incantesimo”, come lamentava John Keats. O piuttosto un eretico che, rinnegando i dogmi del cristianesimo ortodosso, concepiva la filosofia naturale come la ricerca dell’azione provvidenziale di un unico Deus pantokràtor? O, forse, l’ “ultimo dei Sumeri”, un mistico restauratore di una sapienza esoterica paganeggiante?
Keynes è autore di un saggio intitolato “Newton the Man” (1945) che fece scalpore. Dallo studio dei manoscritti in un suo possesso Keynes era arrivato alla conclusione che Newton non era stato il primo scienziato moderno ma piuttosto “l’ultimo dei maghi, l’ultimo dei Babilonesi e dei Sumeri, l’ultima grande mente che ha guardato al mondo visibile e intellettuale con gli stessi occhi di coloro che cominciarono a costruire la nostra eredità intellettuale un po’ meno di diecimila anni or sono”. In effetti i manoscritti Keynes non mancano di destare stupore: qui Newton parla in simboli ed emblemi alchemici, di uno spirito vegetativo che pervade la Natura, di trasmutazioni di metalli, di miti egizi e caldei, della sapienza di Ermete Trismegisto. Chi era dunque Newton? Il matematico che calcola le orbite dei pianeti sposando una visione deterministica della natura spogliando così con la “fredda filosofia” il “terribile arcobaleno” di ogni “incantesimo”, come lamentava John Keats. O piuttosto un eretico che, rinnegando i dogmi del cristianesimo ortodosso, concepiva la filosofia naturale come la ricerca dell’azione provvidenziale di un unico Deus pantokràtor? O, forse, l’ “ultimo dei Sumeri”, un mistico restauratore di una sapienza esoterica paganeggiante?Come si svolse la sua giovinezza?
Newton nasce nel 1642 in una famiglia di piccoli proprietari terrieri a un paio d’ore di macchina da Cambridge (il giovane Newton non percorse questo tragitto né in macchina né a cavallo, ma a piedi, quando si immatricolò nel 1661 al Trinity College). Vale la pena andare a visitare la sua casa natale a Woolsthorpe, dove è allestito un piccolo museo con tanto di albero di mele. Newton quindi viene al mondo allo scoppio delle guerre civili che dilaniano l’Inghilterra, la Scozia e l’Irlanda. La famiglia e la piccola comunità sono dolorosamente divise su questioni che riguardano la fedeltà al Re e alla Chiesa d’Inghilterra. Che cosa sappiamo del Newton bambino? Poco di certo e molta fantasia. Sappiamo che il padre muore prima della sua nascita, che la madre lo lascia alle cure dei nonni quando dopo tre anni si risposa, che Newton alloggia presso un farmacista di simpatie puritane quando frequenta una Grammar School. Sappiamo anche che legge un libro sulla Mathematical Magic, un repertorio di invenzioni che, secondo le testimonianze raccolte dopo la morte di Newton, i manoscritti sopravvissuti e le incisioni di disegni geometrici ancora ammirati dai visitatori della casa natale a Woolsthorpe, devono aver destato un precoce gusto per l’invenzione tecnica e la destrezza manuale nel piccolo Isaac. Ma quello che nel mio libro mi preme sottolineare è appunto il contesto politico e religioso, a dir poco incendiario, nel quale cresce questo ragazzo un po’ scontroso, pensieroso, destinato a cambiare la scienza del suo tempo. -Non dobbiamo mai dimenticaci che le sue idee, anche le più astratte, sono concepite in un contesto fortemente instabile: nella sua vita Newton vedrà una guerra civile, un re decapitato, una repubblica teocratica, la restaurazione di una monarchia filocattolica, il rovesciamento della stessa per opera di un esercito calvinista, una cisi economica senza precedenti, l’ascesa al trono di un re tedesco che non spiccicava una parola di inglese. La matematica, la fisica e l’ottica di Newton trascendono questo contesto, sono ancora significative per noi, ma ne sono anche condizionate: in una certa misura sono una risposta alle domande che la società cui Newton apparteneva si poneva con ansia e turbamento.
In che modo Newton si avvicinò all’alchimia?
Forse già nella bottega del farmacista che lo ospitava durante i suoi studi giovanili. Sappiamo per certo che nel 1669 si procura fornaci, minerali, solventi, ecc., per intraprendere la ricerca della trasformazione dei metalli vili in oro e forse anche per tentare di produrre farmaci. Gli studi teorici e le ricerche sperimentali in campo alchemico intrapresi da Newton sono attestati da un gran numero di manoscritti, dalla corrispondenza, e dalla presenza nella biblioteca newtoniana di opere pazientemente annotate dedicate all’alchimia. L’immagine di un Newton chino su un alambicco fumante alla ricerca della trasmutazione dei metalli fa a pugni con l’immagine ricevuta dalla tradizione illuminista e positivista dello scienziato attento a non formulare ipotesi non suffragate dall’evidenza empirica. Ma in gran parte il paradosso deriva dal fatto che siamo portati ad applicare a Newton categorie di scienza e di alchimia che non sarebbero state condivise dai suoi contemporanei.
 All’epoca lo scienziato era piuttosto un “filosofo della natura” la cui ambizione andava ben al di là di quanto si prefigge oggi un fisico o un chimico. D’altro canto, l’alchimista non era, come vorremmo oggi, un ciarlatano. La denigrazione dell’alchimia è un atteggiamento che comincia a radicarsi in modo diffuso a partire dal Settecento. Nel Seicento, gli alchimisti si dedicavano alla produzione di farmaci, pigmenti e tinture, alla purificazione dei metalli, e spesso le loro competenze nel campo della metallurgia erano ricercate nelle miniere fiorenti nell’Europa centrale. Si può presumere che molti filosofi della natura, come Boyle e Newton, fossero interessati ad entrare in contatto con questi tecnici, i quali possedevano effettivamente conoscenze empiriche sulle proprietà della materia.
All’epoca lo scienziato era piuttosto un “filosofo della natura” la cui ambizione andava ben al di là di quanto si prefigge oggi un fisico o un chimico. D’altro canto, l’alchimista non era, come vorremmo oggi, un ciarlatano. La denigrazione dell’alchimia è un atteggiamento che comincia a radicarsi in modo diffuso a partire dal Settecento. Nel Seicento, gli alchimisti si dedicavano alla produzione di farmaci, pigmenti e tinture, alla purificazione dei metalli, e spesso le loro competenze nel campo della metallurgia erano ricercate nelle miniere fiorenti nell’Europa centrale. Si può presumere che molti filosofi della natura, come Boyle e Newton, fossero interessati ad entrare in contatto con questi tecnici, i quali possedevano effettivamente conoscenze empiriche sulle proprietà della materia.
 Nel Seicento l’alchimia era praticata a corte, nelle miniere, nelle farmacie, nei laboratori di pittori e tintori, e a volte nelle università. Era una disciplina integrata nella cultura del tempo, non necessariamente proibita o clandestina (anche se si ebbero condanne contro la magia e frequenti sono le parodie del mago ciarlatano) e non necessariamente associata a correnti culturali quali l’ermetismo o il misticismo neoplatonico. Si dedicarono all’alchimia importanti contemporanei di Newton, come Locke e Boyle. -Insomma, Newton non era “strano”, era un uomo del suo tempo e sappiamo che era in contatto con una rete di “adepti”. Era certamente convinto che fosse possibile trasmutare i metalli: la sua concezione atomistica della materia d’altronde suggeriva, a lui come a Boyle, che fosse possibile modificare l’arrangiamento dei corpuscoli fondamentali di cui è composta la materia per passare da un metallo all’altro.
Nel Seicento l’alchimia era praticata a corte, nelle miniere, nelle farmacie, nei laboratori di pittori e tintori, e a volte nelle università. Era una disciplina integrata nella cultura del tempo, non necessariamente proibita o clandestina (anche se si ebbero condanne contro la magia e frequenti sono le parodie del mago ciarlatano) e non necessariamente associata a correnti culturali quali l’ermetismo o il misticismo neoplatonico. Si dedicarono all’alchimia importanti contemporanei di Newton, come Locke e Boyle. -Insomma, Newton non era “strano”, era un uomo del suo tempo e sappiamo che era in contatto con una rete di “adepti”. Era certamente convinto che fosse possibile trasmutare i metalli: la sua concezione atomistica della materia d’altronde suggeriva, a lui come a Boyle, che fosse possibile modificare l’arrangiamento dei corpuscoli fondamentali di cui è composta la materia per passare da un metallo all’altro.- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. -- “Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni” (di Niccolò Guicciardini - Intervista).8 gennaio 2021, di Federico La Sala
- CONTINUAZIONE E FINE
“Isaac Newton. Filosofo della Natura, interprete della Scrittura, cronologo degli Antichi Regni” di Niccolò Guicciardini *
- [...]
Che rapporto ebbe Newton con la religione?
Newton era profondamente religioso. E sappiamo molto della sua religiosità dato che ci ha lasciato milioni e milioni di parole sull’argomento, incluse confessioni molto personali su temi come il peccato e la redenzione o suggerimenti sullo stile di vita da tenere per evitare le tentazioni della carne. Newton era un protestante radicale, anticattolico fino al midollo, vicino a correnti eretiche come quella dei sociniani. La sua è una posizione molto personale e che condivise con pochissimi corrispondenti di cui poteva fidarsi. Infatti, le sue convinzioni lo avrebbero escluso dalla società civile, e forse lo avrebbero portato in carcere o addirittura sul patibolo.
 L’aspetto più “eretico” del pensiero di Newton è l’antitrinitarismo: egli negava la Trinità. Un fatto grave all’epoca. Sono numerosi i suoi scritti, privatissimi, dedicati a temi quali la storia della Chiesa, l’arianesimo, l’interpretazione delle profezie e dell’Apocalisse, le dimensioni del Tempio. Dedico molto spazio a questi tempi nel mio libro. Quello che forse mi preme di più osservare in questa intervista è che Newton non era un teologo, anzi non voleva esserlo. La sua religiosità è molto essenziale, di un letteralismo biblico quasi mimimalista: “sola scriptura”! Egli sostiene che partendo dal testo sacro si deduce che esiste un unico Dio, e che dobbiamo adorare l’unico Dio, non Cristo. Cristo è mediatore ed è anche di natura divina, ma sottomesso al Padre. Inoltre sappiamo che dobbiamo amare il prossimo. I due comandamenti bastano al fedele che vuole aderire alla religione delle origini. Il resto è una superfetazione, anzi peggio: è un inquinamento dovuto al piano diabolico messo in atto nel primo Concilio di Nicea. La Trinità, appunto, è un dogma intriso di metafisica platonica pagana. Chi difende la dogmatica trinitaria è colpevole di eresia, secondo la lettura newtoniana. -Newton è avverso al culto dei santi, delle reliquie, ai sacramenti, alla vita monacale: insomma guarda alla Chiesa Cattolica come alla nuova Babilonia. Ma non è un teologo: non scrive di predestinazione o della dottrina della grazia. Della teologia non sa che farsene: basta la Bibbia. Che Newton studia a fondo alla ricerca di interpolazioni che corrompono il testo sacro. Che studia a fondo per interpretare le profezie: ma questo è un tema troppo complesso. Mi permetto di rimandare al libro.
L’aspetto più “eretico” del pensiero di Newton è l’antitrinitarismo: egli negava la Trinità. Un fatto grave all’epoca. Sono numerosi i suoi scritti, privatissimi, dedicati a temi quali la storia della Chiesa, l’arianesimo, l’interpretazione delle profezie e dell’Apocalisse, le dimensioni del Tempio. Dedico molto spazio a questi tempi nel mio libro. Quello che forse mi preme di più osservare in questa intervista è che Newton non era un teologo, anzi non voleva esserlo. La sua religiosità è molto essenziale, di un letteralismo biblico quasi mimimalista: “sola scriptura”! Egli sostiene che partendo dal testo sacro si deduce che esiste un unico Dio, e che dobbiamo adorare l’unico Dio, non Cristo. Cristo è mediatore ed è anche di natura divina, ma sottomesso al Padre. Inoltre sappiamo che dobbiamo amare il prossimo. I due comandamenti bastano al fedele che vuole aderire alla religione delle origini. Il resto è una superfetazione, anzi peggio: è un inquinamento dovuto al piano diabolico messo in atto nel primo Concilio di Nicea. La Trinità, appunto, è un dogma intriso di metafisica platonica pagana. Chi difende la dogmatica trinitaria è colpevole di eresia, secondo la lettura newtoniana. -Newton è avverso al culto dei santi, delle reliquie, ai sacramenti, alla vita monacale: insomma guarda alla Chiesa Cattolica come alla nuova Babilonia. Ma non è un teologo: non scrive di predestinazione o della dottrina della grazia. Della teologia non sa che farsene: basta la Bibbia. Che Newton studia a fondo alla ricerca di interpolazioni che corrompono il testo sacro. Che studia a fondo per interpretare le profezie: ma questo è un tema troppo complesso. Mi permetto di rimandare al libro.Come si articolò il suo programma di ricerca scientifica?
Grosso modo. Newton comincia la sua attività di scienziato creativo con la matematica (il calcolo infinitesimale) e l’ottica. Successivamente scopre la teoria della gravitazione che elabora nel suo capolavoro, i Principi matematici della filosofia naturale pubblicato nel 1687. Solo nel 1704 pubblicò l’Ottica. Ma ormai Newton non era più uno sconosciuto professore di Cambridge, ma il Presidente della Royal Society, e come tale esercitò un’influenza enorme sulla ricerca scientifica britannica. Seguire la biografia intellettuale di Newton vuol dire anche studiare la trasformazione di un matematico attivo in una università, e tutto sommato non così conosciuto, in un personaggio pubblico. Dopo il 1687 le sue idee venivano dibattute da tutta la Repubblica delle Lettere europea.
Quale visione aveva Newton del ruolo delle discipline da lui praticate?
Newton è stato uno dei matematici più creativi della storia. Il presupposto - forse il pregiudizio - da cui parto è che l’opera di Newton debba essere letta a partire dai successi (e anche gli insuccessi!) che Newton ha incontrato nel corso della sua complessa biografia intellettuale. Così nel mio libro la matematica occupa uno spazio forse insolito - e forse sgradito? - per un libro che vuole essere divulgativo. Newton non cessa di riferirsi al metodo matematico, il metodo dell’“analisi e della sintesi”, come alla via più sicura per superare le “congetture e le probabilità che si spacciano ovunque”. Secondo il mio punto di vista, la mentalità di Newton è fortemente influenzata dal suo essere, alla radice, un matematico. Va però riconosciuto che, per praticare le tante discipline in cui si è cimentato, Newton ha acquisito competenze tecniche in ambiti diversi quali l’esegesi biblica, la pratica sperimentale alchemica, l’astronomia, la storia antica, la costruzione di strumenti scientifici. In tutte queste discipline Newton dimostra la volontà di affrontare le questioni più tecniche e ardue. È come se cercasse la verità nei dettagli più complessi, nelle domande irrisolte più ardue. Il suo è sempre un cammino in salita. La verità che Newton cerca è comunque sempre una verità che porta ad una visione religiosa. “The duty of the greatest moment” per lui è comprendere la Natura e la Storia come realtà che sono nelle mani di un Dio che interviene secondo un disegno provvidenziale. Il grande nemico di Newton è Cartesio, il determinismo della filosofia meccanica.
In che modo il grande filosofo della natura fu coinvolto nel contesto dei dibattiti religiosi e politici che ebbero luogo nella sua epoca?
La vita pubblica di Newton inizia nel 1687 quando interrompe la stesura dei Principi per opporsi con coraggio al tentativo del re Giacomo II di imporre all’Università di Cambridge di accettare un monaco benedettino, uno dei tanti tentativi dello Stuart di infiltrare cattolici in posizioni di prestigio. Newton rischia la vita nel dire no al re. La sua fortuna è che nel 1688 Guglielmo di Orange invade l’Inghilterra alla testa di un esercito di mercenari. È la Gloriosa Rivoluzione che costringe Giacomo all’esilio. Newton è eletto membro del Parlamento e pochi anni dopo lo troviamo a capo della Zecca di Londra, e cioè in una posizione di comando che lo gratifica anche economicamente. Newton ora siede a tavola, e invita a casa sua, i politici e gli ecclesiastici più potenti: il suo indirizzo politico è a favore dei Whigh e per la Low Church. L’impatto della sua presenza a Londra sulla cultura inglese, sull’economia e sulla politica del suo tempo non può essere sopravvalutato. È ricordato per aver riconiato la moneta, un intervento di politica economica di grande importanza.
Come trascorse i suoi ultimi anni lo scienziato inglese?
Come abbiamo detto, dal 1688/89 Newton è un personaggio influente della politica inglese: Presidente della Royal Society, eletto Baronetto, Mastro della Zecca (una sorta di ministro delle finanze). Dovrà incrociare i ferri con un altro grande diplomatico, Gottfried Wilhelm Leibniz, bibliotecario del Duca Hannover (che nel 1714 sale sul trono inglese come Giorgio I), consigliere aulico dell’Imperatore e consigliere dello Zar. Un pezzo da Novanta! Il problema, dal punto di vista di Newton, è che ha il difetto di perseguire una politica di pace ecumenica fra le confessioni cristiane. Far la pace con i cattolici è fumo negli occhi di Newton. Inoltre, Leibniz coniuga la metafisica con temi religiosi, come la predestinazione, riproponendo agli occhi di Newton proprio quell’inquinamento filosofico del Cristianesimo che aveva corrotto la Chiesa delle origini. Gli ultimi anni della vita di Newton sono occupati da un’aspra polemica con Leibniz che, dopo l’ascesa al trono di Giorgio I, potrebbe diventare una presenza ingombrante a corte. Così non sarà, Leibniz morirà in isolamento nel 1716. Come scienziato, Newton oltre a dirigere alcune ricerche sperimentali, per esempio sull’elettricità, pubblica opere di matematica e cure varie edizioni dei Principi e dell’Ottica. Riprende i suoi studi di “cronologia”. L’oggetto di questa disciplina consisteva nello scrivere una grandiosa storia comparata della civiltà umana attraverso un confronto della storia del popolo ebreo esposta nella Bibbia con le storie di altri popoli antichi come gli Egizi, gli Assiri, i Persiani, i Greci e i Romani. In questo modo la storia biblica veniva inserita in un affresco della storia antica del Medio Oriente.
 Queste ricerche devono essere collocate nella turbolenta epoca nella quale Newton viveva, un’epoca in cui si stava affermando la consapevolezza della complessa storia della creazione e trasmissione della Bibbia: stabilire il testo “originale” e confermare la veridicità dei libri storici dell’Antico Testamento era un dovere morale per uomini come Newton. La cronologia biblica doveva anche accordarsi con le conoscenze allora accettate sulla demografia, oggetto di interesse tanto per gli studiosi degli effetti delle epidemie (come la peste che aveva colpito Londra) quanto per gli assicuratori che dovevano stabilire una teoria matematica sulle aspettative di vita media. In poche parole: una disciplina ai giorni nostri scomparsa, come la cronologia, poteva essere praticata da chi possedeva conoscenze di filologia, ermeneutica biblica, archeologia, storia antica, mitologia, demografia e astronomia. Newton ormai è diventato un erudito cultore di una disciplina che richiede tanto competenze umanistiche quanto scientifiche.
Queste ricerche devono essere collocate nella turbolenta epoca nella quale Newton viveva, un’epoca in cui si stava affermando la consapevolezza della complessa storia della creazione e trasmissione della Bibbia: stabilire il testo “originale” e confermare la veridicità dei libri storici dell’Antico Testamento era un dovere morale per uomini come Newton. La cronologia biblica doveva anche accordarsi con le conoscenze allora accettate sulla demografia, oggetto di interesse tanto per gli studiosi degli effetti delle epidemie (come la peste che aveva colpito Londra) quanto per gli assicuratori che dovevano stabilire una teoria matematica sulle aspettative di vita media. In poche parole: una disciplina ai giorni nostri scomparsa, come la cronologia, poteva essere praticata da chi possedeva conoscenze di filologia, ermeneutica biblica, archeologia, storia antica, mitologia, demografia e astronomia. Newton ormai è diventato un erudito cultore di una disciplina che richiede tanto competenze umanistiche quanto scientifiche.
 Newton muore nel marzo del 1727. Un funerale di stato, con tanto di sepoltura e monumento nell’Abbazia di Westminster, suggella il suo successo nella sfera pubblica. Il Settecento celebra Newton come il fondatore del metodo scientifico, come un padre nobile dell’Illuminismo. Ma Newton lascia ai suoi eredi un corpus immenso di manoscritti fra i quali si celano ricerche di alchimia, di studi biblici e di storia della Chiesa che verranno scoperte solo grazie alla vendita all’asta del 1936. La distanza fra gli interessi di Newton e quelli di uno scienziato a noi contemporaneo diverrà così evidente.
Newton muore nel marzo del 1727. Un funerale di stato, con tanto di sepoltura e monumento nell’Abbazia di Westminster, suggella il suo successo nella sfera pubblica. Il Settecento celebra Newton come il fondatore del metodo scientifico, come un padre nobile dell’Illuminismo. Ma Newton lascia ai suoi eredi un corpus immenso di manoscritti fra i quali si celano ricerche di alchimia, di studi biblici e di storia della Chiesa che verranno scoperte solo grazie alla vendita all’asta del 1936. La distanza fra gli interessi di Newton e quelli di uno scienziato a noi contemporaneo diverrà così evidente.Niccolò Guicciardini, laureato in Filosofia e in Fisica, è professore ordinario di Storia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano. Ha dedicato molti anni allo studio del pensiero di Newton. È autore di The Development of Newtonian Calculus in Britain (Cambridge University Press, 1989), di Reading the Principia: the Debate on Newton’s Mathematical Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736 (Cambridge University Press, 1999), di Isaac Newton on Mathematical Certainty and Method (The MIT Press, 2009) e ha curato Anachronisms in the History of Mathematics (Cambridge University Press, in stampa). È membro a vita del Clare Hall College (Cambridge). È stato visiting fellow a Clare Hall e a Peterhouse (Cambridge), presso la Biblioteca Universitaria di Basilea, e l’Osservatorio astronomico di Parigi. È stato invitato come docente al California Institute of Technology, e all’Università Paris-Diderot. Nel 2011 ha vinto il Fernando Gil International Prize for the Philosophy of Science, e nel 2018 il Francis Bacon Award in the History and Philosophy of Science and Technology.
* Fonte: Letture.
-
> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ..."NEW TON"!!! --- «Non tutti i virus diventano pandemia: ecco perché è esplosa e perché c’entrano i social media»(di Ilaria Capua).4 gennaio 2021, di Federico La Sala
l’intervento
Ilaria Capua: «Non tutti i virus diventano pandemia: ecco perché è esplosa e perché c’entrano i social media»
La virologa: «Sars, Aviaria, Mers sono state tenute sotto controllo nel giro di qualche mese»
di Ilaria Capua *
Sembra incomprensibile, ma i virus pre-pandemici non creerebbero né pandemie né epidemie se solo li lasciassimo nei loro ecosistemi ed equilibri naturali. Insomma, potrei sintetizzare che i virus pre-pandemici hanno un loro «potenziale pandemico» che è molto legato alla loro via di trasmissione e alla loro contagiosità. Chiamiamolo quindi «fattore virus».
Il «fattore virus» non è l’unico elemento dell’incendio pandemico ma ne è la componente unica e insostituibile. Sono certa che più e più volte in questi anni si siano create condizioni analoghe per l’emergenza di un coronavirus pandemico ma che sempre, fino al 2020, moltissimi di questi si siano estinti mentre altri come Sars, Mers, influenza Aviaria,influenza Suina, Ebola e Zika sono state tenute più o meno sotto controllo nel giro di qualche mese.
 E perché la diffusione è stata contenuta in questi casi e con il Covid-19 no? Perché molto spesso sono proprio gli esseri umani che creano le condizioni affinché queste emergenze sanitarie si possano controllare oppure esplodano e abbiano poi delle ramificazioni di grande impatto. Vieppiù. La pandemia del 2020 ci informa che la sua evoluzione è particolarmente dipendente dal comportamento dei singoli individui e dai sistemi in cui gli individui operano. È indubbio che la diffusione accelerata in tutto il globo terracqueo sia avvenuta grazie alla movimentazione di persone infette sia a livello internazionale, che nazionale e locale fino a livello di frazione del più piccolo comune. Chiamiamolo quindi «fattore individuo» e questo comprende oltre alle caratteristiche dell’individuo stesso e la sua recettività personale all’infezione anche per esempio la sua mobilità.
E perché la diffusione è stata contenuta in questi casi e con il Covid-19 no? Perché molto spesso sono proprio gli esseri umani che creano le condizioni affinché queste emergenze sanitarie si possano controllare oppure esplodano e abbiano poi delle ramificazioni di grande impatto. Vieppiù. La pandemia del 2020 ci informa che la sua evoluzione è particolarmente dipendente dal comportamento dei singoli individui e dai sistemi in cui gli individui operano. È indubbio che la diffusione accelerata in tutto il globo terracqueo sia avvenuta grazie alla movimentazione di persone infette sia a livello internazionale, che nazionale e locale fino a livello di frazione del più piccolo comune. Chiamiamolo quindi «fattore individuo» e questo comprende oltre alle caratteristiche dell’individuo stesso e la sua recettività personale all’infezione anche per esempio la sua mobilità.Fino alla pandemia del 2020 questi due fattori erano i principali determinanti della diffusione di un virus pandemico e credo che nessuno di noi avrebbe immaginato anche solo qualche anno fa che i principali determinanti dell’andamento della pandemia sarebbero state invece entità virtuali come l’informazione e i social media. Mai, negli ultimi cento anni (durante i quali ci sono state cinque pandemie influenzali) l’informazione è stata così pervasiva, liquida e impicciona di argomenti complicati anche per gli addetti ai lavori.
 Il punto chiave che forse sfugge ai più è che questo è il fenomeno biologico e sociale più misurato della storia. È l’evento su cui di punto in bianco si sono rovesciate tonnellate di biotecnologie mature che non solo ci hanno fatto avere milioni di dosi di vaccino in tempo record.
Il punto chiave che forse sfugge ai più è che questo è il fenomeno biologico e sociale più misurato della storia. È l’evento su cui di punto in bianco si sono rovesciate tonnellate di biotecnologie mature che non solo ci hanno fatto avere milioni di dosi di vaccino in tempo record.La medesima tecnologia sta identificando centinaia di migliaia di sequenze genetiche virali (ogni virus ha la sua sequenza) che nessuno, prima d’oggi aveva mai avuto l’ardire di decodificare, analizzare, men che meno interpretare. Lo sforzo è planetario. Vi assicuro: si svolgono incontri virtuali praticamente continui fra virologi evoluzionisti di tutto il mondo per seguire i bandoli della matassa pandemica e discutere le implicazioni di quello che osservano.
 Lo voglio dire con forza: non è giusto né possibile incasellare una serie di fenomeni biologici come le mutazioni, le delezioni e le loro possibili conseguenze in caselle mentali a misura di clickbait o di telespettatore disattento. Perché non è giusto: si disorienta chi poi ha le chiavi per uscire da questa situazione cioè le persone che altro non sono che il «fattore individuo».
Lo voglio dire con forza: non è giusto né possibile incasellare una serie di fenomeni biologici come le mutazioni, le delezioni e le loro possibili conseguenze in caselle mentali a misura di clickbait o di telespettatore disattento. Perché non è giusto: si disorienta chi poi ha le chiavi per uscire da questa situazione cioè le persone che altro non sono che il «fattore individuo».Ma non basta, purtroppo. Oltre alle informazioni giuste o sbagliate - ma comunque pubbliche e quindi tracciabili e verificabili - vi è il mare magnum dei social media. E certo direte voi, questo lo sapevamo. Ecco io volevo solo assicurarmi anche che fosse chiaro che è proprio attraverso il delirio di messaggi che si muovono nella connettosfera dei social e attraverso l’amplificazione di informazioni ambigue emesse da media anche molto accreditati che si determina quello che succede al «fattore virus». Insomma è verosimile che i principali determinanti della pandemia del 2020 saranno quelli virtuali e paradossalmente influenzeranno l’evoluzione pandemica molto di più del fattore virus e del fattore individuo messi insieme. Una pandemia reale che si evolve spinta soprattutto da forze che nel mondo biologico non esistono. Quelle virtuali.
* Corriere della Sera, 2 gennaio 2021 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- L’OLIO DELLE OLIVE, IL PASSATO CHE NON TORNA, E IL CALENDARIO DEI MAYA.21 giugno 2020, di Federico La Sala
L’OLIO DELLE OLIVE, IL PASSATO CHE NON TORNA, E IL CALENDARIO DEI MAYA...*
MA NON è POSSIBILE CHE questa creativa e “magica” connessione tra la bellissima incisione del 1589 sull’olio delle olive e il devastante problema Xylella (cfr. A. Polito, "La Xylella e il passato che non ritorna", Fondazione Terra d’Otranto, 20.06.2020) SIA STATO INDOTTO dalla grandine come neve caduta a fine maggio [nel Salento] e dal riaffiorare, insieme alla “corretta” lettura del calendario dei Maya, alla memoria anche della “profezia” del “Nostradamus salentino”, Matteo Tafuri (1492-1584): “Salento di palme e mite Scirocco, / Salento nevoso ma mai dopo il Tocco. / Due giorni di neve due lampi nel cielo,/ il Mondo finisce lo so non lo anelo”?!
UN “INVERNALE” SEGNO DEI TEMPI?! Senz’altro, una sollecitazione a usare il cervello e ad “avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza”(Kant). Intanto, già da oggi [20.06.2020], sveglia! Domani è il 21 giugno 2020, ed è già tutto più chiaro! O no?!
*
***
P. S.
CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, UNA BOTTIGLIA DI ROCCAMORA.IN VINO VERITAS...
UNA BUONA E BELLA OCCASIONE DA NON SCIUPARE, PER BRINDARE AL BRILLANTE LAVORO DEL PROF. POLITO, ALLA FONDAZIONE TERRA DI OTRANTO, E ALLA “SCHOLA SARMENTI” E AL ROCCAMORA.
*FLS
-
> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO... "NEW TON"! --- COSMOLOGIA E IMMAGINAZIONE MITICA. "Le distese interiori del cosmo" (Joseph Campbell).27 maggio 2020, di Federico La Sala
"CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT) E DEL "MONOMITO" (JAMES JOYCE). UN OMAGGIO A JOSEPH CAMPBELL
LA METAFORA NEL MITO E NELLA RELIGIONE E I PROLEGOMENI AD OGNI FUTURA METAFISICA CHE SI PRESENTERA’ COME SCIENZA.... *
- IL MITO E IL CORPO. [...] I vecchi dèi sono morti o stanno morendo e dappertutto la gente è alla ricerca di qualcosa di nuovo e si chiede: “Quale sarà la nuova mitologia, la mitologia di questa Terra unificata come un unico essere armonioso?”(Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo, i Nottetempo, Milano 2020, p. 23)
- LA COSMOLOGIA E L’IMMAGINAZIONE MITICA. Un’esperienza sorprendente, per me come certo per molti altri spettatori, è stata offerta dalla trasmissione televisiva del viaggio della navicella spaziale Apollo nel momento precedente lo sbarco di Armstrong sulla Luna. Quando dal Centro di controllo di Houston chiesero: «E ora chi è il navigatore?» la risposta che venne dallo spazio fu «Newton!».
 Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».
Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».
 Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).
Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).
Siamo mito
di Moreno Montanari (Doppiozero, 20 marzo 2020).
“Come fuori, così dentro” si potrebbe riassumere così, parafrasando la celebre massima alchemica, la tesi dell’ultimo libro di Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, Nottetempo, 2020. Si tratta di una raccolta di saggi che amplificano delle conferenze tenute tra il 1981 e il 1984 nello sforzo, consueto per Campbell, di illuminare la transculturalità, ossia gli elementi costanti, nonostante le variabili etnico-culturali, dei miti. Al cuore di ogni narrazione mitologica, che Campbell ha il merito indiscusso di mostrare ancora viva negli aspetti più comuni delle nostre culture, ci sono temi che Adolf Bastian (1826-1905) chiamava “idee elementari” e Carl Gustav Jung (1875-1961) “archetipi” ; si tratta di cristallizzazioni di risposte millenarie che la fantasia e l’immaginazione delle diverse civiltà umane hanno elaborato per affrontare questioni esistenziali che le hanno profondamente interrogate. Naturalmente queste forme archetipiche variano a seconda delle idee etniche che una determinata cultura esprime, ma esiste tra di loro una dialettica che Campbell riassume così : “l’idea elementare è radicata nella psiche ; l’idea etnica attraverso cui si manifesta è radicata nella geografia, nella storia e nella società” (p. 145) ; si accede al punto di vista del mito quando “nelle forme di un ambiente traspare la trascendenza” (p. 28).
Il suo lavoro più celebre sull’universalità del mito è sicuramente quello relativo a L’eroe dai mille volti (1949, tr. it. Lindau, Torino, 2012) figura che, nelle più disparate e diversificate espressioni culturali, lontanissime tra loro nello spazio e nel tempo, passa comunque sempre attraverso i seguenti snodi esistenziali : una nascita misteriosa, una relazione complicata con il padre, ad un certo momento della sua vita sente l’esigenza di ritirarsi dalla società e, in questa condizione, apprende una lezione, o elabora un sapere, che orienterà diversamente la sua vita, poi ritorna alla società per mettere al suo servizio la lezione che ha appreso, molte volte (ma non necessariamente) grazie ad un’arma che solo lui può usare.
In questo libro, invece, l’attenzione si rivolge alle diverse cosmologie e ai miti soteriologici elaborati nel corso dei millenni dalle differenti culture che si sono susseguite, e affiancate, nel nostro pianeta, comprese le attuali, e si organizza intorno alla felice intuizione kantiana che spazio e tempo siano categorie interiori della psiche che vengono applicate alla realtà esterna. Citando Novalis Campbell scrive : “La sede dell’anima è laddove il mondo esterno e il mondo interno s’incontrano”, e aggiunge, “è questo il paese delle meraviglie del mito” (p. 43).
 Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.
Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.
 Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:
Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:- “Le figurazioni mitiche sono metaforiche (...) in due sensi contemporaneamente : in quanto portatrici di connotazioni psicologiche e, allo stesso tempo, metafisiche. Attraverso questa doppia messa a fuoco, le caratteristiche psicologicamente interessanti di ogni ordine sociale locale, di ogni ambiente o di ogni ipotetica storia, possono venire trasformate attraverso il mito in trasparenze rivelatrici di trascendenza.
- Immanuel Kant ci ha fornito una formula straordinariamente semplice per interpretare queste due connotazioni. Compare nei Prologomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza ai paragrafi 57-58. Ci viene offerta una proporzione a quattro termini (a sta a b come c sta a x) che punta non tanto a porre un’imperfetta somiglianza tra due cose, ma definire un’identità perfetta di due rapporti tra cose del tutto dissimili (...). Non “a in qualche modo assomiglia a b”, ma il rapporto tra a e b è perfettamente identico a quello tra c e x, dove x rappresenta una quantità che non è soltanto sconosciuta, ma assolutamente inconoscibile, metafisica” (p. 80).
Mi sembra un esempio realmente illuminante per comprendere il senso di ogni comparazione e di ogni ermeneutica simbolica. Lo ha spiegato bene Jung : il simbolo, centrale in ogni mito, non rimanda a una realtà significata, è esso stesso realtà operante, costituisce la specifica capacità umana di “orientare la coscienza verso ulteriori possibilità di senso”, poiché non è mai del tutto riconducibile ad un significato univoco e definitivo ; per questo non può essere ridotto alla semiotica perché la sua funzione è piuttosto psicagogica, vale cioè per gli effetti che produce nella psiche, per le energie, le immagini, le interpretazioni, i processi psichici che sa evocare, promuovere, mettere in gioco (C. G. Jung, Tipi psicologici, 1921 ; tr. it. Bollati Boringhieri, 1977 e sgg, p. 527). Ecco perché il ricorso a Kant, a quell’x che resta inconoscibile e che apre alla metafisica, a ciò che trascende ogni possibilità di possesso e de-finizione del senso ultimo, appare particolarmente pertinente.
I rapporti che vengono suggestivamente indagati da Campbell, dicevamo, sono quelli che comparano lo spazio interiore e quello esteriore, secondo la celebre analogia tra macrocosmo e microcosmo :
- “la profondità e la sublime maestà della mitologia soppressa può essere apprezzata al meglio attraverso due movimenti a orologeria apparentemente irrelati ; l’uno è il più grande orologio dello spazio esteriore, l’altro appartiene allo spazio interiore. Sono rispettivamente la precessione astronomica degli equinozi e il battito fisiologico del cuore umano” (p. 54).
Attraverso un nutrito numero di calcoli e dati ricavati dagli studi di astronomia, i calendari ideati dalle diverse culture a partire dagli antichi babilonesi, le fonti bibliche, le arcaiche Upanisad induiste e i più remoti testi taoisti, Campbell giunge ad analizzare suggestivi - per un certo tipo di lettore - consonanze tra i cicli biologici del sistema solare (macrocosmo) e quelli dell’individuo (microcosmo). Ma non mi sembra questo il punto cruciale dei suoi sforzi, che consiste piuttosto nel promuovere una diversa prospettiva sul mondo e sulla vita, non più incentrata sulle nostre idee etniche, sui limiti delle nostre culture, ma aperta al riconoscimento di un’unica realtà “il cui centro è ovunque”, della quale dovremmo finalmente farci carico in maniera universale (si pensi agli assurdi sforzi dei singoli stati, in questi difficili giorni, di arginare il coronavirus secondo strategie nazionali, anziché comprenderne la portata globale che richiederebbe interventi condivisi, in tutti i sensi, su scala mondiale e non, addirittura, regionale - per non parlare delle differenti valutazioni a seconda delle fasce di età).
Dopo aver preso in esame i miti cosmologici e soteriologici delle diverse religioni delle nostre principali culture, Campbell giunge a questa conclusione :
- “Il primo passo per partecipare al destino dell’umanità, che non è quello di questo o di quel popolo, ma quello dell’intera popolazione del globo, è riconoscere che ogni immagine locale di un dio non è che una delle molte migliaia, dei milioni, forse anche miliardi di simbolizzazioni limitate di un mistero al di là della vista e del pensiero” (p. 63).
Il pensiero mitologico, quando non viene letteralizzato, promuove dunque un’apertura alla transculturalità, alla trascendenza di ogni appartenenza storico-culturale e si propone, in maniera apparentemente contro intuitiva, come strumento di laicità. Qui incontra l’arte, per la sua capacità di trasformare la coscienza e la visione abitudinarie della realtà in favore di un punto di vista nel quale, “la mente viene fermata e innalzata al di sopra del desiderio e dell’odio” ; sono parole di Joyce che Campbell fa sue e che trova affini all’esperienza ascetica che dovette compiere il Buddha prima di raggiungere l’illuminazione : vincere i tre demoni del desiderio (Kāma), della paura della morte (Māra) e l’identificazione con i vincoli sociali (Dharma), per accedere a una condizione che li sappia trascendere (pp. 201-201).
Un percorso e un’opportunità che, in chiave individuativa, sono poste al centro del lavoro di Giovanna Morelli nel suo Poetica dell’incarnazione. Prospettive mitobiografiche nell’analisi filosofica (Mimesis, 2020). In questo libro - uscito per la collana di Mimesis “Philo-pratiche filosofiche” curata da Claudia Baracchi - l’arte appare lo sfondo dal quale può emergere una rappresentazione mitobiografica della vita di ciascuno di noi, ossia, secondo la lezione di Ernst Bernhard, il modo di riconoscere come ogni singola esistenza si apra, o meglio si riconosca, in alcuni mitologemi (singoli aspetti di un mito) che si prestano a leggerne alcune gesta. Lo sguardo mitobiografico con il quale Morelli invita a osservare la vita, a partire dal racconto della propria, permette di “scoprire e amare l’universale attraverso il particolare, preservando entrambe le dimensioni”, di “narrare la propria vita secondo il disegno di senso che la illumina, la magnifica, la collega a figure universali e pertanto la rende epica, emblematica” (p. 127).
L’arte che indaga l’analista filosofo è dunque quella incarnata, ossia, consapevole che la vita di ciascuno di noi accede al simbolico grazie e attraverso quelle che James Hillman chiamava “metafore radicali” offerte dall’inconscio collettivo, ossia le strutture percettive, gli archetipi, che organizzano l’esperienza umana come già da sempre sovrapersonale.
Lo specifico di ogni vicenda biografica non viene meno se riconosce nel suo sviluppo echi, modalità e variazioni di temi ricorrenti nella storia dell’umanità - di cui la psiche mantiene una traccia in forma, appunto, archetipica - ma procede al contrario verso la sua individuazione, la possibilità di autenticare in modo esclusivo la propria esistenza, “se comunica con se stessa alle più diverse latitudini spazio-temporali, attraverso le tante narrazioni-quadro che si sono avvicendate nella storia” (pp. 38-39).
L’arte è qui poiesis, anzi, mitopoiesi e la vita, vista dall’osservatorio privilegiato della stanza d’analisi, ne costituisce il principale teatro (Giovanna Morelli è anche regista d’opera e critica teatrale), lo spazio in cui s’incontrano e si scontrano le nostre maschere sociali e i nostri doppi impresentabili, ma anche dove si facilita una più profonda espressione di sé che, in una vicenda personale, sa scorgere tracce di qualcosa di universale - il che, osserva Jung, è già di per sé terapeutico :
- “Il mito ha bisogno d’una nuova veste in ogni nuova era, se non vuol perdere la sua virtù terapeutica. (...) gli archetipi inconoscibili sono vivi (...) cambiano nome e veste in una successione infinita, e proprio attraverso questi mutamenti esprimono la loro imperscrutabile essenza” (C. G. Jung, Aion, Ricerche sul simbolismo del Sé, Bollati Boringhieri, Torino, p. 170, cit. in G. Morelli, op.cit., p. 45).
Un’operazione che, in modo diverso, sia Campbell che Morelli, ci invitano a fare per riconoscere nei miti la via maestra alla coltivazione di quella trascendenza che non rimanda a mondi altri e paralleli ma anima l’immanenza, qui ed ora, da sempre.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COME ALL’INTERNO, COSI’ ALL’ESTERNO: "VERE DUO IN CARNE UNA". NOTE SUL PROGRAMMA DI KANT
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaDAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - Fede e numeri: il metodo di Newton. La tesi di Rob Iliffe (di Stwfano Gattei)12 agosto 2018, di Federico La Sala
RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, STORIOGRAFIA, E DEMOCRAZIA. LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA è ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA....*
La tesi di Iliffe
Fede e numeri: il metodo di Newton laico devoto
di Stefano Gattei (Corriere della Sera, La Lettura, 12.08.2018)
Che Isaac Newton (1642-1727) fosse profondamente religioso è noto. Che avesse studiato alchimia, teologia e le profezie bibliche, e che avesse approfondito la cronologia antica, non lo è altrettanto, anche se gli studiosi lo considerano ormai un dato acquisito («la Lettura» #69 ne scrisse il 10 marzo 2013). Per anni, tuttavia, gli ammiratori dei Principia mathematica o dei lavori sul calcolo infinitesimale hanno faticato a riconciliare ambiti di ricerca così apparentemente lontani, tanto che non pochi studiosi hanno avanzato l’ipotesi che gli interessi religiosi e pseudoscientifici del grande scienziato (molti dei quali affidati a manoscritti pubblicati dopo la morte) risalissero agli ultimi anni della sua vita, costituendo quindi un sorta di prodotto «senile» del genio.
Nel suo ultimo studio sullo scienziato inglese (Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac Newton, Oxford University Press, 2017) Rob Iliffe mostra l’infondatezza di tale lettura. Professore a Oxford, e direttore del Newton Project, Iliffe prende ferma posizione contro quanti hanno inteso sostenere che gran parte delle ricerche newtoniane siano il residuo imbarazzante di superstizioni.
Parallelamente al racconto della vita dello scienziato, Iliffe ricostruisce come Newton abbia gestito il difficile rapporto tra la propria immagine pubblica e le sue credenze religiose, e ne esplora gli scritti meno noti, soffermandosi sulle idee in tema di creazione del mondo e di Apocalisse, e analizzando la sua tesi che le dottrine centrali del cristianesimo (in particolare sulla Trinità) non fossero che mostruosa idolatria, perversioni sataniche della vera religione.
Agli occhi di Iliffe, non solo le convinzioni religiose di Newton permeano le sue prime ricerche scientifiche, ma le tecniche da lui impiegate per smascherare la corruzione della dottrina cristiana delle origini sono simili a quelle utilizzate per confutare le tesi degli avversari in ambito scientifico. Per Iliffe, Newton è stato un laico devoto che ha messo al centro della propria riflessione la libertà e l’indipendenza del pensiero.
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
- PIANETA TERRA: DOPO COPERNICO, UNA RIVOLUZIONE GENERALE."VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), COME PER KANT, LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA E’ ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA!!!
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO.
- Atomi e coscienza (di Paul K Feyerabend, Atoms and consciousness, «Common Knowledge», 1, 28-32, 1992).
LA VIA DI KANT: USCIRE DAL MONDO, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI "DIO", CONCEPITO COME L’“UOMO SUPREMO”! La “Prefazione” della “Storia universale della natura e teoria del cielo”. Note per una rilettura
L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA. Note per una rilettura della "Critica della Ragion pura" (e non solo)
Federico La Sala
-
> 2060: APOCALISSE... DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! -- IL 27-28 LUGLIO 2018, ECLISSI DI LUNA DA RECORD (44 MINUTI).22 luglio 2018, di Federico La Sala
il gran teatro del cielo
L’eclissi di Luna più lunga del secolo: ecco come osservarla al meglio
di Leopoldo Benacchio *
Fra un mese circa, nella notte tra il 27 e 28 luglio, il gran teatro del cielo ci regalerà uno spettacolo affascinante. Avremo infatti un’eclissi di Luna che, nuvole permettendo, sarà uno spettacolo particolare e affascinante. In Italia inizierà verso le 19:30 e durerà fino a oltre le 2:00 del giorno seguente; la fase di totalità, in genere la più bella, si avrà attorno alle 22:21. Chiariamo subito che le eclissi di Luna non sono certo un fatto eccezionale: quest’anno ne è già avvenuta una il 31 gennaio scorso, ma la particolarità di questa è che sarà molto lunga in termini di tempo: la fase di totalità durerà circa un’ora e 43 minuti, un 40 minuti in più della media. Sarà anche l’eclissi più lunga da qui al 2100, un piccolo record da non perdere.
Ricordiamo che un’eclissi di Luna si ha quando la nostra Terra si mette in mezzo fra il Sole e la Luna stessa, oscurandola. Il nostro satellite infatti non emette luce propria, ma riflette piuttosto bene quella solare. Per avere un’eclissi occorre anche che Sole, Terra e Luna siano sullo stesso piano, cosa che può capitare solo un paio di volte all’anno: la Luna infatti ha un’orbita inclinata attorno alla Terra e noi attorno al Sole. Altrimenti avremmo una eclissi ogni mese.
Che cosa vedremo quindi il 27 luglio prossimo, a partire dalle 19.30? Sdraiati sulla spiaggia o in montagna o anche, molto semplicemente, a casa nostra - però da un posto non troppo luminoso - vedremo la Luna che, man mano, si offusca entrando nella penombra e poi lentamente si avvicinerà alla totalità, verso le 22.20, assumendo un colore più o meno rossastro. L’uscita dalla totalità è simile all’entrata, il nostro satellite riprenderà il suo colore bianco splendente e il fenomeno sarà terminato.
Come mai, ci si potrebbe chiedere, se la Terra si interpone fra Sole e Luna, si vede il nostro satellite anche durante la fase di totalità? L’apparenza data dalla tenue luce rossastra durante il culmine del fenomeno è dovuta al fatto che il nostro Pianeta copre sì completamente il disco lunare, ma anche diffonde nello spazio la luce solare che lo colpisce, grazie anche al filtro della nostra atmosfera. Il colore di questa luce va dal bianco latte a un grigio più cinereo fino a volte al rosso tenue, per un effetto fisico che è quello scoperto dai fisici inglese Raleigh e Jeans circa 120 anni fa. La polvere presente nell’atmosfera infatti assorbe la luce solare e la emette di nuovo nelle frequenze del rosso.
L’ultima cosa che ci resta capire è come mai l’eclissi, questa volta, sia così lunga. Dobbiamo fare mente locale sul fatto che la Luna gira intorno alla Terra, d’accordo, ma non in un’orbita proprio circolare, bensì un po’ ellittica. Per questo motivo la distanza Terra-Luna varia tra i 363.104 chilometri e i 405.696: il primo punto è chiamato perigeo - più vicino alla Terra, in greco antico - l’altro apogeo. Il 27 luglio prossimo sarà proprio all’apogeo, nel punto più lontano, e quindi, per le leggi scoperte dal grande astronomo Giovanni Keplero nel 1600, la Luna deve percorrere la sua orbita un po’ più lentamente nel cielo: ecco quindi che il fenomeno ci metterà un bel 40 minuti in più della media, stabilendo il record del secolo.
Resta da dare un suggerimento importante: osserviamo bene la Luna, come fece a suo tempo il grande Galilei. Proprio così, anche se può sembrare strano, ma Galilei usò per le prime osservazioni lunari un cannocchiale, “cannone” lo chiamava nel senso di grande canna, che oggi non esiteremmo a definire di pessima qualità, data la primitiva tecnologia di costruzione delle lenti ottiche a quei tempi. Comunque il primo da lui usato aveva solo 3 ingrandimenti, come un cannocchiale da teatro che molti di noi hanno in casa. Eppure la scoperta del vero “volto della Luna” che fece cambiò la storia dell’umanità.
Se poi in casa c’è un appassionato di montagna o di mare che abbia un cannocchiale con caratteristiche tipo 7x50, allora userà qualcosa di molto simile al secondo cannocchiale usato da Galilei, che con questi due riuscì nell’inverno del 1609 a capire, come lui stesso scrisse nel “Sidereus Nuncius”, il messaggero delle stelle, che «la superficie della Luna non è affatto liscia, uniforme e di sfericità esattissima, come di essa e degli altri corpi celesti una numerosa schiera di filosofi riteneva, ma al contrario, disuguale, scabra, ripiena di cavità e di sporgenze, non altrimenti che la faccia stessa della Terra ...».
Un consiglio quindi: non aspettiamo l’eclissi del 27 luglio per guardare la Luna, osserviamola ogni sera nel prossimo mese per un attimo, da soli o in compagnia, magari dei figli. Basta un attimo ogni sera per vedere come cambia e come è sempre mutevolmente affascinante.
* Il Sole-24 Ore, 07 luglio 2018 - ripresa parziale.
-
>DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - «Potrebbero bastare uno o due decenni. Il meglio deve ancora venire. Una rivoluzione scientifica è alle porte» (Michael Gillon).22 novembre 2017, di Federico La Sala
L’esploratore di esopianeti Michael Gillon:
«Cari ragazzi, una rivoluzione vi aspetta»
di Nicla Panciera (La Stampa, 22.11.2017)
«Ci sono innumerevoli Soli e innumerevoli terre, tutte ruotanti attorno ai loro soli, esattamente allo stesso modo dei sette pianeti del nostro Sistema Solare», scriveva Giordano Bruno nel 1584. Per dare conferma scientifica a quest’ipotesi visionaria sull’esistenza di pianeti orbitanti intorno a stelle come il Sole ci sono voluti tre secoli. Ma sono bastati 20 anni dalla scoperta del primo esopianeta extrasolare, 51 Pegasi b, per arrivare a contarne oltre 3 mila.
«Queste cifre suggeriscono che quasi tutte le stelle della nostra galassia e, quindi, dell’intero Universo ospitano un sistema planetario. Nei vari mondi fin qui osservati è emersa un’inaspettata diversità e ora ne stiamo studiando le diverse architetture, la loro formazione ed evoluzione», ci spiega Michael Gillon dell’Università di Liegi in Belgio. Per i suoi contributi alla fondazione della disciplina che studia gli «altri mondi», l’esoplanetologia, gli è stato assegnato il Premio Balzan 2017, riconoscimento di 750 mila franchi svizzeri.
È suo il primo nome sul lavoro pubblicato da «Nature» sulla scoperta di sette pianeti simili alla Terra intorno alla nana rossa Trappist-1. Cacciatore di pianeti fin da quando ha deciso di volgere lo sguardo al cielo, il giovane ricercatore ha già incontrato molti studenti intelligenti e brillanti. A loro dice di non farsi spaventare dai piccoli ostacoli iniziali, ma di concentrarsi sulla magia dell’astrofisica: «Imbarcarsi in quest’avventura non li deluderà, viviamo in un momento entusiasmante in cui c’è spazio per grandi scoperte. La passione deve, però, essere così dirompente da sovrastare gli altri bisogni»: parola di un ex militare che ha trascorso sette anni in fanteria prima di decidere di riprendere gli studi e di dedicare il suo rigore e la sua tenacia alle battaglie scientifiche.
È molto riconoscente verso l’amata Wendy e i figli Amanda e Lucas per il supporto ricevuto e ammette di non rappresentare la norma: «Dopo il post-dottorato, a Ginevra, sono tornato a Liegi, ma la maggior parte degli scienziati si sposta per acquisire competenze da un ateneo all’altro, di continente in continente, e spesso finisce per stabilirsi molto lontano dal proprio Paese e dai propri cari».
L’astrofisica - conferma - sta vivendo un momento di grande fermento. Sta per partire il progetto che Gillon ha nominato come i celebri biscotti belgi, «Speculoos» e, nel 2019, Esa e Nasa lanceranno il gigantesco telescopio spaziale «James Webb». Intanto, in Cile, è in via di installazione il telescopio europeo E-Elt, il più grande mai realizzato finora. Assistiamo poi ad un moltiplicarsi di missioni per la ricerca di nuovi mondi: «Tess» della Nasa, al via la prossima primavera, e «Cheops» e «Plato» che l’Esa lancerà rispettivamente nel 2019 e 2025.
Le aspettative sono pari agli sforzi messi in campo: «Ci stiamo attrezzando per esplorare una terra incognita, dove mai abbiamo messo piede e neppure gettato lo sguardo», assicura il cacciatore di esopianeti e, muovendo le mani davanti a sé come afferrando una torcia, ribadisce: «Illuminiamo i territori bui con i nostri telescopi, che ci restituiranno un sacco di sorprese». Come accadde a Galileo con il suo cannocchiale: «È difficile dire che cosa otterremo dai vari programmi in partenza, in pratica tutto è possibile. A guidarci non è solo la teoria ma l’osservazione. Non puntiamo solo, come un tempo, alla conferma sperimentale delle ipotesi fisiche. Stiamo spingendo al massimo le capacità tecnologiche, che costituiscono, di fatto, i limiti delle nostre conoscenze».
E, infine, la grande questione che affascina da sempre l’umanità: la vita. «Cercando tracce chimiche di attività biologica, vogliamo scoprire la prevalenza della vita nello spazio, non avendo alcuni a priori sulla frequenza di questo evento. Questo ci aiuterà a capire meglio le nostre origini e a mettere la nostra esistenza in una prospettiva galattica. Le implicazioni vanno oltre la scienza e invadono i reami della filosofia. Sono gli aspetti sociali e culturali a rendere questo interrogativo fondamentale».
Quanto ci vorrà? «Potrebbero bastare uno o due decenni. Il meglio deve ancora venire. Una rivoluzione scientifica è alle porte». La generazione di giovani scienziati che dichiarerà l’eppur c’è vita, dall’impatto travolgente come l”eppur si muove” galileiano, è già nata.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
-
> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! --- Il 2018 è l’anno del telescopio della Nasa “James Webb”. Individuerà nuovi esopianeti e studierà le loro atmosfere (di Amedeo Balbi).23 agosto 2017, di Federico La Sala
Andremo a esplorare le altre Terre in cerca degli alieni
Il 2018 è l’anno del telescopio della Nasa “James Webb”. Individuerà nuovi esopianeti e studierà le loro atmosfere. E altre missioni si preparano a svelare i misteri della vita
di Amedeo Balbi (La Stampa, 23.08.2017)
Non tutti ne sono ancora consapevoli, ma proprio in questi anni stiamo vivendo una rivoluzione scientifica che potrebbe avere profonde conseguenze per la comprensione del nostro posto nell’Universo, paragonabili a quelle prodotte dalle idee di Copernico o di Darwin. Da poco più di 20 anni abbiamo trovato le prove che esistono altri pianeti intorno ad altre stelle. Non solo, ma molti di questi pianeti sembrano avere caratteristiche fisiche che potrebbero potenzialmente renderli adatti alla presenza di forme di vita.
Se ci si ferma a riflettere sui numeri, c’è da rimanere a bocca aperta: le stime attuali ci dicono che molto probabilmente ognuna dei circa 200 miliardi di stelle della nostra galassia ha almeno un pianeta che le orbita attorno. Quelli potenzialmente abitabili (non da noi, naturalmente, ma da qualche forma di vita «autoctona», magari microscopica) potrebbero essere decine di miliardi. Quando guardate il cielo in una notte d’estate, provate a pensare all’incredibile vastità di ambienti alieni che state abbracciando con un solo sguardo.
Quelle precedenti sono estrapolazioni basate sulle osservazioni di esopianeti (pianeti che orbitano attorno ad altre stelle), compiute negli ultimi due decenni grazie a una serie di sofisticati strumenti astronomici. Attualmente il numero di esopianeti noti supera di poco quota 3500.
La maggior parte è stata scoperta da una missione spaziale di grande successo, il satellite Kepler della Nasa. Kepler è un telescopio relativamente modesto (ha uno specchio di 95 cm, poca cosa rispetto ai più grandi telescopi terrestri che ormai toccano la decina di metri di apertura), ma il fatto di trovarsi nello spazio lo mette in una posizione di vantaggio. Kepler ha potuto osservare la minuscola diminuzione di luminosità causata dal transito di un pianeta di fronte alla propria stella, con una sensibilità che al momento è preclusa agli strumenti terrestri. Alcune centinaia di esopianeti sono stati scoperti con una tecnica differente, basata sull’osservazione del piccolo spostamento periodico della stella indotto dall’interazione gravitazionale con uno o più pianeti.
Dopo la valanga di scoperte recenti, ora stiamo entrando in una seconda fase nello studio degli esopianeti, in cui si esamineranno più in dettaglio i candidati più interessanti, in particolare quelli che sembrano più promettenti dal punto di vista della potenziale abitabilità. Il futuro prevede una serie di nuovi progetti osservativi, alcuni dei quali vedranno la luce a breve. Due nuove missioni spaziali, una dell’Esa e l’altra della Nasa, dovrebbero essere lanciate entro l’anno prossimo. Si tratta, rispettivamente, di Cheops e di Tess. Il primo, un piccolo telescopio spaziale di appena 30 cm di apertura, osserverà il transito di esopianeti già noti per provare a determinarne la densità e quindi la composizione fisica. Il secondo cercherà di incrementare il bottino di pianeti di dimensioni simili alla Terra messo insieme da Kepler, concentrandosi soprattutto su stelle brillanti e relativamente vicine alla nostra. Ciò preparerà la strada per le osservazioni del James Webb Space Telescope, il successore del telescopio spaziale Hubble che la Nasa dovrebbe mettere in orbita verso la fine del 2018.
Le aspettative per questa missione sono altissime (anche visto l’enorme impegno economico profuso per la sua realizzazione) e prevedono la possibilità di studiare le atmosfere di esopianeti già noti, determinandone la natura e la composizione. Capire come è fatta l’atmosfera di un pianeta è uno degli ingredienti cruciali per stabilirne le condizioni climatiche e l’effettiva propensione a ospitare organismi viventi. Non solo, ma la presenza stessa della vita può alterare in modo misurabile la composizione dell’atmosfera, come è avvenuto sul nostro pianeta con la comparsa degli organismi fotosintetici, che hanno rilasciato enormi quantità di ossigeno.
Investigare mondi lontanissimi dal nostro, fino addirittura a cercarvi le possibili tracce della vita, è un obiettivo difficile, che non sarà raggiunto nel giro di pochi anni, e che richiederà uno sforzo congiunto e l’applicazione di molte tecniche diverse. Non solo osservazioni dallo spazio, ma anche con telescopi terrestri: quelli di prossima generazione, come lo European Extremely Large Telescope, o Elt, di cui è iniziata la costruzione in Cile, avranno dimensioni imponenti (lo specchio sfiorerà i 40 metri di diametro) e potrebbero persino ottenere le prime immagini dirette di pianeti simili alla Terra. Se i passati 20 anni sono stati quelli in cui abbiamo capito che esistono altri mondi oltre a quelli del sistema solare, i prossimi 20 saranno quelli in cui proveremo a capire una volta per tutte se siamo davvero soli nell’Universo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
-
> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ..."NEW TON"!!! --- LA COMETA, L’APOCALISSE, E UNA BOTTIGLIA DI ROCCAMORA!!!5 giugno 2017, di Federico La Sala
MATEMATICA, FILOSOFIA, E TEOLOGIA: GALILEI, ROCCAMORA, E NEWTON... *
____________________________________________________________________________
LA COMETA, L’APOCALISSE, LE "CIFRE DELL’EUCHARISTIA", E UNA BOTTIGLIA DI ROCCAMORA!!!
IN VINO VERITAS. Una nota
di Federico La Sala
A COMINCIARE DALLA FINE, E DALLA BOTTIGLIA DI "ROCCAMORA" (sull’etichetta della bottiglia di rosso "negroamaro", in forma di "croce", appare un "calice" con dentro il "sole"!), GUARDANDO E "LEGGENDO" CON maggiore ATTENZIONE L’IMMAGINE DELL’ETICHETTA, E FREQUENTANDO (di più) LA "SCHOLA SARMENTI" , è possibile capire MEGLIO (mi sia lecito!!!) QUESTO PREZIOSO contributo del prof. Armando Polito,
 "ROCCAMORA, OVVERO IL VINO COME STORIA E COME CULTURA",
"ROCCAMORA, OVVERO IL VINO COME STORIA E COME CULTURA",
 e, forse, riuscire a non confondere il buon-vino con il vino taroccato, o, diversamente e più pertinentemente, di non perdere il legame che corre e scorre tra il vino, l’acqua sporca, e il bambino.
e, forse, riuscire a non confondere il buon-vino con il vino taroccato, o, diversamente e più pertinentemente, di non perdere il legame che corre e scorre tra il vino, l’acqua sporca, e il bambino.Qui il discorso è, o, se si vuole, diventa filosofico, antropologico, e teologico! La questione (e la parola) rimanda alla EUCHARISTIA e alle sue CIFRE - all’opera di GIOVANNI DOMENICO ROCCAMORA (CFR.: Delle cifre dell’Eucharistia) - vale a dire al lavoro di DECIFRAZIONE (dei "due libri": Bibbia e Natura, come da lezione di GALILEO GALILEI) portato avanti dal teologo, filosofo e matematico, GIOVANNI DOMENICO ROCCAMORA.
SENZA FARSI PRENDERE DALLA FRETTA (vedi: "Intriga non poco Assist[ens?] et Galil[ei?] discipul[us] ma il tempo incalza"), Il lavoro sulla "Filosofia dei nobili" del 1668, Il trattato sulla cometa del 1970, e il trattato sulle "cifre dell’Eucharistia" (1668-1684) vanno riletti di nuovo e insieme, e, sicuramente, in un orizzonte di cultura che sappia riunire la SAPIENZA dell’Università (Roma) e la "SCHOLA SARMENTI" del ROCCAMORA!!!
UNA BUONA E BELLA OCCASIONE DA NON SCIUPARE, PER BRINDARE AL BRILLANTE LAVORO DEL PROF. POLITO, ALLA FONDAZIONE TERRA DI OTRANTO, E ALLA "SCHOLA SARMENTI" E AL ROCCAMORA..
P. S.
SUL TEMA, da ricordare e non sottovalutare, che tra il 1660 e il 168o ISAAC NEWTON si occupa di interpretazione profezie e particolarmente dell’ "Apocalisse" (cfr. Isaac Newton, "Trattato sull’Apocalisse", a c. di M. Mamiani, TORINO 1994).
- DOC.: GALILEI E LA CATTEDRA DI MATEMATICA ALLA "SAPIENZA" ...
Dalla Controriforma ai Lumi. Ideologia e didattica nella "Sapienza" romana del Seicento
di Giovanni Rita *
[...] Dopo una pausa di altri due anni in cui restò ancora senza maestri, la disciplina vide per la prima volta una continuità con Benedetto Castelli, un monaco benedettino già alunno e amico di Galilei, chiamato dal papa come precettore del nipote Taddeo Barberini 129. Castelli poté svolgere a Roma anche un’attività di consulente in opere idrauliche, fino a che l’esito del processo a Galileo non gli consigliò di ritirarsi in Toscana. Ma intanto il maestro aveva potuto formare numerosi allievi, ricordati ancora oggi in vari campi, ove essi finalmente ebbero modo di applicare i nuovi metodi130. Tra di loro, il lucchese Santini fu suo successore sulla cattedra romana: benché, a giudicare dai ruoli, svolgesse ancora gli Elementi euclidei e la Sfera di Sacrobosco, Santini dedicò un corso a quella che sembra una nuova impostazione disciplinare, la «geometria speculativa et practica»; oppure una «theorica planetarum» che figurava indipendentemente dalla tradizionale «astronomia Ptolemaei» 131. A sua volta l’eclettico monaco Gian Domenico Roccamora, pur subendo ancora a volte il fascino del barocco 132, proseguì nelle innovazioni del predecessore, aggiungendo ulteriori argomenti quali «de arcibus muniendis», «de optica», «de fortificationibus»133. [...].
Nota 132:
"Roccamora (mathematica 1664-1684: I maestri, p. 923) fu autore del Delle cifre dell’Eucharistia. Cioè a dire di quel Libro, che fù discifrato dall’Agnello à i venti quattro Vecchioni dell’Apocalisse, I-IV, Roma, Dragondelli, 1668-1684, grottesca opera di pseudo-esegesi biblica su cui, con ampie citazioni, v. Giovanni Rita, Il Barocco in Sapienza. Università e cultura a Roma nel secolo XVII, in Luoghi della cultura nella Roma di Borromini, Roma, Retablo, 2004, p. 56-58. Da quanto risulta inoltre da ASR, Università 87, f. 6-9 (del 1681) Roccamora aveva progettato una «sfera bizzarrissima» che avrebbe segnato l’ora nelle varie parti della terra oltre alle fasi lunari, eventuali eclissi e perfino riprodotto con giochi d’acqua l’esistenza di fiumi e oceani".
* Cfr. : Annali di Storia delle Università italiane - Volume 9 (2005) - ripresa parziale.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
Federico La Sala
-
>DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ..."NEW TON"!!! - COSMONAUTICA. Luca Parmitano, astronauta: “Il futuro Cristoforo Colombo lo stiamo già addestrando”.21 maggio 2017, di Federico La Sala
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
- MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA ( - e ROCCO PETRONE). Un ’ricordo’
- 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!!
- "voglio superare il concetto secondo cui la Terra sarebbe la culla dell’umanità; in questo momento ne è anche la gabbia e a nessuno piace vivere in cattività" (Luca Parmitano).
INTERVISTA *
Luca Parmitano, astronauta: “Il futuro Cristoforo Colombo lo stiamo già addestrando”
Secondo il primo astronauta italiano protagonista di una passeggiata spaziale, nel futuro non sarebbero da escludere cosmonauti mutanti. E no, non è fantascienza
Di una cosa Luca Parmitano sembra davvero orgoglioso. Ma è difficile scovarla. E non perché l’astronauta catanese, protagonista della prima missione di lunga durata dell’Agenzia spaziale italiana, non vada fiero di quello che fa, anzi. È che complici il suo contegno militare - è Maggiore Tenente Colonnello pilota dell’Aeronautica - e soprattutto il suo carattere. Mai, nei suoi occhi o nelle sue parole, traspare l’ombra del vanto.
Per Parmitano il successo è sempre della squadra. Ogni traguardo, foss’anche Marte, diventa raggiungibile solo grazie alla collaborazione.
E questo, nonostante di risultati personali potrebbe sfoggiarne un elenco: come collaudatore ha accumulato 2mila ore di volo su oltre 40 tipi di velivoli; nel 2005 è stato decorato con la medaglia d’argento al valore per aver portato a terra il suo Amx dopo che l’impatto con una cicogna l’aveva compromesso. Selezionato dall’Agenzia spaziale europea nel 2009 è diventato il sesto astronauta italiano, il quarto ad abitare la Stazione spaziale internazionale (nel 2013, per 166 giorni) e il primo ad averci passeggiato attorno, in due attività extraveicolari, o Eva, portate a termine nonostante una grave avaria della tuta nella seconda occasione.
Nel 2014 è stato comandante della spedizione Caves, con cui l’Esa prepara gli astronauti alle missioni spaziali facendo loro trascorrere sette giorni sottoterra nella diaclasi Sa Grutta, vicino Olbia.
L’anno successivo ha partecipato, sempre come comandante, alla spedizione della Nasa, Neemo20, due settimane vissute dentro Aquarius, una stazione 19 metri sotto la superficie marina al largo della Florida.
Eppure, si diceva, è di un’altra cosa che Luca Parmitano sembra orgoglioso: è il primo europeo a fare da regista a due Eva. Il che significa comunicare direttamente con gli astronauti fuori dalla Iss per guidarli nelle procedure.
Perché, dice lui, “la conquista spaziale non è un’impresa di qualche eroe solitario. E al futuro ci si prepara insieme“.
A proposito, in che modo Neemo e Caves c’entrano con il nostro futuro nello Spazio?
“Entrambe rimandano alla componente esplorativa dei viaggi spaziali, le sono complementari. Consistono in un addestramento in condizioni estreme, come quelle che affronteremo nei prossimi lanci.
“Sottacqua abbiamo un habitat che, per molti aspetti, è come quello di un’astronave sommersa: non solo consente di simulare gravità diverse, implica anche la componente scientifica di ogni missione, con gli esperimenti nel laboratorio, e quella esplorativa grazie alle uscite nello scafandro.
“Che cosa c’entra l’esperienza sottomarina con quella cosmica? Tutto. Lo scafandro è immerso in un ambiente alieno, che consente di testare ingegneria e design degli strumenti che utilizzeremo.
“In Caves ci sono altre componenti: spostarsi dentro grotte sotterranee implica affrontare posti inesplorati e inadatti al nostro soggiorno. Senza supporto, isolati, dove tutto quello che ti serve te lo devi portare appresso. È un contesto in cui sperimentare la dimensione fisica e logistica delle missioni spaziali.
“In sintesi, Neemo e Caves insegnano come addestrare gli astronauti nel futuro. Non è un caso se a breve continuerò la preparazione a Lanzarote, nelle Canarie; quelle zone sono come un pezzo di suolo marziano sulla Terra”.
È plausibile che in tempi brevi colonizzeremo il Pianeta Rosso?
“Al momento prevediamo di raggiungerlo negli anni Trenta [a fine marzo la Nasa ha pubblicato il suo piano in 5 fasi per arrivarci nel 2033, ndr]. Ma meglio non parlare di tempi brevi quando c’è il cosmo di mezzo”.
È pessimista?
“Tutt’altro, ci arriveremo. Mi riferivo al dopo: voglio superare il concetto secondo cui la Terra sarebbe la culla dell’umanità; in questo momento ne è anche la gabbia e a nessuno piace vivere in cattività. A parte la curiosità innata, è per una questione di sopravvivenza ed espansione nel tempo. In questo senso non abbiamo fatto che un primo passo: siamo in orbita in modo continuativo.
“Ce ne sarà presto un secondo, costituito da una probabile permanenza nel sistema Terra-Luna. Questo almeno vorrebbe l’Esa, creare un ambiente adatto alla colonizzazione e allo sfruttamento locale delle risorse. Quindi procedere verso Marte. Il che imporrà si riesca ad affrontare un viaggio interplanetario.
“Non mi azzardo a parlare di terraforming, di trasformazione a nostro uso e consumo di un ambiente extraterrestre. Siamo ancora lontani da questa eventualità, ma molto prossimi a vedere da vicino com’è l’ambiente marziano”.
Poi?
“Poi la prospettiva andrebbe estesa: oggi siamo in grado di confermare la presenza di pianeti abitabili intorno a quasi tutte le stelle, miliardi di mondi in cui la vita è possibile, in cui c’è acqua, con un’atmosfera simile alla nostra. E allora credo sia il caso di pensare al futuro.
“Ecco perché il concetto di tempi brevi, se non altro inteso come un periodo compreso nell’arco della vita umana, andrebbe rivisto.
“I passaggi per effettuare un viaggio interstellare sono esponenzialmente più complessi del volo interplanetario, ma come ricordava Lao Tzu anche il cammino più lungo inizia con un passo.
“Tanto che c’è già chi parla di come inviare un microchip oltre il nostro sistema solare, lambendo frazioni decimali della velocità della luce. Come non intravedere la possibilità di arrivare prima o poi a un’astronave, ovviamente attraverso tutte le tappe intermedie, dai robot ai lander fino all’uomo?”.
L’attività sulla Stazione spaziale rientra in questa progressione?
“Come non potrebbe? Si pensi al Beam, anagramma di Bigelow Expandable Activity Module, installato sulla Stazione nell’aprile del 2016. È un modulo gonfiabile, un esperimento per verificare la resistenza fuori dall’atmosfera terrestre di un ambiente espandibile composto da vari strati, fra cui uno in Vectran, un materiale due volte più resistente del Kevlar.
“È fondamentale comprenderne l’importanza se parliamo del nostro futuro nel cosmo, visto che sarà molto difficile affrontare un viaggio interplanetario con un veicolo di grandi dimensioni.
“L’idea è allora di lanciare masse ridotte per poi espanderle, costruire in volo l’astronave di 2001: Odissea nello spazio con moduli gonfiabili in progressione”.
Adesso mi sembra troppo fiducioso. Eppure visse in prima persona gli imprevisti dello Spazio. Come affrontò l’incidente durante la sua seconda passeggiata fuori dall’Iss? E come lo concilia con il suo entusiasmo attuale?
“Ricordando che nello Spazio non c’è posto per gli individualismi. Se non capissimo noi per primi l’importanza inestimabile del lavoro di squadra, a terra e a bordo, commetteremmo un errore grave. Di quelli che possono costare cari”.
Che cosa intende?
“Il 16 luglio 2013, poco dopo l’inizio della mia seconda attività extraveicolare, l’Eva 23, per un malfunzionamento il mio casco ha cominciato a riempirsi d’acqua. In tutto l’emergenza è durata 35 minuti e per circa 8 l’avaria è stata grave, tanto da costringermi al rientro: in quel frangente ho perso ogni contatto radio oltre che sensoriale. Avevo acqua negli auricolari, nel naso, mi aveva coperto gli occhi. Faticavo a respirare, non potevo sentire né parlare, perché i sistemi di comunicazione, microfoni compresi, si erano bagnati.
“In più, una volta nell’airlock della Stazione, ho dovuto sopportare per 15 minuti la pressurizzazione con il sistema di Valsalva compromesso. È un apparato di compensazione che permette, tappando il naso, di pressurizzare le orecchie, ma essendo spugnoso e zuppo d’acqua si era strappato. Non una bella sensazione: è come scendere di colpo da 3mila metri al livello del mare senza contrastare la spinta sui timpani. Un dolore lancinante cui non ci si può opporre.
“Bene, non voglio sminuire le difficoltà di una situazione critica, fingerei. Sono momenti in cui la tua vita è a rischio. Quello che voglio ridimensionare è il merito dell’individuo.
“Oltre agli astronauti, un’Eva coinvolge numerosi collaboratori a Terra, persone che hanno scelto e curato l’addestramento, selezionato gli strumenti e concordato le procedure. Questo insieme è quello che ti permette di avere il battito cardiaco invariabile durante un’avaria, quello che ti concede l’opportunità di pensare...
“Quel 16 luglio, fuori dall’Iss e con un litro e mezzo di acqua nel casco, non ero solo: portavo con me un bagaglio di esperienze costruitomi, per mesi, da una squadra“.
Sta dicendo di non aver avuto paura?
“Certamente ne ho avuta. Ma la differenza tra una persona senza addestramento e chi è preparato consiste nella gestione dello stress. Fino a un certo livello ha effetti fisiologici positivi: il cuore pompa più forte per preparare i muscoli, l’aumento di adrenalina nel sangue stimola la reattività del cervello, la velocità di ragionamento cresce. È fondamentale imparare a utilizzare queste risposte come uno strumento e non permettere siano loro a controllarci. Proprio a questo obbiettivo punta l’addestramento”.
Qual è il problema maggiore nell’evoluzione dei viaggi spaziali?
“L’essere umano”.
Cioè?
“I nostri limiti fisiologici”.
Si riferisce, per esempio, all’esposizione alle radiazioni cosmiche durante viaggi lunghi?
“Focalizzarsi su un problema non serve. Se non ha soluzione, è un dato: saremo di certo esposti alle radiazioni. Possiamo solo aggirare l’ostacolo”.
Come?
“Tralasciamo per un momento le implicazioni etiche e chiediamoci se sia possibile stimolare un’evoluzione mirata. Sappiamo che il dna umano contiene geni di cui non si conoscono ancora proprietà o funzioni. Per esempio, condividiamo quella parte di corredo cromosomico che permette all’orso bruno di andare in letargo. È possibile attivare quel gene in modo da mandare anche l’uomo in ibernazione?
“In questa condizione il metabolismo rallenta fino quasi ad arrestarsi ed è bene ricordare che le radiazioni hanno effetto sugli esseri umani solo durante meiosi o mitosi, vale a dire quando le cellule si duplicano. Se quindi, durante un viaggio interplanetario, si è in ibernazione, il rischio che si verifichi una mutazione cellulare può essere ridotto di molto”.
Astronauti in letargo?
“Esatto. A questo punto la questione si sposta in ambito eto-biologico: è lecito intervenire sul dna degli esseri umani? O, di contro, fino a che punto è sensato escludere un’evoluzione mirata per una parte di umanità, che possa destinarla all’esplorazione del cosmo e farne il nostro prossimo gradino evolutivo: i viaggiatori interstellari.
“Ricordiamoci che l’etica è flessibile e che trattandosi di evoluzione le questioni da soppesare sono più grandi del singolo individuo.
“Detto altrimenti, se mi trovassi fra mille anni a osservare una parte evoluta della razza umana, capace di andare in letargo, quadrumane e con coda prensile - caratteristiche perfette per l’habitat spaziale -, perché dovrei pensare che è un male?“.
Insiste tanto sulla dimensione esplorativa dei viaggi spaziali.
“Perché è la sintesi di scienza e tecnologia, è l’ampliamento delle nostre conoscenze. Ripercorrendo i tempi, è bene ricordare che siamo andati sulla Luna negli anni ’60. Quel decennio costituì una breve parentesi di stimoli straordinari, capaci di spingere l’uomo a fare cose incredibili. Ma pensiamoci, che cosa abbiamo fatto? Siamo stati come i vichinghi che hanno attraversato la Danimarca, l’Oceano Atlantico, il Circolo polare artico. E arrivati in un nuovo Continente, sono tornati indietro. Un passaggio epocale, un salto nell’ignoto senza precedenti, ma anche un evento a sé stante.
“Poi, per quanto nessun vichingo si sia più avventurato attraverso l’Atlantico, nel Mediterraneo le grandi repubbliche marinare hanno sviluppato enormemente la tecnologia delle proprie imbarcazioni, migliorandone la capacità di navigazione, stoccaggio e anche la strumentazione di bordo. Ecco perché, secoli dopo, si è arrivati in America.
“Cristoforo Colombo ha contrassegnato un altro passaggio, proprio come faremo noi nei prossimi anni con la Luna e Marte. Ecco, probabilmente saremo un po’ come Colombo, nel senso che non riusciremo a rimanere per lungo tempo dove andremo. Non subito, almeno.
“Il vero salto evolutivo sarà quando, come con il Mayflower, diventeremo coloni. E per farlo, avremo bisogno di un balzo non solo tecnologico, ma anche sociale. Chi diventa colone? Quelli che in inglese sono chiamati misfits”.
Reietti?
“Piuttosto persone che non tollerano l’essere costretti in un ambiente. Uomini che hanno un bisogno quasi fisico delle difficoltà, che sono addirittura attratti dalla scomodità.
“Oggi molti vorrebbero rendere il volo spaziale più simile a quello terrestre. Si tende a un ambiente ergonomico, confortevole. Ma quelli che diventeranno i nostri coloni lunari o marziani cercheranno tutt’altro: si imbarcheranno perché hanno bisogno del Far West, di orizzonti aspri, di esperienze ruvide, di una bellezza che non è quella del design raffinato. Ma molto, molto più spartana”.
Ce la faremo a vederli?
“Una parte: forse non vedremo salpare il Mayflower, ma Cristoforo Colombo sì. Lo stiamo già addestrando“.
* WIRED, 19.05.2017 (Ripresa parziale - senza immagini).
-
>CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ..."NEW TON"!!! - 2069: progetto Breakthrough Starshot. Telescopi puntati sul ’fratello’ della Terra.12 gennaio 2017, di Federico La Sala
- IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo.
Telescopi puntati sul ’fratello’ della Terra
Si osserva Proxima b per aprire la via alla futura flotta di vele solari *
Il progetto per inviare una flotta di vele solari a caccia di vita nel pianeta scoperto nel sistema stellare Alpha Centauri, trova l’alleanza con i telescopi dell’Osservatorio Meridionale Europeo (Eso), che si trovano in Cile.
Per preparare il viaggio delle vele solari previsto dal progetto Breakthrough Starshot, rende noto l’Eso, il Very Large Telescope (Vlt) verrà modificato in modo da fotografare i dettagli del pianeta ’gemello’ della Terra scoperto recentemente attorno alla stella più vicina a noi, Proxima Centauri e che potrebbe ospitare forme di vita.
"Da poco tempo - ha spiegato Giancarlo Genta, del Politecnico di Torino e unico italiano membro del comitato scientifico di Breakthrough Starshot - sappiamo con certezza che lì esiste un pianeta, e sembrerebbe avere caratteristiche simili alla Terra, ma niente di più. Prima di mandare una sonda servirebbe saperne di più".
Per questo è nato un’accordo tra Eso, l’osservatorio che ha scoperto l’esistenza di Proxima b, e Breakthrough Starshot, il progetto che prevede di inviare una flotta di mini-sonde capaci di viaggiare a velocità altissime per raggiungere Alpha Centauri in appena 20 anni.
Il progetto Breakthrough Starshot è nato dalle idee di alcuni dei più importanti ricercatori del mondo, tra i quali l’astrofisico Stephen Hawkings, è finanziato dal magnate russo Yuri Milner ed è previsto nel 2069, ma i ricercatori sono già al lavoro.
Dopo l’annuncio della realizzazione di una Google Map dello spazio interstellare, grazie ai dati del telescopio spaziale Hubble, fondamentale per guidare il viaggio delle sonde, arriva adesso l’accordo con uno dei più potenti telescopi al mondo.
"Le sonde - ha spiegato Genta - non potranno essere telecontrollate, ma dovranno essere autonome, quindi maggiori informazioni potremo avere più facile potrà essere il loro lavoro". Per questo si è concordato di fare di miglioramenti allo strumento Visir installato su Vlt, il maxi telescopio di oltre 8 metri di diametro che si trova nel deserto di Atacama, e di trasferire i miglioramenti anche su E-Elt (European Extremely Large Telescope), il super telescopio da 40 metri dell’Eso, ancora in fase di costruzione.
*Ansa, 11 gennaio 2017 (ripresa parziale).
-
> 2060:CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, UN ALTRO ... "NEW TON"!!! - "Addio", materia oscura. Uno studio basato sui dati di Spitzer scardina l’ipotesi "dark matter".21 dicembre 2016, di Federico La Sala
"Addio", materia oscura
Uno studio basato sui dati di Spitzer prende in esame la curva di rotazione galattica, un parametro che lega velocità di rotazione e raggio. Il ritmo di marcia costante di stelle o gas sarebbe determinato dalla presenza di materia visibile
di Agnese Cerroni *
Un girotondo a velocità costante che nega il ruolo della materia oscura nelle dinamiche interne ad una famiglia di stelle. Porta la firma della Case Western Reserve University l’ultimo studio a tema galattico, pubblicato sulla rivista Physical Review Letters e sulla piattaforma arXiv.org, che mette sotto esame 153 galassie - a spirale e irregolari, di vario taglio, dalle più grandi a quelle nane - alcune con rigonfiamento centrale altre senza, per studiare un parametro noto come rotation curve. Si tratta di una misura astronomica che mette in relazione la velocità orbitale delle stelle o dei gas all’interno di una galassia con la distanza radiale dal centro della stessa. In scala ben più ampia, è lo stesso rapporto che lega il periodo di rivoluzione di un pianeta alla distanza che lo separa dal Sole.
Già nel 1970 una coppia di ricercatori, Vera Rubin e Albert Bosma, notò che la velocità di rotazione di una galassia a spirale non diminuiva all’aumentare del suo raggio, contravvenendo alla Legge di Newton. Il motivo di tale anomalia era da ricercare nella presenza invisibile della enigmatica materia oscura che forniva una spinta gravitazionale aggiuntiva.
Le analisi odierne, elaborate sulla base dei dati prodotti dal telescopio NASA Spitzer, ribaltano questa prospettiva scardinando l’ipotesi dark matter: l’accelerazione osservata rispetto al raggio galattico - la rotation curve - sarebbe in relazione con la spinta gravitazionale esercitata soltanto dalla materia visibile e il legame velocità costante/raggio sarebbe l’equivalente di una legge di natura sinora sconosciuta.
Lo studio, boicottando la componente oscura, apre nuovi scenari per la comprensione delle dinamiche fisiche che regolano l’equilibrio dell’Universo.
* ASI - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA, Giovedì 22 Settembre 2016 (ripresa parziale).
-
> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! --- "KEPLER", LE NUOVE «TERRE», E IL CAMBIO DI PARADIGMA (di Guido Tonelli)27 giugno 2016, di Federico La Sala
- LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
C’è vita nell’universo, molta vita
Gli scienziati di Kepler, un grande telescopio lanciato in orbita nel 2009, hanno da poco annunciato di avere scoperto 1.284 nuovi pianeti extra-solari (o esopianeti), cioè pianeti che ruotano attorno a una stella diversa dalla nostra. Tutto fa immaginare che ce ne siano miliardi, alcuni «ospitali». Il mondo sta entrando in una nuova epoca
di Guido Tonelli * (Corriere della Sera, La Lettura, 26.06.2016)
Stiamo entrando in una nuova epoca e nessuno sembra rendersene conto. Di tanto in tanto giornali e televisioni riportano qualche notizia; se ne parla per un paio di giorni poi tutto viene macinato dal tritacarne dell’attualità. L’ultima, di qualche settimana fa, riguarda Kepler, una sonda della Nasa che prende il nome dal grande astronomo tedesco. La sua missione è la scoperta di esopianeti, o pianeti extra-solari, che orbitano cioè attorno ad altre stelle; il fine ultimo è quello di identificare pianeti abitabili, simili alla nostra Terra.
Le primissime ricerche risalgono addirittura agli anni Quaranta, ma utilizzavano tecniche di osservazione piuttosto grossolane. Usando i migliori telescopi allora disponibili si cercavano nuovi sistemi solari sperando di osservare una perturbazione periodica nella posizione della stella-madre. È ben noto che, per le leggi della gravitazione, in presenza di un pianeta la stella-madre non sta ferma, ma compie anch’essa una piccola rotazione intorno al centro di massa del sistema.
Tanto più massiccio è il pianeta tanto maggiore è lo spostamento periodico della stella. Il metodo, detto astrometrico, non ha portato a risultati di rilievo; sono stati identificati un gruppo di potenziali candidati ma nessuno è mai stato confermato. Risultati molto più interessanti si sono avuti con il metodo della misura della velocità radiale. Il principio è lo stesso, si cerca di osservare il minuscolo spostamento periodico della stella-madre, ma la tecnica è basata su misure spettroscopiche che consentono maggiori precisioni. Si analizza lo spettro di emissione luminosa della stella e si controllano nel tempo le righe corrispondenti alle varie frequenze. Se la stella presenta un piccolo movimento orbitale causato dalla presenza di un pianeta, si misura una piccola variazione periodica in frequenza della sua emissione luminosa dovuta all’effetto Doppler.
Quando la stella ha una velocità radiale positiva - cioè si avvicina al nostro punto di osservazione sulla Terra - le righe di emissione si spostano verso il blu, per poi passare dal lato opposto, verso il rosso, quando la stella si allontana. È lo stesso metodo che ci permette di riconoscere, dal suono della sirena, se un’ambulanza si sta avvicinando o si sta allontanando. Con la misura della velocità radiale della stella possiamo calcolare il periodo del moto orbitale del pianeta e la sua massa. I primi pianeti extra-solari sono stati scoperti, con questo sistema, negli anni Novanta. Si trattava di enormi corpi celesti, simili al nostro Giove. Giganti caldi, per lo più gassosi, che gravitavano molto vicini alle loro stelle-madri e avevano quindi una temperatura superficiale spaventosa.
Il metodo della velocità radiale è limitato dal fatto che si deve osservare una stella per volta ed è efficace solo per stelle relativamente vicine a noi, si fa per dire, entro una distanza di circa 160 anni luce, mentre la stragrande maggioranza delle stelle della nostra galassia sta a distanze maggiori.
La vera rivoluzione nella caccia ai pianeti extra-solari è venuta da quando è stato messo a punto il metodo dei transiti. È una tecnica basata sulla fotometria di precisione, cioè si tiene sotto controllo la luminosità della stella e si misura la lievissima attenuazione della luce prodotta dal pianeta che le transita davanti. Anche in questo caso si richiede che la perturbazione, il segnale di transito, abbia carattere periodico. La forma caratteristica del disturbo permette di misurare le dimensioni del pianeta e questa informazione, combinata con la misura della velocità radiale che dà la massa, permette di conoscerne la densità. In questo modo, da alcuni anni, la ricerca di nuove «Terre» ha ricevuto un impulso incredibile e si sono identificati i primi pianeti rocciosi simili al nostro.
Il grande vantaggio del metodo dei transiti è che si possono tenere sotto osservazione, in contemporanea, centinaia di migliaia di stelle e la sensibilità raggiunta dagli strumenti più moderni è tale che il campo d’azione si può estendere fino a distanze di migliaia di anni luce. La sensibilità del metodo è talmente spinta che si possono identificare pianeti addirittura più piccoli di Mercurio. Occorre poi considerare che, nel caso che il pianeta abbia una atmosfera, la luce della stella-madre giunge fino a noi dopo averne attraversato gli strati superiori. Misure accurate della polarizzazione della luce emessa dalla stella permettono quindi di ricavare informazioni essenziali sulla presenza di atmosfera nel pianeta.
L’unico problema del sistema dei transiti è che, per produrre segnali il punto di osservazione deve appartenere al piano delle orbite, cosa che statisticamente avviene solo per una frazione delle stelle osservate. Se poi si cercano pianeti simili alla Terra, che hanno una massa compresa fra metà e due volte quella del nostro pianeta, e che compiono una rivoluzione completa intorno alla loro stella in circa un anno, occorre aspettare molti anni per essere sicuri di avere visto un transito periodico.
Kepler è un grande telescopio lanciato in orbita nel 2009, che sorveglia da anni una piccola zona del cielo compresa fra le costellazioni del Cigno e della Lira. L’apparato tiene sotto controllo circa 150 mila stelle della nostra galassia, distribuite in una regione di dimensioni paragonabili a quella che copriamo con il palmo della nostra mano, se tendiamo il braccio verso il cielo.
La zona di osservazione copre un cono di circa duemila anni luce intorno al nostro Sole che si trova in Orione, un piccolo braccio secondario della spirale che costituisce la nostra Via Lattea. Il telescopio è ottimizzato per misure di fotometria e utilizza un sistema di camere fotografiche molto sofisticate, da 95 milioni di pixel, ma concettualmente simili a quelle che usiamo nei nostri cellulari.
Un mese fa gli scienziati di Kepler hanno annunciato di avere scoperto 1.284 nuovi pianeti extra-solari. La maggior parte dei nuovi corpi celesti sarebbero posti assolutamente inospitali, caratterizzati da atmosfere molto dense, composte essenzialmente da elio e idrogeno, e temperature torride alla superficie. Ma la novità davvero eclatante è la scoperta che pianeti simili alla Terra sono corpi celesti molto comuni fra quelli che orbitano intorno alle stelle.
Fra i nuovi venuti almeno nove dovrebbero essere pianeti rocciosi che si trovano nella fascia cosiddetta abitabile, cioè a una distanza dalla stella-madre tale da consentire temperature simili a quelle che abbiamo qui da noi. Se un pianeta roccioso si trova nella fascia abitabile e contiene acqua, questa potrebbe formare laghi e oceani come quelli che sono così diffusi sulla nostra Terra. Ecco che, di colpo il numero dei nostri potenziali cugini è quasi raddoppiato. E la cosa sorprendente è che Kepler ha osservato soltanto una piccola porzione della nostra galassia. Si stanno già preparando nuove missioni e nuove campagne di osservazioni e nel prossimo futuro si costruirà una mappa sempre più dettagliata delle «nuove Terre». Nel giro di un paio d’anni sarà lanciato un nuovo telescopio per tenere sotto osservazione le 200 mila stelle più vicine a noi fra le quali ci si aspetta di scoprire 500 pianeti rocciosi simili al nostro.
La nostra Via Lattea contiene circa 200 miliardi di stelle ed è soltanto una fra cento miliardi di galassie che popolano il nostro universo. I numeri fanno impressione: se soltanto una stella su diecimila ospitasse pianeti rocciosi nella fascia abitabile dovremmo accettare l’idea che il numero di «Terre» della nostra galassia, quindi astronomicamente vicine a noi, potrebbero essere decine di milioni. Se si considerano i 100 miliardi di galassie dell’Universo intero si potrebbe raggiungere la cifra fantastica di miliardi di miliardi. Insomma c’è pieno di pianeti abitabili intorno a noi ed è molto probabile che ci sia abbondanza di forme di vita nell’universo. Non c’è alcun motivo di credere che acqua e materia organica siano componenti ultra rari.
Fra qualche tempo saremo in grado di analizzare la composizione dell’atmosfera dei nuovi pianeti che orbitano nelle fasce abitabili per cercare eventuali composti organici, chiari indizi della presenza di forme di vita simili a quelle che ci sono familiari. Non mi interessa qui discutere il problema delle distanze e neanche la tecnologia con cui potremo stabilire una comunicazione o un contatto. Sarebbe sciocco argomentare oggi intorno a questioni che, ne sono sicuro, faranno sorridere gli scienziati del futuro.
Vorrei invece sottolineare la necessità di prepararsi a quello che sarà sicuramente un grosso choc culturale. Un’umanità che fa fatica a convivere con se stessa, sarà in grado di superare la crisi di valori legata alla scoperta di altre forme di vita? Che rapporti instaureremo fra noi, per prepararci a queste prime forme di contatto con «gli altri»? Noi che nella colonizzazione della terra non siamo stati capaci di praticare altro che depredazione e spoliazione delle popolazioni con cui siamo venuti in contatto, accetteremo di essere «i primitivi» al cospetto di civiltà che si sono sviluppate qualche milione di anni prima di noi?
E viceversa, quali relazioni saremo in grado di instaurare con forme di vita, magari simili alle nostre, ma che ci potranno apparire a un livello di sviluppo primordiale? È pensabile che si cominci a ragionare dei problemi etici connessi a questo passaggio? Noi che non siamo in grado di gestire l’integrazione di alcuni milioni di rifugiati o di emigranti che sfuggono la guerra o precarie condizioni di vita, con quali strumenti culturali arriveremo a questo appuntamento che ci chiama a un salto di civiltà?
I nostri pronipoti vedranno un mondo che noi, oggi, possiamo solo immaginare. Riusciremo ad attrezzarci nel giro di qualche generazione a questo cambio di paradigma sul piano antropologico?
* E’ uno dei principali protagonisti, insieme a Fabiola Gianotti, della scoperta del bosone di Higgsad LHC, scoperta che ha permesso di conferire il Premio Nobel per la fisica 2013 a François Englert e Peter Higgs.
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN ... 2015, ANNO DELLA LUCE.6 dicembre 2015, di Federico La Sala
- ONU: 2015, ANNO DELLA LUCE. Ai poeti ‘lunatici’ e ai filosofi ‘solari’: "l’abitudine non può rendere insipida la varietà infinita della bellezza" - prodotta dalla luce
 LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE.
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE.
Un Natale nel nome di Isacco (Newton)
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 29.12.2013)
Lo scorso mercoledì una parte del mondo occidentale ha meditato sulle parole del Vangelo secondo Giovanni (I, 6-7): «Venne un uomo mandato da Dio», e «venne come testimone per rendere testimonianza alla luce». E ha festeggiato quell’uomo, che cambiò la storia dell’Occidente, e nacque il giorno di Natale: ma non dell’anno 0, bensì del 1642. Quell’uomo aveva un nome biblico, ma non si chiamava Giovanni o Gesù: bensì, Isacco, o meglio, Isaac.
In realtà, quell’uomo nacque il giorno di Natale solo in Inghilterra, dove la riforma del calendario non era ancora stata adottata: nel resto d’Europa, si era ormai già al 4 gennaio 1643. Ciò nonostante, in Inghilterra il 25 dicembre continua a esser chiamato non solo Christmas, ma anche Newtonmas.
Perché è appunto di Newton che stiamo parlando: un uomo che “rese testimonianza alla luce” in un libro chiamato Ottica, nel quale spiegò al mondo che la luce bianca in realtà è un miscuglio di luci colorate, nelle quali si può decomporre facendola passare attraverso un prisma, e che si possono ricomporre facendole ripassare attraverso un prisma invertito. Solo la mela che ispirò allo stesso Newton la legge di gravitazione universale può competere con il suo prisma nell’immaginario scientifico collettivo, come simbolo del colpo di genio in grado di cambiare la storia del pensiero e dell’uomo.
È per questo che, quando Newton morì, Alexander Pope compose un epitaffio che paragonava la sua nascita non solo a quella di Cristo, ma addirittura alla creazione del mondo: «God said: Let Newton be, and all was light», ossia “Dio disse: Sia fatto Newton, e la luce fu”. Ed è per questo che il 25 dicembre molti si sono augurati, invece che un religioso Merry Christmas, un laico “Merry Newtonmas”!
- ONU: 2015, ANNO DELLA LUCE. Ai poeti ‘lunatici’ e ai filosofi ‘solari’: "l’abitudine non può rendere insipida la varietà infinita della bellezza" - prodotta dalla luce
-
>NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- Newton & Co. geni bastardi. Andrea Frova e Mariapiera Marenzana, ricostruiscono le vicende della Royal Society nel corso del Seicento27 aprile 2015, di Federico La Sala
Che baruffe tra scienziati
Newton contro Hooke, l’aspra rivalità che accelerò il progresso del sapere
Andrea Frova e Mariapiera Marenzana, in un saggio pubblicato da Carocci, ricostruiscono le vicende della Royal Society inglese nel corso del Seicento
Un’autentica rivoluzione avanzò fra gelosie, ripicche ed esperimenti crudeli
di Paolo Mieli (Corriere della Sera, 27.04.2015)
Un’epidemia di peste (1665), un incendio che devastò Londra (1666) e una serie pressoché infinita di imprevedibili dissapori, di assai meschine calunnie, di rivalità tra geni condotte all’esasperazione, furono il contesto in cui nacque la modernità scientifica. Bubboni e fiamme, assieme ai benefici effetti della rivoluzione cromwelliana, conclusasi all’inizio degli anni Sessanta del Seicento, diedero una formidabile spinta alla ricostruzione del Paese. Il clima di selvaggia competizione all’interno della Royal Society fece il resto.
La Royal Society fu fondata nel 1660 e l’anno successivo fu riconosciuta dal sovrano d’Inghilterra Carlo II, che era tornato dall’Olanda per prendere il posto di Carlo I Stuart, il «re martire» giustiziato da Cromwell nel 1649. Grazie a questa Società e alla nascita delle prime riviste scientifiche, gli scienziati dell’epoca iniziarono a interagire tra loro in modo strutturato. Ed è a questo particolarissimo frangente storico che è dedicato lo straordinario libro di Andrea Frova e Mariapiera Marenzana Newton & Co. geni bastardi (con una brillante prefazione di Piergiorgio Odifreddi), in uscita domani per Carocci. Galileo Galilei, ricordano gli autori, era morto nel 1642, lo stesso anno in cui era nato Newton: «Una sorta di epocale passaggio di testimone nel campo della scienza». Il «magnifico circolo dei devoti discepoli di Galileo» - i vari Cavalieri, Torricelli, Castelli, Viviani e altri - aveva dato un apporto fondamentale alla diffusione in Europa del metodo scientifico «fertile di sviluppi e conquiste». Ma poi la scienza in Italia andò declinando. Perché? Le condizioni della penisola, «percorsa e devastata da eserciti stranieri, politicamente divisa» assieme all’«abiura di Galileo e alla presenza minacciosa dell’Inquisizione», la «mancanza di interesse per la scienza da parte dei vari sovrani più disposti a finanziare artisti e poeti di corte, la progressiva perdita di influenza delle potenze marinare Genova e Venezia (che avrebbero potuto costituire stimoli all’avanzamento scientifico e tecnologico)» furono, secondo i due storici, i principali fattori «che contribuirono a un ripiegamento provinciale su se stesso del Paese, incapace di tenere il passo con quanto accadeva nel resto d’Europa, in Francia, in Olanda e più ancora in Inghilterra».
Qui viene naturale un’obiezione: anche in Inghilterra la situazione politica nel XVII secolo era tesissima, le contese religiose erano più che infuocate, drammatici furono gli eventi bellici e politici, più che precaria la situazione economica... Perché allora questo boom della scienza ai tempi di Carlo II? Il fatto è, mettono in rilievo Frova e Marenzana, che «il regno, pur con molte difficoltà, riuscì a superare le crisi e ad acquistare stabilità». E senso di sé. L’espansione coloniale, inoltre, portò ricchezze e conoscenze, stimoli per la scienza e per le sue applicazioni pratiche, che favorirono l’interesse e l’appoggio dei governanti. Isaac Newton, Robert Hooke e gli altri membri della Royal Society si trovarono a vivere questo particolare e stimolante momento storico e, in concorrenza con la Francia, «assicurarono all’Inghilterra il primato di grandi invenzioni e scoperte». Tutto ciò «malgrado la frequente mancanza di rispetto delle regole fondamentali della ricerca scientifica, ossia cooperazione e correttezza». Si svilupparono così tra quegli scienziati «scontri violenti nati da invidie e rivalità, da questioni di priorità e prestigio, ma anche da ambizioni di carriera e di guadagno». Nonché «dal sopravvivere, persino in geni della statura di Newton e Robert Boyle, di atteggiamenti di pensiero e di pratiche prescientifiche, alchemiche, causa ulteriore di fratture, reticenze e sospetti». Al punto che i due autori si domandano se «non fu piuttosto proprio questa competitività esasperata che valse a stimolare le menti e ad acuire l’inventiva e l’impegno».
Subito dopo la conclusione della guerra civile, John Wilkins - «un carismatico intellettuale e uomo di Chiesa, che era passato con successo dalla funzione di cappellano nella casa reale a quella di influente accademico durante il periodo repubblicano di Cromwell» - aveva raccolto attorno a sé un gruppo di persone che veniva chiamato Oxford Esperimental Philosophy Group, di cui facevano parte «studiosi di varia provenienza, senza distinzioni politiche o ideologiche». All’epoca della rivoluzione, Wilkins seppe usare la sua influenza per dare una moderna impronta scientifica e matematica alla vita intellettuale dell’Università di Oxford. Fu lui, in seguito, che assieme ad altri undici studiosi del suo circolo, tra cui Christopher Wren e Robert Boyle, diede vita alla Royal Society, il cui motto poteva essere sintetizzato nelle parole di un loro lontano ispiratore, Francis Bacon (1561-1626), padre dell’empirismo scientifico: «Dio ci vieta di proporre una fantasia nata dalla nostra immaginazione come una descrizione del mondo».
Il principio ispiratore della Royal Society era che alle informazioni dovesse essere garantita la massima circolazione. La comunicazione doveva prendere il sopravvento e la segretezza avrebbe dovuto essere bandita. La comunicazione, poi, doveva «liberarsi dalla vuota eloquenza che aveva caratterizzato i filosofi del passato: via ogni artificio verbale, via ogni forma di retorica». Concretezza e semplicità avrebbero dovuto dettare legge e quando fosse stato possibile si doveva ricorrere al linguaggio della matematica. Il motto della Royal Society, Nullius in Verba , ossia «sulla parola di nessuno», stava a sottolineare «la determinazione dei fondatori di stabilire i fatti secondo il metodo sperimentale, ossia alla maniera di Galileo, e di procedere nell’indagine scientifica in modo oggettivo, ignorando l’influenza della tradizione scolastica, della politica e anche della religione, benché diversi tra i membri fossero alti prelati».
La Royal Society non produsse solo grandi scoperte. La sperimentazione ebbe anche un volto che i due autori non esitano a definire «criminale». Hooke, ad esempio, fece esperimenti d’ogni tipo, «talvolta di dubbio valore scientifico - come nel caso di alcune crudeli dimostrazioni su animali, che peraltro eseguiva controvoglia - per soddisfare la curiosità dei soci scientificamente meno competenti e motivati». Una volta «dovette aprire la cassa toracica di un cane per vedere quanto sarebbe sopravvissuto grazie al semplice pompaggio di aria nei polmoni (in certo senso il primo tentativo di respirazione artificiale), ma fu così disturbato dalla vicenda che in seguito si rifiutò di ripetere un tale esperimento». Hooke si rifiutò poi di partecipare all’«esperimento Coga»: uno studente molto povero, Arthur Coga, accettò il 26 novembre 1667, per il compenso di una ghinea, che il medico Richard Lower e altri membri della Società - su suggerimento del vescovo di Salisbury - gli iniettassero sangue di pecora. Il paziente «non parve mostrare alcuna conseguenza negativa, e lo stesso accadde alla ripetizione dell’esperimento, tre settimane più tardi, di fronte a un diverso pubblico non meno eccitato del precedente». La notizia si sparse per tutta l’Europa, e la sperimentazione fu ripetuta più e più volte: «spesso, però, con esiti fatali». Il che, scrivono gli autori, «getta qualche ombra sulla veridicità del resoconto ufficiale in merito al caso Coga, conservato nei registri della Royal Society».
Qualcosa di esemplare ebbe luogo nel dicembre di quello stesso 1667 a Parigi, nel palazzo del «nobile e ricchissimo» Henry-Louis Habert de Montmor, che aveva fondato una libera accademia scientifica che portava il suo nome (tra i membri figuravano Pierre Gassendi, Marin Mersenne, Christiaan Huygens). In quel palazzo, il medico Jean-Baptiste Denis e il barbiere chirurgo Paul Emmerez procedettero alla trasfusione del sangue di un vitello ad un clochard mentalmente instabile, Antoine Mauroy. Denis sosteneva che tale operazione «avrebbe permesso di rendere l’uomo placido quanto un vitello». Una folla di «medici, chirurghi e altri osservatori, per lo più aristocratici», assistette all’evento. Che fu ripetuto, due giorni dopo, visto il «buon esito» della prima esperienza. Quattro mesi più tardi Mauroy morì e Denis fu sottoposto a processo per omicidio. Processo che si concluse con un’assoluzione, perché Denis riuscì a «dimostrare» che Mauroy era stato avvelenato con l’arsenico dalla moglie. Ma lo stesso Denis non dovette essere del tutto convinto dalle sue argomentazioni difensive e abbandonò la pratica medica. E anche gli altri scienziati si persuasero che quel genere di trasfusione non fosse proficua. Tant’è che fu messa al bando dapprima in Francia (1670), poi in Gran Bretagna e successivamente in quasi tutti gli altri Paesi europei. Solo nel 1829, l’ostetrico inglese James Blundell dimostrò l’efficacia della trasfusione tra esseri umani, ma erano trascorsi 160 anni. È interessante notare, poi, come alla base dei divieti alla fine del Seicento non era tanto «la pietà per le vittime, quanto il timore che la mescolanza di sangue di specie diverse potesse minare la purezza del genere umano e condurre alla creazione di esseri abnormi». In un’era in cui, scrivono Frova e Marenzana, «i confini tra scienza, magia e superstizione non erano ancora ben definiti, ci si chiedeva se per caso gli uomini non avrebbero cominciato a muggire, o magari i vitelli a parlare».
Ma non fu su questo che si litigò all’interno della Royal Society. Furono semmai differenze di carattere e di comportamento. Newton fu quasi un asceta (Voltaire nel 1773 scrisse che non aveva mai «avvicinato» una donna). Hooke invece, assieme a Christopher Wren e Edmond Halley, era un gran frequentatore di coffee houses , seduceva abitualmente le domestiche, nonché la figlia di suo fratello, la nipote Grace, con la quale convisse fino alla prematura morte di lei nel 1684. Newton e Hooke, secondo i due autori, «non avrebbero mai potuto andare d’accordo, né cercare di comporre le loro controversie in maniera civile e utile alla scienza oltre che a sé stessi».
L’avversione di Newton nei confronti del più anziano collega «crebbe nel tempo a tal punto che, divenuto nel 1703 presidente della Royal Society - carica cui giunse, secondo alcuni, brigando in varie maniere - egli pose il massimo impegno nel far sparire ogni traccia di Hooke, morto quello stesso anno». Compresi i ritratti, tant’è che oggi «nessuno è in grado di dire con sicurezza quali fossero le fattezze di Hooke». E non furono, i loro, dissidi dettati solo da divergenze, per così dire, d’ordine morale. Newton scrisse a Halley per denunciare Hooke: «È accettabile che un uomo che pensa di saperla lunga e ama dimostrarlo correggendo e istruendo il suo prossimo, venga da voi quando siete impegnato, e, nonostante le vostre scuse, vi assilli con discorsi e vi corregga attraverso i suoi stessi errori, e dopo discorsi e ancora discorsi si vanti di avervi insegnato tutto ciò di cui vi ha parlato e vi obblighi a dargliene riconoscimento, gridando all’offesa e all’ingiustizia se non lo fate? Penso che lo giudichereste una persona afflitta da uno strano temperamento asociale». Oggi, scrivono i due autori, è evidente che Newton e Hooke «pur nella loro diversità avevano entrambi caratteri difficili e, per dirla secondo l’uso inglese che si fa di questo vocabolo nel mondo della competizione professionale, anche scientifica, erano entrambi dei bastard di discreto calibro».
Nel caso di Hooke, «la mancanza di riconoscimento del suo contributo alla teoria della gravitazione universale da parte di Newton, in aggiunta al fatto che nessuno dei suoi amici, neppure Wren, parlò mai pubblicamente in sua difesa, danneggiò la sua reputazione, lo fece sentire vittima di ingiustizia e di tradimento e avrebbe concorso a rendere assai amara la parte finale della sua vita». Hooke e Newton non si riappacificarono mai, anzi Newton tenne al minimo la sua frequentazione della Royal Society fino a quando Hooke fu in vita. Solo alla sua morte, nel 1703, accettò di divenirne presidente. Anzi, sottolineano i due autori, «brigò alquanto per insediarsi in tale ragguardevole posizione, dalla quale ebbe modo di controllare e condizionare pesantemente la scienza del suo Paese».
Nel 1693 Newton aveva subìto un crollo psicofisico che lo condusse sulle soglie della follia. Ne scrisse lui stesso all’amico Samuel Pepys: «Sono estremamente turbato dallo stato di confusione in cui mi trovo, non ho né mangiato né dormito bene in questi ultimi dodici mesi, e non ho più la mia solidità mentale... Mi rendo conto di dover interrompere il nostro rapporto e di non dover più vedere né voi né gli altri miei amici, ma, se posso, di doverli lasciar andare tranquillamente per la loro strada». Poi ne inviò un’altra ancor più sorprendente a John Locke: «Essendo stato del parere che voi cercavate di confondermi con donne e con altri mezzi, ero così sconvolto che quando mi fu detto che eravate ammalato e non sareste vissuto, risposi che era meglio se voi foste morto... Desidero che mi perdoniate per questa mia mancanza di carità». Newton si scusava altresì con Locke «per aver detto o pensato» che fosse al centro di una macchinazione per confondergli le idee. Poi nei decenni successivi la comunità scientifica dovette assistere a una sua simile polemica con Leibniz. Certo, «per noi oggi», scrivono Frova e Marenzana, «è fin troppo facile stupirci di fronte a molte pagine di Newton che appaiono deliranti, e tuttavia una conoscenza del contesto in cui egli ha operato aiuta a capire come una mente tanto sublime potesse subire il fascino di saperi antichi e prescientifici». E, conseguentemente, abbandonarsi ai deliri di cui si è detto.
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA --- Perché vale la pena farsi un viaggio nello spazio con Interstellar (di Patrizia Caraveo)8 dicembre 2014, di Federico La Sala
Perché vale la pena farsi un viaggio nello spazio con Interstellar
di Patrizia Caraveo *
Uniamo le previsioni più fosche circa il futuro del nostro pianeta con la maestria di un grande fisico nel gestire la relatività generale, aggiungiamo effetti speciali a piacere ed abbiamo tutti gli ingredienti alla base del successo (annunciato) di Interstellar. Un film non banale da vedere, decisamente lungo e impegnativo, alla fine del quale si è provati. Non per niente al botteghino USA, nel primo week-end di programmazione, è stato battuto da Big Hero 6, la storia di un robot gonfiabile nella tradizione dell’animazione Disney. Intendiamoci, è stata tutt’altro che una disfatta: tra IMAX e cinema normali Interstellar ha incassato 53 milioni di dollari, circa un terzo del costo di produzione, che verrà sicuramente ripagato in queste prime settimane di programmazione.
Il regista è una garanzia per i finanziatori, i sette precedenti film di Christopher Nolan hanno fatta registrare un vertiginoso totale di incassi di oltre 3 miliardi e mezzo di dollari. Oltre ad essere la storia di un padre che cerca di salvare l’umanità per amore dei suoi figli, Interstellar vuole essere un film di fantascienza con una solida base scientifica, forse un po’ immaginifica, ma sempre tendenzialmente corretta, basata su effetti della relatività generale come il ripiegamento dello spazio e la dilatazione del tempo.
Tutto parte dalla constatazione che le risorse della terra si stanno esaurendo, qualcosa che ci suona vagamente familiare, visto gli ultimi preoccupanti dati sul riscaldamento globale. Quello che rimane dell’umanità è costretto ad occuparsi a tempo pieno della coltivazione del granoturco, l’unica pianta capace di resistere alle malattie che hanno sterminato tutte le altre coltivazioni. Come se non bastasse la dieta così monotona, il mondo è devastato da terribili tempeste di polvere, che ricordano le descrizioni della dust bowl della grande depressione.
- E’ un mondo senza fiducia nella scienza, che viene fatta in segreto allo scopo di cercare un nuovo pianeta che dia al genere umano la possibilità di sopravvivere alla catastrofe ambientale
Il nostro eroe è un pilota della ex NASA, diventato per necessità coltivatore diretto, in una fattoria che produce un mais stentato, fatto crescere apposta in Canada, in un setting bellissimo ma dalle condizioni non ottimali. Una misteriosa presenza, che si scoprirà dopo essere un’onda gravitazionale, gli dà la sveglia. Così non si può andare avanti, bisogna unirsi agli scienziati che lavorano in segreto e andare alla ricerca di un altro pianeta. Dal momento che il sistema solare non ha nulla da offrire, bisogna andare più lontano, verso altre stelle.
- La scelta è vasta: sappiamo che ogni stella della nostra galassia ha almeno un pianeta e, con 100 miliardi di stelle, i pianeti non sono certo una merce rara
Anche se non tutti sono abitabili, cioè offrono le condizioni perché l’acqua rimanga liquida. Peccato che, con la propulsione attualmente disponibile, anche per arrivare alla più vicina stella ci vorrebbero migliaia di anni. Per accorciare la distanza, o meglio i tempi di percorrenza, ci vuole un aiutino. E quello lo fornisce Kip Thorne fisico teorico del Caltech, famoso per i suoi studi di quello che succede nei dintorni di un buco nero. La passione per la relatività generale lo ha accompagnato in tutta la sua brillante carriera. Così a 74 anni non esita a riempire lavagnate di equazioni che nel film diventano realtà per permettere agli intrepidi esploratori di saltare dal sistema solare ad altri mondi. Kip Thorne dice che il rendering degli effetti di distorsione della luce nelle vicinanze di un buco nero sono i migliori mai fatti e gli hanno permesso di notare effetti ai quali non aveva mai pensato.
Non ne dubito, anche se ne avevo visti di bellissimi in “Black Hole the other side of infinity” di Tom Lucas. Lì i buchi neri stanno nel centro della galassie, dove è normale che stiano, non nel giardino dietro casa nostra, come succede in Interstellar. Il traghetto cosmico è un wormhole nei dintorni di Saturno, una singolarità spazio-temporale che avrebbe non poco effetto di disturbo sui poveri pianeti del nostro sistema solare. Non ce ne preoccupiamo perché è li che le astronavi si tuffano alla ricerca di altri mondi più ospitali della sgangherata terra. Le astronavi sono bellissime: l’ammiraglia Endurance (nella foto in alto, come la nave della disastrosa spedizione Transantartica di Ernest Henry Shackleton) è una gigantesca ruota come quella di 2001 Odissea nello spazio. Poi ci sono due astronavi di servizio per le ricognizioni, chiamate Ranger e Lander e che - una volta confezionate - sono state impaccate in un container e spedite in Islanda dove è stato allestito il set extraterrestre. Da un lato la desolazione del ghiacciaio Vatnajofull coperto da cenere vulcanica, dall’altro lato la laguna Brunasandur che illude gli esploratori con la sua aria accogliente, fino a quando non viene spazzata da un’onda terrificante.
Mentre i nostri sono a spasso chissà dove - e vivono in un tempo dilatato grazie alla relatività generale - sulla terra il tempo passa come al solito e le condizioni peggiorano. L’eroe cerca la figlia e trova una vecchia. In più si scopre che l’onda gravitazionale che l’aveva guidato è la stessa che aveva generato lui al passaggio del wormhole.
- Spazio che si piega, tempo che si dilata, onde gravitazionali come messaggeri da un futuro lontano: ecco perché la visione di Interstellar è un’esperienza impegnativa
Con un costo medio di un milione di dollari al minuto, meglio mettersi comodi e cercare di non perdersi niente. Chissà cosa avrebbe detto di tutto questo diluvio di relatività generale l’antico professore di Kip Thorne, il mitico John Archibald Wheeler, meglio noto come Gravity Joe. Per gli studenti di fisica Wheeler significa un tomo di 1000 pagine dal titolo che non ammette compromessi “Gravitation”, uno scoglio durissimo da superare. Tutto avrebbe potuto immaginare il grande Wheeler, tranne che vedere le sue equazioni diventare il set di un film dal quale i produttori si aspettano incassi stellari.
Chi ha detto che con le equazioni non si mangia?
ROMA, 8 DICEMBRE 2014
*
("Che Futuro", 8 dicembre 2014 (ripresa parziale - senza immagini).)
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- «Si cerca attraverso l’ignoranza». Lo scienziato a caccia della Verità. Colloquio con Carlo Rovelli1 gennaio 2015, di Federico La Sala
Colloquio con Carlo Rovelli
Lo scienziato a caccia della Verità
«Si cerca attraverso l’ignoranza»
 Ho passato la vita a studiare la gravità quantistica temendo che non sarebbe mai servita a nulla
Ho passato la vita a studiare la gravità quantistica temendo che non sarebbe mai servita a nulla
 Poi arriva questo film, Interstellar, dove la gravità quantistica salva il mondo. Fantastico
Poi arriva questo film, Interstellar, dove la gravità quantistica salva il mondo. Fantastico
di Paolo Giordano (Corriere della Sera, 31.12.2014)
All’università, il poderoso volume di Carlo Rovelli sulla «gravità quantistica» circolava surrettiziamente fra gli studenti di fisica teorica, quasi si trattasse di un testo eversivo. Non vi era alcun corso, neppure fra quelli specialistici, che affrontasse la fisica moderna dalla sua prospettiva, perciò il nome di Rovelli suonava alle nostre orecchie come quello di un eremita, isolato chissà dove fra le sue idee troppo audaci.
In realtà, non era così lontano: si trovava appena al di là dell’arco alpino, a Marsiglia (dove lavorava già presso il Centre de Physique Théorique), e si sarebbe presto fatto conoscere fuori dalla cerchia ristretta della fisica teorica, grazie agli articoli sui quotidiani e a saggi come La realtà non è come ci appare (Raffaello Cortina) o Sette brevi lezioni di fisica (Adelphi). Per il suo dono, assai raro, di attraversare indenne la selva oscura della complessità e di uscirne con un racconto semplice, adatto ai più, Rovelli è destinato ad aggiungersi ai pochi punti di riferimento italiani nella comunicazione scientifica. Quando, a luglio, gli consegnai il premio Merck Serono - premio che illumina talenti nel corridoio stretto fra scienza e lettere - ebbi l’impressione che avesse chiara la sua missione in questo senso, che ci fosse, nascosta in lui, una ferita aperta fra la fisica più estrema e il sapere inteso come corpo unico, una ferita che con quel premio, simbolicamente, si rimarginava.
C’è in tutto ciò che scrivi, mi pare, questa ambizione sottostante a voler ricomporre la frammentazione del sapere. Torni spesso a Lucrezio, e ai greci, che potevano ancora permettersi una visione unitaria della conoscenza. Scegli Anassimandro come modello di scienziato. Abbiamo perso qualcosa di importante?
«Abbiamo trovato, più che perso. Abbiamo aggiunto informazioni sulla natura, la musica di Schubert, i pensieri di Kant e Wittgenstein, una letteratura splendida. Non abbiamo perso l’unità del sapere, perché non c’è contraddizione fra le tante facce della cultura contemporanea».
Eppure, il nostro sistema universitario costringe a compiere una scelta drastica fra scienza e cultura umanistica a diciannove anni quando, forse, non si è ancora davvero coscienti delle proprie inclinazioni. Ricordi com’eri all’epoca di quella biforcazione e che cosa ti spinse infine verso la fisica?
«Lo ricordo bene. Un misto di domande sgangherate e confuse, come si hanno a quell’età. Le stesse domande che hanno guidato i miei pensieri nel resto della vita. Credo che si dovrebbe scegliere un mestiere, non quale cultura apprendere. La cultura è una, sfaccettata, inesauribile: è l’insieme degli strumenti che l’umanità ha elaborato per pensare e comprendere il mondo».
Sceglieresti gli stessi studi oggi, o credi che si siano aperti nuovi fronti più eccitanti, come quello delle neuroscienze?
«Leggo tutto ciò che posso sulle neuroscienze, sulle discipline che studiano la coscienza. Stiamo capendo cose nuove e importanti. Ma la bellezza della fisica resta per me ineguagliata. Forse proprio perché ci costringe a smettere di pensare a noi stessi, ci costringe a uscire dalla nostra melma, aprire la finestra, guardare fuori e contemplare la bellezza rarefatta del mondo».
Mi torna alla mente un libro di Saint-Exupéry, «Terra degli uomini», del quale ho scritto pochi giorni fa su queste stesse pagine. Parla di traversate aeree, ma soprattutto di quanto importante sia la «gravità» degli affetti, delle relazioni, ciò che ci dona peso come esseri umani e ci tiene incollati al suolo. Come fisico teorico sentivo spesso venire meno questa forma di gravità, mi sembrava di fluttuare per troppe ore al giorno in uno spazio interstellare, disabitato, e ne avevo paura.
«Io penso che la gravità degli affetti, di ciò che ci rende umani, non venga da un altrove rispetto alla Natura. La Natura è complessa, iridescente, bellissima: costruisce archi di galassie, esplosioni di buchi neri, onde di probabilità, il cielo stellato, il profumo delle viole, i sorrisi della mia ragazza. La fisica non mi fa sentire estraneo al mondo, mi fa sentire profondamente parte del mondo. È come l’alta montagna: uno spazio nudo, spopolato, essenziale. Ma dove ci si sente più a casa nel mondo che lassù?
A proposito di vagare fra gli astri, hai visto Interstellar?
«Ho passato la vita a studiare la gravità quantistica, temendo che non sarebbe mai servita a niente. Poi arriva questo film dove la gravità quantistica salva il mondo. Fantastico. Tra una baggianata e l’altra, il film riesce perfino a spiegare correttamente la differenza di velocità a cui può scorrere il tempo».
La gravità quantistica mi è sempre apparsa come una sorta di «controcultura» della fisica teorica. Il mainstream sono le stringhe, mentre tu hai scelto e difeso un’altra strada per tutta la vita.
«Ogni cultura nasce come controcultura: dal cristianesimo a Mazzini, dagli impressionisti alla gravità quantistica. Le stringhe erano dominanti anni fa, oggi meno. Soprattutto, dopo la mancata scoperta delle particelle supersimmetriche al Cern (la cui esistenza è fondamentale per la coerenza della teoria delle stringhe, ndr ), sono rimasti in pochi a essere sicuri quanto lo erano prima».
La gravità quantistica in una riga?
«Lo spazio vuoto è fatto di granelli indivisibili».
Nel mondo, e anche in Italia, c’è una fame non saziata di conoscenze scientifiche da parte del grande pubblico. Ma i modi di raccontare la scienza sono più o meno sempre gli stessi, non sembrano evolversi alla velocità di altre forme di narrazione.
«A me sembra che siano i romanzi moderni a essere ripetitivi (forse è per questo che, come ultimo romanzo letto e amato, mi cita il Genji Monogatari , datato 1021, ndr ). La divulgazione è invece cambiata moltissimo: il teatro che parla di scienza, i romanzi scientifici, le sperimentazioni su YouTube e sui blog, le iniziative per i bambini. E poi restano i grandi libri di idee, quelli di Hawking, Penrose, Smolin».
E la televisione?
«Ci sarebbe anche la televisione, se la smettesse di fare programmi profondamente antieducativi, come Voyager e simili. In altri Paesi - Inghilterra, Germania, Stati Uniti - ci sono splendide trasmissioni televisive sulla scienza. Piacerebbero anche in Italia».
Al termine di «Sette brevi lezioni» parli di «diffidenza per la scienza di una parte della cultura contemporanea». In Italia è più accentuata che altrove?
«È certamente più accentuata che altrove, sia rispetto ai Paesi ricchi sia rispetto ai Paesi emergenti. Per molti motivi: i residui crociani nella nostra scuola, l’impazzare di Heidegger nei dipartimenti di filosofia, ma soprattutto lo strapotere della Chiesa. Come dice il Vangelo di Matteo, nessuno può servire a due padroni: o la Verità è rivelata, oppure la cerchiamo attraverso la nostra ignoranza, con la limitatezza della nostra ragione».
Lo sai che agli scienziati, ai fisici in particolare, non viene mai risparmiata una domanda sull’esistenza di Dio...
«Sono convintamente ateo. Serenamente ateo».
Lavori fuori dall’Italia da più di vent’anni: Yale, Pittsburgh, Marsiglia. Lasciare il Paese oppure restare è diventato un leit-motiv un po’ irritante, e il modo in cui le generazioni più vecchie guardano alle più giovani e alla loro necessità di andare all’estero sembra solo l’ennesimo atto di commiserazione. Com’è stata la tua vita di nomade?
«Andare in giro per il mondo è bello. Peccato, però, che dall’Italia escano le menti più preziose. Ma arrivano in barca dei giovani dall’Africa: fra loro ce ne sono di sicuro di brillanti, per rimpiazzarle».
Tu che dichiari che «il tempo non esiste», come te la cavi con i passaggi di anno?
«Li vivo come tutti, sentendo il tempo che scivola fra le dita, amando per questo la vita ancora di più: proprio perché breve, è così preziosa».
E nella notte del passaggio?
«Sarò in una casuccia isolata, nel mezzo della natura, insieme alla persona che amo».
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- Onde gravitazionali e viaggi nel tempo, attraverso i buchi neri. Interv. a S. Capozziello (Ansa).13 febbraio 2016, di Federico La Sala
Onde gravitazionali, concepibili i viaggi nel tempo
Attraverso i buchi neri, come quello al centro della Via Lattea *
Viaggiare nello spazio e nel tempo, tuffandosi nei buchi neri e sfrecciando all’interno di un cunicolo spaziotemporale, un wormhole come quelli immaginati nel film Interstellar: sembra fantascienza, ma molto probabilmente tutto questo "diventa concepibile" dopo la scoperta delle onde gravitazionali. "Si apre un mondo per la ricerca. Anzi, si potrebbero aprire più mondi", ha detto Salvatore Capozziello, dell’università Federico II di Napoli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e presidente delle Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione (Sigrav).
"Le onde gravitazionali che adesso siamo in grado di intercettare sono direttamente connesse con la struttura degli oggetti che le emettono, vale a dire - ha spiegato l’esperto - posso desumere da un’onda gravitazionale le caratteristiche dell’oggetto che la emette". Diventa possibile costruire una nuova mappa del cielo: finora avevamo solo quella basata sulla luce visibile, o sui raggi X, o sull’infrarosso, e adesso si può costruire la mappa basata sulle onde gravitazionali.
"E’ appena l’inizio di una lunga storia", ha rilevato Capozziello, perchè una mappa del genere potrebbe essere fatta di una miriade di oggetti che finora sono stati invisibili. Non solo: finora i buchi neri erano solo oggetti teorici previsti dalla teoria della relatività generale; adesso sono oggetti reali. Ne sono state appena visti due, distanti 1,3 miliardi di chilometri, fondersi in un nuovo buco nero. E’ stato ascoltato il loro suono, ne sono state calcolate dimensioni e distanza. Che cosa significa tutto questo, a che cosa potrebbe servire? Sicuramente sono conoscenze senza precedenti e rivoluzionare, ma potrebbe esserci altro".
"Sappiamo - ha detto l’esperto - che i buchi neri sono così densi che non emettono luce e che qualsiasi cosa cada al loro interno non può più uscire". A questo punto bisogna fare i conti con il principio di conservazione dell’energia, per il quale "tutte le grandezze nel buco nero vengono preservate. Vale a dire che tutto ciò che viene ingoiato dal buco nero finisce da un’altra parte a formare un buco bianco".
All’interno del buco nero si forma un cunicolo spaziotemporale, un wormhole. Anche questi oggetti fantascientifici sono previsti dalle equazioni di Einstein, proprio come le onde gravitazionali. Queste ultime aiuteranno a trovarli, per esempio confermando o meno se il buco nero Sagittarius A che si trova al centro della Via Lattea è in realtà un wormhole, come alcuni calcoli indicano.
Viaggiare al loro interno, ha spiegato, potrebbe deformare l’ordine in cui siamo abituati a vivere passato, presente e futuro. "Tutto questo - ha aggiunto - è pura fisica teorica, ma se un domani si riuscisse a vedere un wormhole, significherebbe aver trovato il modo di viaggiare non solo nello spazio, ma nel tempo".
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- "The Newton Papers" di Sarah Dry. I manoscritti mostrano un volto inedito del genio britannico (di Stefano Gattei)5 ottobre 2014, di Federico La Sala
Newton, l’ultimo dei maghi
I manoscritti mostrano un volto inedito del genio britannico
di Stefano Gattei (Corriere della Sera La Lettura, 05.10.2014)
Quando morì, il 20 marzo 1727 (secondo il calendario giuliano, allora vigente in Inghilterra), Isaac Newton non lasciò alcun testamento né eredi diretti. Oltre ai beni, alla biblioteca e a un certo numero di strumenti scientifici, l’inventario stilato dai curatori segnalava un’enorme quantità di fogli manoscritti, difficilmente classificabili. Alcuni contenevano annotazioni scientifiche di vario genere, altri trattavano di alchimia, cronologia, teologia, storia della Chiesa.
John Conduitt, successore di Newton come governatore della Zecca e marito di Catherine Barton, figlia della sorellastra dello scienziato, chiese alla Royal Society di valutare i manoscritti in vista di una loro eventuale pubblicazione. Dopo soli tre giorni di lavoro furono individuati cinque documenti che valeva la pena di dare alle stampe. Il resto, si disse, era stato lasciato in una forma troppo frammentaria, o era comunque inadatto a essere divulgato.
Nel 1740 i manoscritti entrarono in possesso della famiglia Portsmouth, che nel 1872 decise di donarli interamente all’Università di Cambridge, tranne un piccolo numero di testi teologici e cronologici, inviati nel 1755 ad Arthur A. Sykes e successivamente confluiti nella Bodleian Library di Oxford. Venne istituita una commissione, che incaricò due importanti matematici del tempo, John C. Adams e George Stokes, di esaminare gli scritti «scientifici»; a Henry R. Luard, medievista, vennero invece affidati i testi teologici e alchemici. Dopo lunghe indagini, nel 1888 i manoscritti «non scientifici» vennero restituiti alla famiglia, e di essi non si parlò più. Fino al 1936, quando Sotheby’s li mise all’asta a Londra.
I 332 lotti di carte e altri Newtoniana vennero battuti per poco più di novemila sterline, una cifra considerevolmente inferiore a quella cui oggi viene valutato anche un solo foglio manoscritto di Newton. Fra gli acquirenti anche John Maynard Keynes, padre della macroeconomia moderna, che riuscì ad aggiudicarsi 39 lotti. Più tardi, quando provò ad acquistarne altri da alcuni dei partecipanti, scoprì di essere in competizione con un arabista e imprenditore ebreo, Abraham S. Yahuda, particolarmente interessato ai manoscritti teologici.
Keynes riuscì alla fine a entrare in possesso di 130 lotti, Yahuda di 39. Alla morte di Keynes, nel 1946, i manoscritti in suo possesso furono donati a Cambridge; quelli di Yahuda, respinti da Harvard, Yale e Princeton, vennero lasciati allo Stato di Israele, che nel 1969 decise finalmente di destinarli all’Università di Gerusalemme.
C’è un tocco di Borges nell’odissea di questi manoscritti, narrata come un romanzo da Sarah Dry nel suo recente lavoro The Newton Papers (Oxford University Press). Il libro unisce la storia avventurosa dei testi alla descrizione dell’immagine pubblica del grande scienziato, evolutasi di pari passo con la scoperta del «multiforme ingegno» di Sir Isaac.
Migliaia di fogli documentano infatti la lettura, la trascrizione e il commento minuzioso di vari testi alchemici. Le pagine più controverse sono però quelle di carattere teologico. Newton credeva in Dio, ma nel 1667 aveva insistito per farsi esentare, con apposita dispensa regia, dal prendere gli ordini religiosi in seno alla Chiesa anglicana, come veniva richiesto a ogni membro dell’Università di Cambridge; e in punto di morte, alla presenza di due sole persone (che tennero accuratamente nascosta la notizia), rifiutò i sacramenti.
Egli riteneva che nella disputa che aveva segnato la storia della Chiesa durante il IV secolo fosse stata perpetrata, da parte di Atanasio e dei suoi seguaci, una gigantesca frode: il testo sacro sarebbe stato alterato in molti punti allo scopo di affermare la dottrina del Trinitarismo.
Fellow (paradossalmente, viene quasi da dire) del Trinity College, uno dei più prestigiosi dell’Università, Newton si era convinto che la dottrina della Trinità - divenuta dogma, secondo cattolici e anglicani, con il Concilio di Nicea del 325 - fosse stata «inventata» e imposta ai cristiani all’epoca della trionfale vittoria su Ario e sugli «eretici» Ariani.
Adorare Cristo come Dio costituiva, per Newton, una manifestazione di idolatria: mediatore fra l’uomo e Dio, Cristo non è consustanziale al Padre. Se «non si devono ammettere più cause delle cose naturali di quelle che bastano a spiegare i loro fenomeni», come si legge nei Principia , allo stesso modo, per Newton, Dio non va moltiplicato praeter necessitatem.
In alchimia o teologia, come in meccanica e astronomia, Newton non si accontenta del linguaggio metaforico o allusivo comune a tanti autori del tempo, ma conduce un’indagine di carattere quantitativo, esigendo sempre un linguaggio rigoroso, un’argomentazione stringente.
Il teologo e il matematico sono in Newton due facce della medesima medaglia: forse, come piaceva pensare a Maurizio Mamiani (che per primo, nel 1994, pubblicò il Trattato sull’Apocalisse , tratto dai manoscritti di Yahuda), lo studio dei «principi matematici della filosofia naturale» è stato solo l’esercitazione scientifica di un gigante della teologia.
Poco prima di morire, Keynes scrisse che «Newton non fu il primo rappresentante dell’Illuminismo. Fu l’ultimo dei maghi, l’ultimo dei Babilonesi e dei Sumeri, l’ultima grande mente che guardò al mondo con gli stessi occhi con cui lo avevano guardato coloro che migliaia di anni prima avevano gettato le fondamenta del nostro patrimonio culturale».
Alla luce dei manoscritti, che vengono a poco a poco resi disponibili online sul sito del Newton Project, riportare tutte le affermazioni dell’autore dei Principia entro un contesto «scientifico», così come lo intendiamo ora, costituisce senza dubbio un tradimento della sua eredità intellettuale. Ciò non vuol dire sminuirne il genio, anzi. Come osservò ancora Keynes, «credo che Newton fosse diverso dal quadro che convenzionalmente è stato dipinto di lui. Ma non penso, per questo, che egli fosse meno grande».
-
> 2060: APOCALISSE. --- La sapienza antica di Newton. Con il medesimo rigore con cui scoprì la gravitazione universale e il calcolo infinitesimale si applicò alla teologia e alla «prisca sapientia» (di Franco Giudice)19 gennaio 2014, di Federico La Sala
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!
 RILEGGERE VICO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
RILEGGERE VICO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
La sapienza antica di NewtonCon il medesimo rigore con cui scoprì la gravitazione universale e il calcolo infinitesimale si applicò alla teologia e alla «prisca sapientia»
Voleva dimostrare che la civiltà ebraica è più antica di quella egizia
di Franco Giudice (Il Sole 24 Ore/Domenica, 19.01.2014)
- Jed Z. Buchwald-Mordechai Feingold, Newton and the Origin of Civilization, Princeton University Press, Princeton, pagg. 528, $ 49,50
A un osservatore sagace come Voltaire non era di certo sfuggita l’ostentata devozione con cui gli inglesi avevano dato l’ultimo saluto a Isaac Newton, «la gloria della nazione britannica», come lo definì una gazzetta nell’annunciarne la morte il 20 marzo 1727.
Nell’abbazia di Westminster, dove otto giorni dopo furono celebrati i funerali, il philosophe vide sfilare davanti ai suoi occhi il Lord Cancelliere, due duchi e tre conti che reggevano il feretro, con al seguito un lungo corteo che, oltre ai familiari, comprendeva numerose personalità di alto rango.
Un funerale di stato in piena regola, che si concluse con la sepoltura di Newton in «una posizione eminente» della navata centrale, alla stregua «di un re che avesse fatto del bene ai suoi sudditi», come con un po’ di sarcasmo annotò Voltaire.
Ovviamente, quei funerali così solenni rendevano omaggio all’uomo pubblico che nella sua carriera aveva ricoperto cariche prestigiose, al Newton cioè consigliere di fiducia del governo, direttore della Zecca, presidente della Royal Society e insignito del titolo di cavaliere dalla regina d’Inghilterra. Ma a essere celebrato era soprattutto il Newton scienziato, l’autore di capolavori come i Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) e l’Opticks (1704), destinati a segnare per sempre la storia della scienza.
Nessuno o quasi sapeva che l’uomo seppellito con tutti gli onori a Westminster sul letto di morte avesse rifiutato i sacramenti della Chiesa anglicana, di cui deplorava il trinitarismo, che giudicava una forma di idolatria. Ed erano davvero in pochissimi a sospettare che Newton avesse dedicato un tempo incomparabilmente maggiore all’esegesi biblica, all’alchimia e alla cronologia universale che non a tutte le altre discipline da noi oggi considerate, in senso proprio, scientifiche.
Ma nel 1728, la pubblicazione postuma della sua Chronology of Ancient Kingdoms Amended (La cronologia degli antichi regni emendata) avrebbe fornito ai contemporanei un primo saggio di questi interessi, e scatenato subito un grande dibattito. Attraverso un estenuante sfoggio di fonti antiche, non privo di ardite speculazioni filologiche, Newton presentava infatti una drastica revisione della cronologia tradizionale, contraendo la storia greca di cinquecento anni e quella egizia di un millennio.
Sulle vere ragioni però che lo avevano spinto a una simile impresa il silenzio era pressoché assoluto. Ed è proprio su di esse che getta nuova luce il magistrale lavoro di Jed Buchwald e Mordechai Feingold, che ricostruisce il coinvolgimento di Newton nello studio della cronologia.
Newton iniziò a occuparsi di cronologia intorno al 1700, al culmine di approfondite indagini storiche che lo vedevano ormai impegnato da parecchio tempo. Aveva passato al setaccio una quantità enorme di fonti classiche, tra cui Erodoto, Clemente di Alessandria, Diodoro Siculo, Eusebio di Cesarea, insieme ad altri Padri della Chiesa e alle Sacre Scritture. Ma non si trattava di erudizione fine a se stessa.
Quelle letture, come mostrano Buchwald e Feingold, scaturivano da esigenze teologiche ben precise: ripristinare nientemeno l’originaria e vera religione, per capire come e perché si fosse corrotta. E in questo contesto risultava fondamentale spiegare le discrepanze tra la cronologia degli storici pagani e quella dell’Antico Testamento, l’unica che Newton considerasse attendibile.
Dopo lunghi anni di ricerche bibliche, Newton si era convinto che l’originaria religione monoteistica, quella cioè che Dio aveva insegnato ad Adamo ed Eva, fosse stata ripetutamente corrotta in una forma di adorazione di falsi déi. Restaurato da Noè, l’autentico culto di Dio fu di nuovo ristabilito da Mosè e poi da Gesù, cadendo però, a causa del trinitarismo introdotto dalla Chiesa cattolica, ancora una volta nell’idolatria. Newton credeva inoltre che le verità ricevute dagli ebrei non riguardassero soltanto il culto originario di Dio, ma anche l’universo che Egli aveva creato. A Noè e alla sua progenie Dio aveva infatti rivelato che la struttura del mondo è eliocentrica; una sapienza antica che si era smarrita con il sorgere di false religioni, a tutto vantaggio dell’erronea cosmologia geocentrica.
Fu sulla base di queste convinzioni che Newton scrisse La cronologia degli antichi regni emendata. Intendeva dimostrare che la civiltà ebraica, a dispetto dell’opinione prevalente, veniva senz’altro prima di quella egizia. Erano stati Noè, i suoi figli e nipoti che, dopo il diluvio, avevano portato in Egitto l’antica sapienza ricevuta da Dio, e che dagli egizi era stata poi trasmessa ai greci.
Come era possibile dunque conciliare la storia sacra con quella pagana? Newton non aveva dubbi: occorreva riformare la cronologia tradizionale degli antichi regni e correggerla attenendosi alle solide basi della Bibbia. Un’operazione tutt’altro che semplice poiché, a suo avviso, tutte le nazioni, a eccezione di quella ebraica, per accrescere la loro antichità si erano falsamente attribuite centinaia di anni in più. Ma che Newton intraprese con un metodo originale e complesso, dove per l’interpretazione delle fonti antiche diventava indispensabile l’uso della matematica e dell’astronomia. E che Buchwald e Feingold ci aiutano a seguire fin nei minimi dettagli, rivelandosi delle guide scrupolose ed eccellenti.
Si scopre così che un aspetto importante del metodo di Newton consisteva nel confutare, attraverso rigorosi calcoli matematici, il criterio di datazione degli antichi cronologisti. E che pertanto le loro cronologie dovevano essere significativamente ridimensionate rispetto alle loro pretese lunghezze. Ma a colpire ancor di più è il modo in cui Newton impiegava gli strumenti dell’astronomia per collocare la spedizione degli Argonauti, dietro il cui mito pensava si nascondesse un evento storico reale, 45 anni dopo la morte di Salomone. Un risultato, a suo avviso, della massima rilevanza, poiché gli consentiva di stabilire una nuova datazione della guerra di Troia, la cui distruzione sarebbe dunque avvenuta dopo la costruzione del Tempio di Salomone.
Newton, come ci ricordano Buchwald e Feingold, «lavorò su questi problemi fino a pochi giorni prima di morire», determinato a dare alla sua riforma della cronologia quel "rigore matematico" che tutti gli riconoscevano. Ma altrettanto determinato a occultare che tale riforma fosse strettamente legata al suo schema genealogico dei discendenti di Noè e al suo tentativo di restaurare l’autentica religione monoteistica. Gli esiti di queste ricerche preferì mantenerli segreti, disseminandoli in una massa impressionante di manoscritti.
La ragione era quanto mai comprensibile: la negazione della Trinità, nell’Inghilterra dell’epoca, costituiva un reato perseguibile per legge. E Newton lo sapeva molto bene: nel 1710, il suo discepolo William Whiston, che aveva scelto come suo successore sulla cattedra di matematica a Cambridge, fu bandito su due piedi dall’università proprio per aver pubblicamente sostenuto l’antitrinitarismo.
Sarebbe tuttavia riduttivo considerare il libro di Buchwald e Feingold come una semplice, per quanto apprezzabile, ricostruzione degli studi cronologici di Newton. Il loro obiettivo è decisamente più ambizioso: dimostrare che il Newton dedito alla teologia, alla cronologia, all’alchimia e alla prisca sapientia non avesse niente di diverso dallo scienziato che aveva svelato la natura composita della luce solare, inventato il calcolo infinitesimale ed enunciato la legge di gravitazione universale.
Una tesi, possiamo dire con un po’ di orgoglio, sostenuta già da un grande studioso italiano di Newton scomparso circa dieci anni fa, Maurizio Mamiani, cui dobbiamo la prima edizione mondiale del Trattato sull’Apocalisse (Bollati Boringhieri, 1994), ma che gli autori purtroppo non citano. In ogni caso, Buchwald e Feingold hanno il merito di aver analizzato tutti quei manoscritti che, soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, rappresentano una sfida costante per chiunque si occupi di cose newtoniane, sollevando questioni di estremo rilievo.
Che legame c’è tra gli interessi documentati dai manoscritti e le ricerche di Newton nel campo dell’ottica, della meccanica e della matematica? Il Newton nel suo laboratorio alchemico, alle prese con crogioli e fornaci, era lo stesso che analizzava il passaggio della luce attraverso il prisma o che misurava la caduta dei gravi nei diversi mezzi? Cosa ha a che fare il Newton interprete dell’Apocalisse con l’uomo che scrisse i Principia mathematica? E come è possibile conciliare il Newton immerso nello studio della prisca sapientia con l’autore dell’Opticks?
È a queste domande che cerca di dare risposta l’imponente lavoro di Buchwald e Feingold, che documenta come l’approccio di Newton ai diversi campi del sapere si basasse su un "metodo unico", dove a contare erano sempre i numeri e i dati empirici, fossero essi i fenomeni osservativi piuttosto che le Sacre Scritture o le testimonianze dei classici. Un Newton insomma tutto d’un pezzo, destinato a far discutere gli specialisti, ma che rappresenta indubbiamente uno dei contributi più innovativi degli ultimi anni nella prolifica Newtonian industry.
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- Merry Christmas, “Merry Newtonmas”! (di Piergiorgio Odifreddi - Un Natale nel nome di Isacco Newton).29 dicembre 2013, di Federico La Sala
Un Natale nel nome di Isacco (Newton)
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 29.12.2013)
Lo scorso mercoledì una parte del mondo occidentale ha meditato sulle parole del Vangelo secondo Giovanni (I, 6-7): «Venne un uomo mandato da Dio», e «venne come testimone per rendere testimonianza alla luce». E ha festeggiato quell’uomo, che cambiò la storia dell’Occidente, e nacque il giorno di Natale: ma non dell’anno 0, bensì del 1642. Quell’uomo aveva un nome biblico, ma non si chiamava Giovanni o Gesù: bensì, Isacco, o meglio, Isaac.
In realtà, quell’uomo nacque il giorno di Natale solo in Inghilterra, dove la riforma del calendario non era ancora stata adottata: nelresto d’Europa, si era ormai già al 4 gennaio 1643. Ciò nonostante, in Inghilterra il 25 dicembre continua a esser chiamato non solo Christmas, ma anche Newtonmas.
Perché è appunto di Newton che stiamo parlando: un uomo che “rese testimonianza alla luce” in un libro chiamato Ottica, nel quale spiegò al mondo che la luce bianca in realtà è un miscuglio di luci colorate, nelle quali si può decomporre facendola passare attraverso un prisma, e che si possono ricomporre facendole ripassare attraverso un prisma invertito. Solo la mela che ispirò allo stesso Newton la legge di gravitazione universale può competere con il suo prisma nell’immaginario scientifico collettivo, come simbolo del colpo di genio in grado di cambiare la storia del pensiero e dell’uomo.
È per questo che, quando Newton morì, Alexander Pope compose un epitaffio che paragonava la sua nascita non solo a quella di Cristo, ma addirittura alla creazione del mondo: «God said: Let Newton be, and all was light», ossia “Dio disse: Sia fatto Newton, e la luce fu”. Ed è per questo che il 25 dicembre molti si sono augurati, invece che un religioso Merry Christmas, un laico “Merry Newtonmas”!
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- L’altro Newton, alchimista e teologo che si appassionava agli Argonauti (di Stefano Gattei)10 marzo 2013, di Federico La Sala
L’altro Newton, alchimista e teologo che si appassionava agli Argonauti
Nelle opere minori dello scienziato, spesso svalutate dai biografi, ritroviamo lo stesso metodo empirico delle sue grandi scoperte
di Stefano Gattei (Corriere La Lettura, 10.03.2013)
Accanto ai suoi fondamentali lavori di matematica, scienza del moto, ottica e teoria della gravitazione, Isaac Newton (1642-1727) coltivò profondi interessi per l’alchimia, la teologia (abbracciando una qualche forma di eresia antitrinitaria), l’esegesi biblica e la cronologia.
Pubblicati postumi, i suoi scritti su questi temi non mancarono di suscitare critiche accese, in Inghilterra come in Francia, contribuendo a una progressiva erosione dell’immagine del loro autore già nel Settecento. Tanto che nel 1822, nella memoria scritta per la Biographie universelle, Jean-Baptiste Biot - allievo di Laplace, e come lui convinto che ogni riferimento a Dio o alle cause finali non potesse trovare posto nel discorso scientifico - suggerì che l’esaurimento nervoso di cui Newton fu vittima nel 1693, causato da un’applicazione ossessiva alla scienza, avesse lasciato tracce indelebili nella sua mente, ripercuotendosi negativamente sulle opere successive.
Nel 1980, in quella che è tuttora la biografia più completa e accreditata del grande scienziato, Richard Westfall osservava come la Cronologia degli antichi regni (1728), in particolare, fosse un’opera sconclusionata, «di una noia colossale, che dopo aver suscitato per breve tempo l’interesse - e l’opposizione - di un ristretto numero di persone capaci di appassionarsi per la data della spedizione degli Argonauti, cadde nel più totale oblio. È letta oggi da quei pochissimi che, a sconto dei loro peccati, devono passare attraverso quel purgatorio».
Un giudizio duro e autorevole, quello di Westfall, che non poteva non pesare sugli studi successivi. Ma che non ha impedito a due prestigiosi storici della scienza del California Institute of Technology, Jed Buchwald e Mordechai Feingold, di rileggere quelle pagine «minori» alla luce dei molti manoscritti inediti e della corrispondenza di Newton. Il risultato è un contributo originale ed estremamente ricco, che getta nuova luce sulle modalità di indagine e di argomentazione di una delle menti più fertili della storia del pensiero scientifico.
In Newton and the Origin of Civilization (Princeton University Press), Buchwald e Feingold mostrano per la prima volta l’importanza di quelle pagine al fine di comprendere la straordinaria complessità della figura di Newton che, scrivono, «non fu semplicemente portato da questo a occuparsi di quello; piuttosto, il suo modo di lavorare rivela una modalità di pensiero e di azione che è alla base tanto dei suoi sforzi di svelare l’opera di una divinità nella storia, quanto di afferrare i misteri più reconditi dei meccanismi della natura».
Grazie a un’analisi scrupolosa dei testi, i due autori ricostruiscono i passi argomentativi che guidarono Newton alle proprie conclusioni, individuando in una sostanziale continuità metodologica l’elemento caratterizzante della sua riflessione.
In particolare, fu durante i primissimi anni a Cambridge che egli sviluppò le caratteristiche fondamentali del metodo per generare e sviluppare una conoscenza affidabile - un metodo che egli applicò tanto nei Principia mathematica (1687) e nell’Ottica (1704), quanto nei suoi scritti sull’Apocalisse, sulla corruzione di alcuni passi biblici e sulla cronologia.
Ciò non significa che Newton non abbia mai cambiato idea nel corso della sua lunga vita, anzi; ma che l’approccio maturo che egli dimostrò alla natura, alla storia e alla teologia affonda le proprie radici nel suo primo sviluppo intellettuale, fin dagli anni universitari.
Comune denominatore a studi e interessi a prima vista disparati, come la meccanica celeste e l’esegesi biblica, l’analisi matematica e la cronologia, è un modo radicalmente nuovo di comprendere e di accettare (o rifiutare) l’evidenza empirica alla luce di considerazioni di natura teorica. E proprio in questa radicale novità va ricercata la ragione profonda della dura opposizione che le sue opere incontrarono. Con il proprio approccio, infatti, egli poneva con forza un quesito metodologico di fondo: quale tipo di evidenza empirica e di ragionamento teorico governano la comprensione storica e quella teologica?
Le tesi storiche e teologiche che Newton sviluppa, in altre parole, sono profondamente permeate dal suo modo di intendere e di fare scienza, così come la fede nell’azione divina - nella natura o nella storia - non può essere separata dal suo modo di concepire come sia possibile una forma di conoscenza affidabile in entrambi gli ambiti. Come ha osservato Niccolò Guicciardini, il Newton alchimista, storico e teologo non è meno lontano da noi del Newton «tradizionale», matematico e fisico. Da qui il fascino - e la difficoltà - della sua figura.
-
> 2060 --- L’ARCA DELL’ALLEANZA, IL MESSAGGIO EVANGELICO, E L’APOCALISSE (= RIVELAZIONE). GIOACCHINO DA FIORE, DANTE, E LA "GRANDE RUOTA DEL CARRO" DI EZECHIELE.26 novembre 2011, di Federico La Sala
 L’ARCA DELL’ALLEANZA, IL MESSAGGIO EVANGELICO, E L’APOCALISSE (= RIVELAZIONE). Due soli in Terra e il Sole del Giusto Amore (“Karitas seu recta dilectio”) in cielo.
L’ARCA DELL’ALLEANZA, IL MESSAGGIO EVANGELICO, E L’APOCALISSE (= RIVELAZIONE). Due soli in Terra e il Sole del Giusto Amore (“Karitas seu recta dilectio”) in cielo.
 GIOACCHINO DA FIORE, DANTE, E LA "GRANDE RUOTA DEL CARRO" DI EZECHIELE - LA "CHARITAS". Alcune pagine dalla «Concordia Novi ac Veteris Testamenti» e dalla "Monarchia", con note
GIOACCHINO DA FIORE, DANTE, E LA "GRANDE RUOTA DEL CARRO" DI EZECHIELE - LA "CHARITAS". Alcune pagine dalla «Concordia Novi ac Veteris Testamenti» e dalla "Monarchia", con note
-
> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! ---- "Neutrini più veloci della luce". Messo in discussione Einstein22 settembre 2011, di Federico La Sala
FISICA
 "Neutrini più veloci della luce"
"Neutrini più veloci della luce"
 Messo in discussione Einstein
Messo in discussione EinsteinClamorosi risultati di uno studio del Cern e dell’Infn guidato da un fisico italiano: particelle sparate da Ginevra al Gran Sasso hanno infranto il muro considerato invalicabile dalla fisica. Margherita Hack: "Sarebbe una rivoluzione" *
ROMA - I risultati, se confermati, possono rimettere in discussione le regole della fisica cristallizzate dalle teorie di Albert Einstein, secondo le quali niente nell’universo può superare la velocità della luce. Un gruppo di ricercatori del Cern e dell’Infn guidato dall’italiano Antonio Ereditato ha registrato che i neutrini possono viaggiare oltre quel limite. Le particelle hanno coperto i 730 chilometri che separano i laboratori di Ginevra da quelli del Gran Sasso a una velocità più alta di quella della luce.
Il muro è stato infranto di appena 60 nanosecondi. Eppure, il risultato è talmente destabilizzante che il team di ricerca ha atteso ben tre anni di misurazioni per sottoporlo all’attenzione della comunità scientifica. "Siamo abbastanza sicuri dei nostri risultati, ma vogliamo che altri colleghi possano verificarli e confermarli", spiega Ereditato, che lavora presso il laboratorio di fisica delle particelle dell’organizzazione ginevrina.
E le prime reazioni non tardano ad arrivare: secondo il Centre national de la recherche scientifique francese, le fosse confermata la scoperta sarebbe "clamorosa" e "totalmente inattesa" e aprirebbe "prospettive teoriche completamente nuove". Anche per l’astrofisica Margherita Hack si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione perché, osserva, "finora tutte le previsioni della teoria della relatività sono state confermate".
Secondo la teoria della relatività ristretta, elaborata da Einstein nel 1905, la velocità è una costante, tanto da essere parte della celeberrima equazione E=mc², dove E è l’energia, m la massa e c, appunto, la velocità della luce. La relatività, spiega ancora la Hack, "prevede che se un corpo viaggiasse ad una velocità superiore a quella della luce dovrebbe avere una massa infinitamente grande. Per questo la velocità della luce è stata finora considerata un punto di riferimento insuperabile".
Tra l’altro, la teoria della relatività implica l’impossibilità fisica delle traversate interstellari e dei viaggi nel tempo, finora inesorabilmente relegati alla fantascienza e ritenuti irrealizzabili dalla scienza. Ora tutto ciò potrebbe cadere. "Ma io non voglio pensare alle implicazioni", si affretta a precisare Ereditato. "Siamo scienziati e siamo abituati a lavorare con ciò che conosciamo".
La velocità delle particelle è stata misurata dal rivelatore Opera, dell’esperimento Cngs (Cern NeutrinoS to Gran Sasso), nel quale un fascio di neutrini viene lanciato dal Cern di Ginevra e raggiunge i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dell’Istituto nazionale di Fisica Nucleare.
* la Repubblica, 22 settembre 2011
-
> DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!! ---- "Perché il grande disegno non dipende da Dio". La filosofia è morta, solo i fisici spiegano il cosmo (di di Stephen Hawking, Leonard Mlodinow).6 aprile 2011, di Federico La Sala
La filosofia è morta, solo i fisici spiegano il cosmo
I signori della creazione
 Un brano dell’ultimo saggio di Stephen Hawking: "Perché il grande disegno non dipende da Dio"
Per secoli le domande importanti venivano affrontate dai pensatori. Ma oggi la fiaccola della conoscenza è altrove
Un brano dell’ultimo saggio di Stephen Hawking: "Perché il grande disegno non dipende da Dio"
Per secoli le domande importanti venivano affrontate dai pensatori. Ma oggi la fiaccola della conoscenza è altrove
 Spetta alla scienza offrire soluzioni anche se queste vanno contro il senso comune. Come mostra Feynman
Spetta alla scienza offrire soluzioni anche se queste vanno contro il senso comune. Come mostra Feynmandi Stephen Hawking, Leonard Mlodinow (la Repubblica, 06.04.2011) Ciascuno di noi non esiste che per un breve intervallo di tempo, e in tale intervallo esplora soltanto una piccola parte dell’intero universo. Ma la specie umana è una specie curiosa. Ci facciamo domande, cerchiamo delle risposte. Vivendo in questo mondo sconfinato che può essere ora amichevole ora crudele, e volgendo lo sguardo ai cieli immensi che ci sovrastano, gli uomini si sono sempre posti una moltitudine di interrogativi. Come possiamo comprendere il mondo in cui ci troviamo? Come si comporta l’universo? Qual è la natura della realtà? Che origine ha tutto ciò? L’universo ha avuto bisogno di un creatore? La maggior parte di noi non dedica troppo tempo a preoccuparsi di simili questioni, ma quasi tutti di tanto in tanto ci pensiamo.
Per secoli questi interrogativi sono stati di pertinenza della filosofia, ma la filosofia è morta, non avendo tenuto il passo degli sviluppi più recenti della scienza, e in particolare della fisica. Così sono stati gli scienziati a raccogliere la fiaccola nella nostra ricerca della conoscenza.
Questo libro si propone di dare le risposte che sono suggerite dalle scoperte e dai progressi teorici recenti. Tali risposte ci conducono a una nuova concezione dell’universo e del nostro posto in esso, assai diversa da quella tradizionale, e diversa anche da quella che avremmo potuto delineare soltanto un decennio o due fa. Eppure la nuova concezione aveva cominciato a prendere forma embrionale quasi un secolo addietro.
Secondo la concezione tradizionale dell’universo, i corpi si muovono su traiettorie ben determinate e hanno storie definite, cosicché è possibile specificare la loro esatta posizione in ogni istante del tempo. Sebbene tale descrizione sia abbastanza soddisfacente ai fini della vita quotidiana, negli anni ’20 si scoprì che questa immagine "classica" non era in grado di rendere conto del comportamento apparentemente bizzarro osservato sulle scale delle entità atomiche e subatomiche. Era invece necessario adottare un diverso quadro concettuale, chiamato fisica quantistica. Le teorie quantistiche si sono dimostrate straordinariamente precise nel predire gli eventi su tali scale, e al contempo capaci di riprodurre le predizioni delle vecchie teorie classiche quando venivano applicate al mondo macroscopico della vita quotidiana. Eppure la fisica classica e quella quantistica sono basate su concezioni assai diverse della realtà.
Le teorie quantistiche possono essere formulate in molti modi differenti, ma la descrizione probabilmente più intuitiva fu proposta da Richard Feynman (detto Dick), una personalità brillante che lavorava al California Institute of Technology e suonava i bongos in un locale di spogliarelli dei dintorni. Secondo Feynman, un sistema non ha una sola storia, ma ogni storia possibile. Più avanti, nella nostra ricerca delle risposte, spiegheremo nei particolari l’impostazione di Feynman, e ce ne serviremo per analizzare l’idea che l’universo stesso non abbia un’unica storia, e neppure un’esistenza indipendente. Questa sembra un’idea radicale, anche a parecchi fisici. In effetti, come molti concetti della scienza attuale, pare essere in conflitto con il senso comune. Ma il senso comune è basato sull’esperienza di tutti i giorni, non sull’universo quale ci si rivela mediante meraviglie della tecnologia come quelle che ci consentono di spingere lo sguardo fin nel cuore dell’atomo o a ritroso nell’universo primordiale.
Fino all’avvento della fisica moderna era opinione comune che il mondo potesse essere interamente conosciuto tramite l’osservazione diretta, che le cose sono ciò che sembrano, così come vengono percepite mediante i nostri sensi. Viceversa, lo spettacolare successo della fisica moderna, basata su concetti che, come quello di Feynman, sono in contrasto con l’esperienza quotidiana, ha dimostrato che le cose non stanno così. La concezione ingenua della realtà, pertanto, non è compatibile con la fisica moderna. Per affrontare tali paradossi adotteremo un’impostazione che chiameremo realismo dipendente dai modelli. Questa impostazione si basa sull’idea che il nostro cervello interpreti l’informazione proveniente dagli organi sensoriali costruendo un modello del mondo. Quando un simile modello riesce a spiegare gli eventi, tendiamo ad attribuire a esso e agli elementi e ai concetti che lo costituiscono la qualità della realtà o della verità assoluta. Ma possono esserci modi diversi per creare un modello della medesima situazione fisica, e ciascuno di essi potrà utilizzare elementi e concetti fondamentali differenti. (...)
Nel corso della storia della scienza si è scoperta una serie di teorie o modelli sempre migliori, dalla concezione di Platone alla teoria classica di Newton, fino alle moderne teorie quantistiche. È naturale chiedersi: questa sequenza alla fine avrà un punto di arrivo, porterà a una teoria definitiva dell’universo che includa tutte le forze e predica ogni osservazione che è possibile fare, oppure continueremo per sempre a scoprire teorie di efficacia crescente, senza però mai approdare a una che non possa essere ulteriormente migliorata? (...) oggi disponiamo di una candidata al ruolo di teoria ultima del tutto, ammesso che ne esista effettivamente una, e questa candidata è chiamata teoria M.
(...) La teoria M non è una teoria nel senso consueto. È un’intera famiglia di teorie diverse, ciascuna delle quali è una buona descrizione delle osservazioni soltanto entro una certa gamma di situazioni fisiche. È un po’ come accade nel caso delle carte geografiche. Come si sa, non è possibile rappresentare l’intera superficie terrestre in un’unica carta. L’usuale proiezione di Mercatore, utilizzata per i planisferi, fa sembrare sempre più grandi le aree man mano che si va verso nord o verso sud e non copre le regioni dei poli. Per rappresentare fedelmente tutta la Terra si deve ricorrere a una serie di carte geografiche, ciascuna delle quali copre una regione limitata. Le varie carte si sovrappongono parzialmente tra loro, e dove ciò accade mostrano lo stesso paesaggio. La teoria M è in qualche modo analoga.
Le varie teorie che formano questa famiglia possono sembrare molto diverse, ma possono essere considerate tutte come aspetti della medesima teoria fondamentale. Sono versioni della teoria applicabili solo in ambiti limitati: per esempio, quando certe grandezze, come l’energia, sono piccole. Come accade per le carte che si sovrappongono, così dove gli ambiti di validità delle varie versioni si sovrappongono, queste predicono i medesimi fenomeni. Ma proprio come non c’è nessuna carta piana che sia una buona rappresentazione dell’intera superficie terrestre, così non c’è nessuna teoria che da sola sia una buona rappresentazione delle osservazioni in tutte le situazioni.
Vedremo come la teoria M possa offrire soluzioni alla questione della creazione. Secondo questa teoria, il nostro non è l’unico universo. Anzi, la teoria predice che un gran numero di universi sia stato creato dal nulla. La loro creazione non richiede l’intervento di un essere soprannaturale o di un dio, in quanto questi molteplici universi derivano in modo naturale dalla legge fisica: sono una predizione della scienza. Ciascun universo ha molte storie possibili e molti stati possibili in tempi successivi, cioè in tempi come il presente, assai lontani dalla loro creazione.
Gran parte di tali stati saranno radicalmente differenti dall’universo che osserviamo e soltanto pochissimi di essi consentirebbero l’esistenza di creature come noi. Pertanto la nostra presenza seleziona da questo immenso assortimento soltanto quegli universi che sono compatibili con la nostra esistenza. Sebbene siamo minuscoli e insignificanti sulla scala del cosmo, ciò fa di noi in un certo senso i signori della creazione. Per comprendere l’universo al livello più profondo, dobbiamo sapere non soltanto come esso si comporta, ma anche perché. Perché c’è qualcosa invece di nulla? Perché esistiamo? Perché questo particolare insieme di leggi e non qualche altro? Questo è l’interrogativo fondamentale sulla vita, l’universo e il tutto.
 © 2010 by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow Original art copyright © 2010 by Peter Bollinger © 2011 Arnoldo Mondadori Editore S. p. A., Milano
© 2010 by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow Original art copyright © 2010 by Peter Bollinger © 2011 Arnoldo Mondadori Editore S. p. A., Milano
 Per gentile concessione Luigi Bernabò Associates srl
Per gentile concessione Luigi Bernabò Associates srl -
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. ---- L’eretico Newton allargò gli orizzonti del sapere umano. Dalla mela ai colori, un genio infinito (di Stefano Meriggi)30 marzo 2011, di Federico La Sala
L’eretico Newton allargò gli orizzonti del sapere umano
Dalla mela ai colori, un genio infinito
di Stefano Moriggi (Corriere della Sera, 30.03.2011)
«U n francese che giunga a Londra trova molti cambiamenti nella filosofia, come in tutto il resto» . Così avrebbe scritto Voltaire, esiliato in Inghilterra nel 1726. Si sentiva come chi, «lasciato il mondo pieno, lo trova vuoto» . Se infatti a Parigi- notava nelle Lettere filosofiche- «si vede l’Universo costituito da vortici di materia sottile; a Londra non si vede niente di tutto ciò» . Oltremanica una mela del Lincolnshire aveva cambiato tutto. Isaac Newton l’aveva vista staccarsi dal ramo e cadere a terra.
Da quel momento una serie di interrogativi e intuizioni lo avrebbe portato a capire che «la mela attrae la Terra come la Terra attrae la mela» . Questo avrebbe detto un anziano sir Isaac a William Stukeley - l’amico archeologo che così ricorda il loro incontro a Kensington, nel 1725: «Dopo pranzo andammo in giardino a bere il tè all’ombra di alcuni meli. Mi disse che si trovava in una situazione analoga quando, tempo addietro, aveva concepito l’idea della gravitazione» .
Alla formula definitiva, in realtà, sarebbe arrivato un ventennio dopo il leggendario episodio e la rese nota nei Principi matematici della filosofia naturale (1687). Complice anche l’aspra concorrenza con Robert Hooke il quale, negli anni Ottanta, aveva ipotizzato che le orbite ellittiche di Keplero si spiegassero con un’attrazione gravitazionale che diminuisce «in relazione quadrata alla distanza dal centro relativo» .
Era sulla buona strada, ma continuava a sfuggirgli ciò che neppure il ventiquattrenne Newton, al tempo della mela, aveva compreso: ossia, che la gravitazione era una forza di attrazione reciproca, e non solo relativa alla massa dell’oggetto attratto dalla Terra. Ma quando quella mela cascò, Isaac aveva da poco conseguito il baccalaureato al Trinity College di Cambridge. E, in fuga dalla peste- che nell’estate del 1665 già infuriava a Londra - si era rintanato per qualche mese nella casa di famiglia, a Woolsthorpe. Quel periodo lontano dall’accademia sarebbe stato intenso e proficuo. «Ero nel fiore della creatività - ebbe a ricordare Newton - e mi dedicavo alla matematica e alla filosofia più di quanto abbia mai fatto in seguito» .
E infatti, ben prima di succedere (1668) a Isaac Barrow sulla cattedra lucasiana di matematica, aveva già dimostrato il teorema del binomio e sviluppato quel metodo delle flussioni (oggi detto calcolo infinitesimale) - sul quale si sarebbe innescata la polemica con Leibniz per il primato della scoperta. Eppure, la comunità scientifica si sarebbe davvero accorta del suo genio solo nel 1671, quando Newton impressionò i membri della Royal Society con un telescopio a riflessione di sua costruzione.
Nominato membro della prestigiosa istituzione, si convinse così di rendere pubblica la sua Nuova teoria sulla luce e sui colori: la luce solare non è pura e semplice, ma «consiste di raggi che differiscono per gradi indefiniti di rifrangibilità» , ciascuno dei quali è un colore. Quella che lui stesso definì «la più straordinaria, se non la più considerevole, rivelazione che sia stata compiuta finora nelle operazioni della natura» , gli assicurò inimicizie e livori, a partire da quel Robert Hooke che lo avrebbe poi costretto a rimettere mano ai suoi calcoli su mele e corpi celesti. Pur di non concedergli repliche, Newton decise di pubblicare l’Ottica solo dopo la morte del rivale, nel 1704.
Nel frattempo si isolò a Cambridge, dove più che di orbite e corpuscoli luminosi, si sarebbe occupato di alchimia e in segreto di teologia. Era seguace di Ario, e il fatto di negare la Santissima Trinità non sarebbe stato gradito al Trinity College... Negli ultimi vent’anni di vita ricoprì cariche di rilievo: fu presidente della Royal Society, parlamentare e soprattutto, dal 1699, severo direttore della Zecca di Londra. Nel marzo del 1727, anche Voltaire era a Westminster Abbey per rendere omaggio al «grande distruttore del sistema cartesiano» che veniva «seppellito come un re che avesse fatto del bene ai suoi sudditi» .
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. ---- Scoperto il pianeta extrasolare più simile alla Terra. Si chiama Gliese 581g (di Luigi Bignami - Quel pianeta ci somiglia: "Potrebbe ospitare la vita").30 settembre 2010, di Federico La Sala
 SPAZIO
SPAZIO Quel pianeta ci somiglia
Quel pianeta ci somiglia
 "Potrebbe ospitare la vita"
"Potrebbe ospitare la vita"Scoperto il pianeta extrasolare più simile alla Terra. Si chiama Gliese 581g e si trova a venti anni luce da noi. I ricercatori sono sicuri: "Possono esserci esseri viventi"
di LUIGI BIGNAMI *
IL NOME, al momento, non è tra i più accattivanti per quello che potrebbe nascondere: si chiama Gliese 581g ed è il pianeta extrasolare più simile alla Terra tra quelli finora scoperti, il primo sul quale potrebbero essersi create le condizioni per la vita.
Il pianeta si trova a venti anni luce da noi e, come si può capire dal suo nome, orbita intorno alla stella Gliese. Ciò che lo rende più interessante rispetto a tutti gli altri pianeti extrasolari è proprio la distanza dal suo sole: l’energia che lo raggiunge renderebbe possibile la vita sulla sua superficie. La scoperta, pubblicata sulla rivista Astrophysical Journal, è stata realizzata da ricercatori dell’Università della California a Santa Cruz e della Carnegie Institution di Washington, che hanno individuato Gliese 581g attravero l’osservatorio astronomico Keck delle Hawaii. Il pianeta è venuto alla luce grazie allo studio, durato una decina d’anni, che ha considerato le più piccole variazioni di orbita della stella madre, variazioni imputabili ai pianeti che le ruotano attorno.
Ad oggi sono stati scoperti 490 pianeti al di fuori del nostro sistema solare che orbitano attorno a circa 420 stelle, ma nessuno finora aveva caratteristiche idonee a sostenere la vita. Molti di essi infatti, sono gassosi e giganteschi, altri troppo vicini o troppo lontani dalla stella madre perché l’acqua, elemento fondamentale per la vita così come la conosciamo, possa scorrere liquida. Gliese 581g invece, si trova alla distanza giusta e possiede una massa tra 3,1 e 4,3 volte quella della Terra e un diametro tra 1,2 e 1,5 diametri terrestri. Inoltre potrebbe essere roccioso e avere acqua liquida sotto un piccolo strato di ghiaccio superficiale e un’atmosfera in grado di proteggere la vita, se mai è sbocciata. "Personalmente viste le potenzialità di quel mondo, sarei propenso ad affermare che le probabilità di trovare vita su di esso sono del 100%", ha detto Steven Vogt, astronomo dell’Università della California, durante la presentazione della scoperta
Il pianeta ruota attorno alla sua stella in 36,6 giorni e le sue temperature medie di superficie sono comprese fra -31 gradi e -12 gradi. Sembra che esso rivolga sempre la stessa faccia all’astro e questo lo porterebbe ad avere una faccia molto più calda dell’altra. Gliese è una nana rossa, una stella che è circa 50 volte più debole del nostro Sole. Poiché essa è anche più fredda i pianeti papabili di avere vita possono ruotarle attorno a distanza anche molto ravvicinate. Gliese 581g infatti, gli ruota a 0,15 Unità Astronomiche (una Unità astronomica corrisponde a 150 milioni di chilometri ossia la distanza Terra-Sole). Cliese 581g è stato scoperto insieme a un altro pianeta, troppo lontano dalla stella madre per poter ipotizzare una qualche forma di vita.
* la Repubblica, 30 settembre 2010
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- SISTEMA EXTRASOLARE. il satellite astronomico Keplero della Nasa ha scoperto due pianeti che transitano davanti alla stessa stella Keplero-9 della nostra galassia (di Giovanni Caprara).27 agosto 2010, di Federico La Sala
SISTEMA EXTRASOLARE
La Nasa scopre due nuovi pianeti
Kepler-9b e Kepler-9c, entrambi orbitano intorno alla stella Kepler 9. Sono giganti e gassosi. Hanno dimensioni simili a quelle di Saturno. E forse, ce n’è pure un terzo
MILANO - In solo colpo d’occhio il satellite Keplero della Nasa ha scoperto due pianeti che transitano davanti alla stessa stella Keplero-9 della nostra galassia. «Questa è anche la prima conferma ufficiale - ha precisato Doug Hudgins responsabile scientifico del programma - di un sistema solare simile al nostro, mentre altri sono ancora sotto esame».
I due pianeti con una taglia analoga a Saturno e non offrono ambienti abitabili ruotano su orbite diverse: “Keplero-9b”, come è stato provvisoriamente battezzato, è più vicino all’astro compiendo un giro intorno ad esso in 19 giorni; “Keplero-9c” è invece più lontano e impiega 48 giorni.
La scoperta è riuscita misurando l’abbassamento della luminosità della stella quando il pianeta le passa davanti. Il tutto però non è stato semplice perché ha richiesto ben sette mesi di osservazioni. Tra i due corpi celesti si manifesta anche una certa interazione delle rispettive forze gravitazioni, hanno precisato gli scienziati che stanno verificando anche la presenza di un terzo pianeta. Questo sarebbe vicinissimo alla stella-madre volandole intorno in un giorno e mezzo appena. Inoltre la sua consistenza sarebbe differente e risulterebbe una specie di super-Terra perché avrebbe una massa una volta e mezza quella del nostro pianeta. Il satellite astronomico Keplero è stato lanciato il 6 marzo dell’anno scorso proprio per scovare nuovi corpi planetari extrasolari. Dopo un anno di indagini aveva già individuato circa settecento candidati che ora sono al vaglio degli scienziati.
 Giovanni Caprara
Giovanni Caprara* Corriere della Sera, 26 agosto 2010
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. ---- "Emigrare nello spazio per sopravvivere". Intervista all’astrofisico britannico Stephen Hawking (di Cristina NAdotti).10 agosto 2010, di Federico La Sala
L’INTERVISTA
"Emigrare nello spazio per sopravvivere"
L’astrofisico Hawking: "Crescono popolazione e consumo di risorse: possiamo salvarci dalla catastrofe solo esplorando nuovi mondi"
dal nostro inviato CRISTINA NADOTTI *
LONDRA - Mentre i fondi per le esplorazioni spaziali si riducono, l’astrofisico britannico Stephen Hawking sprona l’umanità a colonizzare lo spazio per evitare un’estinzione data per certa nel prossimo secolo. Complice anche il lancio del suo nuovo libro, atteso per ottobre, l’autore del rinomato “Dal Big Bang ai buchi neri” in un’intervista rilasciata al sito britannico “Big Think” ha lanciato l’allarme su quello che considera il periodo più difficile per la sopravvivenza dell’umanità. Hawking non è ottimista: gli esseri umani sono sempre più abili a sfruttare l’ambiente circostante, ma ancora troppo egoisti per pensare al bene comune del Pianeta, quindi non resta che esportare i nostri vizi e le nostre virtù altrove.
“La popolazione e l’uso delle risorse stanno crescendo sulla Terra in modo esponenziale - è l’ammonimento di Hawking - così come cresce in continuazione la nostra capacità di incidere sull’ambiente, sia in termini positivi che negativi. Il problema è che il nostro codice genetico mantiene ancora immutati gli istinti egoisti e aggressivi che erano indispensabili per la sopravvivenza in passato. In queste condizioni non vedo come si potrebbe evitare il disastro nei prossimi cento anni”.
“L’unica possibilità di sopravvivenza a lungo termine per la nostra specie è di non restare a guardare quel che stiamo facendo alla Terra, ma di distribuirci nello Spazio, solo lì possiamo avere un futuro”, è la conclusione di Hawkings, che cita poi una serie di momenti cruciali nella Storia in cui siamo stati sull’orlo dell’abisso. Il suo avvertimento dai pericoli che ci verrebbero nel comunicare con gli alieni risale allo scorso aprile, quando l’astrofisico disse che gli extraterrestri ci sono di sicuro, ma possono non essere ben disposti nei nostri confronti. A 63 anni Hawking, costretto all’immobilità dalla distrofia neuromuscolare, sembra sempre più pessimista e pronto a prefigurare per la razza umana tutte le calamità dei più catastrofici film di fantascienza.
* la Repubblica, 10 agosto 2010
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. ---- Una teoria di Wun-Yi Shu della National Tsing Hua University di Taiwan (di Luigi Bignami - Nessun inizio, nessuna fine.Una nuova teoria dell’Universo).3 agosto 2010, di Federico La Sala
 ASTRONOMIA
ASTRONOMIA Nessun Big Bang, nessuna fine
Nessun Big Bang, nessuna fine
 Una nuova teoria per l’Universo
Una nuova teoria per l’Universo Il nostro cosmo non ha avuto un momento iniziale e non morirà: è in continua evoluzione, mentre massa, tempo e spazio possono convertirsi l’uno nell’altro. Fa discutere lo studio di un ricercatore di Taiwan, che permette di risolvere molti misteri, ma presenta alcune incoerenze
Il nostro cosmo non ha avuto un momento iniziale e non morirà: è in continua evoluzione, mentre massa, tempo e spazio possono convertirsi l’uno nell’altro. Fa discutere lo studio di un ricercatore di Taiwan, che permette di risolvere molti misteri, ma presenta alcune incoerenze di LUIGI BIGNAMI *
di LUIGI BIGNAMI *NESSUN inizio, nessuna fine, ma un Universo in continua evoluzione, dove massa, tempo e spazio possono convertirsi l’uno nell’altro. Un Universo dunque, senza Big Bang e senza fine. Questo è il cosmo in cui viviamo, così come lo ha concepito e definito Wun-Yi Shu della National Tsing Hua University di Taiwan, che permette di risolvere molti problemi ancora aperti della teoria oggi comunemente accettata, che vuole che l’Universo in cui viviamo sia nato dal Big Bang.
Nell’Universo di Shu sono quattro gli elementi in contrasto con l’attuale teoria dell’evoluzione del cosmo e che ne danno una nuova visione. Il primo: la velocità della luce e la "costante gravitazionale" non sono costanti, ma variano con il tempo. Il secondo: il tempo non ha avuto né inizio, né fine, quindi non c’è stato alcun Big Bang. Il terzo: la sezione spaziale dell’Universo è paragonabile ad una sfera a più di tre dimensioni, un’immagine inconcepibile con la fantasia umana, ma che si spiega solo matematicamente. Il quarto, infine: l’Universo vede momenti di accelerazione e decelerazione nella sua espansione.
L’ipotesi di Shu vede da una nuova prospettiva le entità che stanno alla base dell’Universo, in quanto il tempo e lo spazio si possono convertire l’uno nell’altro con la velocità della luce come fattore di conversione. La massa e la lunghezza sono anch’esse intercambiabili: la conversione dipende dalla "costante gravitazionale", che è variabile nel tempo, e dalla velocità della luce, anch’essa variabile. Secondo questa nuova complessa visione, quando l’Universo è in espansione il tempo si converte in spazio e la massa in lunghezza. Quando l’Universo si contrae avviene il contrario.
"Nella mia visione dell’Universo la velocità della luce è un fattore di conversione tra il tempo e lo spazio, in quanto è semplicemente una delle proprietà della geometria dello spazio-tempo", spiega Shu, il quale continua: "Poiché l’Universo è in espansione si può ipotizzare che in fattore di conversione vari in rapporto a tale espansione e dunque la velocità della luce varia con il tempo cosmico".
Questa nuova concezione del cosmo in cui viviamo, tra l’altro, dà modo di spiegare la sua espansione senza ricorrere all’"energia oscura" che, secondo i canoni attuali, compone il 73% dell’Universo (il 23% è materia oscura e solo il 4% è materia ordinaria, quella di cui sono composte le stelle, i pianeti e tutto l’Universo visibile). Dell’energia oscura non si sa nulla e rimane il più grande mistero per gli scienziati.
Alcune critiche, tuttavia, sono già state mosse alla nuova teoria. Le più vigorose vengono da Michael Drinkwater, astronomo alla Univesity of Queelsland, il quale sottolinea come vi siano numerose prove che la velocità della luce è costante e non cambia con il tempo come sostiene Shu. La quantità di idrogeno, elio e altri elementi presenti nell’Universo, inoltre, sono coerenti con la nascita dell’Universo attraverso il Big Bang. Un’altra problematica riguarda la "radiazione cosmica di fondo" che, nel modello del Big Bang, corrisponde alla radiazione residua delle fasi iniziali della creazione dell’Universo e ne è considerata una conferma chiave. Shu è consapevole di queste controversie, ma secondo l’astrofisico è solo una questione di tempo e anch’esse troveranno una spiegazione nell’Universo infinito.
* la Repubblica, 03 agosto 2010
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. ---- ASTRONOMIA. Quanti gemelli della Terra: "Forse sono 100 milioni"28 luglio 2010, di Federico La Sala
ASTRONOMIA
 Quanti gemelli della Terra
Quanti gemelli della Terra
 "Forse sono 100 milioni"
"Forse sono 100 milioni" La sonda Kepler scova 140 mondi simili al nostro in un campione di 1160 sistemi. -Facendo le dovute proporzioni, significa che i pianeti che ci somigliano sono molti di più di quanto si pensasse. Cautela nella comunità scientifica
La sonda Kepler scova 140 mondi simili al nostro in un campione di 1160 sistemi. -Facendo le dovute proporzioni, significa che i pianeti che ci somigliano sono molti di più di quanto si pensasse. Cautela nella comunità scientificaROMA - E’ dai tempi di Copernico che l’uomo si domanda se nell’universo ci siano altri pianeti come la Terra. Oggi la scienza mette a segno una risposta interessante: non solo i pianeti simili al nostro ci sono, ma sono anche un bel po’. Su un campione di 1160 sistemi analizzati nella Via Lattea, ne sono stati individuati 140. Complessivamente, dunque, nella nostra galassia potrebbero esserci anche 100 milioni di gemelli della Terra.
Il dato proviene da "Kepler", la sonda Nasa da 600 milioni di dollari, lanciata nello spazio nel marzo 2009 proprio per setacciare l’universo alla ricerca di nuovi mondi. La notizia è stata data in anticipo sull’uscita dei risultati ufficiali, prevista per il prossimo febbraio. A parlarne è stato, durante una conferenza a Oxford, il ricercatore bulgaro Dimitar Sasselov, docente di astronomia e direttore del progetto "Harvard Origins of Life": "I pianeti come la Terra ci sono, la nostra galassia ne è piena", ha detto Sasselov dell’università di Harvard, intervenendo alla "TEDGlobal conference 1", un evento prodotto da un’organizzazione noprofit. "Solo che, con il nostro piccolo telescopio, nei prossimi due anni riusciremo ad analizzarne al massimo una sessantina".
Questi pianeti sono paragonabili al nostro non perché abitati o abitabili, ma perché di dimensioni similari, ovvero con un raggio inferiore al doppio di quello terrestre. La rivista "Science" riferisce che Sasselov ha mostrato un grafico che illustra la distribuzione di circa 265 pianeti esaminati da "Kepler", 140 dei quali etichettati come "simili alla Terra".
Una novità molto interessante, considerando che da quando la tecnologia ha cominciato, 15 anni fa, a intercettare pianeti anche al di fuori del nostro sistema solare, la stragrande maggioranza di quelli individuati sono stati classificati "giganti gassosi", come Giove, e non "mondi rocciosi", come la Terra o Marte.
L’intervento dello studioso si intitolava "On Completing the Copernican Revolution" ("sul completamento della rivoluzione copernicana") e ha scatenato un polverone nella comunità scientifica, che ancora tiene queste informazioni a distanza di sicurezza, in attesa di riscontri più approfonditi. Con l’inizio del 2012 potrebbe delinearsi un’idea concreta di quanti sono i pianeti simili al nostro nella galassia, ma è ancora presto per trarre conclusioni.
* la Repubblica, 28 luglio 2010
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. ---- ASTRONOMIA. Quanti gemelli della Terra: "Forse sono 100 milioni"8 agosto 2010, di avatar tridimensionaeè la spiegazione più stupenda che abbia mai letto, sapere che esistono altri pianeti uguali al nostro mi giova un sacco, (anche se pur essendomi immaginato che non esisteva solo il nostro come pianeta terra ma anche simili), perchè potrebbe aumentare la possibilità di scoperta che esistano nuove specie nella galassia delle quali sono convintissimo esistano, ma che persone importanti purtroppo vogliono tenere nascoste oppure dare una versione sbagliata degli accaduti
-
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- Newton si è sbagliato. Erik Verlinde lega le sue critiche all’ipotesi delle stringhe e a quella dell’universo olografico (di Federico Rampini).15 luglio 2010, di Federico La Sala
 LA DISPUTA
LA DISPUTA "Newton si è sbagliato
"Newton si è sbagliato
 la gravità non esiste"
la gravità non esiste" Negli Usa si è riaperto il dibattito sui principi formulati dal celebre scienziato grazie ai lavori di un fisico olandese: "La sua teoria è un’illusione". Si tratta di Erik Verlinde che lega le sue critiche all’ipotesi delle stringhe e a quella dell’universo olografico
Negli Usa si è riaperto il dibattito sui principi formulati dal celebre scienziato grazie ai lavori di un fisico olandese: "La sua teoria è un’illusione". Si tratta di Erik Verlinde che lega le sue critiche all’ipotesi delle stringhe e a quella dell’universo olografico dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI *
dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI *NEW YORK - La teoria degli universi paralleli funziona anche come una metafora letteraria e ci sono tre modi per raccontare questa storia. Nella prima versione un ladro nel Sud della Francia fa sparire computer, passaporto e carta di credito di un celebre scienziato. La seconda versione racconta la vita di due gemelli monozigoti la cui vita procede perfettamente identica, fino a un divorzio che spezza l’armonia. La terza storia ci rivela che la teoria della gravità di Isaac Newton è un’illusione. Quest’ultima ci porta alla scoperta dell’universo "olografico", della "teoria delle stringhe" e altri termini esoterici, misteriosi e affascinanti. Nonostante le apparenze è più facile partire dalla fine.
La teoria della gravità è forse la più formidabile legge della fisica, il principio più evidente e universale perché corrisponde a un’esperienza empirica irresistibile. Il bambino ancora non sa parlare e uno dei primi giochi in cui si trastulla dal seggiolone, consiste nel far cadere il cucchiaio della pappa. Lo spettacolo è affascinante nella sua ripetitività. Afferra il cucchiaio, lo solleva, lo lascia cadere, e ogni volta il miracolo si ripete: quell’oggetto viene attratto irresistibilmente a terra, costringendo il paziente genitore a raccoglierlo. Ognuno di noi all’età di 18 mesi è stato Newton senza saperlo. Ebbene, ricrediamoci: la forza di gravità è un’illusione, una beffa cosmica, o un "effetto collaterale" di qualcos’altro che avviene a un livello molto più profondo della realtà.
L’abbandono di Newton era già stato anticipato dalla relatività di Albert Einstein ma ora avviene una rottura ancora più radicale. Un celebre fisico matematico olandese-americano, il 48enne Erik Verlinde che ha già legato il suo nome alla "teoria delle stringhe" (la supersimmetria negli universi paralleli), sta agitando il mondo accademico degli Stati Uniti con una serie di conferenze in cui fa a pezzi la teoria della gravità. Da Harvard a Berkeley, i colleghi scienziati lo stanno prendendo molto sul serio. La sua nuova visione infatti può gettare una diversa luce su alcuni dei grandi temi della fisica contemporanea: la cosiddetta dark energy (energia oscura), una sorta di anti-gravità che sembra accelerare l’espansione dell’universo, o la "materia oscura" che ipoteticamente tiene unite le galassie.
Andrew Strominger, fisico-matematico di Harvard, è uno dei colleghi di Verlinde che non nasconde la sua ammirazione: "Queste idee stanno ispirando discussioni molto interessanti, vanno dritte al cuore di tutto ciò che non comprendiamo del nostro universo". Verlinde è l’ultimo di una serie di scienziati che da trent’anni a questa parte stanno smantellando pezzo dopo pezzo la teoria della gravità. Negli anni Settanta Jacob Bekenstein e Stephen Hawking hanno esplorato i legami tra i buchi neri e la termodinamica. Negli anni Novanta Ted Jacobson ha illustrato i buchi neri come degli ologrammi, le immagini tridimensionali usate per la sicurezza delle nostre carte di credito: tutto ciò che è stato "inghiottito" ed è sparito dentro i buchi neri dell’universo, è presente come un’informazione stampata nell’ologramma, sulla superficie esterna. Juan Maldacena dell’"Institute for Advanced Study" ha costruito un modello matematico dell’universo espresso come un barattolo di minestra in conserva. Tutto ciò che accade dentro il barattolo, inclusa quella che chiamiamo la gravità, è sintetizzato nell’etichetta incollata all’esterno: fuori invece la gravità non esiste.
È a questo punto che entrano in gioco i gemelli e il ladro, che sembrano presi da sceneggiature di film surrealisti. Lo scienziato Erik Verlinde, autore di una formula algebrica che porta il suo nome, ha un fratello monovulare: Herman. Le loro due vite sono state identiche per molto tempo. I gemelli sono due matematici molto rispettati. Si sono laureati insieme all’università olandese di Utrecht nel 1988, insieme andarono in America per proseguire gli studi a Princeton, dove tutti e due ottennero la cattedra. Sposarono due sorelle. Divorziarono. E solo a questo punto una leggera discrepanza si è introdotta nel meccanismo delle loro vite speculari. Herman è rimasto a Princeton, Erik ha deciso di vivere ad Amsterdam per essere più vicino ai figli.
L’estate scorsa, mentre era in vacanza nel sud della Francia, un ladro gli portò via il laptop, le chiavi di casa, il passaporto. "Fui costretto a fermarmi una settimana in più", racconta Erik. Una settimana di cogitazioni che è stata fatale per l’eredità di Newton. Pensate all’universo come una scatola dello scrabble (lo scarabeo, ndr), il gioco in cui si compongono parole con le lettere dell’alfabeto. Se agitate la scatola e sparpagliate le lettere a caso, c’è una sola possibile combinazione che può darvi una poesia del Leopardi. Una quantità pressoché infinita di combinazioni non hanno alcun significato. Più scuotete la scatola delle lettere più è probabile che il disordine aumenti via via che le lettere si combinano per ordine di probabilità. Questo è il nuovo modo di vedere la forza di gravità, come una forma di entropia. O un "effetto collaterale della propensione naturale verso il disordine". Se non è chiaro che cosa la sostituirà, e ancora siamo ben lontani dall’immaginare le possibili applicazioni pratiche, su un punto Verlinde è categorico: "Il re è nudo. Da tempo si era capito che la gravità non esiste. Ora è giunto il momento di gridarlo".
* la Repubblica, 15 luglio 2010
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- MA IL CENTRO DI GRAVITÀ RESTA PERMANENTE. La mela di Newton continua a cadere a terra e il mistero del ’perché’, a quanto pare, rimane (di Franco Gàbici).16 luglio 2010, di Federico La Sala
MA IL CENTRO DI GRAVITÀ RESTA PERMANENTE
E intanto la mela di Newton continua a cadere a terra e il mistero del ’perché’, a quanto pare, rimane.
di FRANCO GÀBICI (Avvenire, 16.07.2010)
Il fisico Erik Verlinde, già famoso per la teoria delle stringhe, ha messo sottosopra il mondo degli scienziati dichiarando senza alcun pudore che la gravità non esiste e che quel ’qualcosa’ intuito e codificato in una famosa legge da Isaac Newton (la legge della gravitazione universale) è solamente una illusione. Detta così la cosa è di quelle che lasciano di stucco, ma se uno considera la gravitazione si accorge che questa proprietà della materia ha sempre dato dei grattacapi ai fisici. A cominciare dallo stesso Newton che non nascose all’amico Richard Bentley le sue non poche difficoltà nel concepire la gravitazione, un concetto che lo trascinava in un circolo vizioso al quale non trovava via d’uscita.
Che cos’è la gravità? È quella forza che fa sì che i corpi si attirano. Ma perché i corpi si attirano? Perché esiste la gravità. E probabilmente per porre fine alla questione Newton chiuse la discussione con il famoso «Hypotheses non fingo» (non invento nessuna ipotesi) che si trova nello ’Scolio generale’ della seconda edizione dei ’Principia’ del 1713: «In verità - scrive Newton - non sono ancora riuscito a dedurre dai fenomeni la ragione di queste proprietà della gravità, e non invento ipotesi».
Poi due secoli dopo, nel 1916, arriva Albert Einstein con la sua relatività generale e toglie dagli imbarazzi Newton proponendo una nuova interpretazione della gravità senza ricorrere al concetto di forza. Secondo Einstein la gravità non è affatto una ’forza’ ma una ’deformazione’ di quel qualcosa chiamato ’spazio-tempo’ nel quale sono immersi i corpi. Un corpo massiccio come il Sole, ad esempio, deforma lo spaziotempo circostante e la Terra, che si trova nei suoi paraggi, si muove non perché il Sole la attira verso di sé ma perché il Sole ha prodotto una deformazione che costringe il nostro pianeta a ’rotolare’ verso di lui.
Questa gravitazione, dunque, è proprio un bel pasticcio tant’è che nel 1968 Peter G. Bergmann, allievo di Einstein, pubblica ’The riddle of gravitation’ (uscito in Italia col titolo ’L’enigma della gravitazione’) e mai titolo fu più azzeccato perché, a conti fatti, la gravitazione continua ancora a far discutere. Sta di fatto che noi conosciamo gli effetti della gravità e sappiamo soltanto che là dove esiste anche un solo atomo di materia là esiste la gravitazione. Ma quale sia l’origine della gravità continua ad essere un mistero. Nel corso del tempo sono state proposte diverse letture del fenomeno, quella di Newton e quella di Einstein e oggi si è aggiunto un altro capitolo a questo ’enigma’. Ma non crediamo che Verlinde abbia inteso negare la gravità.
Negare la gravità vuol dire andare contro l’evidenza dei fatti perché nel nostro quotidiano facciamo continuamente i conti con questo ’mistero’ che prima di oggi veniva interpretato come forza o come deformazione. Oggi Verlinde afferma che la gravità potrebbe essere una ’forma di entropia’ o comunque un effetto collaterale della propensione naturale verso il disordine. Sta di fatto che un corpo lasciato libero tende a cadere a terra e per spiegare il fenomeno sono state introdotte diverse ipotesi a dimostrazione che le teorie non sono mai definitive e possono essere perfezionate. Il caso della gravitazione indica anche che qualcosa di impenetrabile sfugge sempre alla nostra indagine e l’homo super-sapiens dei nostri tempi, gli piaccia o no, si trova costretto a chinare il capo di fronte all’incomprensibile.
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- LA "FEDE RAZIONALE" E L’INTELLIGIBILTA’ DEL MONDO (DI ROBERTO TIMOSSI - "VERLINDE & CO: GLI ATTI DI FEDE DELLA SCIENZA")22 luglio 2010, di Federico La Sala
ORIENTARSI, OGGI - E SEMPRE. LA LEZIONE IMMORTALE DI KANT, DALLA STIVA DELLA "NAVE" DI GALILEI. Invito alla rilettura dell’opera del 1786, "Che cosa significa orientarsi nel pensiero" - e della "Critica della ragion pura" (1781/1787).
VERLINDE & CO: GLI ATTI DI FEDE DELLA SCIENZAdi ROBERTO TIMOSSI (Avvenire, 22.07.2010)
La spiegazione della teoria della gravità ha sempre rappresentato un problema per gli scienziati fin dal tempo dello stesso Isaac Newton. Il fatto che tra corpi dotati di massa si eserciti un’azione a distanza di cui non si conosce con precisione la causa (alcuni teorizzano la presenza di una particella portatrice di forza chiamata gravitone) è stato lungamente considerato un fenomeno quasi esoterico e lo stesso Newton pensò addirittura che per uscire dall’impasse non si potesse fare di meglio che ricorrere all’azione diretta di Dio.
Egli infatti si chiese: «Che cosa c’è nei luoghi quasi vuoti di materia e come avviene che il Sole e i pianeti gravitino l’uno verso l’altro senza alcuna materia densa fra loro?»; e si rispose: «Il sensorium Dei» (il «sensorio» di Dio). Tuttavia oggi, con la tipica disinvoltura di una certa vulgata scientifica, il fisico Erik Verlinde ritiene di risolvere l’enigma della gravità semplicemente proclamando l’infondatezza della newtoniana teoria della gravitazione universale. E c’è da giurare che così facendo, qualcuno riterrà risolta pure la questione della presenza di una causa prima di natura divina.
Ma quale sarebbe dunque la scoperta che annichilirebbe definitivamente la famosa legge gravitazionale di Newton? Si tratterebbe nientemeno che dell’idea di un bizzarro «universo olografico», all’interno del quale la gravità si rivelerebbe una mera illusione. Non pensiamo valga la pena entrare ulteriormente nel merito di una teoria come questa, perché non appare del tutto compiutamente formulata e sicuramente non è ancora scientificamente dimostrata.
Vogliamo invece cogliere l’occasione per evidenziare un aspetto che di solito gli scienziati non colgono o tendono a negare: la presenza talvolta di un vero e proprio atto di fede all’origine dei programmi di ricerca scientifica. Come ha infatti notato anche il fisico e biologo molecolare Edoardo Boncinelli, lo scienziato deve spesso sfogliare la margherita del reale, deve cioè scegliere come un petalo quale strada privilegiare tra una grande quantità di fenomeni naturali sotto osservazione o di ipotesi alternative; e non di rado egli prende una decisione sulla base di un «atto di fiducia» personale, di una soggettiva propensione a sondare per prima una certa direzione piuttosto che un’altra.
La stessa teoria delle stringhe di cui è fautore Erik Verlinde è infatti considerata da molti scienziati una specie di atto di fede, dal momento che non sussistono ancora prove empiriche sufficienti a dimostrarla; mentre c’è chi, come il fisico Lee Smolin, pensa perfino che tali prove non esisteranno mai.
Si tratterebbe insomma di un’ipotesi che, in quanto inconfutabile, non si può definire «neppure sbagliata». In effetti, come non classificare quale pura fede la scelta degli stringhisti di credere senza riscontri empirici o prove razionali nell’esistenza di entità inosservabili come le stringhe? Qui la scienza si avvicina molto alla religione; evento quest’ultimo che preoccupa un astrofisico come Lawrence M. Krauss, il quale parla appunto apertamente della teoria delle stringhe come di un’ossessione religiosa.
Vogliamo allora sperare che anche qualora la tesi della non esistenza della gravità di Verlinde si riveli infondata, l’intera vicenda sia comunque servita a far prendere coscienza di come gli atti di fede risultino usuali e molteplici nell’ambito dell’indagine scientifica. Del resto, senza una fede di fondo nell’intelligibilità del mondo non esisterebbe neppure la scienza.
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. --- MA IL CENTRO DI GRAVITÀ RESTA PERMANENTE. La mela di Newton continua a cadere a terra e il mistero del ’perché’, a quanto pare, rimane (di Franco Gàbici).8 agosto 2010, di avatar tridimensionaepurtroppo è il dubbio, la cosa che più ci accomuna e che tentiamo ogni qualvolta di non darne credito. Ma i fatti parlano chiaro spesse volte ci troviamo a risolvere problemi anche di piccola o grande importanza, fatto stà comunque sia stato l’esito il dubbio permane, cosi lo è stato e tutt’ora continua ad esserci tra gli scienziati, che nonostante facciano grandi progressi hanno lacune, le quali non possono colmare se non con ipotesi su ipotesi.
-
-
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON" !!! --- Entro il 2050 non si tagliano le emissioni di gas serra del 50%, mondo a rischio26 ottobre 2007, di Maria Paola Falqui
 e entro il 2050 non si tagliano le emissioni di gas serra del 50%, mondo a rischio
e entro il 2050 non si tagliano le emissioni di gas serra del 50%, mondo a rischio
 L’Onu: «La Terra verso la catastrofe»
L’Onu: «La Terra verso la catastrofe»
 Tre i grandi mali del pianeta: riscaldamento, sovrappopolazione, fine della biodiversità
Tre i grandi mali del pianeta: riscaldamento, sovrappopolazione, fine della biodiversitàNAIROBI (KENYA) - La Terra è vicina al punto di non ritorno e il futuro dell’umanità è seriamente compromesso. Lo afferma l’ultimo allarmante studio intitolato «Global Environment Outlook» e presentato dallo «United Nations Environment Programme» (Unep), l’organismo delle Nazione Unite che ha sede a Nairobi e che si occupa della tutela ambientale. Lo studio, al quale hanno partecipato oltre 1400 scienziati, è stato pubblicato a 20 anni di distanza dal celebre rapporto «Il futuro di tutti noi», analisi della «Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo» nella quale per la prima volta fu formulato il concetto di «sviluppo sostenibile». Secondo il recente studio tre sono le cause che maggiormente mettono in pericolo la vita sul nostro pianeta: il riscaldamento climatico, il progressivo aumento numero delle specie in via d’estinzione e la rapida crescita della popolazione.
ATTIVITA’ UMANA - Gli scienziati hanno sottolineato che le attività umane ormai condizionano fortemente il clima della Terra e gli ecosistemi. La situazione può diventare ancora più catastrofica se, come stimano alcune proiezioni scientifiche, la popolazione umana raggiungerà gli 8 miliardi e 10 milioni di abitanti nel 2050. Negli ultimi venti anni, la popolazione mondiale infatti è aumentata di 1,7 miliardi di persone, passando da 5 a 6,7 miliardi di abitanti. «La popolazione umana adesso è così numerosa che l’ammontare delle risorse di cui ha bisogna per sopravvivere è superiore a quelle che la Terra riesce a produrre» afferma Achim Steiner, direttore esecutivo dell’Unep
CAUSE - Il riscaldamento climatico e la rapida crescita demografica sono le cause principali del gran numero di animali estinti o in via d’estinzione. Secondo le cifre presentate dall’Unep circa 30% degli anfibi, il 23% dei mammiferi e il 12% degli uccelli rischiano di scomparire, mentre tra i fiumi più grandi del mondo, uno su dieci, a causa dell’inquinamento e dello sfruttamento eccessivo della pesca, è sottoposto a profondo stress idrico e di anno in anno riduce sempre di più la sua portata d’acqua prima di raggiungere il mare.
AVVERTIMENTO E STIMOLO - Il rapporto, secondo gli scienziati, vuole essere allo stesso tempo sia un forte avvertimento sia uno stimolo al cambiamento. Se si vuole evitare una catastrofe, dichiara senza mezzi termini lo studio, entro il 2050 bisogna ridurre le emissioni di gas serra del 50% rispetto a quelle che erano prodotte nel 1990. Ciò significa che i paesi più industrializzati devono tagliare dal 60 all’80% le loro emissioni. Nel rapporto non mancano le note positive. Il direttore Steiner fa notare che i paesi dell’Europa occidentale hanno preso effettive misure per ridurre l’inquinamento atmosferico, mentre il Brasile ha fatto notevoli sforzi per combattere la deforestazione: «La vita sulla Terra potrebbe essere più semplice se non ci fossero questi tassi di crescita demografica. Ma costringere le persone ad avere meno figli è una soluzione semplicistica. La cosa migliore sarebbe accelerare il benessere dell’umanità e usare più razionalmente le risorse che il pianeta ci offre».
Francesco Tortora
SCHEDA. Lo stato di salute della Terra
* Corriere della Sera, 26 ottobre 2007
-
> 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON" !!! - a cura di pfls20 giugno 2007, di Ernesto Solari
Sono Ernesto Solari, studio Leonardo da tanti anni e quando ho letto questa previsione apocalittica di Newton sono rimasto abbastanza colpito e la prima parola che ho pronunciato è Gioacchino, si il DaFiore ha sicuramente ispirato anche Newton così come aveva già ispirato Leonardo. Già una decina di anni fa, al convegno della rivista Astra, presentai una mia tesi relativa alla profezia del cenacolo di Leonardo che consiste nell’indicazione precisa della futura Apocalisse che Leonardo ha voluto lasciare ai posteri. I cassettoni del soffitto sono (7x6) 42 che moltiplicati per 30 anni (gli anni che Gioacchino attribuisce ad una generazione) ci dà come risultato proprio 1260, ma dalla prosecuzione prospettica del soffitto, effettuata al computer, si ottiene un soffitto formato da 72 (12 x 6) cassettoni che danno come tempo totale 2160. E’ evidente che Leonardo conosceva il fenomeno della precessione degli equinozi, è evidente che Leonardo pose il Cristo sole al centro con alla sua destra Giovanni (era dei pesci) e alla sua sinistra Tommaso (era dell’acquario) così come è evidente l’ispirazione gioachimita che notiamo proprio nella suddivisione degli Apostoli. Gioacchino infatti aveva ripreso il discorso sulle cinque chiese petrine (alla destra di Cristo) che rappresentano la vita attiva e quello sulle sette chiese giovannee che rappresentano la vita contemplativa di Giovanni, posto da Leonardo proprio a fianco di Pietro in una sorta di confronto fra i due apostoli (vi è una corrispondenza perfetta fra i cinque apostoli e le 5 chiese. Sono comunque molti altri i simboli che dimostrano questo legame fra Leonardo e Gioacchino ( e qui rimando ad alcune mie pubblicazioni/ vedere sito). Quindi la conclusione di Leonardo è che quell’orologio che pone sul soffitto scandisce il tempo di 1260 anni che detratti dal totale di 2160 danno come tempo rimanente, prima dell’ingresso nell’acquario o nella nuova età dello spirito, 900 anni. Chi ha sbagliato? Lo scienziato Newton o l’ispirato Leonardo? Prof. Ernesto Solari
P.s.: Per Dan Brown: il conflitto fra Giovanni e Pietro, fra la Chiesa attiva e quella contemplativa spiega il coltello dietro la schiena e la mano minacciosa sulla spalla di Giovanni. Per contatti o approfondimenti: sito internet www.museosolari.com