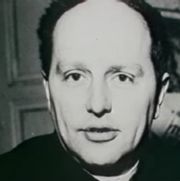
Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di Federico La Sala
venerdì 11 maggio 2007.- [...] Libro-manifesto, si è detto, consegnato al mondo contadino di Barbiana, utopico e indigesto. Ma quel volume, suggerisce Giorgio Pecorini, che ha frequentato il prete per dieci anni, «non deve esser letto come un ricettario, ma come un atteggiamento etico». «Spesso gli amici (...) insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi (...)», annota don Milani in Esperienze pastorali, pubblicato nel 1958, quattro anni dopo l’arrivo a Barbiana. «Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola» [...]
Lo scandalo di Barbiana
di Francesco Erbani *
«Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti». Cominciava così un libro nato per scuotere le sicurezze e il senso comune di una collettività. Si intitolava Lettera a una professoressa, lo scrissero otto ragazzi della scuola di un piccolo borgo toscano, due case addossate a una chiesa - Barbiana, frazione di Vicchio, nel verde del Mugello. Li guidò un prete, don Lorenzo Milani. Il volumetto, centosessanta pagine, uscì a maggio del 1967. Alla fine di quello stesso mese il prete compì quarantaquattro anni e il 26 giugno morì.
A quarant’anni da allora quel libro non ha smesso di scuotere. Ha suscitato appassionati consensi e vibrati dissensi, e ha costruito un mondo a sé, fatto dei modi diversi di leggerlo, arrivando persino a essere giudicato come il modello di una scuola permissiva o, all’opposto, savonaroliana e manesca. La Lettera è però anche lì con la sua scrittura asciugata, le tabelle su quanti ragazzi poveri vengono bocciati nella scuola dell’obbligo, su quanto contano la cultura e il censo della famiglia per il successo scolastico. Un libro sulla scuola che invece di attutirle consolida le differenze e come i cattivi ospedali cura i sani e respinge i malati, sull’ingiustizia di far parti uguali fra disuguali, su quanto invece renda uguali il possesso della lingua, con frasi scolpite, tipo: «Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia». E poi i paradossi, le provocazioni e le male parole. E gli interrogativi che tuttora pone a una comunità la quale, ha ricordato Tullio De Mauro (vedi l’intervista qui accanto), conduce alla licenza media il novantadue per cento di chi ne ha diritto, ma, sola in Europa, custodisce un quaranta per cento di persone che poi stentano a capire una frase con una relativa e un’operazione a due cifre.
Libro-manifesto, si è detto, consegnato al mondo contadino di Barbiana, utopico e indigesto. Ma quel volume, suggerisce Giorgio Pecorini, che ha frequentato il prete per dieci anni, «non deve esser letto come un ricettario, ma come un atteggiamento etico». «Spesso gli amici (...) insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi (...)», annota don Milani in Esperienze pastorali, pubblicato nel 1958, quattro anni dopo l’arrivo a Barbiana. «Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola».
Testimone di come fu scritto quel libro è Adele Corradi. Nel 1963 aveva poco meno di quarant’anni e insegnava Lettere in una scuola media. Le parlò di don Milani la sua preside, moglie del giudice Marco Ramat, uno dei fondatori di Magistratura democratica. Era appena stata varata la riforma della media: obbligo fino a 14 anni, niente più avviamento al lavoro, scuola uguale per tutti, come dettava la Costituzione. Un giorno di settembre salì a Barbiana, lì quel sacerdote proveniente dalla buona borghesia, di solida cultura classica e laica, madre ebrea, convertitosi a vent’anni e ordinato a ventiquattro, sperimentava da un decennio il nuovo sistema. Le avevano detto di fare in fretta, perché gli era stato diagnosticato il morbo di Hodgkin e gli restavano tre mesi di vita.
Quella mattina don Milani e i suoi ragazzi stavano tentando un esperimento: una lettera collettiva agli alunni di un altro grande innovatore, il maestro Mario Lodi. Quel modello di scrittura venne praticato altre volte fino a sfociare nella Lettera a una professoressa.
Nel frattempo la Corradi si era trasferita a Barbiana, aveva affittato una stanza vicino alla chiesa. Don Lorenzo stava male, ma le cure avevano dato risultati e smentito le previsioni più infauste. «La scrittura della Lettera iniziò a fine estate del 1966», racconta la Corradi. «Due ragazzi erano stati bocciati agli esami». Due ragazzi figli di povera gente, a uno dei quali si deve la pagina iniziale: «Cara Signora, lei di me non si ricorderà nemmeno il nome». «Don Lorenzo era spesso a letto, si alzava solo la domenica per la messa. Poi da gennaio non si alzò più. La scrittura collettiva funzionava così: ognuno appuntava delle idee su un foglietto, poi i foglietti venivano accumulati e discussi uno per uno. Si limava, si toglieva il superfluo e si cercavano le parole più efficaci, comprensibili anche all’ultimo degli alunni. Un giorno proposi di inserire un concetto: non limitiamoci a dire agli insegnanti di non bocciare, diciamo che devono anche insegnare. Don Lorenzo mi guardò e disse: "Non va bene. Gli insegnanti devono insegnare. Se non insegnano vanno all’inferno". Giancarlo, un ragazzo di 15 anni, si occupò delle statistiche. A darci una mano venne Giuseppe Matulli, che lavorava all’Istat e che ora è vicesindaco di Firenze. Fu don Lorenzo a trasformare quelle tabelle in disegnini a colori. E fu sempre lui a scrivere il capitoletto sull’Italia contadina assente da quel Parlamento che aveva approvato la riforma della media, con la destra che proponeva più latino, la sinistra più scienza, topi di museo i primi, topi di laboratorio i secondi, li chiamava: "Lontani gli uni e gli altri da noi che non si parla e s’ha bisogno di lingua d’oggi e non di ieri, di lingua e non di specializzazioni"».
Don Lorenzo e i ragazzi lavorarono alla lettera per nove mesi. «Barbiana era una scuola aperta dodici ore al giorno, tutto l’anno», racconta Pecorini. Lui, giornalista dell’Europeo, conobbe il prete nell’estate del 1958, quando la Civiltà Cattolica stroncò Esperienze pastorali, precedendo il decreto del Sant’Uffizio che ne voleva vietare la vendita. «Gli mandai un telegramma e dopo due giorni mi fece telefonare. Arrivai a Barbiana mentre faceva scuola. Senza sollevare la testa da un libro, don Milani sibilò: "Questo è l’imbecille che ci ha mandato il telegramma". Rimasi di sasso. Ma a Barbiana non si distribuiva la posta, non c’erano telefono ed elettricità. Era arrivato un avviso e lui si era allarmato. Qualcuno era sceso a Vicchio e aveva dovuto pagare una multa salata».
La scuola era uno stanzone accanto alla chiesa. Alle pareti, ricorda Pecorini, una libreria costruita dai ragazzi. Poi tavolacci d’osteria, carte geografiche e tabelle sulla decolonizzazione in Africa e in Asia, uno schema del Parlamento, foto di Gandhi e di bambini neri. Più tardi comparve la scritta: «I care». Qualche volta spuntava un gigantesco spartito: «I ragazzi ascoltavano Beethoven e don Lorenzo con una bacchetta li invitava a seguire la musica». La musica, le lingue straniere (poca grammatica, molto uso), saper costruire uno scaffale: erano pilastri pedagogici. Come scrivere e leggere collettivamente. Oppure far scuola fra loro, i più grandi che diventano maestri dei più piccoli. «Niente libri di testo, ma per ogni materia anche cento libri, e poi i giornali, commentati a fondo». Da una porta si entrava nella stanza dove dormiva il priore. Al piano di sopra vivevano Leda, la perpetua, e Michele e Francesco (Francuccio) Gesualdi, che vissero a Barbiana fino alla morte di don Lorenzo. (Michele è diventato sindacalista della Cisl e presidente della Provincia di Firenze, Francuccio è stato fondatore della Rete Lilliput, e ora esce un suo libro Il mercante d’acqua - Feltrinelli, pagg. 132, euro 8).
Quando il libro fu finito, don Lorenzo si era trasferito dalla madre a Firenze, dove continuava a lavorare con i ragazzi. «Venne a trovarlo il proprietario della Libreria editrice fiorentina, che stampò la Lettera in cinquemila copie», racconta la Corradi, «e lui gli disse "ti basteranno per una settimana"». Della Lettera si fecero nuove edizioni, ma don Lorenzo non c’era più. Una copia l’aveva regalata ad Adele con la dedica: «Poi finalmente trovammo una professoressa diversa da tutte le altre che ci ha fatto tanto del bene».
Fonte:la Repubblica, 10 maggio 2007.
FOTO: Wikipedia
Sul tema, nel sito, si cfr.:
 [...] un medico, un giudice, o un uomo politico, può avere in capo molte belle regole patologiche, giuridiche o politiche, al punto da poter diventare egli stesso un profondo insegnante in proposito, e tuttavia cade facilmente in errore nell’applicazione di esse, o perché manca di capacità naturale di giudizio (...) o anche per il fatto che egli non è stato sufficientemente addestrato per questo giudizio, mediante esempi e pratica diretta [...]: si cfr.
[...] un medico, un giudice, o un uomo politico, può avere in capo molte belle regole patologiche, giuridiche o politiche, al punto da poter diventare egli stesso un profondo insegnante in proposito, e tuttavia cade facilmente in errore nell’applicazione di esse, o perché manca di capacità naturale di giudizio (...) o anche per il fatto che egli non è stato sufficientemente addestrato per questo giudizio, mediante esempi e pratica diretta [...]: si cfr.
 EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. GIA’ DANTE LO SOLLECITAVA ...
EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. GIA’ DANTE LO SOLLECITAVA ...
 KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
Forum
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa" -- Diffido dell’istruzione (di Alessandro D’Avenia)6 febbraio 2018, di Federico La Sala
"PIGMALIONE", UNA "FIGURA" NARCISISTICA ED EDIPICA, ANCORA MODELLO DI ESSERE UMANO E DI MAESTRO?!
- L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore. Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale (...) Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi (Alessandro D’Avenia)
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
Diffido dell’istruzione
di Alessandro D’Avenia (Corriere della Sera, 05.02.2018)
«Caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. Ho visto ciò che nessuno dovrebbe vedere: camere a gas costruite da ingegneri istruiti, bambini avvelenati da medici ben formati, lattanti uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati e laureati. Diffido - quindi - dell’istruzione. Aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri formati, degli psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani».
 Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.
Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.Il divorzio tra istruzione ed educazione è uno dei mali peggiori della scuola, frutto del luogo comune secondo cui esisterebbe un’istruzione neutra. Invece sempre si educa mentre si istruisce, perché la prima comunicazione è quella dell’essere, e solo dopo arrivano le parole, altrimenti non sarebbe necessaria la relazione viva con i ragazzi, ma basterebbe caricare le lezioni sulla rete. In senso stretto non esiste insegnamento in differita , ma solo in diretta.
Insegnare è una branca della drammaturgia. È l’essere dell’insegnante che genera la conoscenza, perché apre la via al desiderio dello studente, che scorge nel docente una vita più viva e libera grazie alla cultura e al lavoro ben fatto, e la vuole anche per sé. Lo ricordava con precisione il Nobel Canetti nella sua autobiografia: «Ogni cosa che ho imparato dalla viva voce dei miei insegnanti ha conservato la fisionomia di colui che me l’ha spiegata e nel ricordo è rimasta legata alla sua immagine. È questa la prima vera scuola di conoscenza dell’uomo».
Le nozioni più raffinate da sole non rendono umani, tutto dipende da come gli insegnanti si relazionano tra loro e con i ragazzi, perché, prima delle nozioni, sono le relazioni a essere generative dell’io e del sapere. È nella relazione che si impara a sentire il valore del sé come destinatario del dono del sapere. Quali insegnanti siete tornati a ringraziare e per cosa? Per la lezione sulle leggi della termodinamica e su Leopardi, o per come vivevano e offrivano la termodinamica e Leopardi proprio a voi?
Qualche tempo fa mi scriveva uno studente: «Le racconto due esperienze. La prima: la faccia polverosa della scuola. Un professore, che aveva esordito in prima liceo con “siete troppi: vi ridurremo”, pochi giorni fa ha condensato l’amore per il suo lavoro in questa frase: “Un insegnante non deve avere cuore, deve avere un cuore di pietra... altrimenti farà preferenze”. Uno scherzo, pensavamo. Un mio compagno ribatte: “Ma no, prof! Un insegnante deve avere un cuore talmente grande da non fare nessuna preferenza!”. “No, no: un cuore di pietra”. Parlava seriamente. La seconda: la faccia luminosa della scuola. Quest’anno ho scoperto la poesia grazie al gesto straordinario di un ordinario professore di filosofia, che un giorno ci ha parlato della sua giovinezza e di come la poesia ai tempi occupasse la sua vita e impegnasse la sua fantasia. Interessato anche io dal momento che non avevo letto nessun grande poeta ho chiesto un consiglio. Il giorno seguente lo vedo estrarre dalla sua ventiquattrore un libricino invecchiato. Viene verso di me. “Questo è per te”. Mi ha regalato una delle sue copie di Elegie duinesi, di R.M. Rilke, il suo libro di poesia preferito. Il libro della sua giovinezza!».
La differenza tra le due impostazioni è proprio quella che corre tra chi si illude si possano separare istruzione ed educazione e chi invece le tiene naturalmente unite. Nel primo caso si pensa che il docente sia un distributore di nozioni, nel secondo la didattica è conseguenza della relazione. Il primo professore educa all’insensibilità di cuore, a non sentire l’unicità del tu, il secondo rende Rilke interessante prima di averne letta una riga. Il nesso che tiene unite istruzione ed educazione è nella realtà, e nessuna presa di posizione teorica le può nei fatti separare. L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore.
Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale. Non si può aumentare la conoscenza di qualcosa senza che prima aumenti l’interesse nei confronti del soggetto in questione (vale per l’amicizia come per la chimica). L’amore genera conoscenza e la conoscenza ampliata rinnova l’amore: se il docente non «erotizza» la materia, la materia per quanto ben conosciuta resta inerte, come spiega Massimo Recalcati.
Non esistono cose poco «interessanti», ma uomini e donne poco «interessati», perché le emozioni (la neurobiologia qui ci conforta) sono le guide che aprono la strada allo sviluppo cognitivo. Solo così gli studenti diventano soggetti di possibilità e non oggetti al peggio da ridurre o al meglio da riempire. È questa la rivoluzione copernicana chiesta a ogni docente: non sono gli alunni a ruotare attorno a lui ma il contrario. Un professore - il letto da rifare oggi lo suggerisce lo studente della lettera - è chiamato ad avere un cuore tale da non far preferenze perché preferisce tutti e ciascuno diversamente: sfida difficilissima (quanti errori, quante gioie...) ma decisiva.
È la stessa sfida narrata da Ovidio, nelle sue Metamorfosi, a proposito del mito di Pigmalione. Uno scultore che, deluso da tutte le donne, si innamora della donna ideale che ha scolpito nel marmo. Il suo trasporto è tale che gli dei trasformano la statua in una donna in carne e ossa. Il mito viene usato per descrivere lo sguardo educativo, il cosiddetto effetto-Pigmalione, per il quale se un docente (ma vale per ogni educatore) guarda un alunno convinto che farà bene, genererà in lui una fiducia in sé tale che, nella quasi totalità dei casi, anche a fronte di un’inadeguata disposizione iniziale, otterrà risultati positivi.
L’effetto vale anche in negativo: se sono convinto che non vali, l’effetto sui risultati sarà coerente, anche a fronte di buone capacità. Lo sguardo educante non è mai neutro ma sempre profetico, nel bene e nel male. Ne abbiamo conferma quotidiana nel bambino che, appena caduto, si volge verso i genitori: se si mostrano allarmati ne provocano il pianto, se sorridenti il sorriso, quasi che il dolore, pur oggettivo, venga trasformato nello e dallo sguardo.
I ragazzi non hanno bisogno di insegnanti amiconi né aguzzini, ma di uomini e donne capaci di guardarli come amabili soggetti di inedite possibilità a cui non fare sconti. E non è questione di missione o di poteri magici, ma di professionalità. Per questo l’appello è il momento chiave della giornata scolastica: segna il tono della relazione e fa sì che ognuno senta su di sé lo sguardo profetico che spinge a far bene come conseguenza dell’ esser bene. Il contrario del «siete troppi, vi ridurremo», sterile autoritarismo, è il fecondo «sei unico, ti aumenterò».
La parola autorità viene da augeo (aumentare): la esercita non chi ha il cuore molle o sprezzante, ma chi si impegna ad aumentare la vita che ha di fronte, per quanto fragile, difficile, resistente possa sembrare. Questa è l’istruzione di cui non diffido, perché ispirata da un umanesimo maturo, l’umanesimo dell’altro uomo, come lo chiama il filosofo Lévinas, che fa del tu il cuore dell’etica e smaschera il falso umanesimo dell’istruito incapace di sentire il tu, tanto da distruggerlo proprio attraverso l’istruzione.
Non è facile però essere educatore in un sistema scolastico che asfissia di burocrazia e svilisce la dignità sociale ed economica, e in un contesto culturale che spesso attacca dall’alto (genitori) e dal basso (studenti). Ma questi elementi possono anche diventare scuse per non fare ciò che è alla portata di un uomo libero: prendersi cura di chi gli viene affidato.
Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
- "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". -- Ricordando Michele Gesualdi (La redazione di Mosaico di pace)20 gennaio 2018, di Federico La Sala
Ricordando Michele Gesualdi*
Ci uniamo alla preghiera di tanti per la morte di Michele Gesualdi, l’allievo di don Lorenzo Milani, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla figlia Sandra e al fratello Francuccio.
A noi tocca, più che mia, cogliere l’eredità di don Lorenzo e attualizzarla. Perché tutti abbiano diritto di parola.
«Crediamo che di fronte a una persona che come don Lorenzo ha lasciato un segno nella storia - scrivevano Michele e Francuccio in Toscana Oggi il 21 aprile 2017 -, l’unico atteggiamento corretto è capire cosa ha ancora di importante da dirci, per assumerci le nostre responsabilità. Ossia per chiederci come applicare nel nostro tempo la sua proposta intramontabile. Don Lorenzo ha speso la sua vita per ridare dignità ai contadini e agli operai, che a causa della propria inferiorità culturale, erano umiliati, oppressi e saccheggiati da imprenditori, proprietari terrieri e ogni sorta di profittatori».
La redazione di Mosaico di pace
https://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3779.html
- NEL SITO, SI CFR.:
Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana --- «A noi ragazzi disse: dall’ingiustizia si esce insieme». Intervista a Michele Gesualdi, a cura di Osvaldo Sabato (2013)
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". -- A cinquant’anni dalla morte, in dieci punti la storia del priore di Barbiana (di Elisa Chiari).27 giugno 2017, di Federico La Sala
Don Lorenzo Milani, chi era costui? La storia in 10 tappe
A cinquant’anni dalla morte, avvenuta il 26 giugno del 1967, raccontiamo in dieci punti la storia del priore di Barbiana.
di Elisa Chiari (Famiglia Cristiana, 25/06/2017)
«Trasparente e duro come il diamante, doveva subito ferirsi e ferire», delle definizioni di don Lorenzo Milani è forse la più sintetica ed efficace, non per caso appartiene a don Raffaele Bensi, padre spirituale di Lorenzo Milani dalla conversione alla morte, unico custode del segreto della sua fede. Ma a cinquant’anni dalla morte, ora che anche un Papa ha detto una parola definitiva su di lui, ancora dobbiamo chiederci - rubando il titolo al suo amico Giorgio Pecorini -: Don Milani, chi era costui? Proviamo a rispondere, poco più che in pillole, tenendo conto degli ultimi sviluppi.
1. UNA FAMIGLIA COLTA, AGNOSTICA E FACOLTOSA
Lorenzo Milani nasce, secondo di tre fratelli, a Firenze nel 1923 da Albano Milani Compretti e Alice Weiss, triestina. La famiglia è colta, facoltosa e agnostica, ma i figli Milani vengono battezzati quando si profila il rischio delle leggi razziali, dato che la mamma è di origine ebraica. Il nonno è il filologo Domenico Milani Comparetti. Tra i compagni di giochi nell’infanzia di Lorenzo ci sono i rampolli delle famiglie della borghesia fiorentina, tra loro Oreste Del Buono.
Da ragazzo Lorenzo è uno studente intelligente e incostante, che si applica con passione alle cose che gli interessano e trascura le altre, sapendo però di poter vivere della rendita della cultura respirata in famiglia, e, se del caso, di poter contare sul soccorso degli intellettuali pregiati, cui viene affidato nei momenti di difficoltà. Per un periodo va a lezione da Giorgio Pasquali, uno dei padri della filologia moderna.
Nel 1930 la famiglia si trasferisce a Milano dove Lorenzo completa gli studi fino alla maturità classica. Dopo, rifiuta di iscriversi all’Università e manifesta il desiderio di frequentare l’Accademia delle belle arti, cosa che il padre qualifica, come una “bambinata”. Però non lo ostacola forse nella convinzione che sia una passione transitoria: Lorenzo studia a Brera e va a lezione dal maestro Staube: il talento artistico è quello che è, modesto, ma il maestro coglie nell’allievo una sorta di “veemenza” nell’apprendere, che s’applicherà più tardi ad altre più concrete scelte di vita.
2. MISTERO DELLA FEDE E INDIGESTIONE DI CRISTO
È il 1941, Lorenzo sta studiando pittura e progetta di affrescare una cappella nella tenuta di famiglia a Monterspertoli. La sta esplorando quando, a un certo punto, scrive una lettera all’amico d’infanzia Oreste Del Buono: «Ho letto la Messa. Sai che è più interessante dei Sei personaggi in cerca d’autore?».
Potrebbe essere il primo segno di quello che sta cambiando dentro di lui. Anche se della genesi della sua fede si sa pochissimo, il poco che ha testimoniato don Raffaele Bensi, allora parroco di San Michelino a Firenze. Le lettere pubbliche del loro carteggio sono poche, alcune in Perché mi hai chiamato? (San Paolo). Per molto tempo si è ritenuto che fossero state tutte distrutte, ma gli storici non disperano ancora di poterle ritrovare.
Dell’innesco della fede del futuro don Milani non esistono racconti di eclatanti folgorazioni: c’è solo la testimonianza di un colloquio con don Bensi. Il padre spirituale ricorda il giovane Lorenzo, nel giugno 1943, che, per non interrompere un dialogo avviato, lo accompagna a celebrare il funerale di un giovane sacerdote e in quell’occasione promette: «Io prenderò il suo posto». Comincia lì quella che don Raffaele Bensi chiama «l’indigestione di Cristo», lo studio matto e disperatissimo in cui Lorenzo si immerge per recuperare le conoscenze mancanti.
3. GLI ANNI DEL SEMINARIO
L’ingresso in seminario, nel 1943, segue di poco la conversione: pur ligissimo alle regole, anche lì Lorenzo si rivela uno studente impegnativo che non dà pace a docenti e superiori: fa domande complicate e scomode, obbedisce sempre ma non rinuncia mai ad esercitare il senso critico e non si accontenta di risposte che non siano anche profonde.
Per la famiglia la scelta di Lorenzo è un mistero: non la comprendono ma la rispettano perché capiscono che questa volta non è una bambinata. È anzi, nella sua radicalità una scelta adulta e matura che nel modo esprimersi già manifesta, in nuce, la fedeltà scabra all’essenza del Vangelo, che sarà la cifra del sacerdote don Milani: d’una coerenza e di una franchezza destinate a rivelarsi scomode per molti.
Nelle lettere alla madre Lorenzo racconta con ironia ed entusiasmo la vita del seminario: una vita, negli anni di guerra, di freddo e cibo scarso. Lorenzo minimizza le sofferenze, sapendo bene di dover contenere le preoccupazioni della madre per la salute del figlio da sempre cagionevole e soggetto a bronchiti continue, per non dire delle altre preoccupazioni legate alla sua non compresa scelta di vita: è un’incomprensione che, però, si nutre di affetto e di rispetto reciproci, tanto che Lorenzo invita i genitori alle cerimonie che segnano le tappe della sua formazione religiosa. Ma rispetta le volte in cui decidono di non partecipare. Il 13 luglio 1947 Lorenzo Milani diventa don Milani e celebra la prima Messa San Michelino.
4. SAN DONATO E LA SCUOLA POPOLARE
Dopo pochi mesi a Montespertoli, cappellano di don Bonanni, la prima “vera” destinazione del sacerdote don Milani è San Donato a Calenzano, un comune operaio in provincia di Firenze, a larghissima maggioranza comunista, dove viene mandato come cappellano dell’anziano don Pugi. È in quel contesto che nasce la scuola popolare: don Milani la fonda laica, perché nessuno se ne senta escluso a priori: capisce al volo che dal punto di vista pastorale costringere i giovani a scegliere tra il padre comunista e la scuola, sarebbe il modo di perderli senza neanche provare ad avvicinarli.
Sono gli anni delle grandi lacerazioni politiche attorno alle elezioni del 1948, della scomunica ai comunisti. Don Milani fa campagna elettorale per la Democrazia cristiana, anche se invita a tener conto nelle preferenze dei più attenti alla causa dei poveri. Ma, a contatto con la povertà e con lo sfruttamento, comincia a percepire nell’anima lo scarto tra le opportunità in cui è cresciuto e la miseria materiale e intellettuale in cui versa il popolo che gli è stato affidato e a maturare una profonda coscienza sociale. Fa scuola perché capisce che chi non ha la cultura minima per leggere un giornale o un contratto di lavoro non è in grado di difendersi dallo sfruttamento né di elaborare un pensiero critico. Si rende conto che senza la comprensione delle parole l’orizzonte della vita umana si riduce alla conquista di un piatto di minestra la sera e che anche l’ascolto della Parola rischia di diventare mera prosecuzione di riti, di cui non si comprende il significato.
Sono anche gli anni delle prime prese di posizioni pubbliche come la lettera aperta “Franco, perdonaci tutti, comunisti, industriali, preti”. Pubblicata su Adesso il quindicinale fondato da don Primo Mazzolari, con cui scambia alcune lettere: parole essenziali e molto dirette che mettono a nudo - senza perifrasi - le contraddizioni di una Chiesa non sempre schierata con i poveri nei gesti quanto vorrebbe esserlo predicando.
Cominciano a maturare le convinzioni che sfoceranno in Esperienze pastorali. Cominciano qui le incomprensioni con la gerarchia che vede nelle idee di quel cappellano più un pericolo che un invito accorato al ritorno all’essenza spoglia del Vangelo di Cristo, così efficacemente sintetizzata nel 1950 nella lettera al giovane comunista Pipetta: «Quando tu non avrai più fame né sete, ricordatene Pipetta, quel giorno io ti tradirò. Quel giorno finalmente potrò cantare l’unico grido di vittoria degno d’un sacerdote di Cristo: “Beati i... fame e sete”».
5. L’ESILIO SUL MONTE DEI GIOVI
ll Concilio Vaticano II è lontano, la Curia fiorentina “soffre” il pensiero sociale avanzato da quello che gli storici della Chiesa chiameranno “il chiostro di folli di Dio”, formatosi attorno al cardinale Elia Dalla Costa con La Pira, Balducci, Rosadoni, Barsotti, Fabbretti, Turoldo, Bensi.
La voce del giovane cappellano Milani tuona con una franchezza sconosciuta ai toni felpati della curia del tempo e il suo dialogo “con i lontani”, come si diceva allora, viene percepito come troppo aperto.
Pesano i simboli: la scuola laica che non esclude e il funerale di un giovane operaio, durante il quale in chiesa sono apparse bandiere rosse. Dalle lettere si capirà che don Milani non le condivideva e non le avrebbe volute, ma che in quella circostanza non osò buttarle fuori perché in quel contesto avrebbe significato perdere tutte in blocco le pecorelle che stava faticosamente cercando di riportare all’ovile, distruggere con un gesto tutto il lavoro fatto per sminare il clima di reciproca diffidenza tra il suo popolo e la sua Chiesa. Ma sapeva anche che all’esterno avrebbero frainteso e ne soffriva.
Quando il 12 settembre del 1954 muore il parroco di San Donato don Pugi non accade quello che le pecorelle di San Donato si attendono e cioè che don Milani venga confermato parroco al suo posto. Gli assegnano, invece, un’altra parrocchia, ma non è una delle tante. È Sant’Andrea di Barbiana, una pieve isolatissima sul monte dei Giovi in Mugello.
Barbiana non è un paesello: è una chiesetta, una povera canonica, qualche cipresso e un piccolo cimitero, sul cocuzzolo di una montagna a cinquecento metri d’altitudine: quaranta anime sparse per le case lontane. La parrocchia già destinata alla chiusura resta aperta per don Milani.
6. LA SCUOLA DI BARBIANA
Quando don Lorenzo Milani ci arriva, accompagnato dalla governante di San Donato Eda Pelagatti e dall’anziana madre di lei Giulia, il 6 dicembre del 1954, a Barbiana si sale a piedi, per una mulattiera. Quel giorno piove a dirotto: non c’è acqua corrente, né gas, né luce. Quando don Lorenzo ci arriva, Barbiana è la fine del mondo, ma scrive alla madre che non provino a distoglierlo da lì, a parlargli di un altro sradicamento dopo quello appena subito.
Il giorno dopo va in Comune a Vicchio e si compra una tomba al cimitero di Barbiana: don Milani ha 31 anni. Quello che trova è un popolo di pastori e contadini che pascola pecore e faticosamente strappa, al bosco che tutto mangia, una terra avara di frutti da dividere a metà col padrone in regime di mezzadria. Anche il parroco ha due poderi e don Milani decide subito che non chiederà ai due mezzadri che lo coltivano la metà del raccolto che gli spetterebbe.
E capisce subito che i figli di quel popolo sparso, se il pomeriggio vanno nei campi o a badar pecore, son destinati a uscire prematuramente dalla scuola di Stato senza saper né leggere né scrivere, defraudati, se non nella forma nella sostanza, del loro diritto all’istruzione e dei loro diritti successivi: scartati già da piccoli, come direbbe oggi papa Francesco, costretti a delegare in tutto, incapaci di aver voce in capitolo come persone, come cittadini, come cristiani.
La scuola di Barbiana in casa del priore o sotto il pergolato comincia con un doposcuola, che prestissimo diventa avviamento professionale e, quando sarà il momento, nel 1963, corso di recupero per la media unificata, per cui sarà preziosissimo negli ultimi anni l’aiuto di Adele Corradi, una professoressa che si farà trasferire in una scuola pubblica della zona, per dare una mano a don Milani con continuità.
La scuola di Barbiana è aderente alla vita e a tempo pienissimo: tutto è occasione di apprendimento, la fanno da padrone le parole in tante lingue, grimaldello per capire il mondo e il Vangelo. Don Milani accoglie i più diseredati, quelli senza un’alternativa, rifiutati dalle scuole ufficiali, provenienti dalle case della zona o portati dagli amici, tra loro due fratelli orfani Michele e Francuccio Gesualdi, che gli crescono in casa come figli. L’esperimento educativo di Barbiana, che arriva a mandare i ragazzi da soli all’estero a studiare le lingue, Francuccio addirittura in Algeria, mantenendosi lavorando, attira l’interesse e la curiosità di molte persone che vanno lassù a vedere e vengono messe da don Milani a insegnare ciò che sanno ai suoi ragazzi invitati a far domande a togliersi la timidezza contadina.
7. IL CASO "ESPERIENZE PASTORALI"
Sono gli anni in cui maturano gli scritti di don Milani, Esperienze pastorali esce nel 1958, ha l’imprimatur, ma fa rumore: non è un trattato di scienze pastorali, è la sintesi, dell’esperienza vissuta da don Milani. Una riflessione sociologica, razionale e senza eufemismi - statistiche alla mano - sulle condizioni delle comunità a lui affidate, sul ruolo del parroco in contesti di povertà materiale e intellettuale.
In quelle pagine don Milani prende le distanze dalle forme di intrattenimento in uso negli oratori e nelle parrocchie, indicando lo studio e non lo svago come strada maestra dell’apostolato. Lo fa con un modo di esprimersi diretto, insolito tra i sacerdoti, che risulta urticante a molti e in primis alla Curia fiorentina dell’epoca. Il libro viene ritirato, pochi mesi dopo, dal Sant’Uffizio (per ragioni di opportunità, ma non con un decreto che ne metta in questione l’ortodossia).
Una recensione, firmata da padre Angelo Perego su La Civiltà cattolica, stronca pensantissimamente il libro e, per l’autorevolezza della fonte, segna in modo determinante la storia dell’incomprensione di don Lorenzo da parte della Chiesa, incluso il patriarca Angelo Roncalli futuro Giovanni XXIII. Un motivo di sofferenza senza tregua nella vita di don Milani, che esprime le sue idee con parole che riflettono insieme la sua toscanità e la radicalità del convertito, obbedendo però sempre a ogni minimo ordine dei superiori.
8. L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’
Al di fuori della Chiesa, più che Esperienze pastorali, è - nel 1965 - la Lettera ai Cappellani militari a porre don Milani al centro del dibattito pubblico: è il testo noto come L’obbedienza non è più una virtù. Si tratta di una risposta a una presa di posizione pubblica di alcuni Cappellani militari che tacciano di “viltà” gli obiettori di coscienza.
Don Milani e i suoi ragazzi, che sulla porta della loro scuola hanno il motto “I care”, “mi importa”, “mi faccio carico”, e che stanno riflettendo insieme sul primato della coscienza, sulla necessità dell’assunzione della responsabilità del singolo nella società, rispondono con la lettera aperta che fa un grande clamore: pongono - con rigore logico - il problema morale del cristiano davanti alle armi e alla guerra e all’ordine di sparare sui civili inermi.
L’obiezione di coscienza e il pacifismo non sono ancora un fatto acquisito per la Chiesa e nemmeno lo Stato ha ancora accettato come legale l’obiezione di coscienza al servizio militare: chi si sottrae alla leva obbligatoria finisce in carcere. A complicare a don Milani le cose con la Chiesa c’è il fatto che la lettera, spedita a tutti i giornali anche cattolici, viene pubblicata soltanto da Rinascita. Ma non tutti nel mondo cattolico hanno chiaro che non è stata una scelta del priore pubblicare su un giornale comunista. A complicargliele con lo Stato c’è la legge: Don Milani e Luca Pavolini, direttore di Rinascita, subiscono insieme un processo per istigazione a delinquere. Mentre il dibattito sull’obiezione di coscienza esplode e divide.
Don Milani al processo non partecipa, non nomina un avvocato ma si lascia difendere dall’avvocato d’ufficio Alfonso Gatti. E’già molto malato, un linfoma di Hodgkin gli ha già decretato vita breve, si difende al processo con una memoria difensiva: nota come Lettera ai giudici. Il primo grado si conclude con l’assoluzione di entrambi.
9. LETTERA A UNA PROFESSORESSA
Un altro episodio, la bocciatura di due ragazzi di Barbiana all’esame d’ammissione alle scuole magistrali, innesca l’ultimo scritto: Lettera a una professoressa, una spietata, provocatoria, disamina sulla scuola pubblica dell’obbligo di quegli anni, incapace di colmare, secondo Costituzione, gli svantaggi iniziali di chi nasce in una casa povera di cultura e di denari.
Possibile, si chiede don Milani, che il Padreterno faccia nascere gli asini e gli svogliati solo nelle case dei poveri? La lettera è scritta con l’innovativo metodo della scrittura collettiva insieme ai ragazzi e va alle stampe, con una corsa contro il tempo, nell’aprile del 1967: don Milani è alle ultime settimane di vita, continua a soffrire anche per l’incomprensione della Chiesa, che il suo vescovo non smette di manifestargli. Il testo di Lettera a una professoressa avrà vita propria dopo la morte del Priore: molto citato, poco letto, il più delle volte misconosciuto, diverrà ne mesi successivi icona della contestazione studentesca. Accanto agli entusiasmi non mancano strumentalizzazioni e fraintendimenti che, insieme ad altri successivi, spiegano l’accusa postuma a don Milani, ripetutamente tacciato, fino all’oggi, di essere stato - tramite la Lettera avulsa dal suo contesto - l’ispiratore dei guasti (veri o presunti) dell’istruzione contemporanea.
10. IL TESTAMENTO
Don Lorenzo Milani muore a 44 anni il 26 giugno del 1967 in via Masaccio a casa della madre dove ha trascorso gli ultimi mesi di vita, senza ricevere l’abbraccio del suo vescovo Ermenegildo Florit che non ha mai compreso l’urgenza evangelica sottesa ai suoi comportamenti. Il processo di appello condannerà Pavolini, mentre per don Milani la morte ha estinto il reato. Ai suoi ragazzi lascia un testamento che si conclude così: «Caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non è vero che non ho debiti verso di voi. L’ho scritto per dar forza al discorso! Ho voluto più bene a voi che a Dio. Ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto. Un abbraccio, vostro Lorenzo». Nel 2014 Papa Francesco rimuove il provvedimento emesso nel 1958 dal Sant’uffizio su Esperienze pastorali. Il 20 giugno 2017 Francesco è il primo papa della storia a pregare a Barbiana sulla tomba di don Lorenzo Milani e nelle parole pronunciate quel giorno accoglie, definitivamente, come «un bravo prete da cui prendere esempio», il Priore di Barbiana nell’alveo della Chiesa. Ora possiamo dire che don Milani aveva ragione, quando diceva: «Fra cinquant’anni mi capiranno. E’ andata così, alla lettera».
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e -- Papa Francesco: «Pregate perché io prenda esempio da don Milani» (di Elisa Chiari).20 giugno 2017, di Federico La Sala
L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
- Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani
Papa Francesco: «Pregate perché io prenda esempio da don Milani»
Nelle parole del Papa l’abbraccio della Chiesa che don Lorenzo Milani ha desiderato fino alla morte, il riconoscimento del suo essere sacerdote, non solo maestro non solo pacifista. Un fatto storico, ecco perché
di Elisa Chiari *
«Pregate per me perché anche io sappia prendere esempio da questo bravo prete». Quel bravo prete è don Lorenzo Milani e più chiaro e diretto di così Papa Francesco non avrebbe potuto essere. Non c’era questa frase nel discorso preparato, non c’era la frase finale rivolta ai sacerdoti: "Prendete la fiaccola e portatela avanti». Le ha aggiunte a braccio.
Don Milani aveva ragione, quando nel suo tono sempre un po’ provocatorio diceva: «Mi capiranno tra 50 anni». Forse faceva un numero, per dirla con parole sue, «per dar forza al discorso». Ma la contingenza della storia ha voluto che fosse una cifra esatta, che servissero davvero 50 anni - don Milani è morto il 26 giugno del 1967 - perché un papa venisse quassù, a Barbiana - una Barbiana restaurata con la vasca azzurra come allora non era-, al margine del margine del mondo, nella parrocchia che doveva chiudere e che fu tenuta aperta per isolare un sacerdote che allora si diceva "scomodo" e che oggi papa Francesco dice «ha lasciato una traccia luminosa».
Per molto tempo, don Lorenzo Milani è stato raccontato come l’educatore, il maestro, l’obiettore di coscienza - non senza distorsioni e strumentalizzazioni da parti assortite -: quasi che fosse marginale nella sua presenza storica il suo essere prete. Lo si è raccontato lasciando nell’ombra il lato che a don Milani premeva di più, perché fondava il senso della sua esistenza cristiana: il riconoscimento del suo sacerdozio da parte della Chiesa.
Cinquant’anni dopo Papa Francesco sana, dichiarandolo esplicitamente, questa mancanza. Mette il punto più importante alla fine, Papa Francesco, quasi per lasciarne il significato scolpito - come a segnare un passaggio che chi studierà il rapporto tra don Lorenzo Milani e la Chiesa di qui in poi non potrà ignorare -: «Non posso tacere che il gesto che ho oggi compiuto vuole essere una risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale. In una lettera al Vescovo scrisse: "Se lei non mi onora oggi con un qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato...". Dal Cardinale Silvano Piovanelli, di cara memoria, in poi gli Arcivescovi di Firenze hanno in diverse occasioni dato questo riconoscimento a don Lorenzo. Oggi lo fa il Vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di don Milani - non si tratta di cancellare la storia o di negarla, bensì di comprenderne circostanze e umanità in gioco -, ma dice che la Chiesa riconosce in quella vita un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa. Con la mia presenza a Barbiana, con la preghiera sulla tomba di don Lorenzo Milani penso di dare risposta a quanto auspicava sua madre: "Mi preme soprattutto che si conosca il prete, che si sappia la verità, che si renda onore alla Chiesa anche per quello che lui è stato nella Chiesa e che la Chiesa renda onore a lui... quella Chiesa che lo ha fatto tanto soffrire ma che gli ha dato il sacerdozio, e la forza di quella fede che resta, per me, il mistero più profondo di mio figlio... Se non si comprenderà realmente il sacerdote che don Lorenzo è stato, difficilmente si potrà capire di lui anche tutto il resto"».
Non per caso nelle parole del Papa emerge più di tutto il don Milani sacerdote: le definizioni che dà di don Milani lungo tutto lo snodo del discorso non sono scelte a caso. «Sono venuto a Barbiana» esordisce papa Francesco «per rendere omaggio alla memoria di un sacerdote che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo si incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve». Agli allievi dice: «Voi siete i testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione, nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato, con piena fedeltà al Vangelo e proprio per questo con piena fedeltà a ciascuno di voi, che il Signore gli aveva affidato». E ancora: «La scuola, per don Lorenzo, non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo concreto con cui svolgere quella missione, dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo. Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro, e alla piena appartenenza alla Chiesa, con una fede consapevole».
Papa Francesco sottolinea l’attualità di don Milani: «Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi, in cui solo possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti e spesso confusi messaggi che ci piovono addosso». Il papa parla esplicitamente di "umanizzazione", facendo riferimento a un concetto milaniano: la parola ai poveri non per farli diventare più ricchi, ma per farli diventare più uomini. Non per caso c’è più di Esperienze pastorali sotteso al discorso di don Milani a Barbiana di quanto non ci sia di Lettera a una professoressa. La cita, certo, quando parla agli educatori: ma al centro c’è il sacerdote non il maestro. «La vostra è una missione piena di ostacoli ma anche di gioie. Ma soprattutto è una missione. (...) Questo è un appello alla responsabilità. Un appello che riguarda voi, cari giovani, ma prima di tutto noi, adulti, chiamati a vivere la libertà di coscienza in modo autentico, come ricerca del vero, del bello e del bene, pronti a pagare il prezzo che ciò comporta. E questo senza compromessi».
Ai sacerdoti papa Francesco ricorda che «la dimensione sacerdotale di don Lorenzo Milani è alla radice di tutto quanto sono andato rievocando finora di lui. Tutto nasce dal suo essere prete. Ma, a sua volta, il suo essere prete ha una radice ancora più profonda: la sua fede. Una fede totalizzante, che diventa un donarsi completamente al Signore e che nel ministero sacerdotale trova la forma piena e compiuta per il giovane convertito. Sono note le parole della sua guida spirituale, don Raffaele Bensi, al quale hanno attinto in quegli anni le figure più alte del cattolicesimo fiorentino, così vivo attorno alla metà del secolo scorso, sotto il paterno ministero del venerabile Cardinale Elia Dalla Costa. Così ha detto don Bensi: "Per salvare l’anima venne da me. Da quel giorno d’agosto fino all’autunno, si ingozzò letteralmente di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì subito per l’assoluto, senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad ogni costo. Trasparente e duro come un diamante, doveva subito ferirsi e ferire". Essere prete come il modo in cui vivere l’Assoluto. Diceva sua madre Alice: "Mio figlio era in cerca dell’Assoluto. Lo ha trovato nella religione e nella vocazione sacerdotale". Senza questa sete di Assoluto si può essere dei buoni funzionari del sacro, ma non si può essere preti, preti veri, capaci di diventare servitori di Cristo nei fratelli". Don Lorenzo ci insegna anche a voler bene alla Chiesa, come le volle bene lui, con la schiettezza e la verità che possono creare anche tensioni, ma mai fratture, abbandoni».
E ancora: «La Chiesa che don Milani ha mostrato al mondo ha questo volto materno e premuroso, proteso a dare a tutti la possibilità di incontrare Dio e quindi dare consistenza alla propria persona in tutta la sua dignità».
Quelle ultime parole: «prendete e portate la fiaccola» sono l’abbraccio che don Lorenzo Milani ha desiderato una vita. Chi stava ascoltando sulle seggiole bianche di Barbiana lo sapeva, per aver vissuto con lui il dolore dell’incomprensione, e non per caso ha applaudito proprio i passaggi in cui ha sentito il riconoscimento atteso dal Priore per mezzo secolo.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". - L’inquietudine di don Milani era amore (Papa Francesco).23 aprile 2017, di Federico La Sala
Videomessaggio di Papa Francesco, l’inquietudine di don Milani era amore
Pontefice rivolto alla Fiera dell’editoria, combatteva per la dignità del suo gregge
di Redazione *
ROMA. L’inquietudine di don Lorenzo Milani "non era frutto di ribellione ma di amore e di tenerezza per i suoi ragazzi, per quello che era il suo gregge, per il quale soffriva e combatteva, per donargli la dignità che, talvolta, veniva negata". Lo ha detto Papa Francesco in un videomessaggio per la presentazione dell’opera omnia del sacerdote alla Fiera dell’editoria. "Tutti abbiamo letto le tante opere di questo sacerdote toscano, morto ad appena 44 anni, e ricordiamo con particolare affetto la sua ’Lettera ad una professoressa’, scritta insieme con i suoi ragazzi della scuola di Barbiana".
"Come educatore ed insegnante - ha aggiunto il Papa - egli ha indubbiamente praticato percorsi originali, talvolta, forse, troppo avanzati e difficili da comprendere". "La sua era un’inquietudine spirituale - ha concluso il Papa - alimentata dall’amore per Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola che sognava sempre più come ’un ospedale da campo’ per soccorrere i feriti, per recuperare gli emarginati".
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e -- La lettera di Michele Gesualdi che ha convinto il Papa ad andare a Barbiana.20 giugno 2017, di Federico La Sala
Ecco la lettera che ha convinto il Papa ad andare a Barbiana
La lettera di Michele Gesualdi che ha convinto il Papa. Il suo libro questa settimana con Famiglia Cristiana e Credere *
di Famiglia Cristiana *
- Il 20 giugno papa Francesco si recherà in pellegrinaggio a Bozzolo e Barbiana per pregare sulle tombe di don Mazzolari e don Milani. Una decisione inaspettata e profetica, ma con un retroscena di cui sono stato testimone in prima persona.
 Il 2 dicembre 2016, all’indomani della mia nomina a direttore di Famiglia Cristiana, per una bella coincidenza sono stato ricevuto in udienza da papa Francesco. L’occasione era la consegna delle cartoline di auguri mandate dai lettori per il suo compleanno.
Il 2 dicembre 2016, all’indomani della mia nomina a direttore di Famiglia Cristiana, per una bella coincidenza sono stato ricevuto in udienza da papa Francesco. L’occasione era la consegna delle cartoline di auguri mandate dai lettori per il suo compleanno.
 Nella nostra delegazione c’era anche il direttore editoriale del Gruppo San Paolo, don Simone Bruno, che ha donato al Pontefice il libro di Michele Gesualdi Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana. Vedendo la copertina Francesco ha esclamato: «Oh, don Milani!». Sapeva bene chi era il priore di Barbiana e lo apprezzava. All’interno del volume c’era una busta. «È una lettera», ha spiegato don Simone, «che l’autore, uno dei primi ragazzi di don Milani, ha voluto che le consegnassi personalmente». Francesco fece un segno inequivocabile al suo segretario, per far arrivare il libro e la lettera direttamente sulla sua scrivania.
Nella nostra delegazione c’era anche il direttore editoriale del Gruppo San Paolo, don Simone Bruno, che ha donato al Pontefice il libro di Michele Gesualdi Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana. Vedendo la copertina Francesco ha esclamato: «Oh, don Milani!». Sapeva bene chi era il priore di Barbiana e lo apprezzava. All’interno del volume c’era una busta. «È una lettera», ha spiegato don Simone, «che l’autore, uno dei primi ragazzi di don Milani, ha voluto che le consegnassi personalmente». Francesco fece un segno inequivocabile al suo segretario, per far arrivare il libro e la lettera direttamente sulla sua scrivania.
 Il testo integrale della lettera lo trovate pubblicato per la prima volta qui sotto. Le parole di Michele Gesualdi sono semplici e commoventi. E si concludono con l’invito ad andare a Barbiana: «Una sua visita, con il suo stile semplice e affascinante, in quella periferia da dove quella povera tomba e quella anomala scuola ci richiamano la radicalità del Vangelo che spinge a camminare sulla retta via, sarebbe un gran dono agli ultimi degli ultimi».
Il testo integrale della lettera lo trovate pubblicato per la prima volta qui sotto. Le parole di Michele Gesualdi sono semplici e commoventi. E si concludono con l’invito ad andare a Barbiana: «Una sua visita, con il suo stile semplice e affascinante, in quella periferia da dove quella povera tomba e quella anomala scuola ci richiamano la radicalità del Vangelo che spinge a camminare sulla retta via, sarebbe un gran dono agli ultimi degli ultimi».
 Francesco ha accolto l’invito ed è una gioia per noi esserne stati il tramite. Davvero un dono grande, destinato “agli ultimi degli ultimi”.
Francesco ha accolto l’invito ed è una gioia per noi esserne stati il tramite. Davvero un dono grande, destinato “agli ultimi degli ultimi”.
LA LETTERA DI MICHELE GESUALDI
Caro papa Francesco,
mi è gradito di farLe dono di questo mio ultimo lavoro su don Lorenzo. Ho scritto questo semplice libro per far conoscere ai ragazzi di oggi un grande prete-maestro innamorato di Gesù e della sua Chiesa. Il Gesù che ha incontrato nella trincea della povertà più profonda di Barbiana. Era insieme a quei poveri contadini con la loro stessa faccia denutrita e le mani callose dalla fatica. Con loro ha sofferto, gioito, vissuto la povertà vera, ogni giorno, senza sconti. A loro ha dedicato il suo sapere e il suo apostolato.
La miseria della profonda periferia di Barbiana ha donato a don Lorenzo occhi, orecchie, bocca e cuore nuovo che ne han fatto un uomo diverso: povero tra i poveri rimasto per sempre, nella vita e nella morte, priore di quel niente di Barbiana, che l’amore ha fatto divenire consistenza e parola capace di parlare a tanti cuori e altrettante coscienze, molto lontano. Era Amore con la a maiuscola, incondizionato.
A noi si è dedicato come solo un maestro, fratello, padre sa fare. Ed educato a stare con la classe degli ultimi, a non dimenticarci della umanità bisognosa, a tenere a bada il nostro egoismo e a studiare con e per gli altri, «perché non si tratta di produrre una nuova classe dirigente, ma una massa cosciente», diceva.
Una sua visita, con il suo stile semplice e affascinante, in quella periferia da dove quella povera tomba e quella anomala scuola ci richiamano la radicalità del Vangelo che spinge a camminare sulla retta via, sarebbe un gran dono agli ultimi degli ultimi. Barbiana è ancora oggi un luogo fatto di nulla, in cui salire in punta di piedi a pensare, pregare e ascoltare quel profondo silenzio che scuote.
Con sincero affetto filiale e stima profondissima,
Michele Gesualdi
- Il 20 giugno papa Francesco si recherà in pellegrinaggio a Bozzolo e Barbiana per pregare sulle tombe di don Mazzolari e don Milani. Una decisione inaspettata e profetica, ma con un retroscena di cui sono stato testimone in prima persona.
-
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". -- il problema di fondo di ogni vera scuola (di Vanessa Roghi, storica))17 aprile 2017, di Federico La Sala
La scuola buona, a cinquant’anni da Lettera a una professoressa
Vanessa Roghi, storica (Internazionale, 16.04.2017)
- A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni vera scuola. E siamo giunti, io penso, alla chiave di questo processo perché io maestro sono accusato di apologia di reato cioè di scuola cattiva. -Bisognerà dunque accordarci su ciò che è scuola buona. La scuola è diversa dall’aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi.
 Don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici
Don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici
Nel maggio del 1967 esce per la piccola casa editrice fiorentina LEF un libro dal titolo Lettera a una professoressa. L’hanno scritto don Lorenzo Milani e gli alunni della scuola di Barbiana, una canonica del Mugello a pochi chilometri da Firenze. Un luogo sperduto dell’Appennino, afflitto, ancora negli anni del miracolo economico, dalla miseria e dall’arretratezza. Un luogo di esilio dove don Milani è arrivato il 7 dicembre del 1954, a 31 anni. Niente acqua, né luce, né una strada per arrivarci. Ci vivevano quaranta anime.
Eppure in pochi anni, grazie a questo prete, Barbiana diventa un luogo conosciuto da tutti, e non solo in Italia. Nasce lì, nel 1958, Esperienze pastorali, visto da molti come concreto e profetico contributo al Concilio Vaticano II, immediatamente messo all’indice dalla curia romana che, pur non vietandolo ufficialmente, ne impedisce la pubblicazione. Da Barbiana, nel 1965, parte un invito alla disobbedienza rivolto ai parroci militari. Un testo, pubblicato dal periodico comunista Rinascita e ricordato come L’obbedienza non è più una virtù, che porterà in tribunale don Milani e gli causerà addirittura una condanna dopo la morte.
E sempre a Barbiana nasce il testo più noto di don Milani e della sua scuola, Lettera a una professoressa, autentico livre de chevet di una generazione. “Libretto rosso” del movimento del sessantotto italiano, vademecum di ogni insegnante democratico per anni. Visto oggi come anello centrale di una riflessione sulla necessità di riformare il sistema educativo, che sfocerà nelle grandi battaglie per la scuola degli anni settanta. Ma visto, anche, come l’inizio della fine di tutto: dell’autorità degli insegnanti, della voglia di studiare dei ragazzi, dello stare in disparte dei genitori, come l’inizio, insomma, del “donmilanismo”.
“Noi abbiamo costruito negli anni, grazie anche alle idee di don Milani, una scuola che non insegna più nozioni”, ha scritto Paola Mastrocola. E in un articolo di Sebastiano Vassalli si può leggere: “La mitica scuola di Barbiana (...) era in realtà una sorta di pre-scuola (o di dopo-scuola) parrocchiale, dove un prete di buona volontà aiutava come poteva i figli dei contadini a conseguire un titolo di studio, e se non ci riusciva, incolpava i ricchi”.
Un invito a organizzarsi
Lettera a una professoressa è dunque diventato un libro manifesto, ma non nel modo auspicato dai suoi autori. Eppure il libro è cristallino: non è, né vuole essere, un testo scritto per i ragazzi che vanno all’università, né per i loro genitori, ma per i genitori di chi, all’università, non ci arriverà mai. La lettera è un invito a organizzarsi. Perché la scuola pubblica, così come l’hanno conosciuta i ragazzi di Barbiana e non solo, è una scuola per ricchi, per i “Pierini d’Italia”. La riforma delle scuole medie del 1963 non aveva modificato questa situazione. La scuola di don Milani è una denuncia nei confronti di governi cattolici che per tutto il dopoguerra hanno occupato il ministero della pubblica istruzione (6 ministri laici su 34).
Don Milani sa bene che il suo non è un progetto di riforma ma una testimonianza, scritta in prima persona plurale, con un noi che ha nomi e cognomi. “So che a voi studenti queste parole fanno rabbia”, scrive alla giovane Nadia Neri in una delle sue lettere più belle, “che vorreste ch’io fossi un uomo pubblico a disposizione di tutti, ma forse è proprio qui la risposta alla domanda che mi fai. Non si può amare tutti gli uomini. Si può amare una classe sola (e questo l’hai capito anche te). Ma non si può nemmeno amare tutta una classe sociale se non potenzialmente. Di fatto si può amare solo un numero di persone limitato, forse qualche decina forse qualche centinaio”. E ancora:
- La scuola non può essere che aconfessionale e non può essere fatta che da un cattolico e non può esser fatta che per amore (cioè non dallo Stato). In altre parole la scuola come la vorrei io non esisterà mai altro che in qualche minuscola parrocchietta di montagna oppure nel piccolo di una famiglia dove il babbo e la mamma fanno scuola ai loro bambini.
Il suo, dunque, non è neppure un modello da imitare, come in molti ancora oggi pensano. Eppure, nella sua esemplare essenzialità, questo piccolo esperimento pedagogico che si traduce in una scuoletta di montagna e nella pubblicazione di un libro, poco più di un opuscolo, diventa la scintilla di una rivoluzione. E ancora oggi mobilita il ricordo, innesca passioni, divide e fa litigare, si fissa nella memoria collettiva come un punto di passaggio epocale quando si parla di scuola ma anche di giovani, generazioni, movimenti.
Questo perché fin da pochi mesi dopo la sua pubblicazione il libro acquista una vita completamente autonoma, Lettera a una professoressa è, infatti, il risultato di anni di lavoro e riflessione sulle storture del sistema scolastico italiano e per questo è un libro degli anni sessanta, ma si pone anche l’obiettivo di dire basta con questo ritardo nell’adempimento del dettato costituzionale che vorrebbe il diritto allo studio uguale per tutti. Per questo viene subito adottato dal movimento studentesco.
Su Lettera a una professoressa si fanno seminari in tutte le università occupate; alla Biennale di Venezia del 1968 diventa uno spettacolo teatrale contro l’autoritarismo. Gli insegnanti lo usano per sperimentare nuove forme di didattica; a Roma, all’acquedotto Claudio, don Sardelli fonda una scuola popolare ispirata all’esperienza di Barbiana. Viene definito un libro maoista. Gianni Rodari e il Movimento di cooperazione educativa gli dedicano scritti e riflessioni. Tutti coloro che hanno a cuore il problema dell’educazione si confrontano con Lettera a una professoressa.
Il ruolo di maestre e maestri
In molti dimenticano che il libro riguarda la scuola dell’obbligo e non il liceo o l’università. La questione dell’obbligo scolastico è più di ogni altra la cartina di tornasole di ogni sistema che voglia dirsi democratico. A fine anni sessanta è ampiamente disattesa, dalle famiglie ma anche dallo stato che consente un doppio binario scolastico, per chi ha tutte le parole a casa, può fare ripetizioni, e chi non può. Lettera a una professoressa diventa il vademecum dei primi, ma per fortuna ha ricadute importantissime anche sulla vita dei secondi.
Questo grazie alle maestre e ai maestri che trasformano la scuola primaria italiana, e grazie ai linguisti che colgono l’originalità radicale dell’esperienza di Barbiana: il cuore della lettera e di tutto l’insegnamento di don Milani non sta nel non bocciare, o nel disobbedire, quanto nel ben più impegnativo dare tutti gli usi della parola a tutti. La lingua non è mai statica, né unica né definita o definibile una volta e per sempre: strati e stati si accavallano e convivono; quando uno di essi vince (quando cioè l’innovazione da eterodossa viene accolta come ortodossa), i puristi si sforzano di conservarlo, i grammatici di descriverlo, i maestri di insegnarlo.
Lettera a una professoressa va oltre tutto questo perché coniuga la questione della lingua, che è questione antica, ai cambiamenti della società postindustriale nella quale un analfabeta, come dice un vecchio contadino alla Rai degli anni sessanta, “è cieco”. “La scuola siede tra il passato e il futuro”, scrive don Lorenzo Milani, “e deve averli presenti entrambi”.
continuazione nel post succesivo
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". -- il problema di fondo di ogni vera scuola (di Vanessa Roghi, storica))17 aprile 2017, di Federico La Sala
- CONTINUAZIONE E FINE.
Scrive Oronzo Parlangeli, filologo, nel lontano 1969:
- È colpevole e stupida l’omertà di chi fa dipendere la propria fama dalla percentuale, o dalla massa, dei promossi e non invece dal livello della preparazione dei promossi. Coloro i quali bocciano solo per il gusto di bocciare sono criminali pericolosi e sadici, ma altrettanto pericolosi sono coloro i quali (o per far carriera o per pecoronismo gerarchico o per smania di passar per novatores) promuovono tutti e pretendono che tutti siano promossi: anche per costoro dovrebbe esserci un’azione penale o il manicomio.
Eppure i ragazzi della scuola di Barbiana hanno scritto:
- Gli onorevoli costituenti credevano che si patisse tutti la voglia di cucir budella o di scrivere ingegnere sulla carta intestata (...) Tentiamo invece di educare i ragazzi a più ambizione. Diventare sovrani! Altro che medico o ingegnere”. Il fatto, continua il filologo, è che abbiamo confuso il sacrosanto diritto allo studio con lo stupido diritto alla laurea. Persino la rivolta degli studenti che era e dovrebbe essere generosa contestazione giovanile contro le ipocrisie e i vaniloqui, rischia di adulterarsi o si è già adulterata in uguali ipocrisie e vaniloqui (anche se di segno contrario) e in una perniciosa ricerca del diciotto, quale... minimo sindacale garantito. E i riformatori politici, che già tremavano sotto l’impeto della violenta, ma sacrosanta protesta di chi non è integrato nel sistema (e perciò dice ciò che pensa), ebbene, possono tornare a baloccarsi con esiziali alchimie partitocratiche.
Amen. Bastano queste poche righe per raccontare l’impatto del libro, i suoi fraintendimenti, lo svuotamento dell’aspetto più radicale del suo messaggio, la strumentale sovrapposizione delle sue tesi con quelle di una parte del movimento studentesco. Oggi la sua rilettura viene fatta in nome dell’antisessantottismo e assume una funzione antidemocratica. I primi a mettere in discussione l’utilità della lettera sono stati proprio i professori “democratici” che l’hanno letta e usata per anni: letta, usata e non capita. Nel 1978 un articolo sul Manifesto pone il problema: come comportarsi con i ragazzi del 1977? Bisogna bocciarli. Quindi don Milani aveva torto...
Consapevole di queste strumentalizzazioni, nel 1982 padre Ernesto Balducci si chiede: “Ha ancora un senso riproporre all’attenzione pubblica Lorenzo Milani?”. E ancora: “Il limite di fondo della proposta milaniana è oggi più visibile: non è possibile chiedere alla scuola-istituzione quel che invece può offrire una scuola spontanea animata da un maestro ‘carismatico’. In quanto è un servizio reso a tutti i cittadini, secondo le regole oggettive dello stato di diritto, la scuola di stato non può essere progettata facendo affidamento sulla eventualità della ricchezza soggettiva degli educatori”.
Ma, aggiunge, la contrapposizione fittizia creatasi tra l’umanità della scuola di Barbiana e la disumanità della scuola istituzionale è una balla, la riforma del 1974 risponde proprio all’idea milaniana che la scuola debba essere l’espressione della comunità civile in tutte le sue componenti, un invito ai genitori a organizzarsi, appunto, dentro la scuola pubblica: “Ecco perché la scuola di Barbiana, se vezzeggiata come un modello ideale, può favorire inerzie utopistiche o fughe nel privato. Essa non è un modello, è un messaggio, e il messaggio non si imita mai, è sempre un appello a nuove creazioni”.
Giovanni Miccoli, scomparso da poco e tra i più efficaci interpreti del priore di Barbiana, ha scritto:
- Parlare o scrivere di don Milani è estremamente difficile. C’è il pericolo di appiattirne l’immagine, di semplificarne i contorni, assimilandolo frettolosamente all’una o all’altra delle grandi contrapposizioni che segnavano allora, e in parte segnano ancora oggi, la società italiana.
Appiattirne l’immagine, semplificarne i contorni per ridurlo a fenomeno comprensibile, catalogabile, replicabile. Come poi, puntualmente, è stato fatto, e continua ad essere fatto.
Viene in mente, pensando a don Lorenzo Milani, quanto scriveva Alberto Arbasino su Pier Paolo Pasolini in un articolo pubblicato su Il Giorno nel 1964: “Una larga sezione della nostra cultura gli ha deferito questo incarico, di rischiare a nome di tutti: perché è vero che chi scandalizza i puri di cuore va sacrificato a nome della collettività (che è rimasta a casa a godere a soffrire)”. Don Milani rischia davvero a nome di tutti. La sua stessa vita viene sacrificata sull’altare dello scandalo quando scrive Esperienze pastorali, in anni nei quali ai parroci è chiesto soltanto di leggere commenti alla scrittura, riassunti del catechismo e poi via a dir messa in latino.
Lui, invece, sceglie la parola, la lettura, insegna a vagliare, criticare, stabilire confronti, a scegliere la fonte, il documento. Al fine di sentirsi ognuno responsabile di tutto, come è scritto nella Lettera ai giudici:
- Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all’ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande I care. E il motto intraducibile dei giovani americani migliori. ‘Me ne importa, mi sta a cuore’. E il contrario esatto del motto fascista ‘Me ne frego’.
Viene in mente, pensando a Lorenzo Milani, quello che scrive Alex Langer di Ivan Illich: “Qualcuno ne rimane deluso e lo trova ‘poco organico’, altri ne ricavano spunti decisivi per orientare la propria visione del mondo”. E allora il tentativo di renderlo sistematico, comprensibile, di decifrarlo, e farlo diventare di volta in volta un marxista in nuce, un proto sessantottino, la voce profetica della rivolta, ma anche appunto l’istigatore di risentimento sociale, l’invidioso, lo sciatto. L’icona, il martire, il folle, il presuntuoso, il più grande intellettuale italiano del novecento. Che fatica.
A don Milani invece dobbiamo molto, moltissimo, in termini di categorie analitiche, negli anni della “buona scuola”, del ritorno alla bocciatura, della farsa dei crediti formativi, della selezione non più di classe ma altrettanto spietata tra vincenti e perdenti (oggi si chiama meritocrazia), in termini di contributo alla riflessione, di contestualizzazione storica di fenomeni che appaiono immutabili.
Nessuna nostalgia
Tornare a don Milani, a Lettera a una professoressa e ai ragazzi di Barbiana ha un senso niente affatto nostalgico. Ben poco di affascinante c’è nella figura di un prete, burbero e autoritario, borghese e anti intellettuale, profondamente critico nei confronti della scuola pubblica. Ma non si tratta di questo. Nessuno oggi vuole fare l’errore di chi salì a Barbiana nel 1967 con la Lettera ai giudici in una mano e Herbert Marcuse nell’altra, sperando di trovare un guru, inventandosi di averlo trovato. Scoprendo in Lettera a una professoressa il viatico per la rivoluzione.
Bisogna rileggere Lettera a una professoressa a partire dalle proprie domande e dalle proprie esperienze, inserendola però all’interno di un contesto troppo spesso messo in ombra, da una lettura miope della figura di don Milani, essendo la sua eredità assolutamente non mediata dalla sua voce, ma solo da quella dei suoi eredi. Don Milani è morto infatti a 44 anni nel giugno del 1967, un mese dopo l’uscita del volume, alla fine di una lunga e dolorosissima malattia.
Si tratta, come suggerisce don Luis Corzo, di riprendere in mano Lettera a una professoressa e collocarla nel tempo, e poi rileggerla partendo dalla propria esperienza personale: “Far ricorso alla propria esperienza leggendo la sua, avvicinarsi a essa con le risposte e le domande che già ci incombono dentro, decisi a confrontare con lui le nostre ragioni più autentiche e profonde, quelle che cerchiamo in lui. Tali ragioni non sono né idee né consegne intransigenti, ma crivelli, filtri per l’azione, punti di vista e, in definitiva, libere opzioni”.
Crivelli, filtri per l’azione, punti di vista e, in definitiva, libere opzioni. Come ha scritto Gianni Rodari: “Tutti gli usi della parola a tutti. Mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”.
- A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni vera scuola. E siamo giunti, io penso, alla chiave di questo processo perché io maestro sono accusato di apologia di reato cioè di scuola cattiva. -Bisognerà dunque accordarci su ciò che è scuola buona. La scuola è diversa dall’aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa" - Tra i banchi delle nuove scuole che seguono le tracce di don Milani (di Valentina Pigmei).11 marzo 2017, di Federico La Sala
reportage
Tra i banchi delle nuove scuole che seguono le tracce di don Milani
di Valentina Pigmei, giornalista *
Ho deciso di festeggiare i 50 anni della pubblicazione di Lettera a una professoressa andando a visitare alcune scuole. Scuole, a volte soltanto virtuali, dove si fa ciò che sarebbe piaciuto al burbero priore di Barbiana: scuole un po’ strane, né pubbliche né private, scuole senza voti né bocciature, dove s’insegna a tutti, ricchi e poveri, italiani e immigrati, non “un ospedale che cura i sani e rifiuta i malati”, per usare le famose parole di don Milani.
Scuole dove chiunque ha lo stesso diritto all’eccellenza, proprio perché s’insegna là dove sembra impossibile farlo: si fanno corsi di scrittura creativa a ragazzi che non hanno mai letto un libro, s’insegna italiano a migranti che sono spesso analfabeti nella loro lingua madre, s’insegna filosofia ai bambini delle elementari. Ma chi sono oggi i ragazzi di Barbiana? Non è facile rispondere. Sono gli immigrati? I ragazzi delle periferie? I carcerati?
Nuove povertà e nuove parole
Fondata a Roma dallo scrittore Eraldo Affinati insieme alla moglie Anna Luce Lenzi, la Penny Wirton è una scuola non profit dove i migranti possono imparare gratuitamente la lingua italiana. È una scuola aperta a tutti, con 22 sedi sparse per l’Italia.
Affinati, che insegna da 30 anni in un istituto professionale, non ha dubbi: “L’ultima foto di don Milani è un’immagine di lui con un bambino africano in braccio. Si parte da lì. Oggi i ragazzi di Barbiana sono quelli che arrivano dalla Nigeria, dalla Siria, dall’Afghanistan”. Affinati, autore di L’uomo del futuro, un libro straordinario che ripercorre la vita del priore, mi spiega che per don Lorenzo “la povertà non è solo quella economica, è la mancanza delle parole indispensabili per sciogliere i nodi dell’esistenza. Chi non sa esprimersi, non sa pensare”.
Se così è, allora temo che il problema sia più trasversale. Forse i ragazzi di Barbiana sono un po’ dappertutto: sono gli studenti delle periferie, quelli che abbandonano la scuola, quelli che non hanno nemmeno un libro in casa.
A questi ragazzi, e non solo, si rivolge il Centro formazione supereroi di Milano, una neonata associazione non profit, fondata da due editor di lunga esperienza e grande simpatia umana, Edoardo Brugnatelli e Giuseppe Strazzeri. Aiutati da 40 volontari tra scrittori, grafici, poeti, hanno cominciato a fare laboratori di scrittura creativa nelle scuole di Milano, dalla quinta elementare fino alle superiori.
Il progetto è quello di avere presto una sede a Milano, possibilmente in una zona periferica, dove poter accogliere i ragazzi dopo la scuola. Non sono certo i primi a farlo, negli Stati Uniti lo scrittore Dave Eggers (che è peraltro amico dei due milanesi) ha fondato nel 2002 826 Valencia, una scuola con simili intenti, che oggi ha sette sedi in altrettante città statunitensi e una versione inglese fondata da Nick Hornby. Progetti simili in Italia sono Il porto delle storie in provincia di Firenze e La grande fabbrica delle parole, sempre a Milano.
Qualche settimana fa mi sono faticosamente mimetizzata tra i banchi della classe prima H del liceo Besta di Milano (zona Cimiano) e ho assistito alla prima parte del laboratorio del Centro formazione supereroi. I ragazzi attorno a me avevano quella timidezza e quegli sguardi vacui tipici della loro età. Del resto, per loro il termine “scrittura creativa” è un concetto astruso e poco interessante. Brugnatelli ha captato subito la loro benevolenza chiedendo se per caso sapessero chi ha distrutto l’impero romano. “Non ci sono voti, né note sul registro”, li rassicura. Qualcuno borbotta, qualcun altro mormora piano piano: “I barbari?”. “Si dice che l’impero sia stato distrutto dai ratti”, dichiara l’insegnante e invita gli studenti ormai ammutoliti a disegnare un topo su un foglio di carta.
Quando sei di fianco a loro nel momento in cui scoprono di aver dentro di sé un sacco di storie, be’ sono bei momenti anche per noi
Dopo che ognuno ha prodotto il suo topo, Brugnatelli, tira fuori una pantegana di peluche dallo zaino e propone ai ragazzi di copiarla e poi confrontare i due disegni. Quando gli studenti si accorgono che sono migliori i disegni dal “vero”, è chiaro a tutti che per creare è più facile avere un modello.
Long John Silver non era un pirata, ma un amico del suo creatore, Stevenson, che aveva una gamba di legno; Severus Piton di Harry Potter era il professore di chimica dell’autrice, J.K. Rowling, e così via. Con questo semplice esercizio i ragazzi capiscono che per inventare spesso si parte dalla realtà cambiandola un po’, ma soprattutto capiscono una cosa importantissima: le loro vite o quelle dei loro amici e dei loro famigliari possono essere interessanti se raccontate in un certo modo. Ed è allora questi ragazzi di prima superiore, molti dei quali non hanno mai letto nemmeno Harry Potter, si mettono a scrivere la loro biografia in terza persona (che andrà poi stampata sul libro di racconti che produrranno alla fine del laboratorio).
Le biografie che i ragazzi scrivono sono davvero fantasmagoriche. Alcuni scrivono cose divertentissime, apocalittiche, perfino intime. Devo ammettere che trascorro due ore molto belle, e invidio un po’ i volontari del Cfs: il processo di veder studenti annoiati trasformarsi in scrittori in erba è energia allo stato puro. “Quando hai l’occasione di vederla davvero all’opera, la fantasia”, mi dice Brugnatelli alla fine, “quando sei di fianco a loro nel momento in cui scoprono di aver dentro di sé un sacco di storie, quando si accorgono che anche il più insulso pomeriggio della loro vita è interessante, be’ sono bei momenti anche per noi”.
Nel frattempo Francesco Gungui, uno dei volontari più attivi del Centro, scrittore per ragazzi con una grande esperienza di laboratori, ha tenuto un altro workshop nella stessa classe di fianco, dal titolo Racconta agli alieni il pianeta Terra. Prossimamente lavorerà con altre scuole, chiedendo agli alunni di intervistare il compagno di banco e scriverne la biografia futura. “I bambini e i ragazzi che seguono i nostri corsi”, spiega Gungui, “imparano tutte le risorse della comunicazione, imparano a esprimersi e ad articolare quello che pensano. Ne guadagna tantissimo l’autostima, la dignità”. Lo diceva Flannery O’Connor: “Io scrivo perché non so quello che penso finché non leggo quel che dico”. Sono certa che il Cfs possa diventare a breve un vero riferimento cittadino, “uno spazio accogliente e protettivo”, per usare le parole di un’altra leggendaria insegnante, Carla Melazzini.
Il costo dell’insegnamento
Don Milani era convinto che la scuola costasse molto poco. Per lui bastava “un po’ di gesso, una lavagna, qualche libro regalato e quattro ragazzi più grandi a insegnare”. In certi casi è vero, e la storia della Penny Wirton che racconterò nelle prossime righe, è la dimostrazione che si possa insegnare a costo zero.
Ma è vero anche il contrario. A volte ci vogliono molti denari, soprattutto se si tratta di offrire agli studenti uno spazio per approfondire la scienza e la tecnologia. Se vi capita di andare a Bologna, visitate l’Opificio Golinelli, è un’ex fonderia, nella periferia della città. È un posto aperto a tutti, scuole e privati cittadini, dai bambini di 18 mesi agli studenti universitari: novemila metri quadrati di struttura modernissima, colorata, luminosa.
Inaugurato nel 2015, l’Opificio è stato realizzato grazie a Marino Golinelli, un signore che oggi ha 97 anni, industriale modenese a dir poco illuminato, che ha deciso di fare questo regalo alla sua città d’adozione. Qui all’Opificio, un vero e proprio centro sperimentale, unico in Italia, per la sua offerta e completezza, ci sono stampanti in 3d, microscopi di ultima generazione, apparecchi per studiare il dna e molto altro. Nel 2016 l’Opificio ha accolto 150mila persone (fino a 400 studenti al giorno), tra i quali anche alcuni studenti dell’alternanza scuola/lavoro. Ma questo non è solo un posto per piccoli scienziati. In occasione della Bologna Children Book’s Fair il prossimo aprile, per esempio, si terranno qui una serie di laboratori, per la maggior parte gratuiti, tra i quali spicca Art Explosion, il workshop di action painting con Hervé Tullet (tutte le informazioni sul sito della fondazione Golinelli).
Pausa filosofica
Di eccellenza in eccellenza. A Roma c’è un giovane professore che da dieci anni organizza laboratori di filosofia per le scuole primarie (dalla terza elementare alla quinta) all’interno di alcune scuole pubbliche.
Si tratta di un lavoro di semi-volontariato per Nicola Zippel, che di mestiere insegna al liceo (filosofia, ovviamente). “Lo faccio volentieri, perché dai bambini imparo una libertà e una freschezza di pensiero che non si trova più negli adulti”, racconta. “Oggi, al contrario, nella scuola c’è un grande bisogno di parlare di sé in maniera diversa, di introdurre temi differenti, anche per contrastare la tendenza ‘valutativa’ della nuova scuola che spinge i ragazzi alla competitività. Invece la filosofia insegna proprio come fermarsi a riflettere. Insegna a prendersi una pausa”.
Entrando nei locali della Penny Wirton si ha l’impressione di un affollatissimo alveare, pieno di banchi fitti
Zippel lavora anche sulla formazione e sulla trasmissione del metodo, che lui ha ideato e che oggi è raccontato in un libro appena uscito, I bambini e la filosofia. Esemplare in questo senso è il lavoro fatto nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro dallo stesso Zippel, che ha portato due classi del liceo, divise in gruppi da tre, a tenere a loro volta i laboratori di filosofia ai bambini.
Un’operazione simile è quella che succede anche alla Penny Wirton di Eraldo Affinati dove alcuni dei volontari sono proprio i ragazzi dell’alternanza scuola/lavoro. Qui infatti è stato messo in pratica il metodo teorizzato da don Milani del “faccia a faccia”: ogni studente ha insegnante personale con cui entra in contatto diretto. A volte si tratta anche di ex maestri o pensionati.
La casa del pensiero
Entrando nei locali della Penny Wirton, che al momento ha una nuova sede in zona Ostiense grazie alla generosità della regione Lazio, si ha l’impressione di un affollatissimo alveare, pieno di banchi fitti. Lo spazio ormai non è sufficiente per i 180 studenti che la scuola ospita dal lunedì al giovedì pomeriggio, e per altrettanti maestri che siedono di fronte a loro.
Come mi spiega Affinati, il metodo “faccia a faccia” è fondamentale perché si riesce a promuovere una vera integrazione: spesso nascono addirittura rapporti duraturi tra i ragazzi e gli insegnanti. A Milano, dove la Penny Wirton è diretta dalla scrittrice Laura Bosio, ci sono ormai 150 studenti: “Grazie all’insegnamento ‘uno a uno’”, dice Bosio, “i nostri allievi non imparano solo la lingua italiana, ma lo ‘spirito’ di chi la parla, in un rapporto di scambio profondo. E la parola, lo sappiamo, è la casa del pensiero. Non siamo solo noi a dare a loro: ciascuno di questi ragazzi e ragazze ci porta qualcosa di importante, la loro storia --spesso drammaticissima e vissuta con una forza interiore per noi inimmaginabile - la loro cultura, la loro giovinezza, la loro speranza, nonostante tutto. Come si augurava don Milani, anche noi speriamo che i muri delle nostre scuole assorbano la sofferenza e trasmettano idee”.
Peccato, penso, che queste esperienze trovino posto fuori della scuola e non dentro di essa e, se è vero che don Milani ha lavorato sempre ai margini dell’istituzione, quella scuola inclusiva e non classista da lui sognata e teorizzata non ha molto a che fare con quella di oggi, sempre più “americanizzata” e valutativa. Del resto per gli insegnati dare un voto è molto più facile di scrivere un giudizio. Insegnare può essere un lavoro molto faticoso. Quando a don Milani chiedevano: “Come bisogna fare a scuola?”, lui rispondeva: “Bisogna essere veri”. E a volte questa autenticità, come mi ha scritto Eraldo Affinati, “porta anche a farsi del male. Perché educare significa ferirsi, bruciarsi le mani”.
* Internazionale, 11 Mar 2017 (ripresa parziale).
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". --- "Processo all’obbedienza. La vera storia di don Milani"(M. Lancisi). Una nota di Luca Kocci.10 dicembre 2016, di Federico La Sala
L’OBBEDIENZA NON È PIÙ UNA VIRTÙ. IN UN LIBRO, IL PROCESSO A DON MILANI
di Luca Kocci (Adista/Notizie, 17 DICEMBRE 2016 • N. 44)
38787 FIRENZE-ADISTA. «Non discuterò qui l’idea di patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri». Scriveva così, poco più di 50 anni fa, nel 1965, don Lorenzo Milani ai cappellani militari in congedo della Toscana i quali, al termine di un incontro in ricordo della firma dei Patti lateranensi, avevano attaccato l’obiezione di coscienza al servizio militare, definendola «insulto alla patria», «estranea al comandamento cristiano dell’amore» ed «espressione di viltà».
La vicenda comincia quasi per caso, in un giorno di febbraio. Da oltre 11 anni don Milani viveva a Barbiana, sul monte Giovi, nel Mugello (Fi), dove l’arcivescovo di Firenze, il card. Florit, lo aveva spedito in “esilio” nel dicembre 1954 e dove don Lorenzo aveva messo in piedi una scuola per i piccoli montanari.
La lettura collettiva del giornale era una delle attività quotidiane delle scuola di Barbiana. E così, il 14 febbraio 1965, informato da Agostino Ammannati - un professore del liceo “Cicognini” di Prato che collaborava con don Milani a Barbiana -, don Milani legge insieme ai suoi ragazzi un trafiletto pubblicato due giorni prima sulla Nazione di Firenze:
- «Nell’anniversario della Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato italiano, si sono riuniti ieri, presso l’Istituto della Sacra Famiglia in via Lorenzo il Magnifico, i cappellani militari in congedo della Toscana. Al termine dei lavori, su proposta del presidente della sezione don Alberto Cambi, è stato votato il seguente ordine del giorno: I cappellani militari in congedo della Regione Toscana (in realtà solo 20 su 120, ndr), nello spirito del recente congresso nazionale dell’associazione, svoltosi a Napoli, tributano il loro riverente e fraterno omaggio a tutti i caduti d’Italia, auspicando che abbia termine, finalmente, in nome di Dio, ogni discriminazione e ogni divisione di parte di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise, che morendo si sono sacrificati per il sacro ideale della Patria. Considerano un insulto alla Patria e ai suoi caduti la cosiddetta “obiezione di coscienza” che, estranea al comandamento cristiano dell’amore, è espressione di viltà».
Non si può tacere. E così don Milani, insieme agli alunni della scuola, si mette subito al lavoro per replicare ai cappellani, dal momento che, scrive, «avete rotto il silenzio voi, e su un giornale».
In pochi giorni è pronta la “Lettera ai cappellani militari” che viene ciclostilata e inviata ai preti della diocesi di Firenze e ad una serie di giornali, molti dei quali cattolici, ma che viene pubblicata, il 6 marzo, solo dal settimanale del Partito comunista italiano, Rinascita.
Ha un effetto deflagrante: il priore di Barbiana viene isolato ancora di più dalle gerarchie cattoliche, denunciato da un gruppo di reduci (insieme al direttore di Rinascita, Luca Pavolini) per incitamento alla diserzione e istigazione alla disubbidienza militare, processato, prima assolto e poi condannato (come Pavolini), se il reato non fosse stato dichiarato estinto perché era morto poco prima, il 26 giugno 1967.
Alla vicenda dedica ora un libro il giornalista e scrittore toscano Mario Lancisi (Processo all’obbedienza. La vera storia di don Milani, Laterza, 2016, pp. 158, euro 16; il libro è acquistabile anche presso Adista: tel. 06/6868692; fax 06/6865898; e-mail: abbonamenti@ adista.it; oppure acquistato online su www.adista.it), che sulla lettera ai cappellani esprime un giudizio netto: anche se sono passati cinquant’anni, «conserva intatta la sua carica eversiva». Perché mette il dito su tre piaghe: la patria, la guerra («ogni guerra è classista» perché «altro non è per il priore che la difesa degli interessi materiali ed economici delle classi dominanti») e i cappellani militari.
La lettera e il processo non arrivano come un fulmine a ciel sereno: nel 1961 il sindaco di Firenze La Pira aveva fatto proiettare il film antimilitarista francese “Tu ne tueras point” (“Tu non uccidere”), ignorando la censura e attirandosi le critiche di Andreotti, dell’Osservatore Romano e un processo penale; nel 1963 il primo obiettore cattolico, Giuseppe Gozzini, era stato condannato a sei mesi, e padre Ernesto Balducci, che lo aveva difeso in un’intervista ad un quotidiano, ad otto mesi; Giovanni XXIII aveva emanato la Pacem in Terris, e il Concilio Vaticano II sfiorato il tema, preferendo però soprassedere.
Ma il tuono è decisamente più fragoroso, anche per la potenza della scrittura di Milani, distante anni luce dalla prudenza ecclesiastica («il galateo, legge mondana, è stato eletto a legge morale nella Chiesa di Cristo? Chi dice coglioni va all’inferno. Chi invece non lo dice ma ci mette un elettrodo viene in visita in Italia e il galateo vuole che lo si accolga con il sorriso», scriverà Milani, riferendosi a De Gaulle e alla guerra di Algeria, in un articolo pubblicato post mortem dall’Espresso).
Al processo don Milani non va: è malato, un linfoma di Hodgkin lo sta consumando. Viene difeso da un avvocato d’ufficio - che curiosamente è un “principe del foro”, Adolfo Gatti -, ma invia, come memoria difensiva, un nuovo testo (la “Lettera ai giudici”), destinato anch’esso a diventare una pietra miliare dell’antimilitarismo e della disobbedienza, o piuttosto dell’obbedienza non ad un’autorità precostituita - sia militare che clericale - ma alla propria coscienza («l’obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni»).
Il libro di Lancisi non aggiunge particolari inediti, ma contestualizza e ricostruisce con puntualità e rigore le fasi del processo attraverso le cronache del tempo, fino all’assoluzione in primo grado con formula piena.
Don Milani muore, ma la storia va avanti, con la condanna in appello di Pavolini e della “Lettera ai cappellani”. La sentenza arriva il 28 ottobre 1967, 45° anniversario della marcia su Roma.
«Era nel ‘22 che bisognava difendere la patria aggredita. Ma l’esercito non la difese», aveva scritto Milani nella lettera. «Se i suoi preti l’avessero educato a guidarsi con la coscienza invece che con l’obbedienza cieca, pronta, assoluta, quanti mali sarebbero stati evitati alla patria e al mondo». (luca kocci)
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". -- Don Lorenzo Milani, insegnante (di Alberto Melloni)3 gennaio 2016, di Federico La Sala
Uscirà a settembre l’edizione nazionale delle opere del prete di Barbiana, morto quasi 50 anni fa
 Abbiamo chiesto al presidente del Comitato di raccontare trama filologica e passione civile di testi ancora attuali
Abbiamo chiesto al presidente del Comitato di raccontare trama filologica e passione civile di testi ancora attualiDon Lorenzo Milani, insegnante
Le parole (e le opere) di un ebreo nato artista e diventato sacerdote, esiliato in montagna per le sue posizioni su pace, scuola, obbedienza
di Alberto Melloni (Corriere della Sera, La Lettura, 03.01.2015)
Don Milani trascolora come il Che Guevara che passa sulle magliette di mezza estate senza che chi le indossa abbia alcun interesse per questo predecessore di «Fran-Ché», come diceva una vignetta apparsa durante il viaggio del Papa a Cuba. Don Milani sbiadisce come certe canzoni di Bob Dylan che non sono diventate inni nazionali della raucedine poetica e nuotano in un oblio che ha bisogno di un mediatore o più mediatori (su Desolation Row si sono misurati Fabrizio De André e Francesco De Gregori) per riassaporarne i versi e la musicalità. Don Milani si allontana come il significato che egli dava alla parola «scuola» in quell’Italia neorealista capace di fare dell’istruzione una leva di giustizia e non il nome di un pianeta sindacalizzato a suon di pentole e nel quale l’eroismo individuale di molti si muove d’istinto tentando passi di danza nel suolo difficile di un società slabbrata.
Don Milani anche per questo può sembrare un prêt-à-porter che chiunque può usare per difendersi o per attaccare, massime i pedagogisti con i quali questo ebreo nato artista e diventato prete avrebbe avuto poco di cui discutere, stante l’urgenza esistenziale del suo essere-per. Don Milani può essere chiuso in un sarcofago di buone parole, se del caso pure canonizzato dalla Chiesa che gli diede il Vangelo e le stigmate per capirlo: e il grande applauso liberatorio che ha benedetto l’arcivescovo di Firenze, quando ha fatto il suo nome davanti al Papa, ha segnato non la fine di un risarcimento, ma l’entità della sua portata.
Don Milani è un’eredità contesa, a quasi cinquant’anni dalla morte e a una manciata d’anni dal suo centenario: perché se l’incontro con la sua scrittura ha segnato indelebilmente tutti coloro che ne hanno sentito il fuoco, è del tutto ragionevole che coloro che quel fuoco l’hanno avvertito vivo, nell’affetto e nella forza di questo scultore della parola, ne vivano la custodia come un dovere, anche a costo di finire in una competizione irragionevole come sono quelle fra figli di un unico grande amore. Don Milani è le sue esperienze e quei nomi di luogo - San Donato, Barbiana - e l’angelo di tutte le Barbiane di oggi, da Caivano a Mingara, che condividono il sogno di fare della consegna della parola la leva di un domani diverso.
Don Milani è tutto questo e mille altre cose ancora che una memoria di affetti, di passione, di litigi ha seminato nel tempo che ci separa dalla sua morte, avvenuta il 23 giugno 1967: ma tutte queste cose poggiano su una realtà solida e precisa, più forte d’ogni ricordo e di ogni interesse, di ogni uso o abuso del suo nome, cioè sulla sua «parola scritta».
Per ora ci accontenteremo di chiamarla così l’opera di Lorenzo Milani Comparetti, classe 1923: ragazzino che ha una infanzia milanese solo perché il capofamiglia, le cui rendite sono erose dalla crisi del 1929, deve dedicarsi al lavoro; scolaro non proprio modello, ma che nel coltissimo e raffinato ambiente di famiglia si ritrova a fargli lezione d’italiano, quando le cose vanno male, niente meno che Giorgio Pasquali, padre della filologia e della linguistica nazionali.
Nipote del famoso archeologo che scoprì l’Apollo Milani che prende il suo nome, questo piccolo rampollo con il fratello Adriano e la sorella Elena della famiglia materna dei Weiss, non cresce come un ebreo triestino secolarizzato e nemmeno come un cristiano ambrosiano, pur avendo ricevuto un battesimo «razziale» che secondo la madre Alice avrebbe dovuto proteggerlo in un’Europa nella quale l’antisemitismo la fa da padrone.
Non imbocca la via accademica, come ci si poteva aspettare secondo la tradizione familiare, ma quella dell’arte e sarà scolaro del pittore Hans J. Staude (quello la cui figlia sposerà Tiziano Terzani), manifestando la capacità di dedicazione che sua madre ricorda di lui. Una capacità di assoluto che manifesta nel 1942 a un prete senza eguali, don Raffaele Bensi, e che lo porta in seminario in una ricerca di assoluto che non accetta compromessi o mediazioni.
Una «indigestione di Cristo» definirà don Bensi la vocazione di don Lorenzo: e una indigestione che quando diventa ministero, a San Donato di Calenzano, si esprime subito in una dimensione che lui chiama «scuola» - ma che è qualcosa di più radicale. È la consegna della parola come strumento di conoscenza e di comunicazione: la parola delle lingue, la parola della musica, la parola della letteratura. Una consegna radicale e assoluta, che entra in urto con l’establishment democristiano e gli costa la rimozione dalla parrocchia dove era cappellano e la nomina quasi beffarda a priore di Barbiana, un buco nero di emarginazione montanara, con bimbi nati dopo la guerra che diventano la sua scuola.
Tra San Donato e Barbiana nasce Esperienze pastorali, la riflessione sulla sua esperienza pastorale che il Sant’Uffizio non riuscirà a condannare, ma di cui imporrà il ritiro dal commercio, incrementandone così la fortuna; a Barbiana nasce una scuola senza vacanze, basata sulla laica autorità di un prete in talare, capace di posporre una catechesi affrettata e devozionale alla formazione di una coscienza critica, capace di pensare che la competizione con la quale qualche improvvisato e attempato solone crede di far crescere la performatività del sistema scolastico è quella fra il maestro e i problemi che ha davanti, non quella fra i problemi che ciascuno degli scolari porta.
Una esperienza che diventa ben presto un caso nazionale, che si rifrange nelle grandi lettere che escono dalla scuola di Barbiana: la lettera ai cappellani militari, la lettera ai giudici, la Lettera a una professoressa, gli scritti che trovano posto nella discussione sui grandi temi che vedono il bisogno di assoluto di questo uomo giovane e bellissimo riversarsi in contenitori sempre nuovi, sfuggendo a ogni possessività e smentendo tutte quelle fondatissime ambizioni di custodia che volta a volta sono state avanzate su don Milani in nome della pedagogia, della storia, della spiritualità dell’azione sociale, del riscatto o della educazione.
Nel 1970 sua madre Alice, in una intervista infastidita a un imbarazzato Nazareno Fabbretti che tenta di farle dire qualcosa di pio, diceva che don Lorenzo «non appartiene a nessuno. Nemmeno a me, soprattutto adesso. Né ai borghesi, né ai liberali, né ai radicali. Capisco che se anche ha dato la sua vita ai ragazzi di San Donato e di Barbiana, non si è “esaurito” nemmeno in loro. (...) Barbiana è un momento della sua vita, come ne fu un momento la difesa degli obiettori, come ne fu un altro momento il confronto violento con la gerarchia. Tutte occasioni per un discorso più ampio e più profondo, un discorso che comincia forse ad essere inteso solo adesso». In realtà quel discorso ampio e profondo è difficile da intendere perché è difficile e richiede uno sforzo maggiore al quale il ministro Dario Franceschini ha dato impulso promuovendo l’edizione nazionale degli scritti di don Milani, sulla quale Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, e Giuseppe Betori, cardinale di Firenze, hanno fatto convergere molte energie intellettuali e morali.
Un’edizione nazionale (che uscirà a settembre) è una specie di riconoscimento pubblico che motiva il massimo impegno di studio e la più grande castità di intenti da parte di tutti coloro che vi sono coinvolti: in questo caso le associazioni e fondazioni che raccolgono i suoi allievi, l’arcidiocesi che custodisce alcune carte essenziali, i famigliari, gli studiosi di diverse istituzioni che hanno convenuto sul fatto che fosse possibile fare una edizione critica di quel che finora è stato letto in due autorevoli formati: quello della editio princeps voluta dallo stesso don Milani che nelle sue edizioni per la Lef di Esperienze pastorali o della Lettera curava ogni dettaglio con attenzione puntigliosa; quello delle edizioni di commercio delle altre lettere, alla mamma o agli scolari, che quando sono uscite avevano ritocchi estrinseci e piccoli tagli legati a personaggi viventi o esigenze di uniformità tipografica naturali in queste edizioni.
Una edizione nazionale, invece, è cosa che ritiene significative e meritevoli di attenzioni le varianti cancellate, le pagine cassate o le righe modificate dopo i consigli ricevuti; è opera di ricerca non per affermare il diritto di sprofessorare su testi di incandescente bellezza, ma per onorarne il dettato con la stessa passione assoluta che ha dato a quel culto della parola la sua forma scritta.
Cosa emergerà dalla edizione nazionale? Federico Ruozzi, Anna Carfora, Valentina Oldano, Sergio Tanzarella, insieme a Valeria Milani Comparetti, José Corzo e tanti altri studiosi che insieme a chi scrive collaborano a questa opera, non hanno scoop nel cassetto: quel che andrà in un grande volume di Meridiani non è un’opera che si qualifichi per qualche riga in più (che c’è), qualche riga letta integralmente (che c’è) o qualche variante che fa capire meglio il senso della frase (che c’è).
L’opera omnia di don Milani infatti non riguarda tanto ciò che un lettore sprovveduto può aggiungere a una conoscenza che non ha, ma ciò che un lettore avvertito può restituire a quest’uomo che ha insegnato da un paesino del crinale che una delle eroine che ha più commosso il mondo degli ultimi anni è una inguaribile pessimista. Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace, dice che «una penna, un libro e un insegnante possono cambiare il mondo». Don Milani ha dimostrato che delle tre cose solo una è indispensabile: l’insegnante.
- Testimonianze fotografiche
 Visita ai luoghi della sua missione con guide speciali: i ragazzi di allora.
Visita ai luoghi della sua missione con guide speciali: i ragazzi di allora.
- «E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i “segni dei tempi”, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso». Le parole di don Milani sono riportate in un volume pubblicato da Ancora editrice: La memoria dei luoghi. Sulle tracce di don Lorenzo Milani (pagine 112, e 22). Francesca Cosi (testi) e Alessandra Repossi (immagini) propongono un viaggio fotografico tra i luoghi del sacerdote come appaiono oggi (gli scatti sono del 2013-2015): la casa di Firenze dell’infanzia, il seminario e soprattutto le parrocchie di San Donato a Calenzano e di Barbiana. Luoghi visitati in compagnia degli allievi di don Milani che hanno condiviso con lui l’esperienza della «scuola popolare». Le testimonianze affiancano le immagini in bianco e nero insieme ai testi scritti dal sacerdote e alla ricostruzione della sua vicenda biografica. «Devo tutto quello che so - scriveva in Esperienze pastorali - ai giovani operai e contadini cui ho fatto scuola. Io ho insegnato loro soltanto a esprimersi, mentre loro mi hanno insegnato a vivere».
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". -- Don Lorenzo Milani, Malala Yousafzai, Alberto Melloni.5 gennaio 2016, di Federico La Sala
ALLA FINE DELL’ARTICOLO RIPORTATO NEL POST PRECEDENTE,
ALBERTO MELLONI così scrive:
- L’opera omnia di don Milani infatti non riguarda tanto ciò che un lettore sprovveduto può aggiungere a una conoscenza che non ha, ma ciò che un lettore avvertito può restituire a quest’uomo che ha insegnato da un paesino del crinale che una delle eroine che ha più commosso il mondo degli ultimi anni è una inguaribile pessimista.
 Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace, dice che «una penna, un libro e un insegnante possono cambiare il mondo». Don Milani ha dimostrato che delle tre cose solo una è indispensabile: l’insegnante.
Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace, dice che «una penna, un libro e un insegnante possono cambiare il mondo». Don Milani ha dimostrato che delle tre cose solo una è indispensabile: l’insegnante.
Don Milani, senz’altro, gli avrebbe dato (con spirito critico e rimproverante) un ceffone per la sua super paternalistica buffonesca tracotanza professorale, occidentalizzante e cattolico-romana!!!
Federico La Sala
- L’opera omnia di don Milani infatti non riguarda tanto ciò che un lettore sprovveduto può aggiungere a una conoscenza che non ha, ma ciò che un lettore avvertito può restituire a quest’uomo che ha insegnato da un paesino del crinale che una delle eroine che ha più commosso il mondo degli ultimi anni è una inguaribile pessimista.
- Testimonianze fotografiche
-
> “ESPERIENZE PASTORALI” NON È PIU’ «INOPPORTUNO». RIABILITATO IL LIBRO DI DON MILANI (di Luca Kocci)21 aprile 2014, di Federico La Sala
CONTRORDINE: “ESPERIENZE PASTORALI” NON È PIU’ «INOPPORTUNO». RIABILITATO IL LIBRO DI DON MILANI *
35810 FIRENZE-ADISTA. Meglio tardi che mai, recita l’adagio, e si addice perfettamente a quanto l’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, ha rivelato ad Andrea Fagioli che lo scorso 17 aprile lo ha intervistato sul settimanale diocesano Toscana Oggi, di cui è direttore: la Congregazione per la Dottrina della Fede - annuncia Betori -, sebbene con una formulazione piuttosto minimalista giustificata dal “mutare dei tempi”, ha riabilitato Esperienze pastorali, l’unico volume firmato da don Lorenzo Milani che nel 1958, pochi mesi dopo la pubblicazione, venne giudicato «inopportuno» e «ritirato dal commercio» per ordine del Sant’Uffizio allora guidato dall’ultraconservatore card. Alfredo Ottaviani.
«Nel novembre scorso - spiega l’arcivescovo di Firenze -, dopo un accurato lavoro di ricerca, ho inviato al santo padre un’ampia documentazione su Esperienze pastorali» nella quale evidenziavo che il libro «era ancora sotto la proibizione di stampa e di diffusione.
 Questo dossier il papa lo ha passato alla Congregazione per la Dottrina della Fede che proprio in questi giorni mi ha risposto, sottolineando innanzitutto una cosa che spesso sfugge, ovvero che non c’è stato mai nessun decreto di condanna contro Esperienze pastorali né tantomeno contro don Lorenzo Milani. Ci fu soltanto una comunicazione data dalla Congregazione all’arcivescovo di Firenze (il card. Ermenegilfo Florit, ndr) nella quale si suggeriva di ritirare dal commercio il libro e di non ristamparlo o tradurlo.
Questa comunicazione fu poi resa nota anche attraverso un articolo dell’Osservatore Romano».
Questo dossier il papa lo ha passato alla Congregazione per la Dottrina della Fede che proprio in questi giorni mi ha risposto, sottolineando innanzitutto una cosa che spesso sfugge, ovvero che non c’è stato mai nessun decreto di condanna contro Esperienze pastorali né tantomeno contro don Lorenzo Milani. Ci fu soltanto una comunicazione data dalla Congregazione all’arcivescovo di Firenze (il card. Ermenegilfo Florit, ndr) nella quale si suggeriva di ritirare dal commercio il libro e di non ristamparlo o tradurlo.
Questa comunicazione fu poi resa nota anche attraverso un articolo dell’Osservatore Romano».
 Pertanto, aggiunge, «non c’è stato mai un decreto che in qualche modo dava un giudizio di condanna dell’opera e dell’autore. L’intervento aveva un chiaro carattere prudenziale ed era motivato da situazioni contingenti. Oggi la Congregazione mi dice che ormai le circostanze sono mutate e pertanto quell’intervento non ha più ragione di sussistere. Da ora in poi la ristampa di Esperienze pastorali non ha nessuna proibizione da parte della Chiesa (il testo comunque in questi anni ha continuato ad essere regolarmente stampato dalla Libreria editrice fiorentina, ndr) e torna a diventare un patrimonio del cattolicesimo italiano e in particolare della Chiesa fiorentina, un contributo alla riflessione ecclesiale da riprendere in mano e su cui confrontarsi».
Pertanto, aggiunge, «non c’è stato mai un decreto che in qualche modo dava un giudizio di condanna dell’opera e dell’autore. L’intervento aveva un chiaro carattere prudenziale ed era motivato da situazioni contingenti. Oggi la Congregazione mi dice che ormai le circostanze sono mutate e pertanto quell’intervento non ha più ragione di sussistere. Da ora in poi la ristampa di Esperienze pastorali non ha nessuna proibizione da parte della Chiesa (il testo comunque in questi anni ha continuato ad essere regolarmente stampato dalla Libreria editrice fiorentina, ndr) e torna a diventare un patrimonio del cattolicesimo italiano e in particolare della Chiesa fiorentina, un contributo alla riflessione ecclesiale da riprendere in mano e su cui confrontarsi».Betori getta acqua sul fuoco.
Tuttavia, sebbene il libro non sia stato messo all’Indice, l’intervento censorio c’è stato. La stesura del volume cominciò negli anni in cui don Milani era cappellano, cioè viceparroco, a San Donato di Calenzano (fra il ‘47 e il ‘54). Si trattava di un’analisi della società e della prassi ecclesiale del tempo, a partire dalla sua “esperienza pastorale” a San Donato.
Venne ultimato successivamente e pubblicato dalla Lef nell’aprile 1958 - con una lunga prefazione dell’arcivescovo di Camerino, mons. Giuseppe D’Avack -, quando Milani era già stato esiliato a Barbiana, nel Mugello. Nel settembre di quell’anno La Civiltà Cattolica - il quindicinale dei gesuiti le cui bozze vengono lette e corrette dalla Segreteria di Stato vaticana - pubblicò una severa stroncatura del testo (firmata dal gesuita p. Angelo Perego), preceduta da due recensioni altrettanto negative sulla Settimana del clero e su Orientamenti pastorali.
Tre mesi dopo arrivò l’intervento del Sant’Uffizio, prima con una lettera a mons. Florit (15 dicembre) e poi con la pubblicazione di un lungo articolo sull’Osservatore Romano (20 dicembre): si ordinava che il libro fosse «ritirato dal commercio», poiché conteneva «ardite e pericolose novità» in campo sociale. Il testo non fu condannato perché si allontanava dalla “ortodossia”, ma venne giudicato «inopportuno», e quindi proibito.
Ora, dopo una “pausa di riflessione” durata più di 50 anni, la Congregazione per la Dottrina della Fede ci ripensa. Meglio tardi che mai, anche se manca ancora un passaggio: il riconoscimento che la censura del 1958 fu un grave errore. (luca kocci)
* Adista Notizie n. 16 del 26/04/2014
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, ---- “Perché mi hai chiamato?”. Lettere di un’anima inquieta (di Giovanni Santambrogio)30 settembre 2013, di Federico La Sala
Lettere di un’anima inquieta
di Giovanni Santambrogio (Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2013)
- Lorenzo Milani, “Perché mi hai chiamato?”, San Paolo, Milano 2013
La corrispondenza epistolare possiede il grande valore di trasmettere gli aspetti più riserva ti e veri di una persona. Alla let tera si affidano le confidenze, le paure, gli entusiasmi, le incertezze del proprio vivere. La lettera assume spesso il tono e la forza della pagina di diario, registra i fatti nel loro divenire e li presenta con l’immediatezza delle sfumature. Gli ep i stolari, come genere letterario, invitano il lettore a compiere diversi percorsi in terpretativi oltre a regalare primizie di storia individuale e sociale.
Il don Mila ni che si rivela nel volume da poco edito da San Paolo «Perché mi hai chiamato?» fa seguito, integrandolo, a Lettere di don Lorenzo Milani, Priore di Barbiana (2007), entrambi curati da Michele Ge sualdi attuale presidente della Fonda zione don Milani e tra i primi ragazzi di Barbiana ad aver frequentato la famosa scuola del piccolo paesino toscano.
Gli interlocutori del «prete di avanguar dia» come si autodefinisce in uno scrit to a Loris Capovilla, allora segretario particolare di papa Giovanni XXIII, so no sette sacerdoti fondamentali nel suo percorso umano e spirituale. Sono: Raffaele Bensi a cui il ventenne Lorenzo confidò nel 1943 l’intenzione di «compiere il salto definitivo» e di in traprendere la via del seminario e del sa cerdozio; Daniele Pugi, il parroco di San Donato a Calenzano dove nel 1947 don Milani approda come cappellano; Ren zo Rossi e Bruno Brandani, compagni di seminario; Primo Mazzolari, figura di spicco nella chiesa preconciliare per i suoi scritti, l’impegno politico (fu anche partigiano) e per il suo giornale «Ades so» che pubblicò due scritti di don Lorenzo riportati nel volume; Divo Barsotti, raffinato predicatore, asceta e autore di importanti saggi; Loris Capovilla con il quale discute del suo Esperienze pasto rali, il libro pubblicato dalla Libreria Editrice Fiorentina nel marzo 1958, condannato dal sant’Uffizio il 18 dicembre del lo stesso anno e subito ritirato dalle li brerie perché considerato inopportuno.
Dal volume esce una profonda e ge nuina umanità accompagnata da una decisione per la testimonianza che rompe gli schemi in un Paese percorso dallo scontro politico tra Dc e Pci e cul turalmente concentrato sull’ideologia comunista.
Don Milani (1923-1967) vive immer so nel suo tempo, dominato dalla rico struzione post-bellica e dai primi anni del boom economico, e anticipa nel l’esperienza ecclesiale molte scelte che usciranno dal Concilio Vaticano II. I di versi carteggi mostrano bene e soprat tutto l’inquietudine di un’anima che vuole essere al servizio della Chiesa e che si interroga sempre sulla propria fede e fedeltà a Dio. Bella la raccolta finale di appunti per la predicazione e il catechismo.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- Email ad una professoressa (di Beppe SEvergnini)2 settembre 2013, di Federico La Sala
Email ad una professoressa
di Beppe Severgnini (Corriere della Sera/La Lettura, 1 settembre 2013)
Molte cose, molti anni e molte riforme sono passati dalla Lettera a una professoressa . Ma c’è sempre un po’ di Barbiana, nella buona scuola all’italiana. Vediamo cosa scrivevano don Lorenzo Milani e i suoi allievi, e cosa possiamo aggiungere, quasi mezzo secolo dopo.
Chi era senza basi, lento o svogliato si sentiva il preferito. Veniva accolto come voi accogliete il primo della classe. Sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui. Finché non aveva capito, gli altri non andavano avanti. (pagina 25)
Lei certamente sa, prof, che la parola «insegnante» deriva da in e signo : voi avete il compito, e l’onore, di lasciare un segno. La selezione è prerogativa dell’università. Alle elementari e alle medie - inferiori e superiori - bisogna scavare dentro i ragazzi e scovare le loro inclinazioni, correggendo le loro debolezze. Voi siete minatori di talento e spacciatori d’entusiasmo. Se oggi sono qui e posso scriverle questa mail, è perché ho trovato persone così. Avevo una professoressa d’italiano che, in terza media, mi affidò due ragazzi che rischiavano la bocciatura. «Il tuo voto sarà misurato sul loro voto, il tuo successo sul loro successo», annunciò in classe, incurante del mio sguardo angosciato. Si chiamava Tilde Chizzoli, quella sua collega: ha cambiato la vita a tre persone. Grazie a lei, ho imparato insegnando: anche un po’ dell’umiltà di cui avevo bisogno, venendo da una famiglia privilegiata. Ho passato tanti pomeriggi con quei nuovi amici. Loro mi hanno insegnato a giocare a calcio, a basket, a guidare un motorino 50 cc e a conoscere le ragazze; io gli ho spiegato un po’ d’inglese e Fogazzaro. Ci ho guadagnato, sono convinto.
Ogni volta che capitava un ospite straniero che parlava francese c’era qualche ragazzo che scopriva la gioia di intendere. La sera stessa lo si vedeva prendere in mano i dischi di una terza lingua. (pagina 25)
Pensi a quanto inglese ci gira intorno. I ragazzi italiani ormai lo comprendono, anche se faticano a parlarlo, per eccesso di timidezza o carenza di opportunità. A Urbino e a Modena alcuni insegnanti - scuola superiore - dubitavano di questa mia teoria. Così sono passato dall’italiano all’inglese: i ragazzi, partecipando e rispondendo, hanno dimostrato di capire quanto bastava. E voi, prof?
Il nostro era all’antica. Fra l’altro gli successe che nessuno dei suoi ragazzi riuscì a risolvere il problema. Dei nostri se la cavarono due su quattro. Risultato: ventisei bocciati su ventotto. Lui raccontava in giro che gli era toccata una classe di cretini! (pagina 26)
Dica la verità: voi insegnanti, proprio come noi giornalisti, siete spesso tentati di esclamare «Non capiscono!». Ma se chi sta di là non capisce - allievi o lettori, fa lo stesso - la colpa è sempre di chi sta di qua. Il fallimento di una classe è il fallimento di un insegnante: non ci sono eccezioni a questa regola. L’eccessiva severità maschera l’inadeguatezza. I professori cattivi sono, quasi sempre, cattivi professori.
La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde. (pagina 35)
La scuola superiore italiana, nel 2012, ha perso il 18 per cento degli iscritti: quasi uno su cinque, una percentuale drammatica. I ragazzi di oggi sono fragili, è vero. Le famiglie, spesso, non aiutano, e li spingono verso studi inadeguati. Ma voi siete le donne e gli uomini che devono creare gli italiani di domani. È vero, professoressa: si tratta di un’immensa responsabilità. Roba da far tremare le ginocchia ogni mattina, entrando in aula. Ma la severità, talvolta al limite del sadismo, non è una via d’uscita. Prima di giudicare, bisogna istruire. Prima di selezionare, occorre formare. Altrimenti, come diceva don Milani, «la scuola diventa un ospedale che cura i sani e respinge i malati».
Se ognuno di voi sapesse che ha da portare innanzi a ogni costo tutti i ragazzi e in tutte le materie, aguzzerebbe l’ingegno per farli funzionare. Io vi pagherei a cottimo. Un tanto per ragazzo che impara tutte le materie. O meglio multa per ogni ragazzo che non ne impara una. (pagina 82)
Potrebbe essere un’idea, prof. Che dice?
Non dica però di aver offerto il doposcuola quel preside che ha mandato ai genitori una circolare mezza stinta. Il doposcuola va lanciato come si lancia un buon prodotto. Prima di farlo bisogna crederci. (pagina 85)
Il lavoro di un insegnante è difficile: lo è sempre stato. E le ore di lavoro sono aumentate (cinquant’anni fa non c’erano i consigli di classe e d’istituto!). Eppure si deve trovare il modo di utilizzare le scuole al pomeriggio. Lasciarle vuote è uno spreco. Caricare i ragazzi di compiti a casa - com’è ormai la norma, soprattutto nei licei - è un’alternativa crudele. Non volete chiamarlo doposcuola o tempo pieno? Scegliamo un altro nome. Ministero, dirigenti scolastici, insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario: voi trovate un modo, e noi troveremo i soldi. Nel 2000 ho regalato la rete wi-fi alla mia scuola, il liceo classico «Racchetti» di Crema: è rimasta per anni inutilizzata, per questioni didattiche, amministrative e assicurative. Ma se dobbiamo sempre aspettare il bidello con le chiavi, dove vogliamo andare?
La scuola costa poco, un po’ di gesso, una lavagna, qualche libro regalato, quattro ragazzi più grandi a insegnare, un conferenziere ogni tanto a dire cose nuove gratis. (pagina 91)
Il gesso è sempre utile (basta non usarlo per ingessare la didattica). Ma la scuola costa, come la sanità e la previdenza: sono i tre pilastri delle democrazie occidentali. In Germania la Cancelliera Angela Merkel ha picchiato il pugno durante un consiglio dei ministri: «Tagliate tutto, la scuola e la ricerca no! Sono il nostro futuro». Spendiamo troppo, in Italia, per l’istruzione? Spendiamo la stessa somma destinata al pagamento degli interessi sul debito pubblico. E quella è una cambiale del passato.
Nella nostra scuola l’andare all’estero equivale ai vostri esami. Ma è esame e scuola insieme. Si prova la cultura al vaglio della vita. (pagina 101)
«Il primo grande viaggio lascia nei giovani, di qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che le abitudini non possono comporre; precisa l’idea degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella mente, una nuova forma, una nuova categoria: la categoria della lontananza». Così scriveva Mario Soldati in America primo amore . Oggi, molti decenni dopo, andare all’estero, per un ragazzo, è più facile. Andare all’estero con i compagni di scuola, però, resta speciale. È insieme rassicurante e stimolante, un’avventura protetta. I ragazzi devono imparare il gusto dell’altrove. Bob Dylan si chiedeva «quante strade deve percorrere un uomo, prima che possiamo chiamarlo uomo». La risposta, secondo lui, soffiava nel vento. Soffia anche nelle vostre aule e nelle nostre case, se sappiamo ascoltare. Ai nostri ragazzi dobbiamo dare radici e ali: il resto lo troveranno da soli.
Il maestro dà al ragazzo tutto quello che crede, ama, spera. Il ragazzo crescendo ci aggiunge qualche cosa e così l’umanità va avanti. (pagina 112)
Voi dovete essere buoni insegnanti anche perché ci sono in giro tanti cattivi maestri. I ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento diversi dai genitori: un amico più grande, uno zio eccentrico, un rapper convincente, un compagno di squadra. E un insegnante speciale. Il complimento d’un professore, a una certa età, vale più dell’incoraggiamento di mamma e papà. Certo: ai ragazzi bisogna spiegare che neppure il miglior insegnante può far molto, se trova continue chiusure. Dicono i cinesi: il maestro arriva quando il discepolo è pronto.
Un’altra materia che non fate e che io saprei è educazione civica. Qualche professore si difende dicendo che la insegna sottintesa dentro le altre materie. Se fosse vero sarebbe troppo bello. (pagina 123)
Un’idea, prof: non chiamatela «educazione civica», chiamatela educazione digitale. E portate i ragazzi in cattedra con voi: loro spiegheranno la tecnologia, voi le norme. Perché le norme - quelle del buon senso e quelle del diritto penale - valgono anche sul web, che è un luogo della vita. Molestie, minacce, stalking, calunnie, diffamazione: i ragazzi devono capire che certi errori si possono commettere molto presto; e lasciano conseguenze. Internet ha messo nel telefono e nel computer dei vostri studenti uno strumento di comunicazione di massa, un moltiplicatore, un veicolo potente e potenzialmente pericoloso. I nostri giovani connazionali sanno guidarlo. Ma bisogna aiutarli a capire quando fermarsi, e dove non andare.
Consegnandomi un tema con un quattro lei mi disse: «Scrittori si nasce, non si diventa». Ma intanto prende lo stipendio come insegnante d’italiano. (pagina 125)
Tutto s’impara: dove non arriva il talento, arriva la tenacia. Sa che, in prima superiore, ho preso qualche insufficienza in italiano scritto? Usavo vocaboli incomprensibili, una sintassi barocca, concetti astrusi. Devo ringraziare due sue colleghe - Paola Cazzaniga Milani al ginnasio, Giuseppina Torriani al liceo - se ho cambiato registro. A proposito: oggi come me la sono cavata?
-
> Don Lorenzo Milani --- “Route della Costituzione”. Da Monte Sole a Barbiana, 100 km di pace a piedi tra Emilia e Toscana con Pax Christi. Dal 18 al 25 agosto confronto sul tema “la democrazia secondo la Costituzione italiana”.6 giugno 2013, di Federico La Sala
“Route della Costituzione”
Da Monte Sole a Barbiana, 100 km di pace a piedi tra Emilia e Toscana con Pax Christi
Dal 18 al 25 agosto confronto sul tema “la democrazia secondo la Costituzione italiana”.
di Pax Christi *
Parteciperanno, tra gli altri, fr. Luca Daolio, monaco dossettiano, Domenico Cella, costituzionalista, Anna Rosa Nannetti e Francesco Pirini, testimoni della strage di Monte Sole, Stefano Tagliaferri, amministratore e già presidente della Comunità montana del Mugello, mons. Giovanni Giudici, presidente Pax Christi, Siriana Farri, ex dirigente scolastica, Michele Gesualdi, ex alunno della scuola di Barbiana.
La “Route della Costituzione” di Pax Christi, che arriva quest’anno alla sua sesta edizione, si svolgerà dal 18 al 25 agosto. I partecipanti cammineranno da Monte Sole a Barbiana, dai luoghi della più sanguinosa strage nazifascista, dove oggi è la sede della Piccola Famiglia dell’Annunziata, comunità religiosa fondata da Giuseppe Dossetti, che fu anche fra i più importanti Padri Costituenti, alla sperduta parrocchia di montagna dove don Milani concepì e realizzò la sua scuola per gli ultimi, i figli dei montanari che dovevano diventare "cittadini sovrani", dando concreta attuazione ai principi della Costituzione: non a caso don Milani affermava che i suoi fondamentali punti di riferimento erano il Vangelo e la Costituzione.
Tra l’imbocco del sentiero che sale a Monte Sole e la scuola di Barbiana c’è una distanza di circa 100 chilometri, che nelle ultime cinque estati è stata percorsa, in gruppo, da molti giovani e meno giovani accomunati dall’interesse per la scoperta, o riscoperta, dei luoghi dove è si è fatta e si continua a fare resistenza contro i razzismi, le discriminazioni, la guerra, la violenza: a Monte Sole sessantotto anni fa i contadini e gli sfollati cercarono di difendersi dall’odio razzista delle SS e caddero in 770; a Barbiana più di cinquant’anni fa un “prete scomodo” inventò una scuola che nessuno avrebbe mai potuto copiare, ma che da allora è un modello per tutti quelli che amano davvero la scuola, e amano ancora di più i loro allievi, e che a Barbiana continuano ad andare per respirare quell’aria pura che fatica ancora ad entrare nelle altre scuole; ancora a Monte Sole, alla Scuola di Pace, oggi si impara, tra l’altro, a condividere e a convivere tra giovani ebrei e palestinesi e tra cattolici e protestanti dell’Irlanda del Nord.
Il percorso della route - che si snoda nei luoghi dove si è combattuta la Seconda Guerra Mondiale e si è fatta la Resistenza e dove quindi, come ha detto Calamandrei, è letteralmente nata la Costituzione - diventerà un vero e proprio nuovo sentiero, che è già segnalato nella parte iniziale con i cartelli che riportano integralmente il testo dei primi 13 articoli della Costituzione italiana; gli altri articoli, cadenzati lungo il percorso, seguiranno e l’auspicio è che prima o poi si possano trovare i necessari finanziamenti e arrivare a posare tutti i cartelli.
Come ogni anno la route propone un tema da approfondire: quest’anno i partecipanti alla route si confronteranno su “la democrazia secondo la Costituzione italiana”. Aiuteranno ad approfondire il tema, tra gli altri, fr. Luca Daolio, monaco dossettiano, Domenico Cella, costituzionalista (Presidente Istituto Regionale di Studi sociali “Alcide De Gasperi”) , Anna Rosa Nannetti e Francesco Pirini, testimoni della strage di Monte Sole, Stefano Tagliaferri, amministratore e già presidente della Comunità montana del Mugello, mons. Giovanni Giudici, presidente Pax Christi, Siriana Farri, ex dirigente scolastica, Michele Gesualdi, ex alunno della scuola di Barbiana.
Per informazioni e iscrizioni si può visitare il sito www.paxchristi.it , scrivere a segreteria@paxchristi.it , paxchristibologna@tin.it, telefonare al numero 055 2020375 (Segreteria nazionale Pax Christi).
* Il Dialogo, Martedì 04 Giugno,2013
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana --- «A noi ragazzi disse: dall’ingiustizia si esce insieme». Intervista a Michele Gesualdi, a cura di Osvaldo Sabato28 maggio 2013, di Federico La Sala
«A noi ragazzi disse: dall’ingiustizia si esce insieme»
intervista a Michele Gesualdi,
a cura di Osvaldo Sabato (l’Unità, 27 maggio 2013)
Per chi lo ha conosciuto bene don Lorenzo Milani continua a rimanere l’uomo del futuro, nonostante che gli anni della morte abbiano superato quelli della vita», dice Michele Gesualdi. A novant’anni dalla nascita del prete di Barbiana, il 27 maggio del 1923 a Firenze (ma il destino ha voluto che se ne andasse a 44 anni il 26 giugno 1967) quanto è ancora attuale il suo messaggio?
Michele Gesualdi fu uno dei primi sei allievi di don Milani, oggi è presidente della Fondazione che porta il suo nome, dopo essere stato per anni sindacalista della Cisl e per due mandati presidente della Provincia di Firenze. Chi meglio di lui avrebbe potuto raccontare la storia di don Milani, il priore, come si faceva chiamare dai suoi scolari.
Per il novantesimo dalla nascita è in programma una mostra dal titolo «Don Lorenzo Milani e la pittura - Dalle opere giovanili al Santo Scolaro » che sarà inaugurata il prossimo 6 giugno a Palazzo Medici Riccardi, presso gli spazi espositivi della Provincia di Firenze: oltre 80 opere tra dipinti e disegni, provenienti da collezioni private, di un appassionato studente realizzati all’età di 18 /20 anni, dalle lezioni del pittore Hans-Jachim Staude sino agli studi anatomici presso l’Accademia di Brera.
Non solo. Saranno pubblicati anche scritti inediti che comprendono il carteggio con don Mazzolari, con don Bensi che poi sarebbe diventato suo confessore e quello con monsignor Capovilla. Proprio a lui don Milani chiese allora se il decreto del Santo Uffizio del ’58, che aveva ritirato dal commercio il suo libro «Esperienze pastorali» e ne aveva vietate le traduzioni, potesse considerarsi ormai superato.
A questo proposito è bene ricordare che qualche anno fa la Fondazione lanciò un appello a Papa Ratzinger per la cancellazione della condanna del Vaticano. «Ufficialmente a quella lettera non hanno mai risposto, per vie ufficiose ci è stato detto che con la fine del Santo Uffizio non ci sono più le sentenze emesse, però noi avremmo preferito due righe scritte», dice ora Gesualdi.
Ma oggi il pensiero va a quel prete che si dedicò agli ultimi, alla sua lezione. «Vede, io credo che il messaggio di Don Milani non sia stato logorato dagli anni che sono passati, continua ad essere fresco ed attuale», osserva l’ex allievo, ricordando le migliaia di scolaresche che ancora oggi visitano la scuola di Barbiana. «Io non riesco a immaginarlo vecchio, lo immagino giovane, lui è ancora l’uomo del presente », insiste.
Un esempio della sua bruciante attualità, spiega Gesualdi, è il libro «L’obbedienza non è più una virtù» che comprende «Lettera ai cappellani militari» e «Lettera ai giudici» : si tratta di una forte autodifesa del priore di Barbiana, dopo una denuncia per apologia di reato presentata da un gruppo di ex combattenti, che criticavano i renitenti alla leva. «Sono scritti molto attuali anche dal punto di vista politico», commenta Gesualdi. Che aggiunge. «Lui già allora aveva messo in evidenza i guasti della politica».
Ma come avrebbe commentato quella di oggi? «Direbbe ciò che ha sempre insegnato ai suoi ragazzi: il mondo è ingiusto, perché ci sono i primi e gli ultimi» risponde. «E lo strumento della parola e della cultura può servire a cambiare questo mondo ingiusto».
È un concetto che il sacerdote di Barbiana ha ribadito ai suoi ragazzi fino agli ultimi giorni della sua vita. La scuola di Barbiana nacque dal nulla. «Non c’erano aule, banchi, sedie, libri, carte geografiche. Tutto doveva essere inventato: i banchi li costruimmo noi insieme a lui, come i tavoli e le sedie, anche le carte geografiche erano disegnate a mano con grande cura, poi diventavano strumento per il nostro studio e per quelli che venivano dopo. Noi avevamo al massimo uno o due testi, un ragazzo leggeva ad alta voce e don Lorenzo spiegava a tutti. Quindi fu una scuola che nacque dal niente. Ciò dimostra che per fare cose importanti è fondamentale avere la volontà e l’intuizione che spinge il mondo».
Perché era una scuola diversa dalle altre? «A Barbiana c’erano solo figli di contadini. Don Lorenzo arrivò in un paese dove il prete veniva ritenuto dalla parte del padrone. Trovò in quel posto il concentrato delle ingiustizie sociali. Io credo che, influenzato e riformato da questa nuova cultura che lui non conosceva, acquisì subito occhi, orecchie, bocca nuova, come il cuore. Ebbene, lui presto diventò lo strumento di comunicazione di quella cultura. E Lettera a una professoressa non era altro che il confronto fra le scuole frequentate dai borghesi e la cultura del popolo.
Don Lorenzo fece la sua scuola diversa dalle altre, a partire dall’orario che era di dodici ore al giorno, una manna per i figli dei contadini, che erano costretti a fare sedici ore di lavoro puzzolente e disagiato nelle stalle: per loro la scuola era un grande privilegio. Fra la nostra scuola e quella di Stato erano diversi anche gli obiettivi: la scuola statale indicava obiettivi bassi, mancava il mondo che soffre. E in Lettera a una professoressa questo concetto di don Milani viene espresso con la frase celeberrima: stando insieme ho imparato che uscire da soli è l’avarizia, uscire insieme è la politica».
A distanza di anni, secondo lei quale tipo di scuola ha vinto? «Secondo meLettera a una professoressa è stata una bella frustata nella carne viva del sistema italiano. Però bisogna dire che poi il sistema ha messo in atto gli anticorpi e, sostanzialmente, la scuola è rimasta selettiva».
Ma che persona era don Milani? Si arrabbiava mai con voi? In che modo si faceva sentire? «Era uno che aveva scelto, era schierato con gli ultimi, per cui tutto era finalizzato alla crescita di quel gruppo di figli di contadini, con questa grande capacità di trasformare il particolare dei suoi ragazzi in un ragionamento universale. Per cui noi vedevamo don Lorenzo dolcissimo con i ragazzi, molto premuroso con questo desiderio di vederli sbocciare, crescere, per aiutarli a buttare fuori quell’anima che Dio ha fatto uguale a quella degli altri, non abbrutita. Invece con il mondo intellettuale e borghese era di una ferocia enorme».
Lei ha mai assistito a qualche scontro con gli intellettuali e i politici dell’epoca? «Quando a Barbiana venne Pietro Ingrao, fu duramente attaccato da don Lorenzo. Poi diventarono grandi amici».
Oggi abbiamo una Chiesa con due Papi, uno dimissionario e l’altro in carica, chissà come l’avrebbe vista don Milani... «Ricordo che quando parlava di Celestino V, il pontefice del gran rifiuto, si diceva dispiaciuto del gesto che fece», racconta il presidente della Fondazione. Ma la Chiesa di allora aveva compreso la missione di don Milani? «Per la verità, non l’ha capita nemmeno quella di ora».
Un prete del mondo, che guarda al mondo: sarebbe curioso sapere, nell’epoca di Facebook e Twitter, come avrebbe reagito don Milani. «Avrebbe apprezzato questi nuovi strumenti, pensi che a noi insegnò a usare la calcolatrice», risponde sicuro Gesualdi. Quindi si potrebbe addirittura immaginare che avrebbe aperto una pagina sui social network? «No, credo proprio di no», è la conclusione di chi il prete di Barbiana lo ha conosciuto.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana --- «A noi ragazzi disse: dall’ingiustizia si esce insieme». - Ricordando Michele Gesualdi (La redazione di Mosaico di pace).e20 gennaio 2018, di Federico La Sala
Ricordando Michele Gesualdi*
Ci uniamo alla preghiera di tanti per la morte di Michele Gesualdi, l’allievo di don Lorenzo Milani, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla figlia Sandra e al fratello Francuccio.
A noi tocca, più che mia, cogliere l’eredità di don Lorenzo e attualizzarla. Perché tutti abbiano diritto di parola.
«Crediamo che di fronte a una persona che come don Lorenzo ha lasciato un segno nella storia - scrivevano Michele e Francuccio in Toscana Oggi il 21 aprile 2017 -, l’unico atteggiamento corretto è capire cosa ha ancora di importante da dirci, per assumerci le nostre responsabilità. Ossia per chiederci come applicare nel nostro tempo la sua proposta intramontabile. Don Lorenzo ha speso la sua vita per ridare dignità ai contadini e agli operai, che a causa della propria inferiorità culturale, erano umiliati, oppressi e saccheggiati da imprenditori, proprietari terrieri e ogni sorta di profittatori».
La redazione di Mosaico di pace
-
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana ---- LA MOSTRA. Don Milani si rivela nel suo autoritratto (di Michele Brancale)11 maggio 2013, di Federico La Sala
LA MOSTRA
Don Milani si rivela nel suo autoritratto
di Michele Brancale (Avvenire, 11 maggio 2013)
Dalle opere giovanili al mosaico del Santo Scolaro nella chiesa di Sant’Andrea a Barbiana. Firenze apre gli spazi di Palazzo Medici Riccardi, al primo piano, nella sede della Provincia, per la prima completa mostra di opere artistiche di don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana (1923-1967).
Si tratta in larghissima parte di lavori che precedono e in un certo senso preparano la sua conversione. Realizzati tra Milano, dove la famiglia si trasferisce nel 1930 e dove studia al liceo Berchet, frequenta l’Accademia di Brera tra il ’41 e il ’42 e apre uno studio di pittore, e Firenze, dove la famiglia torna definitivamente alla fine del ’42 e dove, nel ’43, lui entra in seminario.
Su progetto della Fondazione dedicata al priore, in collaborazione con la Provincia di Firenze, la mostra, a cura di Cesare Badini e Sandra Gesualdi, sarà allestita da Bernardo Delton e resterà aperta dal 5 giugno al 24 luglio. «Circa un anno fa una delle due nipoti di don Milani ci ha contattato - racconta Sandra Gesualdi - per dirci che avevano ritrovato i quadri di Lorenzo e aveva piacere che organizzassimo una mostra per renderli pubblici». Una mostra, con alcuni quadri e soprattutto disegni anatomici, si era svolta nel 2009 sempre a Firenze, ma la prossima esposizione rappresenta la prima offerta completa dell’opera pittorica.
«Abbiamo contattato parenti e raccolto testimonianze, interviste, dati - continua Gesualdi -. Un percorso lunghissimo che ha portato alla luce aspetti nuovi del priore, evidenziando il fervore culturale in cui è cresciuto». Saranno esposti oltre trenta dipinti su tela e tavolette, più di venti disegni tra la serie anatomica e la serie accademica, anche schizzi - ed è una novità - di disegni barbianesi, i mosaici e anche un filmino su una lezione di pittura a Barbiana».
Proprio nelle lezioni con i ragazzi di Barbiana, affioravano accenni di don Lorenzo al periodo giovanile, quando parlava dei colori del tramonto, della scoperta del tendine di Achille o accennava alle visite a chiese e conventi per studiare la tecnica degli affreschi, «salvo poi perdere l’interesse artistico - ricordano alcuni suoi allievi - quando i monaci intonavano inni religiosi in gregoriano, che toccavano nel profondo». Rimangono 80 opere tra dipinti e disegni, provenienti da collezioni private, realizzati da un appassionato studente tra i 18 e i 20 anni, frutto in parte delle lezioni apprese da Hans-Joachim Staude (1904-1973), pittore che dopo un’immersione nell’espressionismo si era poi dedicato all’osservazione della natura e quindi si era avvicinato all’impressionismo; e di quelle dei pittori Bruno Cassinari (1912-1992) ed Ennio Borlotti (1910-1992).
Nello straordinario "Autoritratto" sembra evidenziarsi con una certa incisività il filone mitteleuropeo (la madre Alice Weiss, peraltro, veniva proprio da quel contesto geografico e culturale) che fa pensare anche a Egon Schiele. Note sono anche la lettura che Milani fece in quegli anni di Le Corbusier e, successivamente, l’amicizia con l’architetto Giovanni Michelucci (1891-1990), che salirà più volte a Barbiana. La mostra aiuta, dunque, la tessitura di una più puntuale ricognizione biografica per illuminare l’interiorità di Lorenzo Milani da giovane. Entrato in seminario, tornò a visitare in Oltrarno Staude (non cattolico, vicino al buddismo) al quale attribuirà la propria conversione.
«Tu mi hai parlato - gli dirà - della necessità di cercare sempre l’essenziale, di eliminare i dettagli e di semplificare, di vedere le cose come un’unità dove ogni parte dipende dall’altra. A me non bastava fare tutto questo su un pezzo di carta. Non mi bastava cercare questi rapporti tra i colori. Ho voluto cercarli tra la mia vita e le persone del mondo. E ho preso un’altra strada». Nel luglio ’73 Alice Weiss, madre di Milani, scriverà a Renate Staude, moglie di Hans-Joachim, rimasta da poco vedova. «...Penso molto a Lorenzo - scrive Alice - che in Staude ha avuto il suo primo maestro. Maestro di serietà, di coscienza, di quella ricerca dell’assoluto nel bene e nel bello che poi ha portato Lorenzo alla sua strada».
Vi sono altri elementi convergenti, come la pausa estiva del ’42 nella villa di famiglia a Gigliola (Montespertoli), dove avrebbe dipinto la cappella annessa e dove rinviene un messale che lo appassiona (scrive a un amico che: è più interessante dei personaggi in cerca di autore di Pirandello), le lunghe passeggiate e le visite alle chiese di Milano con l’amica Carla Sborgi, e quel decisivo colloquio nel giugno del ’43 con don Raffaele Bensi (1886-1995) proprio davanti a Palazzo Medici Riccardi, che guidò i passaggi del suo ingresso in seminario nel novembre dello stesso anno. Sul retro di un santino don Milani scriverà anni dopo le date fondamentali della sua vita apponendo su di esse una citazione del libro della Sapienza: «A chi non capiva è parso ch’io morissi».
Michele Brancale
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". --- Don Milani: «Volevo dipingere il mondo» (di Michele Brancale)29 giugno 2012, di Federico La Sala
Don Milani: «Volevo dipingere il mondo»
di Michele Brancale (Avvenire, 26 giugno 2012)
Nell’estate del 1942 Lorenzo Milani (1923-1967) in vacanza nella tenuta di famiglia a Gigliola, nei pressi di Montespertoli, entra nella cappellina sconsacrata della villa, vi rinviene un messale e lo legge avidamente, rimanendone prima attratto dall’estetica della liturgia («è più interessante dei Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello») e poi dai contenuti. È una componente essenziale del suo cammino di conversione, compiuta la prima fase del quale entra in seminario e finisce la sua attività di pittore, cominciata a Milano circa due anni prima.
Conclusi gli studi al liceo Berchet, infatti aveva rifiutato di iscriversi all’università a favore, invece, dell’apprendimento della pittura. Alcuni passaggi sono noti. Il professor Giorgio Pasquali presenta alla famiglia Milani il pittore Hans Joachim Staude (1904-1973), perché segua la formazione nelle arti figurative del giovane Lorenzo che, nel ’41, si iscrive all’Accademia di Brera, affitta uno studio e firma le sue opere "Lorenzino Dio e pittore".
Da una parte spinto alla ricerca dell’essenziale da Staude, Milani si lascia attrarre dalle opere dei pittori Bruno Cassinari (1912-1992) ed Ennio Morlotti (1910-1992), non trascurando la lettura di Le Corbusier che accompagna le sue passeggiate nelle chiese di Milano (già prete, diventerà amico di Giovanni Michelucci).
Di quella stagione, la Fondazione don Lorenzo Milani, presieduta da Michele Gesualdi, ha rintracciato, per ora, 45 quadri e 20 disegni anatomici, che sono al centro di un progetto di esposizione, in autunno, a Firenze e Milano. Ne saranno promotori la Fondazione, la Provincia di Firenze, il Comune di Milano e il liceo Berchet della città ambrosiana.
Vi stanno lavorando uno dei "ragazzi" di don Milani, Michele Gesualdi per l’appunto, il professor Cesare Badini, l’architetto Bernardo Delton e la curatrice Sandra Gesualdi. Alla luce delle ricerche compiute, quest’attività, più che finire, diventa uno degli strumenti dell’attività pastorale di don Lorenzo. Gli studi di disegno e pittura si riveleranno, ad esempio, preziosi nella progettazione delle opere utili all’attività didattica (don Milani non era un dilettante, nemmeno in questo) e pastorale (la cartina della Terra Santa, il mosaico del "Santo scolaro").
«Credo che alcune inquietudini che lo avrebbero spinto alla conversione - sottolinea Gesualdi - siano nate dagli studi anatomici compiuti sui cadaveri. Le note di accompagnamento ai disegni rivelano una volontà di comprendere a fondo chi era il soggetto ritratto, ricostruirne la storia». L’osservazione è confortata dai ricordi di Adele Corradi, insegnante che condivise a Barbiana la conduzione della scuola, nel recente Non so se don Lorenzo (Feltrinelli).
«Non gli ho mai chiesto nulla sulla sua conversione - spiega Corradi - Mi limitavo a registrare nella memoria quello che lui diceva. Capitava infatti che raccontasse di momenti in cui era avvenuto come un "incontro": la lettura del libro Il ponte di San Luis Rey, la scoperta del tendine di Achille mentre sezionava un cadavere (faceva il pittore e, diceva, "un pittore doveva conoscere l’anatomia"), la visita al convento di Monte Oliveto Maggiore ("chi ci pensava più agli affreschi... sentendo il canto dei monaci")».
Dal seminario Lorenzo troverà tempo per tornare a trovare il suo maestro Staude, che tutto era tranne che cattolico (si avvicinerà al buddismo, per apprendere alcune tecniche) e che gli chiede il motivo della sua scelta di farsi prete. «È tutta colpa tua - risponde il giovane Milani -. Perché tu mi hai parlato della necessità di cercare sempre l’essenziale, di eliminare i dettagli e di semplificare, di vedere le cose come un’unità dove ogni parte dipende dall’altra. A me non bastava fare tutto questo su un pezzo di carta. Non mi bastava cercare questi rapporti tra i colori. Ho voluto cercarli tra la mia vita e le persone del mondo. E ho preso un’altra strada».
Proprio oggi, a Barbiana, si ricorderanno i 45 anni dalla scomparsa di don Milani, con un convegno nei locali della Scuola di Barbiana (Vicchio di Mugello) a cui prenderà parte il sottosegretario alla Pubblica istruzione Marco Rossi Doria sul tema "La scuola è malata, ripartiamo da Barbiana". Don Renzo Rossi invece parlerà del "Prete don Lorenzo". Alle 17 liturgia presieduta dal cardinale Silvano Piovanelli, arcivescovo emerito di Firenze, in suffragio di don Lorenzo e anche di Eda Pelagatti, sua principale collaboratrice a Barbiana. Il 15 settembre, a Firenze, convegno su "La paternità di don Lorenzo Milani" con la pubblicazione di nuovi scritti inediti. Quindi la mostra.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e --- un povero sacerdote bianco (di Luca Kocci - L’esplosiva profezia del benecomunismo)24 giugno 2012, di Federico La Sala
L’esplosiva profezia del benecomunismo
di Luca Kocci (il manifesto, 23 giugno 2012)
Poco prima di essere trasferito dalla parrocchia di San Donato a Calenzano - un centro operaio tessile alle porte di Firenze - nella sperduta Barbiana - un gruppo di case sparse sul monte Giovi, nel Mugello - don Lorenzo Milani scrisse una lettera appassionata alla madre: «Ho la superba convinzione che le cariche di esplosivo che ci ho ammonticchiato in questi cinque anni non smetteranno di scoppiettare per almeno 50 anni sotto il sedere dei miei vincitori».
Parroco di 40 anime Era il 1954, lo scontro Dc-Pci era aspro, il decreto con cui il Sant’Uffizio nel ‘49 aveva scomunicato i comunisti restava pienamente in vigore, e quel giovane prete - che comunista non era, ma aveva più volte confessato come errore il voto alla Dc il 18 aprile del 1948 («è il 18 aprile che ha guastato tutto, è stato il vincere la mia grande sconfitta », scrive a Pipetta, un giovane comunista calenzanese) - non allineato agli ordini della Curia, di piazza del Gesù e della Confindustria andava reso inoffensivo: esiliato sui monti, priore di una chiesa di cui era già stata decisa la chiusura, «parroco di 40 anime», come disse egli stesso.
Eppure, nonostante il confino imposto dall’arcivescovo di Firenze Ermenegildo Florit, la «superba convinzione» di Milani pare essersi realizzata: le «cariche di esplosivo» piazzate «sotto il sedere» dei vincitori, a 45 anni dalla sua morte (il 26 giugno 1967), continuano a «scoppiettare».
Non hanno avuto la forza d’urto in grado di sovvertire il sistema, ma alcune intuizioni, per lo più inattuate, e molte denunce, inascoltate, conservano intatta la loro dirompenza. Per cui, se è vero che il valore di una vicenda si misura anche con la capacità di anticipare i tempi della storia, allora quella di Lorenzo Milani resta un’esperienza "profetica" che ancora parla alla società, alla politica e alla Chiesa di oggi.
L’ospedale che cura i sani
La scuola rimane l’ambito principale, ma non l’unico. Insieme ai suoi "ragazzi" ne denunciò il classismo in Lettera a una professoressa e la sperimentò come prassi liberatoria, sia nella scuola popolare serale per gli operai di Calenzano, 20 anni prima delle "150 ore" conquistate con lo Statuto dei lavoratori del ‘70, sia nella scuola di Barbiana per i piccoli montanari del monte Giovi. I ministri, sia politici che tecnici, che negli anni si sono avvicendati a viale Trastevere, con qualche eccezione, si sono mostrati devotissimi all’idea milaniana di una "scuola per tutti" - il 26 giugno è in programma l’ennesimo convegno al ministero: Salire a Barbiana 45 anni dopo - e contemporaneamente abilissimi ad ignorarla nella prassi. Magari immaginando una didattica multimediale 2.0 in istituti con classi di 30-35 alunni o inventando premi speciali a pochi studenti apparentemente meritevoli - l’ultima idea di Profumo -, mentre si tagliano risorse, maestre, prof, insegnanti di sostegno e ore di lezione per tutti, così da trasformare la scuola in «un ospedale che cura i sani e respinge i malati», «strumento di differenziazione » piuttosto che ascensore sociale, si legge in Lettera a una professoressa.
E «se le cose non vanno, sarà perché il bambino non è tagliato per gli studi», anche in prima elementare, come i 5 alunni bocciati nella scuola elementare di Pontremoli, pochi giorni fa. È dimenticata la lingua, «la lingua che fa eguali », e le lingue che, in un’ottica "internazionalista", consentono agli oppressi di tutto il mondo di unirsi: a Barbiana studiamo «più lingue possibile, perché al mondo non ci siamo soltanto noi. Vorremmo che tutti i poveri del mondo studiassero lingue per potersi intendere e organizzare fra loro. Così non ci sarebbero più oppressori, né patrie, né guerre».
Milani mandava all’estero i giovanissimi studenti del Mugello, bambine comprese, vincendo paure e resistenze delle famiglie: ne è testimonianza vivente Francesco Gesualdi, ex allievo di Barbiana, a 15 anni spedito in Nord Africa ad imparare l’arabo, oggi infaticabile animatore del Centro nuovo modello di sviluppo per i diritti dei popoli del sud del mondo.
Ci sono anche i beni comuni
Non c’è solo la scuola. Ci sono anche i beni comuni: acqua e casa. È poco nota, ma di grande significato, la lotta fatta insieme ai montanari barbianesi per la costruzione di un acquedotto che avrebbe dovuto portare l’acqua a nove famiglie. Una battaglia persa, perché un proprietario terriero rifiutò di concedere l’uso di una sorgente inutilizzata che si trovava nel suo campo, mandando così all’aria, scrive Milani in una lettera pubblicata nel ‘55 dal Giornale del Mattino di Firenze (allora diretto da Ettore Bernabei) «le fatiche dei 556 costituenti», «la sovranità dei loro 28 milioni di elettori e tanti morti della Resistenza», madre della Costituzione repubblicana.
Di chi è la colpa? Della «idolatria del diritto di proprietà». Quale la soluzione? Una norma semplice, «in cui sia detto che l’acqua è di tutti».
E la casa, col piano Ina-Casa di Fanfani che avrebbe dovuto assicurare un tetto ai lavoratori, ma che venne realizzato solo in minima parte, mentre continuavano gli sgomberi di chi occupava le ville di ricchi borghesi che di abitazioni ne avevano due o tre, tenute vuote «per 11 mesi all’anno».
«La proprietà ha due funzioni: una sociale e una individuale», e «quella sociale deve passare innanzi a quella individuale ogni volta che son violati i diritti dell’uomo», scrive Milani nel ‘50 su Adesso, il giornale di don Mazzolari. Queste parole «domenica le urlerò forte. Vedrete, tutti i cristiani saranno con voi. Sarà un plebiscito. Faremo siepe intorno alla villa. Nessuno vi butterà fuori». Ma non succederà nulla, noterà Milani, che ripeterà: «Mi vergogno del 18 aprile».
La guerra e la storia, attraversate dalla responsabilità individuale - «su una parete della nostra scuola c’è scritto grande: I care», ovvero «me ne importa, mi sta a cuore. È il contrario esatto del motto fascista “Me ne frego”» -, altri temi forti dell’esperienza di Milani: la difesa dell’articolo 11 della Costituzione, l’obiezione di coscienza agli ordini ingiusti soprattutto se militari («l’obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni »), l’opposizione alla guerra e alla guerra preventiva, 40 anni prima di Bush, perché «in lingua italiana lo sparare prima si chiama aggressione e non difesa».
E una rilettura della storia che prende le distanze da ogni suo "uso pubblico" nazionalista e patriottardo, passando in rassegna le italiche guerre, tutte «di aggressione »: da quelle coloniali di Crispi e Giolitti, al primo conflitto mondiale, fino a quelle fasciste di Mussolini, passando per il generale Bava Beccaris, decorato da re Umberto, che nel 1898 prese a cannonate i mendicanti «solo perché i ricchi (allora come oggi) esigevano il privilegio di non pagare le tasse».
Ma «c’è stata anche una guerra giusta (se guerra giusta esiste). L’unica che non fosse offesa delle altrui Patrie, ma difesa della nostra: la guerra partigiana». Quindi, scrive ai cappellani militari che avevano chiamato «vili» gli obiettori di coscienza, se voi avete diritto «di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla Curia, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto».
Un povero sacerdote bianco
Non è stato un "cattolico del dissenso" Milani - il ‘68 era ancora lontano -, ma un "ribelle obbediente", forse proprio per questo guardato con ancora maggiore ostilità dall’istituzione ecclesiastica a cui il prete fiorentino rimproverava di aver perso di vista il Vangelo per inseguire il potere: «Non abbiamo odiato i poveri come la storia dirà di noi. Abbiamo solo dormito. È nel dormiveglia che abbiamo fornicato col liberalismo di De Gasperi, coi Congressi eucaristici di Franco. Ci pareva che la loro prudenza ci potesse salvare», si legge nella visionaria Lettera dall’oltretomba di un «povero sacerdote bianco della fine del II millennio» ai «missionari cinesi» che nel futuro arriveranno in una Europa senza più preti, uccisi dai poveri, pagina conclusiva di Esperienze pastorali, il volume di Milani giudicato «inopportuno» dal Sant’Uffizio nel ‘58 e non ancora riabilitato. «Insegnando ai piccoli catecumeni bianchi la storia del lontano 2000 non parlate loro dunque del nostro martirio. Dite loro solo che siamo morti e che ne ringrazino Dio. Troppe estranee cause con quella del Cristo abbiamo mescolato».
-
> Don Lorenzo Milani: «Verrà un giorno in cui coloro che vogliono guarire le scuole malate dovranno salire a Barbiana» (di Marco Rossi Doria - Scuola malata, è ora di tornare a Barbiana).3 maggio 2012, di Federico La Sala
Scuola malata, è ora di tornare a Barbiana
di Marco Rossi Doria (La Stampa, 3 maggio 2012)
Eravamo nel pieno del boom economico e tutto sembrava finalmente andare per il meglio. Quando, nel 1967, uscì Lettera a una professoressa e arrivò in ogni angolo d’Italia il monito, severo e profetico, di don Milani: «la scuola ha un solo problema: i ragazzi che perde».
In quel libro c’erano i dati che mostravano che la classe sociale dei genitori determinava il successo o l’insuccesso scolastico, in larghissima misura. Quel monito ci sta ancora addosso. Perché è ancora oggi così. Sono i figli dei poveri a fallire a scuola. E sono tanti: il 20% del totale. Che tende a diventare il 30% e più nel Sud come nelle periferie del Centro e del Nord. Lo dicono i dati del ministero dell’Istruzione, quelli Istat, la Banca d’Italia, la relazione della Commissione indagine sulla povertà. Lo mostra, pezzo per pezzo, il bellissimo Atlante dell’infanzia a rischio , curato da Save the children ricordandoci che mentre nella maggior parte d’Europa il figlio di un genitore di medio reddito e istruito ha 2 o 3 volte più probabilità di completare l’intero ciclo di studi, da noi ha 7,7 più probabilità! Il più grande scandalo d’Italia.
Così, è passato quasi mezzo secolo. Ma resta questo il principale problema non solo della scuola ma dell’intera società italiana. Dobbiamo riuscire a dare di più a chi parte con meno nella vita e la scuola va ancora ben sostenuta perché non vi è altro luogo che possa essere leva precoce di emancipazione e riequilibrio sociale.
Per questo l’Unione Europea dal 2000 - la famosa agenda di Lisbona - ci chiede di scendere sotto il 10% di fallimento formativo. E la questione è che noi non ci siamo ancora riusciti. Benché siamo ben consapevoli che il non riuscirci, oltre a essere una minaccia alla coesione sociale, ci priva di enormi risorse umane capaci di azioni positive, un fatto che condiziona la stessa crescita economica. Perciò: l’agenda politica, le scelte nella revisione delle spese e degli investimenti pubblici deve tenere conto innanzitutto di questa questione.
Ma più che i dati, come spesso accade, le vie da imboccare per riparare alle ingiustizie generali le descrivono bene i libri che parlano di gesti, di giorni, di vicende umane.
Nelle bellissime pagine di Insegnare al principe di Danimarca (Sellerio) la molto compianta Carla Melazzini racconta del lungo nostro lavoro con i ragazzi che avevano abbandonato la scuola a S. Giovanni a Teduccio, Barra, Quartieri Spagnoli, Soccavo, Ponticelli. È una scrittura sorvegliata, severa - come Carla era - che mostra, con fatica e poesia, il lavoro della scuola che sa andare verso chi ne è stato escluso. Lavoro di grande complessità artigianale, fatto a Napoli eppure simile a quello svolto da altri insegnanti e educatori a Torino, a Verona, a Palermo, a Reggio Emilia, a Milano. Il creare un luogo salvo, una zona franca, una chance. Dove curare - nel bel mezzo delle devastazioni - le ferite sociali ed emotive.
Per restituire la guida adulta, la via dell’apprendimento, della motivazione, della cura di sé. Per ridare «la capacità di aspirare», come viene definita in un importante saggio di Arjun Appadurai (Le aspirazioni nutrono la democrazia , Et al. Edizioni).
Sono pagine difficili quelle di Carla Melazzini. Perché chiedono di ritornare a pensare alle persone che crescono. Perché chiamano l’intero sistema d’istruzione e formazione a rimettere insieme i pezzi, a coniugare meglio il sapere e il saper fare. E a misurarsi molto di più con l’essere quotidiano di ciascun ragazzo. Com’era a Barbiana, dove nell’aula di sopra c’erano i libri, le figure geometriche e le mappe, nell’aula di sotto gli arnesi per costruire e manutenere oggetti e il laboratorio di esplorazione scientifica e in ogni momento la possibilità di fermarsi e «parlare di noi», di quel che sta succedendo e di come va, senza mai dimenticare che si sta lì per imparare.
Quattro anni prima dell’uscita di Lettera a una professoressa, Adele Corradi salì a Barbiana. Ora finalmente lo racconta nel libro Non so se don Lorenzo (Feltrinelli). Era il 29 settembre 1963. Oggi decide di lasciare indietro la sua riservatezza e ci riporta proprio lì. Con un avvertimento: «Non si racconta in questo libro la storia di don Milani.... Si parla di lui, ma non se ne racconta la storia. Chi la volesse conoscere dovrà rivolgersi altrove.... Qui sono messi a fuoco frammenti di vita, frammenti sparsi, affiorati alla memoria col disordine dei ricordi».
Adele ricorda il giorno dell’inizio, domenica, S. Michele. Ma non ricorda che lezione avesse tenuto. Rammenta, però, che don Lorenzo, in modo per lui inconsueto, le disse: «Ritorni». E lei si è da allora sempre chiesta perché: «.. o gliel’ha suggerito lo Spirito Santo o io con la telepatia». Così, dopo qualche giorno ritornò. E partecipò alla prima vera lezione, un esercizio di scrittura collettiva. E di lì si va avanti nel racconto, scena dopo scena, con i gesti e il parlato riportati entro un interrogarsi profondo e semplice. Perché questo libro rimette ogni lettore nel ritmo e nella parola di quel luogo, nel suo senso quotidiano. E così Adele ci fa un regalo immenso: toglie il peso del mito a Barbiana. E finalmente restituisce quella scena alla magica imperfezione delle persone al lavoro, che tentano, che riparano, che si chiedono, che litigano, che non sanno e che comunque riescono.
Ritrovare l’occasione e il modo di fare bene scuola provando a capire il proprio tempo e il mondo è sempre possibile. E rimettersi in gioco è la chiave dell’educare. Come ci dice ancora Adele, oggi quasi novantenne: «Sono stata insegnante di lettere alle medie fino alla pensione a 67 anni. Devo confessare che ero un’insegnante identica alla destinataria di Lettera a una professoressa ... L’incontro con la scuola di Barbiana ha scavato un solco nella mia vita. Mi sono vista come non mi ero mai vista. E non solo come insegnante, ma come persona».
Dunque, la vicenda di Barbiana e delle buone scuole delle nostre troppe periferie non è solo un’azione a sostegno dell’equità e a vantaggio di una società democratica. Ma permette trasformazioni. E ci dice la direzione da prendere per tutta la scuola. Perché l’azione pedagogica diretta a chi ha più bisogno spesso muta gli approcci profondi e sa indicare vie innovative. La necessità fa virtù. Perciò don Milani diceva: «Verrà un giorno in cui coloro che vogliono guarire le scuole malate dovranno salire a Barbiana».
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, ---- Storia di Adele, la prof che seguì Don Milani nella «buona battaglia» (di Oreste Pivetta)9 aprile 2012, di Federico La Sala
Storia di Adele, la prof che seguì Don Milani nella «buona battaglia»
di Oreste Pivetta (l’Unità, 8 aprile 2012)
Adele Corradi è un’insegnante, ormai ex insegnante, quasi novantenne, che cinquant’anni fa si vide assegnare una cattedra in una scuola media di Castelfiorentino. Da dove, poco dopo la nomina, nel settembre 1963, salì per la prima volta a Barbiana, seguendo una collega che di tanto in tanto si recava a incontrare don Milani. Ero una professoressa - scrive di se stessa Adele Corradi - del tutto simile a quella professoressa cui si rivolgeva la famosa lettera.
Da quel momento non fu più «quella professoressa». Salutandola bruscamente dopo la prima visita, don Milani «si lasciò sfuggir di bocca» (lei usa questa espressione e si immagina di ascoltare un bisbiglio a denti stretti): «Ritorni». Lei tornò. Non aspettò molto. Due giorni appena. Sarebbe tornata ancora e poi ancora, fino alla morte di don Milani, nel giugno1967 (aveva quarantaquattro anni il priore di Barbiana e lo stroncò un tumore), e dopo la morte di don Milani finché non se ne andarono le ultime famiglie che avevano resistitito in quel deserto di montagna, senza acquedotto, con una sola linea del telefono, con l’energia elettrica arrivata da un paio d’anni e quella scuola, che sarebbe diventata celebre, dove si insegnava ai figli dei più poveri e dimenticati, per una cultura che fosse emancipazione, libertà, diritto... «I poveri - scrive don Milani in una lettera riferita da Adele Corradi - non hanno bisogno dei signori. I signori ai poveri possono dare una cosa sola: la lingua cioè il mezzo d’espressione. Lo sanno da sé i poveri cosa dovranno scrivere quando sapranno scrivere».
Di Barbiana Adele Corradi non aveva mai scritto. S’era rifiutata di scrivere. Malgrado, rivela, le molte insistenze, intimorita forse dalle migliaia di pagine che invece erano state scritte da altri. La bibliografia su don Milani è impressionante (e s’aggiungano le lettere, formidabile percorso biografico).
Avvicinandosi ai suoi novant’anni, Adele Corradi ha vissuto una sorta di ripensamento e ha cominciato a ricordare e ad annotare. È giusto dire annotare, perché la narrazione non si sviluppa secondo un filo, ma per frammenti, momenti di vita, impressioni, brevi dialoghi e il racconto procede per istantanee, in stringati capitoli, solidi nell’acutezza dell’osservazione e nella precisione del linguaggio (l’uso proprio delle parole, governare le parole, anche le più dure, anche le parole «proibite», come insegnava don Milani), solidi nella loro totale sincerità e nella vitalità.
Di don Milani si dà un ritratto di grande affetto ma senza reticenze, cogliendo asprezze, contraddizioni, debolezze, rievocando l’umanità e la sensibilità di quel singolare sacerdote, «con la semplice tecnica di dire la verità, senza mitizzazioni e senza enfasi», annota Beniamino Deidda in una delle due testimonianze (l’altra è di Giorgio Pecorini), che chiudono questo piccolo bellissimo libro, tra i più belli che mi siano capitati di questi tempi.
Dico bellissimo per la qualità della memoria e della scrittura, di una semplicità graffiante, per l’evidenza di ogni immagine, nella descrizione di ogni circostanza nella quale don Milani con una intelligenza che disorienta il nostro senso comune si fa, generosamente, totalmente, maestro dei suoi ragazzi, educatore dei diseducati dalla nostra società e dalla nostra scuola e abbandonati dall’una e dall’altra, in un rapporto che è d’apprendimento continuo e reciproco.
Sottolineo dell’apprendimento reciproco, perché deve imparare anche la nostra professoressa, dentro quella realtà che le è nuova e le è speciale e la sorprende, fino all’eventualità del rifiuto, eventualità respinta di fronte al fascino dell’intelligenza, che mai s’arrende all’evidenza e alla norma, di quel prete solitario e isolato, al servizio degli umili, capace di mettere la chiesa e la società alla prova delle loro macroscopiche contraddizioni, per necessità di giustizia.
Nei ricordi e nelle pagine di Adele compaiono altri personaggi, presenti o alla lontana. Presenti come altre donne, la governante Eda, la più vicina al pari di Adele, come la madre di don Milani, come la «fidanzata», lasciata per seguire una vocazione religiosa dal giovane ricco borghese che voleva darsi alla pittura. Presenti come altri sacerdoti, padre Balducci, l’intellettuale, in vigorosapolemica, come Bruno Borghi, il prete operaio. E sullo sfondo Firenze, la città del sindaco La Pira,
la politica, la curia, le gerarchie (ma Firenze era anche la città dell’Isolotto e di don Enzo Mazzi). Adele Corradi racconta come don Milani insistesse caparbio perché il cardinal Florit salisse a Barbiana: non lo chiedeva per superbia, ma semplicemente perché, come spiegava, rimanendo nella stanze del suo arcivescovado il monsignore non avrebbe potuto capire nulla di quel che accadeva lassù.
Nel ricordo di tutti, è, ovviamente, la Lettera a una professoressa, che don Milani attribuì sempre ai suoi scolari, che fu ragione di stimolo e di confronto per una generazione, che poco alla volta l’abbandonò, scegliendo altre strade.
Non so quanto sia presente, al di là del titolo divenuto un «simbolo», di per sé solo, tra i ragazzi d’oggi. Certo che l’insegnamento di don Milani e della Lettera parlano ancora una lingua attuale. Ad esempio su una questione apparentemente solo «di chiesa»: l’esercizio della preghiera. Il prete di Barbiana, senza ipocrisia, riconosce che bisogna pregare, facendo però attenzione alle circostanze e badando quindi alle urgenze: «Se c’era urgenza bisognava agire». Adele non apprezza: «...guardavo fuori, sul Monte Aùto, la casa del contadino che bestemmiava in ginocchio (perché la bestemmia arrivasse meglio ‘lassù’) ...».
Alla fine don Milani è sbrigativo: «Sarà urgente pregare quando a tutti sembrerà importante operar». Operare, fare, contro la logorrea e l’attesa di certi intellettuali, la maggior parte. Sul letto di morte don Milani rivede la sua «buona battaglia» e ne affida ai superstiti il futuro. Di tanto discorso Adele Corradi ricorda solo poche parole: «Ora tocca a voi».
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- La ricreazione non è finita. Le memorie di Adele Corradi (di Goffredo Fofi)11 marzo 2012, di Federico La Sala
DON MILANI (1923-1967)
La ricreazione non è finita
Le memorie di Adele Corradi, stretta collaboratrice a Barbiana, che non sarebbero piaciute a don Lorenzo
di Goffredo Fofi (Il sole 24 Ore - Domenicale, 11 marzo 2012)
A 88 anni Adele Corradi, un’insegnante che fu stretta collaboratrice a Barbiana di don Lorenzo Milani nei suoi ultimi anni di vita (dal 1963, quando aveva 39 anni) ha scritto delle memorie, brani lunghi o brevi che evocano una vicenda molto nota, perché su don Milani si è scritto moltissimo, in chiave agiografica e talvolta, molto quando era in vita, denigratoria.
La Corradi ha voluto essere assolutamente sincera, ha voluto dare di don Lorenzo l’immagine il più possibile rispondente al vero, e occorre subito dire che è riuscita a farlo: il don Milani che narra, quello che lei ha conosciuto, è, con quello delle lettere, il don Milani che resterà; con la sua grandezza e con le sue contraddizioni ma modello di un rigore di cui pochi italiani sono stati capaci e di cui, negli ultimi decenni, anche in ambiente religioso e in ambiente scolastico, sembra essersi perduto, speriamo transitoriamente, il seme.
È la convinzione profonda di essere nel giusto difendendo i suoi ragazzi barbianesi dalla scuola com’era - figuriamoci cosa direbbe oggi della scuola come è diventata! - e dalla cultura borghese che era, diceva e non sbagliava, loro nemica, a colpire di più nella personalità di questo prete che pure veniva dalla miglior borghesia del suo tempo.
La Corradi è ben cosciente di questa radicalità e l’approva e sostiene, ma portando a Barbiana una componente di "genere", la capacità di una mediazione al femminile in cui trova alleata non altre insegnanti ma la Eda, la contadina che lavora per la piccola comunità barbianese, che capisce bene don Milani e che don Milani ama moltissimo, ma nei cui confronti ha a volte scatti di un maschilismo che sconcertano anche la Gonadi.
Non so se don Lorenzo, il titolo del libro, esprime il dubbio della Corradi sulle reazioni che egli avrebbe avuto alla lettura di questo libro, e chiarisce il lungo rinvio nello stendere questi ricordi, quasi in chiave testamentaria, di estrema e doverosa testimonianza.
È pieno di aneddoti significativi sui rapporti di don Milani con le autorità ecclesiastiche, con i ragazzi di Barbiana (ma su questo avremmo voluto saperne e capirne di più) e con gli abitanti di quella parte del Mugello e della Toscana proletaria di quegli anni che egli ha ben conosciuto al tempo di Esperienze pastorali. E contiene un piccolo regesto di frasi forti di don Milani. «Dei borghesi bisogna servirsene, ma senza affezionarcisi». Di certi preti perbene: «A furia di esami di coscienza trasformano in cura di sé perfino il cristianesimo». Nella lettera a Nadia Neri: «Non si può amare tutti gli uomini. Si può amare una classe sola (...) un numero di persone limitato, forse qualche decina, forse qualche centinaio».
Ma ovviamente gli aspetti che più possono intrigare sono quelli religiosi - per esempio l’apparente contraddizione tra «l’obbedienza non è più una virtù» della lettera ai cappellani militari (in difesa di Beppe Gozzini, primo obiettore di coscienza cattolico) e la difesa dell’obbedienza alla chiesa come virtù («Crede che sia facile vivere sempre sul filo del rasoio, sempre col rischio di cadere nell’eresia?») - e quelli pedagogici.
Qui la durezza (e si potrebbe parlare di aristocraticismo) di don Milani si fa discutibile anche per la stessa Corradi. Il rapporto con il piccolo gruppo dei suoi allievi vuol essere esclusivo. Gli chiede Adele cosa farebbe se venisse un prete più bravo di lui e gli portasse via i suoi ragazzi, e lui risponde: «Farei alle fucilate! I ragazzi sono miei. Bravo o ciuco, farei alle fucilate!» «Io sono un grande maestro!» afferma ai suoi allievi che, secondo la Corradi, non sembrano del tutto convinti, eccetto quelli che gli sono stati più vicini e che hanno finito per diventare nel tempo più donmilaniani di don Milani.
Il solo capitolo delle Esperienze che don Milani le dice di voler salvare è quello intitolato La ricreazione, una critica senza sconti dei due modelli di "tempo libero" proposti dalla chiesa - l’oratorio e il rito del calcio - e dalle sezioni del Pci; le case del popolo e il rito del liscio. Semplicemente, il rifiuto di un tempo libero che non sia di lotta e di cultura. E insieme il rifiuto dell’affermazione individuale, della carriera personale diversa da quella di prete o sindacalista o insegnante, ma, dice la Corradi , la visione delle cose nel piccolo gruppo di Barbiana era molto diversa da quella della gente di Nicchio, che stava geograficamente molto più in basso. «Era completamente assurdo per qualunque vicchiese che un giovane non considerasse un dovere "rivestirsi" nei giorni di festa e un fatto naturale "divertirsi". (...) Solo a don Lorenzo un figlio ingegnere poteva sembrare una disgrazia».
È qui, credo, un dilemma centrale, che persone come don Milani o Pasolini - suo lettore e ammiratore dal tempo delle Esperienze - decisero da subito di mettere al centro del loro insegnamento, e non sbaglia chi li ha considerati, dagli anni Sessanta in avanti, come i due maggiori o gli unici pedagogisti italiani. Di questa radicale austerità, la cui durezza deriva dalla comprensione o preveggenza degli effetti della "ricreazione" nella società che stava diventando del benessere, Pasolini fu il portavoce maggiore ed è assai probabile che sia stata la lettura di don Milani a influenzarlo, nonostante le sue contraddizioni fossero ben maggiori di quelle del prete perché nelle norme e negli usi della società del benessere egli si lasciò fin troppo coinvolgere.
La Corradi ricorda come don Milani le dicesse più di una volta, nei fatti e nelle parole, «che la coerenza assoluta era un’assurdità e, per di più, un’assurdità stupida», e commenta perfettamente: «Era quello uno dei tanti momenti in cui mi pareva di capire che non si doveva essere prigionieri di niente, neppure dei "principi". Perché, come direbbe Freire, don Lorenzo era un "radicale". Freire, così mi pare di aver capito, divideva le persone in "radicali" e "settarie". Le "settarie" hanno radici poco profonde e si aggrappano a regole e dogmi. I "radicali" invece hanno radici profonde e non hanno paura della libertà».
Di questa radicalità - e di radicali, non di settari - si ha oggi il massimo bisogno dopo lo scialo che il populismo ha prodotto, a destra e a sinistra, nella società e anche nella parte che è della chiesa, di un’adesione pressoché assoluta alla desacralizzazione di tutto e alla spettacolarizzazione di tutto: a una generale "ricreazione" che paradossalmente, in mancanza delle ore del lavoro, non ha poi molto da "ricreare".
Le contraddizioni di don Milani, frutto di una storia e di un’epoca di grandi contrasti, ci pongono di fronte oggi all’assenza in noi di contraddizioni altrettanto forti, a una società sostanzialmente conformista, dove le classi sociali si sono accostate e si sono culturalmente omologate su modelli comuni imposti dal consumo e dalla pubblicità.
Adele Corradi ci ha ricordato quanto la vocazione di educatore potesse essere difficile rispetto ai valori di un tempo, ma certamente essa è ancora più delicata oggi, quando gli educatori "radicali" (e non i "settari", senza dimenticare la massa compiacente dei new age e la piccola folla dei guru che al solito, preti e laici, predicano A e fanno B) possono ritrovarsi molto più facilmente soli, e spesso sconfessati dai loro stessi allievi, perché affermano altri modelli in un contesto dove il modello dev’essere, secondo chi decide del destino delle società, sostanzialmente uno solo. È di questo che chi questa vocazione o questo dovere sentono ancora di avere, dovrebbero ragionare, è questa il punto, la vera questione, su cui dovrebbero misurarsi la loro intelligenza e la loro responsabilità.
 Adele Corradi, Non so se don Milani, Feltrinelli, pagg. 170, e. 14.00
Adele Corradi, Non so se don Milani, Feltrinelli, pagg. 170, e. 14.00 -
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e --- Adele Corradi, "Non so se don Lorenzo" (di Filippo Gentiloni - La lettera di una professoressa).28 febbraio 2012, di Federico La Sala
DON MILANI, LETTERA DI UNA PROFESSORESSA
di Filippo Gentiloni (il manifesto, 28.002.2012)
A quasi mezzo secolo dalla sua morte (26 giugno 1967) non si parla quasi per niente di don Lorenzo Milani: chi fosse davvero e cosa abbia veramente detto negli anni intensi della sua vita di prete, uomo, cittadino, maestro. Non ci si ricorda nemmeno della sua opera piú famosa: "Lettera a una professoressa", firmata dalla scuola di Barbiana (Libreria Editrice Fiorentina, 1967). Eppure don Milani è stata una delle figure che nel Novecento aveva lasciato piú tracce di sé, nonché della sua esperienza pedagogica legata appunto alla scuola di Barbiana.
Perció è ancora piú prezioso il libro adesso uscito di Adele Corradi, "Non so se don Lorenzo" (Feltrinelli). La Corradi, nata a Firenze nel 1924, insegnante di lettere nella scuola media, per molti anni era stata una stretta collaboratrice di don Milani nella scuola di Barbiana e, ancora per un paio d’anni, vi aveva lavorato dopo la morte di don Lorenzo. In questo libro l’autrice non vuole raccontare la storia della scuola di Barbiana: «Chi la volesse conoscere dovrà rivolgersi altrove».
Qui la Corradi racconta il personaggio di don Milani: «Carismatico, sensibile, non di rado urtante, qualche volta persino antipatico». La scrittrice si lascia visitare dai ricordi con amore, ma senza riverenza, consapevole della eccezionalità dell’anima di don Milani, come anche della difficoltà sociale e politica nella quale si trovava ad operare.
Poco dopo il 1963, la Corradi riuscì a farsi trasferire alla media statale di Borgo San Lorenzo, vicino a Barbiana, mentre don Milani era costretto dall’aggravarsi del male (morbo di Hodgkin) a frequenti ricoveri a Firenze. Prese in affitto una stanza non lontano dalla canonica di Barbiana, cosí poteva dedicare tutto il tempo lasciatole libero dalla scuola statale a quella privata di Barbiana. Racconta che, appena ricevute dall’editore le prime copie di "Lettera a una professoressa", don Milani dal suo letto dov’era quasi moribondo, ne sfiló una dal pacco e la diede ad Adele, scrivendo questa dedica: «Parte quarta: finalmente trovammo una professoressa diversa da tutte le altre che ci ha fatto tanto del bene».
Scrive Giorgio Pecorini che chiunque prenderà in mano questo libro della Corradi per sapere qualcosa di più su don Lorenzo Milani e sulla scuola di Barbiana, si troverà investito da un’onda di emozioni, fra lo stupore della sorpresa e la tentazione del coinvolgimento e avrà una migliore comprensione di quale fosse la vera atmosfera della comunità di Barbiana.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana --- "Non so se don Lorenzo" di Adele Corradi,un testo importantissimo per capire chi fu don Lorenzo Milani (di Roberto Beretta) - Don Milani, l’educazione come «ultima frontiera» (di Goffredo Fofi)5 febbraio 2012, di Federico La Sala
Don Milani e la professoressa buonadi Roberto Beretta (Avvenire, 05.02.2012)
Ci ha fatto un gran regalo, Adele Corradi, a scrivere questo librino che sembra una raccolta di aneddoti, e invece è un testo importantissimo per capire chi fu don Lorenzo Milani. Possibile?! Dopo una letteratura persino sterminata sul Priore del Mugello, sulle sue opere e la sua scuola; dopo mezzo secolo di giornalismo e saggistica dedicati al racconto e all’analisi di ogni aspetto del sacerdote di Barbiana, sembra incredibile non solo che ci sia qualcosa di nuovo da dire in materia, ma soprattutto che questo qualcosa sia decisivo.
Invece è così. È così perché la professoressa Corradi - che finora non aveva mai pubblicato nulla - è stata vicinissima a don Milani negli ultimi 4 anni di vita, passando giorni a far scuola ai ragazzi di Barbiana (era lei che li preparava agli esami di Stato: anche i due che poi vennero bocciati e generarono - loro malgrado - la Lettera a una professoressa ). Ma è così soprattutto perché Adele Corradi ha vissuto quell’esperienza con amore e libertà: gli unici ingredienti che permettono di capire davvero, nel profondo.
Dunque Non so se don Lorenzo, in uscita mercoledì per Feltrinelli (pp. 176, euro 14), risulta libro commovente e capitale. L’autrice d’altronde si presenta in regola: classe 1924 (un anno meno del Priore), «l’Adele» - così don Milani la cita molto spesso nelle lettere alla mamma - è stata una fiduciaria assoluta di Barbiana dal 1963 alla morte del sacerdote toscano nel 1967; innumerevoli i servizi a lei affidati, oltre la scuola: era incaricata di telefonare (a Barbiana non c’era apparecchio) per tenere i più vari contatti, portava al Priore le medicine per la sua grave malattia, accompagnava lassù la mamma di don Milani da Firenze, prestava la macchina a don Lorenzo e anche al primo dei suoi ragazzi, Michele Gesualdi (ci scappò pure un incidente...), fece da ambasciatrice presso il cardinale Florit - il quale la definì nel suo diario «una nevrastenica professoressa»...
Fu lei a salvare l’originale del Catechismo, che don Milani voleva distruggere prima di morire; così come, da una discussione con le ragazze della sua terza media che avevano organizzato una festa da ballo a scuola, nacque il pamphlet milaniano Anche le oche sanno sgambettare.
Non per nulla, quando nel gennaio 1966 il Priore (dopo l’ennesima incomprensione) dichiarò il «blocco continentale» delle visite al suo capezzale per tutti eccetto «contadini, operai, persone che non abbiano fatto più della terza media, preti», la Corradi non ebbe bisogno di lasciapassare: «Lei no perché è barbianese, non le occorre». Ma in che modo la professoressa fiorentina si era meritata di entrare nella ristretta «nostra strana famiglia» (definizione di don Milani per designare il nucleo costituito da se stesso, dalla fedelissima perpetua Eda e da Adele)?
Nel libro lei lo racconta così: «Sono andata a Barbiana il 29 settembre 1963, festa di san Michele, perché era domenica. Sapevo infatti che quella che volevo conoscere era la scuola di un prete e mi pareva che di domenica me ne sarei fatta un’idea più completa. Una collega mi aveva detto che quella scuola dava risultati straordinari, volevo perciò vederla in funzione, giacché funzionava anche nei giorni di festa... Delle lezioni di quella domenica non ricordo però quasi niente. Ricordo bene invece che lo capii subito: dovevo tornare lì al più presto».
Comincia un rapporto che diventa subito strettissimo: la Corradi, che all’epoca insegnava a 40 km di distanza, ritorna già il martedì successivo (anche perché quel prete le sembrava talmente malridotto che - pensava - «sarebbe morto in due o tre mesi»...), e poi due giorni la settimana, dalle 8 del mattino spesso fino a dopo cena; dall’estate 1964 chiede addirittura il trasferimento nella scuola media della vicina Borgo San Lorenzo e va ad abitare in una cascina abbandonata presso Barbiana: non sembrava infatti decoroso che una donna vivesse in canonica. Lo spunto fu dunque la curiosità: «Ero lì per sapere come facevano per imparare a scrivere in italiano. Era il problema che mi assillava di più, fra i tanti che mi si presentavano ascuola - scrive oggi Corradi - Don Lorenzo non mostrò meraviglia e mi rispose che ero fortunata.
Stavano iniziando proprio quel giorno un esercizio molto particolare: la “scrittura collettiva”». Il metodo con cui più tardi sarebbe stata stesa la Lettera a una professoressa , della quale Adele ebbe modo di seguire in diretta la lunga gestazione e il cui esemplare librario meritò con una dedica dolcissima di don Milani, ormai prossimo alla fine: «Parte quarta: poi finalmente trovammo una professoressa diversa da tutte le altre che ci ha fatto tanto del bene». Era «diversa» sì, la Corradi, anche se nel risvolto di copertina del volume precisa di essere stata «un’insegnante identica alla destinataria della Lettera. I rimproveri che i ragazzi di Barbiana rivolgono a quell’insegnante me li meritavo tutti».
Il Priore evidentemente doveva pensarla in modo diverso, se già il primo giorno l’aveva invitata a tornare (un segno di enorme fiducia, per chi conosce la brusca e talvolta violenta diffidenza con cui il prete toscano allontanava invece chiunque non gli garbasse) e quindi le aveva affidato un compito: «Per favore, vuole insegnare a questi ragazzi quelle stupidaggini che chiedete voi agli esami?». Lei si conquista il suo posto con discrezione («Cercavo di disturbare il meno possibile»), perché quella scuola le piace: «Mi trovavo come un pesce nell’acqua e non c’è stato mai un momento, in tutti gli anni che ho passato a Barbiana, in cui possa dire di essermi annoiata. Magari si soffriva, ma non ci si annoiava».
E ancora: «Nulla passava inosservato a Barbiana. Mi vien fatto di dire che lassù si viveva ’nell’attenzione’. E il più attento di tutti era il Priore»; parole che non contrastano affatto con gli scontri e le baruffe di cui lo stesso - e il libro ne dà conto - era sovente protagonista. La Corradi prende don Milani anche come direttore spirituale; sale da lui la mattina presto a confessarsi: «Ogni volta che non ero contenta di me, don Lorenzo trovava sempre la strada per farmi ritrovare la pace. Sempre. Era liberante. Dopo che è morto, questo soprattutto mi è mancato». I due si danno del «lei», e lo faranno fino all’ultimo, anche se il rapporto è davvero strettissimo.
A poco a poco la professoressa apprende «la teologia di Barbiana». Il premio eterno secondo don Milani: «Così sarà quando arriveremo in Paradiso. Lasceremo giù tutta la nebbia e tutto il grigio rimarrà dietro di noi». A proposito dell’ingordigia del capitalismo: «Bisognerebbe dire una cosa che non è di moda... Bisognerebbe parlare del diavolo». La preghiera: «Diceva che non dovevamo prendere esempio da lui, che pregava troppo poco: un Padre Nostro la mattina e un’Ave Maria la sera». A chi però tentava di indurgli scrupoli: «A furia di esami di coscienza trasformano in cura di sé perfino il cristianesimo». Gioielli inediti che illuminano sfaccettature poco note del Priore, per esempio sul dibattuto tema dei rapporti di don Milani con le donne. Ecco come la Corradi descrive il suo ultimo colloquio: «Mi domandò se avevo mai avuto il dubbio “di aver amato un sacerdote oltre i limiti”. La risposta fu immediata: “Con lei? Mai!”. Ero sicurissima.
Lui, non capii perché, fece la faccia di un bambino che vede un bel regalo e disse: “Son contento!”». E quando tuttavia lei riprese: «Le confesso che l’abbraccerei volentieri», lui «non si meravigliò di quel che gli dicevo. Fece un sorriso e disse: “Lo faremo nell’ultimo giorno”». E infatti, dopo la morte di don Lorenzo, Adele Corradi restò fedele a quella che era stata «la nostra strana famiglia»; rimase ancora due anni a Barbiana, prendendo in affido tre fratellini con difficoltà psichiche, tra cui Marcello: un bambino che a 5 anni non sapeva ancora parlare e per questo era stato l’ultimo ’figlio’, il più amato, di don Lorenzo Milani.
Don Milani, l’educazione come «ultima frontiera»
di Goffredo Fofi (Avvenire, 05.02.2012)
A 88 anni Adele Corradi, insegnante che negli ultimi anni di vita di don Milani fu sua strettissima collaboratrice a Barbiana, si è decisa finalmente a scrivere le sue memorie di un’amicizia invero straordinaria. Il mito di don Milani è andato crescendo, invece che spegnersi nel tempo trascorso dalla sua morte, nel 1967, prima che la Lettera a una professoressa stesa diventasse uno dei pochissimi testi di riferimento per la generazione degli studenti del ’68. Essi l’ebbero come unico punto di riferimento forte nella loro azione per il rinnovamento della nostra scuola, perché la scuola trattasse i figli dei proletari e dei poveri così come trattava quelli di chi se la passava meglio, prima di scordarsene per passare alla politica con la kappa rinverdendo il mito del leninismo, peggio che defunto.
Da questi sintetici ricordi, stesi forse al caso della memoria - situazioni, battute, personaggi, incontri... - non esce un don Milani diverso da quello che già conosciamo dai suoi lavori e dalla testimonianza di tanti. La bibliografia sul prete toscano è impressionante, probabilmente più fitta di quella riguardante ogni altro prete o educatore del nostro Novecento, ma il don Lorenzo della Corradi è così vivo e presente in ogni suo gesto o parola da fare di questo libro il resoconto, credo, più complesso e più libero nel raccontare gli ultimi anni del prete toscano, il periodo in cui don Milani era già don Milani, e attirava, ben vivo, grandi simpatie quanto grandi antipatie nella cultura italiana, principalmente nella sua parte cattolica. Non era il solo prete «di frontiera» degli anni Cinquanta e Sessanta: come non ricordare nella stessa Toscana il più dimenticato di tutti, il grande Vannucci, e poi Borghi, il prete-operaio che don Milani considerava un maestro, e lo stesso Balducci?
Di essi si parla spesso nel libro, così come si parla di quelli più timorati e meno amici, o delle gerarchie, e don Milani non ha peli sulla lingua (come non ne ha la Corradi, scrupolosamente ma meno aspramente sincera) anche se ribadisce, l’autore di L’obbedienza non è più una virtù, che era una lettera ai cappellani militari che riguardava un altro tipo di obbedienza, l’obbedienza alla Chiesa. (Ed è sempre curioso registrare la sorpresa dei non cattolici di fronte a quella che a loro appare come una contraddizione.)
Ma Adele Corradi parla soprattutto della vita quotidiana, dei ragazzi e dell’insegnamento, e più di ogni altra cosa, forse, dei rapporti tra don Milani e le donne, le due che gli furono più vicine, la Eda governante contadina e l’autrice, collaboratrice instancabile e amorosa ma - e ci tiene a dirlo - non innamorata, ma anche la madre, e la ’fidanzata’ di don Milani, la ragazza al cui amore egli aveva rinunciato per seguire la sua vocazione, una donna che, dice la Corradi, ha conosciuto un’altra persona, il Lorenzo Milani di un altro tempo. Forse le notazioni più sorprendenti sono, in questo libro, proprio quelle che gettano luce sul ’maschilismo’ di cui qualcuno ha accusato don Milani, certamente coerente alla cultura del tempo e della sua in particolare, ma che risulta di una complessità maggiore, e infine più limpida, di quanto altri non ne abbiano detto, per esempio l’amico di gioventù Michele Ranchetti, eccezionale figura di poeta e studioso.
Ma è soprattutto la figura del don Milani educatore a uscire arricchita da queste pagine, un educatore che si mette decisamente dalla parte dei diseducati dalla scuola e dalla società, dei deboli sottoposti ai ricatti culturali dei potenti, dei ragazzi sottoposti al pregiudizio delle ’professoresse’ - una categoria a cui la Corradi riesce a sfuggire senza sforzo ponendosi anche lei, con decisa ripulsa delle idee e convenzioni del suo ceto e della sua professione (le «vestali delle classi medie», le chiamò acutamente una celebre inchiesta sugli insegnanti) dalla parte dei ragazzi.
Anche se racconta che non sempre condivise certe durezze di un don Milani sempre preoccupato dalle distrazioni devianti dai problemi reali (e ci pare perfino ovvio che egli dicesse, a un certo punto, che di Esperienze pastorali avrebbe salvato soltanto il capitolo, durissimo ma eccezionalmente preveggente, su «La ricreazione»).
Poco tempo prima di morire - racconta Adele Corradi in queste memorie di un’onestà e sincerità che ci sembrano assolute e che sono destinate a restare per il loro valore di testimonianza, per il bellissimo ritratto che ne scaturisce di un italiano come non ce ne sono più. ma anche per la loro austera bellezza - don Lorenzo le «fece un discorso che, riassumendo, somigliava a quello di san Paolo quando dice: ’Ho combattuto la buona battaglia’.(...) Di esso ricordo solo le ultime parole: ’Ora tocca a voi!’».
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa" ---- E don Milani disse: «L’acqua è di tutti». Lettera di don Milani del 1955, pubblicata sul "Giornale del Mattino".9 giugno 2011, di Federico La Sala
E don Milani disse: «L’acqua è di tutti»
di Lorenzo Milani (Avvenire, 09 giugno 2011) *
Caro direttore,
col progetto di consorzio di cui ti parlai si darebbe l’acqua a nove famiglie. Quasi metà del mio popolo. Il finanziamento è facile perché siamo protetti dalla legge per la montagna. La benemerita 991 la quale ci offre addirittura o di regalo il 75 per cento della spesa oppure, se preferiamo, in mutuo l’intera somma. Mutuo da pagarsi in 30 anni al 4 per cento comprensivo di ammortamento e interessi. Nel caso specifico, l’acquedotto costerà circa 2 milioni. Se vogliamo sborsarli noi, il governo fra due anni ci rende un milione e mezzo.
L’altro mezzo milione ce lo divideremo per 9 che siamo e così l’acqua ci sarà costata 55.000 lire per casa. Oppure anche nulla; basta prendere pala e piccone e scavarci da noi il fossetto per la conduttura e ecco risparmiate anche le 55.000 lire.
Se invece non avessimo modo di anticipare il capitale allora si può preferire il mutuo. Il 4 per cento di due milioni è 80.000 lire all’anno. Divise per nove dà 8.800 lire per uno. Se pensi che 8.000 lire per l’acqua forse le spendi anche te in città e se pensi che a te l’acqua non rende, mentre a un contadino e in montagna vuol dire raddoppiare la rendita e dimezzare la fatica, capirai che anche questo secondo sistema è straordinariamente vantaggioso. Insomma bisogna concludere che la 991 è una legge sociale e meravigliosa.
Mi piacerebbe darti un’idea chiara di quel che significa l’acqua quassù, ma per oggi mi contenterò di dirti solo questo: s’è fatto il conto che per ogni famiglia del popolo il rifornimento d’acqua richieda in media 4 ore di lavoro di un uomo valido ogni giorno. Se i contadini avessero quella parità di diritti con gli operai che non hanno, cioè per esempio quella di lavorare solo 8 ore al giorno, si potrebbe dunque dire che qui l’uomo lavora mezza giornata solo per procurarsi l’acqua. Dico acqua, non vino! Tu invece per l’acqua lavori dai tre ai quattro minuti al giorno. A rileggere l’articolo 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale» mi vengono i bordoni. Ma oggi non volevo parlarti dei paria d’Italia, ma d’un’altra cosa.
Dicevamo dunque che c’è questa 991 che pare adempia la promessa del 2° paragrafo dell’art. 3 della Costituzione: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini». A te, cittadino di città, la Repubblica non regala un milione e mezzo, né ti presta i soldi al 4 per cento compreso l’ammortamento. A noi sì.
Basta far domanda e aver qualche conoscenza. Infatti eravamo già a buon punto perché un proprietario mi aveva promesso di concederci una sua sorgente assolutamente inutilizzata e inutilizzabile per lui, la quale è ricca anche in settembre e sgorga e si perde in un prato poco sopra alla prima casa che vorremmo servire. Due settimane dopo, un piccolo incidente. Quel proprietario ha un carattere volubile. Una mattina s’è svegliato d’umore diverso e m’ha detto che la sorgente non la concede più. Ho insistito. S’è piccato. Ora non lo scoscendi più neanche colle mine.
Ma il guaio è che quando ho chiesto a un legale se c’è verso d’ottenere l’esproprio di quella sorgente, ma risposto di no. Sicché la bizzettina di quell’omino, fatto insignificante in sé, ha l’atomico potere di buttare all’aria le nostre speranza d’acqua, il nostro consorzio, la famosa 991, il famoso articolo 3, le fatiche dei 556 costituenti, la sovranità dei loro 28 milioni di elettori, tanti morti della Resistenza (siamo sul monte Giovi! Ho nel popolo le famiglie di 14 fucilati per rappresaglia). Ma qui la sproporzione tra causa ed effetto è troppa! Un grande edificio che crolla perché un ragazzo gli ha tirato coll’archetto! C’è un baco interiore dunque che svuota la grandiosità dell’edificio di ogni intrinseco significato. Il nome di quel baco tu lo conosci. Si chiama: idolatria del diritto di proprietà.
A 1955 anni dalla Buona Novella, a 64 anni dalla Rerum Novarum, dopo tanto sangue sparso, dopo 10 anni di maggioranza dei cattolici e tanto parlare e tanto chiasso, aleggia ancora vigile onnipresente dominatore su tutto il nostro edificio giuridico. Tabù. Son 10 anni che i cattolici hanno in pugno i due poteri: legislativo e esecutivo. Per l’uso di quale dei due pensi che saranno più severamente giudicati dalla storia e forse anche da Dio? Che la storia condannerà la nostra società è profezia facile a farsi.Basterebbe il solo fatto della disoccupazione oppure il solo fatto degli alloggi.
Ma una storia serena non potrà non valutare forse qualche scusante, certo qualche attenuante: l’ostacolo della burocrazia insabbiatrice, quello dell’Italia sconvolta dalla guerra, quello degli impegni internazionali...
Insomma, tra attenuanti e aggravanti, chi studierà l’opera dei cattolici in Italia forse non riuscirà a dimostrare che la loro incapacità sia un’incapacità costituzionale. Saremo perdonati dunque anche se in questa preziosa decennale occasione di potere non avremo saputo mostrare al mondo cosa sappiamo fare. Ma guai se non avremo almeno mostrato cosa vorremmo fare. Perché il non saper fare nulla di buono è retaggio di ogni creatura. Sia essa credente o atea, sia in alto o basso loco costituita. Ma il non sapere cosa si vuole, questo è retaggio solo di quelle creature che non hanno avuto Rivelazione da Dio. A noi Dio ha parlato. Possediamo la sua legge scritta per steso in 73 libri e in più possediamo da 20 secoli anche un Interprete vivente e autorizzato di quei libri.
Quell’Interprete ha già parlato più volte, ma se non bastasse si può rivolgersi in ogni momento a lui e sottoporgli nuovi dubbi e nuove idee. A noi cattolici non può dunque far difetto al luce. Peccatori come gli altri, passi.
Ma ciechi come gli altri no. Noi i veggenti o nulla. Se no val meglio l’umile e disperato brancolare dei laici. Che i legislatori cattolici prendano dunque in mano la Rerum Novarum e la Costituzione e stilino una 991 molto più semplice in cui sia detto che l’acqua è di tutti. Quando avranno fatto questo, poco male se poi non si riuscirà a mandare due carabinieri a piantar la bandiera della Repubblica su quella sorgente.
Manderanno qualche accidente al governo e ai preti che lo difendono. Poco male. Partiranno per il piano ad allungarvi le file dei disoccupati e dei senza tetto. Non sarà ancora il maggior male. Purché sia salva almeno la nostra specifica vocazione di illuminati e di illuminatori. Per adempire quella basta il solo enunciare leggi giuste, indipendente dal razzolar poi bene o male. Chi non crede dirà allora di noi che pretendiamo di saper troppo, avrà orrore dei nostri dogmi e delle nostre certezze, negherà che Dio ci abbia parlato o che il papa ci possa precisare la Parola di Dio. Dicendo così avrà detto solo che siamo un po’ troppo cattolici. Per noi è un onore. Ma sommo disonore è invece se potranno dire di noi che, con tutte le pretese di rivelazione che abbiamo, non sappiamo poi neanche di dove veniamo o dove andiamo, e qual è la gerarchia dei valori, e qual è il bene e quale il male, e a chi appartengono le polle d’acqua che sgorgano nel prato di un ricco, in un paesino di poveri.
* Don Milani scrisse questa lettera dalla montagna alla fine del 1955 e venne pubblicata sul «Giornale del Mattino» di Bernabei. Singolare consonanza con i temi dei referendum dei prossimi giorni. «Mi piacerebbe darti un’idea di quel che significa l’acqua quassù: per ogni famiglia il rifornimento richiede in media 4 ore ogni giorno Qui l’uomo fatica mezza giornata solo per procurarsi da bere» «Tu per l’acqua lavori 3 o 4 minuti...» "Che i legislatori cattolici prendano dunque in mano la Rerum Novarum e la Costituzione e stilino una 991 molto più semplice in cui sia detto che l’acqua è di tutti." (Finesettimana.org)
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- 22 MAGGIO2011: DECIMA MARCIA DI BARBIANA. per una scuola pubblica, di tutti e di ciascuno. Testo dell’appello.21 maggio 2011, di Federico La Sala
Comune di Vicchio
Appello X Marcia di Barbiana
22 Maggio 2011
 Art. 34 della Costituzione:
Art. 34 della Costituzione:
 “La scuola è aperta a tutti.
“La scuola è aperta a tutti.
 L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita.
 I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
 La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”Siamo alla X Marcia di Barbiana: per una scuola pubblica, di tutti e di ciascuno.
Oggi, come sempre, forte è la voce della nostra Costituzione, così centrale anche nel progetto educativo di don Lorenzo Milani.
Una scuola che insegni la Parola ai cittadini italiani ma anche a tutti coloro, ultimi fra gli ultimi, che da tante parti del mondo si spingono nella nostra Patria alla ricerca di integrazione e di una vita più dignitosa. Parola, dunque, che sia strumento di libertà, cifra di riscatto.
La Marcia: ormai un appuntamento tradizionale, ma non per questo meno sentito, a cui convergono da ogni parte d’Italia le forze migliori della nostra società che ogni anno si ritrovano a Barbiana, nel nome della “sua scuola”, per rinnovare e rinvigorire la loro speranza e il loro impegno.
Alla Marcia non hanno mai fatto mancare il loro appoggio e la loro vicinanza le Istituzioni della Nazione e del Territorio, a partire dal nostro Presidente della Repubblica.
 Marceremo con e per i nostri figli: per il loro futuro, mai come ora così incerto, perché si realizzino le loro
legittime aspirazioni e i loro diritti di persone e di cittadini alla cultura, alla libertà, alle opportunità.
Marceremo con e per i nostri figli: per il loro futuro, mai come ora così incerto, perché si realizzino le loro
legittime aspirazioni e i loro diritti di persone e di cittadini alla cultura, alla libertà, alle opportunità.
 Marceremo perché ai giovani siano proposti modelli di società non basati sull’apparire e sull’avere ma
soprattutto sull’Essere Persone.
Marceremo perché ai giovani siano proposti modelli di società non basati sull’apparire e sull’avere ma
soprattutto sull’Essere Persone.
 Marceremo per i nostri insegnanti che nell’impegno quotidiano ci aiutano a crescere i nostri figli, con
passione e senso civico.
Marceremo per i nostri insegnanti che nell’impegno quotidiano ci aiutano a crescere i nostri figli, con
passione e senso civico.
 Marceremo perché la scuola sia riconosciuta come uno dei pilastri della Nazione e non sia guardata solo in
termine di costi.
Marceremo perché la scuola sia riconosciuta come uno dei pilastri della Nazione e non sia guardata solo in
termine di costi.Dietro ai gonfaloni del nostro e degli altri Comuni, saliremo silenziosi verso Barbiana, nel verde di una campagna intatta e bella; la stessa terra che una volta era la terra del duro lavoro dei figlioli dei contadini, per nascita destinati a una marginalità a cui Don Lorenzo volle e seppe sottrarli. Questa esperienza indicò, a tutti coloro che da quel momento avrebbero pensato e progettato di scuola, la strada per una vera e propria rivoluzione copernicana.
Il Sindaco del Comune di Vicchio Roberto Izzo - Il Sindaco del Comune di Calenzano Alessio Biagioli - Il Sindaco del Comune di Montespertoli Giulio Mangani - Il Sindaco di Firenze Matteo Renzi - Il Presidente della Comunità Montana Mugello Stefano Tagliaferri
 Il Presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci - Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
Il Presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci - Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- Album privato di una fede pubblica... Quella modesta frazione del comune di Vicchio denominata Barbiana (di G. Ravasi).24 maggio 2011
Album privato di una fede pubblica
di Gianfranco Ravasi (Il sole 24 Ore, 22 maggio 201)
Quando vivevo a Milano, mi accadeva spesso di passare in via Spiga, la via che con Montenapoleone si contende il primato delle vetrine della moda. Qualche volta gettavo uno sguardo su un edificio immune da quell’invasione: è una scuola elementare per i non molti bambini residenti in un quartiere così esclusivo e asettico, e talora mi è passato per la mente che proprio da quei cancelli, decenni prima, era uscito un ragazzino che avrei voluto incontrare da adulto.
Non fu possibile perché quell’uomo morì nel 1967 a 44 anni, quando io ero da pochi mesi sacerdote. Anche lui era divenuto sacerdote vent’anni prima a Firenze e avrebbe lasciato - sia pure nell’isolamento di un paesino del Mugello - una forte traccia nella storia ecclesiale e culturale del nostro Paese.
Forse alcuni hanno capito di chi sto parlando: don Lorenzo Milani, fiorentino, aveva vissuto la sua adolescenza e giovinezza a Milano. Là, infatti, con la sua famiglia borghese e intellettuale di matrice ebraica, era approdato nel 1930 a sette anni. Aveva, quindi, frequentato quella scuola elementare di via Spiga e poi il liceo Berchet, per iscriversi infine all’Accademia di Brera, anche perché aveva ricevuto una formazione in questo senso attraverso la guida del pittore tedesco Hans Joachim Staude, e il padre gli aveva persino affittato uno studio in piazza della Repubblica.
La morsa della guerra aveva costretto la famiglia Milani a ritornare a Firenze nel 1943 e fu là che iniziò la vicenda spirituale di Lorenzo il quale, tra l’altro, era stato battezzato solo a dieci anni. Non è il caso di ricostruire ora la storia tormentata e gloriosa di questo sacerdote di straordinaria genialità, di intensa spiritualità e di profonda umanità.
Quella modesta frazione del comune di Vicchio denominata Barbiana, ove egli era parroco, è divenuta una sorta di emblema che ancora oggi - nonostante il flusso del tempo e la temperie piuttosto degenerata in cui siamo immersi - rimane come una piccola stella di riferimento. Così come lo sono gli scritti di don Lorenzo che cristallizzavano in sé una vicenda unica di fede e di cultura, a partire dalle Esperienze pastorali del 1958, passando attraverso L’obbedienza non è più una virtù, per approdare a quel dittico "epistolare" indimenticabile della Lettera a una professoressa (1967) su un originalissimo progetto educativo e della Lettera ai cappellani militari della Toscana (1965) sull’obiezione di coscienza, che gli costò una condanna per apologia di reato in Corte d’Appello, condanna postuma perché pronunciata a un anno dalla morte!
Due mesi prima di morire, in un’altra lettera, descriveva così il suo stile personalissimo: «Lo stare per mesi su una frase sola togliendo via tutto quello che si può togliere». Sembra di sentire il Calvino delle Lezioni americane, quando comparava il lavoro dello scrittore a quello dello scultore che crea la sua opera scalpellando materiali dal blocco di marmo, ed era in una delle sue Lettere provinciali che Pascal allo stesso modo annotava: «Ho fatto questa lettera più lunga solo perché non ho avuto tempo di farla più corta».
Don Milani aveva cercato sempre l’essenziale, spogliando la verità dal paludamento della retorica e dal manto dorato dell’ipocrisia, seguendo un programma costante e lineare perché «un atto coerente isolato - scriveva - è la più grande incoerenza». Fu anche per questo che rimase allora incompreso, a partire dalle stesse autorità ecclesiastiche.
Eppure egli fu sempre fedele alla sua Chiesa. Un suo compagno di seminario che sarebbe poi divenuto arcivescovo di Firenze, il cardinale Silvano Piovanelli, mi ricordava questa significativa testimonianza di don Lorenzo: a chi gli chiedeva perché mai non avesse lasciato quella Chiesa così dura nei suoi confronti, egli rispondeva: «E dove mai troverò chi mi perdona i peccati?».
Nelle Esperienze pastorali rivelava, infatti, un vero temperamento da asceta, consapevole della fragilità umana e della necessità del perdono divino: «Il primo problema del cristiano dev’essere racchiuso in queste cinque parole: esame di coscienza, dolore, proposito, accusa, penitenza». È appunto questa la trama del sacramento della riconciliazione.
Nello stesso libro egli puntava l’indice contro la grande tentazione, quella della superbia intellettuale: «Siamo in un mondo in agonia che Dio sta forse accecando per castigarlo di aver troppo e troppo male usato dell’intelletto, oppure di non averne fatto parte agli infelici». Il suo amore per la creatura umana era totale: «Il cuore dell’uomo è qualcosa che i libri non sanno leggere né catalogare. Un’anima non si muta con una parola», scriveva a quella "professoressa" rigida nel suo ottuso sapere. Ed è per questo che nel suo testamento ai ragazzi di Barbiana non esitava a scrivere queste parole evangeliche (si legga Matteo 25,40!): «Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto».
Queste parole chiudono il libro che avremmo dovuto recensire, ma che in realtà non ha bisogno di analisi. Dovrà solo essere "contemplato" e si rivelerà come una mirabile biografia di don Milani: si tratta, infatti, della sequenza di "immagini di una vita" provenienti dall’album dell’amata sorella Elena, a cominciare dalla casa delle origini toscane fino a quel commovente abbandono nel sonno su una sdraio - turbato da uno dei suoi ragazzi - poche settimane prima della morte, quando già il male si era insediato nel suo corpo nobile e fine. Poche pagine scritte aprono e chiudono il libro, compreso un testo appassionato e limpido di padre Ernesto Balducci.
Walter Benjamin, prima, con la sua Piccola storia della fotografia (1931), e Roland Barthes, poi, con la sua Camera chiara (1980), ci hanno insegnato quanto sia efficace e potentemente espressivo un simile mezzo nato a metà del l’Ottocento. È per tale motivo che consigliamo questo ritratto "visivo" della vita di don Lorenzo Milani, un sacerdote che aveva confessato: «Dove è scritto che il prete debba farsi voler bene? A Gesù o non è riuscito o non è importato». È per questo che, se l’ultima foto è quella della sua tomba, vale ciò che di lui scriveva Enzo Biagi: «È sepolto nel cimitero di Barbiana, sperduto e vuoto paese abitato dagli spiriti. Ma don Lorenzo parla ancora».
-
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- SENTIERO DELLA COSTITUZIONE: INAUGURAZIONE. Barbiana 16 Aprile 2011 - Programma.14 aprile 2011, di Federico La Sala
FONDAZIONE Don Lorenzo Milani
Barbiana 16 Aprile 2011
Inaugurazione del ’SENTIERO DELLA COSTITUZIONE’ *
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia la Fondazione don Lorenzo Milani, il Comune di Vicchio e l’ Istituzione culturale don Lorenzo Milani ripropongono i valori costituzionali attraverso il Sentiero della Costituzione a Barbiana.
Sono stati allestiti dalla fondazione Don Lorenzo Milani, lungo un sentiero di oltre un chilometro, 44 grandi bacheche con gli articoli della Costituzione illustrati dai disegni dei ragazzi di diverse scuole d’Italia che per l’occasione hanno collaborato al progetto.
Il percorso scelto è lo stesso che fece a piedi don Lorenzo Milani il primo giorno che fu mandato a Barbiana.
Nella scuola di Barbiana la Costituzione era molto studiata, era considerata la bussola per non smarrirsi, la guida del futuro cammino dei ragazzi nella società. In essa i barbianesi vedevano non solo la Legge fondamentale dello Stato, ma anche il punto d’equilibrio sociale capace di costruire una società nuova, più giusta ed equilibrata. Così come in quella scuola era valorizzato l’impegno politico e sindacale. Un concetto riassunto nella lettera ai giudici con la frase "la leva ufficiale per cambiar la legge è il voto, la Costituzione gli affianca la leva dello sciopero".
Del resto l’affermazione contenuta in - Lettera a una professoressa - "uscire insieme dai problemi è la politica, uscirne da soli è l’avarizia" rappresenta una sintesi molto efficace del valore della solidarietà praticata alla scuola di don Milani e prevista dai primi articoli della Costituzione.
PROGRAMMA
 ore 9,30
ore 9,30
 Vicchio - Teatro Giotto
Vicchio - Teatro Giotto
 Incontro dei ragazzi delle scuole con il Presidente della Corte Costituzionale
Incontro dei ragazzi delle scuole con il Presidente della Corte Costituzionale ore 11
ore 11
 Barbiana
Barbiana
 Inaugurazione del Percorso Costituzionale
Inaugurazione del Percorso Costituzionale Saluto:
Saluto:
 del Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani
del Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani
 Michele Gesualdi
Michele Gesualdi del Sindaco di Vicchio
del Sindaco di Vicchio
 Roberto Izzo
Roberto Izzo del Presidente della Provincia di Firenze
del Presidente della Provincia di Firenze
 Andrea Barducci
Andrea Barducci della Vice Presidente della Regione Toscana
della Vice Presidente della Regione Toscana
 Stella Targetti
Stella Targetti Intervento del Presidente della Corte Costituzionale
Intervento del Presidente della Corte Costituzionale
 Prof. Ugo De Siervo
Prof. Ugo De Siervo Salita per il "Sentiero della Costituzione" fino alla scuola di Barbiana
Salita per il "Sentiero della Costituzione" fino alla scuola di Barbiana Visita del Percorso Didattico
Visita del Percorso Didattico Per comunicazioni e informazioni:
Per comunicazioni e informazioni:
 Fondazione don Lorenzo Milani Tel/Fax 055418811
Fondazione don Lorenzo Milani Tel/Fax 055418811
 e mail: contatti@donlorenzomilan.it
e mail: contatti@donlorenzomilan.it -
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- Lettera dei "ragazzi di Barbiana" al Presidente della Repubblica e una riflessione dalle "Lettere dal carcere" di Antonio Gramsci13 aprile 2011, di Federico La Sala
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- Protagonisti emblematici del libro sono Gianni, il figlio di contadini poveri regolarmente respinto dalla scuola, e Pierino, il ragazzino borghese cui spiana la strada il fatto di essere ricco (di Gianandrea Piccioli - A Barbiana sono risorti gli ultimi).12 marzo 2011, di Federico La Sala
A Barbiana sono risorti gli ultimi
di Gianandrea Piccioli (La Stampa, 12 marzo 2011)
Ci sono libri (Pinocchio, l’Artusi, I Promessi Sposi, Cuore, Il piccolo alpino ...) che hanno fatto l’Italia. Altri restano muti sugli scaffali, benché onorati non entrano nel patrimonio culturale del Paese: sono i libri che non hanno fatto l’Italia (Delle cinque piaghe della Santa Chiesa di Rosmini, mai recepito né dalla Chiesa istituzionale né dalla più vasta cerchia dei credenti italiani; o Il Santo, di Fogazzaro: grande successo all’estero e qui messo all’Indice; o l’Antistoria d’Italia del triestino Cusin, critico intelligente dell’antropologia italica, che anche gli energumeni della Lega potrebbero leggere con profitto).
Altri libri, invece, vengono acclamati fin dal primo apparire, diventano quasi la sineddoche di un intero giro d’anni, ma restano sostanzialmente fraintesi. A esempio gli scritti di Basaglia, cui venne poi data la colpa di essere morto a metà dell’opera, mentre la struttura reinterpretava a modo suo un mai dichiarato «liberi tutti!».
Ma anche il famoso Lettera a una professoressa, opera collettiva di don Milani e dei suoi studenti di Barbiana, pubblicato nel maggio 1967 (don Milani morirà un mese dopo), pochi anni dopo la riforma della scuola media unificata e obbligatoria fino ai 14 anni (1963). Quel testo divenne una bandiera della rivolta studentesca del ‘68, oggi così deprecata, e ispirò, nel 1969, uno spettacolo militante di Dario Fo L’operaio conosce 300 parole, il padrone 1000. Per questo lui è il padrone. E naturalmente a esso rimandarono poi infinite esperienze pedagogiche e antipedagogiche e decine di titoli editoriali e controcorsi nelle università occupate, con richiami non sempre pertinenti a Illich e a Freire, e, con maggior fondatezza, alla pedagogia di Mario Lodi, il grande maestro di Piadena, che negli stessi anni faceva nella Bassa lombarda un percorso analogo a quello di don Milani sull’Appennino toscano.
Protagonisti emblematici del libro sono Gianni, il figlio di contadini poveri regolarmente respinto dalla scuola, e Pierino, il ragazzino borghese cui spiana la strada il fatto di essere ricco, non tanto o non solo di soldi, quanto soprattutto di quello che i soldi potevano dare nell’Italia degli Anni Sessanta: lingua, libri, cultura. La dicotomia è demagogica solo in prima battuta: una serie di tabelle statistiche elaborate dagli autori dimostra inesorabilmente come la scuola di allora fosse realmente una valvola regolatrice dell’esclusione e dell’inclusione sociale funzionante in un solo senso.
Il fatto è che don Milani, prete cattolico convertito dall’ebraismo di famiglia, aveva scelto l’unico luogo possibile a un cristiano credente: il luogo occupato dai poveri, da «coloro che non possiedono» (Ranchetti). Di qui l’apodittica semplicità della sua parola, priva di presupposti teologici e dogmatici, nata da una fede solo apparentemente ingenua perché senza apparati esegetici di riferimento. Di qui, anche, il gusto per la scrittura collettiva, anti-individualistica, per la pagina costruita insieme coi ragazzi, come nel Medioevo una folla anonima ma unita costruiva una cattedrale. E le pagine di Lettera a una professoressa sono scritte benissimo, in una prosa scarna, chiara e netta, con le parole e le frasi che si disegnano come i salti di sassi ben lanciati su acque tranquille.
Ma dalla scelta di campo tra i poveri nasce anche la durezza della scuola di Barbiana. Altroché permissivismo sessantottino! Tutto il giorno, tutti i giorni, domeniche comprese, perché «la scuola sarà sempre meglio della merda» come dice un ragazzo che rigovernava ogni giorno le 36 mucche del padrone. Niente ricreazione. Al posto delle vacanze, viaggi di lavoro e studio all’estero. Rigore e severità, nessuna comprensione per le «esigenze dei giovani», lusso che solo i privilegiati possonopermettersi. E visto che si tratta di scuola dell’obbligo il contratto dei metalmeccanici o la Seconda guerra mondiale piuttosto che la mitologia o la neve che fiocca fiocca fiocca («Quando la scuola è poca, il programma va fatto badando solo alle urgenze»). La cultura di base deve essere viva e servire alla vita. Inutile fare i «custodi del lucignolo spento».
Poi, con gli anni e la burocratizzazione, dalla battaglia contro le bocciature per insegnare a tutti e a tutti dare forza e fiducia in sé stessi perché nessuno più si senta uno scarto della società, si è passati al 6 politico, e dall’impegno diuturno, che contemplava persino l’elogio del celibato, si è passati a un tempo pieno riempito spesso di vacuità. Il che non giustifica le intemperanze della signora Gelmini, che certo non si ispira al rigore del «cattocomunista» don Milani (il peggio del peggio!).
E oggi, nell’americanizzazione forzata e astorica, spacciata per «modernizzazione», la differenza tra Pierino e Gianni si è istituzionalizzata: nemmeno più scuola di ricchi e poveri, ma scuola (buona, privata o all’estero) dei ricchi e scuola (scadente, statale) dei poveri. In una torva parodia di Barbiana, il rifiuto di una cultura sterile è diventato rifiuto della cultura tout court: secondo i giovani virgulti padani, è meglio lavorare e far soldi piuttosto che perdere tempo a scuola. E così la ricchezza produce ignoranza, anzi incultura, che è peggio. Come scrisse il ticinese Francesco Chiesa «L’ignoranza è un terreno vergine, spesso ricco e profondo. [...] L’incoltura è la solida impenetrabile sterilità del terreno pago di nutrire qualche fil d’erba».
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- Davvero è tutta colpa di Rodari e don Milani? (di Giorgio Pecorini).6 marzo 2011, di Federico La Sala
Davvero è tutta colpa di Rodari e don Milani?
di Giorgio Pecorini (il manifesto, 6 marzo 2011)
«Don Milani, che mascalzone!» proclamava su Repubblica del 30 giugno 1992 Sebastiano Vassalli. L’ottimo scrittore (51 anni allora) ricordava d’esser stato insegnante da giovane ma soprattutto fondava la propria sentenza sul giudizio che un professore e preside e ispettore ministeriale in pensione, Roberto Berardi, aveva espresso nel libriccino «Lettera a una professoressa: un mito degli anni Sessanta», edito da Shakespeare and Company.
Mascalzone il Milani, spiegava Vassalli, perché «maestro improvvisato e sbagliato manesco e autoritario». E autore con quella "Lettera" di «un libro bandiera più adatto a essere impugnato e mostrato nei cortei che a essere letto e meditato un atto di calcolata falsificazione della realtà e di violenta demagogia». Un libro, gli garantiva Berardi, inteso «con altre forze disgregatrici ad abbassare il livello della scuola dell’obbligo a danno dei ceti più indifesi, e a creare disordine anche nelle scuole superiori» mirando a obiettivi «ben più ideologici (in senso contestativo) che scolastici».
Passano 19 anni ed ecco Cesare Segre proclamare il 24 febbraio sul Corriere della Sera che lo sfascio della cultura e della scuola italiane «è conseguenza anche della pedagogia di don Milani e Gianni Rodari», responsabile di una «didattica facile che ha cancellato la capacità di studiare».
L’illustre accademico fonda la propria sentenza nell’ultimo libro di Paola Mastrocola, appena pubblicato da Guanda: «Saggio sulla libertà di non studiare». E tanto gli piace che recensendolo vi si identifica fino a condividerne, addirittura radicalizzandola, la diagnosi sul come e perché in Italia lo studio sia «compromesso e svuotato»: «Il suo bersaglio polemico è la didattica di don Milani e di Rodari, che comunque diedero un appoggio, autorevolissimo, a tendenze già in atto. Don Milani predicò contro il babau del nozionismo svalutando il concetto di nozione come conoscenza» sino a frenare l’aspirazione dei propri allievi alla liberazione dai «lavori contadini» per tenerli vincolati al territorio e bloccare in loro «qualunque aspirazione al miglioramento mentale ma anche economico».
Quanto a Gianni Rodari, Mastrocola scopre e Segre conferma, «promuoveva la trasformazione dell’insegnamento in gioco, la vittoria della fiaba sulla razionalità e sulla storia. L’aula scolastica si trasformava in palcoscenico o in laboratorio, e gli scolari, distolti dallo studio, mettevano allegramente in gara la loro pretesa inventività». È così che entrambi spingono i nostri poveri ragazzi «ad aderire all’internazionale dell’ignoranza».
E qui chi abbia anche soltanto un minimo di conoscenza diretta e onesta di quel che Milani e Rodari hanno fatto detto e scritto nelle loro vite non sa se più indignarsi o dolersi. Ma è davvero possibile che persone acculturate, investite di così alta responsabilità sociale quale l’insegnamento, non possano leggere senza pregiudizi e paraocchi? Non riescano a vedere le diverse, anche contradditorie realtà dell’esistenza fuori dall’aula in cui lavorano?
Verrebbe voglia di domandare che cosa sanno davvero e che cosa pensano delle ricerche e delle sperimentazioni del Movimento di cooperazione educativa e del lavoro di insegnanti tipo Mario Lodi, Bruno Ciari, Margherita Zoebeli in cui s’incarnano quelle «tendenze già in atto» che Segre denuncia oggi come rovina del nostro sistema educativo e che nel ’92 Berardi chiamava «forze disgregatrici».
Mi contento di trascrivere, a nostro personale conforto, due frasi brevi: «La scuola - spiega Milani nella "Lettera ai giudici" - siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. È l’arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare il loro senso della legalità, dall’altro la volontà di leggi migliori cioè il loro senso politico».
E Rodari, recensendo "Lettera a una professoressa" quasi con le stesse parole di Pasolini in una famosa intervista: «Un libro urtante, senza peli sulla lingua, spara a zero in tutte le direzioni, non risparmia nessuno. Di una sincerità a volte brutale, di una ingenerosità scostante. Con tutto ciò il più bel libro che sia mai stato scritto sulla scuola italiana. Da quel libro abbiamo tutti da imparare: maestri, genitori, professori, giornalisti, uomini politici».
Mi torna alla mente, a questo punto, l’immagine suggeritami 19 anni fa dell’accoppiata Berardi-Vassallo: quella dei ciechi del famoso quadro di Bruegel che tenendosi permano finiscono insieme nel precipizio. A loro si attaccano ora Mastrocola e Segre: il trenino s’allunga in un bunga-bunga pedagogico!
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa" --Io sto con la professoressa (di Lorenzo Tomasin)26 febbraio 2017, di Federico La Sala
Rileggere don Milani
Io sto con la professoressa
di Lorenzo Tomasin (Il Sole-24 Ore, 26 febbraio 2017)
Rileggo, a cinquant’anni dalla pubblicazione, la Lettera a una professoressa firmata dai ragazzi di Barbiana che si raccolsero attorno a don Lorenzo Milani: il priore moriva il 26 giugno di quello stesso 1967, poco più che quarantenne, e veniva sùbito laicamente santificato da chi voleva farne, senza consultarlo, un ispiratore delle imminenti rivolte, elevato grazie anche a quella Lettera agli altari novecenteschi della contestazione. Ogni rivoluzione del resto ha il suo cappellano, di solito cattolico: quella francese ebbe l’abbé Grégoire, prete e persecutore.
Don Milani e i suoi contadini - ossia poveri, come li si chiamava nel linguaggio della scuola rurale di Barbiana, con termine che copriva indistintamente l’indigenza materiale e quella intellettuale, confondendo l’una con l’altra - presentavano in quel libriccino il programma di una scuola che si voleva inclusiva, democratica, rivolta non tanto a selezionare quanto ad accompagnare verso un livello minimo d’eguaglianza garantita, rimuovendo le differenze derivanti da censo e condizione sociale. Nobili ideali, senza dubbio, destinati a influenzare nei decenni successivi la scuola italiana, in cui molte delle raccomandazioni di don Milani e dei suoi ragazzi trovarono realizzazione talora puntuale, ben al di là - forse - delle loro stesse aspettative. Dalla sostituzione delle vecchie e inutili materie letterarie (a partire dall’inutilissima storia antica e dalla perfida poesia dei classici) con l’educazione civica e con la storia d’oggi; dalla cacciata della grammatica intesa come strumento d’oppressione all’abolizione di ogni forma di giudizio che distingua tra più bravi e meno bravi; dalla soppressione de iure o de facto della bocciatura - di ogni bocciatura - all’adeguamento del sistema educativo al passo dei più lenti. Sono tutti principî notissimi, e variamente giudicati e giudicabili, anche perché condizionati dal modo in cui volta a volta li si è applicati (di solito male; spesso peggio).
Sarebbe fin troppo facile, e ingenerosamente sadico, osservare che la scuola prefigurata dalla Lettera a una professoressa è giust’appunto quella che oggi tutti deprecano, avendola scoperta se possibile peggiore di quella che l’aveva preceduta, perché capace di creare, nel suo sgangherato egalitarismo, disparità e ingiustizie ancor più gravi di quelle imputate all’odiosa vecchia scuola. Intanto, al santino di don Milani, che considerava la professoressa privilegiata e persino strapagata, occhieggiano oggi i rappresentanti del corpo docente peggio pagato e peggio considerato dell’Occidente.
Ma che cos’era, poi, la vecchia scuola? Rileggendo la Lettera oggi, ciò che più colpisce non è tanto quel che impressionava forse i primi lettori: quel che allora pareva innovativo e progressivo sembra oggi logoro e semplicemente travolto, o meglio bocciato, dal corso precipitoso - ma forse non del tutto imprevedibile, né inevitabile - degli eventi. No, non è questo il punto. Ciò che impressiona oggi è il risentimento che anima quelle pagine, e che allora poteva essere inteso come riflesso dell’entusiasmo ribelle. Ma ormai appare solo come la manifestazione di una pervicace abitudine italiana a fare di odio e invidia la base di ogni ragionamento. Quella lanciata contro l’anonima professoressa (anonima sì, ma ben delineata sociologicamente e ritratta nella sua placida e detestata vita familiare, nel suo andare in vacanza al mare, nel suo frequentare i ritrovi degli intellettuali e persino le federazioni comuniste, in alternativa alla chiesa del paese) è una vera e propria lapidazione.
La colpa dell’insegnante, agli occhi dei ragazzi di Barbiana, è di essere la ligia e ben retribuita esecutrice di un complotto scientemente ordito dal Sistema. Un complotto che, come si ripete tante volte nella lettera, mira a ingannare i poveri e i contadini. Se ingannare è ormai parola fin troppo ricercata (grazie all’intervenuto bando della lingua letteraria), se i contadini non esistono più e poveri o impoveriti sono tutti, l’accusa di ingannare i poveri si traduce semplicemente, nel linguaggio oggi più usuale in Italia, in quella di fregare la gente. In quel verbo, che i ragazzi di Barbiana non usano perché nel 1967 non si era ancora liberato dai ricordi squadristi che vi aleggiavano, ma che è davvero difficile sostituire con qualsiasi sinonimo: in quel verbo, e nell’etica che vi è sottesa, sta quanto di profondamente italiano - e purtroppo attuale - c’è nella Lettera a una professoressa. È l’idea che ci sia uno Stato, una scuola, una società, in una parola, un Sistema di cui si parla in terza persona, il cui preciso fine è quello di fregare, appunto, un noi in cui s’includono tutti coloro che, almeno pro tempore, lottano per il disvelamento del grande inganno (e perciò sono esenti da qualsiasi colpa). Nel frattempo, in attesa di passare da fregati a freganti, giacché tertium non datur, prendono per il ciuffo e linciano la professoressa - e, nella Lettera, i laureati in genere : memorabile il passo in cui si lamenta il fatto che «le segreterie dei partiti a tutti i livelli sono saldamente in mano ai laureati». A rileggerlo oggi c’è da ridere fino alle lacrime.
La buona fede della professoressa è un’aggravante, comunque difficile da accettare. Meglio credere che l’azzimata docente sia ben informata del complotto, e lo avalli in coscienza, d’accordo col dottore e col giudice di cui è sposa fedele (così la Lettera). Crederlo renderà più gustosa la sassaiola. La colpa, in fondo, è sempre della professoressa, ultimo ingranaggio del «carro armato» costruito dai ricchi (alias fascisti, aliasdottori, aliasPierino, nel linguaggio della Lettera) per schiacciare i poveri, alias contadini, alias Gianni, eroe degli ultimi di Barbiana, pronti a diventare i primi con rapidità ben poco evangelica.
Già, perché nell’arco di pochi anni ricchi e poveri saranno indistinguibili, e finiranno per scambiarsi le parti in un balletto che avrebbe fatto girar la testa al curato del Mugello. Potenti diverranno gl’incensatori dell’altarino di don Milani, mentre gli odiati laureati, lungi dall’accaparrarsi laticlavi e ministeri (distribuiti con altri imperscrutabili criteri), faranno la coda per un posto da lavapiatti.
Ma è così che i primi saranno ultimi? Ah che rebus! A restare al suo posto sarà solo la professoressa, composta donna d’ordine che ieri bocciava troppo e oggi nemmeno può, anche volendo: ieri come oggi, sotto la gragnuola d’insulti di chi la vuole responsabile di tutti gli analfabetismi, capro espiatorio di ogni delitto. Mi fa una tenerezza. Sarà anche per questo che, in barba ai lapidatori seriali, ai curati ribelli e ai loro chierichetti, ai cercatori di complotti e ai pubblici predicatori, non so che farci: quasi per istinto, io sto con la professoressa.
-
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- Don Milani è vivo (di Elio Boscaini).16 febbraio 2011, di Federico La Sala
Don Milani è vivo
di Elio Boscaini (Nigrizia, 15.02.2011
Il 15 febbraio 1966, il Tribunale di Roma assolveva don Lorenzo Milani dall’accusa di apologia di reato per essersi espresso a favore dell’ dell’obiezione di coscienza al servizio militare. Don Milani aveva 42 anni ed era parroco di 42 anime! Lo scriveva lui stesso. A quella sentenza non potevo essere presente - frequentavo soltanto la terza liceo classico ed ero a Lucca - ma dall’eco data dalla stampa alla notizia, percepivo che rappresentava una pietra miliare nella vicenda civile e religiosa del nostro paese.
Mi sembra bello ricordare quell’avvenimento, a poche settimane dalla celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Perché la Lettera ai cappellani militari, la Lettera ai giudici e la motivazione stessa della sentenza partono sì dal problema allora rovente dell’obiezione di coscienza al servizio militare, ma contribuiscono ad un esame critico di tutta la storia nazionale seguita all’Unità. Proprio partendo dal "ripudio" della guerra, don Lorenzo costruisce una discussione colma di passione sui fondamenti del vivere civile, sugli strumenti di lotta contro le ingiustizie, sul diritto-dovere di migliorare le leggi, sulla responsabilità legata ad ogni scelta personale.
Nello scrivere la Lettera ai giudici (Barbiana, 18 ottobre 1965) - la scrive con i suoi ragazzi! - si scusa di non poter scendere a Roma perché malato: «Ci tengo a precisarlo - scrive - perché dai tempi di Porta Pia i preti italiani sono sospettati di avere poco rispetto per lo Stato. E questa è proprio l’accusa che mi si fa in questo processo. Ma essa non è fondata per moltissimi miei confratelli e in nessun modo per me. Vi spiegherò anzi quanto mi stia a cuore imprimere nei miei ragazzi il senso della legge e il rispetto per i tribunali degli uomini».
Con i suoi ragazzi a scuola 12 ore al giorno e 365 giorni l’anno, ha rivisitato la storia italiana in cerca di una guerra giusta, cioè in regola con l’art.11 della Costituzione: «Non è colpa nostra se non l’abbiamo trovata».
Dall’Africa ho riportato con me L’obbedienza non è più una virtù, della Libreria editrice fiorentina, che raccoglie i documenti del processo di don Milani. Nel rivisitare la nostra storia, il profeta di Barbiana, che peli sulla lingua (sulla penna, bisognerebbe dire) proprio non ne aveva, scriveva: «Ai miei ragazzi insegno che le frontiere sono concetti superati. Quando scrivevamo la lettera incriminata abbiamo visto che i nostri paletti di confine sono stati sempre in viaggio. E ciò che seguita a cambiar di posto secondo il capriccio delle fortune militari non può esser dogma di fede né civile né religiosa. Ci presentavano l’Impero come una gloria della Patria! Avevo 13 anni. Mi par oggi. Saltavo di gioia per l’Impero. I nostri maestri s’erano dimenticati di dirci che gli etiopici erano migliori di noi. Che andavamo a bruciare le loro capanne con dentro le loro donne e i loro bambini mentre loro non ci avevano fatto nulla (...). Che gli italiani in Etiopia abbiano usato gas è un fatto su cui è inutile chiuder gli occhi».
Nella sua risposta ai cappellani militari toscani che avevano sottoscritto il comunicato dell’11 febbraio 1965 in cui «considerano un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta "obiezione di coscienza" che, estranea al comandamento cristiano dell’amore, è espressione di viltà», don Lorenzo se la prendeva con quegli ufficiali che per due volte (1896 e 1935) avevano aggredito « un popolo pacifico e lontano che certo non minacciava i confini della nostra Patria. Era l’unico popolo nero (etiopico, ndr) che non fosse ancora appestato dalla peste del colonialismo europeo. Quando si battono bianchi e neri siete coi bianchi? Non vi basta di imporci la Patria Italia? Volete imporci anche la Patria Razza Bianca? Siete di quei preti che leggono la Nazione? Stateci attenti perché quel giornale considera la vita d’un bianco più che quella di 100 neri. Avete visto come ha messo in risalto l’uccisione di 60 bianchi nel Congo, dimenticando di descrivere la contemporanea immane strage di neri e di cercarne i mandanti qui in Europa?».
Grazie, don Lorenzo, perché continui ad insegnarci che non serve avere le mani libere se poi si tengono in tasca... e che conoscere la storia dell’Italia unita significa anche non dimenticare un passato che non è stato solo glorioso e che continuamente ci rimanda ai rapporti del nostro Paese con i popoli d’Africa che aspirano a più giustizia e maggiore libertà. (Elio Boscaini)
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ---- Don Milani, la forza di dire no (di Giulio Iacchetti).14 novembre 2010, di Federico La Sala
Don Milani, la forza di dire no
di Giulio Iacchetti (Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2010)
Non ricordo con precisione il mio primo incontro con don Milani; nella fase che ha preceduto il servizio militare mi è capitato di approfondire il discorso sull’obiezione di coscienza e credo di averlo incontrato a quell’epoca, leggendo un volumetto postumo, L’obbedienza non è più una virtù, scritto da don Milani insieme ai suoi alunni della scuola popolare di Barbiana. Confrontandomi con quei contenuti ho scelto poi di farlo, il servizio militare, perché ritenevo di non essere ispirato da passioni sincere per fare obiezione di coscienza. Forse mi mancavano argomenti sufficienti per sostenere una scelta che a quell’epoca era molto rigorosa. Un giorno, all’inizio degli anni Novanta, di ritorno da Roma, in un viaggio assieme ad alcuni amici, abbiamo deciso di uscire all’uscita Mugello e di salire a Barbiana: è stato un momento molto forte dopo il quale ho iniziato a leggere e a informarmi maggiormente sull’argomento.
Poi ho incrociato Lettere ad una professoressa. Quando mi chiedono che libro voglio ricordare sopra ogni altro io non ho nessun dubbio, cito sempre Lettere ad una professoressa; per me è ancora uno stimolo fortissimo. Leggendolo, capisco che la sostanza diventa vita e le teorie diventano sangue e carne; mi ritrovo ogni volta commosso dall’esperienza di vita di una persona e di questi ragazzini che, insieme, scrivono un testo capace di azzerare ogni certezza e ogni precisa posizione, e così facendo riescono a costruire un’idea fatta di vissuto e di esistenza autentica, che porta dritti all’essenza del ruolo dell’insegnante e della formazione, visti come possibilità di riscatto dei più poveri.
La dedizione totale alla propria missione è, a mio avviso, una testimonianza spendibile da ognuno di noi, a prescindere dalla questione religiosa, che mi interessa relativamente. In qualità di progettista mi capita spesso di coprire il ruolo del docente, sebbene non sia per me una cosa continuativa; ogni anno ho un corso d’esame e capitano altri lavori presso il Politecnico o altre strutture universitarie. In queste situazioni la mia tensione è quella di trattare le persone con lo sguardo che potrebbe avere don Milani.
Trovo che sia molto semplice stigmatizzare il difetto, il problema, la mancanza, l’incapacità, l’insufficienza ma è più ardimentoso e più appassionante cogliere il buono da ogni idea, anche se mal espressa. Questa è la sfida di sempre: credo che nessuno di noi abbia diritto di bocciare e di rimandare gli alunni, come non aveva diritto la professoressa del libro.
All’epoca c’era una scuola classista, nella quale per i figli dei poveri o per chi abitava in montagna era preclusa ogni possibilità di proseguire gli studi; don Milani lo spiega molto chiaramente, dati alla mano, in termini di giornate scolastiche perse da coloro che non avevano accesso. Gli scolari si perdevano, non andavano più a scuola e interrompevano in anticipo gli studi, spesso venivano bollati come inadatti allo studio, respinti e rimandati nelle fabbriche e nei campi.
Adesso, forse, la situazione del diritto allo studio, grazie anche all’azione di don Milani, è cambiata; purtroppo è cambiata in peggio anche la qualità della scuola italiana.
Le sue passioni avevano a che fare con situazioni molto concrete, dall’organizzazione della scuola popolare, dove quelli più grandi insegnavano a quelli più piccoli, al suo odio verso la ricreazione, vissuta come una forma di impegno che portasse a dimenticarsi il dovere della formazione e per poter affrontare bene il mondo.
Aveva anche scritto a un regista francese per proporgli la trama di un film su Gesù Cristo, per dimostrare che la vita di Gesù Cristo era simile alla vita degli operai; non era solo una questione di fatti evangelici e sacri ma una vita di tristezza e restrizione. Sosteneva che i poveri, i suoi contadini e operai, andando al cinema potevano uscire con l’idea che Gesù Cristo aveva a che fare con la loro vita.
Aveva scritto a Bernabei, allora presidente della Rai, per chiedere che in televisione fossero insegnate le lingue straniere, perché diceva che i figli degli immigrati che tornavano in Italia non sapevano governare bene la lingua che avevano imparato e voleva che fosse forma di riscatto anche l’insegnamento della lingua inglese o tedesca.
Salendo sulla montagna che porta a Barbiana all’inizio si è molto baldanzosi, la strada è bella, in mezzo ai cipressi; poi c’è un ultimo tratto da fare a piedi. Di recente mi è capitato di arrivarci all’ora del crepuscolo, cominciava a fare freddo e quella tipica energia da gita in montagna, allegra, si era smarrita, lasciando il posto a una desolazione completa. Si vedono la canonica e il piccolo cimitero in cui è sepolto. Così ci si può ricondurre veramente allo spirito della sua lezione, alla volontà di mantenere tutto inalterato. Il suo allievo prediletto, che lui ha accolto come un figlio, Michele Gesuardi, in seguito diventato presidente della provincia di Firenze, ha voluto mantenere Barbiana inalterata; per fortuna don Milani non è diventato un’icona nel mondo della chiesa cattolica, ma è rimasto una figura scomoda, scomoda per tutti. A Barbiana non ci sono chioschi che vendono bibite, non c’è la santificazione che si percepisce quando si va in pellegrinaggio a Pietrelcina.
Ancora oggi è un paese difficile da raggiungere, proprio come il suo ispiratore. Visitando la terra in cui ha vissuto e operato, e naturalmente leggendo i suoi libri, si producono sempre dei dubbi. Don Milani, per me, resta un meraviglioso generatore di dubbi.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". ----- E il paese dei balocchi (di Francesco Merlo).25 maggio 2010, di Federico La Sala
Il paese dei balocchi
di Francesco Merlo (la Repubblica, 25.05.2010)
Da ministra del rigore a ministra del tempo libero, da sacerdotessa dello studium a fanatica dell’otium, da bacchetta che castiga a sbracata Lucignola che vuole mandare tutti i bimbi italiani nel paese dei balocchi.
Insomma «per favorire il turismo» la ministra dell’Istruzione Mariastella Gelmini vuole ritardare di un mese l’apertura dell’anno scolastico, dai primi di settembre ai primi di ottobre. Attenzione: non per ragioni didattiche né per qualche forma, sia pure contorta o distorta, di saggezza pedagogica, ma soltanto per allungare la vacanza, per aiutare l’industria del tempo libero, per fare divertire di più i ragazzi italiani che solitamente bastona e per fare riposare di più i professori contro i quali scaglia lampi ed emette tuoni.
Dopo avere maltrattato gli insegnanti come fannulloni ignoranti e avere insultato gli studenti come somari e pelandroni, dopo avere predicato il ritorno alla disciplina e al faticoso impegno, Nostra Signora dei Grembiulini ha dunque scoperto la virtù della pigrizia rilanciando il sogno di tutti gli asini del mondo e persino riproponendo quel modello sessantottino contro il quale si batte in maniera ossessiva: viva la strada che libera gli istinti e abbasso la scuola che li reprime.
Persino la Lega che solitamente incoraggia e istiga le numerose e creative riforme antimeridionali, xenofobe e anti eruopee della Gelmini, ha obiettato alla ministra che le mamme che lavorano non saprebbero letteralmente «dove mettere i bambini» e che la legge italiana impone agli insegnanti almeno duecento giorni di didattica l’anno, che è lo standard europeo del diritto allo studio.
Se non assistessimo all’agonia di un’istituzione che la ministra ha deciso di far saltare ogni mattina nel cerchio di fuoco potremmo limitarci a ridere per questa incoerente sparata a favore del torpore e della lentezza degli italiani che la ministra vorrebbe stiracchiare sino all’autunno, come ai tempi del libro Cuore, quando la scuola cominciava il 17 ottobre perché il signorino Carlo Nobis aveva bisogno di tre mesi di villeggiatura per rilassarsi e il muratorino, che era bravo a fare «il muso di lepre», ne aveva necessità per lavorare, come Precossi, figlio del fabbro ferraio e come Coretti che «si leva alle cinque per aiutare suo padre a portar legna e alle 11 nella scuola non può più tenere gli occhi aperti».
In realtà la Gelmini resuscita il morto per ammazzare il vivo. Non è vero che vuole tornare alla scuola di De Amicis perché coltiva nobili rimpianti, ma solo per ridurre i costi e malmenare ancora gli odiatissimi professori, i nuovi straccioni d’Italia. È per soldi che la Gelmini si è subito gettata su questa proposta del suo compagno di partito, il carneade Giorgio Rosario Costa, un commercialista di Lecce che sinora si era fatto notare proponendo l’istituzione dell’Albo Nazionale dei Pizzaioli, e che adesso deve averla sparata così tanto per spararla e non gli pare vero di essere stato cooptato dalla ministra nell’Accademia dei Saggi e degli Equilibrati.
Ormai gli italiani - anche quelli che la votano - hanno capito che la Gelmini ha una sola ossessione: tagliare, contabilizzare, chiudere e, insieme con l’agitatissimo Brunetta, umiliare e cacciare via. È infatti evidente che spostando l’inizio delle lezioni ad ottobre lo Stato risparmierebbe un mese di stipendio ai precari che per la ministra sono come la Comune di Parigi o la Moneda di Allende, le ultime roccaforti del potere sindacale e della sinistra miserabile. Più in generale se davvero riuscisse ad allungare le vacanze scolari di un altro mese la Gelmini taglierebbe le unghia a tutti gli insegnanti italiani contro i quali sta già per avventarsi la manovra economica con il blocco degli scatti automatici di anzianità e di qualsiasi rinnovo contrattuale. Che cosa vogliono questi fannulloni ai quali lo Stato ha regalato un altro mese di vacanze? Ecco un’idea di buon governo: togliere il lavoro a qualcuno per poi punirlo come scansafatiche, perdigiorno e parassita.
In realtà con l’ossessione che il libro e i processi formativi sono in mano alla sinistra, e con la missione di trasformare gli insegnanti nel nuovo sottoproletariato italiano la Gelmini aggredisce ogni volta che può il già malandato tempio attorno al quale si organizza l’Italia come comunità, il luogo che tiene in piedi la democrazia, lo studium appunto che - mai ci stancheremo di ripeterlo - vuol dire amore, passione e dunque vita: «A Barbiana tutti i ragazzi andavano a scuola dalla mattina presto sino alla sera tardi, estate e inverno, e non c’era ricreazione e non si faceva vacanza neppure la domenica».
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". --- A Barbiana,per iniziativa della Fondazione don Lorenzo Milani, «Il sentiero della Costituzione».14 aprile 2010, di Federico La Sala
A Barbiana il sentiero della Costituzione
Nasce a Barbiana in provincia di Firenze, per iniziativa della Fondazione don Lorenzo Milani, «Il sentiero della Costituzione». *
Saranno allestiti in modo permanente, lungo il sentiero nel bosco che sale per 1,5 km. fino alla Scuola di Barbiana, cinquanta grandi pannelli con gli articoli della Costituzione italiana, illustrati con immagini disegnate da ragazzi di diverse scuole italiane. Una sorta di libro di strada per stimolare le scolaresche, che sempre più numerose si recano a Barbiana, a riflettere sui valori costituzionali. Il Sentiero è lo stesso che percorse don Lorenzo Milani quando arrivò la prima volta a Barbiana. All’epoca, alla canonica si accedeva unicamente per quella mulattiera. Il percorso costituzionale sarà presentato durante una conferenza stampa oggi, mercoledì 14 aprile, nella sede della Provincia a Firenze.
* Avvenire, 14.04.2010
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". --- Minacciare la bocciatura? Non si può. Anzi, è reato. Lo ha stabilito la corte di Cassazione.24 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
"Minacciare bocciatura è reato" *
ROMA - Minacciare la bocciatura? Non si può. Anzi, è reato. Lo ha stabilito, con una sentenza destinata a far discutere, la corte di Cassazione.
Insomma, il professore che intimidisce i suoi studenti promettendogli la bocciatura commette il reato di minaccia aggravata. E nella sentenza si legge che per i ragazzi "la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze" e un simile atteggiamento del docente è "idoneo ad ingenerare forti timori, incidendo sulla libertà morale" degli allievi.
Per questo motivo la Suprema Corte ha confermato la condanna per Marcello P., (50 anni) insegnante del liceo scientifico ’Paolo Lioy’ di Vicenza.
I legali del docente - condannato anche per abuso d’ufficio per aver dato a pagamento ripetizioni private agli studenti costringendoli anche a fargli dei regali - avevano sostenuto che il reato di minaccia non era configurabile "in quanto il tale minacciato (l’ingiusta bocciatura) non dipendeva solo dalla sua volontà, ma dall’intero collegio dei docenti". Ma gli ermellini hanno bocciato questa tesi e confermato il verdetto di colpevolezza emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 23 ottobre 2007.
In particolare, il ’prof’ aveva detto a Silvia C. che "non aveva più alcuna possibilità di essere promossa", per ’vendicarsi’ di un intervento fatto nell’Assemblea dei genitori dalla mamma della ragazza che proponeva di rimuovere il docente, per la sua scorrettezza, nel triennio successivo.
* la Repubblica, 24 settembre 2008
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". --- LORENZO MILANI. ANALISI SPIRITUALE E INTERPRETAZIONE PEDAGOGICA. L’attualità di don Milani oltre le facili letture (di Alberto Ghidini).12 agosto 2008, di Federico La Sala
 PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
 Gettando il proprio corpo nella lotta
Gettando il proprio corpo nella lotta
 L’attualità di don Milani oltre le facili letture
L’attualità di don Milani oltre le facili letture
 di Alberto Ghidini (il manifesto, 10.08.2008)
di Alberto Ghidini (il manifesto, 10.08.2008) LIBRI: LORENZO MILANI. ANALISI SPIRITUALE E INTERPRETAZIONE PEDAGOGICA
LIBRI: LORENZO MILANI. ANALISI SPIRITUALE E INTERPRETAZIONE PEDAGOGICA
 DI JOSÉ LOUIS CORZO,
DI JOSÉ LOUIS CORZO,
 SERVITIUM, PAGINE 478, EURO 28
SERVITIUM, PAGINE 478, EURO 28Nell’ottobre 1967, quattro mesi dopo la morte di don Lorenzo Milani, Pier Paolo Pasolini venne invitato alla Casa della Cultura di Milano per una discussione con i ragazzi di Barbiana. In maniera, come suo solito, «parresiastica», Pasolini si rivolse agli allievi di don Milani criticando Lettera a una professoressa, un libro di cui aveva in ogni caso colto a fondo la portata e da lui stesso definito «straordinario» per diverse ragioni. Interrotto polemicamente più volte per certi suoi passaggi e riferimenti giudicati troppo «intellettuali» e «letterari», riuscì comunque a portare a termine il proprio intervento, a conclusione del quale, dopo aver citato un motto degli intellettuali neri americani secondo cui bisogna «gettare il proprio corpo nella lotta», si rivolse ai presenti cin queste parole: «ebbene fate conto che, invece che a parlare, io sia venuto qui a portare il mio corpo». Si tratta di un episodio indubbiamente significativo, ripreso anche da Giorgio Pecorini nel suo studio documentario Don Milani! Chi era costui? - edito nel 1996 da Baldini Castoldi Dalai -, che getta luce sul rapporto non sempre facile tra Pasolini, i movimenti giovanili del tempo e la loro «ansia di cambiare il mondo».
In un articolo apparso esattamente un anno fa sull’inserto domenicale del Sole 24 Ore, Goffredo Fofi scriveva che Pasolini e (prima di lui) don Milani possono essere considerati a buon diritto come «gli ultimi veri pedagogisti italiani». Entrambi, infatti, credevano ancora nel potenziale rivoluzionario dell’educazione. Per lo scrittore corsaro e luterano che all’inizio degli anni Settanta esercitò una critica violenta alla modernizzazione capitalistica, al nuovo potere educativo e di controllo dei consumi e della comunicazione di massa, agente di un’impetuosa «mutazione antropologica», il prete intellettuale fiorentino rappresentò una vera e propria figura di riferimento.Don Milani aveva infatti capito che non si può educare se non si è pronti a lottare in prima persona, senza mediazioni.
Per questo - ricorrendo all’immagine di Pasolini - «gettò il suo corpo» in un ambiente impervio, non soltanto dal punto di vista geografico, incarnando, fin sul letto di morte, l’idea di una «giustizia necessaria». Non a caso, proprio così lo ricorda anche Michele Ranchetti, nella densa e partecipata nota che accompagna la traduzione di Monica Serena dell’ottima monografia che José Louis Corzo Toral ha dedicato al priore di Barbiana. Si tratta di un libro da leggere - secondo le condivisibili parole del curatore Fulvio Cesare Manara - per imparare ad «ascoltare don Milani» con la stessa «cura» di Corzo, padre scolopio spagnolo, studioso di altissimo profilo, ma anche «militante» della pedagogia di Milani ed esperto di «scrittura collettiva». Corzo, in Italia, è noto anche per una versione ridotta e adattata da Francuccio Gesualdi del suo ampio studio Escritura colectiva: teoría y práctica de la escuela de Barbiana, uscito in Spagna per Anaya e pubblicato in Italia da Edizioni Gruppo Abele con il titolo Don Milani nella scrittura collettiva.
Intrecciando esperienza di vita e ricerca scientifica, Corzo ha saputo accostarsi a don Milani esplorandone criticamente e radicalmente la dimensione spirituale e il contributo pedagogico attraverso una lettura «complessa», che restituisce un’immagine «integrale» del prete educatore. Pubblicato per la prima volta in Spagna nel 1981, questo lavoro - che trae origine dalle ricerche per una tesi di dottorato in teologia difesa all’Università Pontificia di Salamanca, dove ora Corzo insegna presso il campus di Madrid - rimane unico nel panorama europeo, se si esclude per certi versi l’Italia. Va comunque detto che studi tanto approfonditi sull’opera di don Milani sono rari anche in Italia, dove spesso si è privilegiato l’aspetto, per dir cosi, «agiografico». Ciò ha contribuito non poco a una conoscenza parziale e distorta di don Milani, sempre meno studiato e «ascoltato», benché costantemente citato e «tirato per la tonaca» dai più disparati interpreti. Nel maggio scorso anche il ministro Bondi ha provato «a farlo suo» in occasione di un convegno della Fondazione Magna Carta di Marcello Pera svoltosi a Firenze.
Oggi, di fronte al pullulare del suo nome, se vogliamo davvero ricordare Milani, non possiamo farlo se rinnovare al tempo stesso la sua esperienza pedagogica. Per questa ragione, sarebbe bene - come ha suggerito Enzo Mazzi - iniziare a fare i conti con il contesto attuale. Il bel libro di Corzo, in questo, aiuta a comprendere la necessità di ritornare al messaggio di don Milani, ma al tempo stesso invita a capire, come osserva Paolo Perticari nella sua efficace postfazione, a comprendere che cosa resta di quel messaggio mentre si sta affermando uno scenario politico che fa sentire ancora più forte l’urgenza della lotta.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". --- LORENZO MILANI. ANALISI SPIRITUALE E INTERPRETAZIONE PEDAGOGICA. L’attualità di don Milani oltre le facili letture (di Alberto Ghidini).22 agosto 2008Io faccio l’educatore e getto tutti i giorni il mio corpo nella lotta, provare per credere...
-
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". --- Studio di un ricercatore della Banca d’Italia sui divari territoriali e familiari. I ragazzi di provenienza socio-economica svantaggiata sono meno bravi (di Rosaria Amato).10 giugno 2008, di Maria Paola Falqui
 Studio di un ricercatore della Banca d’Italia sui divari territoriali e familiari
Studio di un ricercatore della Banca d’Italia sui divari territoriali e familiari
 I ragazzi di provenienza socio-economica svantaggiata sono meno bravi
I ragazzi di provenienza socio-economica svantaggiata sono meno bravi Scuola, gli studenti più poveri
Scuola, gli studenti più poveri
 rendono meno, soprattutto al Sud
rendono meno, soprattutto al Sud Le differenze si attenuerebbero alla media superiore, ma i più abbienti
Le differenze si attenuerebbero alla media superiore, ma i più abbienti
 sono portati a scegliere gli istituti migliori, in particolare i licei
sono portati a scegliere gli istituti migliori, in particolare i liceidi ROSARIA AMATO *
ROMA - Svantaggiati dalla nascita. Gli studenti del Mezzogiorno provenienti da famiglie povere, o in condizioni economiche modeste, a scuola sono meno bravi. Un divario che incide su quello, più generale, tra Nord e Sud, e che si attenua solo alle scuole medie superiori. Lì a contare è soprattutto la scelta dell’istituto: sono più bravi gli studenti dei licei, meno quelli degli istituti tecnici (frequentati peraltro dal 70% degli studenti italiani). Ma anche in questo la provenienza socio-economica dello studente incide pesantemente, perché sono soprattutto i ragazzi che vengono da famiglie agiate a essere spinti dalla famiglia verso i licei. Sono le conclusioni alle quali arriva uno studio pubblicato dalla Banca d’Italia, condotto da Pasqualino Montanaro, che mette a confronto le principali indagini internazionali sulla scuola, da quella dell’Ocse (Pisa) alla Timss e Invalsi.
Dall’analisi incrociata delle rilevazioni, spiega Montanaro, del Nucleo per la ricerca economica della sede di Ancona della Banca d’Italia, emerge che "il livello di proficiency nel Mezzogiorno è significativamente più basso rispetto agli standard internazionali e a quelli delle regioni settentrionali, in tutti gli ambiti di valutazione considerati (comprensione del testo, matematica, scienze, problem solving), "il grado di dispersione dei punteggi è più elevato al Sud" (cioè al Sud sono molto significative le differenze), "i divari territoriali tendono a crescere durante il percorso scolastico".
Un quadro desolante, nel quale incide pesantemente la situazione economica delle famiglie. "E’ ampiamente riconosciuto - si legge nello studio - che le differenti condizioni sociali e culturali, già a partire dall’età prescolare, influiscono in maniera decisiva sulle abilità cognitive, sulla capacità di esprimere se stessa, di percepire i colori, di comprendere spazi e forme, di rappresentare fenomeni di natura quantitativa".
Gli svantaggi nell’apprendimento dei meno abbienti sono evidenti soprattutto nei primi anni di scuola. Per quanto riguarda la matematica, per esempio, "in media il punteggio ottenuto da uno studente con lo status sociale più elevato supera del 25% circa quello ottenuto da uno studente con lo status sociale più basso". Peraltro in generale gli studenti meridionali sono meno bravi anche quando possono beneficiare delle più favorevoli condizioni sociali, ma "il divario Nord-Sud è più ampio nelle classi sociali più basse e ridotto in quelle più elevate".
Andando però più avanti negli studi, pesa invece soprattutto la scelta del tipo di scuola. Tutte le indagini dimostrano che sono più elevati i rendimenti degli studenti dei licei, anche se "non è chiaro se essere iscritti a un liceo o frequentare comunque una buona scuola effettivamente determini, in maniera diretta, una migliore performance scolastica, o se al contrario questa sia una semplice correlazione spuria, dovuta al fatto che gli studenti migliori tendono, per varie ragioni, a frequentare le scuole migliori, soprattutto se si tratta di licei".
Ma per gli studenti adolescenti la provenienza familiare pesa a quel punto nella scelta della scuola: "In base ai dati Pisa 2003, la probabilità di uno studente appartenente alla classe sociale più elevata di essere iscritto a un liceo è sette volte più alta di quella di uno studente con le più sfavorevoli condizioni familiari. Tali evidenze sono ricorrenti in tutte le aree geografiche".
In altre parole, quando uno studente proveniente da una famiglia povera potrebbe finalmente lasciarsi alle spalle lo svantaggio che gli deriva dalle condizioni sociali, scegliendo un liceo, invece viene spinto a scegliere una scuola professionale, perpetuando così il suo deficit di apprendimento.
* la Repubblica, 10 giugno 2008.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - ---- La figura del sacerdote di Barbiana è messa sull’altare per ridurlo a un innocuo feticcio. Mettiamo via gli incensieri! (di Enzo Mazzi).4 dicembre 2007, di Maria Paola Falqui
La figura del sacerdote di Barbiana è messa sull’altare per ridurlo a un innocuo feticcio
Un mito per tutte le stagioni
Ricordare Don Milani a quarantanni dalla sua morte vuol dire fare i conti con il contesto nel quale operò. E registrare i cambiamenti avvenuti per rinnovare la sua esperienza
di Enzo Mazzi (il manifesto, 02.12.2007)
C’è una affermazione che racchiude credo il senso della vita di don Milani: «Il mondo ingiusto l’hanno da raddrizzare i poveri e lo raddrizzeranno solo quando l’avranno giudicato e condannato con mente aperta e sveglia come la può avere solo un povero che è stato a scuola». È una frase problematica, letta oggi. Perché i poveri hanno avuto ed hanno la scuola. Ma il mondo non sembra che sia stato raddrizzato.
Guardando però quella frase come paradigma ideale della grande transizione storica della nostra epoca, essa racchiude il progetto, la positiva presunzione di Barbiana: vivere la crisi della società arcaica e la caduta di secolari barriere per soddisfare l’altrettanto secolare sete di protagonismo, anzi di sovranità delle classi popolari; e in secondo luogo far propri gli strumenti offerti dalla società moderna, cioè la diffusione delle conoscenze e del senso critico, giungendo a usare tali strumenti contro lo stesso progetto di trasformazione delle classi dominanti.
Un unico filo lega fra loro tutte le altre esperienze di quel laboratorio culturale, ecclesiale, sociale e politico che si è sviluppato nella Firenze degli anni ’50-’70: vivere la grande transizione storica facendo spazio ai valori di giustizia, solidarietà, protagonismo e partecipazione di cui, seppur con grandi contraddizioni, erano portatrici le classi popolari. Le cose non sono andate secondo le aspettative di quel paradigma ideale che ci animava. Ma non sarà che a quello stesso paradigma si dovrà ritornare come unica risorsa per risalire dall’orrido baratro in cui stiamo scivolando?
Esplorare l’ignoto
Quando, nell’immediato dopoguerra, studiavamo teologia nel Seminario fiorentino, la nostra ansia culturale e intellettuale, la tensione morale e la ricerca di fede erano tutte protese a uscire dalla prigione della sintesi sacrale del medioevo, evitando però l’abbraccio mortifero di una modernità che aveva sì riaperto lo spazio dell’autonomia e della libertà ma, per estrema contraddizione, aveva anche sottomesso il mondo al clima di terrore della guerra totale.
La cupola del tempio, imponente utero materno, non racchiudeva più i cuori e le menti di alcuni giovani seminaristi. Avevamo bisogno di volare alto. Ma la cupola di fuoco della bomba si presentava come un approdo altrettanto oppressivo. Fra questi poli, simbolicamente espressi dalle due cupole, nasceva una appassionata ricerca di sintesi nuove, di percorsi creativi, di tentativi inediti. Eravamo ingenui, ma non stupidi; idealisti, ma non privi di quel realismo autentico che è la dote di chi non ha altra scelta che tentare l’inesplorato.
Non sapevamo che il mondo operaio e contadino era agli sgoccioli. Ma non eravamo neppure in attesa della sua messianica vittoria. Ci premeva l’affermazione e la penetrazione dei valori umani ed evangelici dei poveri nella società e nella Chiesa. Quei valori, fra l’altro, che alcuni di noi, provenienti da famiglie proletarie di sinistra, avevano succhiato col latte materno e che poi entrando in seminario avevano abbandonato non senza un senso di rottura e quasi di tradimento. Ora si trattava di immergersi di nuovo in quella realtà dalla quale si proveniva. Non era il caso di don Milani che proveniva da una famiglia alto borghese e che nell’intimo sentiva il bisogno di una specie di lavacro.
Con un tale desiderio di incarnazione nel «mondo dei poveri», uno dopo l’altro uscimmo di seminario. Ci trovammo immersi in un crogiolo che andava ben oltre la nostra immaginazione e i nostri progetti. Si preparava la metafora di uno di quei magici tempi della evoluzione della specie in cui nasce un essere nuovo.
Una rivoluzione copernicana
Ci accorgemmo ben presto, già alle prime esperienze di pratica pastorale, che non si trattava solo di una questione di preti, di Chiesa o di Vangelo. La società intera era investita da una trasformazione profonda e ambigua. Proprio per questo però l’opportunità che si apriva per il Vangelo e per la Chiesa era di incalcolabile valore. Bisognava scommettere la vita intera e la stessa fede. È quello che tentammo di fare, giovanissimi preti, chi in fabbrica, chi nelle parrocchie, perseguendo esperienze che insieme a tante altre analoghe avrebbero preparato e alimentato la rivoluzione copernicana del Concilio e la rivoluzione culturale e sociale del ’68. Isolare don Milani da questo contesto non serve a lui e non serve alla storia.
In particolare chi ha amore alla scuola e cerca e sperimenta la fatica di percorsi innovativi non ha bisogno di miti. Quanto piuttosto, io credo, di annodare i fili di tante esperienze, individuando, anche nella scuola di Barbiana, le costanti o gli orientamenti di fondo di un processo di emersione e di riscatto delle culture negate. O la scuola infatti si porrà come fondamentale l’obbiettivo di levatrice dell’intreccio fra le culture che finora non hanno avuto acccesso alla visibilità o sbatterà la testa contro l’impotenza di un riformismo da allevamento. Barbiana in questo è preziosa; purché non se faccia un quadretto da «presepio di Greccio». I poveri oggi hanno la parola e restano poveri. Molti immigrati che puliscono le nostre fogne sono laureati. Essi non hanno bisogno di maestri. Barbiana a loro non serve come esempio di scuola ma come esperimento di comunità oltre i confini.
Dunque don Milani è stato smentito? Se si isola e si mitizza il messaggio della persona, direi di sì. E qui ritorna il tema della comunità oltre i confini. È vero che don Milani era lontano dall’esperienza delle comunità di base e dalla stessa riforma conciliare. Lui diceva infatti: «la religione consiste solo nell’osservare i dieci comandamenti e confessarsi presto quando non si sono osservati. Tutto il resto o sono balle o appartiene a un livello che non è per me e che certo non serve ai poveri». Non l’abbiamo mai avuto vicino quando alimentavamo, ispiravamo e sostenevamo la battaglia dei padri conciliari, tipo il cardinale Lercaro o dom Franzoni, per la Chiesa povera e dei poveri e per la Chiesa-comunità di comunità aperta e in cammino. Questo significa che lui non ha dato il suo contributo? Ma niente affatto. Se lo si stacca dal contesto può anche essere. Ma collocato dentro il processo storico don Milani ha dato sostegno a tanti come me nella nostra esperienza e nella stessa lotta per l’attuazione del Concilio. Barbiana non è un’esperienza conciliare nella forma e nelle intenzioni, ma lo è nella sostanza. E’ per questo che io sento vivo Lorenzo, lo sento attuale, perché è vivo e attuale il processo storico di umanizzazione sociale dal basso al quale egli ha dato il suo prezioso contributo. E qui vorrei spendere ancora una parola di critica verso la mitizzazione del personaggio. Non ci serve anzi è di ostacolo il mito don Milani che si sta affermando.
Centrare tutta la luce sulla sua persona oscura ancora una volta i poveri, la gente umile. Milani, Milani, sia pure, ma dove sono finiti i contadini, le contadine e gli operai che mezzo secolo fa animavano ancora i monti del Mugello, insignificanti formiche per la cultura borghese, in realtà per noi grandi personalità della cultura popolare? Ne ho conosciuti diversi e mi sono rimasti nell’anima e nella mente.
Un fiore all’occhiello
Ho proposto agli amministratori di alcuni comuni del Mugello, che fanno convegni, ricerche, pubblicazioni su don Milani, di fare una ricerca sulla cultura popolare e i suoi personaggi prima dell’inurbamento. Non ci sentono. Milani è un fiore all’occhiello da sfruttare per far cassa? Non bisognerebbe mai dimenticare quanto egli scrive all’amico Giorgio Pecorini come in un testamento in una delle sue ultime lettere: «Ma devi fare qualcosa per me. Prima di tutto perché è vero quello che ti dico cioè che il lavoro è tutto dei ragazzi... Non voglio morire signore cioè autore di un libro, ma con la gioia che qualcuno ha capito che per scrivere non occorre né genio né personalità ... Così la classe operaia saprà scrivere meglio di quella borghese. E’ per questo che io ho speso la mia vita e non per farmi incensare dai borghesi come uno di loro».
Mettiamo via gli incensieri!
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". --- GAETANO ARFE’ E DON LORENZO MILANI, FERTILE INCONTRO (di Valentino Parlato).14 ottobre 2007, di Federico La Sala
Il lungo e forte legame tra un socialista e un prete molto particolare
Arfè e Milani, fertile incontro
Un rapporto, tra un laico e un cattolico, cominciato negli anni ’50
di Valentino Parlato (il manifesto, 13.10.2007)
Un mese fa è morto a Napoli Gaetano Arfè. Era nato a Somma Vesuviana il 12 novembre 1925: gli mancavano 60 giorni a compiere 82 anni. «Negli ultimi anni della sua lunga vita», ha scritto l’indomani Gianpasquale Santomassimo su questo giornale, «ha lasciato molte memorie, molte ricapitolazioni autobiografiche, quasi con la volontà di fissare il ricordo di uomini, di momenti, di storie individuali e collettive per sottrarle all’oblio». Storico del socialismo italiano, Arfè faceva quel suo mestiere con la stessa onestà con cui da cittadino viveva la militanza politica. Senza però mai subordinare il rigore scientifico alla passione ideologica: «Scrivo non già nelle vesti di storico ma di chi è stato partecipe di una storia che ha avuto i colori dell’epopea e l’andamento di una chanson de geste», ha avvertito a proposito di quelle sue tesimonianze.
Una delle più intense e meno note è sul rapporto con Lorenzo Milani. S’incontrano tra la fine del 1952 e l’inizio del ’53. Gaetano Arfè, 27 anni, è funzionario degli Archivi di Stato: il ministro democristiano dell’interno Mario Scelba lo ha appena trasferito da Napoli a Firenze per la colpa di essere socialista. Lorenzo Milani, due anni e mezzo di più, da 10 convertito, da 5 prete, è cappellano a San Donato di Calenzano, cintura industriale fiorentina. Lì ha impiantato quella scuola popolare serale che, aperta a tutti i giovani senza discriminazioni politiche o partitiche purché di estrazione operaia o contadina, gli ha subito tirato addosso prima la diffidenza poi l’aperta ostilità dei parrocchiani benpensanti, dei notabili democristiani, di tutti i moderati e di quasi tutti i sacerdoti del circondario. Neppure due anni, e la curia se lo caverà dai piedi «promuovendolo» a Sant’Andrea di Barbiana: un centinaio d’anime in una manciata di case sparpagliate a 500 metri sulle pendici del monte Giovi, senza strada, senz’acqua e senza luce: una parrocchia di cui era già stata decisa e annunciata la chiusura, tenuta invece aperta per esiliarci lui.
Ma la scuola intanto continua. Milani, saputo da amici fidati cattolici e laici di quel giovane storico ateo, socialista e serio, lo vuole a farci lezioni sulla storia del socialismo italiano e sulla questione meridionale. Arfè accetta; ed è per entrambi una bellissima reciproca scoperta d’amicizia.
Milani, com’è suo costume, non la racconta: la vive e la utilizza, si può dire la sfrutta. Confinato a Barbiana dal dicembre del ’54. al nuovo amico, diventato parlamentare e direttore dell’Avanti!, chiede prima pareri sull’abbozzo di Esperienze pastorali poi nel ’58, all’uscita del libro, una recensione. Infine nel ’67, ormai alla vigilia della morte, verifiche di dati e notizie per Lettera a una professoressa che sta scrivendo assieme ai ragazzi. Arfè, secondo il proprio mestiere, analizza e documenta. Comincia già nell’ottobre del ’58 recensendo a botta calda Esperienze (Il Ponte, n. 10). Prosegue nel ’74 dando una lunga intervista a Neera Fallaci per la biografia che lei sta scrivendo (Dalla parte dell’ultimo) e nel ’76 intervenendo assieme a Ernesto Balducci e Giorgio La Pira in un film di Ivan Angeli (Don Milani). Conclude nel ’95 con «Una testimonianza» sulla Nuova Antologia (n. 2194). E alle sortite pubbliche accompagna una costante attenzione privata, nelle conversazioni, nella corrispondenza con gli amici e negli incontri coi giovani, sempre più frequenti negli ultimi anni: vedere le due lettere presentate qui accanto.
Ma come e perché un ateo, socialista di fede politica e storico di mestiere, può avere una consonanza così intensa e un rapporto così coinvolgente con un prete dall’ortodossia tanto rigorosa, quasi ossessiva? E, specularmente, come e perché quel prete può avere un rapporto di fiducia e di stima incondizionate oltre che di interesse culturale con un intellettuale non credente? Quale minimo (o massimo?) comune denominatore li unisce? «Quanto profondamente ha studiato il libro il socialista Gaetano Arfè. Lui davvero lo ha capito più di ogni altro», scrive Milani a Giuseppe D’Avack, il vescovo autore della prefazione a «Esperienze pastorali». E in polemica con la feroce stroncatura di Civiltà cattolica che preannuncia la censura del santo offizio, precisa: «Lui certo non trova nessun contrasto tra ciò che lei dice dell’obbedienza e ciò che si legge tra le mie righe. Di me infatti dice che "scrivo mell’àmbito della più rigorosa ortodossia dottrinale e della più rigidamente intesa disciplina ecclesiastica"». Arfè e Milani, insomma, incarnazioni di quelle «due culture», laica e religiosa, che ostinatamente il nostro Filippo Gentiloni esorta a finalmente incontrarsi.
— -
lettereIl carteggio
Gaetano Arfè ha sempre seguitato da studioso e da cittadino a interessarsi di don Lorenzo Milani e delle sue due scuole, senza mai modificare la propria miscredenza laica. Il giornalista Pecorini, un altro laico non credente, non convertito e non convertendo nonostante il privilegio di un’intensa amicizia con don Lorenzo. aveva mandato ad Arfè due libri. Uno era il suo «Don Milani! Chi era costui?» (Baldini & Castoldi), un saggio-testimonianza con acclusa la registrazione di due conversazioni col priore. L’altro «I care ancora», raccolta da lui curata di scritti milaniani: «Lettere, progetti, appunti e carte varie inedite e/o restaurate», con acclusa la videocassetta di un documentario sulla Scuola di Barbiana. Arfè con le due lettere inedite ringrazia, oltre Pecorini, il comboniano Ottavio Raimondo, responsabile dell’Emi, editrice dell’«I care», che glielo aveva spedito direttamente. (senza data, ma entrambe col timbro postale del 6 febbraio 2001)
 Reverendissimo Padre Raimondo,
Reverendissimo Padre Raimondo,
 le sono assai grato del libro che ha voluto inviarmi. Don Lorenzo, mio coetaneo, ha esercitato su di me un influsso assai forte.
le sono assai grato del libro che ha voluto inviarmi. Don Lorenzo, mio coetaneo, ha esercitato su di me un influsso assai forte.
 Nella mia formazione che considero ancora non conclusa - finché si è vivi si deve esser capaci di assimilare esperienze nuove - egli ha -lasciato un’impronta rimasta incancellata.
Nella mia formazione che considero ancora non conclusa - finché si è vivi si deve esser capaci di assimilare esperienze nuove - egli ha -lasciato un’impronta rimasta incancellata.
 Ne ho parlato molte volte con amici e studenti di diversa età - una volta in un teatro napoletano gremito di studenti, provenienti da una scuola media a lui intitolata che organizzarono l’incontro convogliando ragazzi anche da altri istituti.
Ne ho parlato molte volte con amici e studenti di diversa età - una volta in un teatro napoletano gremito di studenti, provenienti da una scuola media a lui intitolata che organizzarono l’incontro convogliando ragazzi anche da altri istituti.
 Fu quella la prima volta che misi per iscritto i miei ricordi e mi permetto di inviarle il testo. Mi ritorna frequente il progetto di riscrivere e ampliare quelle pagine , ma dubito che le mie condizioni presenti me lo consentano.
Fu quella la prima volta che misi per iscritto i miei ricordi e mi permetto di inviarle il testo. Mi ritorna frequente il progetto di riscrivere e ampliare quelle pagine , ma dubito che le mie condizioni presenti me lo consentano.
 Voglia comunque accogliere con indulgenza queste poche pagine e credere al sentimento di amicizia che mi lega a quanti furono amici di don Lorenzo.
Suo Gaetano Arfè
Voglia comunque accogliere con indulgenza queste poche pagine e credere al sentimento di amicizia che mi lega a quanti furono amici di don Lorenzo.
Suo Gaetano Arfè Caro Pecorini,
Caro Pecorini,
 mi scuso del ritardo, ma ho avuto giornate molto pesanti. Mia moglie è allo stadio finale della sua malattia e la mia capacità di resistenza
mi scuso del ritardo, ma ho avuto giornate molto pesanti. Mia moglie è allo stadio finale della sua malattia e la mia capacità di resistenza
 è pressata dagli acciacchi e dagli anni.
è pressata dagli acciacchi e dagli anni.
 Dei due volumi e della cassetta le sono veramente grato. Ho potuto dedicare alla lettura, finora, solo qualche ora e sento il desiderio, direi il bisogno, di leggerli impegnandovi tutto il tempo necessario quando si leggono libri di cui ogni pagina va pensata e «assorbita».
Dei due volumi e della cassetta le sono veramente grato. Ho potuto dedicare alla lettura, finora, solo qualche ora e sento il desiderio, direi il bisogno, di leggerli impegnandovi tutto il tempo necessario quando si leggono libri di cui ogni pagina va pensata e «assorbita».
 Non è un complimento. Con la sincerità che il ricordo di don Milani mi impone, le dico che ho trovato magistrale la tecnica con la quale ha costruito il suo lavoro e affascinante la lettura delle sue pagine. Nessuna delle cose che letto su di lui ha la forza e la freschezza delle sue pagine. Se mi sarà possibile ne scriverò in qualcuna delle riviste semiclandestine che mi ospitano di tanto in tanto. Dovrei avere ancora qualche lettera di don Milani, tra le mie carte colpite a suo tempo da un attentato dinamitardo e successivamente dal crollo di un intonaco. Se riesco a trovarle gliele farò avere.
Non è un complimento. Con la sincerità che il ricordo di don Milani mi impone, le dico che ho trovato magistrale la tecnica con la quale ha costruito il suo lavoro e affascinante la lettura delle sue pagine. Nessuna delle cose che letto su di lui ha la forza e la freschezza delle sue pagine. Se mi sarà possibile ne scriverò in qualcuna delle riviste semiclandestine che mi ospitano di tanto in tanto. Dovrei avere ancora qualche lettera di don Milani, tra le mie carte colpite a suo tempo da un attentato dinamitardo e successivamente dal crollo di un intonaco. Se riesco a trovarle gliele farò avere.
 Grazie ancora, e mi abbia, con grande amicizia
Grazie ancora, e mi abbia, con grande amicizia
 Suo Gaetano Arfè
Suo Gaetano Arfè -
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -9 luglio 2007, di Federico La Sala
LETTERA DI DON LORENZO MILANI A GAETANO CARCANO - MILANO *
Barbiana, 3.9.1958
Caro signor Carcano,
ho ricevuto il suo dattiloscritto e l’ho letto più volte con cura. Ho anche cercato di annotare qualcosa. Ho dovuto però concludere che non ci potevo far nulla.
Se dovessi presentarmi io al Convegno vorrei andare subito al nocciolo del problema degli operai e dei contadini lontani: l’atteggiamento politico e sociale del clero.
Ho nel mio vecchio popolo di San Donato una ventina di licenziati della R. [Importante fabbrica di Sesto Fiorentino]. Gente che ci ha lavorato anche decine d’anni e ci ha rimesso magari anche la salute (silicosi e reumatismi) e che s’è sentita leggere dopo la guerra una lettera che veniva da Milano e diceva che la direzione non avrebbe mai dimenticato quello che gli operai di Sesto avevano fatto per la R. (salvato gli impianti e il museo dai tedeschi. Gesù ebbe un Giuda su 12, la R. tra tutti i suoi operai non l’ebbe). Ora questi operai sono stati licenziati e beffati. E l’uomo che li ha sfruttati (ci si è arricchito in modo inverosimile, il loro lavoro «svogliato» a lui ha fruttato tanto che la loro vecchia fabbrica ne ha fatte nascere altre sette), l’uomo che li ha ingannati e traditi, i preti, proprio i preti (Comitati Civici) lo hanno fatto mettere nella lista di un partito che osa profanare così il nome di cristiano.
Che serve avere una bella chiesa senza immagini di cattivo gusto, non dire «scherzi da. prete», avere canti armoniosi, panche comode, libri di canto unificati, preghiere unificate, mitre che si levano e mettono, fiori naturali invece che finti, messali con la chiara indicazione di Ambrosiano o Romano, zie del prete che non si danno il rossetto, se poi c’è in chiesa la vittima del signor V. [Principale azionista della ditta R.] la quale ha in tasca un volantino comunista dove c’è una fotografia del V. inginocchiato davanti al Papa non per ricevere le invettive evangeliche («Guai a voi...») o scomuniche, ma una benevola benedizione?
Quell’operaio potrà perdonare il Papa, potrà aver pietà di quel povero vecchio ignaro non per sua colpa di tutto ciò che è vita cruda e vera, ma non potrà perdonare il suo prete che non è corso a avvertire il Papa e non inveisce dall’altare in difesa dell’oppresso (non ne aveva tempo, aveva da costruire con l’aiuto economico del Papa un campo sportivo da 11 milioni).
Lei forse dirà: «Questi sono episodi laterali». Ma quell’operaio non li trova affatto laterali e non solo perché c’è di mezzo il pane dei suoi bambini (cosa tutt’altro che laterale), ma anche perché c’è di mezzo la sua dignità di cittadino d’una repubblica che si dice democratica ma manda la Celere solo a difendere i beni del V. contro l’operaio, mai il bene dell’operaio contro il V. che lo calpesta, e poi c’è di mezzo la sua coscienza di cristiano che si ribella all’ingiustizia e alla crudeltà e vede che il suo prete difende il partito che vuol mandare il V. a far le leggi! (come se le leggi non fossero tutte già abbastanza a favore del V. e contro al povero) e vede che il suo prete non inveisce questa volta con la stessa forza con cui inveisce (giustamente) ogni volta che parla di ingiustizie e crudeltà comuniste.
Caro signor Carcano, non vada al Convegno a dir cose laterali e secondarie. Vada a dire che ne aveva pensate tante e poi a un tratto le è apparso davanti agli occhi che c’era una sproporzione tra quelle piccole cose e una cosa grande e grave: i lontani sono lontani perché i preti hanno voluto immischiarsi nelle cose terrene e ci han perso la serenità di giudizio. E hanno consacrato l’attività dell’Azione Cattolica in campo politico (Comitati Civici) e non hanno separato la loro responsabilità da quella dell’Azione Cattolica quando si seppe che i Comitati Civici avevano mercanteggiato con la Confintesa i seggi «cristiani», cioè di ingannare milioni di poveretti che credono in Dio e hanno fiducia nel loro parroco (questa notizia non l’ha data «L’Unità» ma «Il Popolo» e nessuno l’ha smentita).
Ho visto sì anche nel suo questionario qualche domanda generica su questi argomenti, ma se lei ha la fortuna di potersi rivolgere anche per mezz’ora sola a un’accolta di preti e di vescovi non ci vuole una domanda generica e moderata, di quelle che non urtano nessuno, e tanto meno attenuata da tante domande insignificanti che ha accanto. Ci vuole una parola dura, affilata, che spezzi e ferisca, cioè una parola concreta come sono i due esempi qualsiasi che le ho fatto e i tanti altri che lei può leggere sul mio libro. Tagliare e colpire crudelmente come fa il chirurgo perché la maggior pietà del chirurgo è di non aver pietà.
E se tutto questo crede di non poterlo fare, allora per piacere non parli. Non dia ai preti che l’ascolteranno l’illusione di avere ascoltato per bocca sua i bisogni della famiglia cristiana. La famiglia cristiana dell’operaio e del contadino ha bisogno di un prete povero, giusto, onesto, distaccato dal denaro e dalla potenza, dalla Confida, dal Governo, capace di dir pane al pane senza prudenza, senza educazione, senza pietà, senza tatto, senza politica, così come sapevano fare i profeti o Giovanni il Battista. Un prete che chiarisca cosa è bene e cosa è male in fatto di rapporti di lavoro e che si schieri dalla parte del giusto, del vero, del debole e smetta di difendere i «suoi» per partito preso, ma li difenda solo in quei pochissimi casi in cui la loro causa coincida perfettamente con la causa cristiana.
Vorrei dirle ancora molte altre cose, ma ne ho scritte già tante nel mio libro e scritte con la brutalità che si meritano e che le assicuro non è troppa. Se lei dunque vuol giovarsene faccia pure, ma la prego non attenui, non accomodi, non presenti signorilmente le cose che io dico e che non sono affatto signorili.
La presente lettera è uno sfogo privato con lei. Il mio libro le ha già mostrato che non ho paura delle conseguenze delle mie parole, ma se lei vuoi fare uso pubblico di qualche affermazione che qui le ho fatto la prego di avvertirmene perché io possa rivedere, precisare, documentare, portare insomma al livello e allo stile che ho usato nel libro. In questo momento non ho tempo di farlo perché ho qui i ragazzi a scuola che mi distraggono e perché non voglio tardare ancora a darle la risposta che mi ha chiesto. Un saluto affettuoso e mi scusi, suo
Lorenzo Milani
*
Da Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana, Arnoldo Mondadori, 1970, pp.78-82
Il destinatario di questa lettera, che allora era segretario del Comitato milanese del Fronte della Famiglia, doveva partecipare con una relazione a un convegno di aggiornamento sociale. Ammiratore di “Esperienze pastorali”, prima del convegno aveva mandato in lettura la sua relazione a don Lorenzo chiedendone un parere.
Articolo tratto da:
FORUM (62) Koinonia
http://utenti.lycos.it/periodicokoinonia/
* Il Dialogo, Lunedì, 09 luglio 2007
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -27 giugno 2007, di Federico La Sala
 A 40 anni dalla morte di don Milani
A 40 anni dalla morte di don Milani
 Giù le mani da don Milani...
Giù le mani da don Milani...di Alberto Bruno Simoni *
Sui giornali del 24 giugno campeggiava una foto di W.Veltroni e D.Franceschini insieme a M.Gesualdi che li guidava nella loro visita a Barbiana. Il fatto non mi ha entusiasmato ed anzi mi ha un po’ infastidito e insospettito, ricordando le parole di don Lorenzo Milani riportate da E.Martinelli nel suo libro: “Quando sarò morto tutti mi esalteranno, ma voi dovrete difendermi da ogni forma di mitizzazione!”.
In effetti, su L’Unità del giorno avanti, lo stesso M.Gesualdi, in una intervista, affermava: “Quando don Lorenzo morì, lo fece in una estrema solitudine, nessuna cattedrale, non c’erano né autorità civili né religiose, ma soltanto due pretini, gli altri preti stavano tutti lontani Ora lo tirano per la giacchetta, facendogli dire a volte cose che non ha mai detto. Chi pensa di rappresentare la società cerca di appropriarsene e paradossalmente era anche la sua paura, che dopo la sua morte se ne sarebbero appropriati non gli ultimi ma il mondo borghese da cui veniva... Non capisco quale parentela intellettuale possa esserci fra la Moratti e don Lorenzo. Se questi politici volessero fare le cose sul serio dovrebbero solo tacere” (L’Unità, 23 giugno 2007). E forse cercare meno visibilità - fosse pure a Barbiana - mi permetto di aggiungere io!
Non so se queste parole M.Gesualdi le abbia ripetute agli illustri ospiti o se abbia tentato di dire loro quanto avrebbe detto il suo Priore a persone così esposte e rappresentative. Avrebbe certamente potuto ripetere le parole stesse di Gesù riguardo a Giovanni Battista: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re! E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui, del quale sta scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te” (Mt 11, 7-10).
In effetti, don Lorenzo ha esercitato in un piccolo angolo quel ruolo di precursore, che il beato Giovanni XXIII assumerà per se stesso e per la chiesa intera: quello di “preparare al Signore un popolo ben disposto”! E mentre Papa Giovanni guarderà alla “chiesa dei poveri”, per don Milani sono i poveri in carne ed ossa la molla della sua azione pastorale. Tutto il resto per lui è modo, via e mezzo, mentre al di fuori di questa prospettiva tutto diventa visione unilaterale e strumentale, non rispettosa di lui.
Sempre sulle pagine de L’Unità, dedicate opportunamente al Priore di Barbiana, Enzo Mazzi ci richiama a questa realtà di base imprescindibile, e fa una osservazione indicativa di un metodo e di una prassi: “Il Priore di Barbiana non era in grande sintonia con le comunità di base eppure la comunità di vita e di studio a cui ha partecipato era molto simile ad una comunità di base, non nelle intenzioni ma certamente nella pratica: una pratica (fortunatamente) contraddittoria come lo è sempre la realtà della vita”.
Il rilievo di E.Mazzi relativamente alle comunità di base evidenzia un’attitudine costante di don Milani, che potrebbe essere vera anche riguardo al Concilio, all’aggiornamento della Chiesa, alla scuola, alla società e alla politica: egli sembra rimanere formalmente estraneo alle situazioni e ai movimenti esterni, ma in realtà porta la scure alla radice e produce soluzioni ai grandi problemi che altri agitano, senza darsi arie o etichette. Ma venendo al fatto specifico di cui sopra - la visita di Veltroni e Franceschini - c’è da impedire che don Milani venga giocato politicamente, quando invece solleciterebbe tutti a riportare l’azione politica alla sua radice personale di prassi umana o anche di credenti, a quel qualcosa che nasce e si consuma nel cuore di ciascuno e in rapporto all’altro, prima di ogni schieramento ideologico o partitico.
In termini laici di potrebbe parlare di etica o di stile, mentre in chiave religiosa si tratta di spiritualità: qualcosa che don Milani sembra quasi aver tradito, ma che in realtà ha prodotto in abbondanza, facendo giustizia di tante sue forme spurie. Forse sarebbe il caso di parlare anche di una “spiritualità sacerdotale” del Priore di Barbiana, ma soprattutto della sua coscienza di cristiano o di “neofita”. E se ossassimo parlare di “spiritualità politica!?
Uno squarcio di questa spiritualità ce lo offre opportunamente Massimo Toschi, che sempre su L’Unità del 23 giugno ci parla del “paradosso di Barbiana”.
Alberto Bruno Simoni
Articolo tratto da:
FORUM (60) Koinonia
http://utenti.lycos.it/periodicokoinonia/
* Il Dialogo, Mercoledì, 27 giugno 2007
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -24 giugno 2007, di Federico La Sala
Don Milani, la rivoluzione di Barbiana
di Massimo Toschi *
Quarant’anni fa, il 26 giugno 1967 moriva don Lorenzo Milani. Quarant’anni nella Scrittura indicano un tempo lungo, un tempo di ascolto del popolo di fronte a Dio che parla, un tempo di conversione, un tempo di preparazione: il tempo dell’esodo verso la terra promessa. In questi quarant’anni, migliaia e migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno continuato a salire a Barbiana per visitare la scuola, per pregare nella piccola chiesa di S.Andrea, per inginocchiarsi davanti alla tomba di don Lorenzo, nel piccolo cimitero parrocchiale. Una salita senza bandiere, senza associazioni, senza movimenti, senza mobilitazioni, sempre nel silenzio e nella ricerca interiore. Una processione senza fine, mai stanca, di generazioni che si consegnano una memoria. Perché la gente è andata e continua ad andare a Barbiana? A Barbiana non si va per cercare una identità culturale, una appartenenza religiosa, un santo protettore della buona politica come qualcuno ha cercato di fare. Chi va a Barbiana, al di là delle citazioni di rito, percepisce più o meno distintamente che in questa piccola parrocchia delle colline del Mugello è avvenuta una visita di Dio, che nella storia di don Milani ha posto la sua orma, la sua impronta. L’orma e l’impronta della povertà, dei mezzi poveri e della piccolezza.
Nato da madre di origine ebrea, nel 1923, viene battezzato nel 1933, all’età di dieci anni, per proteggerlo da possibili persecuzioni antiebraiche. Frequenta il liceo a Milano, e la sua conversione viene datata dalla testimonianza di don Bensi nel giugno del 1943 e nell’ottobre entra in seminario. Ordinato prete nel 1947, è cappellano di San Donato a Calenzano fino al 1954. Nel dicembre del 1954 viene nominato parroco a Barbiana, sperduta parrocchia del Mugello, già chiusa e poi riaperta per raccogliere questo singolare prete che a San Donato aveva avviato una scuola serale di giovani, che accoglieva insieme cattolici e comunisti, e poi aveva assunto, in occasione di elezioni amministrative e politiche posizioni molto ferme di critica alla Dc e al sostegno che la Chiesa le offriva, producendo reazioni molto forti dei preti delle parrocchie circostanti.
Una carriera ecclesiastica apparentemente modestissima, vissuta spesso nell’isolamento. Anche a Barbiana pochissimi preti lo vanno a trovare. Ma in questa condizione assolutamente modesta Dio davvero opera nella vita di don Milani. Già a san Donato l’intuizione della scuola per i ragazzi, per dare loro la parola e i diritti, fa della sua attività pastorale qualcosa di assolutamente innovativo.
Questa centralità della Parola e delle parole mostra il fallimento radicale di tutta la pastorale della ricreazione (ma la stessa cosa egli dice delle Case del popolo), fatta di forme festaiole che allontanano dai veri problemi di tutti: il lavoro, i diritti, lo scontro sociale nelle fabbriche nell’Italia che stava nascendo. Egli racconta tutto questo nel suo unico e straordinario libro Esperienze pastorali, che esce nel 1958 e alla fine dell’anno viene fatto ritirare dalla Santa Sede, per la radicalità delle sue critiche a un modello, che già allora mostrava tutto il suo fallimento. Don Lorenzo, nella lettera a don Piero, presente nel libro e che egli comincia a scrivere nel novembre 1953, dice: «per un prete quale tragedia più grossa di questa potrà mai venire? Essere liberi, avere in mano sacramenti, Camera, Senato, stampa, radio, campanili, pulpiti, scuola e con tutta questa dovizia di mezzi divini e umani raccogliere il bel frutto di essere derisi dai poveri, odiati dai più deboli, amati dai più forti. Vedersela vuotare ogni giorno di più, sapere presto che sarà finita per la fede dei poveri».
Queste parole sono la denuncia profetica del cristianesimo politico, di cui oggi vediamo gli ultimi e più pericolosi cascami, quando la Chiesa si fa soggetto politico e riempie le piazze per far cadere i governi,svuotando così la fede, manipolando la politica, e avendo la pretesa di diventare un improbabile sindacato di valori. È perché dice questo che don Milani è mandato a Barbiana. E si assiste al paradosso di Barbiana. L’isolamento cercato dalla curia fiorentina diventa immersione (battesimo) nel mondo dei poveri. La punizione diventa conversione ad una radicalità cristiana, fatta di fedeltà alla storia, coerenza evangelica e condivisione della fatica degli oppressi. Una piccola scuola privata e senza mezzi diventa il luogo di un cambiamento radicale della scuola pubblica. I mezzi poveri diventano la forza stessa del suo messaggio e della sua parola. La piccolezza di Barbiana diventa icona di una chiesa povera e libera per il vangelo.
Nel paradosso di Barbiana sta la visita di Dio. È questo paradosso che ancora oggi e domani tutti cercano, perché in questo paradosso sta il futuro della chiesa e della società italiana. In questo contesto nascono le lettere: non solo quelle più importanti la Lettera ai giudici e la Lettera ad una professoressa, ma le molte lettere alla mamma, agli amici e ai suoi ragazzi. In questa straordinaria documentazione si racconta il dramma di don Lorenzo con la sua chiesa e il suo vescovo, la sua concezione nobile della politica, la sua denuncia del fallimento educativo, la sua riforma della democrazia, il suo impegno per la costituzione e l’antifascismo, l’amore indicibile per un Dio che ha il volto povero dei suoi ragazzi.
A quarant’anni dalla sua morte da Barbiana arriva a tutti la lettera della visita di Dio per imparare a dare verità alle nostre parole e dare le nostre parole alla Verità. In questo don Milani non appartiene al nostro passato, ma sta dinanzi a noi e ci indica il futuro, che abita nella Parola libera e mite, capace di disarmare i cuori, e nelle parole, che sappiano narrare la domanda di giustizia dei più piccoli e di dare il nome vero alle ingiustizie.
* l’Unità, Pubblicato il: 23.06.07. Modificato il: 24.06.07 alle ore 13.54
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -21 giugno 2007, di Federico La Sala
Maturita’ 2007
BRP1 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CORSO SPERIMENTALE - Progetto “BROCCA”
Indirizzo: SOCIO - PSICO - PEDAGOGICO
Tema di: PEDAGOGIA
II
“Cercarsi un fine. Bisogna che sia onesto. Grande. Che non presupponga nel ragazzo null’altro che d’essere uomo. Cioè che vada bene per credenti e atei... Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare se non con la politica o col sindacato o con la scuola?
Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. Contro i classisti che siete voi, contro la fame, l’analfabetismo, il razzismo, le guerre coloniali. Ma questo è solo il fine ultimo da ricordare ogni tanto. Quello immediato da ricordare minuto per minuto è d’intendere gli altri e farsi intendere. E non basta certo l’italiano, che nel mondo non conta nulla. Gli uomini hanno bisogno d’amarsi anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna studiare molte lingue e tutte vive...
Perché è solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui. Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli.”
don Lorenzo MILANI, Lettera a una professoressa, 1967
− Cosa suggerisce oggi, a quarant’anni di distanza, il brano riportato? − Quali riflessioni provoca? − Sono ancora attuali le esigenze espresse? − Rispetto a quali situazioni specifiche?
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -20 giugno 2007, di Federico La Sala
Ricordo di un maestro diverso dagli altri. E sono passati 40 anni
Di Sandro Lagomarsini (Avvenire, 20.06.2007)
«La povertà non si misura a pane, a casa, a caldo. Si misura sul grado di cultura e sulla funzione sociale» (Esperienze Pastorali, p. 209). «Lo sai te cos’è per me la scuola popolare, vero? È la pupilla destra del mio occhio destro» (Lettere, p. 5). «Dammi altri trent’anni di scuola popolare e vedrai se non si comincerà a vedere qualcosa» (Lettere, p. 29). «Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio a averla piena. Insistono perché scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per far scuola, ma solo di come bisogna essere per poter far scuola» (Esperienze Pastorali, p. 239). «La scuola mi è sacra come un ottavo Sacramento» (Esperienze Pastorali, p. 203). «Vedo che leggete moltissimo e vi tenete sempre al corrente di tutto quello che di moderno e di geniale viene partorito nel mondo; io invece passo gran parte della giornata a far chiacchierare degli analfabeti per far del bene a loro e per arricchirmi io d’un mucchio di cose che da loro posso imparare» (Lettere, p. 32). «La differenza tra il mio figliolo e il vostro non è nella quantità né nella qualità del tesoro chiuso dentro la mente e il cuore, ma in qualcosa che è sulla soglia tra il dentro e il fuori, anzi è la soglia stessa: la Parola» (Lettere, p. 57). «Il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i "segni dei tempi", indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso» (Lettere, p. 250). «La scuola non può essere che aconfessionale e non può essere fatta che da un cattolico e non può esser fatta che per amore (cioè non dallo Stato). In altre parole la scuola come io la vorrei non esisterà mai altro che in qualche minuscola parrocchietta di montagna oppure nel piccolo d’una famiglia dove il babbo e la mamma fanno scuola ai loro bambini» (Lettere, p. 143). Sono pensieri di Lorenzo Milani, nato il 27 maggio 1923, morto parroco di Barbiana (Fi) il 26 giugno 1967.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -16 giugno 2007, di Federico La Sala
 Barbiana, don Ciotti
Barbiana, don Ciotti
 ricorda don Milani *
ricorda don Milani *Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) organizza un incontro a Barbiana, il 21 giugno prossimo, nel 40° anniversario della morte di don Milani. Una messa in ricordo del sacerdote sarà celebrata alle 11,30 nella chiesa di Barbiana da don Luigi Ciotti. L’iniziativa prevede anche una visita alla casa e al Centro Studi «Don Milani» di Vicchio. L’anniversario è per il Cnca l’occasione per ricordare l’importanza che ha avuto don Milani sull’elaborazione delle pratiche dell’accoglienza e per ripensare, oggi, la proposta educativa della comunità che fanno capo all’associazione.
* Avvenire, 16.06.2007
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -13 giugno 2007, di Federico La Sala
ANNIVERSARI
Il Priore moriva e a Torino nasceva il «Gruppo Abele». Parla don Ciotti
Don Milani, 40 anni sulla strada
«Le Barbiane dei nostri tempi sono ancora tante, in Africa o sulle spiagge dove le onde depongono i cadaveri dei clandestini»
di Luigi Ciotti (Avvenire, 13.06.2007)
Don Lorenzo Milani. Quando morì, quarant’anni fa, il Gruppo Abele cominciava appena a muovere i primi passi sulla strada, luogo di povertà, di bisogni, di linguaggi, di relazioni e domande in continua trasformazione che è stato elemento costitutivo della nostra identità e punto di riferimento del nostro lavoro. Ma è proprio su quella strada - misurandoci con l’incertezza e la complessità, educandoci a non selezionare i compagni di viaggio, nel dialogo e nella responsabilità reciproca - che abbiamo «incontrato» tante volte don Milani, toccati dal suo insegnamento, dalle sue sintuizioni, dalla viva eredità che ci ha lasciato. Ricordo un giorno, molti anni fa. Ero andato a Barbiana assieme a ragazzi del «Gruppo», alcuni dei quali segnati da dolorose e difficili storie di emarginazione. Percorremmo quella via in salita, lasciammo una firma sul quaderno del piccolo cimitero nascosto tra i boschi, ci sentimmo immersi nell’atmosfera di austerità e di essenzialità che avvolgeva quel luogo sperduto dell’Appennino.
Di certi posti aspri e selvatici si usa dire che sono «abbandonati da Dio». L’emozione di quel giorno - un’emozione che si rinnovò anche nelle occasioni successive - mi fece capire che, proprio a Barbiana, Dio aveva trovato in don Milani un testimone straordinario, capace di saldare il Cielo e la Terra, il Vangelo e la giustizia sociale, l’essere cristiani e cittadini in questo mondo e per questo mondo. Se il Gruppo Abele ha scelto come punto di riferimento la strada - e proprio «Università della strada» avremmo chiamato, alla fine degli anni Settanta, la nostra attività di formazione del sociale - fu anche grazie al coraggioso slancio di don Milani e di quella Chiesa che non aveva mai avuto paura d’incontrare e mischiarsi all’umanità più oppressa e fragile, in doppia fedeltà a Dio e all’uomo che non è un dividersi ma un rafforzare l’Uno attraverso l’amore dell’altro.
Suona allora perfino ovvio, a 40 anni dalla morte, parlare di attualità di don Milani. La st rada che ci ha indicato è infatti ancora lunga da percorrere. Nel mondo l’ingiustizia e la povertà non sono certo diminuite, e la Barbiana degli anni Cinquanta si riflette nelle tante Barbiane del nostro tempo: quelle dell’Africa e dell’America Latina, quelle delle zone di guerra e di certe spiagge del Mediterraneo, dove a volte le onde depongono i corpi delle vittime della fame, della schiavitù e dell’ingiustizia globale: 1582 nel solo 2006. Ma anche le Barbiane di chi dall’altra parte è approdato, senza però trovare pace e dignità: quelle delle baraccopoli e dei quartieri ghetto, delle case sovraffollate e dei rifugi di fortuna, quelle di chi cade in mano alle mafie del caporalato e della prostituzione.
Attuale è don Milani anche per la radicalità, la passione, la coerenza con cui ha percorso il suo tratto di strada. Una coerenza e una radicalità che non smettono di provocarci, essere pungolo alle nostre coscienze, animate da una fede che, scrive giovanissimo in Esperienze pastorali, non è qualcosa da «infilare alla prima occasione nei discorsi», ma un «modo di vivere e di pensare».
È in questa tensione spirituale ed etica che nasce e matura l’esperienza straordinaria della scuola. Don Milani riconosce grande importanza alla «parola», strumento non solo di salvezza ma anche di liberazione umana: «Ogni parola che non conosci è una pedata in più che avrai nella vita». La sua esperienza con i ragazzi della Scuola di Barbiana sta tutta in questo impegno: nel cercare di costruire, coinvolgendosi in prima persona, un’esperienza educativa volta a offrire a tutti, e specialmente ai più fragili, la conoscenza e il dominio della parola in quanto strumento essenziale per leggere la realtà, individuarne le contraddizioni e le disuguaglianze, e diventare così consapevoli dei propri diritti, della propria inviolabile dignità di persone e di cittadini. È in questo senso che va interpretato il famoso passo sulla disobbedienza che non è più virtù: non come un generico invito al la ribellione, ma come un’esortazione ad ascoltare la voce della propria coscienza, che non è mai accomodante e ci chiama sempre a quella responsabilità che proprio l’obbedienza acritica permette di eludere. In un mondo dominato dal sistema consumistico, dove i giovani sono continuamente soggetti alle lusinghe di un mercato che vorrebbe trasformarli in massa indifferenziata, la proposta di don Milani è destinata paradossalmente a farsi sempre più strada. Perché è una proposta liberante, che invita a essere critici, attenti a ciò che davvero è sostanziale, andando così incontro al bisogno di differenza presente nel cuore di ogni essere umano ma soprattutto in quello dei giovani, perché la vita in loro è ancora informe e quindi desiderosa di scoprirsi nella sua unicità, diversità, libertà. Libertà di cui don Milani è stato indubbiamente un maestro. A noi spetta il compito di esserne, almeno, testimoni credibili.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -21 maggio 2007, di Federico La Sala
LETTERA AL PRIORE DI BARBIANA *
di Alberto B. Simoni
Caro don Lorenzo,
la lettera è la forma letteraria che hai privilegiato, non solo per comunicazioni personali, ma anche per interventi pubblici, fino a quella “Lettera ad una professoressa” che ci hai lasciata come tuo testamento. Ricordo il giorno della prima presentazione a Roma, a cui partecipai, e fin da quel momento sentii il desiderio di scriverti, semplicemente per dirti grazie. Perché mi rendevo conto di quanto ti fosse costato tutto quel lavoro con i tuoi ragazzi e di quale dono ci aveste fatto..
Anche senza essere un custode della tua memoria e conoscitore di tutti i tuoi scritti (ma so che non ha dato patenti od esclusive a nessuno!), voglio dirti grazie per la tua vita di uomo, di cristiano, di prete: per la tua testimonianza, che hai racchiuso nelle parole “I care”. Ci dicono tutta la tua passione, dedizione, combattività e perseveranza nel cercare ed indicare vie nuove di servizio del Vangelo, perché arrivasse ai suoi destinatari senza troppe mediazioni e con terreno ben preparato. Non a tavolino, ma tra la gente e con la gente, in simbiosi con loro. Grazie per quello che sei stato ed hai vissuto, prima ancora che per il simbolo che sei diventato e che forse non avresti voluto mai essere!
Ma proprio questo innocente tradimento - che ti mette in cattedra, quando tu preferivi metterci i tuoi ragazzi - mi induce a chiederti di perdonarci, per come ti abbiamo utilizzato senza seguirti. Sì, ti abbiamo fatto a pezzi, e ciascuno ha preso quello che meglio credeva a proprio uso e consumo, mentre tu sei stato sempre tutto di un pezzo, senza mai cedere a mode, lusinghe, minacce, condanne. Ti abbiamo trasformato in suggeritore di formule, di proposte, di proteste, di ribellioni, senza mai andare al di là della tua scorza, per solidarizzare per quanto possibile con te e prendere in mano il tuo testimone, fatto di consacrazione piena al servizio del Vangelo per i più poveri, fino a fare “esperienze pastorali” e fare “scuola”, in modo da ridare dignità e sovranità alle persone, ai cristiani, alla Chiesa stessa. Abbiamo colto i frutti di stagione, ma non ci siamo innestati sul tronco di cui sei stato robusta pianta. Sei diventato per molti maestro di pedagogia e di viva coscienza civile - che non è poco. Ma purtroppo è andata dispersa o si è volatilizzata quella linfa vitale che avresti voluto immettere nella Chiesa, che ha avuto paura di essere da te contagiata e di sentirsi costretta a capovolgere la sua abituale e tradizionale scala di valori. Magari questa chiesa ha fatto di te un fiore all’occhiello per la sua credibilità davanti al mondo, ma continua - continuiamo - a tenerti alla porta, dove del resto hai preferito stare, nel senso in cui dicevi a Pipetta. Con la tua parola di verità, hai fatto giustizia di tante sue incrostazioni e avresti voluto ridarle un volto umano. Non sei stato riconosciuto e accolto tra i tuoi, e noi oggi siamo daccapo a dover ritrovare l’essenzialità tra le tante cose spurie di cui siamo ripieni e appesantiti e tra le troppe parole inutili di cui dovremo rendere conto. Nel tuo laboratorio umano sempre aperto, non ti sei stancato di inventare e cercare, sapendo che Dio può far nascere i suoi figli anche dalle pietre: sempre sensibile a chi ti stava accanto e attento a quanto succedeva intorno, non hai mai sperso di vista il tuo obiettivo e alla fine non l’hai mancato: entrare nella giustizia del Regno dei cieli passando per le cruna di un ago..
Ma anche se non ti abbiamo preso abbastanza sul serio, ci hai dimostrato che è possibile venirne a capo, o, come dicevi meglio tu, “sortirne” e sortirne insieme. A patto che rinunciamo a risonanze fatue, a soluzioni facili, a consensi, a paure, a stanchezze e condividiamo con te convinzione e determinazione, come chi ha messo mano all’aratro e non deve voltarsi indietro. Spesso ci siamo rifatti all’insegnamento che ci hai dato con la lettera a Pipetta, per non diventare dei conquistatori e vincitori, ma rimanere solidali con quanti necessitano di pari dignità ed opportunità. Per farci aiutare dalle tue parole a guardare in faccia le cose, abbiamo ora ripreso la “Lettera dall’oltretomba” (ancora una lettera!) e un passo dal libro che, oltre fatica e sofferenza, ti è costato l’emarginazione: “Esperienze pastorali”. E questo perché ci stiamo interrogando - non accademicamente, ma sollecitati dai fatti - sull’essere cristiani, quando le tue previsioni sono ormai realtà e i rimedi che suggerisci sono sempre validi. Ammesso che ci stiamo risvegliando ora, chissà che non sia ormai troppo tardi, e forse continuiamo a mescolare troppe estranee cause con quella di Cristo.
Ci solleciti a riconoscere l’illogicità del nostro modo di essere cristiani e a deciderci per una scelta coraggiosa e coerente, ma tutto sembra cadere nel vuoto, perché perdura lo stato di inferiorità e minorità culturale degli uditori e siamo immersi nella esteriorità e nella massificazione religiosa. Siamo impegnati ad uscire da questo stato di cose cercando di adottare il tuo metodo di riflessione e scrittura collettiva, ma le condizioni ed i tempi non sono molto propizi. Non per questo ci rinunciamo e cerchiamo di far tesoro di tutte le occasioni, le opportunità e le disponibilità, per riportarci ai motivi più profondi della nostra esistenza, umana, cristiana ed ecclesiale.
A tenerti presente in mezzo a noi e a mantenere viva la tua memoria ci aiuta ora uno dei tuoi ragazzi-figlioli, Edoardo Martinelli, che rivisita e rivive il suo rapporto con te per metterti in rapporto con noi tutti col suo libro (Don Lorenzo Milani. Dal motivo occasionale al motivo profondo) di cui parleremo insieme il giorno 16 giugno, per vedere se anche noi, a partire da queste opportunità, riusciamo ad andare in profondità e a condividere la tua testimonianza di ricerca con tutte le forze della tua anima di ciò che era al centro del tuo cuore: Dio e la vita eterna!
Sì, “Dio e la vita eterna” erano i tuoi punti di riferimento in tutte le circostanze della vita, vissuta in obbedienza al Signore Gesù che invitava a cercare il prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia, come tu hai sempre fatto. No, non ti spaventare, non voglio fare di te un santino e gridare “subito santo”, ma ti voglio pensare col tuo Dio e nella pienezza della vita eterna. Ed allora il rapporto con te diventa comunione dei santi e anche - perché no? - preghiera.
A proposito, sarebbe buona cosa se in questa luce la Chiesa fiorentina si proponesse di ricordarsi di te nel giorno del tuo passaggio da questo mondo al Padre, magari con una Eucarestia concelebrata non tanto per dare qualcosa a te, ma per arricchirsi della tua testimonianza e risvegliarsi davanti alle urgenze del momento, magari battendosi il petto. Nel nostro piccolo, ti ricorderemo insieme nel nostro incontro del 3 giugno insieme a Giovanni XXIII per il suo anniversario. Siete in qualche modo simili: l’impianto della vostra fede e spiritualità era dei più classici e tradizionali, ma questo non vi ha impedito di “preparare al Signore un popolo ben disposto”, che sapesse andare per le vie di un mondo non solo del tutto nuovo, ma in continua trasformazione.
La misura del tuo agire erano non genericamente gli “altri”, ma le persone, il prossimo-prossimo in carne ed ossa: non solo vorremmo avere presente questa tua lezione evangelica, ma cercare di tenere presente te come persona che ha “consacrato la sua vita al nome di Cristo Signore”, anche se a molti non sembrava così. Grazie per tutti, don Lorenzo, e continua a darci una mano per mantenere viva la nostra speranza.
Alberto B. Simoni
Articolo tratto da:
FORUM (55) Koinonia
http://utenti.lycos.it/periodicokoinonia/
* IL DIALOGO, Lunedì, 21 maggio 2007
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -26 maggio 2007, di Federico La Sala
Ma don Milani non era nemico della grammatica
di Sandro Lagomarsini (Avvenire, 26.05.2007)
«Non mi scoscenderai neanche con le mine!». Questa feroce volontà di non lasciarsi mettere in crisi è attribuita da don Milani, in «Esperienze Pastorali», al contadino del Mugello che va a confessarsi corazzato di convinzioni tradizionali. Ho l’impressione che lo stesso atteggiamento «corazzato» sia stato alla base dell’attacco al «milanismo» condotto da Sebastiano Vassalli quindici anni fa e rinverdito da Paola Mastrocola qualche giorno fa sulla «Stampa». È una corazza fatta anzitutto di luoghi comuni, a cominciare da don Milani «nemico della grammatica».
Scrive il priore di Barbiana nel ’56: «Sono otto anni che faccio scuola ai contadini e agli operai e ho lasciato ormai quasi tutte le altre materie. Non faccio più che lingua e lingue». Aggiunge nel ’58 che «tre anni di grammatica e di lingua» gli sono bastati per far vibrare i bambini «alla cultura, al pensiero, alla fede», mentre tra i giovani c’è qualcuno che «s’è battuto sui romanzieri russi e li intende». Quanto poi alla impostazione severa ed esigente delle scuole di don Milani, da quella «popolare» di San Donato a quella «privata e pirata» di Barbiana, si tratta di realtà nota e perfino criticata. Ma se i ragazzi barbianesi sull’ultima guerra stavano «quattr’ore senza respirare», è chiaro che alla severità si aggiungeva la capacità di interessare e coinvolgere.
La «Lettera a una professoressa» è datata? Ci mancherebbe che no, ma forse su altri punti, Opera di otto giovani di campagna coordinati da un prete moribondo, la Lettera contiene dati statistici, critiche puntuali, proposte discutibili; il tutto espresso in una lingua - lo riconosceva lo stesso Vassalli - da alta qualità letteraria. E allora è strano che proprio letterati professionisti leggano quelle pagine equivocando il senso di un genere letterario a sé stante, una rivendicazione di dignità che irrita e diverte, commuove e convince, ma non ha nulla a che fare con l’«odio di classe».
La «Lettera» responsabile dei problemi di oggi? Della scuola superiore in generale la «Lettera» non parla e, riferendosi solo alle magistrali, distingue in modo accurato: «Il problema qui si presenta tutto diverso da quello della scuola dell’obbligo. Là ognuno ha un diritto profondo a essere fatto eguale. Qui invece si tratta solo di abilitazioni. Si costruiscono cittadini specializzati al servizio degli altri. Si vogliono sicuri». E la severità vale anche «per il farmacista per il medico, per l’ingegnere». Dov’è dunque l’incoraggiamento al lassismo? I futuri letterati, che purtroppo lavoreranno a prostituire le parole alla merce nella pubblicità, hanno bisogno di conoscere l’«Iliade», l’«Odissea» e Foscolo. Ma nel «canone occidentale» ha un posto anche la Bibbia; la «Lettera» l’ha scoperto e la scuola continua a ignorarlo.
Le «professoresse» ripetono da quarant’anni che amano l’italiano e che devono essere esigenti. Brave. Ma la «Lettera» dice un’altra cosa. Afferma per quasi novanta pagine che la formazione linguistica di base, per milioni di ragazzi privi di retroterra culturale scritto, visto il poco tempo disponibile, deve puntare sul parlato, rinunciando se occorre a qualche «squisitezza letteraria»; e sostiene l’affermazione con dati di esperienza. Dov’è lo scandalo? Certo che le moderne tecniche di semplificazione e frantumazione dei testi - consigliate alle superiori - fanno inorridire, ma che c’entra in questo la «Lettera»? Si leggano, i critici, i programmi delle medie inferiori del 1979, che la «Lettera» ha sicuramente influenzato e dica se non sono ancora attuali; leggano poi i programmi elementari dell’85 e si accorgeranno che a quel punto la scuola ha preso tutt’altra strada. A Barbiana si imparava l’orgoglio delle proprie origini contadine e ci si apriva non da inferiori alle altre culture; la «Lettera» dimostra che il metodo funzionava.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -26 giugno 2007, di Federico La Sala
ANNIVERSARIO
Provocatorio e critico, fu «scomodo» a molti; ma ormai la Chiesa ha accolto il messaggio del Priore morto 40 anni fa
L’eredità di don Milani
C’è chi chiede di «riabilitarlo» però i due vescovi di Firenze Piovanelli e Antonelli hanno detto più volte e dimostrato con i fatti quanto ancora oggi don Lorenzo sia attuale. Gli manca l’aureola, è vero, anche perché la sua dovrebbe pungere come una corona di spine... La sua lezione comunque è filtrata
di Giovanni Gennari (Avvenire, 26.06.2006)
Morto da 40 anni e più vivo che mai: don Lorenzo Milani. Come lo prendi... punge. Sempre così. Decise di entrare in seminario per farsi prete, ma avvertì la madre solo la sera prima, sedendosi a cena: «Domani vado via!». Lasciava senza fiato. Unicamente prete: anche maestro, indagatore di fenomeni sociali, catechista, provocatore sì, ma da prete. E prete della Chiesa cattolica fiorentina, orgoglioso di esserlo nonostante incomprensioni e difficoltà.
Letto di recente su un giornale: «Ma è così difficile riabilitare Don Milani?». Colleghi in ritardo. Due cardinali arcivescovi di Firenze, Piovanelli e Antonelli, lo hanno detto e mostrato con i fatti. Attuale e da ascoltare anche oggi. Qual è il segreto di quest’uomo, di questo prete? Nel metodo, parole come sassi, o anche come spine. Sassi di un David moderno contro i Golia di sempre. Perciò i soliti incorreggibili, che già da vivo non lo sopportavano, sempre più soli dicono che oggi è superato, che la sua visione del mondo è manichea... Lui ha scelto i poveri e li ha resi coscienti della loro dignità: uomini e figli di Dio. Superato? Oggi tre quarti del mondo sono ancora più poveri dei ragazzi di Barbiana che lui, come diceva, ha «tirato su». Benedetto XVI ricorda spesso la fame, le ingiustizie, le umiliazioni di miliardi di figli di Dio! E allora? Don Lorenzo nasce nel 1923, studia, fa l’artista, conosce il mondo, a 20 anni trova Cristo e va in seminario, a 24 è prete. Il resto è conseguenza. Maestro a Calenzano, fa una scuola strana e disturba tanti, a 31 anni lo mandano in un paesino sperduto tra le montagne. Obbedisce, e insiste: prete per tutti e maestro per i ragazzi: 365 giorni all’anno, 12 ore al giorno. Intanto pubblica, con la prefazione calda e prudente di un vescovo, monsignor Giuseppe D’Avack, un libro che racconta le Esperienze Pastorali di Calenzano: analisi sociali, prospettive antropologiche, ipotesi di catechesi, riflessioni pastorali... Roba che pesa, come i sassi di David, e tanti hanno paura di prender li in fronte. Il libro è stroncato da riviste cattoliche e viene ritirato per ordine dell’allora Sant’Uffizio. Così si spiega - lo ha chiarito molte volte monsignor Capovilla - un giudizio duro di Giovanni XXIII ancora Patriarca a Venezia: aveva letto solo le stroncature di Civiltà Cattolica, poi ha mutato parere. Giovanni Battista Montini ha già allora un giudizio diverso, e pur nella prudenza anche da Papa ama e aiuta don Lorenzo, già malato, che gliene è gratissimo. Lui con i ragazzi vive, parla, scrive e testimonia, è irritato da chi cerca di utilizzarlo per dir male della sua Chiesa, cui nella fede ubbidisce sempre anche quando gli ordini paiono crudeli e mentre in ben altri contesti dà scandalo ricordando a tutti che «l’obbedienza non è più una virtù». Sta con i poveri, ma ammonisce - per tutti i Pipetta che sta crescendo - che il Vangelo ha l’ultima parola di beatitudine per la povertà nello Spirito Santo. Critico e autocritico, rigoroso con sé prima che con gli altri, tutto donato a Dio attraverso i suoi ragazzi... Fino alla fine, che arriva il 26 giugno 1967. Fine? Comincia allora la sua definitiva testimonianza, e dura da 40 anni. Ha avuto difficoltà con uomini di Chiesa come il cardinale Florit, che forse non riuscivano a vedere oltre la misura della loro cultura e dei loro limiti... In breve: un santo prete. Provocatorio? Pungente e spinoso? Sì, ma è la traduzione di altre spine, quelle della corona sulla Croce. Le ha portate il Maestro, chi lo segue davvero le indossa, e pungono ancora.
Riabilitare Don Milani? Già fatto, quasi da sempre. 30 (trenta!) anni or sono, qui su Avvenire, 24 giugno 1977, pagina 5, titolone: «Don Milani, un messaggio da riscoprire: ha vissuto solo di fede». E il giorno dopo, ancora pagina 5: «I suoi connotati: l’esperienza radicale della fede, l’amore e la passione per una Chiesa presente agli uomini...». Per caso: stesso giornale, proprio lì accanto, tre colonne: «Commosso saluto di Firenze al cardinale Florit». La fantasia di Dio, misericordiosa e giusta, talora si firma.
-
> Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani - a cura di pfls -6 agosto 2007, di Federico La Sala
RIFLESSIONE. DANIELE NOVARA: RICORDANDO MARIA MONTESSORI E DON LORENZO MILANI
E’ un anno di ricorrenze educative. Cent’anni fa si apriva la prima Casa dei bambini a Roma, l’inizio della straordinaria vicenda umana e pedagogica di Maria Montessori, forse la donna italiana del Novecento piu’ famosa nel mondo, senz’altro la piu’ grande pedagogista. Una figura purtroppo piu’ amata all’estero che nel suo Paese. Amareggiano i dati sul dimezzamento delle scuole montessoriane in Italia negli ultimi vent’anni, in contemporanea con l’aumento delle stesse in Europa e nel resto del mondo.
Come una forma di rinuncia alle proprie buone pratiche, a una memoria che mantenga del nostro Paese le parti e le persone migliori. Quarant’anni fa un’altra grande esperienza attraversava l’Italia: la Lettera a una professoressa, scritta dei ragazzi della scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani. Un documento straordinario che apri’ un dibattito profondo sul rapporto tra istituzione scolastica e benefici sociali, denunciando il sostanziale immobilismo della scuola rispetto alle provenienze socioeconomiche dei propri alunni. Ancora oggi, Lettera a una professoressa potrebbe essere riscritta allo stesso modo o quasi. Ancora oggi, il figlio del dottore e’ al liceo classico e il figlio dell’operaio all’istituto tecnico. Il primo ben avviato verso un’ottima carriera universitaria, il secondo che in forte percentuale mollera’ la scuola giusto col puro e semplice diploma. Anche la provocazione di don Lorenzo Milani resta nel complesso marginale all’interno di quello che oggi e’ il vissuto educativo e scolastico italiano. La scuola raramente e’ artefice di riscatto sociale.
Ma la riflessione che mi sembra piu’ calzante rispetto a questi due importanti anniversari e’ la rimozione nel nostro Paese di una riflessione educativa e di un approccio pedagogico in quanto tale. Recentemente mi sono divertito a scoprire come si possa ultimare un corso di laurea in Scienze dell’educazione senza aver mai sostenuto un esame di pedagogia. Ossia, in diverse citta’ italiane ci si puo’ laureare in Scienze dell’educazione senza la consapevolezza di quella che e’ la pedagogia stessa.
Un altro segnale imbarazzante e’ la chiusura di tutte le case editrici strettamente pedagogiche. Case editrici che, a prescindere dalla qualita’ piu’ o meno ondivaga o alternata, rappresentavano comunque un presidio rispetto al monitoraggio di una serie di confronti, di dibattiti e di approfondimenti comunque necessario per i tanti operatori educativi che da sempre sono presenti nel nostro Paese.
Da ultimo, ma non certo per ultimo, drammatica appare l’assenza da piu’ di dieci anni di ogni forma di formazione o aggiornamento obbligatorio per gli insegnanti della scuola pubblica italiana, come se questi professionisti potessero continuare a svolgere il loro lavoro senza alcun sostegno o rinforzo, senza alcun supporto di riqualificazione che, guarda caso, in tutti gli altri settori lavorativi rappresenta un elemento di qualita’ imprescindibile. * L’interesse che sento verso queste ricorrenze e’ nel ricordare come stiamo vivendo un momento di profonda carenza di riflessione, di ricerca e di confronto pedagogico, e che tutto questo sta provocando gravi conseguenze nella gestione delle nuove generazioni, nei processi di apprendimento, nell’utilizzo pertinente dell’istituzione scolastica ai fini dello sviluppo sociale e civile. Occorre riprendere al piu’ presto, cosi’ come nel resto d’Europa, una vocazione educativa e pedagogica che ha visto attraversare la nostra penisola grandi figure, due le ho ricordate precedentemente, ma si potrebbero segnalarne tante altre che oggi rischiano di essere celebrate piu’ dai nostri vicini europei che non da noi stessi. I tanti libri in lingua tedesca della Montessori e sulla Montessori, ben presenti sugli scaffali delle librerie di oltralpe, ci stanno a ricordare come il futuro dipenda dalla capacita’ di avere consapevolezza del proprio passato.
* Fonte: NOTIZIE MINIME DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO Numero 173 del 6 agosto 2007
[Dal sito www.progettouomo.net riprendiamo il seguente articolo li’ pubblicato il 18 luglio 2007 per gentile concessione del Centro psicopedagogico per la pace di Piacenza, col titolo "Memorie scomode di un’Italia senza sogni. La preziosa eredita’, spesso dimenticata, lasciata da don Lorenzo Milani e Maria Montessori".
Daniele Novara, pedagogista, consulente e formatore, e’ direttore del Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza; tra i primi in Italia ad affrontare in maniera organica una formazione improntata all’educazione alla pace, e’ autore e curatore di numerose pubblicazioni e collabora con varie riviste e case editrici; ha coordinato il progetto Citta’ dei bambini del Comune di Piacenza.
Tra le opere di Daniele Novara: con Lino Ronda, Materiali di educazione alla pace, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1984; con Massimo Esposito, La pace s’impara, Bologna, Emi, 1985; con Lino Ronda, Scegliere la pace. Educazione al disarmo, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1986, 1989; Scegliere la pace. Educazione ai rapporti, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1987, 1997; Scegliere la pace. Educazione alla giustizia, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1989; Scegliere la pace. Guida metodologica, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1991 (quarta edizione riveduta); (a cura di), L’istinto di pace, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1990; con Francesco Beretta, Anna Martinelli, Il litigio, Bologna, Emi, 1990, 1993; (a cura di), Ricominciare da un libro, Molfetta, La Meridiana, 1993; (a cura di), L’ascolto e il conflitto, Molfetta, La Meridiana, 1995; con Patrizia Londero, Scegliere la pace. Educazione alla solidarieta’, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1994, 1997; con Patrizia Londero, Scegliere la pace. Educazione al futuro, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1996; L’ascolto si impara. Domande legittime per una pedagogia dell’ascolto, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2002-3; con Diego Miscioscia, (a cura di), Le radici affettive dei conflitti, Molfetta, La Meridiana, 1998; con Elena Passerini, La strada dei bambini, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2002; con Silvia Mantovani, (a cura di), Bambini ma non troppo, Molfetta, La Meridiana, 2000; con Lorella Boccalini, Tutti i grandi sono stati bambini. Per un uso educativo della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2000; Obiettivo Solidarieta’, Torino, Ega-Paravia, 2001; Obiettivo Giustizia, Torino, Ega-Paravia, 2001; Obiettivo Rapporti, Torino, Ega-Paravia, 2001; Obiettivo Futuro, Torino, Ega-Paravia, 2001; Obiettivi... Guida per l’insegnante, Torino, Ega-Paravia, 2001; con Elena Passerini, Ti piacciono i tuoi vicini? Manuale di educazione socioaffettiva, Torino, Ega, 2003; (a cura di), Memoranda. Strumenti e materiali per la giornata della memoria, Molfetta, La Meridiana, 2003; (a cura di), Abbracci e litigi. Educazione ai rapporti per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni, Torino, Ega, 2004; (a cura di), La scuola dei genitori. Come aiutare i figli a diventare grandi, Piacenza, Berti, 2004; Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti, Io non vinco, tu non perdi. Un kit per promuovere l’educazione alla pace e la gestione dei conflitti tra ragazzi, Unicef, Roma 2004; (a cura di), Il genitore che ascolta. La funzione educativa dei padri e delle madri nella costruzione dell’autonomia dei figli e delle figlie, Piacenza, Berti, 2005; (a cura di), Ognuno cresce solo se sognato. Antologia essenziale della pedagogia critica, Molfetta, La Meridiana, 2005; io e... gli altri. Diventare cittadini - Percorso di educazione alla convivenza civile per il primo grado della scuola secondaria, Torino, Ega, 2005; io e... i diritti. Diventare cittadini - Percorso di educazione alla convivenza civile per il primo grado della scuola secondaria, Torino, Ega, 2005; io e... la solidarieta’. Diventare cittadini - Percorso di educazione alla convivenza civile per il primo grado della scuola secondaria, Torino, Ega, 2005; io e... Guida per l’insegnante. Diventare cittadini - Percorso di educazione alla convivenza civile per il primo grado della scuola secondaria, Torino, Ega, 2005.
Lorenzo Milani nacque a Firenze nel 1923, proveniente da una famiglia della borghesia intellettuale, ordinato prete nel 1947. Opera dapprima a S. Donato a Calenzano, ove realizza una scuola serale aperta a tutti i giovani di estrazione popolare e proletaria, senza discriminazioni politiche. Viene poi trasferito punitivamente a Barbiana nel 1954. Qui realizza l’esperienza della sua scuola. Nel 1958 pubblica Esperienze pastorali, di cui la gerarchia ecclesiastica ordinera’ il ritiro dal commercio. Nel 1965 scrive la lettera ai cappellani militari da cui derivera’ il processo i cui atti sono pubblicati ne L’obbedienza non e’ piu’ una virtu’. Muore dopo una lunga malattia nel 1967; era appena uscita la Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana. L’educazione come pratica di liberazione, la scelta di classe dalla parte degli oppressi, l’opposizione alla guerra, la denuncia della scuola classista che discrimina i poveri: sono alcuni dei temi su cui la lezione di don Milani resta di grande valore. Opere di Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana: Esperienze pastorali, L’obbedienza non e’ piu’ una virtu’, Lettera a una professoressa, pubblicate tutte presso la Libreria Editrice Fiorentina (Lef). Postume sono state pubblicate le raccolte di Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana, Mondadori; le Lettere alla mamma, Mondadori; e sempre delle lettere alla madre l’edizione critica, integrale e annotata, Alla mamma. Lettere 1943-1967, Marietti. Altri testi sono apparsi sparsamente in volumi di diversi autori. La casa editrice Stampa Alternativa ha meritoriamente effettuato nell’ultimo decennio la ripubblicazione di vari testi milaniani in edizioni ultraeconomiche e criticamente curate. La Emi ha recentemente pubblicato, a cura di Giorgio Pecorini, lettere, appunti e carte varie inedite di don Lorenzo Milani nel volume I care ancora. Altri testi ha pubblicato ancora la Lef. Opere su Lorenzo Milani: sono ormai numerose; fondamentali sono: Neera Fallaci, Vita del prete Lorenzo Milani. Dalla parte dell’ultimo, Rizzoli, Milano 1993; Giorgio Pecorini, Don Milani! Chi era costui?, Baldini & Castoldi, Milano 1996; Mario Lancisi (a cura di), Don Lorenzo Milani: dibattito aperto, Borla, Roma 1979; Ernesto Balducci, L’insegnamento di don Lorenzo Milani, Laterza, Roma-Bari 1995; Gianfranco Riccioni, La stampa e don Milani, Lef, Firenze 1974; Antonio Schina (a cura di), Don Milani, Centro di documentazione di Pistoia, 1993. Segnaliamo anche l’interessante fascicolo monografico di "Azione nonviolenta" del giugno 1997. Segnaliamo anche il fascicolo Don Lorenzo Milani, maestro di liberta’, supplemento a "Conquiste del lavoro", n. 50 del 1987. Tra i testi apparsi di recente: il testo su don Milani di Michele Ranchetti nel suo libro Gli ultimi preti, Edizioni cultura della pace, S. Domenico di Fiesole (Fi) 1997; David Maria Turoldo, Il mio amico don Milani, Servitium, Sotto il Monte (Bg) 1997; Liana Fiorani, Don Milani tra storia e attualita’, Lef, Firenze 1997, poi Centro don Milani, Firenze 1999; AA. VV., Rileggiamo don Lorenzo Milani a trenta anni dalla sua morte, Comune di Rubano 1998; Centro documentazione don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana, Progetto Lorenzo Milani: il maestro, Firenze 1998; Liana Fiorani, Dediche a don Milani, Qualevita, Torre dei Nolfi (Aq) 2001; Edoardo Martinelli, Pedagogia dell’aderenza, Polaris, Vicchio di Mugello (Fi) 2002; Marco Moraccini (a cura di), Scritti su Lorenzo Milani. Una antologia critica, Il Grandevetro - Jaca Book, Santa Croce sull’Arno (Pi) - Milano 2002.
Maria Montessori, nata nel 1870 e deceduta nel 1952, medico, illustre pedagogista, antifascista, abbandono’ l’Italia nel 1936.
Opere di Maria Montessori: segnaliamo almeno Il metodo della pedagogia scientifica (poi col titolo: La scoperta del bambino), 1909; L’autoeducazione nelle scuole elementari, 1916; il Manuale di pedagogia scientifica, 1930; Il segreto dell’infanzia, 1950; La mente del bambino, 1952; un’utile antologia (autorizzata dalla Montessori, e curata da M. L. Leccese) e’ Educazione alla liberta’, Laterza, Bari 1950; cfr. anche Educazione e pace, Garzanti, Milano 1970. Opere su Maria Montessori: segnaliamo almeno F. De Bartolomeis, Maria Montessori e la pedagogia scientifica, La Nuova Italia, Firenze 1953; A. Leonarduzzi, Maria Montessori. Il pensiero e l’opera, Paideia, Brescia 1967; A. Scocchera, Maria Montessori. Quasi un ritratto inedito, La Nuova Italia, Firenze 1990. Siti: www.montessori.edu , www.montessori.it . Un’ampia bibliografia di e su Maria Montessori e’ nel n. 899 de "La nonviolenza e’ in cammino"]
-
-
-