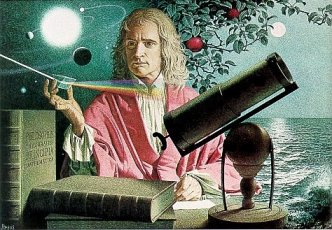
L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima" - di Federico La Sala
- VICO MUORE NEL 1744. Di lì a poco, Gaetano Filangieri nella sua opera La Scienza della Legislazione (1781-88) scrive: "Nella democrazia comanda il popolo, e ciaschedun cittadino rappresenta una parte della sovranità: nella concione [assemblea di tutto il popolo], egli vede una parte della corona, poggiata ugualmente sul suo capo che sopra quello del cittadino più distinto.
 L’oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annuncia la sua debolezza, egli non ha che a fare un passo fuori della soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità"(Libro III, cap. XXXVI).
L’oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annuncia la sua debolezza, egli non ha che a fare un passo fuori della soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità"(Libro III, cap. XXXVI).
- VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura (pdf, scaricabile).
QUI PROSEGUE IL DISCORSO GIA’ AVVIATO IN
- NOTA. Per le citazioni e i riferimenti di pagine, cfr.: Giambattista Vico, Opere filosofiche, introd. di Nicola Badaloni, a c. di Paolo Cristofolini, Firenze 1971
***
“THE VICO ROAD” (James Joyce). Il “De antiquissima italorum sapientia” (vale a dire: “L’antichissima sapienza degli italici da ritrovarsi dalle origini della lingua latina”), come si sa, doveva essere un’opera in tre libri, dedicati rispettivamente alla metafisica, alla fisica, e alla morale: ma Vico scrisse solo il “Libro Primo ossia Metafisico” (1710). Ora, se non ci si lascia ipnotizzare dal titolo, come per lo più è avvenuto e avviene ancora, e si legge l’opera con attenzione, qui, il discorso - al di là dell’occasione e dell’idea da cui il progetto ha preso il via - è un chiaro e forte intervento nel dibattito sul ”metodo geometrico” e il “metodo sperimentale” in fisica, e un grande contributo all’elaborazione di un orizzonte metafisico all’altezza della fisica di Galilei e Newton (non di Cartesio!).
UNA METAFISICA COMMISURATA ALLA DEBOLEZZA UMANA. Se si considera che il primo capitolo è intitolato: “il vero e il fatto”, è più che evidente come e quanto il discorso di Vico riprenda e sviluppi il nucleo del suo tema, già anticipato nella prolusione “De nostri temporis studiorum ratione” (1708)! Qui, egli - con grande lucidità e con una buona dose di ironia - così scrive: “Sostengono i dotti che questa fisica, insegnata col metodo geometrico, è la stessa natura, che scorgi ovunque ti volga a contemplare l’universo; ritengono perciò che siano da ringraziare gli autori che ci liberarono dal grande fastidio di studiare ancora la natura e ci lasciarono questi edifici così ampi e ben costruiti. Qualora necessariamente la natura si comportasse come essi l’hanno concepita, bisognerebbe ringraziarli; ma ove la sua costituzione fosse diversa e fosse falso anche una sola delle norme fissate da codesti studiosi circa il moto (per non dire che non soltanto una se n’è scoperta falsa) stiano attenti a non trattare con sicurezza la natura, sicché, mentre attendono a curare i tetti, trascurino con pericolo le fondamenta di quelle case (...) Perciò codeste cose - continua Vico - che in fisica si presentano per vere in forza del metodo geometrico, non sono che verosimili, e dalla geometria ricevono il metodo, non la dimostrazione: dimostriamo le cose geometriche, perché le facciamo; se potessimo dimostrare le cose fisiche, noi le faremmo. Nel solo Dio ottimo massimo sono vere le forme delle cose, perché su quelle è modellata la natura. Lavoriamo dunque alla fisica come filosofi, per ben educare l’animo nostro, superando in ciò gli antichi, che coltivavano questi studi per contendere empiamente in beatitudine con gli dei, mentre noi lo facciamo per abbassare il nostro orgoglio” (p. 802).
Nel “De antiquissima italorum sapientia”, infatti, ripete "che non si deve introdurre nella fisica il metodo geometrico, ma la diretta dimostrazione sperimentale", che solo "in questo modo la fisica può progredire", e che solo questo "procedimento seguono con diligenza gli inglesi, i quali vietano che nelle pubbliche scuole si insegni la fisica col metodo geometrico"(p. 124), e alla fine, nella “conclusione” sul “carattere” del lavoro svolto, all’Amico a cui ha dedicato l’opera, Vico così sintetizza: “Eccoti, o sapientissimo Paolo Doria, una metafisica commisurata alla debolezza del pensiero umano. Essa non concede all’uomo la possibilità di conoscere tutte le verità, né gli nega la facoltà di poterli conoscere; ma gli consente solo di apprenderne alcune. Metafisica adeguata - egli continua - alla concezione cristiana, la quale distingue il vero divino dall’umano e non prepone la scienza umana alla divina, ma pone la scienza divina come regola della umana. Regola che serve - precisa Vico - alla fisica sperimentale che ora è studiata con grande utilità del genere umano, poiché in funzione di essa riconosciamo per vero in natura solamente ciò che è possibile riprodurre con adeguati esperimenti” (p.130).
IL VERO E IL FATTO: UNA NORMA PER IL SAPERE. Da grande ‘archeologo’ - con uno ‘scavo’ acuto e profondo - Vico ha trovato la chiave per ripensare in modo radicalmente nuovo e unitario tutte le scienze, da quelle umane a quelle fisico-matematiche, e proporre un vasto programma di rinnovamento antropologico e teologico, politico e culturale: “il vero si identifica col fatto”; “il primo vero è in Dio, perché Dio è il primo facitore; codesto primo vero è infinito, in quanto facitore di tutte le cose; è compiutissimo, poiché rappresenta a Dio, in quanto li contiene, gli elementi estrinseci ed intrinseci delle cose. Sapere (scire) significa comporre gli elementi delle cose: quindi alla mente umana è proprio il pensiero (cogitatio), alla divina l’intelligenza (intelligentia)”.
"SOLO DIO E’ SAPIENTE". Sul filo di Socrate, al di là di Platone, egli ha trovato il principio che darà senso e orienterà tutta la ricerca della sua vita: “Date le suddette proposizioni degli antichi sapienti dell’Italia intorno al vero, e data la distinzione che la nostra religione pone tra il generato e il fatto, abbiamo questo principio: poiché soltanto in Dio il vero è completo, dobbiamo dichiarare assolutamente vero ciò che Dio ci ha rivelato; e non cercare il genere e il modo per cui è vero, perché ci è assolutamente impossibile comprenderlo. Muovendo di lì ci è possibile risalire all’origine delle scienze umane, e avere alla fine una norma per riconoscere quelle vere” (p.64).
CONOSCI TE STESSO. Quanto questa scoperta sia importante e decisiva per il cammino di Vico - a partire da se stesso, dal suo presente storico! - egli lo chiarisce immediatamente: “Per conciliare più agevolmente queste considerazioni con la nostra religione, si deve sapere che per gli antichi filosofi dell’Italia il vero e il fatto si convertivano, poiché pensavano che il mondo fosse eterno; inoltre i filosofi gentili venerarono un Dio che sempre avrebbe operato all’esterno cosa che la nostra teologia nega. Perciò nella nostra religione, per la quale professiamo che il mondo fu creato nel tempo dal nulla, occorre qui una distinzione: il vero creato si converte col fatto (factum) il vero increato col generato (genitum)”.
E, poco oltre, così continua: “Le Sacre Scritture, con eleganza veramente divina, chiamarono “Verbo”(Verbum) la sapienza di Dio, che contiene in sé le idee di tutte le cose e quindi gli elementi di tutte le idee. Nel Verbo infatti si identificano il vero e la comprensione di tutti gli elementi che compongono la totalità dell’universo; se volesse potrebbe costituire infiniti mondi; e giacché nella sua divina onnipotenza conosce tutto ciò, esiste un Verbo reale esattissimo, che essendo sin dall’eternità conosciuto dal Padre, dall’eternità è altresì generato da lui” (pp. 62-64).
- N.B.: "DEUS CHARITAS EST" (1 Gv.: 4.8). GIAMBATTISTA VICO "fa una netta distinzione tra carus - caritas ripettivamente col valore di ’caro, costoso, di alto prezzo’ e ’carestia, scarsità’ da una parte, e charus - charitas rispettivamente col valore di ’grazioso, amabile, richiesto’ e ’grazia, amore di Dio’ dall’altra, perché per il Vico questi due ultimi termini derivano etimologicamente" dai termini greci ’charìeis’ e ’chàris’ (cfr. G. Vico, Varia: Il ’De Mente Heroica’ e gli scritti latini minori, a cura di Gian Galeazzo Visconti, Alfredo Guida Editori, Napoli 1996, p. 31)
ILLUMINISMO CRITICO E CRISTIANO. Senza queste premesse e queste coordinate, Vico non è più Vico! Il suo programma è qui tracciato con grande chiarezza e, a ben guardare, si muove su una linea teologica ed epistemologica analoga a quella di Galilei e, con più determinazione, prossima a quella di Locke e di Newton (e poi di Kant), tutta tesa a determinare criticamente i poteri dell’uomo (che pretende di essere “come Dio”).
SCIENZA E SAGGEZZA. E’ abbastanza evidente che ciò a cui Vico pensa è qualcosa di molto vicino all’idea di “instauratio magna” di Francesco Bacone, a una riforma generale del sapere e a una nuova enciclopedia delle scienze. Ben ancorato al suo principio e al suo criterio, e alla concezione dell’uomo come “un animale partecipe della ragione, non padrone completa di essa”, Vico lo chiarisce con forza: “La scienza umana è nata dunque da un difetto della nostra mente, ossia dalla sua estrema limitatezza, per cui è fuori da tutte le cose, non contiene le cose che aspira a conoscere, e, poiché non le contiene, non traduce in effetto le cose vere che si sforza di raggiungere. Ma - egli continua - scienze certissime sono quelle che espiano il vizio d’origine, e per mezzo delle operazioni diventano simili alla scienza divina, in quanto vero e fatto si convertono” (p. 68).
PER BEN EDUCARE L’ANIMO NOSTRO. Per Vico, inoltre, il suo principio - “soltanto in Dio il vero è completo” - non fornisce solo regole per la guida del pensiero - “il criterio e la regola del vero consiste nell’averlo fatto” - ma anche regole per la guida della propria coscienza sulla via della buona volontà e della grazia evangelica: come dirà, a chiusura della “Scienza nuova” del 1730 e del 1744, “questa Scienza porta indivisibilmente seco lo studio della pietà (...) se non siesi pio, non si può daddovero esser saggio” (p.702).
“Per dirla in una parola, il vero - scrive Vico - si converte col buono quando ciò che è conosciuto come vero ricava il suo essere anche dalla mente che lo conosce. In questo caso la scienza umana è imitatrice della divina, per la quale Dio nel conoscere il vero lo genera all’interno dell’eternità, e nel tempo lo fa all’esterno. E il criterio della verità, riguardo a Dio, consiste nell’avere egli comunicato la bontà ai suoi pensieri (“Dio vide che le cose erano buone”), comparativamente, consiste nel nostro fare le cose che conosciamo come vere” (pp. 68-70).
Contro ogni illusione cartesiana e ‘superomistica’, Vico è massimamente lucido: “l’idea chiara e distinta della nostra mente, nonché di tutti gli altri veri, non può essere criterio nemmeno della mente: poiché la mente, quando si conosce, non si fa; e poiché non si fa, non conosce il genere o modo del suo conoscersi” (p. 68); e, poco oltre, accusa “di empia curiosità quelli che si sforzano di dimostrare a priori Dio ottimo massimo” e spiega che “ciò è tanto quanto fare se stessi Dio di Dio, ossia negare il Dio che cercano” (p. 82).
CARTESIO, IL GRANDE PENSATORE DELLA METAFISICA. Nel terzo paragrafo del primo capitolo del “De antiquissima sapientia”, intitolato “Il primo vero meditato da Renato Descartes”, Vico sgombra la sua strada da ogni equivoco e, con spirito ironico fortissimo (degno del miglior Galilei, contro “chi vuol por termine alli umani ingegni”), mette in luce quanto pericolosa sia per la ricerca e per la scienza la strada dei dommatici e degli scettici, gli uni che pretendono di conoscere tutto e gli altri che negano la stessa possibilità di conoscere.
I dogmatici del nostro tempo - scrive Vico - “dubitano di tutte le verità, esclusa la metafisica (...) dichiarano infatti che soltanto la metafisica ci dà un vero esente da dubbio” e ritengono “che la metafisica assegni a ciascuna delle altre scienze il suo proprio campo. Così il grande pensatore della metafisica - prosegue Vico - prescrive a chiunque voglia essere iniziato ai sacri misteri di questa di purificarsi non soltanto delle persuasioni (i cosiddetti pregiudizi) concepite sin dall’infanzia tramite il fallace insegnamento dei sensi, ma anche da tutte le verità apprese dalle altre scienze. E poiché non abbiamo il potere di dimenticare, bisogna secondo lui disporsi ad ascoltare i metafisici, con mente ridotta se non proprio a tavola rasa, per lo meno a guisa di libro arrotolato, che si dispieghi poi ad una luce migliore” (p. 70).
L’ERRORE DI CARTESIO. La critica di Vico alla metafisica cartesiana è radicale: la sua filosofia non porta fuori dallo scetticismo, è solo una finta soluzione e per di più porta l’uomo nelle braccia di un genio (maligno o benigno che sia, è lo stesso)! La metafisica di Renato Descartes - scrive Vico -“ci dischiude il “primo vero”. Ma qual è? “Che cosa esso sia, ce lo spiega - scrive Vico - quel sommo filosofo. L’uomo, egli dice, può dubitare se senta, se viva, se sia esteso, e infine, in senso assoluto, se sia; a sostegno della sua argomentazione escogita un certo genio ingannatore e maligno, in ciò imitando quello stoico che, negli Academica di Cicerone per provare la stessa cosa, ricorre ad un artificio, un sogno mandato miracolosamente dagli dei. Ma è assolutamente impossibile che uno non sia conscio di pensare, e che tale coscienza non concluda con certezza che egli è. Pertanto Renato svela che il primo vero è questo: “Penso: dunque sono” (Cogito: ergo sum)”.
Ma Vico non si ferma qui e, inesorabile, continua: “Veramente anche il Sosia di Plauto, condotto a dubitare della propria esistenza da Mercurio che ha assunto le sue sembianze (come Descartes è indotto in dubbio dal genio ingannatore, e lo stoico dal sogno miracoloso), a forza di meditarci su giunge ad acquietarsi in questo primo vero: (...) Sed quom cogito, equidem certo sum ac semper fui” (pp.70-72).
Un ‘ridicolo’ approdo. Messi a confronto, il dogmatico e lo scettico mostrano che la loro apparente differenza riposa sullo stesso fondamento: il cogito! Il dubbio metodico come il dubbio scettico non porta da nessuna parte - l’uno e l’altro, per quanti passi possano fare, non escono mai dal loro ‘mondo’: la certezza del pensare è coscienza, non scienza.
Per Vico, la coscienza è condizione necessaria, ma non sufficiente per conoscere. Conoscere il vero è la stessa cosa che farlo: “avere scienza significa possedere il genere, o forma, del farsi della cosa; invece l’avere coscienza si riferisce a quelle cose di cui non possiamo dimostrare il genere o forma” (p. 72).
L’uomo è, sì, Dio, ma - solo e solo “cum grano salis”: egli è e resta un animale partecipe della ragione, non padrone completa di essa. La conclusione è che il dogmatico e lo scettico condividono la stessa ignoranza: “non conoscono la genesi del pensiero” e non capiscono cosa significhi che “per la nostra religione l’animo umano è un qualcosa di puro da ogni corporeità” (p.72).
IL PROBLEMA MENTE-CORPO. Altro che campo di battaglia! La metafisica appare a Vico solo una boscaglia piena di “pruni” e “spini”: ignorando le cause del pensiero, ossia il modo in cui il pensiero si fa, i più sottili metafisici del nostro tempo - scrive Vico - si feriscono e si pungono a vicenda, quando “vanno in cerca del modo in cui si compie l’azione reciproca della mente sul corpo, e del corpo sulla mente (mentre solo i corpi possono vicendevolmente toccarsi”.
Stretti da siffatte difficoltà - continua Vico - “ricorrono, come ad un espediente artificiale, a un’occulta legge divina, per la quale i nervi eccitano la mente quando sono urtati da oggetti esterni, e la mente fa tendere i nervi, quando desidera compiere un’azione. Immaginano dunque che la mente umana sia ferma nella ghiandola pineale come un ragno al centro della sua tela; e quando, da una qualsiasi, un filo della tela viene mosso, il ragno lo sente; mentre quando, senza che la tela si sia mossa, il ragno sente l’arrivo del temporale, fa tremare tutti i fili della sua tela”.
Muovendosi in tale ignoranza, lo scettico si conferma “sempre più nella convinzione di non avere scienza del pensare” e il dogmatico insiste che “lo scettico acquista scienza dell’essere dalla coscienza del pensare”; ma lo scettico nega che “dalla coscienza del pensare si acquisti scienza dell’essere; egli sostiene infatti che la scienza è la conoscenza delle cause da cui nasce la cosa”.
Dal ‘dialogo’ con lo scettico e il dommatico o, che è lo stesso, con l’empirismo e il razionalismo, Vico - forte del suo principio che identifica il criterio del vero con l’effettuazione di esso, chiarisce la sua posizione e così scrive: “Ora, io che penso sono mente e corpo, e se il pensiero fosse la causa del mio essere, il pensiero sarebbe causa del corpo; ma ci sono corpi che non pensano. Anzi, io penso proprio perché sono composto di corpo e mente: la causa del pensiero sono corpo e mente uniti. Infatti, se fossi soltanto corpo, non penserei, e se fossi solo mente, intenderei. Di fatto, il pensiero non è la causa, ma un indizio del mio essere mente:” e l’indizio “non è causa” (pp.72-74).
VOI SIETE DEI: “SAPERE AUDE!” Già nel 1699, nella prima delle orazioni inaugurali (“L’argomento, preso globalmente ruota intorno a questo asse e cardine: la conoscenza di se stesso è per ognuno di grandissimo stimolo a completare in breve tempo l’intero complesso delle conoscenze”), in dichiarazioni apparentemente platoniche e neoplatoniche (“Dio è l’artefice della natura; l’animo è, se è lecito dirlo, il Dio delle arti”), Vico mostra con chiarezza come sia importante e cosa significhi coniugare correttamente - in un’ottica cristiana (non dogmatica, non platonico-cattolica o idealistica!) - lo “straordinario carattere dell’animo” con la “somiglianza con Dio Ottimo Massimo” (p.710). L’esito è una ricomprensione critica del passato e, al contempo, il lancio di un programma (come insisterà anche e ancora nell’orazione del 1732, “De mente heroica”) degno del “plus ultra” baconiano e del “sapere aude!” kantiano.
In un passaggio fondamentale, “per restringere in breve” tutto il suo discorso, ecco quanto dice: “tutti gli dei che l’antichità pose in cielo per aver apportato un qualche beneficio alla società umana, siete voi stessi. O mirabile conoscenza di se stesso, quanto in alto ci conduci ed elevi! Per tutti voi, o ascoltatori, il proprio animo è come un Dio per ciascuno: una facoltà divina è quella che vede, divina è quella che ode, quella che produce le immagini delle cose, che percepisce, che giudica, che conclude, che ricorda. Vedere, sentire, inventare, paragonare, inferire, ricordare sono attività divine. La sagacia, l’acume, la solerzia, la capacità, l’ingegno, la velocità sono doti mirabili, grandi e divine” (p.716).
E, alla fine, così chiude: “Tutto abbonda di esempi di stimoli a studiare le scienze; le cose tutte sono piene di esortazioni e voi avete un gran numero di dottissimi maestri, vi è concesso un luogo onorevolissimo per apprendere e siete nati per apprendere compiutamente, in breve e con facilità, ogni dottrina. Che cosa rimane dunque da aggiungere? La vostra buona volontà” (p. 718).
VICO MUORE NEL 1744. Di lì a poco, Gaetano Filangieri nella sua opera La Scienza della Legislazione (1781-88) scrive: "Nella democrazia comanda il popolo, e ciaschedun cittadino rappresenta una parte della sovranità: nella concione [assemblea di tutto il popolo], egli vede una parte della corona, poggiata ugualmente sul suo capo che sopra quello del cittadino più distinto.
 L’oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annuncia la sua debolezza, egli non ha che a fare un passo fuori della soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità"(Libro III, cap. XXXVI).
L’oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annuncia la sua debolezza, egli non ha che a fare un passo fuori della soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità"(Libro III, cap. XXXVI).
Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "Etica": "Quasi a tutti è in bocca il detto: per l’uomo l’uomo è Dio [homo homini Deus est]. Accade tuttavia raramente che gli esseri umani vivano sotto la guida della ragione" (Baruch Spinoza).
VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura (pdf, scaricabile).
FLS
Forum
-
> L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON -- CON SPINOZA (NON CON GLI "SPINOZISTI"). Note su "Le considerazioni di Schopenhauer sulla sua filosofi" (di saverio Mariani).a20 febbraio 2022, di Federico La Sala
COSMOTEANDRIA E SONNO DOGMATICO: SCHOPENHAUER E IL MACROANTROPO, IL CORPO MISTICO DEL MONDO.
- "IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE" DEL MACROANTROPO:
- "Alla chiusa della mia esposizione possono trovare il loro posto alcune considerazioni sulla mia filosofia stessa. [...] che l’interno essere di tutte le cose sia assolutamente uno e medesimo, lo aveva già visto e compreso il mio tempo, dopo che gli elatici, Scoto Eriugena, Giordano Bruno e Spinoza l’avevano estesamente insegnato e Schelling aveva rinfrescato questa dottrina. Ma che cosa sia quest’Uno e come esso giunga a rappresentarsi come Molto, è un problema, di cui la soluzione si trova per la prima volta presso di me. - Parimenti si era, fin dai tempi più antichi, riconosciuto l’uomo come microcosmo.
 Io ho rovesciato il principio e dimostrato il mondo come macroantropo, in quanto volontà e rappresentazione esauriscono l’essere dell’uno e dell’altro. Evidentemente però è più giusto, imparare a comprendere il mondo dall’uomo, che l’uomo dal mondo, perché si ha da spiegare ciò che è dato mediatamente ossia il dato dell’intuizione esterna, da quel che è dato immediatamente, ossia dal lato dell’autocoscienza, non viceversa.
Io ho rovesciato il principio e dimostrato il mondo come macroantropo, in quanto volontà e rappresentazione esauriscono l’essere dell’uno e dell’altro. Evidentemente però è più giusto, imparare a comprendere il mondo dall’uomo, che l’uomo dal mondo, perché si ha da spiegare ciò che è dato mediatamente ossia il dato dell’intuizione esterna, da quel che è dato immediatamente, ossia dal lato dell’autocoscienza, non viceversa. - ARTHUR SCHOPENHAUER, Supplementi al "Mondo", II, Editori Laterza, Bari 1986.
Storia della filosofia
Le considerazioni di Schopenhauer sulla sua filosofia
di Saverio Mariani (Ritiri Filosofici, 20 Febbraio 2022)
In quella che abbiamo definito (almeno in parte) un’opera a sé stante di Arthur Schopenhauer, il filosofo tedesco si pone nella posizione di commentare il suo contributo filosofico in relazione alla storia della filosofia nella quale sente di ricoprire un posto. Nei Supplementi a «Il Mondo come volontà e rappresentazione» infatti, Schopenhauer è franco, diretto, in alcuni passaggi appare “scocciato” da un certo ambiente filosofico. Ci sono ampi passi dell’opera nei quali entra in un dialogo nient’affatto morbido con la filosofia del suo tempo. -L’ultimo capitolo dei Supplementi, il cinquantesimo, è sintomatico essenzialmente di due cose: dell’enorme contrasto che Schopenhauer ha vissuto con l’ambiente filosofico tedesco e del rapporto ambivalente con Spinoza [1]. Entrambe queste cose, a ritroso potremmo dire, ci permettono di capire ancora meglio quanto nelle pagine precedenti l’autore ha trattato con dovizia e una acutezza importante. In queste poche pagine l’autore condensa alcune coordinate fondamentali per apprezzare lo sforzo immane che nel Mondo e poi nei Supplementi egli ha compiuto.
Filosofia immanente ed esperienza
In apertura del capitolo Schopenhauer dice esplicitamente che, prima di chiudere, c’è ancora qualche considerazione sulla sua filosofia che si può svolgere. Ancora una volta, per i motivi che abbiamo già indagato, egli rivendica l’aderenza «ai dati di fatto dell’esperienza esteriore e interiore» (Schopenhauer 2013, 817), quasi a rimarcare la solidità delle premesse di tutto il suo ragionamento. Ciò che è fuori dell’esperienza non è oggetto della filosofia: la filosofia per questo è immanente, ovvero si occupa di ciò che è all’interno della sfera dell’esperienza («nel senso kantiano del termine», scrive).
Tuttavia, persistono delle domande che non possono non essere prese in considerazione; domande che però evadono il campo dell’esperienza e quindi si pongono su un livello diverso rispetto alla filosofia immanente di cui Schopenhauer si fa promotore. Sono le stesse questioni che Kant riconosceva come oggetto della metafisica, alle quali quindi il Principio di ragione - che per l’autore è «l’espressione della forma più generale e costante del nostro intelletto» (Schopenhauer 2013, 818) - non può rispondere. È il tentativo di applicare il Pdr a elementi esterni all’esperienza che ci porta a sbattere contro problemi senza soluzione, «contro le pareti del nostro carcere». L’imperscrutabilità di queste domande, si badi bene, è assoluta, non relativa: in nessun luogo e in nessun tempo si potrà dare, per mezzo dell’intelletto umano, una risposta a tali questioni. Questa zona insondabile non rientra nella forma della conoscenza, e per dare conto di ciò Schopenhauer si affida alle parole di Scoto Eriugena nel De divisione naturae: «Della meravigliosa divina ignoranza, per la quale Dio non capisce che cosa Egli stesso sia» (Schopenhauer 2013, 819).
Quello che sfugge è dunque l’essenza delle cose, una essenza che non è «conoscente, non è intelletto, bensì un’essenza priva di conoscenza», di essa se ne può avere una comprensione parziale, non «esauriente e capace di soddisfare ogni esigenza». Ma questo, conclude Schopenhauer, «concerne i limiti della mia e di ogni filosofia» (Schopenhauer 2013, 819-820).
L’unità
Fatte tutte queste premesse, Schopenhauer compie un passo in avanti. Scrive infatti che l’unità e unicità dell’essenza delle cose è qualcosa di già concepito da tempo: «gli Eleati, Scoto Eriugena, Giordano Bruno e Spinoza lo avevano ampiamente insegnato e Schelling aveva rinfrescato questa dottrina» (Schopenhauer 2013, 820). Il che cosa sia questa unità (Uno) e come si manifesti nella molteplicità (ovvero come si compia il processo di rarefazione da Uno a Molti), sono questioni «la cui soluzione si trova per la prima volta nella mia filosofia».
 La svolta si ha grazie a un rovesciamento del punto di vista e al contempo del principio su cui si incardina la comprensione del mondo: non è l’uomo ad essere un microcosmo, piuttosto è il mondo ad essere un «macroantropo». Il mondo si comprende a partire dall’uomo, da ciò che è immediato (l’autocoscienza), per poi passare a quel che è mediato, ovvero all’intuizione esterna.
La svolta si ha grazie a un rovesciamento del punto di vista e al contempo del principio su cui si incardina la comprensione del mondo: non è l’uomo ad essere un microcosmo, piuttosto è il mondo ad essere un «macroantropo». Il mondo si comprende a partire dall’uomo, da ciò che è immediato (l’autocoscienza), per poi passare a quel che è mediato, ovvero all’intuizione esterna.Il metodo analitico che Schopenhauer rivendica - installato nel quadro ineluttabile dell’esperienza - apre una nuova visuale filosofica nella quale i dati immediati della coscienza, come li chiamerà Bergson qualche anno dopo, ci mostrano la rete di rapporti e il tessuto che ci tiene connessi l’uno all’altro: la volontà.
Se questa posizione può sembrare affine a quella della filosofia panteista, Schopenhauer prende subito le distanza mostrando come esistano sì dei punti di contatto ma anche dei decisivi punti di distanza. Innanzitutto il metodo di conoscenza, ma anche la ricomprensione del male e delle storture del mondo nella “perfezione” di Dio o della Natura. Inoltre, scrive Schopenhauer «per i panteisti il mondo dell’intuizione, ossia il mondo come rappresentazione, è appunto una manifestazione intenzionale del Dio che abita in esso, ma questo non include alcuna spiegazione autentica del suo prodursi» (Schopenhauer 2013, 821-822).
Spinoza
Le riflessioni generali sui panteisti non sono che i prodromi del confronto che Schopenhauer sente di dover avere con Spinoza, e con il quale chiuderà la sua opera.
Dopo la critica kantiana, sostiene Schopenhauer, «i filosofanti tedeschi si sono nuovamente gettati quasi tutti su Spinoza», costruendo di fatto una filosofia post-kantiana che «altro non è che spinozismo agghindato senza gusto, avviluppato in discorsi incomprensibili d’ogni sorta e in vario modo deformato» (Schopenhauer 2013, 822). Il giudizio è sferzante, netto, inequivocabile e pienamente nello stile schopenhaueriano.
Il rapporto che c’è fra Spinoza e Schopenhauer, dice quest’ultimo, è quello che intercorre fra il Vecchio e il Nuovo Testamento: per entrambi «il mondo esiste per sua forza interiore e da se stesso». Ma se Spinoza si è limitato a spersonalizzare Jehova, il Dio-Creatore del Vecchio Testamento, la Volontà schopenhaueriana - «intima essenza del mondo» - è Gesù crocefisso, o il ladrone crocefisso al suo fianco. In Spinoza, infatti secondo Schopenhauer, il Deus è una perfezione di cui rallegrarsi, un’unità dalla quale nulla fuoriesce e tutto è divino. «Quello di Spinoza è ottimismo» (Schopenhauer 2013, 823); ottimismo a cui Schopenhauer guarda con sospetto, poiché tanto il neo-spinozismo, quanto ogni altra dottrina che riconduce l’esistenza del mondo a una qualche necessità assoluta, tanto le dottrine di chi crede che il mondo sia il frutto della creazione benevola di un Dio, ci pongono nell’alveo del fatalismo.
Schopenhauer sostiene di essere il primo ad aver liberato la filosofia da questo vincolo, perché «l’atto di volontà dal quale scaturisce il mondo è il nostro. È un atto libero, giacché il principio di ragione, dal quale solamente ogni necessità riceve il proprio significato, è la mera forma della sua manifestazione fenomenica» (Schopenhauer 2013, 824). E per questo nel momento in cui essa esiste si dipana secondo necessità. Il piano della rappresentazione, dunque, governato dal Principio di ragione ci mostra come necessario qualcosa che è invece, naturalmente, libero. La nostra libertà - conclude Schopenhauer - sta nell’arretrare alle spalle della rappresentazione, immergersi nella «costituzione di quell’atto di volontà e conseguentemente eventualiter volere altrimenti». In altre parole, risiede in quello “spazio” pre-umano che pone le condizioni del nostro mondo come rappresentazione.
Su quest’ultimo punto, per quanto Schopenhauer scriva, Spinoza risuona forte insieme a una piccola schiera di filosofi per cui la molteplicità è il mondo e la porta di accesso alla sfera comune entro la quale tutti ci ritroviamo a bagno sentendoci finalmente liberi.
Note:
[1] Su un altro rapporto ambivalente nei confronti di Spinoza ho provato a dare conto in: Bergson duplice. Spinoza nemico-amico della filosofia della durata, in Lo sguardo n. 26-2018 (I): http://www.losguardo.net/it/bergson-duplice-spinoza-nemico-amico-della-filosofia-della-durata/
Bibliografia:
Schopenhauer 2013: A. Schopenhauer, Supplementi a «Il mondo come volontà e rappresentazione», trad. Giorgio Brianese, Einaudi, 2013
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
SPINOZA, UN "FIGLIO" DEL "DEUS", NON UN "FIGLIO" DEL "LUPUS" (A FIANCO DI KANT, NON DI HEGEL).
Federico La Sala
-
> L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. --- SPINOZA, UN FIGLIO DEL "DEUS", NON UN FIGLIO DEL "LUPUS" (A FIANCO DI KANT, NON DI HEGEL).17 gennaio 2022, di Federico La Sala
Questioni teoretiche
Cantiere Spinoza
di Maurizio Morini (Ritiri Filosofici, 16 Gennaio 2022)
Così come per qualsiasi altra occupazione, anche in filosofia sono necessari strumenti adeguati per fare bene il proprio lavoro, tali soprattutto da superare le difficoltà che presto o tardi sempre si dovranno affrontare. In questo senso uno dei suoi strumenti principali è il concetto di definizione, stabilire il quale non è neutrale ed implica delle conseguenze decisive. Chi delle definizioni ha fatto l’essenza del proprio filosofare è stato Spinoza il quale ha costruito l’intero suo edificio proprio grazie al metodo geometrico. Molti però, tra gli stessi filosofi, ne hanno dichiarato l’inutilità o addirittura l’artificiosità. Adorno nelle sue lezioni confessava che, di fronte alle definizioni del filosofo olandese, si trovava «del tutto disorientato, come la mucca di fronte alla porta nuova». Il filosofo della Dialettica dell’Illuminismo finiva poi per dichiarare che in filosofia ci sono dei concetti che non sono passibili di definizione con la conseguenza che la sua ricerca era inutile. Adorno si rifaceva esplicitamente a Kant il quale aveva sostenuto a sua volta una ben precisa critica della definizione così come utilizzata in filosofia. Solo al termine delle sue lezioni, guardando ai risultati della filosofia contemporanea, Adorno (in maniera onesta) sembra spezzare una lancia a favore della definizione e addirittura ritirare la propria tesi.
La definizione in Aristotele e in Kant
Da un punto di vista etimologico, la parola definizione è composta dalla preposizione de e dal nome finis: discorso sul limite. La definizione quindi indica i confini entro i quali è racchiusa l’essenza o il concetto di qualche cosa. Essa pertanto deve cogliere gli aspetti comuni o differenziali di una certa cosa: in altre parole, la definizione si intende secondo il genere e la differenza specifica. Questa impostazione risale ad Aristotele il quale affermava che c’è definizione solo quando il termine significa qualcosa di primario, ovvero quando si parla di cose che non possono essere predicate di altre. Il genere è il primo elemento della definizione (dove per genere si intende il complesso di caratteri di un certo tipo riuniti sotto un certo nome); la differenza specifica invece, ciò invece che caratterizza la cosa che si intende definire rispetto a tutte le altre.
Kant, nella Dottrina trascendentale del metodo, assume un’altra prospettiva, per comprendere la quale è necessario distinguere due usi della ragione: il primo riguarda l’uso della ragione in base a concetti; il secondo l’uso della ragione in base alla costruzione di concetti. Al primo uso viene dato il nome di filosofia; al secondo il nome di matematica. In quest’ultima i concetti sono già determinati a priori dall’intuizione pura, senza che via sia necessario alcun dato empirico; la filosofia invece non può prescindere dall’esperienza in quanto essa sta a fondamento dei concetti. Posto ciò, Kant conclude che la fondatezza della matematica poggia su definizioni, assiomi e dimostrazioni, nei confronti dei quali la filosofia deve fare a meno («come il geometra, usando il suo metodo nella filosofia, non può costruire che castelli in aria, così il filosofo, applicando il proprio nella matematica, non dia luogo che a chiacchiere»). Kant sostiene che in filosofia la definizione non può essere utilizzata proprio perché i concetti empirici, più che essere definiti, andrebbero resi espliciti, chiariti, dichiarati (tutti termini che in tedesco fanno riferimento al termine Aufkärung). Sono fuori strada quindi tutti coloro che utilizzano termini come sostanza, causa, diritto: in altre parole una vera e propria stroncatura della filosofia di Spinoza.
La definizione in Spinoza
Cosa diceva Spinoza in merito? «Se si deve conoscere una cosa attraverso la definizione costituita da genere e differenza - scrive nel Breve Trattato - non possiamo mai perfettamente conoscere il genere supremo, che non ha alcun genere sopra di sé» (KV, I, 9). Piuttosto, bisogna seguire la vera logica, ovvero la divisione della natura in natura naturans e natura naturata.
Ma è in una corrispondenza epistolare, quella intrattenuta con un giovane mercante di Amsterdam, Simone De Vries, che Spinoza chiarisce meglio il suo pensiero. Chiesto su che cosa dovesse intendersi per definizione, egli rispondeva che bisogna distinguere la definizione della cosa in senso reale, in quanto fuori dall’intelletto, e la definizione della cosa in quanto è concepita in senso nominale. Alla prima si chiede di essere vera in quanto ha un oggetto determinato; la seconda si propone invece al solo scopo di ricerca. In altre parole: il primo genere di definizione deve essere necessariamente vero in quanto, se io ad esempio voglio definire l’essenza del tempio di Salomone, devo stabilire una descrizione esatta della cosa (altrimenti si ha una cattiva definizione). Il secondo tipo di definizione implica invece che si esplichi la sua progettualità, non importa che essa sia vera o no: in questo caso la definizione o si concepisce oppure non si concepisce. Chiariamo con un esempio: un conto che io debba definire l’orologio a parete che ho di fronte a me; un’altra è che io debba definire un orologio a parete che devo ancora costruire, in cui ciò che importa è che la sua costruzione non sia autocontraddittoria, tale cioè da renderlo inservibile allo scopo.
Il problema, insiste Spinoza, consiste nel fatto che la definizione tradizionale (quella aristotelica, che distingue genere e differenza specifica) riposa essenzialmente sull’esperienza, la quale però «non ci dà alcuna essenza delle cose», sicché noi dell’esperienza non abbiamo mai bisogno per la definizione. Infatti - si potrebbe dire - come si potrebbe definire una cosa soggetta al continuo divenire? Lo potremmo fare solo fingendo, per esigenze legate a questioni pratiche, come quello di intendersi su ciò di cui si sta discutendo. La prospettiva dunque sembra avvicinarsi a quella kantiana per poi però allontanarsi in modo radicale: se il tedesco sosteneva che l’esperienza è l’unico campo della filosofia (e per questo rinunciava alla definizione), l’olandese sosteneva che, proprio perchè l’esperienza non era l’unico campo della filosofia, la definizione era essenziale.
Un sistema aperto non una cattedrale di ghiaccio
Se il dialogo tra Spinoza e il suo giovane amico non può essere considerato un dialogo tra sordi, non si può non riconoscere però che i due parlano linguaggi diversi. Da esso si ricavano alcune impressioni (vedi le lettere 8, 9 e 10 dell’epistolario), soprattutto in merito all’oggetto della loro discussione, cioè le proposizioni dell’Etica.
La prima è che l’intero dialogo sulla definizione (tema piuttosto acceso nel circolo spinoziano, come ammette De Vries) è fondato sull’intelletto come strumento per accedere alla verità: cosa che oggi è talmente lontana dalla nostra sensibilità filosofica che facciamo difficoltà a seguirlo e a comprenderlo pienamente.
La seconda impressione è che, contro la retorica del “cristallo” e della “cattedrale di ghiaccio”, il sistema di Spinoza (riassunto nell’Etica) si rivela essere un cantiere aperto in cui, oltre alla scelta dei materiali, rimane determinante la capacità di costruire dei costruttori.
Questo conduce ad una terza domanda (da cui nasce l’impressione): le definizioni dell’Etica sono definizioni reali oppure definizioni nominali? Qui l’impressione è che Spinoza mescoli le carte, alternando le une alle altre senza un indice preordinato e dove la risposta sembra lasciata all’intelligenza del lettore, il quale è invitato a prendere parte alla costruzione. Diceva Wolfson che «l’Etica non è una comunicazione al mondo; è la comunicazione di Spinoza con se stesso». Questo non significa che le sue definizioni siano lasciate al relativismo delle interpretazioni o peggio al solipsismo. Tutt’altro: ciò significa che ogni definizione impegna il lettore nella forza del ragionamento, perché solo questo può mostrare la verità o la falsità di un asserto. Nel Trattato sull’emendazione dell’intelletto Spinoza scrive: «ho dimostrato e ancora tendo a dimostrare il buon ragionamento, ragionando bene».
NOTA: SPINOZA, UN FIGLIO DEL "DEUS", NON UN FIGLIO DEL "LUPUS" (A FIANCO DI KANT, NON DI HEGEL).
CANTIERE SPINOZA. ETICA, MATEMATICA, E CRITICA DELLA DIALETTICA...
Se è vero, come è vero, che l’Etica di Spinoza è “un sistema aperto non una cattedrale di ghiaccio” e che è necessario sciogliere l’enigma se “le definizioni dell’Etica sono definizioni reali oppure definizioni nominali” (M. Morini, "Cantiere Spinoza", Ritiri Filosofici, 16.01.2022), non si può ricadere nella stesso passo falso dell’analisi del “Discorso del Re” (M. Morini), e portare l’acqua al mulino non di “Amleto” (Shakespeare), ma a quello di Hobbes!
Una interpretazioni riduttiva della “Critica della Ragion pura” e della concezione kantiana della “definizione”, dalla sez. della “Dottrina trascendentale del metodo”, riconduce direttamente e di nuovo il discorso sotto il “principio di Hobbes” (e nell’orizzonte di Hegel e di T. W. Adorno), nell’orizzonte del “Leviatano” (e, al contempo, della dialettica di Hegel e della “dialettica dell’illuminismo” di Adorno), “secondo cui le azioni del sovrano non possono mai essere accusate di ingiustizia dai sudditi e il sovrano non può né essere messo a morte né essere punito dai suoi sudditi” (M. Morini, “ [1]”, Ritiri Filosofici, 02.01.2022).
“HOMO HOMINI LUPUS EST”?! Pur condividendo l’impressione “che Spinoza mescoli le carte, alternando le une alle altre senza un indice preordinato e dove la risposta sembra lasciata all’intelligenza del lettore, il quale è invitato a prendere parte alla costruzione” (M. Morini, cit.), è assolutamente non condisibile una conclusione dell’analisi accogliendo la dichiarazione del “Figlio del Lupo” (“Wolf-son”) e dire davvero con Wolfson che «l’Etica non è una comunicazione al mondo; è la comunicazione di Spinoza con se stesso»! E’ posssibile asservire la “filosofia” (nel senso di Kant) di Spinoza al calcolo e alla matematica di Platone, di Cartesio, di Hobbes, ed Hegel, e dire che questo “significa che ogni definizione impegna il lettore nella forza del ragionamento, perché solo questo può mostrare la verità o la falsità di un asserto” (M. Morini, cit.)?!
Non è il caso di riprendere il discorso dalla figura del “capo”, dal “discorso del re”, e rimeditare la “filosofia” e la “matematica” di Kant?! Se no, come è possibile distinguere tra “essere e non essere”, definire, ragionare e, al contempo, decidere sul “che fare?”, qui ed ora?! Non è meglio uscire dall’inferno della “fenomenologia dello spirito” di Hegel e, con Dante e Virgilio, uscire dalla caverna (Inf. XXXIV, v. 90) e ammirare il “cielo stellato” di Koenigsberg?
-
> L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. ---- Il senso dell’italica sapienza (di Michele Ciliberto)31 dicembre 2020, di Federico La Sala
Filosofia
Il senso dell’italica sapienza
Giambattista Vico. Ristampata un’opera molto complessa, nella quale il filosofo elabora definitivamente due concetti centrali nel suo pensiero: quello di forza e quello di azione
di Michele Ciliberto (Il Sole-24 Ore, 28.12.2020)
- De antiquissima Italorum sapientia con le Risposte al «Giornale de’ letterati d’Italia» Giambattista Vico Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, pagg. LVI-216, e. 38.
Sono molti, negli ultimi decenni, gli studi e le ricerche sulla figura e sull’opera di Giambattista Vico grazie, in primo luogo, al Lessico Intellettuale Europeo, specialmente nel periodo in cui fu diretto da Tullio Gregory, e al Centro di studi vichiani. È stata ora pubblicata una delle opere più complesse di Vico, il De antiquissima Italorum sapientia, ad opera di Vincenzo Placella, che aggiunge, opportunamente, al testo vichiano la trascrizione critica degli articoli del «Giornale de’ letterati d’Italia» in cui le posizioni del filosofo erano state contestate e le risposte con le quali il «Signor Giambattista Vico» replica alle «oppositioni» fatte «contra il primo libro De antiquissima italorum sapientia» con due specifiche «risposte», entrambe assai importanti.
Il De antiquissima esce nel 1710. Esso, come è noto, avrebbe dovuto essere costituito da tre parti: una sulla metafisica, una sulla fisica, una sulla morale. Uscì soltanto il primo libro, il Liber metaphysicus, che ha avuto notevole fortuna nella critica vichiana - da Croce a Nicolini, da Pagliaro a Badaloni, da Paolo Rossi a Battistini (per limitarsi ai «classici»).
Antica filosofia italica
È interessante a rileggerla, ancora oggi, la tesi di Badaloni secondo cui, nel De antiquissima, il richiamo all’antica filosofia italica ha «carattere di finzione»: si tratterebbe «di una specie di gergo, entro cui la cultura napoletana capiva perfettamente le allusioni ed i colpi polemici, che in Vico del resto, sono del tutto scoperti». Dal punto di vista filosofico l’importanza del De antiquissima non sarebbe dunque nel richiamo all’antica filosofia italica, ma nella definitiva elaborazione di due concetti diventati centrali per Vico: il concetto di forza che traduce in termini fisici il concetto di spiritus; il concetto di azione, «quale risposta umana al richiamo che la forza in quanto conatus esercita sull’uomo».
Paolo Rossi ha utilizzato il De antiquissima, le due Risposte e l’Autobiografia per delineare «il ritratto di uno zenonista da giovane», sottolineando, con grande originalità, come Vico abbia avuto «una qualche conoscenza dello Zenonismo storico», delle cui posizioni dà anche conto, ma usandole in modo vario e libero nell’ambito della sua riflessione.
Sia Badaloni che Rossi sono stati tra i più insigni studiosi di Vico nella seconda metà del Novecento, e perciò si sono citati: per sottolineare l’incidenza e l’importanza del De antiquissima nella critica degli ultimi decenni. In effetti si tratta di un testo straordinario per la ricchezza di motivi che esibisce: la concezione di un’antica sapienza italica; la critica, fondamentale, del cogito e dei limiti di Cartesio, congiunta - come sostiene con buone ragioni Biagio de Giovanni - a un’altra visione del «moderno» rispetto a quella incentrata sul primato della «ragione scientifica»; il motivo del verum-factum; la distinzione tra intelligentia divina e cogitatio umana; le certezze della matematica e della geometria; il conatus; lo sperimentalismo...
Il libro è dedicato - ed è un altro elemento da rimarcare - a Paolo Mattia Doria, di cui è rivendicata l’originalità del pensiero politico: egli ha formato «il Principe immune da ogni cattiva arte di regno con cui C. Tacito e Nicolò Machiavelli istruirono il loro».
Platone nel Cratilo
Il metodo che Vico segue, distanziandosi dai grammatici, è quello di Platone nel Cratilo: «ricavare l’antichissima sapienza degli Italiani dalle origini della lingua latina». Infatti è con questo metodo che Platone «si sforzò di attingere la primitiva sapienza dei Greci».
Centrale, come si è detto - e vale la pena di ribadirlo, perché è un principio destinato a grandi sviluppi - è nel De antiquissima la riflessione sul principio del verum-factum, i quali in latino «sono in rapporto di reciprocità, o, come si suol dire nelle Scuole, “sono convertibili”». In altre parole: «il criterio e la regola del vero è proprio l’averlo fatto», ed è a questa luce che si può stabilire la distinzione tra uomo e Dio. Vico lo fa con una similitudine: «il vero divino è un’immagine solida delle cose, quasi un’opera d’arte plastica, mentre il vero umano è un pallido abbozzo, ovvero una immagine piana, come una sagoma. E al modo in cui il vero divino è quello che dio nel mentre conosce ordina e produce, così il vero umano, secondo gli antichi filosofi d’Italia, è qualcosa che l’uomo, nel mentre la conosce, compone e fa».
Rendendosi conto della limitatezza della sua mente, l’uomo si è forgiato, tramite l’astrazione, due elementi: il punto e l’uno. «E in questo modo s’è costruito un mondo di forme e di numeri tale da poterlo abbracciare per intero all’interno di se stesso; e prolungando o accorciando o mettendo insieme linee, addizionando, sottraendo o comunque calcolando numeri, compie infinite opere, in quanto conosce, all’interno di se stesso, infiniti veri».
Nella matematica dunque il vero si identifica col fare, e l’uomo - concentrandosi sul «dentro» - è capace di raggiungere il vero. I «veri umani» vanno commisurati sulla «norma del vero divino»: essi «sono quelli di cui noi stessi ci formiamo gli elementi, possiamo contenerli dentro di noi e portarli all’infinito tramite i postulati e, nel mettere insieme tali elementi, siamo in grado di fare i veri che conosciamo tramite quel mettere insieme e, in forza di tutto ciò, di possedere il genere, ovverosia la forma secondo cui facciamo».
Come scrisse Badaloni, la differenza del De antiquissima con il De ratione sta in questo: lì il verum-factum era un principio limitativo, qui è «l’umano criterio di verità».
Nell’Autobiografia Vico descrive in due belle pagine il lavoro fatto nel De antiquissima e lo svolgimento ulteriore del suo pensiero: «il Vico, con la lezione del più ingegnoso e dotto che vero trattato di Bacone da Verulamio De sapientia veterum, si destò a ricercarne più in là i principi che nelle favole de’ poeti, muovendolo a far ciò lauttorità di Platone, ch’era andato nel Cratilo ad investigargli dentro le origini della lingua greca», cominciandogli a dispiacere - dice, riferendosi a se stesso - «le etimologie de’ grammatici»; ma quel «dispiacimento» - così continua poco dopo - «era un indizio di ciò onde poi, nell’opere ultime, ritruovò le origini delle lingue tratte [...] da un principio di natura comune a tutte, sopra il quale stabilisce i principi di un’etimologico universale da dar l’origini a tutte le lingue morte e viventi».
Il De antiquissima è dunque citato e, al tempo stesso, «superato». Sono pochi gli autori che hanno saputo periodizzare con la stessa lucidità lo svolgimento del proprio pensiero.
-
> L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. -- Il carteggio trentennale tra René Descartes, Isaac Beeckman, Marin Mersenne, Lettere 1619-1648.9 maggio 2016, di Federico La Sala
L’occhio di un bue, l’esistenza di Dio, il salto di una palla: le lettere di Descartes
Lettere 1619-1648 tra René Descartes, Isaac Beeckman, Marin Mersenne, da Bompiani. Tre intellettuali molto diversi per estrazione sociale, fede, interessi teoretici, si scambiano idee che saranno fondative della scienza moderna
di Alberto Gaiani (il manifesto, Alias, 08.05.2016)
Nell’Europa della prima metà del Seicento la riforma protestante e la controriforma cattolica si erano ormai radicate e istituzionalizzate, la Francia si avviava a essere il laboratorio dell’assolutismo di Luigi XIV, l’Inghilterra era divisa tra i tentativi autoritari degli Stuart e le rivendicazioni di un parlamentarismo nascente, in cui la componente religiosa puritana giocava un ruolo cruciale, la grande monarchia spagnola imboccava una decadenza irreversibile, e le piccole Province Unite calviniste, da poco indipendenti, stavano per diventare un colosso dei commerci marittimi.
La Guerra dei Trent’anni, ultima grande guerra di religione europea, imperversava dal 1618 e si sarebbe conclusa nel 1648. Le carestie e le pestilenze investivano ciclicamente le popolazioni. In questa lunga fase di crisi, trasformazioni, riassestamenti e novità, nacque una piccola repubblica delle lettere che discuteva di scienza. Raccogliendo i frutti delle ricerche cinquecentesche - due per tutte: il De revolutionibus orbium coelestium di Copernico e il De humani corporis fabrica di Vesalio, entrambi pubblicati nel 1543, e all’origine rispettivamente dell’astronomia e dell’anatomia moderne - da diverse regioni europee dialogavano e fra loro discutevano Keplero, Galilei, Descartes, Harvey, Torricelli, Fermat, e altri forse meno celebri.
Il carteggio trentennale tra René Descartes, Isaac Beeckman, Marin Mersenne, Lettere 1619-1648 (Bompiani, a cura di Giulia Belgioioso e Jean-Robert Armogathe, con testi latini e francesi a fronte, pp. 1674, euro 55,00) costituisce un documento prezioso per osservare tre intellettuali molto diversi tra loro - per estrazione sociale, fede religiosa, interessi teoretici, ruoli istituzionali - scambiarsi le loro idee, mentre in Europa si affermava quel grande sovvertimento del modo di pensare e di conoscere che avrebbe poi costituito la scienza moderna.
Protagonista indiscusso del carteggio è Descartes: sua è la maggioranza schiacciante delle lettere comprese in questa raccolta, centoquarantacinque (centotrentasette a Mersenne, otto a Beeckman), contro le sei di Mersenne (cinque a Descartes, una a Beeckman) e le sette di Beeckman (sei a Mersenne, una a Descartes). Questo scarto si spiega per un verso con l’abitudine di Descartes a tenere tutte le minute delle proprie missive, per altro verso con le travagliate vicende di conservazione e di trasmissione di testi naturalmente esposti al rischio di perdita o di corruzione, ciò che evidenzia l’importanza della storia materiale dei testi, in questo caso di difficoltosa ricostruzione, date le condizioni in cui i tre autori si trovavano a scambiarsi questioni e soluzioni di problemi, e punteggiata da smarrimenti, ritardi, indirizzi sbagliati e corrieri distratti di cui si trova traccia nelle stesse lettere dei tre («le vostre ultime sono rimaste ferme per qualche tempo ad Amsterdam - scrive Descartes a Marsenne - in attesa di colui al quale le avevate indirizzate»; «mi stupisce molto che le tre lettere che mi dite d’avermi fatto l’onore di scrivermi siano andate perdute»; «la perdita delle lettere che vi avevo scritto verso la fine del mese di novembre»).
Il promotore di tutti gli scambi tra i tre interlocutori è Marin Mersenne, il meno brillante dei tre dal punto di vista scientifico ma di certo il più assiduo nell’interpellare, sollecitare, mettere in contatto, porre domande, inviare libri e manoscritti. Monaco dell’ordine di san Francesco di Paola, eclettico per inclinazione e per vocazione, sognava un’accademia europea delle lettere e delle scienze che viaggiasse per corrispondenza. Da Parigi, dove risiedeva, manteneva i contatti con intellettuali sparsi ai quattro angoli del continente, spesso facendo da tramite in prima persona, come si apprende per esempio dalla corrispondenza tra Descartes e Hobbes all’inizio degli anni quaranta, anch’essa riportata nel volume.
Quanto a Isaac Beeckman, era un uomo di scienza delle Province Unite riformate: calvinista, studioso di teologia, di medicina, di fisica, di musicologia, ricopriva ruoli di rilievo nelle università olandesi e da molti suoi contemporanei venne considerato un filosofo di tutto rispetto, nonostante non abbia lasciato dietro di sé tracce rilevanti. René Descartes si presentava invece come un gentilhomme français, discendente della piccola nobiltà di toga che ad un certo punto scelse di lasciare la Francia e ritirarsi, lui cattolico, nell’Olanda calvinista che gli avrebbe garantito quiete, libertà e distanza da tutto ciò che lo distoglieva dalle attività a cui voleva consacrare la propria esistenza: lo studio, la ricerca, la scoperta, la filosofia, la scienza.
Nei trent’anni coperti dall’epistolario i temi che ritornano sono spesso trattati in maniera frammentaria o discontinua: vi si trovano questioni di algebra, di geometria analitica, di ottica, di meccanica, di astronomia, di fisiologia, di musicologia; l’Index rerum che i curatori redigono costituisce una guida importante per chi voglia seguire gli sviluppi dei diversi problemi che i tre autori trattano. Ma quel che è fondamentale, intanto, è capire come Descartes, Beeckman e Mersenne in buona parte, anche se non del tutto, affrontino problemi scientifici a partire dall’ordinario: si arrovellano e discutono di campane, candele, liquidi nei bicchieri, corde, fionde, specchi, rane, balestre, flauti, canne d’organo, lenti, pietre, leve, tubi.
Le esperienze che si scambiano sono semplici, comuni alla vita quotidiana, ma a partire da queste affrontano problemi come la determinazione della forza di gravità, della natura della luce, della massa, della velocità e dell’accelerazione. Si occupano di magnetismo, della propagazione dei suoni e della loro percezione, dell’armonia musicale e della sua traducibilità in termini matematici, della circolazione sanguigna.
 La scienza moderna nasceva dunque fuori dai laboratori, da esperimenti che potremmo riprodurre nelle nostre cucine, ma a compierli erano osservatori portentosi, uomini curiosi che si sentivano investiti del compito di comprendere perché le cose stessero come stavano, e a una straordinaria capacità di osservazione e di problematizzazione dell’ordinario coniugavano la descrizione, nella forma più semplice e più diretta possibile, degli elementi fondamentali dei fenomeni esaminati. Il linguaggio matematico diventava la lingua universale del sapere finalizzato a cogliere il funzionamento della natura.
La scienza moderna nasceva dunque fuori dai laboratori, da esperimenti che potremmo riprodurre nelle nostre cucine, ma a compierli erano osservatori portentosi, uomini curiosi che si sentivano investiti del compito di comprendere perché le cose stessero come stavano, e a una straordinaria capacità di osservazione e di problematizzazione dell’ordinario coniugavano la descrizione, nella forma più semplice e più diretta possibile, degli elementi fondamentali dei fenomeni esaminati. Il linguaggio matematico diventava la lingua universale del sapere finalizzato a cogliere il funzionamento della natura.Per Descartes la verità è stabilita da Dio, dipende interamente da lui e le verità eterne sono innate nell’essere umano. «L’esistenza di Dio, infatti, è la prima e la più eterna di tutte le verità che possono essere e la sola da cui procedano tutte le altre», scrive a Mersenne il 6 maggio del 1630. Ma il Dio che Descartes difende nel proprio sistema filosofico non è il Dio della teologia morale. Quando Mersenne lo incalza sulla dannazione eterna risponde che la questione «è teologica; perciò, vi prego assolutamente di consentirmi di non dirne nulla».
Dio è garanzia epistemologica, fondamento della conoscibilità del reale. E quando, pubblicate le Meditazioni metafisiche nel 1640, sostiene che lo scopo della sua metafisica è «far intendere quali sono le cose che è possibile concepire distintamente», diventa evidente che la riflessione sistematica cartesiana non è semplicemente il razionalismo radicale di un cattolico osservante, ma una teoria della conoscenza che si fonda sulla capacità dell’uomo di pensare e sulla pensabilità del reale.
Sia quando si inerpica sulle vette della dimostrazione dell’esistenza di Dio, sia quando seziona l’occhio di un bue, o osserva i differenti modi di rimbalzare di palle di lana, di metallo, di legno, l’epistemologia di Descartes emerge in queste lettere come un progetto titanico di comprensione della realtà.
-
> L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. --- Tra fisiologia e metafisica. Le due anime di Cartesio (di Franco Giudice)27 marzo 2016, di Federico La Sala
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"!
 VICO, PENSATORE EUROPEO.
VICO, PENSATORE EUROPEO.
Tra fisiologia e metafisicaLe due anime di Cartesio
La tensione tra le «Meditazioni» e i libri non pubblicati in vita (per paura dell’Inquisizione) «Uomo» e «Mondo»
di Franco Giudice (Il Sole-24 ore, Domenica, 27.03.2016)
- Emanuela Scribano, Macchine con la mente. Fisiologia e metafisica tra Cartesio e Spinoza, Carocci, Roma, pagg. 260, € 23.
«Come gli attori, accorti a non fare apparire l’imbarazzo sul volto, vestono la maschera, così io, sul punto di calcare la scena del mondo, dove sinora sono stato spettatore, avanzo mascherato (larvatus prodeo)». L’autore di questa frase ormai celebre è Cartesio, una figura chiave della rivoluzione intellettuale del XVII secolo. Si trova all’inizio di un suo quaderno personale di appunti, una sorta di diario intimo, e reca la data del primo gennaio 1619.
Una frase giovanile dunque che, nonostante le distorsioni cui talvolta è stata sottoposta, aiuta tuttavia a capire perché diverse pagine delle sue opere e la sua stessa biografia suscitino, come ha osservato Eugenio Garin, un’indelebile «impressione di ambiguità», quasi che il filosofo della «chiarezza» intendesse nascondere «una contraddizione segreta, o un conflitto non pacato». Il che spiega forse quelle tensioni concettuali riscontrabili nel suo pensiero e poi riprodottesi in quanti, a vario titolo, se ne sono proclamati eredi.
Proprio quelle tensioni di cui si occupa ora Emanuela Scribano, apprezzata studiosa di Cartesio e del pensiero filosofico moderno. Con l’eleganza e la sobrietà che caratterizzano tutti i suoi lavori, Scribano cerca di individuare le ragioni di alcuni importanti cambiamenti introdotti da Cartesio nella sua teoria della conoscenza e nella sua analisi della percezione sensibile. E per farlo muove dall’ipotesi che essi scaturiscano da una duplice esigenza: da un lato, sviluppare e rafforzare la fondazione metafisica della scienza; dall’altro, rendere coerente tale fondazione con la scienza medesima.
Con la scienza cioè elaborata da Cartesio nell’Uomo, la neurofisiologia, che costituiva la seconda parte del Mondo, dove esponeva la sua fisica e la sua cosmologia. La redazione di questi due scritti, concepiti come un’opera unitaria, fu terminata tra il 1633 e il 1634. L’autore decise però di lasciarli nel cassetto: il Mondo, in seguito alla condanna di Galileo, l’Uomo, invece, per ragioni intrinseche alla stessa ricerca fisiologica. Sarebbero stati pubblicati postumi come testi a sé stanti nel 1664, anche se una traduzione latina dell’Uomo era apparsa due anni prima, e messi insieme per la prima volta soltanto nel 1677.
Queste vicende editoriali sono di estremo rilievo, poiché attestano che quando nelle Meditazioni metafisiche (1641) perfezionò il progetto di fondazione della scienza, Cartesio aveva ormai tracciato le linee portanti della sua fisiologia. E indicano, come fa notare Scribano, «la coesistenza in Cartesio di due anime parallele». Gli scenari che si vengono a delineare, quello metafisico e quello fisiologico, si riveleranno però difficili da amalgamare, creando appunto tensioni profonde, se non addirittura irrisolte.
Nell’Uomo, dove si proponeva di studiare la risposta del corpo umano agli stimoli provenienti dal mondo esterno, Cartesio formulava una teoria della sensazione, dell’immaginazione e della memoria che era esclusivamente materiale. Con un obiettivo quanto mai esplicito: mostrare i poteri del corpo indipendentemente da qualsiasi azione della mente. Al punto che il corpo umano era descritto come una macchina complessa e «intelligente», dotata di sistema nervoso, circolazione sanguigna e cervello, in grado di reagire all’ambiente con comportamenti funzionali alla conservazione della vita.
Nelle Meditazioni egli perseguiva un obiettivo altrettanto esplicito, che andava però nella direzione opposta: ampliare il ruolo della mente e dimostrare che anche nella conoscenza sensibile il corpo, senza un intervento attivo della mente, era impotente. Così, se nell’Uomo, per la conoscenza empirica, la mente si limitava a registrare gli eventi corporei e a tradurli in percezioni, credenze e giudizi; nelle Meditazioni invece veniva teorizzata l’impossibilità della stessa conoscenza empirica, altro non essendo quest’ultima che una costruzione della mente.
A dire il vero, questi due aspetti della riflessione cartesiana ebbero un debutto ufficiale già nel 1637, con la pubblicazione del Discorso sul metodo e dei tre saggi annessi (la Diottrica, le Meteore e la Geometria), dove venivano presentati alcuni elementi centrali della fisiologia sviluppata nell’Uomo insieme a una prima esposizione della sua metafisica.
Qui però il confronto, come ci spiega Scribano, si svolgeva senza particolari problemi, poiché il progetto metafisico di Cartesio non era ancora giunto al livello di maturazione delle Meditazioni che, tra altre importanti novità, introducevano anche la teoria della costruzione mentale dell’esperienza sensibile. Le incoerenze tra le due anime cartesiane emersero dunque nel 1664, quando le tesi neurofisiologiche espresse nell’Uomo divennero finalmente di pubblico dominio, e si cercò di far convivere questo “nuovo” Cartesio con quello delle Meditazioni.
Un compito gravoso, di cui si fecero carico i principali successori del filosofo francese, alle prese con i nodi problematici del suo pensiero. Scribano ricostruisce le tappe più significative del dibattito innescato dalla difficile eredità cartesiana, analizzando in dettaglio le varie soluzioni avanzate da Louis de La Forge, da Gèraud de Cordemoy e da Nicolas Malebranche. Tre filosofi che si erano avvicinati a Cartesio, rimanendone conquistati, più per la lettura dell’Uomo che per quella delle opere da egli edite in vita. Un testo, l’Uomo appunto, che sarebbe stato all’origine della «scelta radicale» di Spinoza: costruire una teoria della conoscenza basata esclusivamente sulla fisiologia cartesiana.
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"!
-
> L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. ---"Inside Out", un "teatro cartesiano". Un omuncolo testardo si contrappone sistematicamente al buon ragionatore che c’è in noi.8 novembre 2015, di Federico La Sala
Inside Out
Se Cartesio sbarca al cinema
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 08.11.2015)
Sta circolando da qualche settimana in Italia il film Inside out, il cui titolo allude al tentativo della Pixar di “tirar fuori ciò che abbiamo dentro”. Cioè di mostrare visivamente i meccanismi mentali nelle loro componenti razionali ed emotive. I critici cinematografici, che evidentemente si intendono solo di cinema, l’hanno esaltato come un’esposizione quasi scientifica delle nuove frontiere neurofisiologiche, scomodando al proposito addirittura i nomi di Antonio Damasio e Oliver Sacks.
In realtà il film avrebbe fatto meglio a intitolarsi Outside in, perché non fa altro che “metter dentro ciò che siamo fuori”. Cioè ripete l’antico “errore di Cartesio”, che credeva che a guidare l’uomo fosse un homunculus dentro di lui, fatto a sua immagine e somiglianza in versione miniaturizzata. Il quale, come i protagonisti del film, sta seduto in un “teatro cartesiano” e osserva dal di dentro ciò che il suo principale a grandezza naturale percepisce dal di fuori.
Naturalmente, poiché un homunculus differisce da un homo solo nelle dimensioni, si può immaginare che nella sua testa ci sia un homunculissimus ancora più piccolo che lo osserva e lo dirige, e così via. L’ipotesi porta dunque a un regresso all’infinito, che non ha bisogno delle neuroscienze per essere confutato: basta la logica, in una delle innumerevoli variazioni del paradosso di Achille e la tartaruga.
Imparare a pensareChe fatica essere logici
Un omuncolo testardo si contrappone sistematicamente al buon ragionatore che c’è in noi. Lo dicono le scienze cognitive. La scuola deve fornire a tutti gli adeguati strumenti critici
di Roberto Casati (Il Sole-24Ore, Domenica, 8.11.2015)
«Prendiamo persone con la stessa gravità di disturbi (misurata, per esempio, attraverso i test di memoria) e li confrontiamo su due fronti: il livello di scolarità e il livello di compromissione cerebrale, rilevata monitorando l’attività metabolica nelle aree tipiche dell’Alzheimer. Cosa osserviamo? Che i soggetti a scolarità alta hanno un peggiore quadro cerebrale: a parità di disturbi manifestati, il loro cervello è più sofferente.» (Stefano Cappa intervistato da Michele Farina, Quando andiamo a casa? Milano BUR, pag. 149).
Quando faccio leggere questa frase, noto una certa sorpresa nei miei interlocutori: sembra che un modo di proteggersi dall’Alzheimer sarebbe quello di non impegnarsi negli studi. In realtà la frase dice esattamente il contrario. «Nonostante siano a uno stadio più avanzato della degenerazione cerebrale, i pazienti a scolarità più alta dimostrano le stesse capacità di memoria di chi presenta un cervello meno devastato e un livello culturale minore. Perché compensano meglio». Adesso, forse, le cose ci sono più chiare. Ma come diceva il biologo americano Stephen Jay Gould, anche se abbiamo capito il senso corretto della frase, se la rileggiamo ci sembra di sentire un omuncolo che va su e giù per nostro cervello a ripetere che è meglio non studiare troppo se ci si vuole proteggere dall’Alzheimer. C’è qualcosa nel testo con cui si apre questo articolo che ci impedisce di arrivare facilmente al senso inteso.
Di omuncoli dispettosi è popolato il cervello raziocinante. Un altro omuncolo ci fa voltare sistematicamente la carta sbagliata nel classico test inventato dallo psicologo britannico Peter Wason: quattro carte sul tavolo davanti a noi, una rossa, una blu, una con scritto sette e una con scritto sei. Sappiamo che le carte hanno un retro colorato in rosso o blu, e un fronte con un numero pari o dispari. Domanda, qual è il numero minimo di carte da girare per verificare la regola «Tutte le carte rosse portano un numero pari»? Pensateci un attimo. Voltare la blu non serve. La rossa va bene (ovviamente: se ci fosse un numero dispari sull’altro lato, la regola sarebbe invalidata). Quali altre? La maggioranza degli intervistati dice che a questo punto basta voltare la sei. Va bene? In realtà, se scoprite che ha il retro blu, questo non vi dice nulla sulla regola. La carta da voltare è la sette. Se il retro della sette fosse rosso, la regola verrebbe violata.
Tutto chiaro, ma la tentazione di voltare anche la carta pari è sempre in agguato. Questo omuncolo testardo è un po’ la maledizione dell’insegnamento della logica perorato con passione nel libro di Paolo Legrenzi e Armando Massarenti (La buona logica. Imparare a pensare, Cortina) che Ermanno Bencivenga ha commentato su queste colonne il 18 ottobre.
L’insegnamento della logica ci informa sulle procedure corrette da mettere in opera quando si affrontano problemi che richiedono di ragionare. Ma non ci mette al riparo dall’omuncolo testardo, che continua a farsi strada nel pensiero. Nella fattispecie, il nostro omuncolo potrebbe venir definito “antispreco”: egli cercava di far tesoro di tutte le informazioni che ha trovato nella formulazione del problema, e in particolare del fatto che si era parlato di una carta pari, il sei, quando si metteva alla prova una regola che richiedeva di pensare ai numeri pari. L’omuncolo antispreco fa parte di quello che oggi gli psicologi cognitivi chiamano il “Sistema Uno”, una batteria di moduli cerebrali che formano l’ossatura delle nostre intuizioni sul mondo, a tutti gli effetti un’eredità biologica che ci permette di risolvere al volo problemi pratici impellenti come scansare ostacoli o fare due conti su cosa ci conviene nel futuro immediato.
Le caratteristiche principali di questi moduli sono la velocità, l’automaticità, e una certa testardaggine; dopotutto, servono a trarci d’impaccio in situazioni in cui il tempo è prezioso, e non hanno molta voglia di star lì a discutere. Al Sistema Uno viene contrapposto il Sistema Due, un modo di operare più lento e modulato dall’attenzione cosciente. Quando attraversiamo la strada a Vicenza noi nati e cresciuti in Italia agiamo in Sistema Uno, ci fidiamo delle nostre intuizioni sul traffico, sappiamo stimare i tempi, non dobbiamo pensare per guardare dalla parte giusta prima di avventurarci sull’asfalto pericoloso. La nostra azione è fluida, agire e pensare fanno un tutt’uno. Quando andiamo a Londra l’ambiente nuovo ci sfida, poniamo invece attenzione a ogni passo: siamo in pieno nel Sistema Due, sincopato, lento e dubitativo. E nonostante tutto anche a Londra l’omunculo “della guida a destra” si fa sentire (è veloce, automatico e testardo) e bisogna cercare di metterlo a tacere se si vuole portare a casa la pelle.
Studiare la logica, fare esercizi come quelli che troviamo in un manuale, ci permette di vedere che il Sistema Uno non sempre dà i risultati migliori. Ma adottare una modalità riflessiva, ovvero esercitare il controllo proprio del Sistema Due, non è cosa che si guadagna facilmente anche dopo aver studiato logica: non dimentichiamo che gli omuncoli automatici devono venir continuamente inibiti. Questo perché la competenza non si riflette automaticamente sulla performance.
Cos’altro possiamo fare, allora, per risollevare i destini della nazione, renderla più raziocinante? Uno dei suggerimenti più interessanti degli ultimi anni viene dal lavoro di Dan Sperber e Hugo Mercier, che hanno messo in luce come la funzione cognitiva principale del ragionamento non sia di migliorare le conoscenze di un dato individuo ma argomentare, cioè convincere gli altri della bontà dei nostri argomenti e valutare gli argomenti altrui in modo critico al fine di essere convinti solo quando è necessario. Segue dalla loro ipotesi che i ragionamenti svolti in coppia o in gruppo danno risultati migliori che quelli effettuati in solitudine. Lavorare in gruppo è un toccasana logico!
Un altro dei fattori che possono rinforzare l’applicazione del pensiero critico è acquisire una certa consuetudine con le procedure di verifica empirica di un’ipotesi che son pane per i denti delle discipline scientifiche. Per esempio, imparare che bisogna sempre controllare i fattori che potrebbero aver influenzato una misura, o imparare a diffidare della ricerca automatica di conferme per le proprie ipotesi.
Un’altra strategia è legata al fatto che si fanno meno errori di ragionamento quando si conosce ciò di cui si parla: imparare bene qualcosa è il primo passo per imparare a pensare bene (contrariamente all’idea di una conoscenza logica generale, passepartout).
Ma direi che non c’è una soluzione definitiva, che ci possa dire che abbiamo finalmente “imparato” a pensare. Gli omuncoli testardi non possono venir eliminati né sconfitti. Possono solo venir tenuti a bada, ed è sulle tecniche per imbrigliarli che potrebbe focalizzarsi una pedagogia innovativa che, mi pare, dovrà necessariamente far uso di checklist.
-
> L’ERRORE DI CARTESIO ----- PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.19 aprile 2013, di Federico La Sala
-
> L’ERRORE DI CARTESIO --- IL DESIDERIO, LA RAGIONE, E DIO.8 aprile 2013, di Federico La Sala
VICO: IL DESIDERIO, LA RAGIONE, E DIO. Note per la (ri)lettura del “De antiquissima italorum sapientia” (II parte)
di Federico La Sala
UOMO E DIO. Nel “De antiquissima italorum sapientia” (1710), Vico riprende i temi del discorso dell’orazione inaugurale del 1699, sullo “straordinario carattere dell’animo”, e della sua ”somiglianza con Dio Ottimo Massimo”, sul fatto che “il proprio animo è come un Dio per ciascuno” (p. 710), sull’importanza della “buona volontà” (p. 718) o, diversamente, del buon uso del libero arbitrio, e li riarticola in modo definitivo all’interno del nuovo orizzonte segnato dal principio del “verum ipsum factum”. E’ un passo decisivo, un passo fondamentale verso la “Scienza Nuova”.
IL CERTO E IL VERO. Nel VI capitolo, intitolato “De Mente”, egli riafferma il valore dell’antica concezione “che la mente è data, immessa negli uomini dagli dei”, che l’“animi mens”, la mente dell’animo, “così come la libido, la facoltà di desiderare, è per ciascuno una propria divinità”, rinnova il suo accordo e insieme la sua polemica con Cartesio e (ora anche) con Malebranche, e porta ulteriori elementi di chiarificazione sul suo discorso critico (e cristiano) relativo alla “indubitabile verità” della metafisica (p. 112) e al “Dio Ottimo Massimo” della religione cristiana. Detto diversamente, egli mostra quanto e come sia necessario mettersi sulla strada che porta dal certo al vero e, al contempo, dare una risposta risolutiva alla questione della “divinità, propria di ogni uomo”, al di là delle vecchie risposte degli aristotelici, degli stoici, e dei socratici (p. 110) e delle soluzioni ingannevoli di geni maligni (o benigni che siano!).
Con Cartesio, Vico concorda che “l’uomo acquista certezza anche se dubita, anche se erra e sbaglia”, ma questa - per lui - è solo la premessa e non la fine di un discorso che vuole essere metafisicamente e teologicamente attento e critico. Mi meraviglio - egli scrive - che l’acutissimo Malebranche “accetti la prima verità di Renato Descartes: cogito, ergo sum” e, poi, considera “Dio creatore nell’uomo delle idee”: se vuole dimostrare una tale dottrina, dovrebbe piuttosto - continua Vico - concludere così: “Qualcosa in me pensa, dunque qualcosa è; ma nel pensiero non trovo alcuna idea di corpo, dunque ciò che pensa in me pensa è purissimo pensiero, è appunto Dio”. MA Vico, ovviamente, non si ferma e, poco oltre, prosegue nell’attacco: se Malebranche “avesse voluto essere coerente con la propria dottrina, avrebbe dovuto insegnare che la mente umana è investita da Dio non solo della cognizione del corpo che ad essa è congiunto, ma anche della conoscenza di se stessa, di modo che non può conoscersi se non si conosce in Dio. La mente infatti si manifesta pensando, ma è Dio che in me pensa, dunque in Dio io conosco la mia propria mente”.
MA QUALE DIO?! Per Vico, “la meravigliosa forza della mente umana, (...) rivolta seco se stessa, ci conduce alla conoscenza del sommo bene, di Dio Ottimo Massimo!” (p. 714); ma dal “fatto” al “vero”, - come già aveva chiarito nell’orazione inaugurale del 1699 - il cammino non è facile: “la cosa che mi desta più meraviglia è il fatto che vi sia un così gran numero di uomini ignari”, che non fanno buon uso delle “facoltà dell’animo” (p. 716). Come con Cartesio, con Malebranche il ‘dialogo’ continua, ma ovviamente sulla strada di Vico: ciò che conosciamo in noi stessi è “il fatto che Dio sia il primo Autore di tutti i moti tanto dei corpi che degli animi”, ma qui - egli scrive - sorgono le secche e gli scogli”!
IL DIO DELLA GRAZIA. Molti sono i nodi da sciogliere. Ma le coordinate epistemologiche, antropologiche, e teologiche sono già chiare e ferme. E Vico, in forma quasi stenografica - così prosegue: “ in che modo Dio può essere il motore della mente umana se riscontriamo tante imperfezioni, tante brutture, tanti errori, tanti vizi? Come è conciliabile il fatto che in Dio vi è verissima ed assoluta scienza mentre l’uomo possiede il libero arbitrio delle sue azioni? Sappiamo con certezza che Dio è onnipotente onnisciente ottimo, che il suo pensare è la verità stessa, che il suo volere è il massimo bene, che il suo pensiero è semplicissimo ed evidentissimo e che la sua volontà è salda ed ineluttabile. Ma sappiamo anche, come insegna la Sacra Scrittura, che “nessuno di noi può andare al Padre se il Padre stesso non lo avrà tratto a sé”. Ma in qual modo può trarlo a sé, se l’uomo è in possesso del proprio volere? Ecco la risposta di Agostino: “non solo egli trae l’uomo volente, ma lo trae lieto, e con piacere dell’uomo stesso”. Qual pensiero può più giustamente accordare la fermezza divina con la libertà del nostro arbitrio?” (p. 110).
LIBERO ARBITRIO E PROVVIDENZA. A queste domande, Vico ha trovato già la risposta, e così precisa: “Per questa ragione accade che Dio mai si allontana dalla nostra presenza, neppure quando erriamo, perché abbracciamo il falso sotto l’aspetto del vero ed i mali sotto l’aspetto del bene (...) questo ingannarsi non significa altro che gli uomini, perfino quando sono incauti e falsamente giudicano delle cose create, ravvisano sempre Dio in queste stesse imitazioni” (p. 112). L’idea-guida per la“Scienza Nuova” (la prima, quella del 1725) è già pronta: l’opera, come si sa, è aperta dal motto “A Iove principium musae” ed è chiusa “con l’altra parte: Iovis omnia Plena” (p. 329). Sembrano vecchie parole, ma il titolo è più che eloquente: “PRINCIPI DI UNA SCIENZA NUOVA intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principi di altro sistema del diritto naturale delle genti”. Contrariamente a quanto tutti hanno pensato (e pensano ancora), è l’inizio di una Storia Nuova: “Prima che ci fosse un uomo in Irlanda, c’era un signore, un lord in Lucania” (James Joyce, Finnegans Wake)!
Federico La Sala
-
> L’ERRORE DI CARTESIO: VICO --- PASQUA DI RESURREZIONE. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE".30 marzo 2013, di Federico La Sala
 IL DIO AMORE DELL’EVANGELISTA GIOVANNI: "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-8). E IL DIO MAMMONA DEL VANGELO DI BENEDETTO XVI : "DEUS CARITAS EST"(2006).
IL DIO AMORE DELL’EVANGELISTA GIOVANNI: "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-8). E IL DIO MAMMONA DEL VANGELO DI BENEDETTO XVI : "DEUS CARITAS EST"(2006).
 PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". Gioacchino (con Dante) invita Benedetto XVI a correre ai ripari
PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". Gioacchino (con Dante) invita Benedetto XVI a correre ai ripari
-
>L’ERRORE DI CARTESIO: VICO --- E IL MAGISTERO EQUIVOCO DI DUE PAPA.30 marzo 2013, di Federico La Sala
 FRANCESCO, IL NUOVO PAPA, OLTRE IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI: DAL "DEUS CARITAS EST" AL "DEUS CHARITAS EST"?
FRANCESCO, IL NUOVO PAPA, OLTRE IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI: DAL "DEUS CARITAS EST" AL "DEUS CHARITAS EST"?
 DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?! Un resoconto dell’incontro, con note
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?! Un resoconto dell’incontro, con note
-