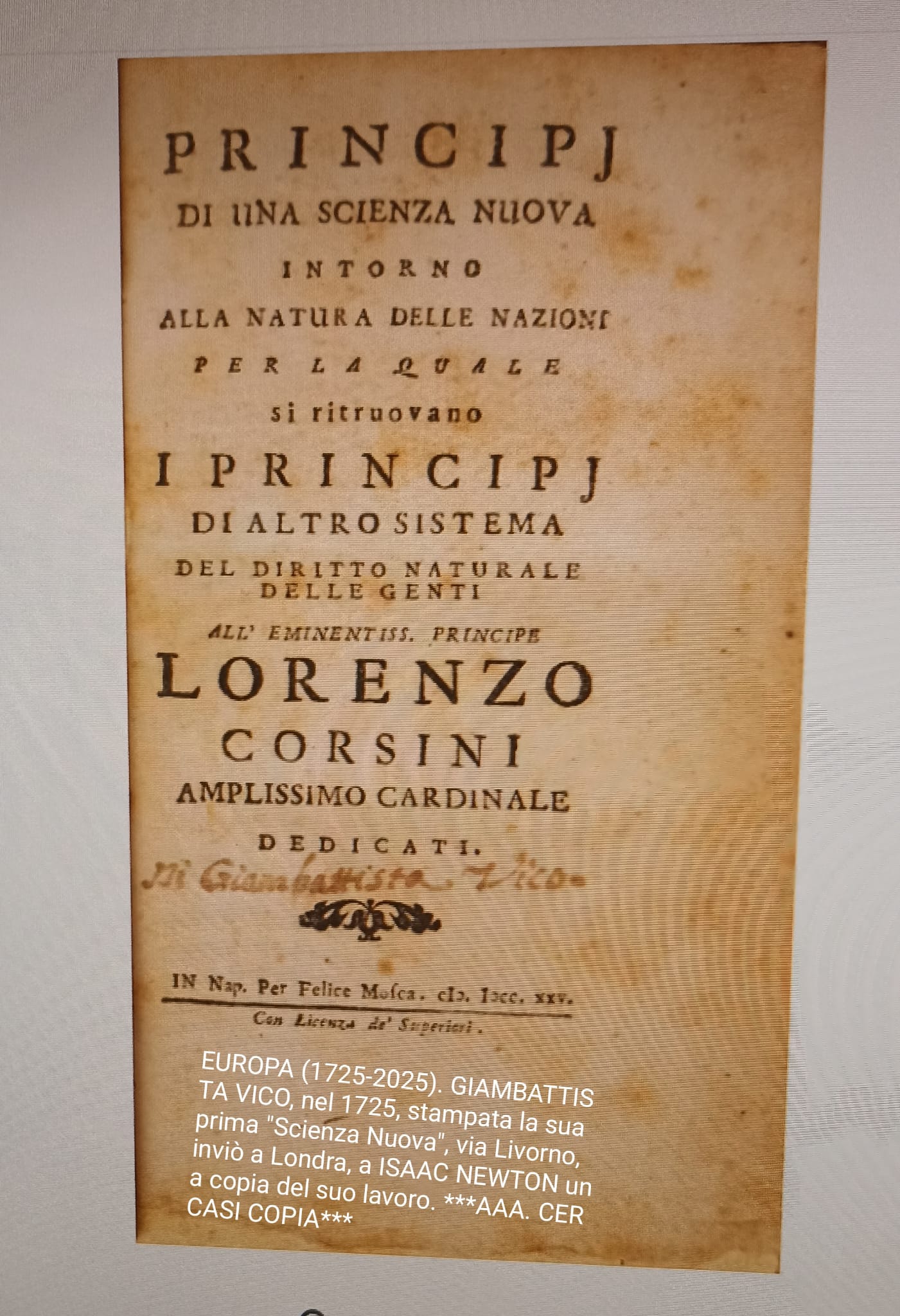
GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE
mercoledì 2 luglio 2025.C’era un lord in Lucania.... *
Se pochi filosofi e letterati sanno dell’omaggio di Ugo Foscolo al filosofo delle “nozze e tribunali ed are” (“Dei sepolcri”, v. 91), moltissimi “addottrinati” ignorano ancora e del tutto che Vico per circa nove anni decisivi per la sua vita ha abitato a Vatolla, nell’antica Lucania (in particolare, nell’attuale Cilento, a poca distanza dall’antica Elea-Velia, Ascea, Paestum, Palinuro, Agropoli) e, al contempo, che James Joyce a Giambattista Vico ha reso l’omaggio più grande che mai poeta potesse fare a un filosofo: "La strada di Vico gira e rigira per congiungersi là dove i termini hanno inizio. Tuttora inappellati dai cicli e indisturbati dai ricorsi, sentiamo tutti sereni, mai preoccupati al nostro doveroso compito... Prima che vi fosse un uomo in Irlanda c’era un lord in Lucania"(FW 452.21 ss.).
C’era un lord in Lucania (Italia): "The Vico road goes round and round to meet where terms begin. Still anappealed to by the cycles and onappaled by the recourses, we fill all serene, never you fret, as regards our dutyful cask... before there was a man in Ireland there was a lord in Lucan " (Cfr.: AA. VV., Introduzione a Finnegans Wake, trad. di Francesco Saba Sardi, Sugar Editore, Milano 1964. La citazione è ripresa dal saggio di Samuel Beckett, "Da Dante a Bruno, da Vico a Joyce", pp. 9-26. La precisazione sulla Lucania e Vatolla è mia).
E, ancora: nessuno sa che Giambattista Vico, stampata la sua prima “Scienza Nuova”, inviò a Londra, a Isaac Newton una copia del suo capolavoro. E che la "Scienza Nuova" seconda (1730), con la "dipintura" di Domenico Antonio Vaccaro, è un omaggio e una ’risposta’ al lavoro di Shaftesbury (a Napoli, dal 1711 al 1713, anno della sua morte).
Per lo più si è ancora dentro il sofisticato cerchio hegeliano di Benedetto Croce: "Propugnatore, come sono della filosofia intesa nel senso di uno «storicismo assoluto», il Vico mi attirava e parlava alla mia mente per una ragione che mi si è poi chiarita e che ho potuto definire: in lui si presenta la prima forma, la «forma arcaica», dello storicismo assoluto".
Dopo quasi tre secoli, nei confronti di colui che ha osato disubbidire alle Leggi della Repubblica di Platone e riammettere a pieno titolo nello Stato Omero, i “poeti”, e restituire alle donne tutta loro dignità, la rimozione continua: la cecità dei nipotini di Platone (come di Cartesio, Hegel, e Heidegger), i sacerdoti della casta atea e devota, è totale! Di fronte all’impresa e alla dipintura della Scienza Nuova perdono subito (e ancora) la loro ‘magistrale’ lucidità e ripiombano nella notte della loro “barbarie della riflessione”! Persa la Memoria delle Muse, delle Grazie (“Charites”), e della Grazia (“Charis”), e delle Dee come delle Sibille, non sanno più cogliere nemmeno la differenza tra Mosè e il Faraone, tra Gesù e Costantino, tra l’amore e la carità dell’uno (“charitas”) e la “carestia” e l’elemosina dell’altro (“caritas”)!
Quanto segue vuol essere solo una sollecitazione e un invito a rileggere tutta l’opera di Vico e, possibilmente, a valutare al meglio il suo grande contributo, a gloria dell’Italia, per la dignità dell’uomo, dell’intero genere umano! Non altro.
Federico La Sala
- "ANATOMIA" (GIOVANNI VALVERDE, 1560) E PSICANALISI (2005).Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo. Una risposta-commento di Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).
INDICE: *
PREMESSA
C’era un lord in Lucania....
Introduzione
A) CROCE E "LA FILOSOFIA DI G. B. VICO". Due note
B) "NOVA SCIENTIA TENTATUR": VICO E "IL DIRITTO UNIVERSALE".
 1. VICO CONTRO CARTESIO.
1. VICO CONTRO CARTESIO.
 2. UNA METAFISICA PER LA FISICA DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima italorum sapientia" (I parte)
2. UNA METAFISICA PER LA FISICA DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima italorum sapientia" (I parte)
 3. IL DESIDERIO, LA RAGIONE, E DIO. Note per la (ri)lettura del “De antiquissima italorum sapientia” (II parte)
3. IL DESIDERIO, LA RAGIONE, E DIO. Note per la (ri)lettura del “De antiquissima italorum sapientia” (II parte)
 4. ESSERE GIUSTI CON VICO. Riprendere l’indicazione di Eugenio Garin.
4. ESSERE GIUSTI CON VICO. Riprendere l’indicazione di Eugenio Garin.
 5. LE TRE EDIZIONI DELLA “SCIENZA NUOVA”: QUESTIONI DI METODO.
5. LE TRE EDIZIONI DELLA “SCIENZA NUOVA”: QUESTIONI DI METODO.
 6. PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI.
6. PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI.
 7. VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!
7. VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!
 8. LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI.
8. LA "BIBBIA CIVILE" RAGIONATA E GLI INTELLETTUALI ITALIANI: IL CASO COLLETTI.
 9. IL DESIDERIO DI IMMORTALITA’, LA STORIA, E LA PROVVIDENZA.
9. IL DESIDERIO DI IMMORTALITA’, LA STORIA, E LA PROVVIDENZA.
 10. FILIAZIONE DIVINA E PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732
10. FILIAZIONE DIVINA E PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732
 11. LA CARITA’ “POMPOSA” DI LUDOVICO A. MURATORI E IL GIUDIZIO DI VICO. Un breve estratto dalla “Prefazione ai lettori” del “Trattato sulla carità cristiana” di Ludovico A. Muratori
11. LA CARITA’ “POMPOSA” DI LUDOVICO A. MURATORI E IL GIUDIZIO DI VICO. Un breve estratto dalla “Prefazione ai lettori” del “Trattato sulla carità cristiana” di Ludovico A. Muratori
 12. PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA [1730, 1744]: SPIEGAZIONE DELLA DIPINTURA PROPOSTA AL FRONTISPIZIO CHE SERVE PER L’INTRODUZIONE DELL’OPERA
12. PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA [1730, 1744]: SPIEGAZIONE DELLA DIPINTURA PROPOSTA AL FRONTISPIZIO CHE SERVE PER L’INTRODUZIONE DELL’OPERA
 13. “LEMURUM FABULA”: IL PUTTANESIMO. LA BRUTTEZZA DELLA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA [La Scienza Nuova 1730]
13. “LEMURUM FABULA”: IL PUTTANESIMO. LA BRUTTEZZA DELLA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA [La Scienza Nuova 1730]
 14. MATERIALI SUL TEMA.
14. MATERIALI SUL TEMA.
* Cfr., Federico La Sala, Vico e la barbarie della riflessione.
Forum
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE ---FILOLOGIA E STORIA: UN "SOGNO" DI TEOCRITO, LE GRAZIE ("CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI GRATITUDINE29 ottobre 2024, di Federico La Sala
UN "#SOGNO" DI #TEOCRITO, LE #GRAZIE ("#CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE:
- UNA #DOMANDA DI #ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...
- In ricordo di Lorenzo Valla e di Giambattista Vico, una breve nota a margine di una vecchia curiosità...
DELLA #GRAZIA ("#CHARIS - #ΧÁΡΙΣ"), DELLA CARITÀ ("CHARITAS") E DEL "SÀPERE AUDE!" (#KANT): COME MAI OGGI, NELL’ATTUALE PRESENTE STORICO, LE "#GRAZIE" (LE GRECHE "CHARITES = ΧÁΡΙΤΕΣ", LE COSIDDETTE "CARITI") SONO DEL TUTTO ASSENTI DA OGNI #CATTEDRA DI ISTRUZIONE E INFORMAZIONE E LE "#DIS_GRAZIE" HANNO INVASO DEL TUTTO IL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA #CONVIVENZA UMANA? #MEMORIA E #POESIA.
Sul filo di #Virgilio ("Bucoliche") e di #DanteAlighieri, forse, un aiuto a trovare una possibile risposta alla domanda del "cruciverba" può venire da Teocrito (in greco antico: Θεόκριτος, Theókritos; #Siracusa, 315 a.C. - 260 a.C. circa). Egli è stato un poeta siciliano, inventore della poesia bucolica, che in una sua opera, gli "Idilli", in particolare nel XVI, intitolato "Le Grazie, o Ierone", così conclude:
 "Che cosa esiste di amabile per gli esseri umani senza le Grazie? Che io possa restare insieme con le Grazie per sempre
"Che cosa esiste di amabile per gli esseri umani senza le Grazie? Che io possa restare insieme con le Grazie per sempre
 ("[...[τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν ἀνθρώποις ἀπάνευθεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ’ εἴην.").
("[...[τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν ἀνθρώποις ἀπάνευθεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ’ εἴην.").- NOTE:
- ANTROPOLOGIA, MITO STORIA E LETTERATURA: LE CARITI. "Le Cariti (in greco antico: Χάριτες, #Chàrites) sono dee della mitologia greca, corrispondenti nella mitologia romana alle #Grazie (in latino: Gratiae). Sono personificazioni degli aspetti della #Grazia ed erano, probabilmente sin dall’origine, legate al culto della natura e della vegetazione. Sono anche le dee della gioia di vivere ed infondono la gioia della Natura nel cuore degli dèi e dei mortali. [...]"(cit.).
- STORIA E LETTERATURA:VIRGILIO. #TEOCRITO E L’#ARCADIA DELLE "#BUCOLICHE". "[...] La trattazione di temi pastorali non era un elemento di novità per l’ambiente culturale romano del I secolo a.C.; era innovativo invece il fatto che un poeta dedicasse a questo tema un intero libro. All’inizio della sesta egloga, Virgilio scrive: «La nostra Talia, per prima, si degnò di scherzare col verso siracusano / e non si vergognò di frequentare le selve.» [...] allude alla figura di Teocrito [...] Per Virgilio la poesia pastorale non era però semplicemente imitazione di Teocrito o mero esercizio letterario; era qualcosa di strettamente connesso con la sua indole e le sue esperienze. [...] L’Arcadia, che è il locus amoenus dei pastori virgiliani, è carico di significati metaforici: è un luogo di riparo, un luogo dove vivere e cantare l’amore, anche deluso, ed è il luogo della civiltà contrapposta alla barbarie. [...] nella IV egloga, in particolare [...] il poeta celebra l’imminenza del ritorno dei Saturnia Regna, in seguito alla nascita di un “bambino divino”, che avrebbe posto fine al tragico presente per inaugurare una nuova età dell’oro. [...] nella #DivinaCommedia il poeta latino #Stazio dice di essersi convertito al Cristianesimo dopo avere letto la IV #Bucolica (Purgatorio - Canto ventiduesimo, vv. 55-93). Questa tradizione iniziò con un discorso di #CostantinoilGrande, databile tra il 313 e il 325, e riportato da #EusebiodiCesarea in appendice alla sua Vita di Costantino col titolo All’assemblea dei santi. [...]" (cit. )
- GIAMBATTISTA VICO E LA #MEMORIA STORICA DELL’ARCADIA, DELLA "PASTORAL POESIA" DI #TEOCRITO ##VIRGILIO E #SANNAZARO, NELLA "SCIENZA NUOVA" DEL 1744:
- "[...]Tal propietà di pascere tali primi greggi del Mondo dev’essere stata d’Apollo, che truovammo Dio della Luce Civile, o sia della Nobiltà, ove dalla Storia Favolosa ci è narrato Pastore in Anfriso; come fu Pastore Paride, il quale certamente era Reale di Troja: e tal’è ’l Padre di famiglia, che Omero appella Re; il quale con lo scettro comanda, il bue arrosto dividersi a’ mietitori, descritto nello Scudo d’Achille; dove sopra abbiamo fatto vedere la Storia del Mondo, e quivi esser fissa l’Epoca delle Famiglie: perchè de’ nostri pastori non è propio il pascere, ma il guidar’, e guardare gli armenti, e i greggi; non avendosi potuto la Pastoreccia introdurre, che dopo alquanto assicurati i confini delle prime città, per gli ladronecci, che si celebravano a’ tempi eroici: che dev’essere la cagione, perchè la Bucolica, o Pastoral Poesia venne a’ tempi umanissimi egualmente tra’ Greci con Teocrito, tra’ Latini con Virgilio, e tra gl’Italiani con Sannazaro. (Giambattista Vico, "Scienza Nuova" del 1744, L. V, II.).
-
> GIAMBATTISTA VICO --- NAPOLI E LA SCIENZA. STORIA E STORIOGRAFIA. Nota a margine di "The Science of Naples. Making knowledge in Italy’s pre-eminent city, 1500-1800".1 luglio 2024, di Federico La Sala
NAPOLI E LA SCIENZA. STORIA E STORIOGRAFIA:
GIAMBATTISTA VICO CON #NEWTON E CON #SHAFTESBURY.
- Una nota di commento a margine di "The Science of Naples. Making knowledge in Italy’s pre-eminent city, 1500-1800", Edited by Lorenza Gianfrancesco and Neil Tarrant", #UCLPress - University College London, 2024):
- "[...] Following the end of Spanish rule and a brief period of Austrian power, the kingdom was conquered by Charles of Bourbon in 1734. He established an independent monarchy with a royal court in Naples. Charles also sought to implement a series of reforms. While not always successful, the monarchy’s reformist efforts were informed and celebrated by the city’s cohort of Enlightened thinkers. The work of scholars such as Giambattista #Vico (1668-1744), Pietro #Giannone (1676-1748), Antonio #Genovesi (1713-1669) and Gaetano #Filangieri (1753-1788), to name but some, undoubtedly reflected the continued vibrancy of Neapolitan intellectual life and the city’s connections to the intellectual centres of #Europe. [...]" (Open Access)
***
LA PUNTA DI UN ICEBERG: "[...] #ROYAL SOCIETY, NEWTON, VALLETTA. Se Vico, nel 1725, invia a Newton una copia della sua prima “#ScienzaNuova”, ha le sue buone ragioni: non è il gesto di un isolato dalla cultura europea del suo tempo! Una di queste ragioni è che egli, sin dagli anni degli studi universitari (1689-1693), era in relazione con Giuseppe Valletta.
 Ecco quanto #Croce dice di lui nel suo discorso del 1924: a Napoli, “lo Shaftesbury entrò in relazione (...) con Giuseppe Valletta e col suo circolo (...) Valletta, già mercante e avvocato (...) conoscitore com’era, oltre che del latino e del greco, del francese, e dell’inglese, segnatamente verso l’#Inghilterra tenne rivolto lo sguardo, e coi dotti e le società scientifiche inglesi coltivò corrispondenze.
Ecco quanto #Croce dice di lui nel suo discorso del 1924: a Napoli, “lo Shaftesbury entrò in relazione (...) con Giuseppe Valletta e col suo circolo (...) Valletta, già mercante e avvocato (...) conoscitore com’era, oltre che del latino e del greco, del francese, e dell’inglese, segnatamente verso l’#Inghilterra tenne rivolto lo sguardo, e coi dotti e le società scientifiche inglesi coltivò corrispondenze.
 Di libri inglesi, scarsissimi allora in Italia, era assai ben provvista la sua libreria, e dall’inglese egli traduceva in italiano o in latino le notizie scientifiche, in specie quelle che la Società reale di Londra gl’inviava sulle esperienze che essa veniva compiendo. Il segretario di quella società, il Waller, gli richiese tra l’altro, nel 1712, una informazione - continua e precisa Croce - sull’eruzione del #Vesuvio allora accaduta, e poi ancora sull’epidemia del bestiame che impersava in Italia, e le sue memorie su tali argomenti furono lette in quell’adunanza, presente e presidente il Newton. Così stimato era quei dotti - continua ancora Croce - che più volte gli fu offerta (narra un biografo) da milordi e signori inglesi un luogo in quella Regia società: onore che egli, modesto com’era, rifiutò” [...]" (cfr. Federico La Sala, "IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA").
Di libri inglesi, scarsissimi allora in Italia, era assai ben provvista la sua libreria, e dall’inglese egli traduceva in italiano o in latino le notizie scientifiche, in specie quelle che la Società reale di Londra gl’inviava sulle esperienze che essa veniva compiendo. Il segretario di quella società, il Waller, gli richiese tra l’altro, nel 1712, una informazione - continua e precisa Croce - sull’eruzione del #Vesuvio allora accaduta, e poi ancora sull’epidemia del bestiame che impersava in Italia, e le sue memorie su tali argomenti furono lette in quell’adunanza, presente e presidente il Newton. Così stimato era quei dotti - continua ancora Croce - che più volte gli fu offerta (narra un biografo) da milordi e signori inglesi un luogo in quella Regia società: onore che egli, modesto com’era, rifiutò” [...]" (cfr. Federico La Sala, "IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA").NOTE:
PER UN’ALTRA EUROPA E PER UN’ALTRA ITALIA. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova": GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE).
LA SCIENZA A NAPOLI NEL SETTECENTO: L’UNIVERSITA’ E L’ AZIONE RIFORMATRICE DI #CELESTINO #GALIANI E #ANTONIO #GENOVESI *:
"[...] The principal context of the chapter is the tenure of Celestino Galiani (1681-1753) as the rector (or ‘Cappellano Maggiore’) of the University of Naples and the published work of his protégé Antonio Genovesi (1711-1769). The history of Galiani’s and Genovesi’s curricular reforms is well known among historians of the Settecento Meridione.
 However, the place of ‘political science’ - that is, the teaching and study of ‘politics’ - in this history still awaits study. The chapter begins by surveying the institutional background to Galiani’s curricular reforms as Cappellano Maggiore; it then turns to the works of Genovesi and members of the so-called ‘#scuola #genovesiana’. Although the latter published on ‘political’ topics, neither Genovesi nor his students developed a curricular ‘political science’ [...]" (cfr. Felix Waldmann, "Political science in the Settecento University of Naples", in "The Science of Naples", op. cit., p. 61).
However, the place of ‘political science’ - that is, the teaching and study of ‘politics’ - in this history still awaits study. The chapter begins by surveying the institutional background to Galiani’s curricular reforms as Cappellano Maggiore; it then turns to the works of Genovesi and members of the so-called ‘#scuola #genovesiana’. Although the latter published on ‘political’ topics, neither Genovesi nor his students developed a curricular ‘political science’ [...]" (cfr. Felix Waldmann, "Political science in the Settecento University of Naples", in "The Science of Naples", op. cit., p. 61).*
b) ANTONIO GENOVESI.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE ---IL "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO gALILEI, 1610): UNA STORIA DI #LUNGADURATA E, FORSE, DI UN PROSSIMO "ARROSSIMENTO GENERALE".15 aprile 2024, di Federico La Sala
UNA #STORIA DI #LUNGADURATA E, FORSE, DI UN PROSSIMO "ARROSSIMENTO GENERALE" : IL "#SIDEREUSNUNCIUS" (#GALILEOGALILEI, 1610), L’#ITALIA E IL SUO GRANDE #PROVINCIALISMO NELLO STORICO PRESENTE DEL "#VILLAGGIO #GLOBALE" (2024).
CULTURA E SOCIETÀ, #OGGI: "SÀPERE AUDE!" (Koenigsberg, 1784; Kaliningrad, 2024).
- Una nota a margine di una riflessione di Giorgio Mascitelli:
- "La situazione italiana è caratterizzata da un marcato provincialismo culturale: esso è senz’altro in aumento rispetto a trent’anni fa. [...] Certo tutta l’#Europa è diventata più provinciale, eppure anche lo scarto con gli altri paesi europei è aumentato. [...] alla base della superprovincializzazione italiana sta una trasformazione di fondo: fino a 30 fa l’Italia era un paese in cui si producevano merci, questo poneva tutta una serie di problemi generali e locali che implicavano una cultura che li affrontasse; oggi dopo la #globalizzazione, l’Italia è diventata un centro di consumo, secondario, di merci prodotto altrove che vive di speculazione edilizia e finanziaria e di turismo [...]
- Pertanto è favorito lo sviluppo di una cultura d’accatto, che idolatra ciò che è secondario, in cui è più importante #imitare che #sperimentare e l’accresciuta internazionalizzazione è il sintomo di questo processo. E tuttavia, stanno arrivando tempi in cui non avere una cultura del tutto provinciale sarà importante e non un semplice orpello." ( cfr. cfr, Giorgio Mascitelli, Fbook 12 aprile 2024 ).
ANTROPOLOGIA, #STORIOGRAFIA, E #CRITICA DELLA #FACOLTÀ DI #GIUDIZIO (#KANT2024). CONSIDERANDO che il "villaggio globale" dell’attuale storico presente (#Nicea 325-2025) è molto prossimo (epocalitticamente) alla "#pace #perpetua" (#Kant2024), è sperabile che in giro emergano molte tracce di rimorso dell’incoscienza passata (e presente) e che "lo spirito critico" sia in Italia sia in Europa riprenda il suo cammino.
 Nota:
Nota:- Anthropology and #Metaphysics: "The Critical Spirit. Essays in Honor of Herbert Marcuse" (Kurt H. #Wolff, #Barrington Moore, Beacon Press, 1967 - 436 pagine).
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- LA "STORIA" DEL "RE LEONE", E LA PROFETICA "VITTORIA" DEL "FORTEBRACCIO" DI SHAKESPEARE ("AMLETO")..27 marzo 2024, di Federico La Sala
TEATRO METATEATRO E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. FREUD):
LA SCOPERTA DEL "MARCIO IN DANIMARCA" (IN EUROPA), LA "STORIA" DEL "RE LEONE", E LA PROFETICA "VITTORIA" DEL #FORTEBRACCIO DI #SHAKESPEARE ("HAMLET", V.2).
- Una nota di commento a margine del lavoro in corso di Paul Adrian Fried (Part 37: Sts. Gertrude, pilgrim’s lovers, & mousetraps (Interlude D.4) - March 26, 2024).
"QUANDO IL GATTO NON C’E’, I TOPI BALLANO". Per orientarsi nel pensiero e nell’analisi dell’opera di Shakespeare (#Hamlet), forse, è utile rileggere la "storia" del #pifferaio di #Hamelin (Der #Rattenfänger von #Hameln, letteralmente "l’ accalappiatore di ratti di Hameln").... e ripensare in parallelo la pericolosa "condizione" di #Amleto, #Principe #Figlio (in relazione alla #Regina-madre, #Gertrude, e all’avvelenatore "Re-padre", #Claudio), e ... la "condizione" di Simba, il principe-figlio di Mufasa, il "Re Leone", sotto il governo dello zio assassino, diventato re, il leone Skar, alleato con le iene, e sposo della leonessa, regina-madre: una situazione molto simile all’assalto dei Proci a Itaca, al regno di Penelope e Ulisse e Telemaco dell’ #Odissea...
- Nota. The soundtrack of the Lion King is inspired to Mozart’s music (Ave Verum Corpus, K. 618).
SUL TEMA, PER APPROFONDIMENTO, SI CFR.:
L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova" - di Federico La Sala
 IL PUTTANESIMO. "Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria".
IL PUTTANESIMO. "Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria".fls
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- ARCHEOLOGIA, ARCHITETTURA, E GIUSTIZIA: IL PONTE DELLA CITTÀ DI PARMENIDE.26 luglio 2022, di Federico La Sala
SCIENZA NUOVA: NUOVO ANNO ACCADEMICO E NUOVO RETTORE ALL’UNIVERSITÀ DI MACERATA. UN OMAGGIO A John McCourt - in ricordo dell’omaggio di James Joyce a Giambattista Vico...
***
- "The Vico road goes round and round to meet where terms begin. Still anappealed to by the cycles and onappaled by the recourses, we fill all serene, never you fret, as regards our dutyful cask... before there was a man in Ireland there was a lord in Lucan" (James Joyce, "Finnegans Wake").
- "La strada di Vico gira e rigira per congiungersi là dove i termini hanno inizio. Tuttora inappellati dai cicli e indisturbati dai ricorsi, sentiamo tutti sereni, mai preoccupati al nostro doveroso compito... Prima che vi fosse un uomo in #Irlanda c’era un lord in Lucania" (Vico ha abitato per vari anni a Vatolla, poco distante da Paestum, Agropoli, Elea e Palinuro).
***
UNIMC: ORTO DEI PENSATORI E CORTILE DELLA FILOSOFIA. *
Chiarissimo John McCourt, augural-mente, per ben iniziare i lavori e meglio illuminare il cammino nella nuova #direzione, ripensando al profondo legame di James Joyce con Giambattista Vico (vissuto per quasi dieci anni in Lucania, oggi Cilento), forse, non è male ricordare di considerare la particolare rilevanza per il "Dip. di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo", dell’antica città di Elea - Velia /Ascea), invitare a rileggere il "Poema" di Parmenide e a ripercorrere la strada che portava sull’acropoli, al tempio della Dea Giustizia (Dike): come si sa, la via non passa e non è mai passata attraverso la cosiddetta "Porta Rosa", ma attraverso il ponte, il viadotto che passa appunto sopra la cosiddetta "Porta Rosa" (https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Rosa). Contrariamente a quanto pensava Platone (e hanno pensato nei secoli i suoi "nipotini"), il #Logos della città di Parmenide, non il Logo del padrone di una #caverna, era ed è il fondamento stesso del dialogo, «l’unico ponte tra le persone» (Albert Camus). Moltissimi auguri. Buon inizio...
***
ARCHEOLOGIA, PSICOANALISI, E PLATONISMO PER IL POPOLO: "COME NASCONO I BAMBINI". Osare mettere il dito nella "piaga" e interrogarsi sulla storia del nome della "Porta Rosa" (https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Rosa#Storia->). A mio parere, la "cosa" è carica di teoria e qui è opportuno (per capire) ricollegarsi a Freud e andare oltre Lacan: è una questione di immaginario e di una "logica" più che bimillenaria e ... di "fretta". L’Archeologo, probabilmente troppo eccitato dalla scoperta, ha voluto rendere omaggio alla propria compagna, alla luce della propria e generale tragica tradizionale concezione della donna (un vicolo cieco in cui mettere il proprio seme e far fiorire la pianta), senza fare i conti con le spine della Dea Giustizia (Dike) e la Costituzione (il Logos) materiale e spirituale della stessa città di Elea (come della Repubblica Italiana): "Il dialogo è l’unico ponte tra le persone" (Albert Camus)!
***
QUESTIONE ANTROPOLOGICA: L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!! E CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CITTADINI E CITTADINE D’ITALIA!!!
Federico La Sala
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Storia globale: "A New History of Humanity" . L’alba di tutto, ovvero: non siamo mai stati stupidi (di Lorenzo Velotti).17 marzo 2022, di Federico La Sala
L’alba di tutto, ovvero: non siamo mai stati stupidi
di Lorenzo Velotti (gli asini, 1 marzo 2022)
Un giorno d’ottobre 2018, in una Londra decisamente già troppo invernale, entravo nervoso in una classe stracolma. Anche ai lati, per terra, gli spazi scarseggiavano. Riuscii a sedermi per terra, quasi sotto un banco. Il professore, David Graeber, che vedevo in quel momento per la prima volta, era impegnato a scrivere sulla lavagna: “Rousseau; Hobbes; De Lahontan; Kandiaronk...”. Si girò e ci rassicurò: avrebbe chiesto all’amministrazione una classe più grande. Poi cominciò la lezione, con un po’ di studenti costretti a seguire da fuori, sbirciando dalla porta aperta. Fu la prima lezione del corso “Antropologia e Storia Globale”, che si tenne solo quell’anno e del quale gran parte dei contenuti erano relativi al libro che, ci rivelò, stava scrivendo con l’archeologo David Wengrow. Il corso si interrogava sulla relazione tra antropologia e storia, e culminava con le domande: “In che modo la storia è consapevolmente prodotta da chi ne partecipa? Secondo quali dinamiche la potenziale inquadratura narrativa degli eventi diventa un elemento chiave in politica o, addirittura, l’aspetto decisivo dell’azione politica stessa?”
Ora, queste non sono, almeno esplicitamente, le domande che pone il libro L’alba di tutto. Una nuova storia dell’umanità (Rizzoli 2022), che Wengrow e Graeber finirono di scrivere soltanto una settimana prima della prematura morte di quest’ultimo (avvenuta a Venezia nel settembre 2020). Tuttavia, sono domande particolarmente utili da cui partire per cogliere gli aspetti fondamentali di questa ricerca. Infatti, nonostante i sospetti postmoderni nei confronti delle metanarrative, queste ultime sembrano aver costituito, da sempre, un elemento fondamentale nell’intreccio tra storia e azione politica.
Da una parte, scegliere di ignorarne la rilevanza implica quasi sicuramente la loro accettazione. Dall’altra, riconoscerle, spacchettarle, studiarne le basi storiche e le implicazioni politiche, problematizzarle e, così facendo, porre potenzialmente le basi per narrative diverse, è l’ambiziosa e interessante sfida colta da Graeber e Wengrow.
Il punto di partenza è che, nonostante l’illusorio disincanto associato parallelamente al metodo scientifico e alla massimizzazione di utilità e profitti, la società e la sua “scienza sociale” continuano a fondarsi su una serie di miti. I miti, ci dice l’antropologia, si svolgono sempre in un passato indefinito, ma hanno effetti concreti sul mondo presente. Il più delle volte hanno a che fare con un’indagine sulla natura umana.
 Ora: vi sarà capitato, in un’accesa discussione politica sull’origine dei problemi attuali, di arrivare al punto in cui da una parte si sosterrà che la natura umana è fondamentalmente egoista e competitiva e, dall’altra, qualcuno dirà che invece è essenzialmente altruista e collaborativa? Tendenzialmente, la prima sarà una posizione difesa da chi si colloca un po’ più a destra, e la seconda da chi si sente un po’ più a sinistra (ma non necessariamente).
Ora: vi sarà capitato, in un’accesa discussione politica sull’origine dei problemi attuali, di arrivare al punto in cui da una parte si sosterrà che la natura umana è fondamentalmente egoista e competitiva e, dall’altra, qualcuno dirà che invece è essenzialmente altruista e collaborativa? Tendenzialmente, la prima sarà una posizione difesa da chi si colloca un po’ più a destra, e la seconda da chi si sente un po’ più a sinistra (ma non necessariamente).
 Questa dicotomia, in ogni modo, ha un chiaro corrispettivo nella storia delle dottrine politiche e viene ricercata in ciò che viene spesso definito lo “stato di natura”. In questo passato mitico, in cui troviamo esseri umani che altro non hanno che la loro pura umanità, le possibilità sembrano essere due: o gli esseri umani vivevano fondamentalmente la violenza quotidiana del tutti contro tutti (da qui la posizione hobbesiana secondo cui lo stato sarebbe necessario per convivere in pace); o erano invece esseri cooperativi ed egualitari “per natura”, ma la rivoluzione agricola e la conseguente invenzione della proprietà privata hanno rappresentato una caduta dall’Eden (elemento mitico ricorrente) verso l’inevitabile disuguaglianza attuale (Rousseau).
Questa dicotomia, in ogni modo, ha un chiaro corrispettivo nella storia delle dottrine politiche e viene ricercata in ciò che viene spesso definito lo “stato di natura”. In questo passato mitico, in cui troviamo esseri umani che altro non hanno che la loro pura umanità, le possibilità sembrano essere due: o gli esseri umani vivevano fondamentalmente la violenza quotidiana del tutti contro tutti (da qui la posizione hobbesiana secondo cui lo stato sarebbe necessario per convivere in pace); o erano invece esseri cooperativi ed egualitari “per natura”, ma la rivoluzione agricola e la conseguente invenzione della proprietà privata hanno rappresentato una caduta dall’Eden (elemento mitico ricorrente) verso l’inevitabile disuguaglianza attuale (Rousseau).La tesi hobbesiana è di fatto ripresa da gran parte della destra o da pensatori liberali come Steven Pinker. Quella rousseauiana, in realtà dominante, è il sottotesto dei best seller di Francis Fukuyama, Jared Diamond o Yuval Noah Harari. L’agricoltura introduce necessariamente un surplus appropriabile e dunque la proprietà privata. La popolazione aumenta e le società diventano più “complesse”, dove la complessità è praticamente sinonimo di gerarchia. -Un’idea di “scala” tanto diffusa quanto infondata (che gli autori confessano essere, probabilmente, la più difficile da scalfire) crea una corrispondenza tra gerarchie spaziali e sociali, che si materializzano inevitabilmente attraverso la burocrazia e lo stato. Ma, per fortuna, con tutto questo arrivano anche la scrittura, la scienza e l’arte. La civilizzazione è inspacchettabile: o tutto o niente.
I miti, tuttavia, non si fondano primariamente su fatti realmente avvenuti. La storia classica delle dottrine politiche, neppure. Né Hobbes né Rousseau affermano, in alcun modo, che si tratti di fatti (pre-)storici. Si tratta di ipotesi, o esperimenti mentali, che tuttavia hanno finito per diventare miti cosmogonici.
 In L’alba di tutto, la conoscenza delle più recenti scoperte archeologiche da parte di David Wengrow, unita alla teoria antropologica e politica di David Graeber, servono a mettere insieme innumerevoli pezzi - di fatto già esistenti nella letteratura specifica delle due discipline - per rivelare l’abisso che le separa dalla metanarrativa mitica. Naturalmente, la messa in discussione della metanarrativa imperante ha delle profondissime implicazioni per quanto riguarda il dibattito politico contemporaneo e il relativo spettro di possibilità alternative. Gli autori sono in grado di presentare un’abbondanza di dati archeologici e antropologici così da mostrare, essenzialmente, una diversa, ben più complessa, storia del mondo. Non solo, sono in grado di farlo in modo estremamente piacevole per chi legge, mantenendo, attraverso le oltre cinquecento pagine che compongono il saggio, una suspense continua.
In L’alba di tutto, la conoscenza delle più recenti scoperte archeologiche da parte di David Wengrow, unita alla teoria antropologica e politica di David Graeber, servono a mettere insieme innumerevoli pezzi - di fatto già esistenti nella letteratura specifica delle due discipline - per rivelare l’abisso che le separa dalla metanarrativa mitica. Naturalmente, la messa in discussione della metanarrativa imperante ha delle profondissime implicazioni per quanto riguarda il dibattito politico contemporaneo e il relativo spettro di possibilità alternative. Gli autori sono in grado di presentare un’abbondanza di dati archeologici e antropologici così da mostrare, essenzialmente, una diversa, ben più complessa, storia del mondo. Non solo, sono in grado di farlo in modo estremamente piacevole per chi legge, mantenendo, attraverso le oltre cinquecento pagine che compongono il saggio, una suspense continua.Non è facile riassumere un tomo di queste dimensioni, ma proverò a delinearne alcuni elementi fondamentali. Il libro inizia problematizzando una domanda piuttosto comune, da cui gli autori stessi raccontano di essere partiti: “Quali sono le origini della disuguaglianza sociale”? Il problema, rilevano però gli autori, sta nella domanda stessa, giacché si presta con estrema facilità a una risposta di natura mitica. Il concetto di eguaglianza, peraltro, è relativamente recente: nel medioevo, i termini “uguaglianza” e “disuguaglianza” erano tutt’altro che comuni.
 Verso la fine del diciassettesimo secolo, raccontano gli autori, l’incontro tra coloni europei e indigeni americani (e in particolare la critica politica elaborata dai secondi nei confronti dei primi) ha prodotto un notevole fermento di idee riguardo al concetto di libertà. Gli americani, infatti, erano particolarmente scossi dall’assenza di libertà che rilevavano presso gli europei.
Verso la fine del diciassettesimo secolo, raccontano gli autori, l’incontro tra coloni europei e indigeni americani (e in particolare la critica politica elaborata dai secondi nei confronti dei primi) ha prodotto un notevole fermento di idee riguardo al concetto di libertà. Gli americani, infatti, erano particolarmente scossi dall’assenza di libertà che rilevavano presso gli europei.
 In particolare, i protagonisti di questo capitolo sono: Kandiaronk, noto leader politico e diplomatico nordamericano (che visitò l’Europa), e il Baron de Lahontan, grazie ai cui scritti conosciamo il pensiero di Kandiaronk. Non è l’unico incontro rilevante, ma sicuramente il principale. In breve, le idee nordamericane di libertà, nell’incontro con la realtà europea, cominciano a scontrarsi con determinate nozioni di proprietà, l’abilità di trasformare la ricchezza in potere, e dunque l’“uguaglianza”. In Europa, acquisiscono una tale rilevanza che qualcuno comincia a sentire la necessità di rispondere e giustificare le condizioni sociali europee: è qui che Turgot elabora la nozione stessa di “progresso”, fatto di stadi di sviluppo che, pur creando inevitabilmente la povertà di alcuni, hanno fatto avanzare la società “complessa” nella sua interezza. L’idea non dispiacque a Adam Smith, che la riprese. In questo quadro, Rousseau non fece altro che una sintesi intelligente tra le due posizioni di cui si discuteva animatamente nella Francia di quei tempi, e la sua sintesi divenne, in qualche modo, il documento fondante del progetto intellettuale della sinistra dominante fino a oggi (chiamata appunto: “sinistra progressista”).
In particolare, i protagonisti di questo capitolo sono: Kandiaronk, noto leader politico e diplomatico nordamericano (che visitò l’Europa), e il Baron de Lahontan, grazie ai cui scritti conosciamo il pensiero di Kandiaronk. Non è l’unico incontro rilevante, ma sicuramente il principale. In breve, le idee nordamericane di libertà, nell’incontro con la realtà europea, cominciano a scontrarsi con determinate nozioni di proprietà, l’abilità di trasformare la ricchezza in potere, e dunque l’“uguaglianza”. In Europa, acquisiscono una tale rilevanza che qualcuno comincia a sentire la necessità di rispondere e giustificare le condizioni sociali europee: è qui che Turgot elabora la nozione stessa di “progresso”, fatto di stadi di sviluppo che, pur creando inevitabilmente la povertà di alcuni, hanno fatto avanzare la società “complessa” nella sua interezza. L’idea non dispiacque a Adam Smith, che la riprese. In questo quadro, Rousseau non fece altro che una sintesi intelligente tra le due posizioni di cui si discuteva animatamente nella Francia di quei tempi, e la sua sintesi divenne, in qualche modo, il documento fondante del progetto intellettuale della sinistra dominante fino a oggi (chiamata appunto: “sinistra progressista”).Tornando alla domanda sulle “origini”: il progetto di Graeber e Wengrow è quello di confutare la tesi che ci sia una netta separazione tra uno stato di natura composto da selvaggi egualitari (o di caos e violenza) e un successivo, unidirezionale, monolitico processo di civilizzazione che ci ha portato sin qui. -La preistoria, per esempio, è un periodo di circa tre milioni di anni che viene spesso appiattito in frasi quali: “l’uomo preistorico era così”; “le società preistoriche erano organizzate cosà”; e così via. Esiste un tacito pregiudizio nei confronti dei “primitivi” quali esseri del tutto incapaci di riflessioni consapevoli, ed è infatti comune - per esempio nel caso di Harari, fanno notare gli autori - considerarli più simili alle scimmie che agli esseri umani. Da qui il determinismo di chi sostiene che il “modo di sussistenza” è l’unica variabile in grado di spiegare quanto un popolo fosse più o meno gerarchico: le condizioni ecologiche non sono prese come alcune delle variabili in gioco ma come la variabile determinante.
 Gli autori argomentano che nel periodo corrispondente all’era glaciale le forme sociali non erano “congelate”, bensì costantemente trasformate in base a molteplici fattori, a volte anche stagionalmente.
Gli autori argomentano che nel periodo corrispondente all’era glaciale le forme sociali non erano “congelate”, bensì costantemente trasformate in base a molteplici fattori, a volte anche stagionalmente.
 Da qui la domanda che ricorrerà più e più volte tra le pagine del libro: piuttosto che interrogarci sulle origini della disuguaglianza, chiediamoci: com’è possibile che gli esseri umani sono stati in grado di fare e disfare gerarchie costantemente, e ora non sembrano esserlo più? Come si è persa quell’autoconsapevolezza politica? Come si è finiti a credere che ci sia una sola modalità possibile? Che cosa si è inceppato?
Da qui la domanda che ricorrerà più e più volte tra le pagine del libro: piuttosto che interrogarci sulle origini della disuguaglianza, chiediamoci: com’è possibile che gli esseri umani sono stati in grado di fare e disfare gerarchie costantemente, e ora non sembrano esserlo più? Come si è persa quell’autoconsapevolezza politica? Come si è finiti a credere che ci sia una sola modalità possibile? Che cosa si è inceppato?Da un certo punto di vista, il problema è la proprietà: gli autori analizzano dunque diverse concezioni di proprietà (nella storia e nell’antropologia) per dimostrare che anche la proprietà non ha, di per sé, un’origine definita: in un certo senso, esiste da sempre. La domanda da porsi è, piuttosto, come sia arrivata a definire così tanti altri aspetti dell’esistenza umana. La riflessione viene dunque portata ai processi di schismogenesi culturale (e di rifiuto creativo) avvenuti nella costa occidentale del continente nordamericano, in relazione alla schiavitù, alla cura, e ai modi di produzione.
 Chi legge è dunque trasportato da un continente all’altro per problematizzare l’idea che la “rivoluzione agricola” sia un concetto effettivamente utile. La domesticazione di pianti e animali, secondo l’archeologia più recente, ha cominciato a verificarsi in una ventina di posti diversi nel mondo, in un processo durato almeno 3000 anni, senza implicare necessariamente delle enclosures, e peraltro spesso alternata o parallela alla caccia e ai raccolti, o addirittura adottata per certi periodi, abbandonata e poi ripresa. Peraltro, sottolineano gli autori, la prima agricoltura ha avuto a che fare con un’organizzazione sociale più egualitaria, e non il contrario; il tutto, sostengono Graeber e Wengrow, in un contesto di scelte politiche consapevoli.
Chi legge è dunque trasportato da un continente all’altro per problematizzare l’idea che la “rivoluzione agricola” sia un concetto effettivamente utile. La domesticazione di pianti e animali, secondo l’archeologia più recente, ha cominciato a verificarsi in una ventina di posti diversi nel mondo, in un processo durato almeno 3000 anni, senza implicare necessariamente delle enclosures, e peraltro spesso alternata o parallela alla caccia e ai raccolti, o addirittura adottata per certi periodi, abbandonata e poi ripresa. Peraltro, sottolineano gli autori, la prima agricoltura ha avuto a che fare con un’organizzazione sociale più egualitaria, e non il contrario; il tutto, sostengono Graeber e Wengrow, in un contesto di scelte politiche consapevoli.
 Un altro viaggio nel tempo e in diversi continenti avviene per demolire, servendosi di recenti scoperte archeologiche, la narrativa convenzionale e teleologica che riguarda l’avvento delle città. Anche qui, l’associazione tra urbanizzazione e gerarchizzazione delle relazioni risulta riflettere più dei preconcetti che non sulle prove fornite dall’archeologia. Tra le vicende più interessanti ci sono quelle che compongono la storia sociale mesoamericana, composta da repubbliche urbane e da democrazie indigene (come l’incredibile storia di Tlaxcaca).
Un altro viaggio nel tempo e in diversi continenti avviene per demolire, servendosi di recenti scoperte archeologiche, la narrativa convenzionale e teleologica che riguarda l’avvento delle città. Anche qui, l’associazione tra urbanizzazione e gerarchizzazione delle relazioni risulta riflettere più dei preconcetti che non sulle prove fornite dall’archeologia. Tra le vicende più interessanti ci sono quelle che compongono la storia sociale mesoamericana, composta da repubbliche urbane e da democrazie indigene (come l’incredibile storia di Tlaxcaca).Segue una brillante argomentazione sulle origini dello stato; o meglio: sul perché lo stato non avrebbe “un’origine”. Si tratta anche qui di un concetto recente (risalente alla fine del sedicesimo secolo), nei confronti del quale gli autori mostrano che qualsivoglia definizione si decida di adottare, si trovano innumerevoli esempi di forme di organizzazione sociale storica in grado di smentire, rendere inadeguata, o sfidare il senso di qualsivoglia particolare descrizione contemporanea di stato.
 Siamo invitati dunque a lasciar perdere gli stati-nazione attuali come categorie di cui proiettare l’immagine su società passate, per ricercare invece direttamente nella storia l’esistenza o meno di quelle che gli autori identificano come le tre forme di dominazione fondamentali: il controllo della violenza (alla base della sovranità), il controllo dell’informazione (alla base della burocrazia), e il carisma individuale (alla base della politica competitiva, ossia della “democrazia” liberale). Questi tre principi, a seconda dell’esempio storico prescelto, possono essere ipotizzati in un ordine temporale diverso, ma l’assunto teleologico criticato dagli autori è che, fondamentalmente, si dia per scontato che il risultato è e debba essere necessariamente l’unione definitiva di questi tre principi. Gli autori, attraverso una lunga analisi delle varie combinazioni possibili di tali principi che si ritrovano nella storia, dimostrano che gli attuali stati nazione sono solo una delle innumerevoli organizzazioni possibili dei vari elementi, che hanno origini proprie e assai diversificate. Così facendo, riescono a liberare il concetto di “civilizzazione” da quello di “stato”, riscoprendone il significato di “estesa comunità morale”, peraltro in gran parte fondata sul lavoro e le innovazioni delle donne (al contrario del luogo comune che lega la civilizzazione allo stato-nazione patriarcale e ai monumenti).
Siamo invitati dunque a lasciar perdere gli stati-nazione attuali come categorie di cui proiettare l’immagine su società passate, per ricercare invece direttamente nella storia l’esistenza o meno di quelle che gli autori identificano come le tre forme di dominazione fondamentali: il controllo della violenza (alla base della sovranità), il controllo dell’informazione (alla base della burocrazia), e il carisma individuale (alla base della politica competitiva, ossia della “democrazia” liberale). Questi tre principi, a seconda dell’esempio storico prescelto, possono essere ipotizzati in un ordine temporale diverso, ma l’assunto teleologico criticato dagli autori è che, fondamentalmente, si dia per scontato che il risultato è e debba essere necessariamente l’unione definitiva di questi tre principi. Gli autori, attraverso una lunga analisi delle varie combinazioni possibili di tali principi che si ritrovano nella storia, dimostrano che gli attuali stati nazione sono solo una delle innumerevoli organizzazioni possibili dei vari elementi, che hanno origini proprie e assai diversificate. Così facendo, riescono a liberare il concetto di “civilizzazione” da quello di “stato”, riscoprendone il significato di “estesa comunità morale”, peraltro in gran parte fondata sul lavoro e le innovazioni delle donne (al contrario del luogo comune che lega la civilizzazione allo stato-nazione patriarcale e ai monumenti).Infine, una volta concluso quest’avvincente viaggio attraverso la storia dell’umanità, il libro torna a mettere in luce la trappola dell’evoluzionismo, nonché ciò che ci può offrire uno sguardo nuovo nei confronti delle popolazioni nordamericane, a partire dal loro stesso pensiero politico, che sembra aver avuto un ruolo fondamentale nel dare forma alle idee più emancipatorie dell’illuminismo.
L’emancipazione e la libertà sono senza dubbio i concetti chiave del libro. Gli autori non si riferiscono alla libertà in senso astratto, o liberale, ma identificano, a partire dalla loro ricerca, tre forme concrete di libertà sociali che hanno avuto enorme peso in passato e che, nella configurazione attuale, sembrerebbe che abbiamo perso. Queste sono (1) la libertà di andarsene o trasferirsi altrove; (2) la libertà di ignorare o disobbedire gli ordini; (3) la libertà di dare forma a nuove realtà sociali, o di alternarne più d’una. Le prime due emergono come sostegno fondamentale della terza in innumerevoli casi.
Ed è proprio questa terza libertà, e la consapevolezza politica su cui si fonda, a destabilizzare le basi delle nostre concezioni mitiche. Incrociando i dati gli autori scoperchiano un’abbondanza di elementi controintuitivi: piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori estremamente gerarchici da una parte, grandi città egualitarie che praticavano l’agricoltura dall’altra, ma anche società che cambiavano organizzazione sociale a seconda delle stagioni, o regioni che vivevano lunghi periodi di libertà, seguiti da secoli gerarchici poi ribaltati da ribellioni che innescavano interi periodi di pratiche consapevolmente anti-autoritarie, o infine il fatto che tanto la schiavitù quanto la guerra stessa siano state abolite più volte, in luoghi diversi, lungo tutto il corso della storia dell’umanità.
Tra i fattori in grado di materializzare queste forme concrete di libertà ricorre quello del gioco (in particolare associato a riti, feste e carnevali), presentato come costante elemento di sperimentazione sociale o, lo definiscono gli autori, come un’enciclopedia delle possibilità sociali. Non è un caso che Graeber abbia definito altrove il giocare come la massima espressione della libertà. Ma anche alle origini dei regni, racconta il libro, c’erano forme giocose, così come si possono identificare agli inizi dell’agricoltura. Non è un caso, credo, che gli autori scrivano di aver iniziato a fare ricerca per questo libro, circa dieci anni fa, al margine delle loro principali preoccupazioni accademiche, come forma di gioco: anche il libro stesso è, in un certo senso, un’enciclopedia delle possibilità sociali.
La pubblicazione di The Dawn of Everything: A New History of Humanity (Allen Lane, 2021), nel mondo anglofono, ha avuto una certa risonanza. Immediatamente un best seller del New York Times, nonché libro dell’anno del “Sunday Times”, dell’“Observer” e di “BBC History”, è stato elogiato da innumerevoli intellettuali. Mi limito a tradurre le belle parole di James Scott: “L’Alba di Tutto merita di diventare il porto di imbarco per quasi tutti i successivi lavori su questi temi così significativi. Chi si imbarcherà avrà, nei due David, navigatori impareggiabili”. Indubbio, quest’opera non è stata e non potrà essere ignorata. È altrettanto vero, com’è ovvio, che ha suscitato reazioni di tutti i tipi. Tra le recensioni entusiaste ci sono quelle di “The Atlantic”, il “Guardian”, il “New York Times” - che si chiede “E se tutto quello che abbiamo imparato sulla storia umana fosse sbagliato?” - e “Jacobin”, dove Giulio Ongaro paragona il libro alle opere di Galileo e Darwin.
 Tra le recensioni critiche: sulla “New York Review of Books” il filosofo Kwame Anthony Appiah contesta, in modo molto dettagliato, le fonti storiche e archeologiche utilizzate (e da qui emerge un interessante scambio a partire dalle risposte di Wengrow); l’antropologo Chris Knight scrive che il libro sbaglia quasi su tutto; lo storico David A. Bell lo valuta trascurato e pieno di errori anche sul sito di “Domani”; mentre troviamo un’interessante e bilanciata recensione su “Micromega”, dove Graeber e Wengrow vengono tuttavia accusati di volontarismo. Certamente, come ha scritto lo stesso Wengrow, il libro è tutto fuorché la parola definitiva sulla storia dell’umanità (se così fosse sarebbe tutt’altro che emancipatorio) e c’è da augurarsi un ampio spettro di ricerche che investighi più a fondo le questioni poste.
Tra le recensioni critiche: sulla “New York Review of Books” il filosofo Kwame Anthony Appiah contesta, in modo molto dettagliato, le fonti storiche e archeologiche utilizzate (e da qui emerge un interessante scambio a partire dalle risposte di Wengrow); l’antropologo Chris Knight scrive che il libro sbaglia quasi su tutto; lo storico David A. Bell lo valuta trascurato e pieno di errori anche sul sito di “Domani”; mentre troviamo un’interessante e bilanciata recensione su “Micromega”, dove Graeber e Wengrow vengono tuttavia accusati di volontarismo. Certamente, come ha scritto lo stesso Wengrow, il libro è tutto fuorché la parola definitiva sulla storia dell’umanità (se così fosse sarebbe tutt’altro che emancipatorio) e c’è da augurarsi un ampio spettro di ricerche che investighi più a fondo le questioni poste.Concludo da dove ho iniziato. Quando Graeber, ai margini del corso, ci parlava del libro, raccontava divertito del titolo provvisorio che aveva in mente: “Non siamo mai stati stupidi”, in una sorta di ribaltamento del “non siamo mai stati moderni” di Latour. A me, forse, piaceva di più, e ci diceva che il “selvaggio” non era né nobile né stupido. In altre parole, è come noi tanto cognitivamente quanto intellettualmente, e non esiste un’“infanzia degli esseri umani” dove gli umani più umani di noi mostrano la vera natura umana. La vera natura umana, probabilmente, non è altro che la singolare capacità di negoziare costantemente tra le infinite alternative possibili.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- "SCIENTIFIC REPORTS": In Liguria la più antica sepoltura di una neonata (di Osvaldo Baldacci).8 gennaio 2022, di Federico La Sala
La piccola Neve, in Liguria la più antica sepoltura di una neonata
di Osvaldo Baldacci *
L’hanno chiamata Neve. È stata scoperta in Liguria la più antica sepoltura di una neonata in Europa risalente a 10.000 anni fa: si tratta di un’eccezionale testimonianza del Mesolitico e rivela una società di cacciatori-raccoglitori che teneva in particolare considerazione anche i suoi membri più giovani. Il ritrovamento è avvenuto nel sito dell’Arma Veirana, in provincia di Savona ed è oggi pubblicato su “Scientific Reports”, rivista del gruppo “Nature”.
I ritrovamenti e la più antica sepoltura di una neonata
Scavando in una grotta del comune di Erli, nell’entroterra di Albenga, un team internazionale di ricercatori ha scoperto la più antica sepoltura fino ad oggi mai documentata in Europa relativa a una neonata mesolitica. Le attività di scavo e di ricerca sono state condotte in regime di concessione da parte del Ministero dei Beni Culturali, per conto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, rilasciata al professor Fabio Negrino, in quanto coordinatore e responsabile scientifico del progetto.
Un antichissimo rito funebre per la sepoltura di una neonata
La scoperta permette di indagare un eccezionale rito funerario della prima fase del Mesolitico, di cui sono note poche sepolture, che testimonia un trattamento apparentemente egualitario di un loro giovanissimo membro. La comprensione di come i nostri antenati trattassero i loro morti ha un enorme significato culturale e consente di indagare sia i loro aspetti comportamentali sia quelli ideologici.
Esiste una buona documentazione di sepolture riferibili alla fase media del Paleolitico superiore (Gravettiano), nonché alle sue fasi terminali (Epigravettiano recente). Non frequenti sono le sepolture riferibili al Mesolitico e particolarmente rare, per tutte le epoche considerate, quelle attribuibili a soggetti infantili. La scoperta di Neve è quindi di eccezionale importanza e ci aiuterà a colmare questa lacuna, gettando luce sull’antica struttura sociale e sul comportamento funerario e rituale di questi nostri antenati.
Lo studio delle gemme dentarie
L’istologia virtuale delle gemme dentarie della neonata, realizzata presso il laboratorio di luce di sincrotrone Elettra a Trieste, ha stabilito la sua età di morte, avvenuta 40-50 giorni dopo la nascita; ha inoltre evidenziato come la madre di Neve avesse subito alcuni stress fisiologici, forse alimentari, che hanno interrotto la crescita dei denti del feto 47 e 28 giorni prima del parto. L’analisi del carbonio e dell’azoto, sempre estratto dalle gemme dentarie, ha inoltre evidenziato che la madre si nutriva seguendo una dieta a base di prodotti derivanti da risorse terrestri (come ad esempio animali cacciati), e non marine (come la pesca o la raccolta di molluschi).
Gli ornamenti
La sepoltura ha restituito, insieme ai resti del piccolo corpo, un corredo formato da oltre 60 perline in conchiglie forate (Columbella rustica), quattro ciondoli, sempre forati, ricavati da frammenti di bivalvi (Glycimeris glycimeris) e un artiglio di gufo reale. Lo studio degli ornamenti, costituiti da conchiglie cucite su di un abitino o un fagotto in pelle, ha evidenziato la particolare cura che era stata investita nella loro produzione; inoltre, diversi ornamenti mostrano un’usura che testimonia come fossero stati prima indossati per lungo tempo dai membri del gruppo e che solo successivamente fossero poi stati impiegati per adornare la veste della neonata. Neve testimonia dunque che anche le femmine più giovani erano riconosciute come persone a pieno titolo in queste antiche società.
*
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Ventiquattro matrimoni forzati in due anni. Il Viminale ha pubblicato il primo rapporto sulle donne costrette a un’unione che non vogliono (di Silvia Guzzetti)..29 giugno 2021, di Federico La Sala
Report . Ventiquattro matrimoni forzati in due anni. Un terzo ha coinvolto minorenni
Il Viminale ha pubblicato il primo rapporto sulle donne costrette a un’unione che non vogliono. Nove casi si sono verificati nei soli primi cinque mesi di quest’anno. In tante come Saman Abbas
di Silvia Guzzetti (Avvenire, lunedì 28 giugno 2021)
- [Foto] Saman Abbas la diciottenne di Novellara scomparsa dopo che i genitori volevano costringerla a un matrimonio forzato - Ansa
Quante sono le Saman in Italia? Ovvero quante ragazze sono costrette a matrimoni forzati o uccise perché non vogliono accettarli? È questa una delle domande alle quali cerca di rispondere il primo "Report sulla costrizione o induzione al matrimonio in Italia", curato dal Viminale, secondo il quale dal 9 agosto 2019 al 31 maggio 2021 sono 24 i casi di matrimoni forzati registrati nel nostro Paese, 9 dei quali nei soli primi cinque mesi di quest’anno. È proprio al 9 agosto 2019, infatti, che risale l’entrata in vigore del "Codice rosso", che ha introdotto uno specifico reato con lo scopo di contrastare proprio il fenomeno delle "spose bambine",
Dietro la definizione un po’ arida di "matrimonio precoce" come di una "unione formale nella quale viene coinvolto un minorenne, considerato forzato se quest’ultimo non è in grado di esprimere compiutamente e consapevolmente il proprio consenso non solo per le responsabilità che ci si assume con quell’atto ma anche per il fatto che la sua età le impedisce il raggiungimento della piena maturità e capacità di agire", che è contenuta nel rapporto del Viminale, vi sono anche tante storie tragiche simili a quella di Saman Abbas. La diciottenne, di origine pakistana, abitante a Novellara, è scomparsa dalla fine di aprile e gli inquirenti, che stanno indagando per omicidio e occultamento di cadavere il padre e la madre della ragazza, sospettano che sia stata la famiglia a ucciderla e farla scomparire.
LA SCOMPARSA DI SAMAN
Saman è stata vista per l’ultima volta l’11 aprile quando si è allontanta dal centro protetto nei pressi di Bologna dove viveva dallo scorso dicembre. Aveva voluto tornare a casa sua, forse per prendere alcuni documenti, e non ha più fatto ritorno. Agli assistenti sociali che la stavano seguendo e le avevano garantito un rifugio lontano dall’ambiente oppressivo della sua famiglia, aveva raccontato che i genitori volevano costringerla a un matrimonio forzato con un cugino residente in Pakistan. Papà e mamma non riuscivano a perdonare alla figlia di volersi costruire un futuro diverso che comprendesse andare a scuola, viaggiare, lavorare. Le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nei pressi dell’azienda in cui lavorava il padre della ragazza mostrano, la sera del 29 aprile, tre persone provviste di un secchio, un sacco nero per la spazzatura e una pala dirigersi verso il campo che circonda l’abitazione di Saman.
CHE COS’E’ IL MATRIMONIO FORZATO
Storie simili vengono suggerite dalle parole usate dal Report del Viminale. "Il fenomeno del matrimonio forzato ha radici storiche, culturali e talvolta religiose. L’emersione di questo reato non è facile perché spesso si consuma tra le mura domestiche e le vittime sono quasi sempre ragazze giovani, costrette ad abbandonare la scuola, talvolta obbligate a rimanere chiuse in casa nell’impossibilità di denunciare anche per paura di ritorsioni".
È sempre il Report ad ammettere che "i dati, inevitabilmente, fotografano una situazione sottodimensionata rispetto a quella reale".
Insomma le statistiche senz’altro sottostimano l’incidenza di questo reato. Il rapporto, che è stato curato dalla direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, parla di un 85% dei reati, sempre tra agosto di due anni fa e maggio scorso, riguardanti donne. In un terzo dei casi le vittime sono minorenni (il 9% hanno meno di 14 anni e il 27% hanno tra i 14 e i 17 anni). Ci sono poi le straniere, che sono il 59%, in maggioranza pachistane, seguite dalle albanesi mentre per Romania, Nigeria, Croazia, India, Polonia e Bangladesh si registra una sola vittima.
Nel 73% dei casi gli autori del reato sono stati uomini, anche in questo caso più frequentemente pachistani, seguiti da albanesi, bengalesi e bosniaci. Nel 40% dei casi i responsabili erano di età compresa tra 35 e 44 anni mentre il 27% aveva tra 45 e 54 anni. Il 15% aveva tra 25 e 34 anni.
LA PANDEMIA HA PEGGIORATO LA SITUAZIONE
Sempre il Report del Viminale getta anche uno sguardo globale su questo fenomeno, ricordando che, nel 2020, per effetto delle conseguenze economiche della pandemia, per la prima volta, dopo anni di progressi, si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei matrimoni forzati che stanno coinvolgendo molte adolescenti, soprattutto nell’Asia meridionale, nell’Africa centrale e nell’America Latina.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.
FLS
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- "PERICLE IL POPULISTA" E LA QUESTIONE OMERICA.2 febbraio 2021, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE...
- TUCIDIDE E LA GUERRA CONTRO I "POETI": "[...] non abbiamo bisogno di alcun Omero che canti la nostra gloria né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un’interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà: con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie, e ovunque abbiamo innalzato alle nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato amabilmente la morte in combattimento [...]" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 41, Bari, Laterza 1986).
PER NON CADERE (di nuovo e ancora, dopo millenni) NELLA TRAPPOLA DELLA TRACOTANZA E DELLA MALAFEDE DI "PERICLE", E NON DIMENTICARE CHE LA SUA LINEA POLITICA SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DELLA GLORIA E DEL PROGETTO POLITICO DI ATENE, forse, è opportuno - ricordando la messa al bando di Omero e dei "poeti" dalla "Repubblica" di Platone - riprendere e rivedere (non solo i lavori di Eric A. Havelock, ma anche) la brillante analisi del cosiddetto "Elogio di Atene" da parte di Umberto Eco nella sua nota sul "Pericle il populista" di ieri e di oggi (la Repubblica, 14 gennaio 2012):
- "Il discorso di Pericle (riportato da Tucidide, in Guerra del Peloponneso) è stato inteso nei secoli come un elogio della democrazia, e in prima istanza è una descrizione superba di come una nazione possa vivere garantendo la felicità dei propri concittadini, lo scambio delle idee, la libera deliberazione delle leggi, il rispetto delle arti e dell’educazione, la tensione verso l’uguaglianza. Ma che dice in realtà Pericle?";
e, al contempo, volendo, rimeditare la storica lezione di Giambattista Vico sulla questione "Omero" e riflettere sulla sua proposta di una "Scienza Nuova", al di là dell’imbalsamazione crociana.
Federico La Sala
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- ROSMINI, LE SIBILLE, E IL MESSAGGIO EVANGELICO.14 dicembre 2020, di Federico La Sala
PROFETI, SIBILLE, E MESSAGGIO EVANGELICO:
ANTONIO ROSMINI E LA "CHARITAS". Un invito a ...
Rileggere il testo della "BREVE DISSERTAZIONE DI ANTONIO ROSMINI SULLE SIBILLE" (Patricia Salomoni, "Rosmini Studies", 6, 2019). Che Rosmini abbia iniziato il suo percorso riflettendo sulle figure delle Sibille, è da considerarsi un fatto degno della massima attenzione - e, ovviamente, di ulteriore approfondimento!
La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).
Già all’inizio del suo percorso, benché partito con buona volontà e - kantianamente ("Sapere aude!") - con gran coraggio, infatti, egli s’inchina all’autorità di sant’Agostino ("De Civitate Dei", XVIII, 47) e - pur rendendosi conto con lo stesso Agostino che "qualsiasi predizione su Cristo poteva essere dichiarata falsa dagli empi e soggiacere al medesimo discredito, sia che si trattasse degli oracoli delle Sibille o delle profezie degli Ebrei" - conclude con un "non è gradito a Lui stesso che, nelle dispute, noi dedichiamo troppe energie più a quelli che a queste" e attribuisce la palma della credibilità solo a "queste .. certissime, luminosissime, custodite dal popolo ebraico a noi assai ostile, e protette da ogni corruzione con incomparabile ed encomiabile cura nel corso di molti secoli" (P. Salomoni, cit, p. 227).
A partire da "queste" premesse (promesse già non mantenute!), ovviamente, accolta solo la parola dei "profeti" non si può che rinarrare e riscrivere la vecchia "storia dell’Amore" di Adamo ed Eva:
- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.
 La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore.
La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore. - La seconda ragione dell’amore fra gli uomini è nella similitudine della natura. Il divino istitutore della natura umana e dell’amore, nel formare Eva, disse che essa doveva essere ad Adamo un aiuto simile a lui, perché «buona cosa non era che egli stesse solo» (Gn 2, 18). Dio con queste parole faceva il più bello encomio della società umana, nel seno della quale nasciamo tutti, e dalle cui materne sollecitudini siamo educati e sollevati ad una inaspettata e meravigliosa perfezione, e quasi ad una nuova e più eccellente natura. E guai all’uomo solitario che si allontana e rifiuta i benefici della società dei suoi simili, presumendo del proprio giudizio e nutrendosi del proprio affetto individuale! Egli già comincia in quell’ora medesima ad isterilire nei suoi ragionamenti e nei suoi affetti. E appena si potrebbe chiamare ancora uomo, se troppo a lungo tenesse le orecchie chiuse alle amorevoli, alle sagge voci dei suoi simili. Perché i germi di bene più preziosi o starebbero in lui come non fossero, o tralignando porterebbero dei frutti inutili e tristi. Per cui veramente, come dice la Bibbia, «non è bene all’uomo starsene solo [...]».
- La terza ragione assegnata all’amore fu la felicità degli uomini. Gli uomini dovevano trarre vantaggio inestimabile dalla scambievole amicizia. Perciò Eva è nominata da Dio “un aiuto di Adamo”. Essa era aiuto al solitario Adamo allo scopo di rendergli piacevole la vita e permettergli di diffondere e comunicare in lei se stesso. Perché l’umano sentimento, l’uomo stesso, come il bene, cerca di essere diffusivo ed espansivo. Da qui ha origine la dottrina apostolica, che descrive l’uomo quale «immagine e gloria di Dio” e la donna quale “gloria dell’uomo [...]».
- Da tutte queste cose si può pertanto concludere, che nella sacra società coniugale, stabilita da Dio a principio fra gli uomini innocenti e felici, ebbero loro capo e inizio tutte le specie dei legittimi amori. Da lì nasceva l’amore naturale nelle famiglie, da lì l’amore di elezione nelle amicizie, da lì l’amore di vantaggio nell’umano commercio. E come da Dio partivano, così in Dio finivano ugualmente tutti questi affetti, temperati in un unico e sublimissimo affetto (Antonio Rosmini, La storia dell’Amore, "Charitas", 5, maggio 2016, pp. 111-112).
E così, contravvenendo frettolosamente alle regole morali del suo stesso "metodo filosofico", il suo desiderio di lasciarsi guidare "in tutti i suoi passi dall’amore della verità", come dalla carità ("charitas") piena di grazia (charis), resta confinato nell’orizzonte della caduta e della minorità - e la presenza delle Sibille insieme ai Profeti nella Volta della Cappella Sistina è ancora un grosso problema!
Federico La Sala
- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- FRATELLI TUTTI?! "Quel ’Fratelli’ (senza sorelle) non si può usare nel 2020 (di Luigino Bruni).)22 settembre 2020, di Federico La Sala
Caro Papa Francesco.
Finché è ancora in tempo, per favore cambi il titolo della nuova encliclica. *
Quel ’Fratelli’ (senza sorelle) non si può usare nel 2020.
Lei ci ha insegnato il peso delle parole.
Il titolo si mangerà il contenuto.
L’altro nome di Francesco è Chiara.
(Luigino Bruni - Twitter, 23 settembre 2020).
*
- Fratelli tutti è la terza enciclica di papa Francesco scritta nel suo ottavo anno di pontificato. Annunciata dalla Sala stampa vaticana il 5 settembre 2020[1], verrà firmata dal Papa il 3 ottobre 2020, in occasione della visita al santuario di Assisi e porterà la data del 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda san Francesco d’Assisi[2]. Il nucleo tematico è rappresentato dalla fraternità e dalla amicizia sociale, a partire da riflessioni circa la pandemia da COVID-19 del 2020. (Wikipedia - ripresa parziale.)
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- FRATELLI TUTTI?! - L’età della Controriforma: "con il dolore delle donne il mercato divenne divino" (di Luigino Bruni).13 luglio 2021, par Federico La Sala
L’analisi.
E con il dolore delle donne il mercato divenne divino
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 13 marzo 2021)
L’età della Controriforma fu un tempo decisivo per la cultura economica e sociale dell’Italia e degli altri Paesi dell’Europa meridiana. Qualcosa si interruppe nell’evoluzione dell’etica della mercatura che aveva fatto di Firenze, Venezia o Avignone luoghi straordinari di ricchezza economica e civile. Tra i molti volti dell’età moderna c’è anche quello delle donne, in particolare quello della vita monastica femminile, poco noto perché nascosto e persino occultato. Il Concilio di Trento aveva reintrodotto la clausura strettissima per le monache. I vescovi e le congregazioni romane inasprirono controlli e norme sui monasteri femminili. Di fronte a una Chiesa riformata che annunciava la salvezza per sola grazia, che criticò la vita consacrata fino ad abolirla, che aveva molto ridimensionato il ruolo dei sacramenti, confutato radicalmente la teologia dei meriti e quindi delle indulgenze, e abolito il Purgatorio..., la chiesa di Roma rilanciò con forza l’importanza delle opere dell’uomo per la salvezza, moltiplicò gli istituti di vita consacrata, rafforzò la pastorale dei sacramenti incluso quello della confessione, rimise al centro il merito, le indulgenze e il Purgatorio.
In questa grande battaglia teologica le prime e più numerose vittime furono, anche qui, le donne, soprattutto quelle recluse nei monasteri e nei conventi. Un movimento enorme, se pensiamo che tra coriste, converse e terzi ordini in alcune regioni italiane le monache raggiungevano nel Seicento anche il 10-15% della popolazione femminile "adulta" (cioè, allora, con più di dodici anni). Quindi capire un po’ la vita di queste donne significa comprendere di più la storia dell’Europa e anche il nostro presente.
 Ma perché esisterebbe un rapporto tra la vita dei monasteri femminili e l’economia? Il primo pensiero va all’ora et labora, ma non è quello più interessante e giusto, perché dove la logica economica è entrata pesantemente nella vita delle monache, è, paradossalmente, nella spiritualità, nell’ascetica e nella mistica. Già il Medioevo aveva prodotto una sua "religione economica". Le penitenze tariffate dei monaci, dove a ogni peccato corrispondeva una pena con relativa tariffa, dopo il XIII secolo divennero commerciabili come una sorta di merce. La penitenza venne oggettivizzata e separata dal peccatore, e così una colpa poteva essere pagata da una persona diversa dal colpevole. Da qui tutto il commercio di preghiere, pellegrinaggi, fino al famoso mercato delle indulgenze.
Ma perché esisterebbe un rapporto tra la vita dei monasteri femminili e l’economia? Il primo pensiero va all’ora et labora, ma non è quello più interessante e giusto, perché dove la logica economica è entrata pesantemente nella vita delle monache, è, paradossalmente, nella spiritualità, nell’ascetica e nella mistica. Già il Medioevo aveva prodotto una sua "religione economica". Le penitenze tariffate dei monaci, dove a ogni peccato corrispondeva una pena con relativa tariffa, dopo il XIII secolo divennero commerciabili come una sorta di merce. La penitenza venne oggettivizzata e separata dal peccatore, e così una colpa poteva essere pagata da una persona diversa dal colpevole. Da qui tutto il commercio di preghiere, pellegrinaggi, fino al famoso mercato delle indulgenze.La Controriforma conobbe una forte ripresa della dimensione economico-retributiva del cattolicesimo, sebbene con importanti novità. Una riguarda direttamente le donne. Mentre, infatti, nel Medioevo gli attori del commercio religioso erano quasi esclusivamente maschi, nella prima età moderna sono le donne le prime operatrici di questa strana versione della religione cattolica. Le principali piazze di queste originali Borse valori erano i monasteri e i conventi, soprattutto quelli femminili. E il capitalismo latino divenne divino. Vediamo come.
 Tutto ruota attorno a una particolare (e stravagante) interpretazione del significato e dell’uso del dolore umano, letto in rapporto al dolore di Cristo. Sappiamo che nel Nuovo Testamento esiste una tradizione che aveva letto la passione e la morte di Gesù come pagamento di un prezzo al Padre per lucrare il perdono dei nostri peccati. Questa idea di un Dio-Padre che per essere "soddisfatto" ebbe bisogno del sangue del suo Figlio (perché solo un prezzo dal valore infinito poteva estinguere un debito infinito), ha attraversato il primo millennio e fu sistematizzata da sant’Anselmo d’Aosta.
Tutto ruota attorno a una particolare (e stravagante) interpretazione del significato e dell’uso del dolore umano, letto in rapporto al dolore di Cristo. Sappiamo che nel Nuovo Testamento esiste una tradizione che aveva letto la passione e la morte di Gesù come pagamento di un prezzo al Padre per lucrare il perdono dei nostri peccati. Questa idea di un Dio-Padre che per essere "soddisfatto" ebbe bisogno del sangue del suo Figlio (perché solo un prezzo dal valore infinito poteva estinguere un debito infinito), ha attraversato il primo millennio e fu sistematizzata da sant’Anselmo d’Aosta.Ma era rimasta una faccenda per teologi, fino a quando con la Controriforma divenne nei monasteri qualcosa di spettacolare e di impensato, una colonna dell’età barocca. L’antica teologia dell’espiazione si trasformò in una vera e propria cultura dell’espiazione, che pervadeva le pratiche religiose e la pietà popolare. Il dolore umano divenne così la principale moneta per pagare i debiti/colpe propri e di altri.
 Ciò che nel Medioevo era il commercio delle indulgenze e dei pellegrinaggi, nell’età della Controriforma divenne il commercio del dolore, sotto forma di penitenze, umiliazioni, mortificazioni. Un dolore principalmente femminile. Il linguaggio dei Manuali per confessori, che esplodono in questo tempo, rivela questa svolta: "opere penali", "opere soddisfattorie", "riparazione", "anime-vittime". Il confessionale divenne il principale meccanismo di trasmissione di questo commercio del dolore.
Ciò che nel Medioevo era il commercio delle indulgenze e dei pellegrinaggi, nell’età della Controriforma divenne il commercio del dolore, sotto forma di penitenze, umiliazioni, mortificazioni. Un dolore principalmente femminile. Il linguaggio dei Manuali per confessori, che esplodono in questo tempo, rivela questa svolta: "opere penali", "opere soddisfattorie", "riparazione", "anime-vittime". Il confessionale divenne il principale meccanismo di trasmissione di questo commercio del dolore.Su tutto spicca un’espressione: sofferenza vicaria. Si inizia cioè a pensare (e agire) che si potesse soffrire a vantaggio di altri, che qualcuno potesse pagare in proprio per espiare colpe altrui, ancora vivo o in Purgatorio. Sulla base di alcune citazioni della scrittura (ad esempio, della lettera deutero-paolina ai Colossesi: "completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo": Col 1,24) e un uso originale della categoria di Chiesa come "corpo mistico" (dove ciò che accade in un membro si ripercuote su tutti gli altri), si creò un immenso mercato del dolore e delle sofferenze. E così mentre l’Europa del Nord sviluppava i mercati "reali", nel Sud le categorie economiche venivano applicate alla religione e alle donne. Un ingrediente di questo originalissimo sistema di scambi era il cosiddetto "Tesoro dei meriti" di Cristo e Maria, meriti talmente grandi da superare il debito dei peccati umani; così la Chiesa poteva "vendere" la parte eccedente di quel tesoro per rimettere altri debiti di peccatori, tramite le indulgenze. Ma il colpo di genio teologico fu pensare che le penitenze e l’offerta delle sofferenze umane potessero aumentare il Tesoro e quindi la sua parte eccedente disponibile per i peccatori vivi e ancor più per quelli in Purgatorio: «Dio vuol che ’l debito si paghi» (Divina Commedia, Pg X,108). Ecco allora che i monasteri femminili si trasformarono in "centrali di produzione" di questa ricchezza spirituale: con il loro dolore dovevano incrementare il Tesoro. Come amava dire Veronica Giuliani: «Tante anime vanno all’inferno perché non c’è chi fa sacrifici per loro».
Da qui la proliferazione nei monasteri femminili di penitenze sempre più estreme, spesso ordinate dai confessori grazie al loro enorme potere sulle monache. Il sistema raggiungeva però la sua perfezione quando le monache interiorizzavano il valore del loro dolore e quindi si auto-infliggevano mortificazioni, umiliazioni, procurandosi in perfetta buona fede ogni sorta di dolore al fine di salvare se stesse e soprattutto gli altri. Un equilibrio perfetto: le monache attribuivano un senso e un valore al loro essere "vittime recluse" poiché leggevano il proprio sacrificio come offerta gradita a Dio e agli uomini; la Chiesa e la società attribuivano un valore sociale e religioso a quelle esistenze rinchiuse, ma "produttive". Impressionanti sono le biografie o auto-biografie di monache: «Il confessore convenne che due ore di sonno per notte, con un lenzuolo lacero come unica coperta, sarebbero state sufficienti. Dandole un nuovo cilicio munito di più di cinquecento aculei e una frusta con la punta di ferro, e non fece obiezione al fatto che Maria Maddalena portasse catene seghettate alle braccia e alle gambe» (Anne J. Schutte, "Orride e strane penitenze", pp. 159; 266).
 In un’altra biografia: «Una simile risposta ebbe da Dio quando, durante una notte di Natale, sr. Margerita chiese di essere ammessa tra il bue e l’asinello per adorare il Bambino Gesù: Nel presepe non c’è posto per te, perché gli animali al tuo confronto hanno maggiori e più meritorie qualità» (Mariano Armellini, "Margherita Corradi monaca benedettina" (1570-1665), 1733). E nella celebre storia di suor Maria Crocifissa: «Prima di pranzo, stando le sorelle in refettorio sono andata a guisa di Bestia, cioè incatenata a quattro piedi, baciando i piedi alle sorelle» (Francesco Ramirez, 1709).
In un’altra biografia: «Una simile risposta ebbe da Dio quando, durante una notte di Natale, sr. Margerita chiese di essere ammessa tra il bue e l’asinello per adorare il Bambino Gesù: Nel presepe non c’è posto per te, perché gli animali al tuo confronto hanno maggiori e più meritorie qualità» (Mariano Armellini, "Margherita Corradi monaca benedettina" (1570-1665), 1733). E nella celebre storia di suor Maria Crocifissa: «Prima di pranzo, stando le sorelle in refettorio sono andata a guisa di Bestia, cioè incatenata a quattro piedi, baciando i piedi alle sorelle» (Francesco Ramirez, 1709).Altra fonte essenziale sono i libri spirituali per monache: «Subito che vi risvegliate figuratevi d’esser un reo incatenato, e condotto al tribunale per essere giudicato, o come un lebbroso, carico tutto di piaghe; e con questi o altri simili pensieri, andatevi vestendo» (Giovanni Pietro Pinamonti, "La religiosa in solitudine", 1697, p. 31). E in un Manuale per confessori molto diffuso, quello settecentesco di Alfonso Maria de’ Liguori, si legge: «La penitenza poi non solo deve essere medicinale per rimedio della vita futura, ma anche penale e vendicativa per la vita passata. Le penitenze generalmente utili a tutti sono l’entrare in qualche congregazione» (Alfonso M. de’ Liguori, "Il sacerdote provveduto", p. 240).
 Entrare in congregazione visto dunque come forma di penitenza utile a tutti. Queste idee e pratiche sono durate secoli, in molti casi fino al Concilio Vaticano II. Ancora in un testo del secolo scorso leggiamo: «Nel convento delle Domenicane di Vercelli, v’era fra le altre una regola che vietava di bere fra un pasto e l’altro senza permesso della superiora, la quale però lo concedeva rarissimamente, eccitando le consorelle a questo piccolo sacrificio in memoria della sete che Gesù patì sul Calvario» (Luigi Carnino, "Il purgatorio nella rivelazione dei Santi", cap. 17, 1946). Non è stato per me affatto facile pensare e scrivere questo articolo. L’ho scritto con lo spirito con cui si scrive una lapide, una stele in memoria di quelle donne-vittime quasi sempre ignote. Per soffermarsi davanti ad esse, riflettere, piangere. Scrivere, poi, anche per chiedere loro scusa a distanza di secoli - scuse vicarie che faccio da uomo per conto di altri uomini del passato.
Entrare in congregazione visto dunque come forma di penitenza utile a tutti. Queste idee e pratiche sono durate secoli, in molti casi fino al Concilio Vaticano II. Ancora in un testo del secolo scorso leggiamo: «Nel convento delle Domenicane di Vercelli, v’era fra le altre una regola che vietava di bere fra un pasto e l’altro senza permesso della superiora, la quale però lo concedeva rarissimamente, eccitando le consorelle a questo piccolo sacrificio in memoria della sete che Gesù patì sul Calvario» (Luigi Carnino, "Il purgatorio nella rivelazione dei Santi", cap. 17, 1946). Non è stato per me affatto facile pensare e scrivere questo articolo. L’ho scritto con lo spirito con cui si scrive una lapide, una stele in memoria di quelle donne-vittime quasi sempre ignote. Per soffermarsi davanti ad esse, riflettere, piangere. Scrivere, poi, anche per chiedere loro scusa a distanza di secoli - scuse vicarie che faccio da uomo per conto di altri uomini del passato.Il dolore umano può avere un senso. Forse alcune o molte di queste monache furono più grandi del loro destino e delle teologie sbagliate e violente verso il corpo delle donne. Forse. Ma prima Giobbe e poi i Vangeli ci avevano detto che solo gli idoli gradiscono il sangue dei loro fedeli. Il Dio biblico è diverso. Solo una visione sbagliata degli uomini e soprattutto delle donne può pensare di usare la loro sofferenza come moneta gradita a un qualche Dio. Un’ultima nota.
Tutto questo commercio di sangue e di dolore femminile era totalmente gratuito. La Chiesa nei suoi uomini vendeva le indulgenze e chiedeva ai laici elemosine per compensare i peccati: «La regola è: per i peccati di avarizia, limosine» (Alfonso M. de’ Liguori, cit.). Il commercio religioso che avveniva sul corpo delle donne era invece tutto dono, e quindi gratis. La donna come icona del sacrificio gratuito, per proteggerla dal commercio mercenario. Sono passati decenni, secoli. Le monache e le suore che oggi entrano nei monasteri e nei conventi sono molto diverse, e spesso neanche conoscono queste storie. Quelle antiche penitenze sono state eliminate dal Concilio Vaticano II, anche se radicata in tanti cristiani è ancora l’idea teologica che il nostro dolore possa essere una "moneta" che il Dio-creditore degli uomini accetta volentieri, che quindi Dio gradisca il dolore dei suoi figli, facendolo così diventare peggiore di noi. Ma nella vita civile ed economica le donne continuano ancora troppo a praticare espiazioni vicarie, a pagare nella loro carne per le famiglie e per la società, e il loro lavoro non riconosciuto e svalutato, e non di rado in nome del dono. Donne molto lontane e diverse, sofferenze ancora troppo simili.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- A TROIA FU GUERRA CIVILE. Un’ipotesi diventa certezza.2 luglio 2020, di Federico La Sala
CULTURA
A Troia fu guerra civile: Godart riscrive leggenda omerica
(di Paolo Martini) *
Dagli ultimi scavi sulla collina di Hissarlik, in Turchia, un’ipotesi diventa certezza: a Troia non furono due popolazioni diverse a scontrarsi, molto più semplicemente fu una ’guerra civile’. Gli Achei venuti dalla Grecia combatterono contro gli Achei che si erano già insediati in città. Lo sostiene uno dei massimi studiosi delle civiltà egee, il professore Louis Godart, in un articolo che esce sul nuovo numero della rivista "Archeologia Viva" (Giunti Editore).
"Greci e Troiani parlavano la stessa lingua, avevano le stesse credenze, stessi usi e costumi, stesso tipo di armamento. Omero lo dice chiaramente nella sua Iliade. Oggi la conferma arriva dall’archeologia che aiuta a riscrivere un’intera pagina di storia, decisamente la più nota e popolare": così sintetizza la scoperta lo storico e archeologo Louis Godart, che ha insegnato Civiltà egee all’Università ’Federico II’ di Napoli ed è stato consigliere per la conservazione del patrimonio artistico presso la Presidenza della Repubblica italiana ed è membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Institut de France e dell’Accademia di Atene.
"Le ricerche condotte a Troia dalla missione archeologica dell’Università tedesca di Tubinga abbinate a una riflessione sullo studio dei testi delle tavolette in lineare B scritte nel dialetto acheo dei Greci micenei - dichiara Godart - cambiano radicalmente le nostre prospettive sulla storia dell’Anatolia nord-occidentale e dell’Egeo alla fine del II millennio, in particolare tra il 1200 e il 1180 a.C.".
È a questo periodo che risale la cosiddetta Troia VIi (secondo le numerazione che gli archeologi hanno dato ai vari strati della lunga vita della città), in quel momento la città più importante dell’Anatolia e del Vicino Oriente, dove la gente si rifugiò all’interno delle mura sistemando nel suolo grandi vasi per lo stoccaggio di derrate alimentari (rinvenute dagli archeologi) per poter sostenere il lungo assedio che poi si concluse con la caduta della città, come lasciano intendere i resti umani e le tracce dei combattimenti rinvenuti nello strato di distruzione dell’insediamento.
Achei e Troiani, due facce dello stesso popolo. In Omero Achei e Troiani non sono mai differenziati in modo netto. Secondo l’Iliade, i due popoli pregavano gli stessi dèi, ai quali tributavano gli stessi sacrifici. Parlavano la stessa lingua e i troiani avevano nomi greci. Non vi sono mai problemi di comunicazione tra Achei e Troiani e anche il nome Ettore non era un nome barbaro per i greci, spiega sempre Godart. Vi era un culto di Ettore a Tebe; a Taso, isola vicina alla costa della Tracia, una divisione della città portava il nome di Priamides. In una serie di tavolette in lineare B (la scrittura dei Micenei) di Pilo, è stato identificato l’antroponimo ’e-ko-to’ che corrisponde al greco ’Hector’, mentre in un altro testo rinvenuto sempre nel palazzo di Nestore, c’era il patronimico ’e-ko-to-ri-jo’, ’Hectorio’s, ’figlio di Ettore’.
"Il nome Ettore è quindi un nome acheo, anche se nell’Iliade indica il grande campione troiano - illustra sempre Godart - Poiché i nomi degli eroi troiani sono greci, Omero, facendo parlare una stessa lingua agli Achei e ai Troiani, non fa altro che rispecchiare la situazione che vigeva sull’acropoli di Troia alla fine del XIII secolo a.C.".
"Sarei assolutamente propenso, come sostengo nel mio articolo su ’Archeologia Viva’ e nel mio libro ’Da Minosse a Omero’ (Einaudi) - spiega Godart - a ritenere che sia stata un’aristocrazia micenea a comandare a Troia nella fase VII che ispirò Omero. L’abbondante ceramica micenea rinvenuta sul sito di Troia negli strati del XIII secolo a.C. conforta indubbiamente una simile ipotesi. Se è davvero così e se Priamo era un re acheo, dovremmo ritenere che la guerra di Troia cantata da Omero sia stata una guerra civile in cui implacabilmente si opposero gli Achei del continente, delle isole e di Creta a altri Achei".
Louis Godart è autore di importanti pubblicazioni presso Einaudi: "Il disco di Festo. L’enigma della scrittura", "L’invenzione della scrittura", "L’oro di Troia. La vera storia del tesoro scoperto da Schliemann" (con Gianni Cervetti), e il recente "Da Minosse a Omero. Genesi della prima civiltà europea".
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- È la legge del desiderio a farci amare la creatività (di Elio Franzini)6 ottobre 2018, di Federico La Sala
È la legge del desiderio a farci amare la creatività
Non è solo una forza oscura, vuota: ha a che fare sempre con la materia, con il costruire. Elogio di una pulsione che va ben al di là di fisiologia e psicologia
di Elio Franzini (la Repubblica, 05.10.2018) *
 Rettore dell’università Statale di Milano
Rettore dell’università Statale di MilanoPensare al problema del desiderio ha significato, per molti anni, aderire a una sorta di prospettiva che genericamente potremmo chiamare " postmoderna", che scioglieva il desiderare nell’inconscio, o in macchine desideranti, " indebolendola" nelle pulsioni dell’Es. Non si può infatti dimenticare che, per un autore come Lyotard, sin dagli anni Settanta del Novecento, il desiderio si pone sul piano di una decostruzione come strada per distruggere la metafisica occidentale, annullandone le categorie e riportandole a pulsioni originarie. Questa strada è stata variamente percorsa da molti autori, con volumi di grande successo (si pensi a "L’anti- Edipo" di Deleuze e Guattari).
Strada lecita, senza dubbio, ma che forse non riesce a far comprendere non solo la ricca fenomenologia del desiderio, ma neppure l’ambiguità del suo ruolo multiforme nella formazione del soggetto e nella storia del pensiero stesso.
"Romanae Disputationes", l’ormai noto certamen filosofico che ogni anno raccoglie migliaia di studenti delle scuole superiori italiane, aiuterà certo ad ampliare questo concetto, rendendo possibili nuovi percorsi, che mostrino le possibilità formative del desiderio.
Il desiderio deve infatti essere guardato anche, se non soprattutto, al di fuori di uno schema psicologico, vedendolo connesso a un percorso di costruzione del senso. Il desiderio è creativo e, come dimostra la pratica dell’arte, ha una funzione formativa: è grazie al desiderio, a questo fondo oscuro, al suo lavoro nei processi costruttivi come in quelli ricettivi, che l’opera appare come una realtà "infinita", ovvero mai pacificata, che non possiamo ridurre a una sorta di ambigua sublimazione estetica.
In altri termini, il desiderio, in sé indefinibile per la varietà di significati che assume nei suoi vari campi di azione, può venir visto come ciò che tiene viva, nel processo e nel progetto dell’arte, la forza formativa, un senso sensibile e, per così dire, " mitico" e originario.
Il desiderio non può allora essere " spiegato", definito, ridotto a una sequenza lineare, clinica, sintomale. Ridurre questo percorso a economie libidinali non permette di comprendere che il desiderare è connesso a un piacere non riducibile alla fisiologia o alla psicologia. Il desiderio non è un impulso vuoto, meramente fantastico, ma si confronta sempre con la materia, con il costruire.
Tende a riempire di contenuti radicati nel mondo stesso la forza produttiva dell’immaginazione. L’energia che circola nello psichico è senza dubbio un’azione desiderativa: ma le sue manifestazioni non possono rimanere isolate nel vuoto di una perdita, nell’impersonalità, nell’Es.
La costruzione artistica come emblema di un percorso formativo mostra invece il desiderio in un’opera concreta, che si confronta con il mondo, la società, la cultura, la storia.
Desiderio di costruire qualcosa che rimanga, e che generi nuovi processi desiderativi, in questo modo liberandosi da un soggettivismo relativistico e affidandosi a un dialogo costruttivo che comporta il gesto di un soggetto costruttore.
Il desiderio, per concludere, è lo sfondo, che mai potrà essere rinchiuso in una sola prospettiva, di una possibilità costruttiva e progettuale capace di cogliere, nel mondo che ci circonda, una serie di trame che sono già nelle cose e che il desiderio porta in luce, mostrando sempre di nuovo la profondità e l’intensità della vita.
- "Un extrême désir (Cartesio, Discorso sul metodo) - Natura e possibilità del desiderio" è il titolo della VI edizione di Romanae Disputationes, concorso nazionale di filosofia per le scuole superiori. Il progetto, riconosciuto dal Miur, coinvolge 4mila studenti di tutta Italia accompagnati dai loro docenti e intende risvegliare l’interesse alla filosofia e riflettere su un tema di rilevanza culturale e sociale, col contributo di partner come il Museo nazionale del cinema di Torino e la Cineteca di Bologna. I team di studenti si sfideranno nelle categorie "scritto", "video" e "dibattiti filosofici". Appuntamento il prossimo 26 ottobre per la lectio di Massimo Recalcati sul tema del desiderio (Auditorium Testori, Milano). Per informazioni: www. romanaedisputationes. com
* https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/10/05/news/franzini_desiderio-208274414/
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA POTENZA DEL DESIDERIO E IL PROBLEMA DI DIO. UNA IMPOSTAZIONE ALL’ALTEZZA DI NEWTON E KANT, CHE SI SPINGE IN UN’ORIZZONTE CHE VA OLTRE FREUD E LACAN ...
 GIAMBATTISTA VICO: LA LIBERTA’, LA PROVVIDENZA, E LA TEOLOGIA DELL’UMANITA’ "TUTTA DISPIEGATA":
GIAMBATTISTA VICO: LA LIBERTA’, LA PROVVIDENZA, E LA TEOLOGIA DELL’UMANITA’ "TUTTA DISPIEGATA":
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5609
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5609FILOSOFIA. Il desiderio del desiderio, il desiderio antropògeno di riconoscimento, l’antropologia e la FENOMENOLOGIA ....
 DELLO SPIRITO DI ALEXANDRE KOJÈVE: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3231
DELLO SPIRITO DI ALEXANDRE KOJÈVE: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3231FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829
Federico La Sala
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- La lezione di Omero sulla capacità di autodeterminazione (di Eva Cantarella)24 giugno 2018, di Federico La Sala
La lezione di Omero sulla capacità di autodeterminazione
Tra libertà dagli dèi e volontà umana
di Eva Cantarella (Il Sole-24 Ore, Domenica, 24.06.2018)
Potrà sembrare singolare che per parlare del potere della libertà ci si rivolga a Omero, tornando indietro di alcuni millenni. Ma per rendersi conto di quale sia la rilevanza di quel potere nelle nostre vite è necessario tornare col pensiero al momento in cui la libertà nacque. E l’unica possibilità per farlo è rivolgersi ai poemi omerici, che documentano quando e come, nella cultura occidentale, quel momento si verificò. Ma prima di farlo si impone una premessa.
Che Omero sia storicamente attendibile è cosa già implicita in quanto scriveva Giovan Battista Vico nella Scienza nuova, definendolo «il primo storico della gentilità», e che è oggi comunemente riconosciuta. Beninteso, intendendo per storia non quella degli avvenimenti, ma quella dell’intero patrimonio culturale di un popolo: nella specie, della Grecia arcaica.
 Come è ben noto, infatti, nei 26mila versi di cui Iliade e Odissea si compongono sono confluiti i canti orali con i quali i famosi aedi o rapsodi intrattenevano il pubblico nei secoli in cui la Grecia era ancora totalmente preletterata, e come tutte le culture di quel tipo disponeva di un solo strumento per comunicare e trasmettere la sua cultura di generazione in generazione, vale a dire i poeti: gli aedi e i rapsodi. E questo fa sì che grazie all’Iliade e all’Odissea sia possibile ricostruire il processo che portò i greci alla scoperta della prima fondamentale libertà dell’essere umano: quella dagli dèi e dal fato. Cosa che accadde partendo da un momento nel quale essi davano per scontato che tutto quel che accadeva fosse determinato dagli dèi.
Come è ben noto, infatti, nei 26mila versi di cui Iliade e Odissea si compongono sono confluiti i canti orali con i quali i famosi aedi o rapsodi intrattenevano il pubblico nei secoli in cui la Grecia era ancora totalmente preletterata, e come tutte le culture di quel tipo disponeva di un solo strumento per comunicare e trasmettere la sua cultura di generazione in generazione, vale a dire i poeti: gli aedi e i rapsodi. E questo fa sì che grazie all’Iliade e all’Odissea sia possibile ricostruire il processo che portò i greci alla scoperta della prima fondamentale libertà dell’essere umano: quella dagli dèi e dal fato. Cosa che accadde partendo da un momento nel quale essi davano per scontato che tutto quel che accadeva fosse determinato dagli dèi.A ben vedere, infatti, tanto nell’Iliade quanto nell’Odissea si svolgono parallelamente due azioni: una nel mondo dei mortali e una nel mondo degli dèi, e a decidere quel che accade, in cielo e in terra, sono sempre e solamente gli dèi: come Apollo, che aveva mandato la peste con cui ha inizio l’Iliade; o come Zeus, che aveva mandato ad Agamennone un segno ingannevole per promettergli la vittoria e indurlo alla battaglia.
Ma se questo è il punto di partenza, ci sono nei poemi dei passaggi che segnalano lo slittamento verso l’idea che anche la volontà umana ha un ruolo nel determinare gli eventi: parlando del viaggio nel corso del quale Telemaco spera di avere da Nestore notizie del padre, Atena lo incoraggia dicendogli che i numi gli suggeriranno come comportarsi, ma qualcosa «penserai tu nel tuo animo» (Od., 3, 26 27). E quando grazie allo stratagemma del cavallo i Greci riescono a entrare a Troia, Elena è felice, e se ne rallegra perché, come dice, «l’animo s’era già volto a tornare indietro, in patria, e piangevo la colpa che Afrodite mi spinse a commettere...»(Od., 4, 260 264). Se non la fuga a Troia, la decisione di tornare dal marito dunque è sua, ed Elena la rivendica come tale.
 E ci sono anche passaggi nei quali l’umanità appare totalmente libera e capace di determinarsi, come quello nel quale Zeus rimprovera agli uomini di incolpare ingiustamente le divinità dei loro dolori. In realtà questi sono causati dai loro «folli delitti», tra i quali il dio cita quello di Egisto, l’amante di Clitennestra, che insieme a questa aveva ucciso Agamennone al ritorno dalla guerra di Troia. Gli dei, in quell’occasione, avevano mandato Ermes, il loro messaggero, a dirgli di non farlo. Ma Egisto non lo aveva ascoltato e aveva agito contro la moira, vale a dire contro il destino superiore, al quale l’uomo non doveva sottrarsi (Od., 1, 32 34.).
E ci sono anche passaggi nei quali l’umanità appare totalmente libera e capace di determinarsi, come quello nel quale Zeus rimprovera agli uomini di incolpare ingiustamente le divinità dei loro dolori. In realtà questi sono causati dai loro «folli delitti», tra i quali il dio cita quello di Egisto, l’amante di Clitennestra, che insieme a questa aveva ucciso Agamennone al ritorno dalla guerra di Troia. Gli dei, in quell’occasione, avevano mandato Ermes, il loro messaggero, a dirgli di non farlo. Ma Egisto non lo aveva ascoltato e aveva agito contro la moira, vale a dire contro il destino superiore, al quale l’uomo non doveva sottrarsi (Od., 1, 32 34.).E per finire ci sono casi nei quali gli uomini sono capaci non solo di autodeterminarsi, ma anche di autocontrollarsi, come più di una volta riesce a fare Ulisse: una prima volta quando, chiuso nell’antro del Ciclope che aveva appena divorato due dei suoi compagni, avrebbe voluto d’impulso uccidere il mostro, ma lo aveva trattenuto il pensiero che se lo avesse fatto sarebbe sicuramente morto. Mai e poi mai lui e i compagni avrebbero avuto la forza di spostare la roccia con la quale il Ciclope, da lui accecato, aveva chiuso l’imboccatura del suo antro (Od., IX, 299-300). E poi, ancora, quando, tornato a Itaca ed entrato nella sua reggia in veste di mendicante, aveva scoperto che alcune delle sue ancelle lo avevano tradito, passando dalla parte dei proci. Anche in quel caso era stato tentato di reagire immediatamente, uccidendole, ma era riuscito a contenersi ricordando che, dopo aver subito oltraggi ancora peggiori dal Ciclope, si era salvato trattenendo i suoi impulsi e aspettando il momento in cui avrebbe potuto farlo grazie alla sua astuzia (Od., 20,10-23).
Questi episodi rappresentano il variare della percezione di sé dei greci: il primo passo della strada che li avrebbe condotti alla nascita della distinzione tra atti volontari e involontari e all’inizio della individuazione di alcune delle cause della involontarietà, quali la volontà degli dèi, la necessaria obbedienza a un ordine superiore, divino o umano, e la necessità determinata da una violenza fisica o psichica. E sulla base di questa distinzione si era affermato il principio che era colpevole solo chi aveva agito volontariamente, e che si rispondeva solo di quegli atti, come dimostra il comportamento di Ulisse quando, dopo aver sterminato i proci, punisce i suoi dipendenti infedeli. -Ma solo quelli che hanno agito volontariamente: e quindi risparmia Femio, l’aedo che ha cantato per i proci, ma contro la sua volontà: come conferma Telemaco, era stato costretto a farlo dal loro numero e dalla loro tracotanza. Grazie alla conquista e alla consapevolezza della propria libertà dagli dèi e dal fato i greci avevano elaborato il principio della responsabilità morale e i concetti etici e giuridici tut tora a fondamento della nostra civiltà.
* Questo testo è tratto dalla lezione di Storia che l’autrice terrà a Milano a Santa Maria delle Grazie il 27 giugno alle 21, nell’ambito del progetto ideato da Laterza e dedicato al «Potere degli antichi»
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- IL RAZZISMO E LA LEZIONE DI VICO (di Liliana Segre).5 maggio 2018, di Federico La Sala
IL RAZZISMO E LA LEZIONE DI VICO
Una commissione contro il razzismo
di Liliana Segre (la Repubblica, 05.05.2018)
Cari ragazzi e ragazze della Nuova Europa, ci sono molti modi per impegnarsi, efficacemente, nella materia, enorme e delicata, della discriminazione, ed io non cerco scorciatoie. Per dirla con parole antiche (Giambattista Vico) i rischi di una deriva autoritaria sono sempre dietro l’angolo. Lui, l’autore dei corsi e ricorsi storici, aveva visto lungo. Arrivo subito al punto consegnando a voi, che siete su un’isola, un “messaggio in bottiglia”: il mio primo atto parlamentare.
Intendo infatti depositare nei prossimi giorni un disegno di legge che istituirà una Commissione parlamentare d’indirizzo e controllo sui fenomeni dell’intolleranza, razzismo, e istigazione all’odio sociale. Si tratta di raccogliere un invito del Consiglio d’Europa a tutti i paesi membri, ed il nostro Paese sarebbe il primo a produrre soluzioni e azioni efficaci per contrastare il cosiddetto hate speech.
Questo primo passo affianca la mozione che delibera, anche in questa legislatura ( la mia firma segue quella della collega Emma Bonino) la costituzione di una Commissione per la tutela e l’affermazione dei diritti umani. C’è poi il terzo anello del discorso, l’argomento che più mi sta a cuore e che coltivo con antica attitudine: l’insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado della storia del ‘900. In una recentissima intervista, la presidentessa dell’Anpi, Carla Nespolo, ha insistito sullo stesso punto: «La storia va insegnata ai ragazzi e alle ragazze perché raramente a scuola si arriva a studiare il Novecento e in particolare la seconda guerra mondiale. Ma soprattutto non si studia che cosa ha significato per interi popoli europei vivere sotto il giogo nazista e riconquistare poi la propria libertà». Ora che le carte sono in tavola rivolgo a voi un invito molto speciale.
Un appello per una rifondazione dell’Europa, minacciata da “autoritarismi e divisioni” che segnalano l’emergere di una sorta di “nuova guerra civile europea”.
Il vento che attraversa l’Europa non è inarrestabile. Riprendete in mano le carte che ci orientano, che sono poche ma buone: in quelle righe sono scolpiti i più alti principi della convivenza civile, spetta a voi battervi perché trovino applicazione: grazie alla nostra Costituzione (70 anni fa) siamo entrati nell’età dei diritti e gli articoli 2 e 3 della Carta sono lì a dimostrarlo, il passaporto per il futuro.
La carta europea dei diritti fondamentali (che ha lo stesso valore dei trattati) è l’elevazione a potenza europea di questi principi, intrisi di libertà ed eguaglianza che abbiamo, orgogliosamente, contribuito a esportare.
Se vogliamo impastare i numeri con la memoria direi che siamo passati, in un solo “interminabile” decennio, dalla difesa della razza (1938) alla difesa dei diritti (1948). Il futuro deve essere orientato diversamente nel solco dei diritti inalienabili ecco perché, concedetemi la citazione, a cinquant’anni dal suo assassinio, Martin Luther King diceva che occorre piantare il melo anche sotto le bombe. È questo il momento giusto!
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE -- IL LUNGO SILENZIO CHE FERISCE LE DONNE.20 novembre 2017, di Federico La Sala
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne... *
Verso il 25 novembre
Il lungo silenzio che ferisce le donne
La denuncia di violenze è stata messa a tacere nel corso della storia. Solo da poco ha ottenuto uno spazio pubblico e un accenno di ascolto
di Elisabetta Rasy (Il Sole-24 Ore, Domenica, 19.11.2017)
Di fronte al cupo e regolare rimbombo degli omicidi, quello che si chiama sbrigativamente femminicidio, cioè vite femminili spezzate con violenza e furore da persone contigue e non da criminali occasionali, spesso si tende a dire che si tratta della reazione dei maschi sviliti di fronte al nuovo potere e alla nuova libertà femminile che essi, i maschi impauriti, non sarebbero in grado di accettare.
Ma le cose stanno davvero così? Basta uno sguardo alla cronaca per rendersi conto che la violenza contro le donne è orizzontale: dagli stupri indiani a quelli dell’Isis, dalle bambine forzate al matrimonio alle punizioni corporali per le colpevoli di adulterio secondo la legge islamica, dalle pratiche di aborto selettivo - selettivo cioè dei feti femminili - alle figlie femmine chiuse in orfanotrofi lager in Cina e ai dati dell’obitorio di Ciudad Suarez con le migliaia di ragazze brutalizzate e uccise, è impossibile non rendersi conto che la mappa delle violenze non conosce confini e riguarda il mondo occidentale evoluto come quelle aree più remote dove lo sviluppo economico e sociale fatica ad arrivare. E basta poi dare uno sguardo al passato, ai libri di storia e di letteratura, per capire che la violenza femminile è anche verticale, comincia dal mito, per esempio il sacrificio di Dafne per sfuggire ad Apollo, come lo racconta magnificamente Ovidio o come superbamente l’ha scolpito Bernini: uno stupro fatto ad arte, potremmo definirlo.
Poiché sono molti gli equivoci in materia, vorrei insistere contro l’idea che possa esserci una sorta di prezzo da pagare per la (ancora poca) libertà conquistata: Yara Gambirasio aveva tredici anni quando è stata barbaramente aggredita e lasciata morire, l’unica libertà che aveva era di andare a far ginnastica in palestra. Proprio questo scampolo di libertà, questa libertà da bambina, le è stato fatale. Fortuna Loffredo, del derelitto Parco Verde di Caivano, aveva sei anni quando è stata buttata dal settimo piano e da un anno veniva regolarmente abusata: aveva la libertà che hanno le bambine di cui nessuno si occupa e che possono diventare il giocattolo della crudeltà del mondo.
Pure a qualcuno viene ancora in mente, vedi il parroco del quartiere San Donato di Bologna, di mettere in relazione la violenza maschile con la libertà delle donne che spesso non è altro che fiducia, voglia di allegria. (Chissà se quel parroco tanto impegnato su Facebook ha avuto il tempo di leggere la notizia delle ventisei giovani nigeriane trovate morte su un gommone partito dalle coste libiche verso l’Italia, sui corpi delle quali sono stati trovati lividi, segni di percosse, ossa rotte, forse brutalizzate prima della partenza o forse dopo, per lasciarle indietro come merce avariata al momento del tentativo di salvataggio: sono state sventate?). E, dal momento che è il tema del giorno, viene in mente a qualcun altro, una bellissima e ammiratissima attrice, di richiamare alla prudenza (prudenza? e di chi verso chi?) e di invitare a non confondere avances e molestie, quando anche una adolescente sa che le avances sono tali quando lei le gradisce e quando c’è reciprocità nel desiderio e smettono immediatamente di esserlo quando invece sono atti subiti.
Il caso Weinstein ha un merito: ha messo in campo, oltre a uno smodato desiderio di dire la propria opinione e di creare tifoserie contrapposte, un interessante pregiudizio basato sostanzialmente su un unico capo d’accusa: se molestie ci sono state andavano smascherate subito e invece, arrivando anni e anni dopo i fatti, la denuncia delle donne è in colpevole ritardo.
Vero, giusto, proprio così, non si potrebbe mettere meglio a fuoco la situazione: la parola delle donne è in ritardo. Solo che non si tratta di quei venti anni dai fatti, cioè dalla prepotenza sessuale del produttore americano. Gli anni sono molti di più: sono secoli e millenni. La parola femminile sconta un ritardo infinito per essere stata tacitata da un inviolabile obbligo di silenzio lungo tutto il corso della storia. È davvero da molto poco che ha conquistato uno spazio pubblico, e solo qua e là nel mondo uno spazio di ascolto. Ed è un ritardo certamente colpevole, essendo la colpa però non di chi non può parlare ma di chi impedisce all’altro di farlo: non è un silenzio qualsiasi, è l’impossibilità di parola che sempre si verifica quando c’è uno sbilanciamento dei poteri, uno squilibrio dei diritti.
In materia di donne è proprio ritardo la parola chiave. Lo incontriamo in ogni campo della vita femminile e non è difficile scorgere il nesso tra questo ritardo e la violenza. Dai ritardi del passato (siamo sicuri di ricordare che solo nel 1981 vengono abrogate nel norme del codice penale relative al delitto d’onore?) a quelli di oggi la situazione non è meno grave.
Di violenza parlano chiaramente le cifre. Per esempio quelle di una recente ricerca del World Economic Forum sul divario di genere nel mondo, i cui parametri non sono la ridda delle opinioni contrapposte ma elementi precisi, cioè economia, politica, salute, formazione. Ci vorranno, secondo le previsioni, cento anni per colmarlo, questo divario.
L’Italia, rispetto ai quattro parametri, è all’ottantaduesimo posto (dopo Burundi, Bolivia, Mozambico...), ma se si considerano invece solo i parametri della situazione economica e della salute scende al centodiciottesimo posto. Salute e denaro, cioè utensili della sopravvivenza. Come è possibile che chi sia in una posizione così precaria possa difendersi dagli agguati della violenza? La precarietà crea dipendenza, fragilità, sottomissione, cioè potenziale esposizione alla violenza. E non riguarda soltanto le più sfortunate e le più derelitte: è vero, c’è anche chi guadagna bene e chi può curarsi, ma se non c’è parità diffusa che possa penetrare nelle menti e nei cuori e nel corpo collettivo della società, non c’è sicura difesa dalla violenza. E non c’è sicurezza senza giustizia, se non sono tutelate tutte le donne non lo è nessuna.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
 Uomini e donne, per un "cambio di civiltà" - al di là del Regno di "Mammasantissima": l’alleanza edipica della Madre con il Figlio, contro il Padre, e contro tutti i fratelli e tutte le sorelle.
Uomini e donne, per un "cambio di civiltà" - al di là del Regno di "Mammasantissima": l’alleanza edipica della Madre con il Figlio, contro il Padre, e contro tutti i fratelli e tutte le sorelle.
 USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE.
USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE
 PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE -- IL MITO DELLA GRECITÀ. Il nazismo e l’Antichità.29 luglio 2017, di Federico La Sala
IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ: LA PUNTA DI UN ICEBERG. Molti filologi, storici, archeologi e filosofi italiani e tedeschi si prestarono a favorire questa operazione ...*
Nazisti antiquari, non filologi
di Roberto M. Danese (Alfabeta-2, 27 luglio 1917)
- Johann Chapoutot, Il nazismo e l’Antichità, traduzione di Valeria Zini, Einaudi 2017, 523 pp., € 34
Nel 2008 esce in Francia il volume di Johann Chapoutot Le national-socialisme et l’Antiquité per le edizioni PUF. Nel 2012 il libro viene ripubblicato in edizione rivista con il titolo Le nazisme et l’Antiquité. È quest’ultima versione che esce ora in Italia come Il nazismo e l’Antichità. La differenza nel titolo non è secondaria. Se vogliamo trovare infatti un limite in quest’opera, è il tono generale un po’ troppo apertamente irridente nei confronti dei nazisti, a partire dalla scelta di sostituire nel titolo l’originario national-socialisme con il più polemico nazisme usato negli anni Venti dagli oppositori di Hitler.
Chapoutot è un brillante storico del Terzo Reich, che ha voluto riservare specifica attenzione a un fenomeno già piuttosto noto e indagato, ma comunque bisognoso di una nuova analisi scientifica. La necessità di un libro come questo, molto ben documentato e altrettanto ben costruito, è data non solo dall’interesse per un aspetto importante della politica culturale nazista, ma anche dall’impatto che uno studio del genere può avere sul nostro tempo.
Chapoutot dimostra con grande abilità che il nazismo non si è limitato a mistificare la cultura greca e romana, ma ha fatto di questa mistificazione una base fondamentale per la giustificazione ideologica del proprio agire politico e uno strumento formidabile di indottrinamento per il popolo tedesco. Insomma, ben più di quanto fece il fascismo con il folclorico riutilizzo della romanità. Hitler (e in qualche modo Himmler) prima crearono, grazie alla connivenza di studiosi tedeschi proni al dettato ideologico del Reich, una base scientifica che sancisse in modo indiscutibile l’origine germanica delle grandi civiltà greca e romana, quindi utilizzarono questa - per loro - incontrovertibile verità per rivendicare a sé tutti i migliori frutti di quelle antiche culture, a cominciare dalle città e dalle opere d’arte.
Non fu purtroppo solo un gioco propagandistico, ma una delle giustificazioni principali per l’espansionismo tedesco e per il progressivo irrobustirsi della politica razziale: proclamandosi eredi e insieme padri delle civiltà di Pericle e Augusto (entrambi, per loro, di sangue nordico), si arrogarono il diritto di proclamare inferiori, corrotte e corruttrici tutte quelle razze e quelle culture che non rientravano in questa netta linea genealogica, arruolando come campioni della razziologia autori quali Tirteo oppure Orazio.
Sulla reviviscenza di quegli antichi valori modellarono poi il loro inquietante programma ideologico: superiorità della razza nordica, eliminazione delle razze degenerate di origine negroide-semitica, una institutio nazionale che unisse cura del corpo e della mente, fede nell’irrazionalismo e nello Stato sociale contro il razionalismo di matrice umanistica, opposizione fra l’uomo “totale” ariano e l’uomo “scisso” di ascendenza cristiana.
Il libro di Chapoutot è molto dettagliato e complesso, ma di lettura agevole e avvincente, soprattutto chiaro nel mettere a fuoco gli obiettivi che il nazismo perseguiva nell’utilizzo dell’antichità classica. Sarebbe interessante analizzare molti aspetti di questo saggio, ma ne sceglierò solo un paio per cercare di mostrarne l’utilità e l’attualità. Nel 1933 Hitler volle una grande riforma scolastica che contribuisse a formare sin dall’infanzia il vero uomo tedesco.
Molti filologi, storici, archeologi e filosofi tedeschi si prestarono a favorire questa operazione, che voleva inculcare nei ragazzi i grandi ideali “nordici” della Grecia e di Roma, senza però farli riflettere troppo sui testi. Chapoutot documenta molto bene il dibattito che si accese in merito fra politica, classicisti e insegnanti di scuola: bisognava esaltare l’affinità di sangue e di cultura con gli antichi, ma bisognava anche diminuire le ore di greco e di latino nelle scuole, privilegiando gli studi storico-ideologici a discapito di quelli linguistico-grammaticali.
Se guardiamo al dibattito oggi in atto in Italia e in Europa sugli studi classici, non possiamo non accorgerci che si stanno usando simili argomentazioni per limitare il ruolo e lo studio delle lingue antiche, in vista del perseguimento di una cultura del fare più che del pensare.
Scrive Chapoutot sul programma educativo nazista: “Il sapere è legittimo solo nella misura in cui è immediatamente utile alla comunità del popolo e allo Stato”. E poi: “Il sapere specializzato consacrato dal regime è un sapere tecnico, pratico, immediatamente disponibile e utilizzabile, che dunque esclude ogni meditazione e quella libertà disinteressata che è propria del pensiero”.
Leggete gli attacchi contemporanei verso il liceo classico e verso lo studio del greco e del latino sui nostri giornali e sul web, considerate la filosofia di accreditamento degli Atenei da parte delle Agenzie per la Valutazione dell’Università e della Ricerca, quindi provate a fare un confronto con la cultura del fare esaltata dal regime nazista e messa alla base di ogni suo progetto formativo. Alla fine anche Heidegger aveva capito che tutto ciò era pericoloso, molto pericoloso...
Veniamo poi al marcato antifilologismo di tanti intellettuali al servizio del Führer. Chapoutot ci racconta che Hitler volle un aumento di attenzione verso l’antichità classica ma un’attenuazione del suo studio dal punto di vista veramente scientifico.
È qualcosa di simile a quello che sta succedendo oggi, in un quadro di crescente attenzione per l’antichità classica: nelle università ci sono sempre più archeologi che non sanno una parola di greco o di latino, modernisti che non riusciranno mai a leggere Stazio o Virgilio in latino, latinisti e grecisti che considerano un fastidio fare edizioni critiche e lavorare su testi ecdoticamente fondati. Non parliamo di quello che succede nei licei.
Lo studio delle grammatiche e della prassi filologica per l’antichità classica insegna a non dar mai per scontato nulla di fronte a un testo, insegna a interrogarsi sempre su ciò che una sequenza di parole o di immagini vuol veramente dire, insegna a capire le retoriche.
Questo per i nazisti non solo era inutile, ma anche dannoso: la verità sul significato dei testi antichi su cui si fondava la loro ideologia la diceva il regime stesso, quindi perché fornire allo studente i mezzi per cercare di comprendere da solo quei testi, rischiando di fargli nascere nella testa idee “sbagliate”?
La filologia è invece un bene prezioso perché, come ci hanno mostrato i primi grandi umanisti, raffina l’arte del dubbio: e anche oggi non dobbiamo dimenticare quanto si debba stare in guardia nei confronti di chi subdolamente bolla come inutile al progresso e perditempo colui che indugia nel lento esercizio della perplessità e della riflessione.
Il libro di Chapoutot non è dunque solo interessante, ma anche assai utile e la sua lettura dovrebbe essere consigliata a molti, se è vero che historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ, magistra vitæ, nuntia vetustatis.
*
SUL TEMA, SI CFR.:
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.- GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE
- UNA LEZIONE DI JOYCE (da "FINNEGANS WAKE")
- L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. -
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE -- Artemisia Gentileschi, una femminista nel 1600 (di Ambra Lancia)7 aprile 2017, di Federico La Sala
Artemisia Gentileschi, una femminista nel 1600
di Ambra Lancia *
- A Roma fino al 7 maggio, la mostra “Artemisia e il suo tempo”, presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi. Artemisia Gentileschi, una pittrice di prim’ordine, che non si limitava alla sublime tecnica pittorica, ma che seppe, quella tecnica, trasformarla.
“È qui la forza dei quadri della Gentileschi: nel capovolgimento brusco dei ruoli. Una nuova ideologia vi si sovrappone, che noi moderni leggiamo chiaramente: la rivendicazione femminile". (Roland Barthes)
Circa 100 sono in totale le opere in mostra, provenienti da ogni parte del mondo, pezzi rari da prestigiose collezioni private come dai più importanti musei. Un viaggio nell’arte della prima metà del XVII secolo per ripercorrere la vita e le opere di un’artista grandiosa, in dialogo con quelle di alcuni protagonisti della pittura seicentesca a lei precedenti e contemporanei - con i quali Artemisia ha stabilito un dialogo, un confronto, in alcuni casi uno scontro - come Cristofano Allori, Simon Vouet, Giovanni Baglione, Antiveduto Gramatica e Jusepe de Ribera, nella cornice storica e politica dalla Roma della Controriforma, alle altre città che l’hanno segnata come Firenze e Napoli.
Artemisia Lomi Gentileschi nasce a Roma, l’8 luglio 1593, figlia di Orazio Gentileschi (Pisa 1563-Londra 1639), un noto pittore [1] originario di Pisa dagli iniziali stilemi tardo-manieristi che perfezionò approdando nell’Urbe, quando la sua pittura raggiunse il suo apice espressivo, risentendo grandiosamente delle innovazioni del contemporaneo Caravaggio, dal quale derivò l’abitudine di adottare modelli reali, senza idealizzarli anzi, trasfigurandoli in una potente quanto realistica drammaticità. Il pittore stesso frequentò il grande e famoso atelier di Gentileschi, in Via Margutta, hub di molti artisti dell’epoca.
Roma era in quel momento un grande centro artistico e la sua atmosfera di arte e cultura rappresentava un ambiente unico in Europa, con tutte le contraddizioni del caso... Il Concilio di Trento (1545-1563) determinò una radicale svolta dei tempi, che finì per influenzare l’arte ben al di là delle indicazioni precettistiche date: un clima controriformistico che di fatto perdurò per tutto il XVII secolo, cominciando a diradarsi agli inizi del Settecento. Da un lato, la Riforma Cattolica, in effetti, costituì per l’Urbe un’eccezionale spinta propulsiva, e portò al restauro di numerose chiese - e, dunque, ad un sostanziale incremento di committenze che coinvolse tutte le maestranze impegnate in quei cantieri - e a molteplici interventi urbanistici, per ridefinire la città.
Nello spazio delimitato della "città" dovevano idealmente convergere aspirazioni ed esigenze sia funzionali che estetiche e la città assume per questo un ruolo di spicco nei confronti delle arti: non solo semplice luogo privilegiato in cui se ne esprimono e se ne raccolgono le manifestazioni ma, soprattutto, spazio teorico e aperto all’invenzione, pur sempre in posizione gerarchicamente sovraordinata. La città, dopo il Rinascimento, diventa così il luogo dove il reale deve manifestare una intima coerenza, un’armonia monumentale che occulti la dimensione sociale, conflittuale che è insita a questa forma del vivere. Una coerenza del reale che non verrà mai raggiunta. I monumenti, le opere architettoniche, i dipinti e disegni rinascimentali sono cioè da considerare la rappresentazione iconografica di una città ideale che non è mai esistita, né esisterà mai.
Roma era da sempre il punto di attrazione e confluenza di un’umanità cosmopolita: numerosissimi i pellegrini che vi affluivano, gli artisti, frati, prostitute e un’altissima densità di mendicanti abitavano le strade della città, ibridandola.
Artemisia, primogenita di sei figli, osserva sin da bambina la vita brulicante nel laboratorio del padre, attorno a cui ruotano artisti di ogni tipo, nobili committenti, sarte, scalpellini, barbieri e pellegrini. Orazio introdusse la figlia all’esercizio della pittura insegnandole come preparare i materiali utilizzati per la realizzazione dei dipinti: la macinazione dei colori, l’estrazione e la purificazione degli oli, il confezionamento dei pennelli con setole e pelo animale, l’approntamento delle tele e la riduzione in polvere dei pigmenti furono tutte perizie che la piccola metabolizzò nei primi anni, un talento precoce il suo che eclisserà totalmente quello dei fratelli.
Artemisia imparò la pittura confinata entro le mura domestiche, mentre dovette subentrare, dopo la morte prematura della madre, alle responsabilità della conduzione familiare, dalla gestione della casa e della custodia dei suoi fratelli minori. L’ambiente dell’arte era quanto di più maschile si potesse immaginare, le donne che frequentavano gli atelier erano le modelle che il pittore-creatore avrebbe plasmato nella tela. “Misia” non poteva, quindi, fruire degli stessi percorsi di apprendimento intrapresi dai colleghi maschi, nessuna possibilità per una donna di entrare all’Accademia di Roma, ma alla fine, perfino il difficile e scontroso Orazio, dovette riconoscere che la giovane discepola poteva rappresentare un valido aiuto. A., infatti, iniziò a intervenire su alcune tele paterne, ad aiutarlo nelle commissioni con il suo talento nella ritrattistica, superiore a quello del padre.
“Una donna che dipinge nel milleseicentoquaranta è un atto di coraggio”. [2]
Nel 1610, a soli diciassette anni, l’esordio artistico con la realizzazione del primo e celebre capolavoro, Susanna e i vecchioni, un’opera che dimostra una capacità magistrale di restituire in maniera naturalista un nudo di donna, in un periodo di Controriforma, dove dipingere nudi era un gesto provocatorio. La gestualità dei personaggi è decisa, le espressioni sono realistiche e il dipinto mostra la sua conoscenza dell’anatomia umana, dei colori, del pennello e il suo gusto per la struttura del quadro.
- [Susanna e i vecchioni, 1610]
Nel 1611 Orazio decise di affidarla alla guida artistica dell’amico Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe-l’œil (la pittura all’aria aperta, metodo sperimentale all’epoca), con cui collaborava alla realizzazione per il cardinal Borghese della loggetta della sala del Casino delle Muse, a palazzo Rospigliosi. Agostino “lo smargiasso” - come era sovente soprannominato, un carattere sanguigno e iroso e dai trascorsi inquietanti. Ciononostante, Orazio Gentileschi aveva grande stima di Agostino, che frequentava assiduamente la sua dimora. Tassi iniziò a puntare subito la giovane diciottenne Artemisia e nel maggio del 1611, quando ricevette l’ennesimo rifiuto, approfittò dell’assenza di Orazio e stuprò Artemisia nell’abitazione dei Gentileschi in via della Croce con la compiacenza di Cosimo Quorli, furiere della camera apostolica, e della vicina di casa che negli anni si era presa cura della ragazza...
“Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch’io non potessi serrarle et alzatomi li panni, che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l’altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne”.
Orazio sporge querela al pontefice Paolo V, dando inizio ad una vicenda processuale storica che creerà ampio dibattito pubblico. Ha inizio la gogna alla donna che ha osato ribellarsi, Artemisia Gentileschi che la parte avversa, ritrae come “una ragazza facile, che usava affacciarsi alla finestra per adescare i giovani”. La Roma nel XVII secolo che ergeva chiese era anche la Roma della Santa Inquisizione e dell’oscurantismo religioso e nel 1600, i processi per stupro nello Stato Pontificio prevedevano la tortura della vittima, per verificarne l’attendibilità e “purificarla dal disonore subìto”. Per Artemisia viene espressamente previsto il tormento “dei sibilli”, doppiamente pericoloso per una pittrice: legati i polsi per evitare che la donna si divincolasse, venivano poste delle cordicelle tra le dita delle mani congiunte e successivamente si azionava un randello che, girando, stringeva fino a stritolare le falangi. Ad ogni nuovo giro di vite, le dita si gonfiavano e il sangue non circolava più; ciò poteva causare anche delle invalidità permanenti. Negli atti del processo viene specificamente indicata come “tortura disposta per emendare la colpa”.
Pensiamo che ancora nel 1800 i fascicoli dei procedimenti per reato di stupro recavano la dicitura “processo per violenza carnale commessa con la signorina...”, come se si implicasse una correità della vittima. Fino al 1981, poi, il reato di violenza carnale veniva considerato estinto, se seguito dal matrimonio con lo stupratore. Risale soltanto al 1996 la legge che colloca il reato di violenza sessuale tra i delitti contro la persona, invece che contro la morale. E c’è ancora tanta battaglia da fare...
Al termine del processo verrà riconosciuta la colpevolezza del Tassi, colpevole anche di aver corrotto i testimoni. Egli già sposato e che non poteva “riparare”, fu, quindi, condannato al pagamento di una somma di denaro, che fungerà da dote per la giovane.
Dopo lo scandalo seguito al processo per stupro - ormai la carriera artistica per Artemisia a Roma era finita - e un matrimonio riparatore un anno dopo (1612), voluto e imposto dal padre Orazio, con un modesto pittore toscano, Pietro Antonio Stiattesi, Artemisia deve lasciare Roma e recarsi a Firenze. Interromperà definitivamente i rapporti con il padre. Dalla vicenda dello stupro in poi, emerge l’esigenza di un’autonomia artistica quanto personale, a partire dal cambio di nome, Artemisia Lomi (così si firmerà nelle opere del periodo fiorentino) liberandosi anche dai lacci paterni.
- [Giuditta che decapita Oloferne, 1612-1613]
Ogni lavoro creativo si fonda sul presupposto di un coinvolgimento intenso, un’esperienza “sensoriale” che lega il soggetto all’opera che andrà a rappresentare. Se poi l’impulso creativo si inserisce in un percorso di rielaborazione personale, come in Giuditta che decapita Oloferne (1612-1613) è possibile che elementi individuali si sommino ad elementi archetipici, conferendo all’opera un’intensità simbolica universale. Giuditta uccide il generale Oloferne, che aveva messo sotto assedio la sua città imponendo la resa al popolo israelita. Nel dipinto, interpretato in chiave psicologica e psicoanalitica, la mano di Giuditta che tiene ferma la testa del tiranno mentre lo decapita è la mano della stessa Artemisia che punisce il suo “carnefice”che ha le fattezze quasi di Tassi, impugnando con fermezza la spada in una situazione che potrebbe essere definita come l’esigenza di annullare la violenza subita mediante un rovesciamento di prospettiva. Se confrontiamo quest’opera con quella nota di Caravaggio con stesso soggetto, è immediata la potenza della prima, quasi filmica.
A Firenze inizierà ad affermarsi come artista, divenendo amica delle personalità più importanti del tempo, da Cosimo II dei Medici che le apre le porte della raffinata Corte di Firenze, alle due figure fondamentali per la sua formazione: Michelangelo Buonarroti il Giovane (nipote del famoso Michelangelo) - suo mecenate - e lo scienziato Galileo Galilei, con cui intrattenne rapporti epistolari e di amicizia, accompagnandolo con il suo affetto durante gli anni dell’abiura. E Artemisia lo omaggia con due quadri: Aurora (1625) e Inclinazione (1615 -1616).
- [Caravaggio, Giuditta e Oloferne, 1599]
Nel 1616 entra - prima donna della storia - nella più antica accademia di belle arti del mondo, l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. La produzione artistica del periodo fiorentino è abbondante. Come sottolineano i critici, spesso nei quadri dipinti su commissione ritroviamo, nei volti delle protagoniste femminili, gli stessi lineamenti presenti nei suoi autoritratti. Artemisia è autrice ma anche modella dei suoi dipinti. Proprio la bellezza e la sensualità sono un altro tratto che caratterizza i suoi lavori. Le sue eroine hanno un aspetto avvenente ma elegante, sguardi intensi e complici, le sue modelle spesso, sono donne cercate per strada, braccia robuste, gambe tornite, rubate alle donne che conoscevano la fatica del vivere quotidiano.
Giuditta, Susanna, Lucrezia, Cleopatra sono tante sfaccettature che compongono la figura di Artemisia, eroine bibliche e storiche che hanno segnato il nostro immaginario culturale dall’Antichità all’oggi trasfigurate dalle pennellate dell’artista. In Giuditta con la sua ancella (1618-1619) - conservato a Palazzo Pitti a Firenze - l’artista sembra aver attinto a una forza interiore fino a quel momento rimasta inespressa. Rispetto al prototipo di Caravaggio, la fedele ancella Abra è una giovane donna e una “partner attiva” nell’aiutare Giuditta (possiamo osservare la mano appoggiata sulla spalla) come se Artemisia ricercasse quella solidarietà femminile che non aveva trovato nella realtà, nell’amicizia tradita della vicina di casa Tuzia, accusata in seguito di complicità con Tassi.
- [Giuditta con la sua ancella, 1618-1619]
Come suggerisce una intensa Sibilla del padre Orazio, che quasi “buca la tela”, e sembra presagire il luminoso destino della figlia, proprio nel 1621 Artemisia farà ritorno da sola nella città natale con l’investitura di artista ormai affermata; dovette, infatti, lasciare Firenze dopo la difficile convivenza con il marito (sembra molto geloso della superiorità artistica della moglie) e per i debiti accumulati. Il secondo periodo artistico romano di Artemisia coincide con il pontificato di Urbano VIII e con nuovi orientamenti stilistici che fioriscono a Roma, il classicismo della scuola bolognese e l’estrosità barocche, mentre Gianlorenzo Bernini sta trasformando il volto della città e gli interni di San Pietro... Nonostante la forte personalità e bravura artistica, le commissioni che le vengono affidate sono circoscritte alla sua perizia ritrattistica (abbandonerà totalmente qualunque accenno alla prospettiva nei suoi quadri dopo il 1611) e alla rappresentazione di scene religiose, le sono precluse, invece, le grandi opere come le pale d’altare o i cicli dei grandi affreschi riservati agli artisti.
- [Orazio Gentileschi, Ritratto di giovane donna come Sibilla, 1620]
Una delle opere più conosciute e raffinate viene realizzata in questi anni: L’Autoritratto dell’allegoria della pittura- acquistata da Re Carlo I d’Inghilterra tra il 1639 e il 1649 che entra a far parte della Royal Collection - nel quale dimostra la padronanza con la tempera ad olio ritraendo sé stessa messa di tre quarti, con la mano destra sollevata verso la tela mentre con la sinistra tiene la tavolozza nell’atto di dipingere, circondata dagli strumenti della pittura; un autoritratto abbastanza insolito per i suoi tempi. Un’allegoria della pittura, appunto, in cui Artemisia ha costruito un’immagine in cui lei non guarda frontalmente come se fosse davanti ad uno specchio e in cui non rovescia la figura, in quanto la vediamo comunque dipingere con la destra. Gli autoritratti al maschile in genere sono sempre degli esercizi di stile, centrati, focalizzati su di sé, prove in cui si afferma con forza l’autocoscienza dell’essere artisti. Artemisia invece ha un sguardo diverso, al centro non mette direttamente se stessa ma ciò verso cui sta guardando: l’opera.
- [Autoritratto come allegoria della Pittura, 1638-1639]
La dimensione dell’alterità pittorica, di un differente modo di rappresentare e di vedere la realtà, fino a quel momento caratterizzata al maschile; un modo espressivo “di genere”, antichissimo, eppure del tutto nuovo perché finora lasciato nel silenzio. La ragione e il fondamento della pittura secondo Artemisia non stanno quindi nelle capacità espressive dell’artista, quanto nell’attrattiva che la realtà esercita su di lei, in una vera allegoria della pittura, quindi, che ci dice come essa sia un esercizio di stupore più che una prova di forza. [3]
Durante un soggiorno a Genova incontrerà Anthony Van Dick, e i due artisti si influenzeranno a vicenda. Dopo alcuni rari ritratti maschili e un breve intermezzo veneziano, a Napoli (1630-1653) dove fa conoscenza di Velázquez, le viene affidata l’esecuzione di tre dipinti per la Cattedrale di Pozzuoli. Grazie alla sua arte fu una donna indipendente, anche sul piano economico, al punto di poter abbandonare un matrimonio imposto e sfortunato per poter crescere da sola i suoi figli (ne avrà quattro o cinque secondo altre fonti) e inseguire un altro amore. L’ultimo periodo della sua vita sarà uno dei più difficili per l’artista, costretta a vendere i suoi dipinti a basso prezzo. “Il nome di donna fa star in dubbio finché non si è vista l’opera”, scriveva Artemisia nel 1649.
Muore a Napoli, città che l’ha accolta generosamente per vent’anni, nel 1653. Ciò che rimane della sua vita e della sua esperienza artistica sono 34 dipinti e 28 lettere. Nel tempo in cui si andava affermando lo stile rivoluzionario di Caravaggio e di tutti i suoi, non sempre all’altezza, emuli, la pittrice riuscì a reinterpretarne in maniera autonoma il linguaggio drammatico e potente, sapientemente bilanciato tra realismo e teatralità. Due artisti che si somigliano anche per la sorte avversa che segnò profondamente e molto presto la loro esistenza.
Artemisia Gentileschi rappresenta una delle figure più importanti nel panorama dell’arte italiana del XVII secolo, sebbene sia restata inosservata per molto tempo agli occhi dei critici dell’arte e degli storici anche suoi contemporanei, i quali si interessarono morbosamente più alle vicende biografiche che alle opere. Riscoperta solo nel Novecento è diventata col tempo una figura simbolo del femminismo a livello internazionale e del desiderio di emancipazione.
Artemisia non è stata la vittima sacrificale del mondo e del potere maschile del tempo, come a volte viene riportato, ma ha saputo rivendicare la sua autodeterminazione artistica e sociale e diventare una “grande pittrice di narrazione, drammaturgia e di sfumature”.
***
[1] Tra il 1587 e il 1588 lavorava nelle sale sistine della biblioteca vaticana. Nel 1590 aveva già realizzato un affresco a Santa Maria Maggiore, e opere nella basilica di San Giovanni in Laterano. Molte opere sono conservate al Louvre a Parigi, al Prado di Madrid e in molte altre città del mondo.
[2] Anna Banti, Artemisia, 1947
[3] Viene scardinata l’idea della pittura come una sorta di deflorazione da parte del pittore della tela vergine. Forse solo con Marcel Duchamp si può parlare di una rottura dell’idea della pittura come una “prova di forza” in una perdurante necessità di un confronto erotico con la stessa, letteralmente assimilata a un corpo femminile che il pittore deve possedere. Pensiamo alle parole di un artista come Kandinskij ancora nel Novecento: “[...] La tela, conoscerla come un essere che resiste al mio desiderio, e a sottometterla al mio desiderio con violenza. All’inizio lei è lì, come una vergine pura e casta [...] In seguito arriva il pennello [...] che la conquista poco a poco con tutta l’energia di cui è capace [...] per piegarla così al suo desiderio”
(V. Kandinskij, Sguardo al passato, in Id. Tutti gli scritti, vol.2, Feltrinelli, Milano 1974) back to top
*Per il testo completo, cfr.: http://www.dinamopress.it/news/artemisia-gentileschi-una-femminista-nel-1600 , 06 Aprile 2017.
-
> GIAMBATTISTA VICO E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Se la mappa della filosofia cancella il Sud (di Massimo Adinolfi)23 febbraio 2017, di Federico La Sala
- IN MEMORIA DI ENZO PACI E DELLA SUA RISPOSTA A VICO....
 IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
Se la mappa della filosofia cancella il Sud
di Massimo Adinolfi (Il Mattino, 23.02.2017)
Impossibile tracciare una mappa della filosofia in Italia. Accompagnando la meritoria iniziativa del «Corriere della Sera» che pubblica una nuova collana di libri dedicata ai «maestri del pensiero più importanti», Pierluigi Panza, a colloquio con il presidente della Società italiana di estetica, Elio Franzini, ci prova coraggiosamente in due righe. Eccole: «la scuola di Milano ha avuto una tradizione fenomenologica con Banfi e Paci; quella di Torino è stata caratterizzata dall’ermeneutica, ma ora ha svoltato con il «ritorno alle cose» di Ferraris; epistemologia e cognitivismo di stampo anglosassone sono variamente disseminati; al Sud è sopravvissuto un po’ di idealismo crociano con un approccio più storicista». Poche righe sommarie, in cui non compaiono Venezia, Padova o Pisa, ma in cui soprattutto il Mezzogiorno quasi non è avvistato: se non fosse per le sparute sopravvivenze storiciste, citate con troppa sufficienza, sembrerebbe che al di sotto della linea Gustav di filosofia non ve ne sia quasi più traccia.
Le cose però non stanno così. Basti pensare che fra gli autori italiani di gran lunga più tradotti all’estero vi sono oggi Giorgio Agamben e Roberto Esposito, uno romano e l’altro napoletano: chiunque intendesse stendere una mappa della filosofia in Italia, a meno di personali idiosincrasie, non potrebbe non includerli in posizione di spicco. E, certo, comprenderebbe il bresciano Emanuele Severino, il milanese Carlo Sini, il veneziano Massimo Cacciari e il torinese Gianni Vattimo, ma anche i napoletani Vincenzo Vitiello, Biagio De Giovanni e Paolo Virno, e i romani Donatella Di Cesare, Pietro Montani e Gennaro Sasso. Se si disputasse il derby fra Nord e Sud come fecero i Monty Pithon con la finale mondiale fra filosofi greci da una parte e tedeschi dall’altra Roma e Napoli, insomma, non sfigurerebbero affatto.
Ci sarebbero volute più righe? Certo. Ma soprattutto ci sarebbero voluta una più generosa attenzione verso tradizioni e stili di pensiero che evidentemente l’articolista non ama: dall’ermeneutica al post-operaismo, dal neoparmenidismo alle filosofie del senso. Ne sarebbe venuta fuori la rappresentazione di una ricerca filosofica molto più vivace e molto più plurale, per nulla prossima alla scomparsa.
Quel che invece rischia davvero di scomparire, e che forse induce a qualche errore di prospettiva, è l’infrastruttura istituzionale che dovrebbe sostenere l’insegnamento e la diffusione del pensiero filosofico, ormai al Sud quasi del tutto assente. La morte di Gerardo Marotta ha riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica la vicenda dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della sua biblioteca, che rischia di divenire metafora di un più generale destino della ricerca nel Mezzogiorno. Ma siccome l’articolo del «Corriere della Sera» si chiude con una sentenza discutibile, che cioè oggi si fa filosofia «senza disturbare», proviamo a recare qualche disturbo.
O almeno a porre una domanda: se il Mezzogiorno non ha più un grande editore (e non ha più una grande banca), se il sistema universitario meridionale viene continuamente penalizzato nel trasferimento delle risorse, se i centri di ricerca non dispongono degli stessi polmoni finanziari che sostengono la ricerca al Nord, se manca o è carente l’organizzazione di grandi kermesse, se chiudono le fiere della letteratura o dell’arte, se tutto questo avviene nonostante la ricchezza di espressioni artistiche, fermenti letterari, compagnie teatrali, gruppi musicali che si muovono in città come Napoli, deve meravigliare il fatto che un grande giornale milanese, a colloquio con un professore milanese, scriva che di filosofia al Sud ce n’è pochina, quasi nulla, e che magari quella che c’è ha un certo sapore d’antico?
Qualche settimana fa si è tenuta a Bologna la Fiera internazionale di arte contemporanea. Bologna: ovvero il lembo più meridionale del sistema italiano dell’arte, perché sotto l’Appennino tosco-emiliano esposizioni simili non ce ne sono. È quasi inevitabile, allora, che chi volesse basare la propria mappa dell’arte italiana oggi su tutto quello che simili manifestazioni mettono in circolo avrebbe qualche difficoltà a inserirvi significative presenze meridionali. La teoria istituzionalista sostiene che è arte ciò che le istituzioni del mondo dell’arte affermano che sia tale. Forse è solo un escamotage, per sfuggire al compito impossibile di metter su una definizione che consenta di tenere insieme Raffaello e Malevic, Giotto e Warhol. Ma se qualcosa del genere è stata proposta persino per la scienza, al punto che vi sono epistemologi per i quali scienza è ciò che la comunità degli scienziati dice che è tale, figuriamoci se questo non accade anche nei riguardi della filosofia, il cui statuto è molto più incerto.
O perlomeno: è incerto solo in linea di principio, perché, come giustamente osserva Franzini, se si prende un filo che proviene dal fondo della tradizione occidentale e lo si prova a tirare fino a noi, un modo per orientarsi nel pensiero, e riconoscervi la forma in cui la filosofia si continua, di fatto c’è. Ma chi lo tira, quel filo? Se a tirarlo sono sempre gli stessi giornali, a margine della pubblicazione delle stesse collane, proposte dagli stessi gruppi editoriali, con operazione culturali che guardano verso le stesse scuole filosofiche che son lì a fare da sponda, allora è inevitabile che solo alcuni fili vengano sempre di nuovo tessuti, mentre altri finiscono con lo spezzarsi e col perdersi.
Una mappa della filosofia in Italia è impossibile, dicevamo. O meglio: dice Panza sul «Corriere della Sera». Ma non dice chi, nel caso, dovrebbe tracciarla, e soprattutto ignora il punto decisivo, che cioè la mappa viene ogni volta tracciata in via di fatto entro l’organizzazione dei saperi e dei poteri di una società. Se si vuole una filosofia che torni a recare qualche disturbo, forse non bisogna liquidare troppo in fretta una simile questione. E le commistioni con società, politica e scienza, che ancora Franzini giudica positive, come un accrescimento del senso del filosofare, aiuteranno allora a disegnarne una trama meno semplificata e soprattutto meno sbrigativa di quella che vede solo un po’ di Milano e un po’ di Torino, qualche sparso e inoffensivo residuo storicistico, tra Napoli e Bari, ma tutto considerato posizioni marginali, a cui non si deve molto più che un atto di omaggio. Le cose non stanno così e, sia detto en passant, se mai compariranno nelle prossime uscite della collana filosofi italiani, si può star certi che da Bruno a Vico, da Croce a Gentile saranno pensatori meridionali.
- IN MEMORIA DI ENZO PACI E DELLA SUA RISPOSTA A VICO....
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE7 febbraio 2017, di bitti cattaneo
Gentilissimo Federico La Sala, certamente Giambattista Vico, non è di semplice lettura, ma non è vero che nessuno sa che Vico inviò una esemplare della edizione della Scienza Nuova del 1730 a Newton. Mi risulta che G.B. Vico affidò a Giuseppe Athias,profondo conoscitore della lingua ebraica, studioso della Bibbia, di matematica e di fìlosofia, intenditore di musica e bibliofilo, conosciuto a Napoli nell’aprile 1725, i primi esemplari a stampa della Scienza Nuova perché fossero inviati a G. Averani, al Salvini e al Newton.
Ho una preparazione classica, ma mi sono laureata in matematica, per passione personale sto studiando l’entourage di G.B. Vico, Paolo Mattia Doria, e di un illustre genovese, totalmente sconosciuto a cui Vico dedicò sei epitaffi.
La scoperta di un quadro commissionato dal genovese a Francesco Solimena, mi ha spinto a questi studi e nel quadro sono rappresentate anche due gigantesche statue: l’Ercole farnese e la flora pomona, che, penso rappresentino, da un lato i genitori del committente, dall’altra i giganti dell’età dell’oro, ma anche l’Ercole dell’età eroica. Saluti Anna Cattaneo
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE - LA PUNTA DI UN ICEBERG.7 febbraio 2017, par Federico La Sala
CHIARISSIMA CATTANEO
MI COMPIACCIO ALLA GRANDE della sua attenzione e della sua passione - e della sua sottolineatura e precisazione! Ma, su questo, cfr., in dettaglio, nel testo completo del mio lavoro (qui: pdf, scaricabile).
DELLA COSA, a suo tempo, sensibilizzai anche il Centro Studi Vichiani e ho sollecitato anche un prof. del Warburg Institute a cercare la possibile presenza della copia della SN 1725 a Londra - risultato: ne è stata individuata una sola! Ma oltre, per ora, non mi è stato possibile andare. Un dirigente del Centro Studi Vichiani mi assicurò che avrebbe "sguinzagliato" i suoi Ricercatori. Ma fino ad ora...
COME PUO’ BENISSIMO VEDERE, dalla nota apparsa su "Logos" (10-2015) ( IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg), nei limiti delle mie forze, sono riuscito, ad alzare il coperchio sul problema più vasto di una necessaria rilettura del lavoro di Vico, ma il mondo accademico, evidentemente, pensa a ben altro!!!
Personalmente sono contento non solo della ricerca avviata sulla SN 1725 inviata a Newton, ma anche della piccola e bella scoperta fatta nel Finnegans Wake di Joyce. Alla fine, non potrà non mancare l’omaggio al Lord!
Federico La Sala
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE - LA PUNTA DI UN ICEBERG. --- A book from Sir Isaac Newton’s library discovered at the Warburg Institute.12 ottobre 2018, par Federico La SalaMichael Maier (1568-1622), "Lusus serius: or, Serious passe-time: a philosophicall discourse concerning the superiority of creatures under man", 1654: cfr.: A book from Sir Isaac Newton’s library discovered at the Warburg Institute (https://warburg.blogs.sas.ac.uk/2018/10/11/book-isaac-newtons-library-warburg/).
-
-
-
> GIAMBATTISTA VICO. -- E l’Umanesimo italiano rivisitato in chiave contemporanea da Ebgi e Cacciari (di Massimo Natale)11 dicembre 2016, di Federico La Sala
- DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia"
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"! VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
Questo canone così tragico e mosso
«Umanisti italiani», Millennio per Einaudi. Da Petrarca a Valla, da Pico a Machiavelli, l’Umanesimo rivisitato in chiave contemporanea da Ebgi e Cacciari
di Massimo Natale (il manifesto, Alias, 11.12.2016)
Se torniamo a certe pagine di Eugenio Garin - per esempio quelle affidate a un agevole libello come La cultura del Rinascimento, uscite in prima battuta nella Propyläen-Weltgeschichte edita nel 1964 - vi leggiamo che una tale epoca è segnata anzitutto dalla «coscienza della nascita di un’età nuova, con caratteri opposti a quelli dell’età precedente», una «coscienza polemica» la cui cifra è la «volontà precisa di ribellione, un programma di distacco da un mondo vecchio per instaurare altre forme di educazione e di convivenza, un’altra società e diversi rapporti tra uomo e natura».
Lontanissimo da ogni presentimento di una «bella età de l’oro» e da ogni rappresentazione oleografica dei secoli della prima modernità, il mondo rinascimentale si presenta allora, per Garin, «più enigmatico e inquieto che limpido e armonioso», un cosmo nel quale «il senso tragico della vita e una religiosità scavata» si precepiscono anzitutto «nella grandezza delle forme michelangiolesche».
Virate o estese alla cultura propriamente umanistica fra Tre e Quattrocento - a ulteriore conferma della loro efficacia - queste parole potrebbero fare da ottimo viatico anche a chi sfogli Umanisti italiani Pensiero e destino, a cura di Raphael Ebgi, con un saggio di Massimo Cacciari (Einaudi «I millenni», pp. CVI-558, € 85,00).
Il volume è approntato in forma di antologia, disposta per temi fondamentali - otto sentieri, dal rapporto fra Vita activa e Vita contemplativa alla Metaphysica alla Teologia poetica - di volta in volta preparati da un cappello introduttivo, storico-interpretativo. Si compone così una sorta di breviario umanistico, che spazia da Machiavelli a Pico, da Bessarione a Giorgio di Trebisonda, da Landino a Poliziano, non avvalendosi peraltro soltanto di stralci di opere già a loro agio nel canone, ma anche di glosse, appunti o pagine di diario (con l’aggiunta preziosa di un paio di trouvailles inedite, fra cui un brano latino di Pico in calce a una lettera a Battista Guarini, ritrovato da Franco Bacchelli nel codice Capponiano della Biblioteca Apostolica Vaticana).
In partenza Garin e Vasoli
A orientare scelte e intenzioni ermenutiche è comunque, da subito, l’articolato studio di Cacciari - che prende non a caso le mosse proprio dal nome di Garin e da quello di Cesare Vasoli - con l’obiettivo di Ripensare l’umanesimo. A cominciare dalla necessità di limitare o sorpassare senz’altro le «riserve, diffidenze e incomprensioni, quando non aperte critiche», che la filosofia contemporanea ha riservato a questo periodo della storia europea.
L’intervento di Cacciari si potrebbe in effetti leggere in buona parte - libro dentro il libro - come il tentativo di ripercorrere la lunga parabola di una mislettura profonda, secondo la quale Umanesimo implicherebbe - essenzialmente ed erroneamente - uno «spirito conservatore», una «visione essenzialmente antitragica» dell’esistente e un ideale di «paideia totalizzante-armonica». Per capire quanto sia diverso, qui, lo sguardo gettato sui nostri umanisti, basterebbe considerare come venga servito fra gli altri, da Cacciari e Ebgi, un Petrarca. Immediatamente scelto per aprire il primo capitolo antologico - dal titolo molto eloquente di «Umanesimo tragico» - ecco il Petrarca di una lettera a Ludwig van Kempen, impegnato a riconoscere, con maturo disincanto, la potenza di Fortuna: «occorre lasciare che la fortuna faccia i suoi giochi (...). Per vincerla, nessun’arma è migliore della sopportazione (...). Nessuna speranza di quiete si trova in questo capo di fatiche, giacché la vita dell’uomo non è solo milizia, ma guerra, e chiunque viene in questo mondo, viene in un campo di battaglia».
Saremmo cioè, già con Petrarca, di fronte a uno fra i primi diagnosti della finitezza e debolezza dell’individuo (un Petrarca con il quale inizia peraltro, secondo Cacciari, il «canto-threnos di Europa: ed ecco allora il poeta dei Fragmenta, con il suo sguardo sul Passato, accostato nientemeno che allo Schicksalslied dell’Hyperion di Hölderlin).
Ciò che probabilmente più affascina, nell’ampia ricostruzione proposta, è la scelta di riavvicinarsi all’Umanesimo tenendo un punto di osservazione saldamente ‘contemporaneo’. Autori, opere e nodi non sono affrontati per medaglioni, quanto piuttosto per linee: non sono ritratti in istantanea, ma immagini in movimento. E infatti il risultato non è tanto un magari nuovo e però statico quadro della cultura umanistica, ma una vera e propria genealogia del moderno.
Lo si capisce bene se si guarda, anzitutto, alla questione del rapporto fra linguaggio e pensiero: «asse portante», annota Cacciari, «dei momenti più alti» della speculazione umanistica, nella prima e precoce coscienza che ogni argomentare e ogni teoresi è anche un problema di «prassi linguistica» (ben in anticipo su certe non distanti riflessioni, ormai novecentesche).
Il richiamo a Dante
Qui è un altro il padre di ogni discorso sull’Umanesimo italiano, ovvero il Dante del De vulgari eloquentia. Il quale - pur non presente nella scelta antologica del volume - è più volte richiamato nelle pagine introduttive, ed evocato anzi come il punto di partenza necessario per ogni ritorno agli umanisti (un punto di partenza anteriore, dunque, al più scontato ‘proto-umanesimo’ di Petrarca o Boccaccio e dintorni, e indispensabile tanto più se si osserva l’epoca dalla specola di una filosofia del linguaggio). Certo, il De vulgari eloquentia è un primo atlante di dialettologia volgare: ma è, anche più, la sanzione dell’uscita del linguaggio poetico dalla sua condizione limitante di cognitio minor, di pensiero imperfetto o favola falsa. Il moderno sta insomma imparando, già a quest’altezza, la «piena rilevanza cognitiva» di un pensiero diverso, poetico, per immagini.
Si intravede già, in fondo al percorso, Leopardi: un altro nome che Cacciari spende a più riprese, laddove vuole per esempio ricordarci come esperienza e immanenza siano alla radice del pensiero di un Guicciardini (ed ecco sfruttati i leopardiani Pensieri: lì Guicciardini «è forse il solo storico tra i moderni, che abbia conosciuto molto gli uomini, e filosofato attenendosi alla cognizione della natura umana).
Ma Leopardi è nome talmente consustanziale - e non da oggi - alla riflessione di Cacciari, che lo si può anche criptocitare nel definire la filosofia di Lorenzo Valla - certamente uno dei perni del volume - una «filosofia dolorosa, ma vera» (così il leopardiano Dialogo di Tristano e di un amico, nelle Operette); o si veda infine la suggestiva «amicizia stellare» che legherebbe insieme Leopardi e Alberti, all’insegna di un comune pessimismo per così dire agonista. Speziare l’Umanesimo col moderno si può, forse anzi si deve, se non si vuole perderne alcuni tratti fondamentali, mantenendolo - con Nietzsche: anche lui spesso chiamato in causa - sempre in bilico fra attuale e inattuale.
Galleria iconografica
E si potrebbero indicare molti altri annunci, presentimenti di futuro consegnatici dal pensiero umanista: limitiamoci a scomodare almeno il suo carattere sempre fortemente civile, nel suo porre costantemente al centro una comune educazione, un dialogo duraturo fra Filosofia, Filologia ed Ermete (e allora il nome da fare sarà, stavolta, quello di Aby Warburg, nel cui segno si pone la splendida galleria iconografica che arricchisce il volume, e che accompagna il lettore da Bosch a Benozzo Gozzoli, a Giorgione ecc., suggestivamente commentati). Oppure, a come già tra Ficino e Pico - con il supporto della Lettera ai Romani di San Paolo - tramonti ogni possibile teodicea, nell’eventuale annullamento del libero arbitrio umano da parte della volontà divina. O a come, in ultima analisi, tra Machiavelli e Valla ogni azione umana sembri rivelare il proprio vero fine nella più nostra, nella più moderna delle ragioni: la ricerca della felicità, ovvero il principio di piacere.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO --- IL NILO A POMPEI."Paestum e l’Egitto". Conferenza di Gabriel Zuchtriegel.30 luglio 2016, di Federico La Sala
PAESTUM, GIAMBATTISTA VICO, E L’EGITTO. LA "CITAZIONE" DI GABRIEL ZUCHTRIEGEL:
"Paestum e l’Egitto":
(Museo Egizio di Torino, “Il Nilo a Pompei. Visioni d’Egitto nel mondo romano”)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"!
 VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura
VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO --- IL NILO A POMPEI."Paestum e l’Egitto". Conferenza di Gabriel Zuchtriegel --- Grecità ed Età di Goethe. Winckelmann e la nuova Ellade dell’Europa moderna.22 settembre 2016, par Federico La Sala
DIALOGHI
Le lettere di Winckelmann, il tedesco padre dei greci
Maria Fancelli ha curato per l’Istituto Italiano di Studi Germanici i tre volumi delle «Lettere» di Winckelmann: la rete di relazioni per il fondatore del mito della classicità
di CLAUDIO MAGRIS (Corriere della Sera, 22.09.2016)
- Gruppo del Laocoonte, degli scultori Agesandro, Atanodoro e Polidoro, I secolo d.C., Musei Vaticani
«È grigia qualunque teoria, ma verde è l’albero della vita», dice nel Faust Mefistofele burlandosi di uno studente che vorrebbe spendere la sua vita fra i libri e gli studi eruditi. Questa contrapposizione tra vita e cultura, nata soprattutto nella Germania dello Sturm und Drang e del Romanticismo, è presto divenuta un diffuso luogo comune, sino all’esaltato vitalismo dilagante tra fine Ottocento e primo Novecento. A essere celebrata è la vita nel suo scorrere, morire e rifiorire come una pianta, ma presto sarà la vitalità ad apparire distruttiva e angosciosa, come un’indomabile radice che affiora squarciando il terreno e devastando la rassicurante casa costruita su quel terreno dall’uomo e dalla sua ragione. Nell’ultimo e più affascinante dei suoi libri, il vecchio Croce è sgomento dinanzi alla «vitalità verde» che sconvolge il classico e solido edificio dei concetti e delle categorie filosofiche.
Quella contrapposizione è seducente ma falsa e pochi la smentiscono come Winckelmann, infaticabile e geniale studioso fondatore di quel mito della grecità, indagato con precisione antiquaria e appassionata partecipazione sensuale, che avrebbe rivoluzionato non solo la storia dell’arte ma in generale lo spirito, il gusto, la sensibilità, lo stile della Germania e dell’Europa. La sua Storia dell’Arte nell’Antichità è una monumentale opera storiografica e un canone di bellezza assoluta, non soggetta ai mutamenti della Storia.
 Bellezza della classicità greca - conosciuta da lui peraltro non nei capolavori originali, bensì nelle copie romane - che è modello della bellezza universale umana, perfetta sintesi di «nobile semplicità e serena grandezza». Serenità dell’anima e armonia del corpo rispecchiate dall’insondabile serenità del mare, dalla trasparente lievità dell’acqua non increspata e dalla perfezione del marmo pario. Una minuziosa ricerca erudita e un’inesausta passione vitale, permeata di eros omosessuale, porta Winckelmann a formulare il primato assoluto dell’arte e dunque dell’umanità greca - la perfezione dell’Ercole Farnese, l’Apollo del Belvedere «sopra ogni cosa» - e a vedere nella Germania la nuova Ellade dell’Europa moderna.
Bellezza della classicità greca - conosciuta da lui peraltro non nei capolavori originali, bensì nelle copie romane - che è modello della bellezza universale umana, perfetta sintesi di «nobile semplicità e serena grandezza». Serenità dell’anima e armonia del corpo rispecchiate dall’insondabile serenità del mare, dalla trasparente lievità dell’acqua non increspata e dalla perfezione del marmo pario. Una minuziosa ricerca erudita e un’inesausta passione vitale, permeata di eros omosessuale, porta Winckelmann a formulare il primato assoluto dell’arte e dunque dell’umanità greca - la perfezione dell’Ercole Farnese, l’Apollo del Belvedere «sopra ogni cosa» - e a vedere nella Germania la nuova Ellade dell’Europa moderna.Filologia e passione, archivi e biblioteche e sogno del mare ellenico, enorme lavoro a tavolino e una rete di relazioni con personalità di tutto il mondo, che esigono e creano un epistolario ricco come un’enciclopedia e affascinante come un romanzo; anzi che è pure un vero romanzo epistolare, come scrive Maria Fancelli che ha pubblicato, insieme a Joselita Raspi Serra, tre fondamentali volumi di Lettere (1742-1768), in un lavoro di anni.
 Lavoro filologico, storico e letterario che rappresenta un evento di eccezionale importanza nella cultura italiana. Edita dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, l’eccellente traduzione delle lettere in tedesco - molte Winckelmann le scrisse in italiano - è dovuta a Bianca Maria Bornmann, Barbara Di Noi, Paolo Scotini, Francesca Spadini e Delphina Fabbrini, col coordinamento di Fabrizio Cambi.
Lavoro filologico, storico e letterario che rappresenta un evento di eccezionale importanza nella cultura italiana. Edita dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, l’eccellente traduzione delle lettere in tedesco - molte Winckelmann le scrisse in italiano - è dovuta a Bianca Maria Bornmann, Barbara Di Noi, Paolo Scotini, Francesca Spadini e Delphina Fabbrini, col coordinamento di Fabrizio Cambi.Per realizzare quest’opera, di una ricchezza culturale e di una chiarezza classica degne del grande autore studiato, è sceso dunque in campo uno Stato maggiore della germanistica italiana. Maria Fancelli, formatasi alla grande scuola fiorentina di Vittorio Santoli da lei originalmente proseguita, è autrice di studi fondamentali (per esempio In nome del classico, 1979; Il secolo d’oro della drammaturgia tedesca; l’edizione italiana del Werther).
 I suoi saggi - su Goethe, Kleist, Heine, Stifter o Benn - e la sua ventennale direzione di una notevolissima collana di classici tedeschi per l’editore Marsilio e il suo impegnato e creativo insegnamento le hanno valso una laurea ad honorem presso l’Università di Bonn, che ha premiato una singolare simbiosi di rigore filologico e originale e generosa intelligenza critica, una sanguigna e fresca comprensione delle cose e delle persone e una innovativa attività di scambio culturale che coinvolge Italia, Germania e Francia.
I suoi saggi - su Goethe, Kleist, Heine, Stifter o Benn - e la sua ventennale direzione di una notevolissima collana di classici tedeschi per l’editore Marsilio e il suo impegnato e creativo insegnamento le hanno valso una laurea ad honorem presso l’Università di Bonn, che ha premiato una singolare simbiosi di rigore filologico e originale e generosa intelligenza critica, una sanguigna e fresca comprensione delle cose e delle persone e una innovativa attività di scambio culturale che coinvolge Italia, Germania e Francia.
 Joselita Raspi Serra, storica dell’arte allieva del grande Cesare Brandi, ha curato tra l’altro l’edizione in quattro volumi Il primo incontro di Winckelmann con le collezioni romane (2002-2005) e ha scritto il saggio La Fortuna di Paestum e la memoria moderna del Dorico 1750-1830, importante per la comprensione di quel mito dorico così presente e talora inquietante nella cultura tedesca.
Joselita Raspi Serra, storica dell’arte allieva del grande Cesare Brandi, ha curato tra l’altro l’edizione in quattro volumi Il primo incontro di Winckelmann con le collezioni romane (2002-2005) e ha scritto il saggio La Fortuna di Paestum e la memoria moderna del Dorico 1750-1830, importante per la comprensione di quel mito dorico così presente e talora inquietante nella cultura tedesca.Come nasce - chiedo a Maria Fancelli - l’idea di questa edizione? Cosa significano queste lettere per un lettore di oggi?
Maria Fancelli - A parte l’occasione del duplice giubileo di Winckelmann, la nascita a Stendal e la tragica morte a Trieste, l’idea nasce anzitutto per rendere accessibile agli italiani un’opera che è insieme un grandioso affresco culturale sovranazionale e un appassionante romanzo di vita vissuta, uno spaccato di grande storia europea e italiana, in cui sfilano protagonisti dell’arte, della cultura e della politica di vari Paesi, vicende di danaro, di passione, di accorta diplomazia, di indomabile entusiasmo, mentre grazie a Winckelmann, alle verità e alle menzogne della sua vita, nasce una nuova storia dell’arte e un nuovo senso dell’arte e nasce una nuova Germania, rinnovatrice ed erede della civiltà e dell’arte greca.
 Uno dei grandi libri che hanno indagato questo binomio di Grecità ed Età di Goethe - come dice il titolo, Griechentum und Goethezeit - l’ha scritto non a caso il grande germanista che ha curato la prima edizione di queste Lettere di Winckelmann, Walther Rehm, che del resto tu hai conosciuto e frequentato...
Uno dei grandi libri che hanno indagato questo binomio di Grecità ed Età di Goethe - come dice il titolo, Griechentum und Goethezeit - l’ha scritto non a caso il grande germanista che ha curato la prima edizione di queste Lettere di Winckelmann, Walther Rehm, che del resto tu hai conosciuto e frequentato...Claudio Magris - Sì, quando studiavo a Freiburg im Breisgau, in quei semestri 1962-63 che sono stati fondanti per il mio percorso germanistico, ho seguito in modo particolare le lezioni di Walther Rehm, anche perché il mio Maestro Lionello Vincenti, che era suo amico, mi aveva per così dire un po’ affidato a lui. E Rehm - credo fosse il suo ultimo anno di insegnamento - parlava proprio di Grecità e Germania goethiana, riprendendo e rinnovando i suoi antichi studi. È stata per me un’esperienza molto importante, in quella piccola vivacissima Freiburg nella Selva Nera, in cui c’erano anche Heidegger e ogni tanto compariva Celan, che però non ho mai visto, nonostante fossi legato a un altro germanista, più giovane, Gerhart Baumann, che era molto vicino a quella cultura così radicalmente diversa da quella classica. Ma è a Freiburg che, per così dire, ho incontrato la classicità tedesca e anche Winckelmann. Ma Winckelmann fonda forse non tanto il Classico, la Classicità tedesca, quanto il Neoclassicismo - che differenza c’è tra i due?
Maria Fancelli - La nozione di Classico è estesa e antica, ha molte variazioni di senso e spesso si definisce per opposizione (classico-romantico), è difficile da definire sinteticamente, e lo stesso vale per Neoclassico. Comunque, classico è ciò che è divenuto esemplare, che è riconosciuto quale modello e che dispiega la sua esemplarità nel corso delle generazioni e della lunga durata. Questo termine raggiunge il suo massimo potenziale a metà Settecento, quando classico diventa idea portante di un progetto, aspirazione a un sapere organico e unitario, mito fondativo del nuovo.
 Classico indica l’esemplarità del mondo greco nella sua fase più alta ma anche la potenzialità più autentica e più duratura del moderno. Classico per eccellenza è il prodigioso decennio della collaborazione tra Goethe e Schiller (1795-1805), straordinario cantiere della modernità. Neoclassico indica piuttosto movimenti definibili in senso temporale e spaziale, legati a un’epoca o a un periodo storico nel quale si torna a sentire l’esemplarità dei valori etici, formali ed estetici del Classico, il bisogno del decoro e della misura. Epoche in cui le speranze del rinnovamento politico paiono meno forti e prevale il ritorno a modelli antichi più imitati che ricreati, forme levigate e nobili, Antonio Canova, il Foscolo de Le grazie.
Classico indica l’esemplarità del mondo greco nella sua fase più alta ma anche la potenzialità più autentica e più duratura del moderno. Classico per eccellenza è il prodigioso decennio della collaborazione tra Goethe e Schiller (1795-1805), straordinario cantiere della modernità. Neoclassico indica piuttosto movimenti definibili in senso temporale e spaziale, legati a un’epoca o a un periodo storico nel quale si torna a sentire l’esemplarità dei valori etici, formali ed estetici del Classico, il bisogno del decoro e della misura. Epoche in cui le speranze del rinnovamento politico paiono meno forti e prevale il ritorno a modelli antichi più imitati che ricreati, forme levigate e nobili, Antonio Canova, il Foscolo de Le grazie.Claudio Magris - Forse Winckelmann è il padre di entrambi, classico e neoclassico... Nei mesi trascorsi a Firenze tra il 1758 e il 1759, si è occupato pure di arte etrusca, come testimonia la mostra in corso (fino al 30 gennaio 2017) al Salone del Nibbio del Museo Archeologico di Firenze, curata da Giovannangelo Camporeale e Stefano Bruni. Quale significato ha questa sua esperienza nella sua vita e nella sua opera?
Maria Fancelli - La mostra lascerà un segno nel campo degli studi winckelmanniani e, quel che più conta, susciterà domande e nuove ricerche: sulla malinconia degli Etruschi, sulla linea che lega gli Etruschi all’arte di Michelangelo. Lo dimostra il prestigioso catalogo uscito in versione italiana e tedesca a cura di Barbara Arbeid, Stefano Bruni e Mario Iozzo per l’Ets di Pisa. Pur affascinato dagli Etruschi, che comunque conosceva solo in parte, Winckelmann scrive che alla loro arte mancava «la grazia», un concetto chiave del Neoclassicismo. Sì, forse Winckelmann è stato il padre del Classico e del Neoclassico, ma è stato soprattutto il fondatore di quell’età che sarà detta classica per eccellenza e che altri renderanno, per sempre, «esemplare», da Goethe a Schiller a Hölderlin. Una classicità non certo levigata ma vitale, inquietante, anche esplosiva.
-
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE -- La prima donna alla Royal Society (di Franco Giudice)21 giugno 2016, di Federico La Sala
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"!
 VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura
VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura
La prima donna alla Royal Society
di Franco Giudice (Il Sole-24 Ore, Domenica, 19 Giugno 2016)
- David Cunning, Cavendish, Routledge, Abingdon, pagg. 322, € 103
È innegabile. Nelle tradizionali storie della filosofia e della scienza, le donne non figurano mai tra i cosiddetti autori canonici, quasi che una coltre di oblio volesse sottrarle alla nostra memoria storica. Così, anche se ora sappiamo che nel XVII secolo diverse donne si occuparono di scienza e filosofia, per lunghissimo tempo i loro libri sono rimasti pressoché invisibili, come se fossero stati scritti con inchiostro simpatico.
Un destino davvero beffardo, tanto più se consideriamo che quei libri suscitarono all’epoca notevole interesse e discussioni vivaci. Ma per rendersene conto, si è dovuto aspettare fino agli anni Settanta del Novecento, quando l’onda lunga dei movimenti femministi ha portato, soprattutto negli Stati Uniti, alla creazione di numerosi dipartimenti universitari di women studies, al proliferare di riviste specializzate, e alla riscoperta appunto del ruolo delle donne nello sviluppo della filosofia e della scienza in età moderna. Gli studi che ne sono derivati - non tutti, bisogna riconoscerlo, convincenti e con tesi sempre condivisibili - ci hanno restituito un panorama più variegato, popolato da figure femminili spesso trascurate, gettando una luce inattesa su ambienti culturali solo in parte noti. A tal punto che oggi, almeno nel mondo anglosassone, i risultati di tali ricerche trovano accoglienza in ogni buon manuale politically correct, dove non manca mai un capitolo sulle women philosophers o sulle women scientists.
In questa ricca e ormai quasi incontrollabile letteratura, un posto di primo piano è occupato da Margaret Cavendish, duchessa di Newcastle. Negli ultimi anni, i lavori sulla storia della sua vita, sulle sue opere e sul contesto in cui visse sono aumentati a un ritmo così incalzante da costituire un autentico filone di studi specialistici. Ai quali si deve ora aggiungere il libro di David Cunning: un’accessibile e documentata introduzione alla filosofia della Cavendish e alla sua evoluzione. La duchessa di Newcastle fu una delle più affascinanti e dotate figure intellettuali del Seicento inglese. Basti pensare che in un periodo storico in cui era piuttosto insolito che le donne si cimentassero con problemi di filosofia naturale, lei scrisse ben sei libri sull’argomento. Non solo: diede alle stampe poemi, testi teatrali, orazioni, discorsi, e perfino un’opera di fantascienza.
Un’autrice dunque prolifica, che arrivò a pubblicare qualcosa come ventitré volumi e che, pur essendo nota ai contemporanei per i suoi lavori letterari, si distinse anche per la sua attività filosofica. Anzi, fu soprattutto a tale attività che dedicò gran parte delle proprie energie, elaborando una dottrina sistematica e originale. Che si rivela ancor più sorprendente, giacché la duchessa, come ci ricorda Cunning, era priva di un’istruzione accademica formale.
Nata nel 1623 a Colchester, nella contea dell’Essex, da una famiglia della piccola nobiltà terriera, Margaret Lucas, questo il suo nome da nubile, aveva ricevuto la tipica educazione riservata alle ragazze del suo rango: le fu cioè insegnato, oltre a leggere e scrivere, canto, danza e poco altro. Nonostante un’istruzione così modesta, da lei stessa deplorata, riuscì ugualmente a farsi una straordinaria cultura filosofica e scientifica che le consentì di essere informata sulle più importanti e dibattute questioni del suo tempo. E a rendere possibile tutto ciò fu un evento che cambiò per sempre la sua vita: il matrimonio con William Cavendish, duca di Newcastle.
Eminente personaggio di corte e convinto realista, William Cavendish nutriva un profondo interesse per la filosofia e le scienze, e insieme al fratello Charles, un matematico di talento, fin dagli anni trenta del Seicento avevano creato una sorta di accademia, il cosiddetto circolo di Newcastle, di cui facevano parte alcuni dei pensatori più innovativi dell’epoca, tra cui Thomas Hobbes.
Durante la guerra civile inglese, questo gruppo, che condivideva una concezione meccanicistica della natura, espatriò a Parigi, entrando in contatto con gli intellettuali che gravitavano intorno al padre Marin Mersenne, il segretario della République des Lettres. E fu proprio a Parigi - dove si trovava anche lei in esilio come damigella d’onore della regina Enrichetta Maria, moglie di Carlo I d’Inghilterra - che nel 1644 Margaret incontrò il duca di Newcastle, che sposò l’anno dopo. Grazie alla ricca rete di relazioni dei fratelli Cavendish, Margaret scoprì un mondo forse prima nemmeno sospettato, dove poteva partecipare all’esecuzione di elaborati esperimenti scientifici e compiere osservazioni con i microscopi e i telescopi dell’imponente collezione messa insieme dal duca, che vantava due esemplari costruiti da Torricelli.
Nella residenza parigina del marito, oltre a Hobbes, la cui impostazione materialistica avrebbe esercitato un’enorme influenza sulla sua evoluzione filosofica, conobbe Mersenne, Descartes e Gassendi. Tutti autori che avevano formulato sistemi filosofici alternativi alla tradizione aristotelica ancora dominante nelle università, e di cui Margaret divorò le opere. Un lavoro insomma di studio e di ricerca, che non abbandonò più e che dal 1660, quando dopo la Restaurazione ritornò in Inghilterra, proseguì con maggiore intensità, leggendo gli scritti di Galileo e di William Harvey, così come di Robert Boyle e di Robert Hooke, due dei principali esponenti della filosofia sperimentale propugnata dalla Royal Society.
Ma la duchessa di Newcastle, come a ragione sottolinea Cunning, non voleva essere una semplice spettatrice della rivoluzione scientifica. Convinta che le competenze acquisite negli anni le avessero consentito di elaborare un originale sistema filosofico in grado di rivaleggiare con quelli dei suoi contemporanei, intendeva ritagliarsi un ruolo da protagonista. Anzi, come scrisse in una delle sue prime opere, «non desidero altro che la fama». Ovviamente, sapeva bene di vivere in un’epoca in cui la filosofia era territorio esclusivo degli uomini, e che forse anche le stesse donne l’avrebbero biasimata: «immagino che sarò censurata da quelle del mio stesso sesso e che gli uomini considereranno il mio libro con un sorriso di scherno, pensando che le donne ambiscano ad arrogarsi molte delle loro prerogative, ritenendo che i libri siano la loro corona e la spada lo scettro con cui regnano e governano». Ciò, tuttavia, non le impedì di sfidare le convenzioni sociali né, tanto meno, di rivendicare il diritto di rendere pubblica la propria concezione del mondo.
In tutte le opere di filosofia naturale, Margaret Cavendish articolò un materialismo di tipo organicistico dove la materia, a differenza di quanto pensavano i meccanicisti come Hobbes e Descartes, non era inerte e passiva, ma possedeva un movimento intrinseco, era cosciente di sé e dotata di percezione. A suo avviso, in natura non esisteva alcuna sostanza incorporea, e sosteneva che anche l’anima, per quanto più rarefatta e più pura, fosse corporea. Idee poco ortodosse, che la duchessa esprimeva con uno stile creativo estremamente personale, confidando che la scienza avrebbe tratto grandi vantaggi dall’essere presentata in modo immaginifico. Così, nello spiegare come gli atomi, con i loro principi attivi, possano creare diversi mondi, li paragonava agli «operai che costruiscono le case», e assimilava il loro movimento alla «danza».
Nel suo libro, Cunning offre una dettagliata analisi della dottrina della Cavendish, che trovò la sua esposizione più completa e matura nelle Observations upon Experimental Philosophy del 1666. In questo testo, la duchessa di Newcastle non si limitava a riproporre in forma sistematica tutti gli elementi della sua filosofia naturale, ma esprimeva anche una critica razionalistica della scienza sperimentale praticata dalla Royal Society. Un attacco duro, rivolto soprattutto a Hooke, il celebre autore della Micrographia (1665), e che prendeva di mira l’eccessivo entusiasmo per strumenti come il telescopio e il microscopio, da lei considerati, per averne avuta esperienza diretta, non sempre attendibili e spesso ingannevoli.
Non stupisce dunque che quando nel maggio 1667, dopo lunghe trattative, poté infine partecipare a una seduta della Royal Society - ed era la prima volta che un simile “privilegio” veniva concesso a una donna - si trovò di fronte una folla di curiosi, accorsi lì per vedere questa eccentrica figura femminile che varcava la soglia del tempio della scienza. La duchessa di Newcastle morì il 15 dicembre 1673, e fu seppellita nell’abbazia di Westminster come un personaggio di fama riconosciuta, proprio quella fama da lei tanto agognata. Ma ci sono voluti più di tre secoli per stabilire il valore dei suoi contributi e per correggere giudizi poco generosi e troppo affrettati. Come quello, assai autorevole e influente, di Virginia Woolf che nel Lettore comune (1925) la definì una donna «irrequieta e contorta», accusandola addirittura, in Una stanza tutta per sé (1929), di aver «buttato via il proprio tempo scribacchiando cose senza senso e sprofondando sempre più nell’oscurità e nella follia».
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"!
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE -- i MAESTRI DEL DISPREZZO PER LE DONNE,8 giugno 2016, di Federico La Sala
I maestri del disprezzo per le donne
di Daniela Monti (Corriere della Sera, 08.06.2016)
Nel 1929 Virginia Woolf, nel saggio Una stanza tutta per sé, inventa una storia: quella di Judith, ipotetica sorella di William Shakespeare, stessa genialità, stessa irrequietezza, stessa voglia di fare del fratello. Per seguire il proprio talento, Judith si istruisce come può, leggendo il poco che trova per casa (ma appena i genitori se ne accorgono, le tolgono i libri e le mettono in mano delle calze da rammendare), rifiuta il matrimonio spezzando il cuore al padre, scappa per inseguire il sogno di fare teatro e viene accolta da un impresario che la schernisce e da un agente teatrale che, impietosito, la mette incinta. Alla fine, non trova altra via di uscita che uccidersi.
Mentre il talento del fratello è celebrato, il suo non vale niente: ha sfidato l’ordine naturale delle cose che la vuole debole, inferiore, indegna di ricevere un’istruzione e, insieme, selvaggia e ingestibile, una a cui mettere fin da subito il guinzaglio; si è illusa di potersi esprimere da donna e artista, senza neppure ricorrere all’espediente di camuffarsi da uomo, che pure è una strada battuta; ha sbagliato tutto, è andata fuori ruolo e infatti non c’è nessuno disposto ad ascoltarla. Così Judith «giace sepolta a un certo incrocio, lì dove ora gli autobus si fermano nei pressi di Elephant and Castle». Potessimo posare una lapide mortuaria, sopra ci sarebbe scritto: coraggiosa e ingenua Judith Shakespeare, vittima di due millenni di pregiudizi contro le donne.
Perché quello contro il genere femminile, «a conti fatti, appare come il più antico, radicato, diffuso pregiudizio che la vicenda umana è stata in grado di produrre», scrive Paolo Ercolani nel suo Contro le donne (Marsilio, pp. 318, e 17,50), resoconto dettagliato di come, dalle origini della società occidentale, scrittori, filosofi, intellettuali abbiano alimentato un dibattito «tutto fra uomini» - le donne sembrano assenti dalla filosofia, se non come oggetto del discorso dei filosofi maschi - «per arrivare a stabilire l’inferiorità inemendabile e irrecuperabile dell’essere femminile». I grandi filosofi greci, i padri della Chiesa, gli illuministi, i rivoluzionari, i filosofi idealisti, persino quel campione della causa femminile che fu John Stuart Mill: un’operazione culturale a senso unico che affonda le radici nella presunta «deficienza fisica» delle donne per poi esportare tale mancanza in altri campi, quelli dell’etica, della morale, dell’organizzazione politica della società.
Fu nell’Atene democratica, «tanto esaltata dalla tradizione occidentale, che si diffuse il costume di imporre alle donne il velo di fronte a situazioni pubbliche e a uomini scapoli, al contrario di quello che accadeva a quel tempo in Persia o in Siria», scrive Ercolani, aprendo il fronte della globalizzazione del pregiudizio, il quale, come le malattie contagiose, è riuscito a infettare culture lontane e all’apparenza inconciliabili, stringendole in un unico blocco misogino.
E loro, le donne? «Molto spesso sono le donne stesse a sminuirsi rispetto al maschio, in una sorta di autofobia indotta da secoli di indottrinamento», scrive Ercolani. Il femminismo, che pure è una delle grandi narrazioni della modernità, resta ai margini del lungo excursus, diventando esso stesso un bersaglio quando «negando l’esistenza di una specificità femminile (differente dal maschio) e prefigurando irrealistici scenari di individui a-sessuati ha finito con il fare da sponda al pensiero misogino».
La via d’uscita proposta sta nel ridefinire i canoni dell’identità e soggettività umana, al di là del «narcisismo di genere». Come scriveva Caterina Botti nel suo Prospettive femministe (Mimesis), «fino a relativamente poco tempo fa l’assenza delle donne dalla filosofia non era considerata una questione degna di nota. Oggi invece lo è».
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
- DAL "CHE COSA" AL "CHI" ... DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant
- IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
- "ANDRAGATHIA" (’NDRANGHETA). IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DEL MACROANTROPO ("UOMO SUPREMO", "SUPERUOMO", "DOMINUS IESUS"): FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT
LA RISATA DI KANT
-
> OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- GLI ETRUSCHI E LA MERAVIGLIA DI ARISTOTELE (di Matteo Nucci)4 aprile 2016, di Federico La Sala
La civiltà che rifiutava l’immortalità letteraria
di Matteo Nucci (la Repubblica, 04.04.2016)
Nel Fedro, Platone si affannò a spiegare il motivo per cui la scrittura debba essere condannata in favore dell’oralità. Gli scritti contengono parole immobili e sterili come pietre, perché non sanno a chi si rivolgono e non sono capaci di rispondere. Le parole vive invece possono offrire risposte e per questo penetrano l’anima di chi ascolta e si rendono immortali. Anche Platone tuttavia sapeva bene che la grande letteratura deve essere scritta perché possa seriamente eternarsi.
Lo sapeva per sé, per quel che scriveva, e lo sapeva perché i canti composti oralmente dagli aedi omerici, quei canti che sarebbero diventati i più eterni fra i poemi epici dell’antichità, vennero fermati dalla scrittura e permisero così ai due eroi dell’Iliade, Ettore e Achille, di rimanere immortali, come essi stessi avevano sognato andando incontro alla fine.
Fu dunque la battaglia contro la morte attraverso la letteratura ciò che mancò agli Etruschi? Difficile stabilirlo. Può darsi che le nuove acquisizioni chiariscano qualcosa.
Per ora, di fronte all’immensa produzione letteraria di Greci e Latini, è lecito supporre che gli Etruschi avessero messo da parte quella speranza di immortalità letteraria e cercassero di procurarsela solo attraverso il culto, la religione, la cura del morto e tutto ciò che della loro civiltà ci resta con chiarezza. Ma può darsi che ci sia anche altro. Può darsi che sospettassero già quella che è la dannata disillusione raccontata dall’Odissea omerica attraverso le parole di Achille, quando morto nell’Ade incontra Odisseo. Non importa più al grande eroe quel che aveva sognato quando era in vita. Non gli importa più che ci siano poeti che ne cantano la gloria. Preferirebbe vivere la condizione peggiore, quella del servo, pur di vivere.
La letteratura dunque fallisce nel suo sogno di immortalità? Forse questo immaginavano gli Etruschi. E perciò scelsero di dedicarsi completamente a vivere questa vita e non perder tempo negli inutili giochi della letteratura. Forse.
Un’unica idea potrebbe confermare questa ipotesi che li rese così lontani dai “vicini” Greci e Latini. Ossia la più sorprendente delle loro conquiste: la condizione della donna. Aristotele dichiara con meraviglia che le donne mangiavano assieme agli uomini e con essi dunque discutevano alla pari. Teopompo ci racconta dello straordinario equilibrio che si raggiunse in quella società così unica in cui la libertà sessuale e la ricerca del piacere erano centro indiscusso. Forse gli Etruschi avevano semplicemente capito come vivere bene questa vita. Ed eliminarono tutto quello che non gli parve necessario, tra cui le più volatili illusioni di immortalità, quelle della letteratura.
*
L’autore è uno scrittore, grecista, studioso del pensiero antico. Ha pubblicato saggi su Empedocle, Socrate e Platone. Il suo ultimo libro è Le lacrime degli eroi ( Einaudi)
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- «Calibano e la strega»: i colpevoli roghi della storia europea e le lotte delle donne (di Anna Curcio)30 marzo 2016, di Federico La Sala
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
I colpevoli roghi della storia europea e le lotte delle donne
«Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria» di Silvia Federici per Mimesis. Una lettura dell’accumulazione originaria di Marx, per riscoprirne centralità e tuttavia parzialità. E la narrazione politica della caccia alle streghe come «guerra di classe»
di Anna Curcio (il manifesto, 30.03.2016)
«Come le recinzioni espropriarono i contadini dalle terre comunali, così la caccia alle streghe espropriò le donne dal proprio corpo, liberato, a funzionare come una macchina per la produzione della forza-lavoro». Questa in sintesi l’ipotesi teorica che Silvia Federici propone in Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria, edizione riveduta e aggiornata di Il grande Calibano - classico del femminismo marxista che Federici scrisse con Leopoldina Fortunati negli anni Ottanta - finalmente anche in traduzione italiana (Autonomedia 2014, ora Mimesis, pp. 234, euro 30,00).
 Ripensare lo sviluppo del capitalismo da un punto di vista femminista, considerando cioè l’accumulazione e riproduzione della forza-lavoro. Non solo dunque accumulazione di «lavoro morto» come beni espropriati con la recinzione delle terre o attraverso la razzia coloniale che Marx considera, seppur con peso tra loro differente, ma anche accumulazione di «lavoro vivo» sotto forma di esseri umani, resi disponibili allo sfruttamento dal controllo esercitato sul corpo delle donne.
Ripensare lo sviluppo del capitalismo da un punto di vista femminista, considerando cioè l’accumulazione e riproduzione della forza-lavoro. Non solo dunque accumulazione di «lavoro morto» come beni espropriati con la recinzione delle terre o attraverso la razzia coloniale che Marx considera, seppur con peso tra loro differente, ma anche accumulazione di «lavoro vivo» sotto forma di esseri umani, resi disponibili allo sfruttamento dal controllo esercitato sul corpo delle donne.Nell’assumere il proletariato industriale salariato quale protagonista dell’accumulazione originaria Marx ha perso di vista le profonde trasformazioni che il capitalismo ha introdotto nella riproduzione della forza-lavoro e nella posizione sociale delle donne. Intorno a questa ipotesi Federici intreccia la trama, spesso taciuta, delle lotte che hanno accompagnato la transizione al capitalismo. Così donne, contadini, piccoli artigiani e vagabondi, perlopiù cancellati dalla storia, assurgono in Calibano e la strega a veri protagonisti. Ripercorrendo la storia della caccia alle streghe nel Medioevo, il volume evidenzia i processi di criminalizzazione e degradazione sociale che colpirono le donne, il loro lavoro, i loro saperi e pratiche all’indomani della crisi demografica seguita alla Peste Nera europea. Allo stesso tempo, intreccia i destini delle streghe in Europa a quello dei sudditi coloniali nel Nuovo Mondo, insistendo sui processi di inferiorizzazione e sulla costruzione di gerarchie razziali che accompagnano l’espansione coloniale.
L’accumulazione capitalistica che Federici marxianamente indaga è soprattutto «di differenze», di ineguaglianze e gerarchie costruite sul terreno del genere e della razza; processi di segmentazione sociale costitutivi del dominio di classe. Per questo la femminista non ha dubbi: la caccia alle streghe è «guerra di classe portata avanti con altri mezzi».
Due secoli di «terrorismo di stato», tra il XVI e il XVII secolo, avrebbero dunque insegnato agli uomini a temere il potere delle donne, soprattutto il controllo esercitato sulla funzione riproduttiva. Mentre la donna «prodotta» come essere sui generis, «lussuriosa e incapace di governarsi» fu sottoposta al controllo maschile.
 Federici ribadisce così il carattere artificiale dei ruoli sessuali nella società capitalistica. La stessa sessualità femminile venne sanzionata, criminalizzando quelle attività non orientate alla procreazione e al sostegno della famiglia; la prostituzione, la nudità e le danze furono proibite e la sessualità collettiva al centro della vita sociale nel medioevo divenne «incontro politico sovversivo» del sabba.
Federici ribadisce così il carattere artificiale dei ruoli sessuali nella società capitalistica. La stessa sessualità femminile venne sanzionata, criminalizzando quelle attività non orientate alla procreazione e al sostegno della famiglia; la prostituzione, la nudità e le danze furono proibite e la sessualità collettiva al centro della vita sociale nel medioevo divenne «incontro politico sovversivo» del sabba.
 Le nuove coordinate della femminilità si orienteranno allora tra «lavoro di servizio all’uomo e all’attività produttiva», monogamia e una nuova concezione della famiglia «con il marito sovrano e la moglie suddita del suo potere», mentre il corpo della donna diventava macchina della riproduzione.
Le nuove coordinate della femminilità si orienteranno allora tra «lavoro di servizio all’uomo e all’attività produttiva», monogamia e una nuova concezione della famiglia «con il marito sovrano e la moglie suddita del suo potere», mentre il corpo della donna diventava macchina della riproduzione.
 In questo senso, la caccia alle streghe è soprattutto «lotta contro il corpo ribelle»: il tentativo messo in atto da chiesa e stato per trasformare le capacità dell’individuo in forza-lavoro; cosa che mistificherà, da lì in avanti, il lavoro orientato alla riproduzione come destino biologico. Il corpo - l’utero in particolare - si fa dunque «macchina da lavoro»: bestia mostruosa da disciplinare da una parte, involucro e «contenitore» della forza-lavoro dall’altra, salendo alla ribalta del pensiero politico del tempo (da Hobbes a Descartes) come prerequisito per l’accumulazione capitalistica. Non sorprenderà allora che ogni pratica abortiva o contraccettiva sia stata condannata come maleficio, così le donne espulse da quelle attività come l’ostetricia o la medicina che avevano fin lì esercitato sulla base di saperi tramandati nel tempo.
In questo senso, la caccia alle streghe è soprattutto «lotta contro il corpo ribelle»: il tentativo messo in atto da chiesa e stato per trasformare le capacità dell’individuo in forza-lavoro; cosa che mistificherà, da lì in avanti, il lavoro orientato alla riproduzione come destino biologico. Il corpo - l’utero in particolare - si fa dunque «macchina da lavoro»: bestia mostruosa da disciplinare da una parte, involucro e «contenitore» della forza-lavoro dall’altra, salendo alla ribalta del pensiero politico del tempo (da Hobbes a Descartes) come prerequisito per l’accumulazione capitalistica. Non sorprenderà allora che ogni pratica abortiva o contraccettiva sia stata condannata come maleficio, così le donne espulse da quelle attività come l’ostetricia o la medicina che avevano fin lì esercitato sulla base di saperi tramandati nel tempo.Una vera e propria «politica del corpo» sottolinea Federici, in cui il corpo non è fattore biologico né il «soggetto universale, astratto, asessuato» della Storia della sessualità di Foucault, precisa, bensì è un corpo situato, denso di «rapporti sociali» (non solo di «pratiche discorsive») fonte di sfruttamento e alienazione e al contempo spazio di resistenza. E nella misura in cui, come Federici tra altri sottolinea, l’accumulazione originaria è un processo che si ripete in ogni fase dello sviluppo capitalistico e dentro le sue crisi, il corpo e le attività legate alla riproduzione restano oggi, come agli albori del capitalismo, un campo di battaglia. E qui si rintraccia l’estrema attualità di Calibano e la strega.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE - ARISTOTELE E FILLIDE. La donna che volle cavalcare Aristotele.28 gennaio 2016
- A PARTIRE DA PLATONE E ARISTOTELE, L’INTERA TRADIZIONE FILOSOFICA ha sempre sostenuto “per diritto naturale che la materia obbedisca alla forma, il corpo all’anima, l’appetito alla ragione, i bruti all’uomo, la moglie al marito, l’imperfetto al perfetto, il peggiore al migliore, per il bene dell’uno e l’altro dei due”
Fillide, la donna che volle cavalcare Aristotele
di Donatella Cianci (Il Sole-24 Ore, Domenica, 21/07/2013)
Aristotele ha parlato dell’akrasia, della debolezza della volontà rispetto alla virtù rafforzata dall’etica e probabilmente ne aveva fatto esperienza nella sua quotidianità con le donne. Una leggenda poco nota, forse la più stravagante di tutta l’iconografia aristotelica, lo raffigura anziano e piegato, mentre si fa cavalcare sulle sue spalle da una giovane donna.
La ragazza probabilmente era Fillide, “primadonna” esempio della debolezza filosofica, come ricorda lo studioso Infurna in un volumetto pubblicato per i tipi di Carocci, il quale sottolinea che i primi a parlare di questa vicenda, in Occidente, son stati Jacques de Vitry e Henri d’Andeli, quest’ultimo in un poemetto dei primi del Duecento, nel quale si dice: «Quella donna è bella davvero. Mi piacerebbe vedere come sta addosso. Rendimi questo servizio! Se presto arriverò alla fonte, volentieri ti concederò di baciare all’istante la mia bocca». La donna desiderava “cavalcare” uno dei più importanti filosofi dell’Occidente e ci sarebbe riuscita, probabilmente mentre il giovane Alessandro (poi divenuto Magno) se la spassava a guardare quanto l’anziano maestro avesse perso il senno per quella sua follia d’amore.
Un prezioso e originale volumetto a cura di Marco Infurna (Henri d’Andeli, Il Lai di Aristotele, Carocci, 2005) ricostruiva le origini di questa storiella, forse di origine orientale, poi approdata in area francese. In Italia l’episodio è ricordato da Brunetto Latini nei Livres dou tresor, da Paolo Zoppo e da Enea Silvio Piccolomini, fonti che raramente si menzionano. Nel XIV secolo la leggenda è invece citata da Francesco da Barberino nel suo trattato Del reggimento e dei costumi delle donne.
In ambito iconografico, come mostra un’ampia ricerca non ancora pubblicata, le raffigurazioni sono centinaia, una molto nota è quella che si vede a San Gimignano.
- Memmo di Filippuccio, Fillide e Aristotele - particolare dagli affreschi dal Palazzo Comunale di San Gimignano (Siena) - inizio XIV secolo.
Ma come mai l’episodio ha avuto una tale ricezione? Certamente l’eccitazione e la passione amorosa del severo filosofo colpì i più curiosi, tanto che Bedier, nel 1926, pensò che Aristotele fosse impazzito a causa del suo intenso lavoro. Invece, come ricordato anche ne Il lancio del nano da Armando Massarenti (Come smettere di fumare, Aristotele vs Platone), Aristotele era conscio e tollerante verso la debolezza umana, verso la passione, concetto ribadito in studi degli anni ’90 di ambito anglosassone, che evidenziano una discrepanza fra il livello normativo e l’effettivo agire.
Infurna non fa riferimento alle fonti greche, ma è interessante notare come nella biografia aristotelica spunti il nome di una certa “Erpillide”, che fosse proprio Fillide? Il retore Alcifrone scrisse che lo Stagirita si stava facendo dilapidare il patrimonio da quella ragazzina: «Sei diventato matto Eutidemo, non sai dunque chi è in realtà quel saggio dall’aria così arcigna, che vi espone tutti quei discorsi elevati, ma quanto tempo credi che sia passato da quando mi ha dato il tormento perché vuole uscire con me? Tra l’altro, si fa consumare il patrimonio da Erpillide, la sua favorita di Megara». Dalla donna probabilmente Aristotele ebbe anche un figlio. Il nome torna anche in Eusebio, nel lessico Suda e persino nel biografo dei filosofi, Diogene Laerzio.
Per saperne di più:
 Henri d’Andeli, Il Lai di Aristotele, a cura di Marco Infurna, Firenze, Carocci, 2005;
Henri d’Andeli, Il Lai di Aristotele, a cura di Marco Infurna, Firenze, Carocci, 2005;
 Raffaele di Cesare, Di nuovo sulla leggenda di Aristotele cavalcato: in margine ad una recente edizione del Lai d’Aristote di Henri de Andeli, Milano, Vita e Pensiero, 1956;
Raffaele di Cesare, Di nuovo sulla leggenda di Aristotele cavalcato: in margine ad una recente edizione del Lai d’Aristote di Henri de Andeli, Milano, Vita e Pensiero, 1956;
 Id., Due recenti studi sulla leggenda di Aristotele cavalcato, Milano, Università Cattolica del S. Cuore, 1957;
Id., Due recenti studi sulla leggenda di Aristotele cavalcato, Milano, Università Cattolica del S. Cuore, 1957;
 Laura Dal Prà, Roberto Perini, Artigianelli, Il ciclo pittorico di Castel Pietra al tramonto dell’età cortese, Trento, Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, 1992;
Laura Dal Prà, Roberto Perini, Artigianelli, Il ciclo pittorico di Castel Pietra al tramonto dell’età cortese, Trento, Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, 1992;
 Le vie del gotico: il Trentino fra Trecento e Quattrocento, a cura di Laura Dal Prà, Ezio Chini, Marina Botteri, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni culturali, Ufficio beni storico-artistici, 2002.
Le vie del gotico: il Trentino fra Trecento e Quattrocento, a cura di Laura Dal Prà, Ezio Chini, Marina Botteri, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni culturali, Ufficio beni storico-artistici, 2002. -
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Quando le ateniesi scoprirono l’arma del sesso (di Mirella Serri)9 settembre 2015, di Federico La Sala
Quando le ateniesi scoprirono l’arma del sesso
Mentre la città assiste alla prima della Lisistrata due giovani vengono brutalmente violentate: un affresco crudo e avvincente della Grecia nel 411 a. C. con le donne che combattono per la giustizia e la democrazia contro gli oligarchi
di Mirella Serri (La Stampa/TuttoLibri, 05.09.2015)
«La Grecia antica sembra molto lontana, ma non è così. E’ stata il laboratorio delle più scottanti questioni politiche che ancora adesso dominano lo scenario internazionale, dalla gestione della democrazia ai governi dittatoriali. Al tempo della guerra del Peloponneso si protestava contro gli oligarchi ateniesi e ora, analogamente, lo scontro avviene con i vertici della finanza internazionale. Nel mondo classico Atene era il cuore dell’Impero, forte e straricca. Attualmente proprio la piccola e marginale patria di Alexis Tsipras ha infastidito e messo in crisi le capitali mondiali in cui si concentrano risorse economiche e potere». Grecia di ieri e di oggi: lo storico e narratore Alessandro Barbero, di cui è in uscita l’avvincente romanzo Le Ateniesi, individua nel passato uno specchio della nostra complicata modernità. E lo fa raccontando una vicenda dura e coinvolgente, un terribile abuso sessuale di gruppo che avviene mentre tutta Atene è sugli spalti per assistere alla prima della Lisistrata, la commedia in cui Aristofane, scandalizzando un contesto sociale in cui le donne non avevano alcuna autonomia, immagina una netta presa di posizione femminile di fronte al protrarsi del conflitto.
Medievista per formazione e traditore per vocazione - ha ambientato, per esempio, in epoca napoleonica Bella vita e guerre altrui di mr. Pyle, gentiluomo, con cui ha vinto il premio Strega - l’autore torinese, adesso, si è trasformato in un «viaggiatore incantato» di periodi più remoti. A spingerlo in quest’esplorazione è stata la lettura dei libri di Luciano Canfora e il desiderio di confrontarsi con il «sistema democratico ateniese - spiega Barbero - che assicurava il voto a tutti e offriva anche forme di sussistenza e di reddito garantito per i più poveri». Il prologo delle Ateniesi si apre al suono dei flauti che accompagnano gli spartani in guerra: quella musica ammaliante nella battaglia di Mantinea irretisce e intrappola due opliti ateniesi, Polemone e Trasillo, che finiscono sotto le spade nemiche e vengono feriti ma non a morte. Sette anni dopo l’epico scontro, i due ex combattenti, nonché genitori di due graziose fanciulle, assistono alla rappresentazione della Lisistrata dove le consorti, stanche di essere lasciate sole dai loro mariti, fanno lo sciopero del sesso e occupano l’Acropoli. Grandi protagoniste del romanzo di Barbero, che si svolge alla fine dell’inverno del 411 a.C., sono dunque le donne, al contempo vittime ed eroine.
La violenza sulle due figlie di Polemone e Trasillo si verifica mentre i cittadini di Atene sono a teatro: questa simultaneità degli eventi, l’abuso sessuale e la rivolta femminile, ha un valore simbolico?
«Lo stupro è la manifestazione del profondo disagio degli uomini di fronte al desiderio di emanciparsi delle mogli. Non confondiamo però Lisistrata con le progressiste pacifiste e “di sinistra” dei nostri giorni: l’astinenza tra le lenzuola da lei promossa coincide con il desiderio di pace degli oligarchi che, al contrario della plebe e della gran massa della popolazione, non vedevano nel conflitto un’occasione di guadagno. Nei capitoli in cui narro la rappresentazione teatrale della Lisistrata - che ho personalmente ritradotto dal greco - ho cercato di dar vita alle emozioni degli spettatori, alle urla d’indignazione, ai berci e alle discussioni che accompagnarono lo spettacolo».
Ma il vero e più cruento show si svolge altrove, fuori dal teatro, nella sontuosa magione dove le ragazze, attirate con un inganno, vengono torturate e ridotte in fin di vita da Cimone e dai suoi amici: in queste pagine al lettore sembra di rivivere il massacro compiuto al Circeo dai tre pariolini, esponenti della Roma bene. Era nelle sue intenzioni?
«Ogni generazione conserva la memoria indelebile di qualche eccidio. Mio padre non dimenticò mai la strage di Villarbasse in Piemonte del 1945 in cui dieci persone vennero bastonate e gettate vive in una cisterna. A 16 anni mi s’impresse come un marchio il delitto del Circeo in cui i violentatori erano tali anche per affermare la loro superiorità sociale ed economica».
I ricchi che abusano delle fanciulle sono gli stessi aristocratici che vogliono abbattere le istituzioni democratiche?
«Quello ateniese era un governo del popolo che, è necessario ricordarlo, aveva anche un volto assolutamente spietato. Quando gli abitanti di Melos scelsero di essere neutrali, i combattenti di Atene sgozzarono gli uomini e ridussero in schiavitù donne e bambini. Ho affidato a Crizia, politico, filosofo e scrittore, il compito di organizzare un putsch pacifista con altri nobili riuniti nelle Eterie, le sette segrete che praticavano la lettura di opere poetiche, la pederastia come forma di educazione per i giovani e l’abitudine del simposio esclusivamente maschile».
Nel suo libro i sussulti antidemocratici si risvegliano quando si percepisce una diffusa fragilità. Un altro richiamo alla contemporaneità?
«Mentre scrivevo non pensavo ai nostri giorni più recenti ma al Novecento, all’avvento del fascismo, agli sconvolgimenti dittatoriali che hanno segnato il Sudamerica. Crizia poi diventerà il capo dei Trenta Tiranni e instaurerà il terrore condannando a morte i suoi avversari, cacciando via i meno abbienti dal governo della città, privandoli del voto e di ogni trattamento umano».
In Italia ora, però, non si sente per fortuna alcun tintinnar di sciabole. Cosa ci insegna il mondo classico?
«Stiamo vivendo in un momento di svuotamento e di profonda trasformazione delle istituzioni. La democrazia anche quella moderna è una conquista che non è data una volta per tutte, è instabile e mutevole e va tutelata, questa la lezione dell’antichità, dai soprusi dei più facoltosi e potenti».
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Su filosofia e politica Platone tradì Socrate. "Socrate" di Hannah Arendt.2 settembre 2015, di Federico La Sala
Su filosofia e politica Platone tradì Socrate
Il rapporto fra i due pensatori greci, il ruolo dei sapienti nella polis e la tradizione occidentale in un’originale riflessione di Hannah Arendt
di Hannah Arendt (la Repubblica, 02.09.2015)
Il testo di Hannah Arendt è l’incipit di Socrate, un saggio che compare per la prima volta in traduzione italiana Il volume, a cura di Ilaria Possenti, che ha scritto anche l’introduzione, e con interventi critici di Adriana Cavarero e Simona Forti, è pubblicato da Raffaello Cortina (pagg. 123, euro 11) L’abisso tra filosofia e politica si apre storicamente con il processo e la condanna di Socrate, che nella storia del pensiero politico rappresenta un punto di svolta analogo a quello rappresentato dal processo e dalla condanna di Gesù nella storia della religione. La nostra tradizione di pensiero politico ha inizio quando, con la morte di Socrate, Platone perde ogni speranza nella vita della polis e giunge a mettere in dubbio anche i fondamenti dell’insegnamento socratico.
Il fatto che Socrate non fosse riuscito a persuadere i giudici della propria innocenza e dei propri meriti, che erano così ovvi per i migliori cittadini ateniesi e per i più giovani, aveva indotto Platone a dubitare del valore della persuasione . (...) Per gli Ateniesi la persuasione, peithein , era la forma specificamente politica del discorso. (...) L’argomento centrale di Socrate, nel discorso pronunciato in propria difesa di fronte ai cittadini e ai giudici ateniesi, era l’aver sempre agito nell’interesse della città. Nel Critone , lo vediamo spiegare agli amici che non può fuggire, e che deve anzi accettare la pena di morte, per ragioni politiche e filosofiche. Ma pare che Socrate non sia riuscito a persuadere i suoi giudici, né tantomeno a convincere i suoi amici. Per così dire, la città non sapeva che farsene di un filosofo e gli amici non sapevano che farsene dell’argomentazione politica.
Tutto questo rientra nella tragedia di cui i dialoghi platonici recano testimonianza. Strettamente connessa al dubbio sul valore della persuasione è la furiosa denuncia che Platone fa della doxa , l’opinione. Questa denuncia, oltre a percorrere come un filo rosso le sue opere politiche, diventa una delle pietre angolari del suo concetto di verità. In Platone la verità è sempre intesa, anche quando la doxa non è menzionata, come l’esatto opposto dell’opinione ( doxa).
È lo spettacolo di Socrate che sottopone la propria doxa alle opinioni irresponsabili degli Ateniesi, e che viene infine sconfitto da una maggioranza, a spingere Platone al disprezzo delle opinioni e a fare di lui un ardente fautore di criteri assoluti - cioè di criteri in base ai quali le azioni umane possano essere giudicate e il pensiero umano possa acquisire un certo grado di esattezza. Da quel momento, sarà questo l’impulso primario della sua filosofia politica, e tale impulso influenzerà in modo decisivo anche la dottrina puramente filosofica delle idee.
Personalmente non penso, come spesso si sostiene, che il concetto delle idee fosse in primo luogo un concetto di standard e misure, né penso che la sua origine fosse politica. Ma questo equivoco è tanto più comprensibile e giustificabile dal momento in cui Platone è il primo a usare le idee per scopi politici, cioè per introdurre criteri assoluti nella sfera degli affari umani, dove, senza criteri trascendenti di questo tipo, tutto resta relativo. Come lo stesso Platone era solito far notare, noi non sappiamo che cosa sia la grandezza assoluta, ma abbiamo solo esperienza del fatto che qualcosa è più grande o più piccolo di qualcos’altro.
Sicuramente, la contrapposizione tra verità e opinione è la conclusione più antisocratica che Platone potesse trarre dal processo di Socrate. Ai suoi occhi, fallendo nel tentativo di convincere i cittadini, Socrate aveva mostrato che la città non è un posto sicuro per il filosofo: non solo nel senso che il possesso della verità mette in pericolo la vita del filosofo; ma anche nel senso, assai più rilevante, che non si può fare affidamento sulla città per preservare la memoria del filosofo, la sua presumibile grandezza e la fama immortale che gli è dovuta. Se erano arrivati a uccidere Socrate, gli Ateniesi sarebbero stati fin troppo propensi a dimenticarlo una volta morto. Per salvaguardare la sua immortalità terrena, occorreva incoraggiare i filosofi a una solidarietà tutta loro, contrapposta alla solidarietà con la polis e con i concittadini. Per questo Platone avrebbe infine rivoltato contro la città un vecchio argomento usato contro i sophoi (i sapienti), e ancora presente in Platone e Aristotele: i sapienti non sanno che cosa sia bene per loro (che è il prerequisito della saggezza politica), appaiono ridicoli quando si mostrano nella piazza del mercato, e sono di fatto lo zimbello di tutti (come Talete, che fu deriso da una giovane contadina quando si mise a fissare il cielo e cadde nel pozzo ai suoi piedi).
Per comprendere l’enormità [della replica di Platone, cioè] della pretesa che il filosofo governi la città, dobbiamo tenere ben presenti questi comuni pregiudizi, che la polis nutriva nei confronti dei filosofi ma non nei confronti di artisti e poeti: solo il sophos non sa che cosa sia bene per se stesso, e ancora meno sa che cosa sia bene per la polis . L’ideale platonico del sophos o sapiente che governa la città deve qui essere inteso in contrapposizione all’ideale comune del phronimos , colui che è capace di comprensione, e che in virtù della sua perspicacia negli affari umani è qualificato per la leadership - ma non per regnare. Nella polis la filosofia, l’amore per la sapienza, non era affatto identificata con la saggezza, con la phronesis . Il sapiente, infatti, si occupa di questioni estranee alla vita della polis . E Aristotele concorda pienamente con l’opinione comune quando afferma: «Anassagora e Talete erano sapienti ma non saggi. Non si interessavano di ciò che è bene per gli uomini - gli anthropina agatha».
Ora, Platone non negava che il filosofo si occupasse di argomenti eterni, immutabili, non umani. Ma non era d’accordo sul fatto che ciò lo rendesse inadatto a un ruolo politico. Ossia non era d’accordo con la polis , secondo la quale il filosofo, proprio perché disinteressato a ciò che è bene per gli uomini, corre continuamente il pericolo di diventare un buono a nulla (...). Questa accusa, e cioè che la filosofia possa fiaccare le qualità del cittadino, è implicitamente contenuta nella famosa affermazione di Pericle: «Amiamo il bello senza esagerazione e amiamo la sapienza senza sdolcinature ed effeminatezze». In altri termini, diversamente da noi e dai nostri pregiudizi, che imputano “sdolcinature” ed “effeminatezze” all’amore per il bello, i Greci vedevano pericoli di questo tipo nella filosofia. La filosofia, intesa come interesse per il vero senza riguardo per gli affari umani (e non come amore per il bello, che era rappresentato dappertutto nella polis , nelle statue come nella poesia), spingeva i filosofi fuori dalla polis e li rendeva incapaci di occuparsene.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE -- Il Rinascimento perduto, ma non solo (di Mauro Bonazzi)30 luglio 2015, di Federico La Sala
Il Rinascimento perduto, ma non solo
di Mauro Bonazzi (Il Mulino, 29 luglio 2015) *
Ci sono libri che offrono molto più di quanto il titolo prometta. Così, il lettore che aprisse lo studio di Celenza (Il Rinascimento perduto. La letteratura latina nella cultura italiana del Quattrocento, Carocci, 2014) potrebbe attendersi una dotta disquisizione sulla produzione letteraria in lingua latina tra Quattro e Cinquecento. Che è ovviamente quello che troverebbe. Ma insieme troverà altro ed è questo che fa la differenza: una riflessione complessiva su cosa sono Umanesimo e Rinascimento e su cosa essi significano per noi - o meglio una discussione sulle ragioni del crescente oblio che sta avvolgendo quel periodo della nostra storia, e una spiegazione dei rischi che questo comporta.
Nessuno lo nega: Umanesimo e Rinascimento costituiscono per tutti una pagina gloriosa della storia umana, una vetta dello spirito, che ha prodotto opere meravigliose. Ma una pagina gloriosa di cui, una volta che gli si è tributato l’omaggio di convenienza, ci si dimentica in fretta, presi come si è da problemi più seri. Si potrebbe pensare che questo sia il destino inevitabile che attende tutte le epoche del passato; e magari è così. Ma almeno dovrebbe essere chiaro che questo avviene non per ineluttabili leggi naturali, bensì in conseguenza di decisioni umane, decisioni su cui è giusto riflettere, almeno per chi resista alla mistica dell’hegelismo, per cui quello che accade è giusto per il semplice fatto che accade. Di queste decisioni tratta il libro di Celenza.
Una prima questione riguarda le politiche accademiche. Sintetizzando al massimo, il problema del Rinascimento è in effetti semplice e concreto: questo periodo non ha uno spazio disciplinare ben definito e questo significa che chi ad esso si dedica ha sempre meno possibilità di trovare un posto in università. Il che innesca un circolo vizioso deleterio, dalle conseguenze facilmente prevedibili. Celenza parla del sistema americano, ma le cose da noi non vanno troppo diversamente. Data l’importanza di questo periodo per la nostra storia, quello che sta succedendo dovrebbe dunque suggerire qualche riflessione. Si arriva così al punto più importante.
Il problema saliente non è infatti la denuncia accorata dei rischi a cui va incontro una disciplina accademica. Quello su cui è interessante riflettere sono le ragioni teoriche che stanno alla base di questa tendenza. Il Rinascimento è ormai associato alla storia dell’arte (e ci mancherebbe!), a qualche capolavoro letterario e allo studio di argomenti sempre suggestivi come ad esempio la magia. Ma tutti questi fenomeni, per quanto importanti, erano visti dai contemporanei come sviluppi di un problema più sostanziale. Un problema sostanziale che è la filosofia. Per i contemporanei, la novità del Rinascimento è una novità che ha a che fare con una nuova concezione della filosofia, intesa come un sapere eminentemente pratico e politico, che si contrappone al sapere speculativo della scolastica medievale. Chi, ai giorni nostri, sarebbe d’accordo con questa idea di un Rinascimento eminentemente filosofico? Ma il punto è proprio questo: il problema del Rinascimento è un problema filosofico.
La marginalizzazione dello studio del Rinascimento è infatti il risultato di una storia di lungo corso: dipende da una concezione della filosofia che si è progressivamente imposta nel sistema universitario tedesco nell’Ottocento e che da lì si è diffusa negli altri Paesi.
Naturalmente, i motivi che hanno prodotto un simile risultato sono molteplici, e non vanno sottovalutati. L’importanza che nell’Ottocento veniva accordata alle lingue nazionali cospirava contro il modello rinascimentale che si fondava su una lingua franca come il latino: per chi era convinto che la lingua esprimesse «il genio di un popolo», è evidente che la scelta di scrivere in una lingua estranea aveva di fatto impedito lo sviluppo di una cultura autonoma e capace di parlare dei problemi reali; il mondo degli umanisti è eine Welt des Scheines, aveva scritto il filologo Georg Voigt, «un mondo di apparenze», in cui gli umanisti si muovevano come «meri sofisti, persuasi che il mondo che avevano fondato con il linguaggio fosse il proprio mondo reale» (p. 34). Più in generale, non bisogna poi dimenticare, sottotraccia, il ruolo non indifferente giocato dalla graecomania tipica del mondo tedesco e protestante; anche questo ha giocato contro una valutazione equilibrata della cultura umanistica latina.
Ma la vera ragione della marginalizzazione di Umanesimo e Rinascimento come campo disciplinare autonomo ha a che fare in ultima istanza con la filosofia. L’appiattimento progressivo dei saperi umani sul modello dei saperi scientifici ha imposto con forza crescente una nozione di filosofia intesa come "scienza rigorosa" e teoretica, con la conseguente esclusione di autori e periodi che in questo schema non potevano rientrare. Ecco spiegato il problema del Rinascimento - lo sfasamento di prospettiva tra come noi valutiamo quel periodo e come esso fosse valutato dai suoi protagonisti.
Naturalmente, l’obiettivo di Celenza non è quello di preconizzare un improbabile ritorno ai bei tempi che furono. Piuttosto si tratta di prendere coscienza del fatto che il sapere umano segue un percorso meno lineare, e dunque molto più interessante, di cui vale la pena essere consapevoli. Tra Quattro e Cinquecento la filosofia è esperienza di vita più che sistema dottrinale; s’interessa più alle tecniche argomentative, alla retorica, che ai problemi epistemologici; ha una dimensione pratica, etica e politica, dominante, che la conduce al continuo confronto con lo studio della storia (cfr., ad esempio, pp. 83 e 117).
A partire dall’età moderna a contare sempre di più sarà invece la philosophia naturalis, vale a dire il confronto con la scienza: è una lunga ondata che ancora produce i suoi effetti e che oggi, di fronte ai progressi immensi della ricerca scientifica, rischia di togliere tutto il terreno sotto i piedi della filosofia. Negare l’importanza, storica e teorica, del confronto con le scienze sarebbe ridicolo; ma non meno ridicolo è dimenticarsi che la filosofia non è necessariamente solo questo. L’interesse della polemica di Celenza è in fondo tutta qui: in questo invito a ricordarci che la filosofia è una disciplina più ricca, più ambigua, più complicata, di come spesso si tende a credere. E questo suggerisce qualche considerazione su di noi.
Il contributo che lo studio del pensiero rinascimentale può offrire a una concezione più ricca della filosofia diventa infatti particolarmente significativo proprio se consideriamo il caso italiano. In fondo, se si accetta una nozione teoretica e sistematizzante della filosofia, è forte la tentazione di concludere che non ha molto senso parlare di una filosofia italiana, così come invece si parla di filosofia tedesca, francese, inglese o americana.
Ma non si tratterebbe di un giudizio affrettato? Un giudizio che riflette inconsapevolmente una nozione parziale, troppo ristretta, della filosofia, di cui sarebbe ormai ora di liberarsi? Che la tradizione dell’Italian thought offra strumenti interessanti per pensare la complessità del mondo contemporaneo, proprio in virtù della sua vocazione non sistematica e pratico-politica, è opinione sempre più condivisa, confermata dal successo di numerosi autori italiani all’estero. Quello che vale la pena di ricordare in questa occasione è che è proprio sulla radice rinascimentale che si sono sviluppati questi rampolli moderni.
È una convinzione espressa con chiarezza negli studi recenti di Roberto Esposito, in particolare in Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana del 2010, che trova ora una conferma, dotta e ben articolata, in uno studio recentemente pubblicato in America. In The Other Renaissance. Italian Humanism between Hegel and Heidegger (University of Chiacago Press, 2014) Rocco Rubini (assistant professor all’Università di Chicago) ricostruisce il dibatitto sul Rinascimento che si sviluppò intorno agli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, mostrandone la rilevanza filosofica: non si trattava semplicemente di dibattiti storiografici, ma della rinnovata difesa di una concezione del sapere capace di conseguenze pratiche.
In questo contesto un ruolo di primo piano spetta senza ombra di dubbio a L’umanesimo italiano di Eugenio Garin, inizialmente pubblicato in tedesco nel 1947 presso l’editore Francke di Berna in una collana curata da Ernesto Grassi, insieme - come a farne da contrappunto - alla Lettera sull’umanesimo di Martin Heidegger.
Non si potrebbe dare dimostrazione più plastica di due modi diversi, probabilmente incompatibili, ma entrambi legittimi e interessanti, di intendere la filosofia (e non si potrebbe trovare un esempio più illuminante dell’opposizione culturale tra la Germania “grecomane” e l’Italia rinascimentale e latina).
E se la tradizione metafisica di cui Heidegger, volente o nolente, fa parte è nota, non sarebbe ora di tornare a occuparci anche della tradizione alternativa, secondo cui la filosofia non è più ricerca di verità assolute e intemporali, ma anche «tempo e memoria, e senso della creazione umana e dell’opera terrena e della responsabilità», come scriveva Garin? Integrare Heidegger (ma anche i metafisici analitici contemporanei) con Coluccio Salutati e Leonardo Bruni, i due cancellieri che nella filosofia di Platone e Aristotele avevano trovato un pensiero capace di guidarli nell’amministrazione di Firenze? Perché no, perché non interessarsi anche a una concezione "romana" della filosofia, in una linea di pensiero che dall’umanesimo ci condurrebbe ad esempio all’illuminismo?
* http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:2919
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Storia dei fatti umani. Le tre edizioni della Scienza Nuova e Giambattista Vico a Vatolla14 settembre 2014, di Federico La Sala
Giambattista Vico/1
Storia dei fatti umani
Un nuovo volume con tutte le edizioni della «Scienza nuova» opera a cui il filosofo napoletano lavorò per tutta la sua vita
di Maria Bettetini (Il Sole Domenica, 14.09.2014)
- Giambattista Vico, Opere di Giambattista Vico, vol.9: La Scienza Nuova 1744, a cura di Paolo Cristofolini e Manuela Sanna, Edizioni di Storia Letteratura, Roma, pagg. 376, € 52.00, già in Giambattista Vico, Cento libri per mille anni, a cura di Fulvio Tessitore e Manuela Sanna, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma
- Giambattista Vico, La Scienza nuova, le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, a cura di Manuela Sanna e Vincenzo Vitiello, Bompiani, Milano, pagg. 1.320, € 30.00
Con un curriculum vitae così, Giambattista Vico non potrebbe certo oggi aspirare alla carica di Ministro o Rettore, forse nemmeno Preside. Nato a Napoli in via San Biagio dei Librai il 23 giugno del 1668, figlio appunto di un libraio, quest’uomo di genio, oggetto negli ultimi tempi di attenzioni interdisciplinari, a sette anni cadde e si fratturò il cranio. Le previsioni mediche lo volevano morto o stolido, ma riuscì a seguire la scuola di grammatica dei Gesuiti. Presto però la abbandonò, cercò di studiare da solo, sconfitto tornò dai Gesuiti, che di nuovo lasciò annoiato per studiare Suarez per conto suo. Inutile dire che si iscrisse all’università da privatista e si laureò in giurisprudenza, pur nutrendo interessi soprattutto filosofici. Il giovane Vico si dedicò a studi sempre privati, per vivere insegnò, tentò senza riuscire di avere un posto come segretario in Municipio, si ammalò di tisi, ottenne per un pelo una cattedra di retorica, ma perse il concorso per quella di diritto, a cui teneva tanto.
Gianbattista Vico deve mantenere padre e fratelli, ai quali dal 1699 si aggiungono la moglie Caterina e via via otto figlioli. Scrive su commissione, insegna, pubblica. Alcuni suoi testi vanno perduti, altri sono di tono celebrativo, ma la mole di opere scientifiche a noi giunte è davvero imponente. Fisica, metafisica, filosofia del diritto, i suoi autori di riferimento sono Platone (e i Neoplatonici), Tacito, Bacone, Grozio (da lui chiamato «Ugon capo»), è evidente l’attenzione per il rapporto tra civiltà e presenza divina, vita sociale e valore della storia.
Dopo l’ennesimo concorso universitario andato male, nel 1723, sorpreso e amareggiato, Vico dedica alla scrittura tutte le energie che il mantenimento della famiglia gli lascia. Esce così nel 1725 la prima versione dei Principj di una Scienza Nuova intorno alla natura delle nazioni o più brevemente la Scienza nuova. A quest’era Vico lavorò per tutto il corso della vita, con un’edizione del 1730 integralmente riscritta, anche a seguito di critiche ricevute, e infine quella postuma, rivista del tutto se pur senza grandi modifiche, pubblicata nel 1744, a pochi mesi dalla sua morte, dal figlio Gennaro cui aveva già lasciato il posto di insegnante di retorica. Anche questa sorta di cattedra in eredità fa comprendere come fino all’ultimo Vico dovette occuparsi della famiglia, colpita tra l’altro negli anni da malattie e disgrazie.
Ora le tre edizioni della Scienza nuova sono disponibili grazie a quella che oggi si definisce sezione napoletana dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno, già Centro di studi vichiani. Fu Pietro Piovani, illustre storico della filosofia, a incoraggiare un’edizione critica delle opere di Vico, e in trent’anni sono stati pubblicati, da suoi allievi e da allievi loro, nove volumi del Vico italiano e latino, tra i quali le edizioni della Scienza Nuova: quella del 1730, a cura di Fulvio Tessitore e Manuela Sanna e quella del 1744 a cura di Paolo Cristofolini e sempre Manuela Sanna. Non c’è ancora una edizione critica della Scienza del 1725 e finché non sarà pronta si propone ancora quella di Fausto Nicolini, del quale si conoscono i tentativi di normalizzazione, e quindi di mancato rispetto, del testo vichiano.
Nel frattempo i curatori hanno presentato una doppia uscita editoriale, per Bompiani le tre edizioni in un unico volume, con in nota solo le citazioni delle fonti dirette, introdotte da un saggio di carattere teoretico di Vincenzo Vitiello.
In volumi unici, invece, le singole edizioni della Scienza, ultima quella del 1744 per le Edizioni di Storia e Letteratura, con commenti e apparati più specialistici. Insomma, un librone con i tre testi alla portata del pubblico colto, i volumi separati per i professionisti della storia della filosofia. Tutti comunque, anche i non specialisti, concorderanno nel trovare la prosa di Vico piana e comprensibile, penalizzata da quelli che a noi suonano arcaismi, ma invece erano parte del parlare quotidiano in lingua volgare. Spesso oggi si utilizzano invece gli arcaismi per vezzo, come fiori che dovrebbero innalzare il tono di discorsi già complessi.
Veniamo dunque alla Scienza di Vico, definita anche storia ideale eterna o storia delle umane idee o filosofia dell’autorità: perché «nuova»? Perché, contrapponendosi a Cartesio, Spinoza, Leibniz, Vico intende come principio della conoscenze non il lavoro di un intelletto astratto e purificato, ma i fatti così come si presentano a noi nel presente e nel passato. Il primo «fatto» che appare a ogni umano è il desiderio di vivere eternamente, che rinvia a una forza superiore alla natura, quel Dio che non occorre porre altrimenti in discussione. La religione non è dunque campo della fede, ma principio di spiegazione razionale dell’inizio della storia.
Una storia che inizia dal «sapere volgare» e non dalle pensate filosofiche, «la sapienza volgare del genere umano, la quale cominciò dalle religioni e dalle leggi, e si perfezionò e si compiè con le scienze con le discipline e con le arti». Sintetizzerà Foscolo qualche decennio più tardi: «Dal dì che nozze e tribunali ed are / Dier alle umane belve esser pietose / Di sè stesse e d’altrui, toglieano i vivi / All’etere maligno».
Quel giorno per Vico è l’inizio della Storia, che viene poi raccontata nei libri seguenti come un indistinto procedere di fatti e di pensieri, di miti, di arti. Come in una seconda Città di Dio, gli eventi storici sono ricollocati secondo un ordine biblico e filologico, a partire dal Diluvio Universale, scanditi nelle tre età, degli dei, degli eroi, degli uomini. Si affidano agli dei (plurale) gli uomini che non sanno ancora usare della ragione e ascoltano i sensi, onorano eroi gli uomini che imparano a usare della forza, sanno agire per ragion di Stato, usano della fantasia come di una forza conoscitiva e credono per certo il vero perché dotati di quel «senso comune» che permette di trovare gli stessi desideri, vizi e virtù in ogni umano. Gli uomini entrano poi nell’età degli uomini quando infine sanno darsi delle leggi e dei tribunali, e sanno indagare il vero con la ragione.
I filosofi? Non sempre utili, per esempio Talete, il primo, «cominciò da un principio troppo sciapito - dall’acqua - forse perché aveva osservato con l’acqua crescer le zucche». Che insolente questo Vico. I posteri l’avranno anche riconosciuto, ma con questo atteggiamento e questo cv, lo dicevamo, oggi come allora sarebbe bocciato ai concorsi.
Giambattista Vico/2
È la legge che ci rende civili
Nella concezione vichiana il legislatore deve riflettere il retroterra culturale di un popolo, difendere gli interessi comunitari e l’utilità sociale
di Gennaro Sangiuliano (Il Sole Domenica, 14.09.14)
Per Giambattista Vico, la legge, o meglio l’ordinamento giuridico, che presiede uno Stato e un popolo, è il metro capace di misurare l’avanzamento della civiltà umana. Lo dimostra chiaramente nella sua opera fondamentale La Scienza Nuova laddove ripercorre gli snodi di alcune legislazioni fondamentali dell’antichità attraverso le quali è possibile operare una hermeneutica historiae. La Legge Publilia, ad esempio, «un punto massimo d’istoria romana» segnò il passaggio dalla repubblica aristocratica a quella popolare.
Laureato in legge, profondo conoscitore dei giuristi francesi e olandesi, con una breve esperienza nell’avvocatura, Vico, indaga a fondo sul rapporto fra legge e cultura, perché la legislazione non è altro che l’organizzazione normativa di una comunità e ne riflette il sentire comune, il retroterra culturale. Tema decisivo, non privo di implicazioni delicate se si pensa ai pericoli di una cultura egemone che vuole imporre i suoi postulati attraverso la legge.
Argomento rimasto intatto nel suo valore del quale si occupano i Saggi scelti - Giambattista Vico a Vatolla (Edizioni Palazzo Vargas, pagg. 144, € 10,00) curati e introdotti da Gianpiero Paolo Cirillo che affronta il rapporto fra politica, governo e amministrazione nella formazione dello Stato moderno. Il tema del delicato rapporto fra cultura e diritto, e quindi delle relazioni fra diritto e filosofia, trova in Vico una soluzione che influenzerà a lungo tutto il pensiero a lui successivo.
L’originalità è nell’aver affermato la storicità del diritto, nell’inquadrare il fatto come accadimento storico che diventa fatto normativo. Gli istituti giuridici devono corrispondere agli interessi comunitari che li hanno espressi e mantenere l’utilità sociale.
Il giurista nella concezione di Vico deve elaborare una dimensione assiologica tenendo presente il trascendentale storico di una comunità, individuare «l’intelligenza dei valori» di un popolo, impostazione poi rimarcata da Giovanni Gentile nei suoi studi vichiani. «Quando il giurista si accosta al tema della cultura, lo fa con una sorta di complesso di inferiorità, che forse gli deriva dalla consapevolezza che, anche nell’ipotesi in cui egli crei una teoria giuridica del tutto nuova e appagante, non ci si trovi di fronte ad un atto creativo in senso proprio», avverte Cirillo, che chiarisce come il «rapporto tra il giurista e l’uomo di cultura è un rapporto servente». Ma il giurista può essere esso stesso persona colta capace di ricercare quel «senso comune delle Nazioni», la «primitiva sapienza dei popoli», elementi che Vico ritiene punto di partenza dell’attività del legislatore e di quella interpretativa. Nell’opera De uno universi juris principio et fine uno ricorda, quindi, come la conoscenza della storia sia fondamentale per la produzione della legge.
Del resto, la Scienza Nuova è "nuova" perché apre al riconoscimento della storia delle idee, dei costumi e degli usi dei popoli puntando ad armonizzare senso e ragione. Il sorgere della legge, disegnato dal diritto dei filosofi, è il rinvenimento di questo ordine che ha tratti metafisici capaci di coniugarsi con la verità del fatto.
L’attualità di Vico è anche nella determinazione del delicato rapporto fra ordinamenti nazionali e organismi sovranazionali diventati, in alcuni casi invadenti. «Il problema da affrontare oggi - scrive Cirillo - è quello di individuare degli strumenti con cui i governi e le burocrazie interne possano fronteggiare lo strapotere che le comunità internazionali esercitano attraverso la tecnicizzazione delle norme».
In una lettera scritta nel 1787 da Napoli Wolfgang Goethe definì Giambattista Vico l’Altvater della sapienza, intuendo il debito che la cultura germanica avrebbe contratto con la filosofia vichiana.
Prima ancora che un grande filosofo, l’autore della Scienza Nuova fu un giurista a tutto tondo, un teorico del diritto che rifiuta una legge universale ed astratta in nome di una legge profondamente ancorata alla cultura di un popolo.
-
> GIAMBATTISTA VICO --- CARLO LEVI: UN ECCEZIONALE INTERPRETE DI G. B. VICO.10 settembre 2014, di Federico La Sala
CARLO LEVI: UN ECCEZIONALE INTERPRETE DI G. B. VICO. Una nota
ALLA LUCE del nostro tempestoso presente storico (e della "barbarie ritornata"), non è male (mia opinione e mio invito) rileggere il ricco e complesso lavoro sociologico-politico (altro che "romanzo"!) di Carlo Levi, “Cristo si è fermato ad Eboli”, e soffermarsi - in particolare - sul passaggio relativo alla “Ditta Renzi - Torino”, alle tasse, e alle capre (pp. 40-42, Einaudi, Torino 2010 - in rete).
Il ’passaggio’ offre un ‘cortocircuito’ tra ieri (1935) e oggi (2014), una sintesi eccezionale della "cecità" di lunga durata delle classi "dirigenti" del nostro Paese, e ricorda a tutti e a tutte come e quanto, ieri come oggi, ” (...) quello che noi chiamiamo questione meridionale non è altro che il problema dello Stato (...) (p. 220, cit.). E non solo: "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010)!
Il discorso è di lunga durata e investe le strutture stesse dellla cultura europea e planetaria: nel Cristo si è fermato a Eboli, c’è "la scoperta prima di un mondo nascente e delle sue dimensioni, e del rapporto di amore che solo rende possibile la conoscenza" (C. Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia, "Introduzione" [1955], Einaudi, Torino 1978).
A mio parere, il lavoro (non solo questo! Si veda almeno anche "Paura della libertà", scritto in Francia nel 1939 - dopo il confino in Basilicata - e pubblicato nel 1946, dopo la scrittura nel 1942-1943 e la pubblicazione nel 1945 del suo capolavoro) di Carlo Levi, è ancora tutto da leggere e da rimeditare - assolutamente; è nell’ottica di una visione inaudita e inedita della storia, per molti versi (per intendersi e orientarsi) vicina a Giambattista Vico* e a Walter Benjamin*.
- WALTER BENJAMIN. "Noi oggi capiremmo ben poco di quelle pagine [cioè, di Paura della libertà] se non le collocassimo in un contesto complesso. Quando Levi stende le sue note in una sorta di finis terrae che potrebbe accomunarlo alla condizione di Benjamin, la scena del mondo è estremamente confusa. Lo spazio della critica e della riflessione autonoma a sinistra è di fatto azzerato. Sono i mesi del patto Molotov-Ribbentrop, della criminalizzazione di Paul Nizan, da parte del Pcf per il suo rifiuto di aderire alla svolta staliniana del patto tedesco-sovietico, delle lacerazioni tra cultura della pace e necessità della guerra" (cfr. David Bidussa, Prima di Eboli. La riflessione civile e politica di Carlo Levi negli anni del fascismo e dei totalitarismi, in: Carlo Levi, Scritti politici, a c. di D. Bidussa, Einaudi, Torino 2001, p. xxvi, senza le note).
- GIAMBATTISTA VICO. "1939 settembre-dicembre. Costretto a fuggire in Francia, è a La Baule, presso St. Nazaire in Bretagna. Qui scrive in compagnia di Vico e della Bibbia, Paura della libertà" (cfr. Gigliola De Donato - Sergio D’Amaro, Un torinese del sud: Carlo Levi. Una biografia, Baldini e Castoldi, Milano 2001, p. 353). *
Al di là dei vari storicismi idealistici o materialistici, con grande consapevolezza filosofica e teologico-politica, in un passaggio sul nodo della civiltà contadina e delle sue guerre ("le sue guerre nazionali") e della storia "di quello che non si svolge nel tempo: la sola storia di quello che è eterno e immutabile, una mitologia", così scrive, contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli (come di Torino):
"La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino"; e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (C. Levi, Cristo..., cit., pp. 123-125).
- MADONNA DI VIGGIANO E ROOSEVELT. "Ma quello che ogni volta mi colpiva (ed ero stato ormai nella maggior parte delle case) erano gli sguardi fissi su di me, dal muro sopra il letto, dei due inseparabili numi tutelari. Da un lato c’era la faccia negra e aggrondata e gli occhi larghi e disumani della Madonna di Viggiano: dall’altra, a riscontro, gli occhietti vispi dietro gli occhiali lucidi e la gran chiostra dei denti aperti nella risata cordiale del Presidente Roosevelt, in una stampa colorata. Non ho mai visto, in nessuna casa, altre immagini: né il Re, né il Duce, né tanto meno Garibaldi, o qualche altro grand’uomo nostrano, e neppure nessuno dei santi, che pure avrebbero avuto qualche buona ragione per esserci: ma Roosevelt e la Madonna di Viggiano non mancavano mai. (...) A volte, una terza immagine formava, con quelle due, una sorta di trinità: un dollaro di carta, l’ultimo di quelli portati di laggiù, o arrivato in una lettera del marito o di un parente, stava attaccato al muro con una puntina sotto alla Madonna o al Presidente o tra l’uno e l’altro, come uno Spirito Santo, o un ambasciatore del cielo nel regno dei morti.
 Per la gente di Lucania, Roma non è nulla (...) Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi uomini senza Stato potessero averne una" (op. cit., pp. 107-108,).
Per la gente di Lucania, Roma non è nulla (...) Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi uomini senza Stato potessero averne una" (op. cit., pp. 107-108,).
Detto diversamente, egli ha ben compreso - come scrive all’editore Einaudi nel 1963 - non solo "la Lucania che è in ciascuno di noi", ma anche "tutte le Lucanie di ogni angolo della terra". Nato a Torino (29 novembre 1902) e morto a Roma (4 gennaio 1975), ora riposa nel cimitero di Aliano, nella sua Terra. A suo onore e memoria, possono valere (in un senso molto prossimo) le stesse parole del "Finnegans Wake" di Joyce, riferite a Giambattista Vico (che pure aveva vissuto molti anni, a Vatolla, ai margini della grande foresta lucana, dell’"ingens sylva"): "Prima che vi fosse un uomo in Irlanda, c’era un lord in Lucania".
Come Vico e con Vico, Carlo Levi aveva capito da dove ripartire, per affrontare da esseri umani la "Paura della libertà" (cfr. Carlo Levi, Scritti politici, cit., pp. 132-209) . Una lettura meditata e criticamente assimilata della vichiana "Scienza Nuova" (a partire da quella del 1725, "che tutta incominciammo - come scrive lo stesso Vico - da quel motto: A Iove principium musae, ed ora la chiudiamo con l’altra parte: Iovis omnia plena") è alla base di questo suo primo lavoro (ripetiamo: scritto dopo il confino a Grassano e ad Aliano, e prima della scrittura - cinque anni dopo - di "Cristo si è fermato ad Eboli").
Il suo omaggio a Vico non si riduce e non è riducibile solo alle allusioni già evidenti nei titoli dei capitoli (Ab Jove principium, Sacrificio, Amor sacro e profano, Schiavitù, Le muse, Sangue, Massa, Storia sacra):
- "Ab Jove principium. E anche noi dovremmo cominciare di là, da quel punto inesistente d cui nasce ogni cosa: ma il nostro Giove non dovremo cercarlo nei cieli, ma là dove sta, nei luoghi più terrestri e oscuri, negli abissi umidi e materni. Esso assomiglia assai più a un verme che a un’aquila; ma troverà ben presto le sue aquile araldiche, e le predilegerà su ogni altro balcone o insegna, perché questo gli consentirà di non essere divorato, una volta per sempre, dalle aquile vere.
 Fuor di metafora, non potremo intendere nulla di umano se non partiremo dal senso del sacro: il più ambiguo e profondo e doppio e vermaquilino dei sensi, l’oscura continua negazione della libertà e dell’arte, e, insieme, per contrasto, il generatore continuo della libertà e dell’arte. Né potremo intendere nulla di sociale se non partiremo dal senso del religioso, questo figlio poco rispettoso del sacro" (C. Levi, Scritti politici, cit., p. 132);
Fuor di metafora, non potremo intendere nulla di umano se non partiremo dal senso del sacro: il più ambiguo e profondo e doppio e vermaquilino dei sensi, l’oscura continua negazione della libertà e dell’arte, e, insieme, per contrasto, il generatore continuo della libertà e dell’arte. Né potremo intendere nulla di sociale se non partiremo dal senso del religioso, questo figlio poco rispettoso del sacro" (C. Levi, Scritti politici, cit., p. 132);
- "Una foresta, al principio dei tempi, era, secondo il racconto, sulla faccia della terra, e copriva la faccia della terra. Quella stessa prima foresta informe e piena di germi e di terrore, nera nasconditrice di ogni volto, portiamo in noi: da essa cominciò il viaggio; la ritroviamo a mezzo cammino, con la sua paura: selva giovanile di possibilità illimitate. Fuori della creatrice libertà, ogni attività, ogni determinazione di quella infinita potenza, è una limitazione, un dolore, una fatica immensa, e il senso di una perdita irrevocabile - perché ogni religione è sacrificio e abbandono. Vagavano, secondo il mito, i primi uomini nella selva senza forma, finché si fermarono in certi luoghi, amarono certe donne, e adorarono certi dèi. Vagano tuttora gli uomini nella eterna selva, e cercano una certezza che si paga con servitù e con morte" (op. cit., p. 144).
- "Ab Jove principium Musae - dal religioso non nasce il linguaggio né la poesia, ma le divinità del linguaggio e della poesia, i simboli e i rituali dell’arte, i generi letterari, le Muse. Ma i tempi veri di libertà, nel loro passare fuggevole, foggiano la lingua e l’arte della felicità; e rimandano in cielo, con tutti gli dèi, le Muse sorelle, a celarsi in quel Padre, che tutti gli uomini hanno, allora, innocentemente dimenticato" (op. cit., p. 172)
- "Il peccato che deve finire è l’adorazione da parte dell’uomo di una cosa umana, di un idolo bestiale, che è animale araldico, mostro adorato, religione statale, guerra e schiavitù" (op. cit., p. 203);
- "Che la poetica, e così vera (ma vera soltanto nella sempre ripetuta, infinita esperienza) vicenda della Cacciata e della Redenzione e dell’Apocalisse, del sorgere cioè della religione umana e del suo liberaqrsi e finire potesse essa stessa, nella sua lettera, dogma, legge, religione, non è che una prova della profondità del racconto e della verità della sua interpretazione: poiché gli uomini incapaci di libertà non possono reggere al terrore del sacro, che agli occhi aperti si manifesta - e debbono trasformare in mistero, nascondere, adorare come un simbolo incomprensibile la rivelazione stessa, che è chiara luce di verità" (op. cit., p. 204).
Come vincere la paura della libertà, come convivere con la ingens sylva? L’incredibile è che, nel 1939, quando "un vento di morte e di oscura religione sconvolgeva gli antichi stati d’Europa" e "la bandiera tedesca fu alzata sulla torre Eiffel", Giambattista Vico è a fianco di Carlo Levi, come nel 1944, nel Lager di Wietzendorf, è a fianco di Enzo Paci - e ha aiutato entrambi a non perdere la strada e a riprendere il cammino della giustizia e della libertà.
- ENZO PACI. “Negli anni passati in Germania, in un campo di concentramento, la grande ombra di Vico venne a trovarmi e mi sembrò di sentire che tutta la sua opera era stata una lotta eroica contro la ingens sylva della barbarie (...)” (cfr.: Lettere di carteggio di Enzo Paci con B. Croce e F. Nicolini, a c. di A. Vigorelli, “Rivista di storia di filosofia”, I, 1986, p. 103).
Nel gennaio 1946, nella "Prefazione alla prima edizione" di Paura della libertà, Carlo Levi così parla della sua "confessione" (definita poi "breve poema", nel 1964, e "poema filosofico" nel 1971): "Quello che avevo scritto era all’incirca la parte introduttiva dell’opera progettata, la prefazione: ma tutti gli svolgimenti particolari che avevo avuto in animo di fare vi erano impliciti (...) mi parve che il libro contenesse già tutto quello che intendevo dire, e che non occorresse più squadernarlo esplicitamente. C’era una teoria del nazismo, anche se il nazismo non è una sola volta chiamato per nome; c’era una teoria dello Stato e della libertà; c’era una estetica, una teoria della religione e del peccato, ecc. Il libro rimase qual era, senza seguito. Lo portai con me nel ’41, di nascosto in Italia; e molti amici mi consigliarono di stamparlo subito (...) non ho cambiato neppure una parola della stesura primitiva (...) mi è parso che convenisse lasciare a questo piccolo libro (Così diverso dal mio Cristo si è fermato a Eboli, scritto cinque anni dopo) il suo tempo, che è forse il suo valore di espressione" (C. Levi, Scritti politici, cit ., pp. 218-219).
Federico La Sala (07.09.2014)
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE -- La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone.13 luglio 2014, di Federico La Sala
Filosofia minima
Aristofane e le donne libere di Platone
di Armando Massarenti (Il Sole Domenica, 13.07.2014)
«Se tutti i beni saranno in comune, come potrò far doni a una ragazza per conquistarla?». È la domanda di Blepiro, personaggio della commedia di Aristofane Ekklesiazùse (Donne in assemblea), che si prende gioco della proposta di legge emessa dalla protagonista Prassagora; costei, insieme ad altre donne travestite da uomini, è riuscita a far approvare nel parlamento ateniese una sorta di proto-comunismo. Prassagora risponde in modo rassicurante: «Potrai far l’amore gratuitamente. Infatti stabilisco che anche le donne siano in comune a tutti gli uomini e facciano figli con chi vogliono». La sagacia di Aristofane, che con il suo teatro comico riesce a toccare la coscienza politica degli spettatori ateniesi, viene indagata da Luciano Canfora nel suo La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone (Laterza).
Con un’argomentazione stringente, e contraddicendo gran parte della tradizione filologica a partire da Stephen Halliwell, Canfora dimostra come uno dei bersagli polemici della commedia sia soprattutto il filosofo Platone, autore di una delle più celebri utopie politiche della storia. Quando un personaggio delle Ekklesiazùse chiede: «Ma come si farà, nel momento in cui tutte le donne saranno in comune, a capire di chi sono i figli?», leggiamo quasi le identiche parole critiche rivolte da un interlocutore a Socrate nel dialogo della Repubblica: infatti l’utopia comunistica platonica presume la condivisione anche di donne e figli. In un altro luogo della commedia, poi, si fa riferimento a un personaggio piuttosto lascivo, tal Aristillo, che è un riferimento a Platone: il suo vero nome infatti era Aristocle, il cui diminutivo, per distinguerlo dal nonno omonimo, era proprio Aristillo.
L’utopia platonica viene dunque capovolta comicamente con un’altra utopia, quella delle donne al potere che mettono in scena l’assurdità della proposta astratta di un filosofo che non solo era imparentato con i Trenta Tiranni, ma che aveva perseverato - con il tiranno Dionisio I di Siracusa - nel fallimentare tentativo di realizzazione pratica delle sue idee politiche. Una fin troppo lunga tradizione culturale occidentale ha operato una "santificazione" filosofica di Platone, omettendo di criticarne adeguatamente le idee politiche e non solo.
Canfora, complice Aristofane, indica la strada per una lettura nuova e più onesta del filosofo greco e per una rilettura della sua utopia. Facendoci consapevoli dell’enorme impatto che deve aver avuto in una società maschiocentrica come Atene la Repubblica di Platone (soprattutto per la proposta della parità in pubblico uomo/donna e parità in funzioni cruciali) e l’eco di essa in una città in cui le donne "libere", cioè in grado di esplicare le proprie capacità, sono esplicitamente quelle considerate "di malaffare". Lo scandalo è che Platone propugna la fuoriuscita di casa delle donne "perbene", il loro libero commercio con gli uomini e soprattutto la loro funzione primaria nella difesa della città.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- LA RINASCENZA DEL SOGGETTO. SULLE TRACCE DI BENJAMIN, AL DI LA’ DELL’EDIPO.17 aprile 2014
 UOMINI E DONNE: ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA FILOSOFICA: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE"
UOMINI E DONNE: ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA FILOSOFICA: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE"
 LA RINASCENZA DEL SOGGETTO. SULLE TRACCE DI BENJAMIN, AL DI LA’ DELL’EDIPO. Una nota di Nicola Fanizza sul libro di Federico La Sala
LA RINASCENZA DEL SOGGETTO. SULLE TRACCE DI BENJAMIN, AL DI LA’ DELL’EDIPO. Una nota di Nicola Fanizza sul libro di Federico La Sala
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- FILOSIE NEL MONDO. «La filosofia è una serie di note vergate in margine a Platone»(Alfred N. Whitehead).6 aprile 2014, di Federico La Sala
Platone l’africano. E australiano, anche
Whitehead disse: «La filosofia è una serie di note vergate in margine a Platone»
Un saggio esamina figure e scuole di pensiero fuori dalla prospettiva europea
E va ben oltre le antiche tradizioni di India e Cina
di Armando Torno (Corriere della Sera,/La Lettura, 06.04.2014)
La filosofia fu la più bella invenzione dei Greci. Alfred North Whitehead, un pensatore che ha lasciato tracce anche in matematica, asserì che essa è una serie di note vergate in margine a Platone. Non aveva torto. Ma, detto questo, è lecito chiedersi: ci sono filosofie nazionali o sistemi nati oltre l’Occidente che hanno sviluppato qualcosa di simile al miracolo greco? In Africa? Nell’Asia, che ha nel suo seno le sapienze di Cina e India?
A questa e a simili domande risponde un libro curato da Virgilio Melchiorre: Filosofie nel mondo (Bompiani). Uno sguardo sulle avventure di pensiero delle «altre» culture che possono dipendere o no dalla nostra. Dalla scuola australiana alle correnti dell’islam contemporaneo, dai sistemi latinoamericani alle istanze ebraiche e giapponesi. Tredici capitoli con dodici profili, giacché il primo, di Ugo Perone, è intitolato Philosophia Occidentalis.
Lo stesso Melchiorre spiega come è stata realizzata l’opera: «Questo volume nasce dall’esigenza di risalire alle fonti delle diverse civiltà. Si è pensato di raccogliere a confronto alcune voci presenti nella recente Enciclopedia filosofica, curata per le edizioni Bompiani dal Centro studi filosofici di Gallarate... Le abbiamo aggiornate, ove occorreva, e le abbiamo integrate con voci nuove».
Il libro si riallaccia a una nobile tradizione. Già nel decimo volume della Storia della filosofia diretta da Mario Dal Pra (usciva da Vallardi nell’ottobre 1978; parte che verrà poi ripensata in tre tomi editi da Piccin) vi erano due capitoli di Gianni Paganini dedicati rispettivamente alla filosofia negli «altri Paesi europei» (con Russia sovietica e Jugoslavia) e ai «Paesi minori extraeuropei», tra cui non mancavano il Canada, il continente africano, l’Australia e così di seguito. All’India e alla Cina erano dedicati i primi due volumi della grande opera, che precedevano le trattazioni sulla Grecia.
Filosofie nel mondo, che offre utili bibliografie aggiornate, comincia con un essenziale profilo dell’Occidente: emergono i due pilastri su cui si regge ancora molta parte del nostro pensiero, ovvero Platone e Aristotele. Soprattutto vengono messe in evidenza alcune tematiche che percorrono epoche e correnti, quasi incuranti delle infinite discussioni causate. Tra esse il tempo, presente in Agostino e ancora motivo d’angoscia in pieno Novecento (Heidegger insegna). Si passa poi all’esame delle scuole: la prima è l’australiana, che ha elaborato una significativa filosofia analitica e una discreta logica, tanto che Franca D’Agostini, autrice della parte, parla di uno «stile australiano». Una figura di riferimento, tra le diverse possibili, indicata per la logica è Richard Routley.
Segue la filosofia russa. Sostanzialmente il vero esame è dal XVIII secolo, epoca in cui nell’immenso territorio degli zar ci si rivolse al pensiero europeo, a cominciare da figure quali Aleksandr N. Radišcev, autore del libro Viaggio da Pietroburgo a Mosca (1790) che costò all’autore la condanna a morte da parte di Caterina II. I periodi precedenti invece risentono, o si confondono, con l’eredità di Bisanzio; e l’inventario passa più per la teologia che per le costruzioni logico-concettuali. L’autrice Chiara Cantelli, oltre le correnti e le scuole ottocentesche e sovietiche, oltre slavofili e occidentalisti, evidenzia figure quali Florenskij o Dostoevskij; anzi, quest’ultimo con i suoi romanzi costituirà «un essenziale punto di riferimento nella discussione filosofica del Novecento europeo» e creerà le basi nel contesto russo «per accogliere Nietzsche».
Un breve profilo - i caratteri generali sono esposti da Alberto Ventura e Carmela Baffioni - della filosofia islamica (ricchissima nel Medioevo, giacché ha riportato molto di Aristotele in Occidente e ha avuto sommi maestri come Avicenna e Averroè) lascia spazio a una parte contemporanea, trattata da Massimo Campanini e Stefano Minetti.
 Figure sorprendenti, anche di femministe: tra esse la conservatrice Zaynab al-Ghazali, la quale «pur rivendicando alle donne il diritto alla rappresentanza e all’attività politica attiva e passiva, ha voluto custodire il ruolo prevalente di moglie e di madre».
Figure sorprendenti, anche di femministe: tra esse la conservatrice Zaynab al-Ghazali, la quale «pur rivendicando alle donne il diritto alla rappresentanza e all’attività politica attiva e passiva, ha voluto custodire il ruolo prevalente di moglie e di madre».Della filosofia ebraica la figura centrale resta il medievale rabbino e medico Maimònide; tuttavia una questione posta da Giuseppe Laras, che ha scritto la parte, è quella di interrogarsi sul contributo dei pensatori ebrei a idee e tendenze occidentali. In tal caso protagonisti quali Spinoza o Bergson sono da evidenziare. C’è poi una filosofia ebraica dopo il 1945, in seguito alla Shoah: è un profilo firmato da Massimo Giuliani. Tra le figure portanti della neo-ortodossia contemporanea ricordiamo Joseph B. Soloveitchik.
La filosofia cinese, esplorata da Alfredo Cadonna, non può prescindere da Confucio, il Platone del Celeste Impero. Per giungere nell’ambito contemporaneo si potrebbe segnalare Fang Dongmei, che indica come le tradizionali categorie confuciane siano ancora utilizzate per distinguere il pensiero cinese da quello greco (o europeo).
Per l’America Latina, esaminata da Pio Colonnello, va notato il fatto che solo dopo il 1856 è possibile parlare in questi termini: prima non aveva un nome. Tra i numerosi pensatori che si sono distinti in quel continente, vale la pena ricordare il messicano (molto occidentale) Antonio Caso, scomparso nel 1946; né mancano spagnoli rifugiatisi là con l’avvento del franchismo. Eduardo Nicol elaborò una filosofia in contrasto con gli altri esiliati.
Per l’Africa - la parte è di Lidia Procesi - è posto in evidenza chi ha dato vita a una filosofia autoctona, come Alexis Kagame, morto nel 1981; c’è stato anche chi ha elaborato una sociologia e una teologia (Il Dio che libera ) come il camerunense Jean-Marc Ela, morto nel 2008.
L’India, di Gianluca Magi, è il ventre di una sapienza superiore: oltre le grandi correnti di induismo, buddhismo, jainismo, si potrebbe giungere al mondo contemporaneo per ricordare Ramana Maharshi, morto nel 1950, pensatore caratterizzato da «una rigorosa forma di astinenza interiore ed esteriore per giungere alla realizzazione della propria identità col divino». Un grande induista del nostro tempo.
C’è infine - ne scrive Giuseppe Jiso Forzani - la filosofia del Giappone, che rampolla da una spiritualità arcaica e che ha nel principe Shotoku Taishi (574-622) con la Costituzione di diciassette articoli un riferimento etico ed esistenziale. Del tempo moderno ricordiamo Nishi Amane, che nel 1862 preparò le prime conferenze sul pensiero occidentale; quindi la scuola di Kyoto (di Brian Shudo Schroeder), che trattò il nulla assoluto e la Grande Morte. Il punto di partenza è Nishida Kitaro, lo sviluppo vide Hajime Tanabe e Keiji Nishitani. Ma qui si torna al linguaggio dell’Occidente. Proprio Nishitani intende la Grande Morte come un progettarsi in cui si passa attraverso la nullità e si «rinasce» con il morire. O meglio è «il ritorno del sé a se stesso nel suo modo di essere originario». Heidegger insegna ancora.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Platone, la "Germania" di Tacito, e la "Bioetica" (di Luciano Canfora).29 marzo 2014, di Federico La Sala
Platone e la Germania di Tacito precursori illustri dell’eugenetica
Il filosofo parlò di «razza pura», lo storico ispirò Himmler
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 29.03.2014)
Francesco Paolo Casavola, il cui efficace compendio intitolato Bioetica (Salerno editrice, pagine 88, e 7,90) è da qualche tempo in libreria, oltre a racchiudere in sé tutta la necessaria preparazione filosofico-giuridica, è anche dal 2006 presidente del comitato nazionale per la bioetica.
È un umanista che sa investirsi delle ragioni degli scienziati. Non trascurabile palestra in tal senso è stata per lui la presidenza dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, dove da sempre si saldano e dialogano forze intellettuali facenti capo a tutti i rami del sapere.
Forse in nessun altro ambito come nella ricerca bioetica appare evidente che il confine tra progresso e conservatorismo non è di immediata né automatica evidenza. Né i comportamenti di movimenti politici connotati come progressisti producono ipso facto risultati conformi. Si pensi alla campagna per l’eliminazione dei disabili progettata dalla gloriosa e sempre osannata socialdemocrazia svedese negli anni Trenta e Quaranta. Luce è venuta, a questo proposito, dalla ricerca di Piero Colla, pubblicata quasi 15 anni or sono presso Carocci: Per la nazione e per la razza.
Mentre la cura dell’infanzia e della maternità era al centro dello Stato sociale svedese, partiva contemporaneamente un programma per la sterilizzazione di individui giudicati «portatori di un patrimonio genetico difettoso», o anche solo sospettati di essere inadatti a darsi cura della propria prole. La sorpresa fu che tali normative erano ancora in vigore, nella patria di elezione del socialismo «umano», ancora alla metà degli anni Settanta.
Anche Winston Churchill aveva concepito in gioventù visioni eugenetiche siffatte, ma si può ben dire che il solo paragone possibile è con il dodicennio nazionalsocialista in Germania, dove il tentativo di creare davvero una «razza pura» portò ad esperimenti devastanti come il programma Lebensborn.
Eugenetica e pregiudizio intorno ad una ipotetica purezza razziale avevano, come è ben noto, in Germania un testo di riferimento, che divenne per Himmler, propugnatore di Lebensborn, il peso di un vangelo: il quarto capitolo della Germania di Tacito, là dove si parla dei Germani come «non contaminati da connubii con altre stirpi» e perciò «tra loro molto simili fisicamente». Scrive Tacito: «Il tipo fisico è uguale in tutti, nonostante si tratti di una popolazione così numerosa». Libro pericoloso, che innescò, tra Otto e Novecento, anche una aberrante disputa tra studiosi dell’Europa del Nord intorno alla maggior purezza degli svedesi ovvero dei popoli germanici del continente.
Né va dimenticato che pulsioni verso l’ingegneria genetica affiorarono da molto presto nei più diversi programmi di «riordino a progetto» della società (le cosiddette utopie): nella Città del sole di Campanella non meno che nelle isole del sole di Giambulo, di cui narra Diodoro Siculo nella Biblioteca storica. Ma l’archetipo è già nel V libro della Repubblica di Platone, dove il progetto dettagliato, comprese le norme sull’allattamento, riguardante la formazione di un ceto di «guardiani» è finalizzato al costituirsi di una «razza pura» (katharon genos ). Ginnastica e razzismo si son dati la mano negli esperimenti fascisti del Novecento.
È dunque l’eugenetica davvero agli antipodi della bioetica? Ma può lo sviluppo della ricerca scientifica venir frenato da presupposti etico-filosofici? Sorge la domanda: chi garantirà del valore assoluto di tali presupposti? Plausibilmente un accordo largamente accettato intorno al cosiddetto «diritto naturale».
Anche in questo ambito i Greci avevano cercato di venire a capo dell’aporia, escogitando la nozione di «leggi non scritte la cui violazione provoca vergogna universalmente riconosciuta» (così Pericle nell’epitafio). Ma essi stessi sapevano che la legge non scritta poteva essere o diventare un’arma temibile in mano ad un ceto o ad un gruppo, magari protetto da un’aura sacrale, capace di imporsi come unico interprete di tale legge.
Anche qui l’intuizione platonica, che ravvisa nella legge non scritta il «legame» tra norma vigente e norma che si affermerà in un prosieguo di tempo, è precorritrice. Precorre la moderna scoperta della storicità della legge e il fenomeno, oggi sotto gli occhi di tutti, della consapevolezza di nuovi diritti, prima non percepiti come tali. La polis - per usare una formula cara al Casavola - è la storicità della legge. Ma questa visione mette in crisi l’idea della oggettiva esistenza, e dunque della fissità dei diritti naturali.
Resta in piedi, e non è questione di facile soluzione, la domanda se non sia una violazione dell’etica frenare per motivi etici una ricerca potenzialmente capace di salvare in futuro molte vite. Come ognun vede, le domande che si affollano intorno alla bioetica hanno a che fare con una parola difficile e abusata, cioè con la nozione stessa di libertà: nozione controversa, tranne che per i banalizzatori. I quali (beati loro) hanno sempre le idee chiare!
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Altro che quote rosa, è democrazia paritaria (di Francesca izzo)18 marzo 2014, di Federico La Sala
Altro che quote rosa, è democrazia paritaria
di Francesca Izzo (l’Unità, 18.03.2014)
È ACCADUTO CON LA PAROLA «FEMMINICIDIO»: AL PRINCIPIO C’ERA UNA RESISTENZA FORTISSIMA AD USARLA perché brutta e urticante, ma poi l’ha spuntata perché è l’unico termine appropriato per denotare l’uccisione di una donna solo perché è donna. Quando con una grande campagna di informazione si è chiarito che mariti, fidanzati, conoscenti le uccidono perché, aspettandosi acquiescenza e subordinazione, non riescono invece a tollerare la loro libertà e il loro rifiuto, allora il termine è diventato di uso corrente.
Ecco ora siamo alle prese con un’analoga situazione, forse ancora più difficile. L’espressione che deve entrare nell’uso comune è «democrazia paritaria» ma deve combattere per affermarsi contro quella semplice e diffusa di «quote rosa». In questi giorni di quote rose se ne è scritto e detto a destra e manca per raccontare dell’iniziativa di un consistente numero di deputate di inserire nella nuova legge elettorale il principio della parità. Chi si è dichiarato a favore chi contro, ma tranne pochissime eccezioni, tutti a parlare di quote rosa.
Appena qualche giorno fa, ad esempio, Gian Antonio Stella ne ha sostenuto la necessaria e temporanea introduzione per vincere uno storico gap. Invece una platea vasta, arringata a sorpresa ieri sera a Che tempo che fa da una Luciana Littizzetto antiquote, è duramente contraria perché respinge le tutele, vuole il merito e non i recinti protetti. Soprattutto le giovani donne si mostrano ostili: hanno misurato a scuola, negli studi, nei concorsi il loro valore e sanno di poter competere alla pari con i loro coetanei e quindi non vogliono essere ricacciate nel ghetto degli svantaggiati, di quote infatti si parla per chi ha degli handicap, per le minoranze ...
Hanno pienamente ragione: le donne non sono una minoranza e per giunta oggi le giovani donne sono forti, preparate e competitive, altro che svantaggiate. E allora? Il fatto è che le parole sono le cose e usare la parola quota per indicare qualcosa di diverso produce terribili fraintendimenti.
Democrazia paritaria è l’espressione adeguata. Adeguata ad indicare che la rappresentanza del popolo (quella che con il voto eleggiamo in Parlamento), per essere democratica e non «oligarchica», deve dare «rappresentazione» del dato basilare che il popolo è fatto per metà da uomini e per metà da donne e che quindi la composizione parlamentare deve essere paritaria. I criteri con i quali vengono scelti i rappresentanti, cioè i famosi merito, qualità e competenza dei candidati riguardano in egual misura sia gli uomini che le donne e prescindono dalla regola paritaria, a meno che non si pensi che merito, qualità e competenza abbondino tra gli uomini e scarseggino tanto drammaticamente tra le donne da dover ricorrere a sciocche incompetenti per rispettarla.
La democrazia paritaria non configura alcuna concessione, alcun regalo o tutela, è la semplice presa d’atto (frutto però di un’epocale rivoluzione culturale e politica) che il popolo sovrano è fatto di uomini e donne e non è una nozione neutra, indistinta. È stata quella nozione neutra a consentire, anche nella storia repubblicana, di considerare «normale» che la rappresentanza fosse monopolizzata dagli uomini e che la presenza delle donne fosse un’anomalia, un’eccezione da giustificare con meriti altrettanto eccezionali. Questa visione, diffusa ancora oggi, è l’eredità di un lungo passato che non vuole passare, nel quale la politica era per definizione cosa esclusivamente di uomini e alle donne era vietato, proibito di occuparsene e qualcuna, per sfidare il divieto, ci ha rimesso pure la testa.
La democrazia paritaria è il compimento della democrazia, perché porta a compimento l’inclusione delle donne nella polis. E fa anche un’altra cosa non meno rilevante: sottrae all’arbitrio o alla «generosità» degli uomini che ne detengono le chiavi una parte del potere di decidere, rendendo più libere le donne.
Non si chiedono meriti o medaglie speciali alle donne per entrare nella cittadella della rappresentanza, né ci aspettiamo azioni miracolistiche dalla loro presenza. Ma credo sia chiaro a tutti che una rappresentanza popolare composta per metà da donne, cambiamenti nella concezione e nella concreta azione politica li produce e sicuramente in meglio, vista la crisi drammatica di credibilità e di fiducia delle istituzioni rappresentative.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- “Le donne all’assemblea”. La sfida di Aristofane a Platone. Un saggio di Luciano Canfora sul contenuto della commedia.10 marzo 2014, di Federico La Sala
Un saggio di Luciano Canfora sul contenuto della commedia “Le donne all’assemblea”
La sfida di Aristofane a Platone sul campo di battaglia dell’utopia
Sarcasmo feroce contro l’ipotesi di profonde riforme sociali
di Umberto Curi (Corriere della Sera, 10.03.2014)
Il difetto principale dei filosofi - scriveva Giambattista Vico - è di non aver «accertato le loro ragioni con l’autorità dei filologi», mentre dall’altra parte è imputabile ai filologi il non essersi curati «d’avverare la loro autorità con la ragione dei filosofi». Per ovviare a queste opposte unilateralità, sarebbe necessario nutrire la «scienza del vero», in cui consiste la filosofia, con «la coscienza del certo», assicurata dalla filologia, sviluppando dunque fra l’una e l’altra un rapporto di complementarità.
Se ci si riferisce al panorama degli studi riguardanti in particolare il pensiero classico, non si può dire che l’appello vichiano sia stato effettivamente raccolto. In termini generali, si è da tempo cristallizzata una distinzione fra ricerche di carattere microfilologico, insensibili all’esigenza di «inverare il certo», e testi filosofici incapaci di «accertare il vero».
Il merito principale dell’opera di Luciano Canfora La crisi dell’utopia (Laterza) può essere indicato nel risoluto superamento di ogni sterile distinzione disciplinare, alla quale si sostituisce una ricostruzione accurata e rigorosa, finalizzata a fare emergere alcune importanti questioni propriamente filosofiche. Con un’aggiunta che rende ancor più prezioso, e per certi aspetti perfino «necessario», il contributo arrecato da questo libro, e cioè il fatto che la sinergia tra filologia e filosofia non si limita a gettare luce su alcune questioni circoscritte, relative al rapporto tra Aristofane e Platone, ma è invece messa al servizio di un interrogativo di persistente e anzi rinnovata attualità, quale è quello che riguarda il ruolo dell’utopia.
L’obbiettivo programmatico del testo è esplicitamente dichiarato fin dall’esordio. Si tratta di dimostrare che la commedia di Aristofane intitolata Le donne all’assemblea (Ecclesiazusai), colpisce con l’arma del sarcasmo quel progetto di riforma radicale della società che viene proposto da Platone, in particolare nei libri IV, V e VI del dialogo dedicato allo Stato.
Attorno a questo nucleo problematico si addensano poi una molteplicità di temi più specifici, ciascuno dei quali esigerebbe una adeguata valorizzazione: il carattere «scenico» dei dialoghi di Platone, opportunamente trattati alla stregua di vere e proprie drammaturgie; l’identificazione del misterioso Aristillo, personaggio che compare in due commedie aristofanee, con il filosofo, il cui vero nome era come è noto Aristocle; il perfino sorprendente parallelismo strutturale, analiticamente documentato, fra la Kallipolis descritta da Platone e il modello di società messo alla berlina nelle Ecclesiazusai; la ricognizione delle affinità e delle differenze fra alcune utopie, più o meno direttamente riconducibili a Platone, dal mito di Atlantide, fino alla Città del sole di Tommaso Campanella.
Se è vero che l’importanza di un libro si misura sul rilievo delle questioni che è in grado di suscitare, più ancora che sulle risposte specifiche in esso contenute, il testo di Canfora offre un contributo di primissimo ordine nella prospettiva ora accennata.
Per prima cosa, pur lavorando sul nucleo propriamente «utopistico» della teoria politica di Platone, l’autore offre argomenti idonei a ridimensionare energicamente la tradizionale interpretazione «idealistica» del filosofo, mostrando al contrario fino a che punto la stessa Kallipolis descritta nella Politeia non possa essere assimilata senza residui ad un modello astratto, non abbia affatto i contorni di quello «Stato perfetto» che si è soliti attribuire all’autore ateniese.
Con ciò, non importa se talora in maniera indiretta, Canfora aiuta a riconoscere un punto di fondo, abitualmente rinnegato dalla critica, vale a dire il fondamentale «realismo» dell’approccio platonico al problema dello Stato, e di conseguenza l’assunzione della politica come pharmakon, destinato a «curare» - ma insieme mai a «guarire» completamente - i mali che affliggono gli Stati.
Un secondo e decisivo ordine di considerazioni può essere proposto in relazione alla trattazione dei dialoghi platonici in termini di drammaturgie. Questo suggerimento, per lo più ignorato o sottovalutato dagli studiosi, andrebbe invece ulteriormente approfondito, cogliendo il drama non soltanto in alcuni aspetti attinenti alla struttura esterna dei dialoghi, o in alcune «citazioni» da coeve opere sceniche, ma nell’articolazione stessa dell’argomentazione filosofica. Nel Sofista , ad esempio (testo più volte citato dallo stesso Canfora), più ancora della «scena» d’esordio, che funge come mera «cornice» introduttiva, genuinamente drammatica è l’alternativa di fronte alla quale i due interlocutori vengono a trovarsi, stretti fra la necessità di ricorrere al parricidio e la rinuncia alla possibilità di usare il logos.
Come accade anche nel Teeteto (che costituisce notoriamente il preambolo narrativo del Sofista) la ricerca condotta assume i caratteri di una intensa drammaturgia, proprio perché in gioco è una questione letteralmente di vita o di morte, quale è quella connessa all’ipotesi di dover rinunciare a parlare e a pensare.
Un’ultima considerazione, apparentemente marginale, fra le molte a cui per brevità si è costretti a rinunciare. Secondo un uso da tempo tanto consolidato, in Italia e fuori, quanto totalmente immotivato, il titolo del dialogo platonico riguardante lo Stato - in greco: Politeia , che designa ciò che attiene allo «Stato», o la «Costituzione» - è tradotto con l’italiano Repubblica.
 La giustificazione abituale per questo vero e proprio abuso linguistico è che i titoli italiani delle opere greche vanno tradotti attraverso la denominazione latina. Ma anche uno scolaro della prima liceo sa che l’espressione latina res publica , con la quale si traduce il greco politeia , indica lo Stato , e non una forma specifica di governo, quale è appunto la repubblica. Come peraltro confermano i titoli di altre opere coeve (si veda ad esempio l’Athenaion politeia, la Costituzione degli ateniesi di Aristotele, che a nessuno verrebbe in mente di tradurre con «la repubblica degli ateniesi»).
La giustificazione abituale per questo vero e proprio abuso linguistico è che i titoli italiani delle opere greche vanno tradotti attraverso la denominazione latina. Ma anche uno scolaro della prima liceo sa che l’espressione latina res publica , con la quale si traduce il greco politeia , indica lo Stato , e non una forma specifica di governo, quale è appunto la repubblica. Come peraltro confermano i titoli di altre opere coeve (si veda ad esempio l’Athenaion politeia, la Costituzione degli ateniesi di Aristotele, che a nessuno verrebbe in mente di tradurre con «la repubblica degli ateniesi»).L’auspicio è allora che, giovandosi della sua indiscussa autorità di antichista, Canfora possa accreditare una dizione corretta del titolo di un testo così importante.
-
> GIAMBATTISTA VICO --- BENEDETTO CROCE, ENZO PACI, E LORD SHAFTESBURY.6 febbraio 2014
SHAFTESBURY A NAPOLI (1711-1713) E CROCE A LONDRA (1923-1924). LA PUNTA DI UN ICEBERG.
Una nota *
Quale Cebete tebano fece delle morali, tale noi qui diamo a vedere una Tavola delle cose civili, la quale serva al Leggitore per concepire l’idea di quest’Opera avanti di leggerla, e per ridurla più facilmente a memoria, con tal aiuto che gli somministri la fantasia, dopo di averla letta. (G. B. Vico, “Spiegazione della dipintura...”, 1730, 1744)
Premessa. Il 26 agosto 1780, Pietro Verri, a cui Gaetano Filangieri da Napoli ha inviato la prima parte della “Scienza della Legislazione”, così risponde da Milano: “(...) alla pagina 59 del primo tomo ho ascoltata la voce di Ercole che ha rimbombato sul mio cuore, e ogni dubbio è svanito. A misura poi che mi sono avidamente inoltrato nella interessantissima lettura”. Il riconoscimento è grande: Filangieri ne è fiero e compiaciuto. Ma a cosa allude Verri, che Filangieri ben sa e bene accetta? Che cosa significa “la voce di Ercole”? A ben pensare, non ci sono dubbi: a cinquanta anni dalla pubblicazione della seconda “Scienza Nuova” (1730) e a trentasei anni dalla morte di Vico e dalla pubblicazione della sua terza “Scienza Nuova” (1744), è un omaggio dovuto e condiviso al lavoro di Chi in Ercole ha visto e teorizzato “il carattere degli eroi politici”, l’eroe fondatore di “ogni nazione gentile”:
“(...) questa Scienza, ne’ suoi Principii, - scrive Vico nella “Spiegazione della dipintura proposta al frontespizio, che serve per l’introduzione dell’opera” (1730 e 1744) - contempla primieramente Ercole (poiché si truova ogni nazione gentil’ antica narrarne uno, che la fondò); e ’1 contempla dalla maggior sua fatiga, che fa quella con la qual uccise il Lione, il quale, vomitando fiamme, incendiò la Selva Nemea, della cui spoglia adorno, Ercole fu innalzato alle stelle (il qual Lione qui si truova essere stata la gran Selva della Terra, a cui Ercole, il quale si truova essere stato il carattere degli Eroi Politici, i quali dovettero venire innanzi a quelli delle guerre, diede il fuoco e la ridusse alla coltura); - e per dar’ a intender’ altresì il Principio de’ tempi appo i Greci, da’ quali abbiamo tutto ciò, ch’abbiamo dell’Antichità gentilesche; i quali tempi incominciarono loro dalle Olimpiadi, co’ giuochi olimpici, de’ quali Ercole pur ci si narra, essere stato il Fondatore (...)” (“Scienza Nuova”, 1730).
LA PUNTA DI UN ICEBERG. Nel 1924, Croce è a Londra: alla “Modern Humanities Research Association” di Cambridge tiene la sua prolusione, è il suo “Presidential Address”, quale “presidente per l’anno 1923-1924”. Il titolo e il tema è “Shaftesbury in Italia”, vale a dire syl soggiorno di Lord Shaftesbury a Napoli dal 1711 al 1713, anni coincidenti con gli anni in cui Giambattista Vico era già un importante protagonista della vita culturale della Città. Il discorso è una brillante ricostruzione storiografica della figura di Shaftesbury, ma al contempo è anche una drammatica implicita confessione non solo del gran ritardo con cui egli ha messo a fuoco la presenza di Shaftesbury a Napoli ma anche - per contrasto - del limite della prospettiva con cui ha guardato al Vico filosofo, al Vico rappresentante di cultura, al Vico uomo (cfr. B. Croce, La filosofia di Giambattista Vico, 1911). Aveva ragione Nicola Abbagnano: “Attenzione a non valutare la biografia di un filosofo povera di eventi esterni”.
Benché Croce, già nel 1915, avesse cominciato a riflettere sul proprio percorso (cfr. Contributo alla critica di me stesso, Milano 1989), il suo orizzonte teoretico (gnoseologico-metafisico) è già chiuso e segnato: alle sue orecchie non è arrivata e non arriva alcuna “voce di Ercole”! Più tardi, come Gentile (e il Fascismo), farà il suo ‘concordato’ con la Chiesa cattolico-romana (cfr. B. Croce, Perché non possiamo non dirci cristiani, 1942) e continuerà a pensare nel solco di Hegel anziché di Vico: “la malattia morale” (1944) è superata, ma non risolta - l’Italia comincia a star meglio, ma non è affatto guarita! La “brutta dipintura” della “Scienza Nuova” del 1730, per quanto ignorata (e non ripresa nella “Scienza Nuova” del 1744, è un monito perenne - un invito a non lasciarsi sedurre dalla cattiva immaginazione e a percorrere “gli impervi sentieri delle Muse”, delle Grazie (“Charites”) e della Grazia (“Charis”).
ENZO PACI E VICO. Incredibilmente - poco dopo e negli stessi anni, nel 1944 (a duecento anni dalla morte di Vico e dalla pubblicazione della terza “Scienza Nuova”), a un militare italiano internato nel Lager di Wietzendorf capita di imbattersi in un libretto su La giovinezza di Vico (di Fausto Nicolini, Bari 1932) e di essere risvegliato dal suo sonno dogmatico dal rimbombo della voce di Ercole. Il militare intemato è Enzo Paci, che così poi ricorda e scrive da Milano: “Negli anni passati in Germania, in un campo di concentramento, la grande ombra di Vico venne a trovarmi e mi sembrò di sentire che tutta la sua opera era stata una lotta eroica contro la ingens sylva della barbarie (...)” (cfr.: Lettere di carteggio di Enzo Paci con B. Croce e F. Nicolini, a c. di A. Vigorelli, “Rivista di storia di filosofia”, I, 1986, p. 103). Egli, nel 1949, riprende il discorso su Vico (cfr. E. Paci, Ingens sylva, Bompiani. Milano 1994) e, nel 1954, dà vita alla rivista “Aut Aut”: nel nome, non solo il richiamo a Kierkegaard, ma anche il ricordo dell’‘incontro’ e della lezione dell’eroico Vico!
1.0 - SHAFTESBURY A NAPOLI. Ad ogni modo, la sorpresa di Croce, su quanto acquisito relativamente alla presenza di Lord Shaftesbury a Napoli, è grande: “La pubblicazione di lettere e frammenti inediti dello Shaftesbury, fatta dal Rand nei due volumi che s’intitolano The life, unpublished letters ad philosophical Regimen of Anthony, Earl of Shaftesbury (London, Sonnenschein, 1900), e Second Characters or the language of forms (Cambridge, University Press, 1914), mi ha messo innanzi molto materiale atto a illustrare il soggiorno dello Shaftesbury a Napoli; e questo materiale ho poi accresciuto con altre lettere e scritti di quelli che serbano ancora inediti nel Record Office, tra gli Shaftesbury Papers, da me consultati” (“La Critica”, 1925, 23, p. 2. Il rifermineto successivo del n. delle pagine, senza le note, è a questo n. della Rivista). E grande è anche la consapevolezza sul valore delle sue scoperte (per tutto ciò che riguarda Vico, evidentemente): l’anno successivo ripubblica il testo del suo discorso - già stampato in opuscolo a Cambridge - su “La Critica”, “pensando che possa riuscire di qualche interesse anche agli studiosi italiani” (p. 1). Ma i tempi sono quelli che sono: due anni dopo, nel 1927, “Shaftesbury in Italia” è ‘archiviato’ nei volumi di “Uomini e cose della vecchia Italia” (cfr. Laterza, Roma-Bari, 1956, vol. I, pp. 273-309).
1.1 - ROYAL SOCIETY, NEWTON, VALLETTA. Se Vico, nel 1725, invia a Newton una copia della sua prima “Scienza Nuova”, ha le sue buone ragioni: non è il gesto di un isolato dalla cultura europea del suo tempo! Una di queste ragioni è che egli, sin dagli anni degli studi universitari (1689-1693), era in relazione con Giuseppe Valletta. Ecco quanto Croce dice di lui nel suo discorso del 1924: a Napoli, “lo Shaftesbury entrò in relazione (...) con Giuseppe Valletta e col suo circolo (...) Valletta, già mercante e avvocato (...) conoscitore com’era, oltre che del latino e del greco, del francese, e dell’inglese, segnatamente verso l’Inghilterra tenne rivolto lo sguardo, e coi dotti e le società scientifiche inglesi coltivò corrispondenze. Di libri inglesi, scarsissimi allora in Italia, era assai ben provvista la sua libreria, e dall’ingese egli traduceva in italiano o in latino le notizie scientifiche, in specie quelle che la Società reale di Londra gl’inviava sulle esperienze che essa veniva compiendo. Il segretario di quella società, il Waller, gli richiese tra l’altro, nel 1712, una informazione - continua e precisa Croce - sull’eruzione del Vesuvio allora accaduta, e poi ancora sull’epidemia del bestiame che impersava in Italia, e le sue memorie su tali argomenti furono lette in quell’adunanza, presente e presidente il Newton. Così stimato era quei dotti - continua ancora Croce - che più volte gli fu offerta (narra un biografo) da milorfi e signori inglesi un luogo in quella Regia società: onore che egli modesto com’era, rifiutò” (pp. 5-6).
1.2 - VALLETTA, DORIA, E VICO. Premesso che Vico, negli anni della permanenza di Lord Shaftesbury a Napoli (1711-1713), è già tra i protagonisti della vita culturale della Città (nel 1708 tiene la settima orazione inaugurale “De nostri temporis studiorum ratione”, e nel 1710 pubblica il “De antiquissima Italorum sapientia”) , Croce così prosegue nel raccontare le sue acquisizioni e precisazioni progressive: “tra quegli amici del Valletta, frequentatori dello Shaftesbury, era Paolo Mattia Doria (...). Il Vico, che anche lo frequentava, lo dice “gran cavaliere e filosofo” (...). E’ possibile - continua Croce - che nel circolo del Valletta fosse già pervenuta o si sapesse qualcosa della prima edizione delle Characteristics, che è del 1711, e che si conoscesse alcuno dei giudizi che dei saggi dello Shaftesbury avevano dato i giornali letterari di Europa qui avidamente cercati e letti” (pp. 7-8).
1.3 - SHAFTESBURY, IL “GIUDIZIO DI ERCOLE”, E LA TAVOLA DI CEBETE. Nel 1712 il “famoso maestro” Paolo de Matteis, “il successore di Luca Giordano in Napoli” lavora per Lord Shaftesbury: “Il quadro che egli eseguì fu il Giudizio di Ercole o Ercole al bivio, secondo la favola di Prodico, per il quale il filosofo inglese gli fornì, in una speciale memoria stesa in francese, la più accurata analisi psicologica del soggetto, la determinazione del momento determinante da cui prescegliere, le fisionomia e gli atteggiamenti delle tre figure, di Ercole, la Virtù e la Voluttà. Preceduta, quella memoria scritta a uso del De Matteis, da una lettera sull’arte del disegno (A letter concerning the Art or Science of Design to Milord***) con la data di Napoli, 6 marzo 1712, e tradotta in inglese col titolo A notion of the Historical Draught or Tablation of the Judgement of Hercules according to Prodicus, fu divulgata sin d’alora e unita di poi alle edizioni e traduzioni delle Characteristics, portando sempre a capo, come pregio una piccola riproduzione del quadro del pittore napoletano” (pp. 12-13)”. Shaftesbury - continua Croce - “dopo aver scritto quella lettera [sul disegno] e la traccia del quadro di Ercole, e abbozzato una traduzione con commento della Tavola di Cebete, si veniva occupando nel mettere insieme gli appunti per un più ampio saggio da intitolare Plastics, or the original, progress and power of designatory Art: e di tutto questo pensava di fare un’opera da aggiungere alle prime Characteristics col titolo di Second Characters (“secondi parti nel dramma”) or the Language of Forms in four treatises). Sarebbe stata, questa, come la sua “Estetica”, da far sèguito alla “Filosofia morale” esposta nella prima opera” (pp. 17-18).
1.4 - PAOLO DE MATTEIS E DOMENCO ANTONIO VACCARO. Nell’illuminare meglio il rapporto di Paolo de Matteis con Shaftesbury, Croce racconta che ha anche avuto la fortuna di guardare “alcuni numeri superstiti di una Gazzetta di Napoli degli anni 1712 e 1713” (p. 11) e che nel numero del 2 aprile [1712] è scritto: “Domenica si aprì la prima volta la sagrestia di san Pietro a maiella dei padri celestini, dopo l’incendio del 1711, ed è riuscita assai vaga, sì per per la pittura del celebre Paolo de Matteis ed ornamento di Francesco saraceno, come ancora per il finissimo lavoro ad intaglio di noce, col pavimento di marmo mischio, l’uno e l’altro fattosi con l’assistenza dell’ingegnere Domenico Vaccaro” (p.12). La lingua batte dove il dente duole: la notizia illumina sì il rapporto del De Matteis con Shaftesbury, ma evidentemente ciò che colpisce Croce è la partecipazione ai lavori dell’ingegnere Domenico Antonio Vaccaro, il collaboratore di Vico, l’autore della “Dipintura” della Scienza Nuova del 1730 e del 1744. E questo a Croce, ovviamente, non sfugge e lo annota - per i posteri: chi ha orecchie per intendere intenda!
1.5 - LA SCELTA DI SHAFTESBURY: “PROMETEO”. Lontanamente dal pensare oggi che “l’idea (...) che è centrale per tutta la Scienza Nuova, è la stessa che sorregge la concezione che ha Shaftesbury della morale, della religione, e dei reciproci rapporti, la quale si può pensare che riguardi tanto il comportamento individuale quanto il corso storico dell’umanità (cfr. F. Crispini, L’etica dei moderni. Shaftesbury e le ragioni della virtù, Donzelli, Roma, 2001, p. 117), Croce dall’alto della sua conoscenza della storia dell’idealismo tedesco non si sbagliava del tutto nell’analisi delle tensioni dell’orizzonte teoretico di Shaftesbury: “Nell’estetica, del pari che nella filosofia morale, lo Shaftesbury non si pone il problema dialettico dello spirito e dei suoi momenti o forme, e dell’arte e della morale come momenti dialettici; non procede come, ai tempi suoi, e senza sua saputa, già faceva il Vico e, in certo senso anche il Baumgarten tentava; e, pur nondimeno - precisa Croce - egli reca un contributo di prim’ordine al chiarimento del vero concetto dell’arte. Quella sua Calogathia, quella sua sua concezione della moralità come bellezza e della bellezza come moralità (...) Si ricordi come egli parli, nelle Characteristics, del poeta, che non è per lui (come per i retori del suo e di tutti i tempi) il rimatore e il cadenzatore di periodi, ma “un altro creatore, un Prometeo, posto sotto Giove, e che simile a quest’artista sovrano o alla Natura plastica, forma un tutto legato e proporzionato in se stesso, con debita subordinazione delle parti costitutive, e segna i limiti delle passioni, conosce esattamente i loro toni e la loro misura, e perciò le rappresenta correttamente, mostra il sublime dei sentimenti e delle azioni, distingue il bello dal deforme, l’amabile dall’odioso, e in questo senso, e per questa necessità della rappresentazione vera, è un artista morale” (pp. 19-20). Croce, guardando dal punto di vista hegeliano ai segni del pensiero dello Shaftesbury in tutta la letteratura e la filosofia classica tedesca è impedito a comprendere che quelli “ritrovati e molteplici in Kant” hanno un valore tutto diverso, carichi come sono proprio della lezione di Shaftesbury “sull’entusiamo” e del suo lavoro critico sui sogni prometeici dei metafisici-visionari. Kant sapeva (grazie alle sollecitazioni di Shaftesbury, e a una immaginazione analoga a quella di Vico) - come scrive nel 1794 a Schiller- che “Solamente dopo aver domato dei mostri, Ercole diventa Musagete, ma davanti a tale fatica, queste buone sorelle, indietreggiano con terrore. Queste compagne di Venere-Urania sono sorelle cortigiane al seguito di Venere-Dionea, appena esse vogliono indicarne i moventi” (cfr. La religione entro i limiti della sola ragione, 1794- II ediz., Laterza, Bari 1980).
VICO E SHAFTESBURY. Lord Shaftesbury morì a Napoli il 15 febbraio 1713, a soli quarantuno anni. Nel 1730 Vico ha finito la sua seconda “Scienza Nuova”: se Shaftesbury fosse stato ancora vivo, egli sicuramente ne avrebbe spedito a Londra una copia! E questa volta la risposta certamente non sarebbe mancata: già solo a vedere la “dipintura” - la “Tavola delle cose civili”, Shaftesbury avrebbe accolto con socievole entusiamo l’omaggio e il lavoro del Filosofo conosciuto negli anni decisivi del suo soggiorno a Napoli.
* Federico La Sala (06.02.2014)
-
> GIAMBATTISTA VICO --- Che cosa diviene la virtù senza immaginazione? L’Immaginazione, la regina delle facoltà (di Alessandro Piperno - Immaginazione. La vera sapienza)..20 gennaio 2014, di Federico La Sala
La lezione del mio maestro Enrico Guaraldo. Dopo, la letteratura non fu più la stessa
Immaginazione
La vera sapienza
Costruitevi un harem nella testa e affollatelo di sogni e fantasie Aiuta a vivere, ha ragione Flaubert
di Alessandro Piperno (Corriere della Sera/La Lettura, 19.01.2014)
Ero all’ultimo anno di università quando mi imbattei in quello che ben presto sarebbe diventato il mio maestro. Per quanto pomposo possa apparire è così che gli aspiranti accademici chiamano i propri mentori: maestro. Un po’ come in Guerre stellari fanno i giovani Padowan con gli Jedi.
Il mio maestro si chiamava Enrico Guaraldo. È morto l’anno scorso.
Quando lo incontrai, il mio disincanto per gli studi accademici aveva bucato il muro del suono dell’insostenibilità. Sebbene mi fosse stato inculcato un severo rispetto per le istituzioni, non ero riuscito ad accettare che una cosa splendida e scapestrata come la letteratura fosse trattata in modo così tedioso, supponente, pedestre e burocratico da individui privi di talento e fantasia. Frattanto gli ultimi fuochi dello strutturalismo avevano incenerito le ormai risicatissime foreste vergini del pensiero. Com’era possibile che i capolavori dell’umanità fossero commentati da saggisti il cui stile si riduceva al birignao torbido e oscuro di una losca tecnocrazia orwelliana?
Ecco lo stato del mio umore quando per la prima volta entrai nella classe in cui il professor Guaraldo teneva il suo corso sulla Bovary. Non era un uomo avvenente. Vestiva in modo lezioso (la lunghezza della cravatta superava disastrosamente le colonne d’Ercole della cintura di coccodrillo). Per timore dei germi, al posto del microfono messo a disposizione dalla facoltà, utilizzava un karaoke personale. Chiuse la porta a chiave. Per non dare adito a equivoci, ci spiegò che era permesso uscire dall’aula solo su una barella nel pieno di un attacco cardiaco. Poi lesse un pezzo di une delle lettere scritte dal giovane Flaubert a Luise Colet. Una specie di mantra ad uso di giovani scrittori. Da allora me lo sono ripetuto così tante volte che ho finito per impararlo a memoria: «Il faut se faire des harems dans la tête, des palais avec du style, et draper son âme dans la pourpre des grandes périodes». «Bisogna farsi degli harem nella testa, dei palazzi con lo stile, drappeggiare la propria anima della porpora dei grandi periodi».
Quando il mio futuro maestro prese a commentare queste strane parole, accadde qualcosa che ho seria difficoltà a descrivere. Fummo invasi da una specie di voluttà. Investiti da una freschezza balneare poco confacente a un’aula universitaria. Trascinati in un mondo diverso da quello in cui vivevamo, ma che, allo stesso tempo, in un bizzarro paradosso, sembrava scaturire dai luoghi più oscuri e misteriosi di noi stessi. L’ironia, l’arguzia, la competenza, l’erudizione, l’irriverenza, la spregiudicatezza, il gusto per l’analogia e per la divagazione, e una dose assolutamente irresistibile di piacioneria, tutto al servizio di una didattica impeccabile. Da allora le parole di Flaubert divennero il nostro grido di battaglia.
Gli harem nella testa
Bisogna farsi degli harem nella testa. È un’esortazione che Flaubert rivolge a se stesso. Che forse andrebbe allargata a chiunque. Bisogna riempirsi la testa di concubine o di gigolò. Bisogna abbandonarsi al fascino corrotto della molteplicità. Perché la mente è il solo luogo del nostro corpo in cui l’abbondanza non è insana; il solo angolo di mondo in cui l’omicidio non è punito, e l’incesto non giudicato; la sola alcova in cui accogliere la donna dell’amico senza per questo tradirlo.
Ciò di cui Flaubert sta parlando è l’immaginazione. L’unica cosa che conti realmente nella vita. Il guaio è che Flaubert non è Diderot. La folla che ingolfa la sua mente non è fatta di pensieri, ma di immagini. Di immagini lussuose e variopinte, di marmi, di palmeti marocchini, di donne e di uomini (già, pare che il Nostro avesse gusti anfibi). Immagini romantiche e truculente, gotiche e romantiche, talvolta persino stucchevoli e triviali, ma chi se ne importa... Un altro vantaggio della nostra mente è che là dentro è abolito il buon gusto.
I tempi lunghi della fantasia
Ecco uno dei consigli più preziosi che mi dava il mio Maestro: «Non legga avidamente. Legga con lentezza. E quando finalmente incontra una grande immagine, per carità di Dio, chiuda il libro. Non vada avanti. Se la goda un po’, quella immagine. Se la porti a letto, al bagno, al ristorante. Non se la lasci scappare. Ci giochi un po’. La stravolga se necessario. La modifichi a suo piacimento. Se ne appropri. A questo serve la letteratura».
Allora credevo che questo fosse il segreto di un vero lettore. Avrei imparato sul campo che questo è ancor più il segreto di chi scrive. Chiunque svolge questa professione sa che scrivere non è sempre una luna di miele. La paura di sbagliare, l’influenza mefitica di chi ti ha preceduto, l’orrore di te stesso, il senso di gratuità... Eppure ci sono momenti che qualsiasi imbrattacarte conosce, in cui improvvisamente sei visitato da un’immagine, una sola. Che ti sembra preziosa solo perché originale, solo perché non è corriva come tutte quelle che ti vengono in mente abitualmente. Ti senti felice, euforico. Per un momento ti sembra di capire ciò che intendevano i modernisti con il termine «epifania». È questa cosa qui. La gioia di un’immagine che ti si dona. Che ti gonfia il petto. Che un po’ ti fa ridere, un po’ ti commuove. Non è detto che sia un granché, ma almeno è tua come il tuo spelacchiato peluche. E allora che fai? Ti metti a scrivere? Ma sei matto? Vuoi rovinarti la festa? Neanche per sogno. Te la tieni per te. La smonti e la rimonti a piacimento. Usi parecchio il replay e il fermo immagine. I più spregiudicati ricorrono a una specie di photoshop interiore. Malgrado per me si tratti di un ricordo remoto, direi che gli amori dell’adolescenza (tanto meglio se non corrisposti) favoriscono certe euforiche fantasticherie. Trastullarsi con l’immagine di ciò che probabilmente non capiterà mai può regalare gioie insperate.
Ne Le botteghe color cannella - il più immaginifico memoir mai scritto - Bruno Schulz narra la strana avventura di suo padre. Un piccolo bottegaio askenazita che sceglie di staccarsi dalla realtà, per abbandonarsi sfrenatamente al suo mondo interiore fatto di immagini colorate, bizzarre e spaventose. Schulz racconta l’impazzimento paterno, l’irriducibile alienarsi dal mondo che coincide con il progressivo rimpicciolimento delle membra, degno di Alice nel paese delle meraviglie. Ma invece di condannarlo o assolverlo, Schulz lo glorifica, tributandogli retrospettivamente l’onore delle armi: «Soltanto oggi comprendo il solitario eroismo con cui egli, da solo, mosse guerra all’elemento sconfinato della noia che soffocava la città. Senza alcun appoggio, senza alcun riconoscimento da parte nostra, quell’uomo straordinario difese la causa persa della poesia».
Quindi, da una parte c’è la noia che soffoca la città, dall’altra la causa persa della poesia. E non è mica detto che per proteggersi dalla prima e per difendere la seconda uno debba per forza impazzire. Basta aprire l’album di fotografie interiori. Riesumare ricordi, talvolta persino inventarseli di sana pianta. Oppure prevedere il futuro, profetizzare. Che ne sarà dell’Imu nel 2530? E della Tares? E naturalmente ci sono sempre le stelle, gli alieni, altre civiltà del tutto inimmaginabili. Poi c’è l’arte, che resta pur sempre la vita interiore dell’umanità. Avete presente quando Woody Allen in Manhattan si mette lì a enumerare tutte le ragioni per cui vale la pena vivere? Ecco, una cosa del genere, ma con le immagini. Che so: Anna Karenina nello scompartimento del treno con un libro in mano mentre fuori imperversa una tempesta di neve. E, a proposito di bianco, il bicchiere di latte tracannato da Christoph Waltz in Inglorious Bastards. Gli occhi di Lucrezia Panciatichi dipinti da Bronzino. La Londra avvolta in una nebbia azzurrina delle prime indimenticabili pagine di Casa desolata. Il colpo di testa di Simeone contro la Juve che ci regalò lo scudetto. Una vacanza in Cornovaglia del 1984. Per non dire delle immagini lascive di cui è meglio tacere...
La regina delle facoltà
Del resto, enfatizzare l’aspetto ludico, per così dire disneyano, dell’immaginazione, è un modo fin troppo demagogico di porre la faccenda. Almeno per i miei gusti. L’immaginazione merita rispetto. Per questo è tempo di affidarsi a colui che ha scritto le pagine definitive sull’immaginazione. Sto parlando di Charles Baudelaire naturalmente, uno degli uomini più intelligenti del XIX secolo. Può esistere intelligenza senza ironia? Altroché se può! Baudelaire è la dimostrazione che forse l’intelligenza pura non conosce l’ironia. Lui non scherza mai. Lui si prende sempre dannatamente sul serio. Certe volte provo a immaginarmelo ridere a una barzelletta di un amico. Be’, non ci riesco. Baudelaire non ride. Baudelaire è sempre di una solennità insostenibile. Eppure non sbaglia un colpo. Ha una lucidità sovrannaturale. Soprattutto quando parla dell’immaginazione, che definisce la regina delle facoltà. «Tutto l’universo visibile non è che un deposito di immagini e di segni ai quali l’immaginazione deve attribuire un posto e un valore relativo: una sorta di nutrimento che l’immaginazione deve assimilare e trasformare. Tutte le facoltà dell’anima umana vanno subordinate all’immaginazione, la quale le requisisce tutte in una».
C’è chi ha amato vedere in questa idea baudelairiana una deriva fricchettona, una sorta di prefigurazione della famigerata «fantasia al potere».
Ora, basta conoscere Baudelaire per sapere che le cose non stanno così. Baudelaire detesta la democrazia non meno di quanto detesti la sovversione, in qualsiasi forma essa si manifesti.
Come dicevo, le sue idee non indulgono mai in alcun tipo di edonismo. Per lui l’immaginazione è davvero la cosa più seria di tutte. Come quando scrive: «L’immaginazione ha una parte decisiva anche nella morale; poiché, se mi è concesso di spingermi fino a questo punto, che cosa diviene la virtù senza immaginazione? È come dire la virtù senza pietà, la virtù senza il cielo; qualcosa di duro, di crudele, di sterile, che in certi luoghi si è risolta nella bigotteria, e in altri nel protestantesimo». Che idea magnifica! Pensate a quei censori, di cui oggigiorno il nostro Paese è pieno, sempre pronti a castigare i costumi altrui, a giudicarli. I professionisti dell’indignazione e del civismo. Cosa dire di questi inflessibili Robespierre, se non che sono uomini privi di immaginazione? Che cos’è l’empatia se non la forma più intima di immaginazione? Solo provando a immedesimarsi nelle debolezze degli altri si riesce a essere indulgenti e misericordiosi.
Allora forse Baudelaire ha ragione: l’immaginazione, a dispetto di quel che si potrebbe credere, è la sola vera sapienza. Semmai è la cosiddetta «realtà», ammesso che la si riesca a definire, a essere talmente pleonastica da risultare irrilevante e tediosa. «Trovo inutile e fastidioso - scrive ancora Baudelaire - rappresentare ciò che è, poiché niente di ciò che è mi appaga. La natura è laida, preferisco i mostri della mia fantasia alla volgarità del reale». Non mi sorprende che a un secolo di distanza, uno degli allievi più riottosi di Baudelaire, ossia Vladimir Nabokov, rincari la dose, anche se con toni più scanzonati: «La mente non afferra nulla senza l’aiuto della fantasia creativa, di quella goccia d’acqua che sul vetrino dà nitore e rilievo all’organismo osservato».
Dopo tutte queste elucubrazioni capisco perché fui tanto colpito dalla prima lezione sulla Bovary del mio Maestro. Quel modo fantasioso di insegnare e concepire la letteratura era davvero contagioso. Era aria di montagna per polmoni intossicati. «Non importa se un’idea è giusta e ragionevole» mi diceva sempre il mio Maestro. «L’importante è che non sia troppo noiosa». Chissà che, dopo tanto ciarlare, non serva a questo l’immaginazione? A non annoiarsi troppo.
Alessandro Piperno
-
> GIAMBATTISTA VICO --- "NEWTON AND THE ORIGIN OF CIVILIZARION". Come conciliare la storia sacra con quella pagana? (di Franco Giudice - La sapienza antica di Newton)19 gennaio 2014, di Federico La Sala
La sapienza antica di Newton
Con il medesimo rigore con cui scoprì la gravitazione universale e il calcolo infinitesimale si applicò alla teologia e alla «prisca sapientia»
Voleva dimostrare che la civiltà ebraica è più antica di quella egizia
di Franco Giudice (Il Sole 24 Ore/Domenica, 19.01.2014)
- Jed Z. Buchwald-Mordechai Feingold, Newton and the Origin of Civilization, Princeton University Press, Princeton, pagg. 528, $ 49,50
A un osservatore sagace come Voltaire non era di certo sfuggita l’ostentata devozione con cui gli inglesi avevano dato l’ultimo saluto a Isaac Newton, «la gloria della nazione britannica», come lo definì una gazzetta nell’annunciarne la morte il 20 marzo 1727.
Nell’abbazia di Westminster, dove otto giorni dopo furono celebrati i funerali, il philosophe vide sfilare davanti ai suoi occhi il Lord Cancelliere, due duchi e tre conti che reggevano il feretro, con al seguito un lungo corteo che, oltre ai familiari, comprendeva numerose personalità di alto rango.
Un funerale di stato in piena regola, che si concluse con la sepoltura di Newton in «una posizione eminente» della navata centrale, alla stregua «di un re che avesse fatto del bene ai suoi sudditi», come con un po’ di sarcasmo annotò Voltaire.
Ovviamente, quei funerali così solenni rendevano omaggio all’uomo pubblico che nella sua carriera aveva ricoperto cariche prestigiose, al Newton cioè consigliere di fiducia del governo, direttore della Zecca, presidente della Royal Society e insignito del titolo di cavaliere dalla regina d’Inghilterra. Ma a essere celebrato era soprattutto il Newton scienziato, l’autore di capolavori come i Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) e l’Opticks (1704), destinati a segnare per sempre la storia della scienza.
Nessuno o quasi sapeva che l’uomo seppellito con tutti gli onori a Westminster sul letto di morte avesse rifiutato i sacramenti della Chiesa anglicana, di cui deplorava il trinitarismo, che giudicava una forma di idolatria. Ed erano davvero in pochissimi a sospettare che Newton avesse dedicato un tempo incomparabilmente maggiore all’esegesi biblica, all’alchimia e alla cronologia universale che non a tutte le altre discipline da noi oggi considerate, in senso proprio, scientifiche.
Ma nel 1728, la pubblicazione postuma della sua Chronology of Ancient Kingdoms Amended (La cronologia degli antichi regni emendata) avrebbe fornito ai contemporanei un primo saggio di questi interessi, e scatenato subito un grande dibattito. Attraverso un estenuante sfoggio di fonti antiche, non privo di ardite speculazioni filologiche, Newton presentava infatti una drastica revisione della cronologia tradizionale, contraendo la storia greca di cinquecento anni e quella egizia di un millennio.
Sulle vere ragioni però che lo avevano spinto a una simile impresa il silenzio era pressoché assoluto. Ed è proprio su di esse che getta nuova luce il magistrale lavoro di Jed Buchwald e Mordechai Feingold, che ricostruisce il coinvolgimento di Newton nello studio della cronologia.
Newton iniziò a occuparsi di cronologia intorno al 1700, al culmine di approfondite indagini storiche che lo vedevano ormai impegnato da parecchio tempo. Aveva passato al setaccio una quantità enorme di fonti classiche, tra cui Erodoto, Clemente di Alessandria, Diodoro Siculo, Eusebio di Cesarea, insieme ad altri Padri della Chiesa e alle Sacre Scritture. Ma non si trattava di erudizione fine a se stessa.
Quelle letture, come mostrano Buchwald e Feingold, scaturivano da esigenze teologiche ben precise: ripristinare nientemeno l’originaria e vera religione, per capire come e perché si fosse corrotta. E in questo contesto risultava fondamentale spiegare le discrepanze tra la cronologia degli storici pagani e quella dell’Antico Testamento, l’unica che Newton considerasse attendibile.
Dopo lunghi anni di ricerche bibliche, Newton si era convinto che l’originaria religione monoteistica, quella cioè che Dio aveva insegnato ad Adamo ed Eva, fosse stata ripetutamente corrotta in una forma di adorazione di falsi déi. Restaurato da Noè, l’autentico culto di Dio fu di nuovo ristabilito da Mosè e poi da Gesù, cadendo però, a causa del trinitarismo introdotto dalla Chiesa cattolica, ancora una volta nell’idolatria. Newton credeva inoltre che le verità ricevute dagli ebrei non riguardassero soltanto il culto originario di Dio, ma anche l’universo che Egli aveva creato. A Noè e alla sua progenie Dio aveva infatti rivelato che la struttura del mondo è eliocentrica; una sapienza antica che si era smarrita con il sorgere di false religioni, a tutto vantaggio dell’erronea cosmologia geocentrica.
Fu sulla base di queste convinzioni che Newton scrisse La cronologia degli antichi regni emendata. Intendeva dimostrare che la civiltà ebraica, a dispetto dell’opinione prevalente, veniva senz’altro prima di quella egizia. Erano stati Noè, i suoi figli e nipoti che, dopo il diluvio, avevano portato in Egitto l’antica sapienza ricevuta da Dio, e che dagli egizi era stata poi trasmessa ai greci.
Come era possibile dunque conciliare la storia sacra con quella pagana? Newton non aveva dubbi: occorreva riformare la cronologia tradizionale degli antichi regni e correggerla attenendosi alle solide basi della Bibbia. Un’operazione tutt’altro che semplice poiché, a suo avviso, tutte le nazioni, a eccezione di quella ebraica, per accrescere la loro antichità si erano falsamente attribuite centinaia di anni in più. Ma che Newton intraprese con un metodo originale e complesso, dove per l’interpretazione delle fonti antiche diventava indispensabile l’uso della matematica e dell’astronomia. E che Buchwald e Feingold ci aiutano a seguire fin nei minimi dettagli, rivelandosi delle guide scrupolose ed eccellenti.
Si scopre così che un aspetto importante del metodo di Newton consisteva nel confutare, attraverso rigorosi calcoli matematici, il criterio di datazione degli antichi cronologisti. E che pertanto le loro cronologie dovevano essere significativamente ridimensionate rispetto alle loro pretese lunghezze. Ma a colpire ancor di più è il modo in cui Newton impiegava gli strumenti dell’astronomia per collocare la spedizione degli Argonauti, dietro il cui mito pensava si nascondesse un evento storico reale, 45 anni dopo la morte di Salomone. Un risultato, a suo avviso, della massima rilevanza, poiché gli consentiva di stabilire una nuova datazione della guerra di Troia, la cui distruzione sarebbe dunque avvenuta dopo la costruzione del Tempio di Salomone.
Newton, come ci ricordano Buchwald e Feingold, «lavorò su questi problemi fino a pochi giorni prima di morire», determinato a dare alla sua riforma della cronologia quel "rigore matematico" che tutti gli riconoscevano. Ma altrettanto determinato a occultare che tale riforma fosse strettamente legata al suo schema genealogico dei discendenti di Noè e al suo tentativo di restaurare l’autentica religione monoteistica. Gli esiti di queste ricerche preferì mantenerli segreti, disseminandoli in una massa impressionante di manoscritti.
La ragione era quanto mai comprensibile: la negazione della Trinità, nell’Inghilterra dell’epoca, costituiva un reato perseguibile per legge. E Newton lo sapeva molto bene: nel 1710, il suo discepolo William Whiston, che aveva scelto come suo successore sulla cattedra di matematica a Cambridge, fu bandito su due piedi dall’università proprio per aver pubblicamente sostenuto l’antitrinitarismo.
Sarebbe tuttavia riduttivo considerare il libro di Buchwald e Feingold come una semplice, per quanto apprezzabile, ricostruzione degli studi cronologici di Newton. Il loro obiettivo è decisamente più ambizioso: dimostrare che il Newton dedito alla teologia, alla cronologia, all’alchimia e alla prisca sapientia non avesse niente di diverso dallo scienziato che aveva svelato la natura composita della luce solare, inventato il calcolo infinitesimale ed enunciato la legge di gravitazione universale.
Una tesi, possiamo dire con un po’ di orgoglio, sostenuta già da un grande studioso italiano di Newton scomparso circa dieci anni fa, Maurizio Mamiani, cui dobbiamo la prima edizione mondiale del Trattato sull’Apocalisse (Bollati Boringhieri, 1994), ma che gli autori purtroppo non citano. In ogni caso, Buchwald e Feingold hanno il merito di aver analizzato tutti quei manoscritti che, soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, rappresentano una sfida costante per chiunque si occupi di cose newtoniane, sollevando questioni di estremo rilievo.
Che legame c’è tra gli interessi documentati dai manoscritti e le ricerche di Newton nel campo dell’ottica, della meccanica e della matematica? Il Newton nel suo laboratorio alchemico, alle prese con crogioli e fornaci, era lo stesso che analizzava il passaggio della luce attraverso il prisma o che misurava la caduta dei gravi nei diversi mezzi? Cosa ha a che fare il Newton interprete dell’Apocalisse con l’uomo che scrisse i Principia mathematica? E come è possibile conciliare il Newton immerso nello studio della prisca sapientia con l’autore dell’Opticks?
È a queste domande che cerca di dare risposta l’imponente lavoro di Buchwald e Feingold, che documenta come l’approccio di Newton ai diversi campi del sapere si basasse su un "metodo unico", dove a contare erano sempre i numeri e i dati empirici, fossero essi i fenomeni osservativi piuttosto che le Sacre Scritture o le testimonianze dei classici. Un Newton insomma tutto d’un pezzo, destinato a far discutere gli specialisti, ma che rappresenta indubbiamente uno dei contributi più innovativi degli ultimi anni nella prolifica Newtonian industry.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Asor Rosa, Galli della Loggia e Esposito "sulle scienze umane". Un "appello" pedante e libresco (di Michele Dantini)15 gennaio 2014, di Federico La Sala
Un "appello" pedante e libresco. Asor Rosa, Galli della Loggia e Esposito "sulle scienze umane"
di Michele Dantini
Storico dell’arte contemporanea, critico e saggista *
Siamo certi che le discipline umanistiche possano nutrirsi di se stesse e insieme pretendere di conservare rilievo politico? O che gli attuali assetti scientifici e istituzionali debbano valere anche per le giovani generazioni? L’ Appello per le scienze umane di Asor Rosa, Galli della Loggia e Esposito si guarda indietro con nostalgia mentre dimentica di delineare innovative connessioni tra cultura critica, scienza e tecnologia (per non parlare di Rete o digitale).
Il ruolo delle Humanities è concepito con esclusivo riferimento alla memoria nazionale, in un’impenitente riedizione della figura risorgimentale dell’intellettuale vate. La specificità - o meglio il "primato" - italiano è invocato in polemica con il "progressismo illuminista e romantico" di Martha Nussbaum e gli intellettuali angloamericani a lei vicini. Alla capacità di Nussbaum di mobilitare un’ampia platea internazionale in merito a un problema tutt’altro che locale, cioè l’offensiva neoliberista contro l’educazione umanistica, Asor Rosa, Galli della Loggia e Esposito rispondono sollevando la richiesta di eccezione. Chiudono così la discussione in una riserva culturale.
Chiamato a impegnarsi in un interminabile esercizio di anamnesi, il pensiero dell’"origine" smarrisce ogni perspicuità e prontezza nel confrontarsi con processi storici concreti. Nell’Appello le "giovani generazioni" compaiono solo perché (con condiscendenza mista a ripugnanza e terrore) se ne deplorano la mancata formazione o l’infima cultura. I rari compagni di viaggio che i firmatari si scelgono con superstiziosa meticolosità appartengono alla generazione che va dai settanta agli ottanta (e oltre). Si fa ampio ricorso a retoriche identitarie, incuranti di distinguere un patriottismo civico e collaborativo dall’avocazione a sé di gratificanti ruoli senatoriali. Si sarebbe tuttavia dovuto mostrare maggiore attenzione al contesto economico e occupazionale. La domanda di professioni qualificate giunge oggi dalle imprese tecnologiche, non dallo Stato.
Il rapporto delle Humanities con scienza e tecnologia è considerato solo difensivamente, sul presupposto (a mio avviso fuorviante) della fatale distruttività di orizzonti culturali post-identitari. "Le discipline scientifiche", leggiamo, "le matematiche o l’ingegneria elettronica, la biologia molecolare o la geologia, sono dovunque le medesime, dovunque eguali a se stesse, e non a caso tendono sempre di più a esprimersi dovunque in una medesima lingua: l’inglese". L’affermazione riflette un punto di vista tanto semplificato e banale da destare non poche perplessità. Si è davvero a conoscenza di ciò di cui si parla? Ne dubitiamo. E’ sbagliato presupporre che nella ricerca scientifica e tecnologica non abbiano luogo processi linguistici e immaginativi complessi. Ed è limitativo ritenere che le discipline storiche, filosofiche e soprattutto letterarie abbiano repertori prefissati e immutabili. E’ vero il contrario: il pensiero critico (l’indagine "socratica" di Nussbaum) trae alimento proprio dal confronto con la cultura tecnica e scientifica.
In che modo le competenze umanistiche, opportunamente trasformate, possono contribuire a una corroborante messa a fuoco delle politiche del turismo, dell’industria creativa, digitali e del patrimonio? Non è dato sapere, eppure è proprio questo che si vorrebbe sapere. Ci si preoccupa del paesaggio e dell’eredità culturale pur senza nominare chi, tra gli storici dell’arte, si è più battuto in questi anni per una migliore cultura della tutela. Ma il punto di vista, mai posto in discussione, è quello di chi, con arroganza forse preterintenzionale, si autoproclama detentore esclusivo di conoscenze politiche, storiche e sociali.
Gli estensori dell’Appello non sembrano cogliere l’enormità delle mutazioni istituzionali, cognitive, neurali che l’ubiquità dei gadget va prefigurando per ciascuno di noi. Non c’è alcuna necessità di indulgere alla detestabile retorica dei "nativi digitali" per comprendere come l’interazione tra mente e macchina ("intelligente") determini inediti processi di adattamento bioevolutivo e imponga di modificare in profondità le gerarchie dei saperi. Al pari di psicologi cognitivi, neuroscienziati o tecnologi "critici", gli umanisti possono partecipare utilmente al dibattito sull’innovazione tecnologica. O meglio: hanno l’obbligo di farlo. E’ loro compito contribuire alla manutenzione di un’opinione pubblica informata e indipendente o incoraggiare l’abitudine al libro, alle buone pratiche argomentative e alla scrittura.
L’assenza di un "oggetto" disciplinare rigidamente precostituito può costituire un vantaggio specifico, a patto però che ci si impegni a maturare competenze duplici e ci si spinga di tanto in tanto al di fuori del logoro recinto dei saperi antiquari. La contrapposizione tra competenze storiche e competenze scientifiche o tecnologiche non ha in sé niente di "umanistico": semmai di corporativo. Denuncia inoltre un allarmante deficit di comprensione storica e (per così dire) epistemologica del presente.
L’attitudine all’autocommiserazione affiora stridula e petulante. I "decisori" ci ignorano, questa la tesi dell’Appello; e l’attuale classe politica è sprovvista di competenze (o sensibilità) umanistiche. Non intendo certo negare la circostanza, al contrario. Osservo solo che una qualsiasi dimostrabile ratio economica è assente dal testo e che elementi congiunturali tanto decisivi quanto drammatici, disoccupazione e sottoccupazione giovanile ad esempio, sono ignorati dai tre intellettuali. Come difendere l’occupazione qualificata nell’ambito delle professioni culturali? Questa è la domanda che una riflessione politico-istituzionale responsabile dovrebbe stabilire come prioritaria. Perché tanta insensibilità al tema del lavoro? Se bene intesa, la formazione umanistica ha il compito di debellare culture libresche e dissociative, in definitiva autoritarie.
Si rimpiange il liceo classico d’antan, luogo di selezione delle élite gentiliane e postgentiliane. Il latino, scrivono Asor Rosa, Galli della Loggia e Esposito con trepida metafora amniotica, è il "grembo linguistico nel quale più di metà della storia europea si inscrive". Forse: ma questo non rende meno affascinanti o necessarie, per un paese culturalmente retrivo come l’Italia, la fisica quantistica, l’etologia cognitiva o gli studi culturali.
Infine: appare scientificamente scorretta l’attitudine a ignorare debiti intellettuali. Si contesta l’ANVUR: ma si dovrebbe riconoscere, citando, l’impegno di chi lo fa da lungo tempo in modo ragionato e condiviso. Si insorge contro le retoriche pro-innovazione tecnologica di ministri come Profumo: eppure non ricordo che i tre firmatari siano intervenuti tempestivamente quando, Profumo ministro, le testate con cui loro stessi collaborano da tempo immemorabile gareggiavano nel promuoverne iniziative e rilanciarne i più risibili proclami.
Il competitivo egotismo è il grande torto di un "appello" che ha dalla sua alcune piccole ragioni. Non un dubbio sull’esaurimento del "mandato". Né tantomeno una riflessione sul venir meno della propria autorevolezza (o "morfologia") di intellettuali. Si pretendono pur sempre per sé posizioni di stizzosa contiguità al potere. L’omaggio a Pasolini appare strumentale.
-
> GIAMBATTISTA VICO --- «Il Mulino» riapre il dibattito su scienza e umanesimo (di Antonio Carioti)12 gennaio 2014, di Federico La Sala
 I due saperi, rivali o alleati
I due saperi, rivali o alleati
 «Il Mulino» riapre il dibattito su scienza e umanesimo
«Il Mulino» riapre il dibattito su scienza e umanesimo
 Il degrado degli studi produce una politica senza idee
Il degrado degli studi produce una politica senza idee di Antonio Carioti (Corriere della Sera, 12.01.2014)
di Antonio Carioti (Corriere della Sera, 12.01.2014)Il grido d’allarme in favore dell’umanesimo lanciato da Alberto Asor Rosa, Roberto Esposito ed Ernesto Galli della Loggia, pubblicato dalla rivista «Il Mulino», denuncia lo svilimento degli studi storici, filosofici e letterari come un pericolo mortale per l’Italia. Un tema che può essere considerato da svariati punti di vista. L’appello non è piaciuto agli autori convinti che il guaio peggiore del Paese sia piuttosto la carenza di cultura scientifica, mentre altri studiosi ne hanno apprezzato e sottolineato la valenza sul terreno politico.
Al primo gruppo appartiene Gilberto Corbellini, autore del saggio Scienza (Bollati Boringhieri): «Io insegno Storia della medicina e vedo che quasi tutti gli studenti escono dalla scuola superiore senza sapere nulla del metodo scientifico, senza avere idea, per esempio, di come si accerta l’efficacia di un farmaco: poi non c’è da stupirsi se si dà credito agli imbonitori, come nel caso Stamina».
A suo avviso l’appello uscito sul «Mulino» ha un taglio conservatore: «È pervaso dall’idea che la conoscenza umanistica sia più profonda e dinamica, rispetto al presunto appiattimento del sapere scientifico».
Assai diverso l’approccio di Massimo Adinolfi, docente di Filosofia teoretica e autore del saggio Continuare Spinoza (Editori Internazionali Riuniti), che ha commentato positivamente l’appello sul «Messaggero» del 5 gennaio: «Il punto cruciale colto dai tre sottoscrittori riguarda il destino della politica. Essa in Italia ha tratto la sua linfa da una tradizione impregnata di cultura umanistica. Se quel patrimonio storico finisce nel dimenticatoio, come sta accadendo, si perdono le coordinate della vita pubblica. E poi ci ritroviamo ad essere governati da partiti come quelli attuali: formazioni senz’anima e senza storia, incapaci persino di declinare un albero genealogico coerente».
Non tutti però apprezzano il retroterra della cultura politica italiana. Molto critico si mostra ad esempio il sociologo Luciano Pellicani nel libro Contro la modernità (Rubbettino), scritto con Elio Cadelo: «L’appello uscito sul “Mulino” - dichiara - rispecchia una grave arretratezza. Penso all’invettiva contro la cosiddetta “idolatria del mercato”, che forse ha un senso negli Stati Uniti, ma è paradossale in un Paese votato allo statalismo come il nostro. Quanto alla tradizione politica, nelle campagne elettorali italiane non si fa cenno ai temi della ricerca scientifica, che sono invece centrali nei dibattiti delle presidenziali americane. Lungi da me l’idea di sottovalutare l’importanza della letteratura o della filosofia, ma l’emergenza di cui soffriamo è su un altro versante».
Roberto Esposito, firmatario dell’appello, mette in guardia contro gli equivoci: «Abbiamo puntato l’attenzione sull’umanesimo in modo molto netto, forse anche provocatorio, ma non pensiamo certo che si debbano ridimensionare le discipline scientifiche. E siamo consapevoli della necessità di un’osmosi. Essa tuttavia è possibile solo se ciascuno dei due ambiti (anzi tre, se si aggiungono le scienze sociali come l’economia e la sociologia) mantiene la sua specificità. L’errore è omologare i saperi come fanno certi meccanismi di valutazione, tutti basati su parametri quantitativi e oggettivi, che non possono valere per gli studi umanistici, fortemente caratterizzati in senso qualitativo e soggettivo».
Su questo Corbellini concorda: «Anch’io trovo ridicole le modalità di valutazione oggi in uso e la sceneggiata dell’abilitazione nazionale per la docenza universitaria. I tre firmatari dell’appello hanno ragione nel definire umiliante e provinciale la richiesta che un commissario straniero partecipi alle procedure di valutazione. Ed è assurdo che chi scrive fesserie in inglese abbia più probabilità di essere abilitato rispetto a chi scrive cose intelligenti, ma solo in italiano».
Tuttavia, a suo avviso, questi sono proprio i risultati di una tradizione che ha svalutato la scienza: «La nostra classe politica, cui si devono i guasti denunciati sul “Mulino”, non viene quasi tutta da una formazione umanistica? Servirebbe una franca autocritica da parte di chi opera in quel campo. Invece l’appello esalta i tratti peculiari dell’identità italiana, proponendo quasi una riedizione del Primato di Vincenzo Gioberti, men- tre trascura il ruolo cruciale che la scienza ha giocato nello sviluppo della modernità, della tolleranza e della democrazia liberale».
È un’impostazione che non convince Adinolfi: «L’idea che tutti i Paesi si debbano adeguare a un modello unico liberale di matrice anglosassone mi sembra priva di senso storico. In realtà l’Italia del dopoguerra ha conosciuto enormi progressi economici e civili finché hanno tenuto i filoni politico-culturali originali radicati nella nostra vicenda nazionale, come il cattolicesimo democratico della Dc e la tradizione socialista del movimento operaio. Quando quei riferimenti ideali si sono consunti, il nostro Paese ha perso quota ed è entrato in una fase di grave declino».
«Vorrei ricordare - osserva a sua volta Esposito - che l’attuale ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, e il suo predecessore, Francesco Profumo, sono docenti di materie scientifiche, quindi il monopolio dell’umanesimo al governo non esiste più. Riconosco comunque che la tradizione culturale italiana è stata spesso interpretata in modo mediocre dalle classi dirigenti. Aggiungo che tuttavia negli Stati Uniti, dove ha sempre prevalso il sapere scientifico, oggi si riscopre l’importanza della visione umanistica e proprio la filosofia italiana è molto apprezzatra. Ma quella espressa nel nostro appello sul “Mulino” non è una posizione di difesa identitaria: semmai abbiamo voluto sottolineare una innegabile specificità italiana, cioè il ricchissimo patrimonio artistico e culturale che ci deriva dal passato. È una risorsa immensa, di cui altri Paesi non dispongono. Ma come si può valorizzarla, se si emarginano gli studi umanistici?».
Pellicani pensa che la priorità sia un’altra: «Mancano i laureati in matematica e in fisica, per giunta i più dotati tra loro vanno all’estero. E troppi studiosi di materie umanistiche continuano a ignorare gli sviluppi delle scienze naturali e il loro contributo alla comprensione delle nostre esperienze individuali e sociali. Mi sembra che temano un’invasione di campo, anche per la diffidenza diffusa verso tutto ciò che è misurabile e quantitativo. Io invece, come sociologo, giudico prezioso, per esempio, l’apporto della psicologia evoluzionista, che studia il tasso di condizionamento biologico nei comportamenti della specie umana».
Esposito nega però ogni paura di contaminazione: «Nessuna chiusura. Al contrario, personalmente parlo da anni di biopolitica, cioè sostengo la necessità di mettere in rapporto politica e dinamiche biologico-naturali. Neuroscienze e filosofia trovano un terreno comune nella categoria di bios, la vita biologica, attraverso la quale si va facendo strada un nuovo paradigma scientifico più flessibile, attento al divenire, alle differenze, alle varianti. Ma un confronto fecondo esige che non si pretenda di allineare tutti i saperi lungo l’unico orizzonte delle scienze naturali».
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA.23 dicembre 2013, di Federico La Sala
 SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. A scuola di Dante, Bruno, Galilei, Kant ... e Kurt H. Wolff
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. A scuola di Dante, Bruno, Galilei, Kant ... e Kurt H. Wolff
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. Materiali
DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. Materiali
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- TRACCE DI UNA NUOVA ANTROPOLOGIA.8 luglio 2013, di Federico La Sala
 Per riflettere su "Chi siamo noi in realtà?" (F. Nietzsche).
Per riflettere su "Chi siamo noi in realtà?" (F. Nietzsche).
 PARMENIDE, UNA "CAPPELLA SISTINA" CARMELITANA, LE XILOGRAFIE DI FILIPPO BARBERI E LA DOMANDA ANTROPOLOGICA. Un lavoro di Federico La Sala, con pref. di Fulvio Papi
PARMENIDE, UNA "CAPPELLA SISTINA" CARMELITANA, LE XILOGRAFIE DI FILIPPO BARBERI E LA DOMANDA ANTROPOLOGICA. Un lavoro di Federico La Sala, con pref. di Fulvio Papi
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE ---- Melissa Lane: «Eco-Republic - What the Ancients Can Teach Us about Ethics, Virtue, and Sustainable Living».1 luglio 2013, di Federico La Sala
Platone e la green-economy. Se gli antichi ci insegnano l’ecologia (e la finanza)
di Alberto Magnani (Il Sole-24 Ore, 27 giugno 2013)
L’aneddoto non è notissimo. La Regina Elisabetta, a colloquio con i baroni della British Academy, chiede: come è possibile che la crema dell’accademia anglosassone non sia riuscita ad anticipare la crisi finanziaria? Come è possibile che chi pronosticava l’implosione della bolla dei mutui subprime venisse scaricato come un «visionario», quando i contraccolpi del leverage erano in agguato da anni? Il mea culpa dei professori recita così: «In summary, your majesty, the failure to foresee the crisis was a failure of the collective imagination to understand the riks of the system as whole». In sostanza, vostra altezza, il fallimento nella previsione della crisi era il fallimento della nostra immaginazione. Troppi numeri, poca filosofia. Certo, un passo della Repubblica di Platone non rimpiazzerà le analisi macroeconomiche. Ma pulisce gli occhi dall’ovvio. Con uno sguardo un po’ più in là, che è la prima risposta alle crisi di domani, dai mercati finanziari al cambiamento climatico.
Melissa Lane, politologa e classicista in cattedra alla Princeton University rispolvera l’immaginazione degli antichi per far volare la "scienza triste" nella direzione della sostenibilità. Lane parte dal fondatore dell’Accademia, e lo supera allargando la potenza d’urto dei suoi dialoghi dall’élite degli aristocratici della cultura alla società di massa. In «Eco-Republic - What the Ancients Can Teach Us about Ethics, Virtue, and Sustainable Living» (Princeton University Press, 2012), Lane ragiona sui concetti di inerzia, immaginazione e iniziativa, per la sfida a scatto immediato del cambiamento climatico.
L’inerzia come blocco mentale, pigrizia - ad esempio - degli imprenditori edili che ignorano le tecniche di costruzione a impatto zero perché «non credono sia possibile». Immaginazione come idealità imprenditoriale, coraggio metafisico (nel vero senso del termine: oltre la fisica, oltre quello che c’è) contro i tecnicismi dei modelli di rischio che per anni hanno escluso dai propri calcoli le urgenze dell’economia reale. Iniziativa come slancio nella realizzazione, riannonando le file tra i risparmiatori, i cittadini e un sistema che sta esaurendo le pile. Con la crisi delle risorse, dal petrolio all’acqua, che incalza e chiederà spiegazioni più tempestive di quelle della British Academy.
La "Repubblica verde" è la Repubblica del dialogo di Platone, con il filtro di più di 2000 mila anni di cambiamenti. E un realismo di base che azzera i rischi di "castelli in aria", alla peggior maniera della filosofia politica che istituisce modelli senza considerare i fatti. Sono i provvedimenti normativi a dover fare il primo passo: briglie alla finanza sregolata (la Tobin tax?), tasse sul carbonio per limitare e quantificare le emissioni, sgravi sulle tecnologie go-green.
Ma l’immaginazione psico-sociale resta il migliore e il primo dei complementi. Come nel caso dell’emergenza rifiuti a Nuova Delhi, quella che l’Economist ha ribattezzato la «pestilenza dei sacchetti di plastica»: un’epidemia di «plastic bag» che intasano le fognature e avvelenano il bestiame.
Basterebbe una rivoluzione minima per invertire la rotta. Ma l’inerzia mentale è così rigida che solo i salassi delle multe hanno sortito un - parziale - miglioramento: tra il pagare una multa e cambiare le proprie abitudini, in tanti preferiscono salvaguardare le proprie abitudini. La sostenibilità, dice la Lane, sta a metà tra scienza ed etica: non insegue il "bene" universale, ma impronta il comportamento in base a quello che è bene nelle necessità reali. Costruendo castelli reali, e impatto zero, sulla scia di Platone.
-
>LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- DA BERTHA VON SUTTNER A VANDANA SHIVA. NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE PER LA PACE E IL DISARMO24 maggio 2013, di Federico La Sala
DA BERTHA VON SUTTNER A VANDANA SHIVA. NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE PER LA PACE E IL DISARMO *
Nella ricorrenza della Giornata internazionale delle donne per la pace e il disarmo, il "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo ha realizzato un incontro di riflessione nella mattinata di venerdi’ 24 maggio 2013.
Nel corso dell’incontro sono stati letti e commentati brevi estratti da testi di Bertha von Suttner, Rosa Luxemburg, Virginia Woolf, Simone Weil, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Franca Ongaro Basaglia, Luce Fabbri, Assia Djebar, Rigoberta Menchu’, Martha C. Nussbaum, Luce Irigaray, Aung San Suu Kyi, Silvia Vegetti Finzi, Eve Ensler, Vandana Shiva.
Concludendo l’incontro a nome delle e dei partecipanti il responsabile della struttura nonviolenta viterbese ha riassunto alcuni dei convincimenti profondi che dagli anni Settanta sono alla base della riflessione e dell’attivita’ del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo.
1. Che il pensiero delle donne e’ stato nel Novecento ed e’ oggi il contributo teorico piu’ importante della civilta’ umana: in tutti i campi di riflessione fondamentali il contributo delle pensatrici e’ decisivo.
2. Che il movimento delle donne e’ l’unico movimento storico di liberazione dell’umanita’ che nella sua azione non ha violato i diritti umani, non ha commesso stragi, non ha instaurato nuove oppressioni: e’ quindi l’unico movimento di liberazione integralmente coerente con le sue premesse e i suoi fini di universale solidarieta’ e liberazione.
3. Che la lotta di liberazione delle donne e’ tout court la lotta di liberazione dell’umanita’, poiche’ solo se si sconfiggera’ la violenza maschilista e patriarcale sara’ possibile abolire la guerra e l’ingiustizia sociale, il militarismo e l’autoritarismo, il razzismo e il totalitarismo, il potere mafioso e il regime della corruzione, il pregiudizio e le persecuzioni, le pratiche necrofile e l’ecocidio, tutte violenze che nell’ideologia e nelle pratiche del maschilismo e del patriarcato trovano la loro piu’ profonda radice.
4. Che il femminismo e’ la corrente calda della nonviolenza in cammino, l’esperienza storica decisiva della lotta dell’umanita’ contro tutte le violenze e le menzogne. Femminista ed ecologista, socialista e libertaria, solo la nonviolenza puo’ salvare l’umanita’.
*
Il "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
Viterbo, 24 maggio 2013
Mittente: "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo,
 strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo,
strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo,
 e-mail: nbawac@tin.it e
e-mail: nbawac@tin.it e
 centropacevt@gmail.com,
centropacevt@gmail.com,
 web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/
web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/-
> LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- Assia Djebar, la rivincita delle donne arabo-musulmane (di Francesca Paci).8 febbraio 2015, par Federico La Sala
Assia Djebar, la rivincita delle donne arabo-musulmane
Assia Djebar, pseudonimo di Fatima-Zohra Imalayen, era nata a Cherchell, 80 chilometri a Ovest di Algeri il 30 giugno 1936
Si è spenta a 78 anni la scrittrice algerina che si batté per l’indipendenza del suo Paese e aprì la strada al femminismo islamico
di Francesca Paci (La Stampa, 08.02.2015)
Quando c’interroghiamo sul ruolo delle donne nel mondo arabo-musulmano, presupponendo una subalternità quasi genetica, dimentichiamo spesso nomi come quello di Assia Djebar, la scrittrice algerina morta a 78 anni ieri in un ospedale di Parigi. Ritenuta una sorta di Toni Morrison nordafricana, a detta di Le Figaro ha sempre mancato di poco il premio Nobel per aver voluto scrivere solamente in francese (la lingua che suo padre insegnava alla scuola elementare di Cherchell, sulla costa algerina).
Chi studia il femminismo islamico nelle sue molteplici declinazioni, dalle attiviste di «Tahrir bodyguard» che denunciano il dilagare delle molestie sessuali in Egitto fino alle aspiranti mujaheddin follemente ma consapevolmente votate alla guerra santa di Siria, non può ignorare l’opera e la vita di Assia Djebar, in trincea quando ignoravamo quella trincea.
La futura autrice di opere come Donne d’Algeri nei loro appartamenti e Lontano da Medina ha 22 anni quando nel 1958 sposa a Parigi il membro della resistenza algerina Ahmed Ould-Rouis conosciuto durante le proteste studentesche. L’Europa in quel momento è lanciata verso il futuro e la Francia, dove il padre ha mandato Assia a studiare storia dopo la scuola coranica privata algerina frequentata da due sole bambine, è assai diversa dal paese spaventato che oggi vede nel fondamentalismo islamico la propria immagine distorta e profanata.
Assia cresce, assorbe, conosce, quando decide di mettersi a scrivere dimentica di chiamarsi Fatima-Zohra Imalayen per non creare problemi alla famiglia e durante un gioco in taxi con il fidanzato del momento si ribattezza Assia Djebar, il nome con cui si batterà per l’indipendenza patria, lavorerà come giornalista in Tunisia rivelando il dramma dei connazionali rifugiati, pubblicherà i libri maghrebini più tradotti al mondo e diventerà la prima donna algerina ammessa alla Ecole Normale Supérieure francese. Rinuncerà alla Ecole durante la guerra per l’indipendenza algerina, ma verrà reintegrata da Charles de Gaulle per «meriti letterari» (otterrà anche il titolo di Accademica di Francia).
Pochi hanno raccontato come Assia Djebar il corpo mortificato delle donne arabo-musulmane quando non era di moda, quando le adultere lapidate nello stadio di Kabul non facevano notizia, quando quasi nessuno aveva realizzato che l’Algeria dei primi Anni 90 era un laboratorio di terrore così annichilente da spingere una come lei a lasciare l’università di Algeri e trasferirsi negli Stati Uniti perché stanca di un paese in cui «in strada non si vedono più donne, solo uomini».
Il corpo delle protagoniste dei romanzi e dei documentari di Assia Djebar è lingua, una lingua così tanto silenziata nel suo mondo d’origine d’averla probabilmente spinta a servirsi del francese rinunciando a quell’arabo disprezzato per essersi messo al servizio degli uomini. Con il film in bianco e nero La Nouba des femmes du Mont Chenoua la Djiebar guadagna il premio internazionale della critica al Festival di Venezia 1979, ma a sedurre l’Italia è più la potenza dell’immagine che la forza della denuncia di un’avanzata integralista che dopo la marginalizzazione delle donne come lei sarebbe dilagata oltre.
Negli ultimi anni si è sentito poco il suo nome, aveva sempre meno voglia di parlare. Una delle ultime uscite risale all’indomani delle Twin Towers, la Djebar era a New York mentre le Torri Gemelle crollavano seppellendo l’illusione della fine della Storia e la pacificazione del mondo. Disse di aver pensato che «il dramma conosciuto in Algeria negli anni della violenza integralista fosse sotto i miei occhi in una versione più spettacolare». E intitolò il libro appena terminato La donna senza sepoltura, il testamento di una cultura.
Assia Djebar morta: raccontò il corpo delle donne nella società islamica
La scrittrice è morta a Parigi a 78 anni. I suoi 14 romanzi sono stati pubblicati in Italia da Giunti e Il Saggiatore. Le protagoniste, vere e proprie eroine femministe, sfidavano spesso i divieti imposti dalla società musulmana algerina
di Davide Turrini (Il Fatto quotidiano, 7 febbraio 2015)
Assia Djebar, in quell’islamismo radicale che oggi tanto sconvolge, era completamente immersa. Eppure in 50 anni di romanzi, sceneggiature, film e riflessioni su quel macigno storico e culturale, la Djebar, scomparsa la notte scorsa a Parigi all’età di 78 anni, da donna, da algerina, da femminista, e da anticolonialista riuscì a crearci un poema infinito, suadente e penetrante, musicale e magmatico, tumultuoso ed affascinante, lungo 14 romanzi (in Italia pubblicati da Giunti e Il Saggiatore) in 50 anni di carriera.
Nata Fatima-Zohra Imalayan il 4 agosto del 1936 nel sobborgo costiero di Cherchell, vicino al porto di Algeri, quando decise di esordire nel 1957 come scrittrice con il libro La Sete adottò un nom de plume che poi le rimase per il resto della vita: Assia Djebar. Timorosa della punizione paterna e delle leggi di un patriarcato onnipresente e regolatore dimostrò subito di che pasta fosse fatta: quel libro e quello immediatamente successivo - Le Impazienti (1958) - erano romanzi provocatori le cui protagoniste, vere e proprie eroine femministe, sfidavano i divieti imposti dalla società algerina alla condizione della donna. Pubblicità
La Djebar aveva subito compreso che la partita dell’emancipazione femminile, intersecatasi in quegli anni con un’altra “guerra”, quella del popolo algerino contro il colonialismo francese, passava attraverso il corpo delle donne: “Per tutte, giovani o vecchie, in clausura o mezze-emancipate, la lingua resta quella del loro corpo: quel corpo che gli occhi dei maschi chiedono sia invisibile, finché non riescono a incarcerarlo coprendolo interamente; quel corpo in trance, danzante, che si adatta alla speranza e alla disperazione; quel corpo ribelle, in grado di leggere e scrivere, in cerca di qualche spiaggia sconosciuta come meta del suo messaggio d’amore”, spiegò con una prosa armonica la scrittrice algerina.
Perché lei, mentre le cugine pensavano a mettersi il velo, imparava il francese e andava al liceo: nel 1955 va a Parigi, dove è la prima donna ammessa all’École Normale Supérieure de Sèvres. E nel ’58 è a Tunisi dove da un giornale locale denuncia il dramma dei rifugiati algerini. L’esordio letterario si intreccia poi con la guerra di liberazione algerina. Nello stesso anno sposa Ahmed Ould-Rouïs, membro della Resistenza Algerina, dal quale divorzia per poi sposare nel 1980 il poeta Malek Alloula.
Nel 1962 è ad Algeri dopo la dichiarazione d’indipendenza algerina. Insegna Storia del Nord Africa presso la Facoltà di Lettere poi nel 1977 ecco l’esordio dietro la macchina da presa con La Nouba des femmes du Mont Chenoua, film in bianco e nero che vince il Premio Internazionale della Critica al Festival di Venezia nel 1979, dove si narra la vicenda di una donna che decide di tornare sulle montagne berbere del suo paese natale alla ricerca delle “Madri” che parteciparono alla guerra d’indipendenza algerina per ritrovare i suoni della “memoria strappata”.
Con le recrudescenze dell’oscurantismo islamico che fa irruzione in Algeria negli anni ottanta, la Djebar si allontana definitivamente dal suo paese natale per trasferirsi negli Usa, in Louisiana, poi a Parigi, e ancora a New York: ironia della sorte proprio pochi giorni prima degli attentati dell’11 settembre 2001: “Quella mattina ero lì, a dieci minuti a piedi dalle Torri Gemelle, chiusa nel mio appartamento, senza televisione. (...) La mia prima impressione è stata che il dramma che avevo conosciuto in Algeria negli anni della violenza integralista fosse sotto i miei occhi in una versione più spettacolare”, spiegò la Djebar.
“La cosa che più mi ha colpito, nei giorni successivi, sono state le fotografie dei dispersi appese dappertutto e, a partire dal quarto giorno, la disperazione dei parenti che capivano che non avrebbero più avuto indietro neppure i loro corpi. È stato allora che ho deciso di chiamare il romanzo che avevo appena finito La donna senza sepoltura”. Djebar è, infine, stata la prima donna di origine araba a far parte dell’Accademia di Francia nel 2006. “E’ una fortuna essere uno scrittore, perché la scrittura - e questo me lo prometto ogni giorno interiormente - deve essere risparmiata dal sangue e dall’oscurità della violenza”, disse in un’intervista a Giovanna Taviani. “Ancor di più oggi mi rendo conto che il compito della scrittura letteraria è proprio questo: lavorare su se stessi, sulla propria memoria, sul ritorno o sul non-ritorno”.
-
-
>OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE --- DONNE E LEADERSHIP. Dichiarazione del Forum 2013 delle teologhe indiane (di Indian Women Thologians’ Forum 2013).24 maggio 2013, di Federico La Sala
 DONNE, UOMINI, E L’USCITA DA INTERI MILLENNI DI "PREISTORIA" E DI "LABIRINTO"- OGGI, 2013 dopo Cristo ....
DONNE, UOMINI, E L’USCITA DA INTERI MILLENNI DI "PREISTORIA" E DI "LABIRINTO"- OGGI, 2013 dopo Cristo ....
 INDIA E CHIESA CATTOLICA: DONNE E LEADERSHIP. Dichiarazione del Forum 2013 delle teologhe indiane di Indian Women Thologians’ Forum 2013
INDIA E CHIESA CATTOLICA: DONNE E LEADERSHIP. Dichiarazione del Forum 2013 delle teologhe indiane di Indian Women Thologians’ Forum 2013
 Condividere la nostra personale esperienza di donne leader in vari ambiti ha rivelato un filo comune dell’esperienza delle donne nella presenza del divino e nella loro capacità di rispondere con fede e coraggio. L’ingiunzione scritturale “egli dominerà su di te” (Gen 3,16) sembra essere la sanzione religiosa che legittima il controllo maschile sulle donne all’interno delle sfere di famiglia, chiesa e società in senso generale.
Condividere la nostra personale esperienza di donne leader in vari ambiti ha rivelato un filo comune dell’esperienza delle donne nella presenza del divino e nella loro capacità di rispondere con fede e coraggio. L’ingiunzione scritturale “egli dominerà su di te” (Gen 3,16) sembra essere la sanzione religiosa che legittima il controllo maschile sulle donne all’interno delle sfere di famiglia, chiesa e società in senso generale.
-
> GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE --- LA SCELTA DI ERCOLE: LA LEZIONE DI ERWIN PANOFSKY.18 maggio 2013, di Federico La Sala
 ICONOLOGIA, ESTETICA, ED ETICA. I pittori del rinascimento alla mitologia greco-romana, interpretata allegoricamente, affidavano lo stesso ruolo filosofico a essa affidato dalla letteratura.
ICONOLOGIA, ESTETICA, ED ETICA. I pittori del rinascimento alla mitologia greco-romana, interpretata allegoricamente, affidavano lo stesso ruolo filosofico a essa affidato dalla letteratura.
 LA SCELTA DI ERCOLE: LA LEZIONE DI ERWIN PANOFSKY. Note di Antonio Gnoli e Anna Li Vigni
LA SCELTA DI ERCOLE: LA LEZIONE DI ERWIN PANOFSKY. Note di Antonio Gnoli e Anna Li Vigni
 Ercole sapeva scegliere (e fare) la cosa giusta (...) E noi? L’ Italia, maestra dell’ arabesco, ha quasi sempre preferito l’ arte del rimando, come dire: è sempre meglio che la decisione la prenda qualcun’ altro.
Ercole sapeva scegliere (e fare) la cosa giusta (...) E noi? L’ Italia, maestra dell’ arabesco, ha quasi sempre preferito l’ arte del rimando, come dire: è sempre meglio che la decisione la prenda qualcun’ altro.