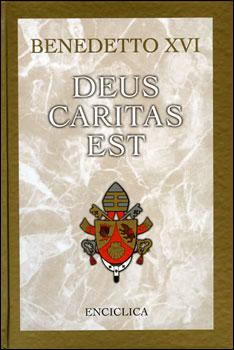
NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO. "NATALE" A OXFORD NON SI DICE PIU’ "CHRISTMAS"? MA IN VATICANO "AMORE" NON SI DICE "CHARITAS" GIA’ DA TEMPO !!! Un articolo di Marco Tosatti - con una nota di Federico La Sala
Al di là del gioco degli equivoci, delle polemiche strumentali, e della cecità delle varie gerarchie religiose, la decisione del Consiglio Comunale di Oxford sembra essere - in buona fede - un’altra: riportare l’Acqua della "vecchia" Sapienza nella Città nuova!!!
"CHRISTMAS" VUOL ESSERE - SEMPLICEMENTE E SENZA CONTRAPPOSIZIONI - LA "FESTA DELLA LUCE D’INVERNO", SIA NATURALE SIA SOPRA-NATURALE!!!
VERITA’ E RICONCILIAZIONE: AL DI LA’ DI OGNI DUALISMO E DI OGNI FONDAMENTALISMO - NEL SEGNO DEL "X", DEL "CHRISTMAS" E DI .... O"X"FORD!!!
"LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE" (Gv 1. 5). E ... LE TENEBRE L’ACCOLGONO, FINALMENTE.
__________________________
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO.
Se Oxford cancella il Natale... *
di Marco Tosatti *
La città inglese famosa per la sua Università ha sostituito con la "Festa della luce invernale" le celebrazioni natalizie. Contrari tutti gli esponenti religiosi.
Il consiglio comunale di Oxford ha ufficialmente cancellato la parola Natale, “Christmas” da tutti gli eventi del 25 dicembre e dei giorni successivi per sostituirla con una nuova definizione, quella di “Winter Light Festival”, la Festività della Luce Invernale. Una associazione di beneficenza locale, la Oxford Inspires, sarebbe la principale ispiratrice della decisione. Tei Williams, portavoce dell’organizzazione, ci tiene a ricordare che questa “Winter Light Festival” è ben di più del Natale: due mesi di festa nei quali rientrano eventi, incontri, spettacoli, concerti... tutto quanto fa spettacolo (e possibilmente, fa vendere). "In questo contesto ci saranno anche celebrazioni del Natale, come i cori di canzoni natalizie".
Il vicesindaco di Oxford, Ed Turner, approva l’idea: "Faremo lo stesso un grande albero di Natale nella piazza principale della città", dice. "Ma lo chiameremo in modo diverso". "Mancherà qualcosa alle luminarie di Natale a Oxford, quest’anno: qualsiasi riferimento al Natale". Il Daily Mail sintetizza, così, nell’attacco dell’articolo, la novità ’politically correct’ decisa dall’amministrazione comunale della cittadina inglese famosa in tutto il mondo per la sua Università. La Chiesa Anglicana è scandalizzata, e altrettanto critiche le confessioni cristiane di Oxford: ma contrari all’iniziativa anche i rappresentanti di altre religioni.
Anche se la decisione degli amministratori era motivata dall’intenzione di non offendere la comunità islamica locale, per Sabir Hussain Mirza, presidente del Consiglio Musulmano di Oxford, "il Natale è la data del calendario attesa da tutti. Non solo i cristiani, ma anche i fedeli islamici e quelli di altre confessioni lo aspettano con trepidazione. Il Natale è una festa speciale e non può essere cancellato con un tratto di penna. Il Natale fa parte dell’essere britannici".
Fra l’altro i musulmani conoscono il Natale, “Aid al Ualid”, anche se non lo festeggiano come altre feste islamiche, perché considerano gesù, Issa, uno dei profeti. Dello stesso parere il rabbino Eli Bracknell, direttore del Jewish Educational Centre, il centro di studi ebraici di Oxford: "E’ importante mantenere un tradizionale Natale britannico. Qualsiasi iniziativa che diluisce la cultura tradizionale e la cristianità del Regno Unito non è positiva per l’identità britannica".
Secondo la Santa Sede la decisione del consiglio comunale di Oxford di abolire qualsiasi riferimento al Natale è un sintomo dell’ateismo che oggi si promuove con l’indifferenza religiosa, constata un rappresentante vaticano. L’Arcivescovo Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha commentato la decisione della città britannica di menzionare tutti gli eventi del 25 dicembre e dei giorni successivi con il nome "Festività della luce invernale".
Monsignor Ravasi, ha constatato alla "Radio Vaticana" che il desiderio di questa iniziativa di Oxford "non è tanto quello, a mio avviso, di riuscire a ristabilire un dialogo in modo tale da non avere prevaricazioni, quanto, piuttosto, quello di stingere fino al punto di estinguere qualsiasi identità propria, qualsiasi storia che sta alle spalle, e non stabilire un vero dialogo". "Il vero dialogo lo si costruisce proprio attraverso le identità; quindi, in questo caso, io ritengo che non solo si tratti di una stravaganza, ma alla fine anche di una negazione consapevole - non so fino a che punto - di una grandezza che sta alle proprie spalle, che costruisce il proprio stesso volto".
"Mentre in passato, quando si combatteva la presenza dei segni religiosi, lo si faceva con delle argomentazioni, persino con il desiderio di opporre un sistema del tutto alternativo, ora, invece, tante volte, questa avanzata della negazione è una specie di onda grigia, di nebbia; si vuole introdurre proprio una componente così fluida ed inconsistente che è la caratteristica della secolarizzazione attuale", spiega il rappresentante vaticano. "Dio non viene negato, viene del tutto ignorato e l’impegno pastorale è ancora più complesso perché di fronte ad una negazione si possono apportare le argomentazioni. Di fronte invece a questa sorta di ’gioco di società’ incolore, inodore, insapore, c’è, alla fine, l’impossibilità di una reazione". "Ora noi non abbiamo più l’ateismo nel senso forte, qualche volta drammatico del passato. Noi ora abbiamo l’indifferenza. Questa indifferenza stempera tutto, stinge, scolora, e alla fine, forse impedisce all’uomo anche di interrogarsi - come fanno tutte le grandi religioni - sui temi fondamentali, temi capitali che vengono invece dissolti nell’interno di un’atmosfera così inconsistente".
L’Arcivescovo considera molto positivo il fatto che i musulmani si oppongano a questa iniziativa, perché significa che anch’essi sono consapevoli dei pericoli di questo tentativo di eliminare le identità. “Ancora una volta si tratta di linguaggio politicamente corretto impazzito e sono contento di sapere che i nostri amici musulmani e ebrei la pensano allo stesso modo”. Così mons. Crispian Hollis, vescovo responsabile della diocesi di Portsmouth, alla quale appartiene il lato meridionale di Oxford, ha commentato la decisione della nota città universitaria di bandire la parola Natale e chiamare le prossime festività “Festival invernale della luce”. “La decisione offende la comunità cristiana della città, non fa nulla per promuovere l’armonia razziale e, nel nome dell’inclusività, esclude le tradizioni di una significativa parte della popolazione della città. Deploro questa decisione e spero che il comune ci ripensi”, ha detto ancora il vescovo.
* La Stampa/San Pietro e dintorni, 4/11/2008
.... IL VATICANO HA CANCELLATO GIA’ DA TEMPO LA "CHARITAS"!!!
di Federico La Sala
 CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE (...)
CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE (...)
 DEUS CHARITAS EST (...)
DEUS CHARITAS EST (...)
 ET NOS CREDIDIMUS CHARITATI
(1Gv., 4. 1-8).
ET NOS CREDIDIMUS CHARITATI
(1Gv., 4. 1-8).
 CARISSIMI, NON PRESTATE FEDE A OGNI SPIRITO (...)
CARISSIMI, NON PRESTATE FEDE A OGNI SPIRITO (...)
 DIO E’ AMORE (...)
DIO E’ AMORE (...)
 E NOI ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE
E NOI ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE
 (1 Gv., 4. 1-8)
(1 Gv., 4. 1-8)
Caro BENEDETTO XVI ...
Corra, corra ai ripari (... invece di pensare ai soldi)! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. L’Eu-angélo dell’AMORE (“charitas”) è diventato il Van-gélo del ’caro-prezzo’ e della preziosi-tà (“caritas”), e la Parola (“Logos”) è diventato il marchio capitalistico di una fabbrica (“Logo”) infernale ... di affari e di morte?! Ci illumini: un pò di CHIAREZZA!!! FRANCESCO e CHIARA di Assisi si sbagliavano?! Claritas e Charitas, Charitas e Claritas... o no?!
Federico La Sala
 “DEUS CARITAS EST”: IL “LOGO”
“DEUS CARITAS EST”: IL “LOGO”
 DEL GRANDE MERCANTE
E DEL CAPITALISMO
DEL GRANDE MERCANTE
E DEL CAPITALISMO
di Federico La Sala *
In principio era il Logos, non il “Logo”!!! “Arbeit Macht Frei”: “il lavoro rende liberi”, così sul campo recintato degli esseri umani!!! “Deus caritas est”: Dio è caro-prezzo, così sul campo recintato della Parola (del Verbo, del Logos)!!! “La prima enciclica di Ratzinger è a pagamento”, L’Unità, 26.01.2006)!!!
Il grande discendente dei mercanti del Tempio si sarà ripetuto in cor suo e riscritto davanti ai suoi occhi il vecchio slogan: con questo ‘logo’ vincerai! Ha preso ‘carta e penna’ e, sul campo recintato della Parola, ha cancellato la vecchia ‘dicitura’ e ri-scritto la ‘nuova’: “Deus caritas est” [Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006]!
Nell’anniversario del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio, non poteva essere ‘lanciato’ nel ‘mondo’ un “Logo” ... più ‘bello’ e più ‘accattivante’, molto ‘ac-captivante’!!!
Il Faraone, travestito da Mosè, da Elia, e da Gesù, ha dato inizio alla ‘campagna’ del Terzo Millennio - avanti Cristo!!! (Federico La Sala)
*www.ildialogo.org/filosofia, Giovedì, 26 gennaio 2006.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO.
 CHARITAS (AMORE) O CARITAS (CARO-PREZZO, MAMMONA)?!
CHARITAS (AMORE) O CARITAS (CARO-PREZZO, MAMMONA)?!
 Il Papa incontra i partecipanti al primo seminario del forum cattolico-musulmano*
Il Papa incontra i partecipanti al primo seminario del forum cattolico-musulmano*
*
GOD IS LOVE - This truth, which we consider foundational, was what I wished to emphasize in my first Encyclical, Deus Caritas Est...
DIO E’ AMORE - Questa verità, che consideriamo fondante, è ciò che ho voluto evidenziare nella mia prima Enciclica, Deus Caritas est
[...] The Christian tradition proclaims that God is Love (cf. 1 Jn 4: 16). It was out of love that he created the whole universe, and by his love he becomes present in human history. The love of God became visible, manifested fully and definitively in Jesus Christ. He thus came down to meet man and, while remaining God, took on our nature. He gave himself in order to restore full dignity to each person and to bring us salvation. How could we ever explain the mystery of the incarnation and the redemption except by Love? This infinite and eternal love enables us to respond by giving all our love in return: love for God and love for neighbour. This truth, which we consider foundational, was what I wished to emphasize in my first Encyclical, Deus Caritas Est, since this is a central teaching of the Christian faith. Our calling and mission is to share freely with others the love which God lavishes upon us without any merit of our own. [...]
[...] La tradizione cristiana proclama che Dio è Amore (cfr. 1 Gv 4, 16). È per amore che ha creato tutto l’universo, e con il suo amore si fa presente nella storia umana. L’amore di Dio è divenuto visibile, manifestato in maniera piena e definitiva in Gesù Cristo. Così egli è disceso per incontrare l’uomo e, pur rimanendo Dio, ha assunto la nostra natura. Ha donato se stesso per restituire la piena dignità a ogni persona e per portarci la salvezza. Come potremmo spiegare il mistero dell’incarnazione e della redenzione se non con l’Amore? Questo amore infinito ed eterno ci permette di rispondere dando in cambio tutto il nostro amore: amore verso Dio e amore verso il prossimo. Questa verità, che consideriamo fondante, è ciò che ho voluto evidenziare nella mia prima Enciclica, Deus Caritas est, poiché è un insegnamento centrale della fede cristiana. La nostra chiamata e la nostra missione sono di condividere liberamente con gli altri l’amore che Dio ci prodiga senza alcun merito da parte nostra [...]
*
Si cfr.:
 Il Papa incontra i partecipanti al primo seminario del forum cattolico-musulmano. Il nome di Dio può essere solo
un nome di pace e fratellanza, Osservatore Romano, 7 novembre 2008
Il Papa incontra i partecipanti al primo seminario del forum cattolico-musulmano. Il nome di Dio può essere solo
un nome di pace e fratellanza, Osservatore Romano, 7 novembre 2008
Forum
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO. "NATALE" A OXFORD NON SI DICE PIU’ "CHRISTMAS"? MA IN VATICANO "AMORE" NON SI DICE "CHARITAS" GIA’ DA TEMPO !!! - La dittatura della X, fra affetti e affari (di Vittorio Zucconi)1 dicembre 2017, di Federico La Sala
PERDITA DELLA MEMORIA FILOLOGICA E TEOLOGICA: LA “X” (“CHI”, GRECO) DIVENTA “X” (“ICS”, LATINO; E, SEMPLICEMENTE, "C", IN ITALIANO) E GESU’, IL FIGLIO DELLA GRAZIA EVANGELICA ("CHARITAS") DIVENTA IL "TESORO" DI "MAMMONA" ("CARITAS") E DI "MAMMASANTISSIMA" DEI FARAONI ...
- "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS": LA CARITA’ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia) NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!).
opinioni
La dittatura della X fra affetti e affari
di Vittorio Zucconi (la Repubblica D, 25.11.2017)
Il Medioevo italiano la mise al bando, ma ora si usa ovunque, perché, evidentemente, attira l’attenzione. Che si tratti di business o di baci
ATTESO DA ALMENO cento milioni di esseri umani, molti dei quali in fila da giorni, è arrivato l’ultimo totem per il villaggio globale: l’iPhone X della Apple. Niente di misterioso in quella X, solo la celebrazione in numeri romani del decimo anniversario dell’iPhone lanciato da Steve Jobs: così dicono dalla Mela, ma mentono sapendo di mentire. Per segnalare il decennale, avrebbero potuto benissimo chiamarlo iPhone 10, come i predecessori 6, 7 o 8.
I geni del marketing hanno scelto la X per lo stesso motivo che ha spinto i concorrenti della Microsoft a chiamare la loro scatola da giochi XBox e (nell’ultima edizione diffusa negli stessi giorni dell’iPhone X, per tormentarci il Natale) addirittura XBoxOneX. Tre X al prezzo di una. Non è necessario essere geni dell’enigmistica e dei cruciverba per notare la fissazione per una lettera-simbolo che, da secoli e mai come ora, è uscita dal recinto dell’algebra per invadere i territori del commercio, dell’immaginazione, del calcio e del sesso, pardon, del sex.
La X vende, piace, intriga, nella sua invadenza. L’epidemia di questa lettera (che, nel Medioevo, l’alfabeto italiano aveva escluso, insieme con K e Y, presenti invece nell’alfabeto latino) è naturalmente partita dagli Stati Uniti ed è un indizio del dominio culturale anglofono. È ovunque e le femmine ne hanno pretese addirittura due nei propri cromosomi, XX, lasciando a noi maschi l’umiliazione di quella Y solitaria.
S’insinua nella vita di ogni paziente, che ha sicuramente inghiottito una pillola il cui nome conteneva una X o è stato esposto ai raggi X. Ci sono almeno 50 farmaci da ricetta che la esibiscono, dal tranquillante Xanax, che raddoppia per sembrare più efficace, all’antibiotico Ciprofloxacina, somministrato a milioni di persone afflitte da infezioni delle vie urinarie.
Qualche linguista Usa ha cercato di spiegare l’attrazione con il Cristianesimo, partendo dalla croce che i Romani usavano per uccidere i nemici più pericolosi e che era fatta appunto a X, e non a T come nell’iconografia ufficiale. Ma non c’è nulla di mistico in banali varietà musicali come X Factor, copiato anche in Italia. Dubbi religiosi riaffiorano in dicembre, quando gli americani, sempre impazienti, abbreviano Christmas, Natale, in XMas. Ma poi si sprofonda nel prosaico esercizio del voto, che utilizzò quel segno affinché anche gli analfabeti potessero manifestare sulle schede le scelte politiche.
Resta in esso sempre il brivido del mistero, dell’incognita, come nelle equazioni o nella fantascienza della serie X-Files. Sa di frutto proibito, nei film porno classificati come XXX o nei commerci erotici, in quei Sex Shop che, se si chiamassero "botteghe del sesso", farebbero ancora più schifo. Diventa il richiamo alla morte e alla ferocia dei pirati, con le ossa incrociate a forma - che altro? - di X sotto il teschio. È uno dei molti simboli satanici, ma anche di tenerezza, nella stenografia da chat o da sms, dove sta per "baci", insieme con O, per "abbracci": XOXO, "ti mando baci e abbracci". Tende a essere estremista nell’abbigliamento, con le taglie XS, XL o addirittura, aiuto!, XXL. Anche l’immagine che guardiamo sul televisore, sul computer o sullo schermo dello smartphone paga un tributo, essendo formata da pixel.
Non ha colpe, né meriti questa lettera prepotente, immigrata senza autorizzazione fra di noi, ma qualche segreta e scaramantica influenza negativa forse sì. Soltanto uno, fra i 45 presidenti degli Stati Uniti in 200 e più anni, ha osato avere una X nel proprio nome, Richard Nixon. Finì infatti, primo e unico dimissionario nella storia, crocefisso alla vergogna delle proprie colpe.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori - a c. di Federico La Sala
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!Federico La Sala
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO. --- A Merry Christmas and a Happy New Year to You. Perché si dice “Merry Christmas”? E non Happy Christmas?25 dicembre 2015
Perché si dice “Merry Christmas”?
E non Happy Christmas, come potrebbe sembrare più naturale? C’entra l’alcol *
Su molti biglietti d’auguri, non solo nei paesi in cui si parla inglese, oggi appaiono due parole: Merry Christmas. Per quanto il senso sia immediatamente chiaro - Buon Natale - il Natale è probabilmente l’unico momento dell’anno in cui l’aggettivo merry conosce questa diffusione e popolarità, tanto da essere ormai associato quasi esclusivamente alla parola Christmas. Ma perché si dice Merry Christmas e non, come potrebbe sembrare più naturale, Happy Christmas? In inglese, infatti, si dice per esempio Happy New Year o Happy Thanksgiving. La spiegazione la riporta, tra gli altri, Matthew Schmitz sul sito della rivista religiosa First Things (ma è largamente diffusa su Internet).
L’espressione Merry Christmas nasce naturalmente in Regno Unito, anche se oggi è diffusa soprattutto negli Stati Uniti e in Nord America. In inglese antico la parola merry significava piacevole più che felice o gioioso, ma già nel Cinquecento veniva utilizzata di tanto in tanto per augurare buon Natale.
La prima attestazione dell’espressione risale al 1565 ed è contenuta nel manoscritto municipale della cittadina inglese Hereford: «And thus I comytt you to God, who send you a mery Christmas» («Vi raccomando a Dio, che vi mandi un Buon Natale»). Nel 1843 fu il Canto di Natale di Charles Dickens a renderla popolare e modificare il suo significato, associandola più a gioviale e festoso: nel romanzo Ebenezer Scrooge irride il Natale dicendo «If I could work my will... every idiot who goes about with ‘Merry Christmas’ on his lips should be boiled with his own pudding» («Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va attorno con cotesto ‘allegro Natale’ in bocca, avrebbe a esser bollito nella propria pentola», nella traduzione italiana più diffusa). Oltre alla grande popolarità dell’opera di Dickens, contribuì alla fortuna del termine anche il primo biglietto di auguri preparato per Natale (stampato a sua volta nel 1843) che conteneva l’espressione A Merry Christmas and a Happy New Year to You. L’aggettivo merry venne sempre più diffuso, venendo associato a un clima festoso e particolarmente sopra le righe.
Già dal Medioevo l’aggettivo aveva assunto questo significato, indicando in particolare l’ubriachezza. Sia la Bibbia di Wycliffe (una traduzione della Bibbia in inglese medievale risalente al 1382-1395) e la Bibbia di re Giacomo (una traduzione in inglese della Bibbia completata nel 1611) usavano il termine in tal senso, nella descrizione di una festa organizzata dal ricco Nabal: «He held a feast in his house, like the feast of a king; and Nabal’s heart was merry within him, for he was very drunken» («Tenne una festa a casa sua, una festa da re; e il suo cuore era allegro perché era molto ubriaco»).
Nell’Ottocento questo significato si rafforzò, finendo per indicare i festeggiamenti brilli e sfrenati delle classi più basse. Negli Stati Uniti la parola merry continuò a venire usata e a diffondersi nel corso dell’Ottocento, finendo per soppiantare il termine happy. Lo attesta per esempio la storia della poesia A Visit from St. Nicholas, una delle più popolari degli Stati Uniti, cha ha plasmato la figura di Babbo Natale come la conosciamo oggi. La versione originale, scritta dal poeta americano Clement Moore nel 1823, si chiudeva con l’augurio di Happy Christmas to all, che in molte edizioni successive venne sostituita con la più popolare Merry Christmas to all.
In Gran Bretagna e Irlanda invece, la parola merry venne via via abbandonata dalle classi medio-alte dell’epoca vittoriana, caratterizzate da puritanesimo e da una forte volontà moralizzatrice. Mentre il termine merry indicava le feste dei ceti bassi, dissennate e alcolizzate, la parola happy suggeriva invece festeggiamenti più sobri, dove la contentezza derivava da una vita virtuosa e dal duro lavoro. Ancora adesso in Regno Unito la formula più diffusa è Happy Christmas: e non è un caso che sia quella preferita dalla regina Elisabetta, che la utilizza ogni anno per fare gli auguri ai sudditi nel tradizionale discorso di Natale.
* http://www.ilpost.it/2012/12/25/perche-si-dice-merry-christmas/
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO. "NATALE" A OXFORD NON SI DICE PIU’ "CHRISTMAS"? --- Merry Christmas, “Merry Newtonmas”! Un Natale nel nome di Isacco Newton (di Piergiorgio Odifreddi)29 dicembre 2013, di Federico La Sala
Un Natale nel nome di Isacco (Newton)
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 29.12.2013)
Lo scorso mercoledì una parte del mondo occidentale ha meditato sulle parole del Vangelo secondo Giovanni (I, 6-7): «Venne un uomo mandato da Dio», e «venne come testimone per rendere testimonianza alla luce». E ha festeggiato quell’uomo, che cambiò la storia dell’Occidente, e nacque il giorno di Natale: ma non dell’anno 0, bensì del 1642. Quell’uomo aveva un nome biblico, ma non si chiamava Giovanni o Gesù: bensì, Isacco, o meglio, Isaac.
In realtà, quell’uomo nacque il giorno di Natale solo in Inghilterra, dove la riforma del calendario non era ancora stata adottata: nel resto d’Europa, si era ormai già al 4 gennaio 1643. Ciò nonostante, in Inghilterra il 25 dicembre continua a esser chiamato non solo Christmas, ma anche Newtonmas.
Perché è appunto di Newton che stiamo parlando: un uomo che “rese testimonianza alla luce” in un libro chiamato Ottica, nel quale spiegò al mondo che la luce bianca in realtà è un miscuglio di luci colorate, nelle quali si può decomporre facendola passare attraverso un prisma, e che si possono ricomporre facendole ripassare attraverso un prisma invertito. Solo la mela che ispirò allo stesso Newton la legge di gravitazione universale può competere con il suo prisma nell’immaginario scientifico collettivo, come simbolo del colpo di genio in grado di cambiare la storia del pensiero e dell’uomo.
È per questo che, quando Newton morì, Alexander Pope compose un epitaffio che paragonava la sua nascita non solo a quella di Cristo, ma addirittura alla creazione del mondo: «God said: Let Newton be, and all was light», ossia “Dio disse: Sia fatto Newton, e la luce fu”. Ed è per questo che il 25 dicembre molti si sono augurati, invece che un religioso Merry Christmas, un laico “Merry Newtonmas”!
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO --- Merry Christmas, “Merry Newtonmas”! Un Natale nel nome di Isacco Newton --- ONU: 2015, ANNO DELLA LUCE.6 dicembre 2015, di Federico La SalaONU: 2015, ANNO DELLA LUCE. Ai poeti ‘lunatici’ e ai filosofi ‘solari’: "l’abitudine non può rendere insipida la varietà infinita della bellezza" - prodotta dalla luce
 LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE.
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE.
-
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO. "NATALE" A OXFORD NON SI DICE PIU’ "CHRISTMAS" ---- IL "FINANCIAL TIMES" E LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI.21 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... e un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio ("Charitas") con Mammona ("Caritas")!!!
Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... e un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio ("Charitas") con Mammona ("Caritas")!!!
 NATALE A LONDRA: LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI E IL "FINANCIAL TIMES". Il testo di Benedetto XVI e una nota di Sergio Cesaratto
NATALE A LONDRA: LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI E IL "FINANCIAL TIMES". Il testo di Benedetto XVI e una nota di Sergio Cesaratto
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO. ---- Charles Dickens, di cui ricorrono oggi i duecento anni dalla nascita, un maestro di verità sociali, parola di Marx (di Enrico Palandri) - Dickens in Italia sull’orlo del vulcano (di Richard Newbury)7 febbraio 2012, di Federico La Sala
Dickens, maestro di verità sociali, parola di Marx
Per l’autore del «Manifesto» ha fatto più denuncia politica dei politici di professione. A 200 anni dalla nascita il romanziere inglese influenza lo sguardo che abbiamo ancora oggi sul lavoro, la finanza, la povertà
di Enrico Palandri (l’Unità, 07.02.2011)
Di Charles Dickens, di cui ricorrono oggi i duecento anni dalla nascita, Karl Marx scrive in un articolo apparso sul New York Tribune il primo agosto del 1854 che è un autore le cui... pagine eloquenti e icastiche hanno donato al mondo più verità politiche e sociali di quelle pronunciate da professionisti della politica, pubblicisti e moralisti messi insieme, descrivono ogni tratto della borghesia, dai detentori di capitale e beneficiari di rendite che guardano dall’alto ogni altro commercio come volgare, ai negozianti e gli avvocati.
La straordinaria influenza della società colta da Dickens ci ha costruiti e rimane lo sguardo che abbiamo ancora oggi sul lavoro, la finanza, la povertà. Di questo mondo ebbe esperienza diretta e lo racconta con uno schema pressoché costante in tutta la sua opera: rigida divisione in classi sociali e potenza del denaro, che istituisce e abolisce barriere in contrasto con l’umanità dei personaggi.
Denaro, ed è questa la grande innovazione, che è quindi del tutto indipendente dal merito e dal lavoro e al contrario è volatile, finanziario, appare e scompare improvvisamente attraverso eredità o eredità mancate, si moltiplica o crolla per accumuli e investimenti in borsa. Denaro che scorre insieme al sangue per le strade di Londra, la vera protagonista dei suoi romanzi, la cui natura completamente umana è data proprio dalla sua variegatissima popolazione.
Di queste fortune Dickens ebbe esperienza diretta: suo padre era stato rinchiuso nella famosa Marshalsea per debiti quando Charles Dickens aveva dodici anni, e altrettanto miracolosamente ne era uscito ereditando 450 sterline dalla nonna paterna (come Dickens racconterà nel personaggio William Dorrit).
FORTUNA AL CINEMA E IN TV
Dickens provò in quel periodo il destino del suo personaggio Oliver Twist, lavorando in una fabbrica piena di ratti per dieci ore al giorno, e in seguitò o per esperienza diretta o nelle sue inchieste giornalistiche, conobbe da vicino le diversissime condizioni sociali che ritrae nei suoi libri.
Quel mondo è ancora vivissimo nel nostro modo di pensare il mondo: dai suoi dodici romanzi principali e soprattutto da A Christmas Carol sono stati tratti 180 adattamenti cinematografici o televisivi, per non parlare della fortuna di Scrooge, che è l’archetipo di una miriade di personaggi fino allo Zio Paperone di Disney, che nell’ originale inglese porta infatti il suo nome.
Negli ultimi anni la Bbc ha rinvigorito l’industria che ripropone queste storie al grande pubblico. Little Dorrit, Nicholas Nickleby o Bleak House sono tutte diventate fortunatissime serie televisive.
LA COMICITÀ
Recitate e messe in scena di solito molto bene, queste storie non catturano purtroppo i tratti letterari più preziosi e specifici di Dickens. Innanzitutto la comicità. Persino nelle vicende più tragiche o patetiche Dickens intrattiene con i suoi lettori una complicità fondata soprattutto sul sorriso. Con i nomi parlanti dei personaggi, ma soprattutto con l’osservazione parodica delle aspirazioni alla promozione sociale che costituiranno un modelo per tutti i romanzieri fino a Mme. Verdurin di Proust e oltre.
Ma è soprattutto la straordinaria prosa inglese di questo autore a rimanere impressa nei lettori: la capacità di impostare un tono che pur restando sempre concreto trascende la scena con una profonda simpatia umana degna della Ginestra di Leopardi, come nell’incipit di Our mutual friend, dove vengono descritti un padre e una figlia che vanno in barca lungo il Tamigi, di notte, per ripescare i cadaveri di assassinati gettati nel fiume per tentare di recuperare qualcosa: un orologio, qualche moneta.
Sono personaggi che non resteranno al centro del racconto, ma che danno la misura di come l’arte del romanzo, emancipandosi dalla poesia e dalla memorialistica, mescolandosi con i materiali corrivi del giornalismo o della cronaca giudiziaria, iniziasse allora a inventare un proprio ambito estetico, facendo di noi stessi il teatro in cui la parola letta silenziosamente ma nella social catena di una nuova readership avida di emancipazione, risuona più netta e limpida che nella recitazione di un grande attore. Anche solo per questo, buon compleanno Charles Dickens!
 Dickens in Italia sull’orlo del vulcano
Dickens in Italia sull’orlo del vulcano
 Il grande scrittore inglese nasceva duecento anni fa
Il grande scrittore inglese nasceva duecento anni fa
 Nei suoi reportage le contraddizioni del nostro Paese
Nei suoi reportage le contraddizioni del nostro Paese di Richard Newbury (La Stampa, 07.02.2012)
di Richard Newbury (La Stampa, 07.02.2012)- Festa a Portsmouth e omaggio su Radio3
 La Gran Bretagna festeggia oggi il bicentenario della nascita di Charles Dickens, uno dei più grandi scrittori della letteratura inglese i cui romanzi sono diventati classici intramontabili. Sono previste celebrazioni in tutto il paese, da Londra a Portsmouth, dove Dickens nacque il 7 febbraio 1812 (morì a Gad’s Hill l’8 giugno 1870). Anche l’Italia rende omaggio allo scrittore: oggi su RadioTre Rai alcune pagine dei suoi libri, lette dall’attore Massimo Lello, accompagneranno tutti i programmi della giornata. E nel pomeriggio gli sarà dedicato uno speciale Fahrenheit
La Gran Bretagna festeggia oggi il bicentenario della nascita di Charles Dickens, uno dei più grandi scrittori della letteratura inglese i cui romanzi sono diventati classici intramontabili. Sono previste celebrazioni in tutto il paese, da Londra a Portsmouth, dove Dickens nacque il 7 febbraio 1812 (morì a Gad’s Hill l’8 giugno 1870). Anche l’Italia rende omaggio allo scrittore: oggi su RadioTre Rai alcune pagine dei suoi libri, lette dall’attore Massimo Lello, accompagneranno tutti i programmi della giornata. E nel pomeriggio gli sarà dedicato uno speciale Fahrenheit
Una strana, triste creatura, che era sempre in movimento ma non era mai certa se alla ricerca di qualcosa o in fuga da esso»; così Robert Douglas Fairhurst descrive l’autore nella sua nuova biografia Becoming Dickens (Diventare Dickens).
Dickens era un giornalista che diventò romanziere. Il circolo Pickwick descrive i luoghi che aveva visitato in qualità di giovane giornalista. Il mondo di Dickens era anche un luogo di cambiamenti, dalla diligenza al vagone ferroviario, dalla vela al vapore. Nel 1843 attraversò l’Atlantico su una nave a vapore diretto verso «La Repubblica della mia immaginazione libera da monarchia, aristocrazia e logore convenzioni, solo per essere deluso da questa Nazione volgare, grossolana e meschina», «guidata da un branco di mascalzoni».
Se c’era una cause célèbre per l’élite liberale inglese di ritorno nel Vecchio Mondo questa era l’Italia. Gli esuli italiani, non ultimo «il divino» Mazzini, erano molti e influenti. Dickens era profondamente coinvolto nelle scuole per gli inglesi poveri e appoggiò fortemente nel 1841 la scuola fondata all’Hatton Garden di Londra da Mazzini per i bambini italiani vittime della tratta, dove ambientò la casa di Fagin in Oliver Twist .
Nella decisione di recarsi in Italia per 2 anni nel 1844-5 c’è un misto dickensiano di giornalismo investigativo sullo «stato della nazione [italiana]», e aspirazioni sociali di un nuovo ricco ora in grado di vivere a Londra in un palazzo piuttosto che in una casa. È la sua prima vacanza dall’età di 12 anni, «prima non ho mai saputo cosa significasse essere pigri». Sarebbe stato così aspro con i suoi ospiti italiani come lo era stato con gli americani? A luglio Genova appariva bella dalla nave, ma da vicino «dev’essere la regina tra tutte le città dimenticate da Dio, ammuffite, tristi, sonnolente, sporche, pigre, malmesse. Sembrava di essere arrivati alla fine di tutto». Tuttavia, proprio come gli esuli italiani nella nebbiosa Londra, ben presto si sistemò, soprattutto dopo aver scambiato il suo «carcere rosa» ad Albaro per Palazzo Peschiere, nel cuore di Genova, aver preso un palco all’opera ed essersi fatto degli amici.
Un breve viaggio a Londra con il suo nuovo libro Le campane inizia con un tour pickwickiano in diligenza di Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Ferrara. «Che strano dormiveglia, mezzo triste e mezzo delizioso, è il passaggio attraverso questi luoghi addormentati che si crogiolano al sole! Ognuno, di volta in volta, appare il luogo del mondo più ammuffito, triste, dimenticato da Dio! » È colpito, però, mentre prosegue, dalle «piacevoli» Verona, Mantova e Milano, fino al Sempione.
Nel gennaio 1845 porta la moglie a Roma «degradata e decaduta, che giace addormentata sotto il sole tra un cumulo di rovine» via Pisa e Siena. «Non c’è niente di più bello al mondo della strada costiera tra Genova e La Spezia». Della Torre di Pisa: «Come la maggior parte delle cose collegate nelle loro prime associazioni con i libri di scuola, è troppo piccola. L’ho sentito profondamente».
È il Dickens giornalista e attivista contro la pena capitale a raccontare, senza commenti, nei minimi dettagli, di un assassino ghigliottinato: nella morte, ha notato, i bianchi bulbi oculari del condannato erano ancora rivolti verso l’alto per evitare di dover guardare nel cesto sporco. A Napoli nelle prime fasi di un’eruzione sul Vesuvio Dickens e la sua famiglia arrivano quasi al «vedi Napoli e poi muori» perché l’intrepido, se pur gotico, giornalista insiste a voler guardare oltre il bordo del cratere. Torna con gli abiti in fiamme, ma due delle sue guide scompaiono per sempre nella discesa sul ghiaccio. Dickens lasciò l’Italia attraverso il San Gottardo via Firenze. «Qui sopravvive la parte imperitura della mente umana... quando la tirannia dei molti, o dei pochi, o di entrambi, non è che un racconto, quando Orgoglio e Potere sono caduti insieme nella polvere».
«Lasciate che ci congediamo dall’ Italia, con tutte le sue miserie e le ingiustizie, affettuosamente, con la nostra ammirazione per le bellezze, naturali e artificiali, di cui è piena fino a traboccare, e con la nostra tenerezza verso un popolo, naturalmente ben disposto, paziente e di temperamento mite. Anni di abbandono, oppressione e malgoverno hanno operato per cambiare la sua natura e fiaccare il suo spirito; gelosie miserabili... sono state il cancro alla radice della nazionalità... ma il bene che era in esso c’è ancora, e un popolo nobile può, un giorno, risorgere dalle ceneri. Coltiviamo la speranza», conclude Dickens in Impressioni d’Italia .
- Festa a Portsmouth e omaggio su Radio3
-
> NEL BUIO ... Oxford vende il suo blasone ad un’industria mobiliera cinese. La protesta dei professori che l’hanno definita una forma di “prostituzione intellettuale” che svilisce la tradizione dell’università.20 settembre 2011, di Federico La Sala
IL CASO
 Oxford vende il suo blasone
Oxford vende il suo blasone
 ad un’industria mobiliera cinese
ad un’industria mobiliera cineseIl marchio della prestigiosa università inglese potrà essere utilizzato dall’azienda di Pechino sulle riproduzioni dei mobili presenti nell’ateneo, come la sala da pranzo vista nel film di Harry Potter o la libreria che porta il nome della celebre biblioteca. -La protesta dei professori: "Una cosa maledettamente volgare"
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
LONDRA - Avete sempre sognato di mangiare in una sala da pranzo simile a quella del refettorio di Harry Potter? Ora potrete farlo, anche se vi costerà 2650 sterline, quasi 3 mila euro. Le scene dei film sul maghetto ambientate nella mensa di Hogwart, infatti, sono state girate all’interno di una magnifica sala di Christ Church, uno dei collegi più prestigiosi dell’università di Oxford, che ora ha venduto a un mobilificio cinese il diritto di applicare il proprio marchio ufficiale a una nuova linea di mobili. La sala da pranzo stile Harry Potter non è l’unica che avrà il blasone di Oxford: si potrà anche acquistare una libreria (da 3800 sterline) che porta il nome della celebre Bodleian Library, la biblioteca di Oxford, la più grande e più ricca biblioteca universitaria d’Europa; oppure una scrivania di marocchino rosso intitolata a john Radcliffe, che fu il medico personale di re Guglielmo II e anche lui un frequentatore dell’illustre ateneo. E poi ancora divani, poltrone, accessori di lusso, tutti “made in China” e tutti ornati dal simbolo della più antica università d’Europa.
A detta di varie classifiche e statistiche, Oxford è ancora la migliore d’Europa e una delle migliori del mondo, in competizione con la vicina Cambridge e l’americana Harvard. Ma nonostante l’aumento delle rette universitarie, portate da 3 mila a 9 mila sterline l’anno (circa 11 mila euro), i finanziamenti statali e le massicce donazioni che riceve da benefattori che sono spesso ex-alunni, anche Oxford si sente a corto di soldi, un po’ per la crisi economica, un po’ per la difficoltà di rimanere appunto una università di elite in termini di ricerca, docenti e apparecchiature. Così i suoi amministratori devono avere pensato che tutte le strade sono buone per guadagnare qualche sterlina extra, compresa l’idea di cedere il diritto a fregiarsi di Oxford, un brand pressochè imbattibile, a chiunque fosse interessato. Si sono fatti avanti i mobilieri cinesi, e sono stati accolti a braccia aperte. Pare che venderanno la “collezione Oxford” nei negozi più di lusso, a partire dai grandi magazzini Harrod’s di Londra.
L’iniziativa non è piaciuta ai professori di Oxford, che l’hanno definita una forma di “prostituzione intellettuale” che svilisce la tradizione dell’università. “E’ una cosa maledettamente volgare”, protesta Peter Oppenheimer, docente emerito al Christ Church. “Non ho parole. Nessuno nella nostra comunità universitaria li ha autorizzati a un’operazione di questo genere”. C’è da dire che Oxford non è la prima a vendersi il marchio per ragioni commerciali. Qualche anno fa anche l’università di Harvard ha fatto lo stessa cosa, cedendo il proprio nome a un’azienda di abbigliamento maschile che lo ha utilizzato per una linea di vestiti per giovani bene: pantaloni kaki e completi a righine, golf da cricket e bermuda, tutti battezzati con lo stemma dell’ateneo numero uno d’America.
* la Repubblica, 19 settembre 2011
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO. "NATALE" A OXFORD NON SI DICE PIU’ "CHRISTMAS"? ---- Dal Natale di Charles Dickens alle ideologie utopistiche. La vera gioia non si può immaginare né programmare (di George Orwell)16 dicembre 2008, di Federico La Sala
 George Orwell si confronta con le opere di Wells, Morris e Swift
George Orwell si confronta con le opere di Wells, Morris e Swift Dal Natale di Charles Dickens alle ideologie utopistiche
Dal Natale di Charles Dickens alle ideologie utopistiche
 La vera gioia non si può immaginare né programmare
La vera gioia non si può immaginare né programmare Può un socialista essere felice?
Può un socialista essere felice?
 La vanità di qualsiasi modello fondato sulla ricerca della perfezione
La vanità di qualsiasi modello fondato sulla ricerca della perfezionedi George Orwell (Corriere della Sera, 16.12.2008)
Il Natale ci fa pensare quasi automaticamente a Charles Dickens, e per due buone ragioni. La prima è che Dickens è uno dei pochi scrittori inglesi ad aver scritto sul Natale, che è la festa più amata dagli inglesi, ma ha ispirato poche opere letterarie. Ci sono i canti, i Christmas Carols, quasi tutti di origini medievali; c’è una manciata di poesie di Robert Bridges, T.S. Eliot e qualche altro, c’è Dickens; e poco di più. La seconda ragione è che tra gli scrittori moderni Dickens è uno dei pochi, quasi l’unico, a offrire un’immagine convincente della felicità.
Dickens ha parlato del Natale due volte, in un capitolo del Circolo Pickwick e nel Canto di Natale. Quest’ultimo racconto venne letto a Lenin morente che, secondo la moglie, ne trovò del tutto intollerabile «il sentimentalismo borghese». In un certo senso aveva ragione, ma se fosse stato in condizioni di salute migliori si sarebbe forse accorto che quel racconto ha dei risvolti sociologici interessanti. Anzitutto, per quanto Dickens calchi la mano e il «sentimentalismo» di Tiny Tim possa sembrare sgradevole, la famiglia Cratchit pare proprio divertirsi. Ha l’aria felice, a differenza, per esempio, dei cittadini di Notizie da nessun luogo di William Morris. Inoltre, la loro felicità deriva soprattutto dal contrasto, e il fatto che Dickens se ne renda conto è uno dei segreti della sua forza. Sono contenti perché una volta tanto hanno cibo in abbondanza. Il lupo è alla porta, ma sta scodinzolando. Il vapore del pudding natalizio aleggia su uno scenario fatto di banchi di pegni e di duro lavoro e accanto alla tavola imbandita il fantasma di Scrooge è sempre presente. Bob Cratchit vuole perfino brindare alla salute di Scrooge, cosa che la signora Cratchit, giustamente, rifiuta di fare. I Cratchit riescono a godersi il Natale proprio perché viene solo una volta all’anno. La loro felicità è convincente proprio per questo. La loro felicità è convincente perché è descritta come provvisoria.
Tutti i tentativi di descrivere una condizione di felicità permanente, d’altro canto, si sono risolti in un fallimento. Le Utopie (a proposito, la parola Utopia non significa «bel luogo», ma «luogo inesistente ») sono comparse spesso nella letteratura degli ultimi tre o quattrocento anni, ma quelle «positive» sono immancabilmente poco attraenti, e di solito anche prive di vitalità.
Le Utopie moderne di gran lunga più note sono quelle di H.G. Wells. La visione del futuro prefigurata da Wells è enunciata appieno in due libri scritti all’inizio degli anni Venti, The Dream e Men Like Gods. Vi si trova un’immagine del mondo che a Wells sarebbe piaciuto, o che pensava gli sarebbe piaciuto. È un mondo in cui le note dominanti sono l’edonismo illuminato e la curiosità scientifica. Tutti i mali e le miserie di cui soffriamo sono scomparsi. L’ignoranza, la guerra, la povertà, la sporcizia, la malattia, la frustrazione, la fame, la paura, la fatica opprimente, la superstizione non ci sono più. Così descritto, non potremmo negare che sia il genere di mondo a cui tutti aspiriamo. Tutti noi vogliamo abolire quel che Wells vuole abolire. Ma c’è qualcuno che voglia veramente vivere in un’Utopia wellsiana? È semmai il contrario: non dover vivere in un mondo come quello è ormai diventata una questione politica ben presente. Un libro come Il mondo nuovo è espressione della paura che l’uomo moderno nutre nei confronti della società edonistica razionalizzata che ha il potere di creare. Uno scrittore cattolico ha affermato recentemente che le Utopie sono oggi tecnicamente possibili, e che ora il vero problema è come evitarle. Non possiamo limitarci a ritenere ridicola quest’osservazione e a ignorarla, perché una delle molle del movimento fascista è proprio il desiderio di evitare un mondo troppo razionale e comodo.
Tutte le Utopie «positive» sembrano simili nell’ipotizzare la perfezione ed essere incapaci di dare un’idea della felicità. Notizie da nessun luogo è una specie di versione edulcorata dell’Utopia wellsiana. Tutti sono gentili e ragionevoli, la tappezzeria viene tutta da Liberty, il miglior negozio, ma si avverte una vaga malinconia. Colpisce, però, che neanche Jonathan Swift, uno degli scrittori più ricchi d’immaginazione, riesca meglio degli altri a costruire un’Utopia «positiva».
La prima parte dei Viaggi di Gulliver è probabilmente la critica più feroce alla società umana che sia mai stata scritta. Ogni parola di quel libro è ancora attuale; a tratti vi si trovano prefigurazioni dettagliate degli orrori politici del nostro tempo. Swift fallisce, però, quando cerca di presentarci una razza di individui che suscitano la sua ammirazione. Nell’ultima parte, in antitesi agli sgradevoli Yahoo, vengono mostrati i nobili Houyhnhnms, cavalli intelligenti e privi delle debolezze umane. Questi cavalli, nonostante il loro spirito elevato e l’infallibile buon senso, sono creature piuttosto noiose. Come gli abitanti di tante altre Utopie, si preoccupano soprattutto di evitare i problemi.
Conducono vite monotone, controllate, «ragionevoli», libere non solo dai litigi, dal disordine o da incertezze di ogni genere, ma anche dalla «passione», compreso l’amore fisico. Scelgono i compagni seguendo principi eugenetici, evitano gli eccessi dei sentimenti, e sembrano quasi contenti di morire quando giunge la loro ora. All’inizio del libro Swift mostra dove la follia e la ribalderia portano l’uomo: ma se si eliminano la follia e la ribalderia, ciò che rimane sembra essere un’esistenza tiepida, che non ha molto senso vivere. I tentativi di descrivere l’approdo a una felicità ultraterrena non hanno avuto maggiore successo. Come Utopia il Paradiso è un fiasco, mentre l’Inferno occupa una posizione ragguardevole in letteratura, ed è stato spesso descritto in modo dettagliato e convincente.
Sappiamo bene che il Paradiso cristiano, come è di solito rappresentato, non attrarrebbe nessuno. (...) Molti pastori evangelici, molti preti gesuiti (anche nel terribile sermone in Ritratto dell’artista da giovane di James Joyce) hanno spaventato a morte i fedeli con le loro rappresentazioni dell’Inferno. Ma quando si passa al Paradiso, si torna invariabilmente a valersi di parole come «estasi» e «beatitudine», senza fare molto per cercare di spiegare in che cosa consistano. Forse il passo più vitale su questo argomento è quello, famoso, di Tertulliano, in cui si dice che una delle maggiori gioie del Paradiso è guardare le torture dei dannati. Le versioni pagane del Paradiso sono forse un po’ migliori. Si ha la sensazione che nei campi elisi ci sia sempre il tramonto. L’Olimpo, dove vivevano gli dei, con il nettare e l’ambrosia, le ninfe ed Ebe, «puttane immortali» come le ha chiamate D.H. Lawrence, potrà essere un po’ più interessante del Paradiso cristiano, ma non fa venir voglia di passarci molto tempo. Il Paradiso musulmano, con le sue 77 urì (vergini) per ogni uomo, tutte presumibilmente desiderose di attenzioni allo stesso momento, è un vero e proprio incubo. Nemmeno gli spiritualisti, che ci assicurano di continuo che «tutto è luminoso e bello», riescono a descrivere una qualche attività dell’altro mondo che una persona avveduta possa trovare, se non attraente, almeno sopportabile.
Nello stesso modo si risolvono i tentativi di descrivere la perfetta felicità che non siano né utopistici né ultraterreni, ma semplicemente sensuali. Danno sempre l’impressione di essere vuoti o volgari, o entrambe le cose. All’inizio di La pulzella d’Orléans, Voltaire descrive la vita di Carlo IX con la sua amante Agnes Sorel. Erano «sempre felici », dice. E in cosa consisteva la loro felicità? Un susseguirsi incessante di feste, libagioni, partite di caccia e amplessi. Chi, dopo qualche settimana, non si stancherebbe di un’esistenza simile? Rabelais parla delle anime fortunate che si divertono nell’aldilà, come consolazione per essersela passata male in questo mondo. Cantano una canzone che si potrebbe grossolanamente tradurre così: «Saltare, danzare, far scherzi, bere vino bianco e rosso, e non far niente tutto il giorno se non contare monete d’oro». Che noia, in fin dei conti! L’idea vana del divertimento senza fine è ben raffigurata nel quadro di Brueghel Il paese di cuccagna, dove tre grassoni giacciono addormentati uno accanto all’altro, tra uova sode e cosce di pollo pronte a farsi mangiare.
Sembra che gli esseri umani non sappiano descrivere, né forse immaginare, la felicità se non in termini di contrasto con una opposta condizione. Per questo da un’epoca all’altra il concetto di Paradiso o quello di Utopia cambiano. Nella società preindustriale il Paradiso era descritto come un luogo di infinito riposo, e lastricato d’oro, perché l’essere umano medio conosceva solo la fatica del lavoro e la povertà. Le urì del Paradiso musulmano riflettevano una società poligama dove la maggior parte delle donne scomparivano negli harem dei ricchi. Ma queste immagini di «eterna beatitudine» sono sempre poco attraenti perché quando la beatitudine diventa eterna (eternità intesa come tempo infinito), il termine di paragone scompare. Alcuni motivi convenzionali radicati nella nostra letteratura sono nati da condizioni fisiche che ora hanno cessato di esistere. Ne è un esempio il culto della primavera. Nel Medioevo la primavera non significava rondini e fiori di campo. Significava verdura, latte e carne fresca dopo parecchi mesi di maiale salato consumato in capanne fumose e prive di finestre. I canti della primavera erano allegri, «Se la carne poco costa, e le femmine son care, e i bulletti vanno apposta tutt’intorno a gironzare, non ci resta che mangiare, stare allegri e ringraziare il buon Dio che ci largì l’allegria di questo dì» (Shakespeare, Enrico IV), perché c’erano buone ragioni per rallegrarsi. L’inverno era finito, questo era il fatto principale. Lo stesso Natale, una festa pre-cristiana, è probabilmente nato perché, di tanto in tanto, mangiate e bevute fuori del comune aiutavano a interrompere l’insopportabile inverno nordico.
L’incapacità del genere umano di immaginare la felicità in forme diverse dalla liberazione dalla fatica o dal dolore pone ai socialisti un grave problema. Dickens sa descrivere una famiglia stretta dalla povertà che si butta su un’anatra arrosto, e farla apparire felice; allo stesso tempo, gli abitanti di universi perfetti non mostrano nessuna allegria spontanea e sono di solito assai poco attraenti. Ma ovviamente noi non vogliamo il mondo descritto da Dickens, né, probabilmente, nessuno dei mondi che avrebbe potuto immaginare. L’obiettivo dei socialisti non è una società dove alla fine tutto si risolve perché vecchi signori gentili regalano tacchini. Il nostro obiettivo non è forse una società in cui la «carità» non sia necessaria? Vogliamo un mondo in cui Scrooge, con i suoi dividendi, e Tiny Tim, con la sua gamba storpia, siano entrambi impensabili. Significa che aspiriamo a un’Utopia senza dolore? A rischio di dire una cosa che i redattori del Tribune potrebbero non approvare, affermo che il vero scopo del socialismo non è la felicità. La felicità finora è stata una conseguenza occasionale e, per quel che ne sappiamo, potrebbe rimanere tale. Il vero scopo del socialismo è la fratellanza umana. Spesso lo si pensa, ma di solito non lo si dice, o non lo si dice a voce abbastanza alta. Gli uomini passano la vita in strazianti lotte politiche, si uccidono in guerre civili, o vengono torturati nelle prigioni della Gestapo, non per costruire un qualche Paradiso con riscaldamento centralizzato, aria condizionata e illuminazione al neon, ma perché vogliono un mondo in cui gli esseri umani si amino, anziché derubarsi e uccidersi a vicenda. Questo è per loro un primo passo. Quale direzione poi prenderanno non è dato sapere, e il tentativo di prevederlo accuratamente non fa che confondere le cose.
Il pensiero socialista deve immaginare un futuro, ma solo in senso lato. Spesso bisogna tendere a obiettivi che si vedono solo in modo indistinto. In questo momento, ad esempio, il mondo è in guerra e vuole la pace. Il mondo, però, non ha esperienza di pace, non ne ha mai avuta, a meno che non sia esistito il Buon Selvaggio. Il mondo vuole qualcosa della cui esistenza è solo vagamente consapevole, che non riesce a definire con precisione. Questo Natale migliaia di uomini verseranno il loro sangue sulla neve russa, o annegheranno in acque gelate, o si faranno a pezzi nelle isole paludose del Pacifico; bambini senza casa andranno in cerca di cibo tra le rovine delle città tedesche. Far sì che questo non accada più è giusto. Ma dire con precisione come sarà un mondo in pace è tutt’altra cosa.
Quasi tutti i creatori di Utopie facevano pensare a un uomo con il mal di denti, per il quale la felicità consiste quindi nel non avere mal di denti. Volevano costruire una società perfetta prolungando all’infinito una condizione apprezzabile solo perché temporanea. Sarebbe meglio dire che ci sono delle linee lungo le quali l’umanità deve muoversi, che il disegno strategico è tracciato, ma che fare previsioni dettagliate non è affar nostro. Chiunque cerchi di immaginare la perfezione ne mette in luce solo la vacuità. È successo anche a un grande scrittore come Swift, che sa mettere perfettamente alla berlina un vescovo o un uomo politico: quando cerca però di creare un superuomo, ci dà l’impressione, opposta alle sue intenzioni, che i maleodoranti Yahoo avessero più possibilità di evolversi degli illuminati Houyhnhnms. (Traduzione di Maria Sepa)
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO ---- Rissa tra monaci a Gerusalemme (Video).11 novembre 2008, di Maria Paola Falqui
VIDEO - Rissa tra monaci a Gerusalemme
Fonte Reuters
Una violenta rissa tra monaci armeni e greci ortodossi è scoppiata nella Basilica del Santo Sepolcro, uno dei siti più sacri del cristianesimo. Si tratta dell’ultimo di una serie di scontri tra monaci delle sei diverse confessioni che si contendono il controllo del sito dove secondo la tradizione si trova la tomba di Gesù. - PER VEDERE IL FILMATO, CLICCARE SUL ROSSO.
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO..... "RELIGULOUS".... «il più irriverente, divertente documento sulla fede», «foriero di interrogativi profondi».11 novembre 2008, di Maria Paola Falqui
 «Religulous» si scaglia contro i predicatori e le celebrità che ostentano la fede
«Religulous» si scaglia contro i predicatori e le celebrità che ostentano la fede Attacco laico
Attacco laico Le religioni in un documentario «comico»
Le religioni in un documentario «comico»
 Cristiani, ebrei e musulmani nel mirino
Cristiani, ebrei e musulmani nel mirinodi Giovanna Grassi *
LOS ANGELES - «La religione è una sovrastruttura dell’uomo e del potere. È sempre foriera di traumi, inibizioni, gerarchie. Non solo è pericolosa, ma nasconde anche una ricattatoria fandonia: quella di far diventare gli esseri umani buoni». Questo è l’assioma che sostiene Bill Maher nel documentario che ha scritto e prodotto, Religulous, e di cui ha affidato la regia a Larry Charles (Borat) - il miglior amico di Michael Moore - che, ironia della sorte, con la sua gran barba e sempre vestito di nero sembra proprio un predicatore.
Maher è il «comedian/reporter » più politicamente scorretto d’America: nato a New York nel 1956, è figlio di un noto giornalista della Nbc di adamantina fede cattolica e di una signora di religione ebraica. È stato radiato dalla ABC, con il suo popolare show di interviste e dibattiti (intitolato Politically Incorrect), dopo aver innescato uno scandalo nazionale per aver detto che i terroristi dell’attacco alle Due Torri non erano «vili né codardi ».
Religulous non sarà sicuramente in corsa per gli Oscar, ma resta nella top ten degli incassi Usa a diverse settimane dal debutto; in Italia uscirà il 5 dicembre, dopo essere passato al morettiano Festival di Torino. Il New York Times lo ha definito «il più irriverente, divertente documento sulla fede», ma è anche molto angoscioso e «foriero di interrogativi profondi», ha ribattuto il Los Angeles Times.
Il film è imperniato su una carrellata di predicatori, sette, religioni ufficiali, ortodosse e non dell’ America. Racconta Bill: «Da sempre volevo girare un documentario sulla fede essendo io stato segnato da una crescita divisa tra due religioni. Ho girato il mondo e volevo, non è un paradosso, che il nostro lavoro fosse anche divertente e che, nell’analizzare il potere spesso corrotto che si nasconde dietro tanti culti, instaurasse un dibattito tra intelligenza e stupidità con i suoi discutibili idoli, spesso simili a rock star nella loro leva sulle folle. Ho intervistato centinaia di persone, scienziati, letterati, intellettuali, vescovi, ciarlatani... Ho utilizzato migliaia di spezzoni, compresi quelli di Bush quando afferma, per i suoi tornaconti e crimini di guerra «Dio e Gesù Cristo sono esistiti per dare libertà agli uomini». E anche McCain, che di religione non parla, ma dichiara di credere al diavolo. Tom Cruise seguace di Scientology ha rifiutato l’incontro, ma appare in alcune sue dichiarazioni, come John Travolta, adepto della fede di L. Ron Hubbard».
Che cosa ha divertito e preoccupato di più l’indomito Bill, che da bambino litigava con la madre ebrea e con il padre cattolico, decisi entrambi a imporgli la loro fede (ma per rispetto e amore ha dedicato il film a mamma Julie, defunta)? «Sicuramente - risponde - gli incontri con i predicatori americani, che hanno migliaia e migliaia di fedeli ». Ed ecco gli esempi che più l’hanno colpito: «Due soprattutto rappresentano l’assurdità del bisogno di fede. Il miliardario predicatore Josè Luis de Jesus Mirada che, coperto di oro e con abiti di sartoria ("Perché Cristo è stato e resta una icona fashion") proclama di essere il nuovo Gesù a folle adoranti; l’ex leader gay oggi sposato John Wescott, che ha creato il suo business di fede per convertire tutti i gay alla cristianità e che nega che Gesù abbia mai parlato della materia. E, poi, gli islamici integralisti da me intervistati, i cittadini dell’ America profonda che dichiarano di aver parlato con il loro angelo custode, gli scienziati, gli analisti della religione autori di best seller, il capo della Cannaba Religion, Ferre van Beveren".
Ce n’è per tutti e genitori e figli fanno la fila per vedere e contestare il documentario con striscioni «God helps us» (Dio ci aiuta) o poster irridenti. Dice Maher: «Mi interessa molto la reazione della platea italiana, cattolica e no. Perché avevo solo un obiettivo nel realizzare il nostro lavoro. Far confrontare i popoli con la fede, quindi con la politica, il potere e la propria coscienza ». Scusi, una o due regole di fede per lei?: «Stimolare controversie, essere frugale e sempre ragionare con i fatti».
* Corriere della Sera, 11.11.2008
-
> NEL BUIO E NEL GELO DELL’INVERNO. ----- Gli Stati Uniti oggi hanno dato una lezione importante anche alla Vecchia Europa... In quale Paese europeo oggi sarebbe possibile immaginare un presidente di colore figlio di un immigrato?.5 novembre 2008, di Federico La Sala
America avvera sogno di Martin Luther King
(di Stefano Polli) *
ROMA - Il sogno di Martin Luther King è diventato realtà: i cittadini americani hanno deciso che Barack Hussein Obama sarà il primo presidente nero degli Stati Uniti, il primo uomo di colore ad insediarsi alla Casa Bianca. E’ un segnale indiscutibile di coraggio, di capacità di cambiare. E’ un segnale che conferma che l’America sa sempre trovare dentro di sé - soprattutto quando tutto sembra andare per il verso sbagliato - la forza, la determinazione e le motivazioni per scegliere strade nuove, per avviarsi in sentieri inesplorati alla ricerca ancora di un’ altra "nuova frontiera".
Obama è figlio di un immigrato keniano e di una donna bianca del Kansas. Ha vissuto la sua infanzia tra le Hawaii, dove è nato, e l’Indonesia, ha combattuto per poter crescere in un’America che non gli mai ha regalato niente, ma che gli ha anche dato le possibilità di meritarsi una scalata sociale - dalla Columbia University alla Harvard Law School - che sarebbe molto difficile in qualunque Paese europeo. Il nuovo presidente Usa ha saputo incarnare l’anima profonda degli americani, quella che sa vivere di sogni e traguardi apparentemente irraggiungibili, di cambiamento e di nuove sfide. In lui, gli americani che oggi guardano con paura a un futuro dai contorni indefinibili e carico di presagi negativi, hanno visto un uomo capace di dare nuove speranze e, forse, di indicare una strada diversa da quella difficile e tortuosa che sono costretti a percorrere da qualche tempo.
I paragoni, per ora sicuramente prematuri, fatti con John Fitzgerald Kennedy si giustificano, in parte, più dal lato emotivo che da quello concreto dei programmi e dei fatti, anche se Obama ha già indicato alcuni cambiamenti strutturali davvero significativi. Ma il punto fondamentale è che Obama ha saputo parlare al cuore dei suoi concittadini, dando loro la sensazione e, forse, la convinzione che un cambiamento non solo è necessario, ma anche possibile.
Gli Stati Uniti oggi hanno dato una lezione importante anche alla Vecchia Europa. Nei momenti difficili gli americani sanno ritrovarsi come hanno fatto oggi nelle lunghe file, in tutti gli angoli del Paese, davanti ai seggi elettorali. Sanno decidere con coraggio senza guardarsi indietro, sanno scegliere senza paura di sbagliare, sanno osare e voltare pagina. In quale Paese europeo oggi sarebbe possibile immaginare un presidente di colore figlio di un immigrato?