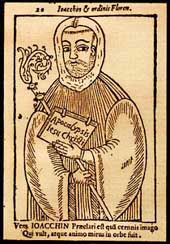
MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. Per i ‘Settanta’ di VATTIMO: 1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA A SILVANA MANSIO (CS) - di Federico La Sala
domenica 8 luglio 2007.A gloria e difesa della nostra Costituzione: Viva l’Italia!!!
SECONDO L’ORDINE DI MELCHISEDECH
In memoria di don Lorenzo Milani e in omaggio a Carlo A. Ciampi
di Federico La Sala
Caro Direttore,
Nella risposta data (nella sua rubrica) da frà Calvino alla mia lettera (cfr. Etsi deus non daretur..., ildialogo, 06 maggio 2006), c’è un ‘passaggio’ su cui - a mio parere - è assolutamente necessario ritornare e chiarirlo, subito e decisamente: “Tu, sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedech!”*. E’ un’amnesia, un lapsus, o che?!
Solo una indicazione rapida: non ci si ricorda più di che cosa e di quanto importante è successo con la Riforma protestante?. Capisco, capisco, ma - me lo permetta - Spinoza, Lessing**, Rousseau, Kant, Feuerbach, Marx, e Max Weber ... avevano capito che c’era un nesso tra religione e capitalismo e cercarono di trovare proprio la parola nascosta: Melchisedech - re di Giustizia e di Pace! Il richiamo di Paolo, a questa Figura, è decisivo - ma è una mezza verità!!! E Lutero (e Calvino!!!) aveva capito tutta l’importanza di questa questa mezza verità: sacerdozio universale!!! L’altra mezza verità ... nell’ordine del messaggio eu-angelico: regalità universale!!! Tocca a noi, tutti e tutte, riprenderla: Tu, sei re in eterno secondo l’ordine di Melchisedech .... e di Giuseppe e Maria e Gesù!!!
Cosa ha detto e ripetuto, qual è stata l’indicazione e il messaggio di don Lorenzo Milani!? Non è stata quella di avere il coraggio di dire ai nostri e alle nostre giovani che sono tutti e tutte re e regine ... sacerdoti e sacerdotesse?! E questo non è nell’ordine di Melchisedech ... di Gesù, e dell’Amore dei nostri Padri e delle nostre Madri?! E della Costituzione della Repubblica Italia, della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri? O no?!
E, allora - me lo permetta! Basta con la deligittimazione continua e costante che la gerarchia vaticana porta alla nostra società e alle nostre Istituzioni - a cominciare dalla Scuola Pubblica ... con il suo falso e terribile revisionismo (cfr. F. Colombo, Il papa revisionista, L’Unità, 29.05. 2006***) culturale, politico, storico, e teologico!!! La sua dottrina - come è già stato detto - è incompatibile con la nostra e ogni repubblica democratica e , in particolare, con la Costituzione dei nostri Padri e delle nostre Madri!!!
VIVA LA COSTITUZIONE ....E VIVA WOJTYLA!!! W O JTYLA = W. O. ITALY !!! VIVA L’ITALIA! (29.05.2006).
Molti cordiali saluti,
Federico La Sala
(www.ildialogo.org/filosofia,30.05.2006)
* DOC. 1
SAN MELCHISEDECH RE DI SALEM E SACERDOTE
26 agosto
II millennio a.C.
“Melchisedech, re di Salem e sacerdote del Dio altissimo” è citato due volte nell’Antico Testamento. Incontrò Abramo, gli offrì pane e vino e lo benedisse. Abramo in cambio gli consegnò la decima del bottino recentemente conquistato (Gn 14,18-20). Quando Gerusalemme diventò capitale del Regno di Israele, il re Davide venne proclamato “sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedech” (Sal 110,4). Tale allusione ad un altro sacerdozio, differente da quello levita, venne utilizzata nella Lettera agli Ebrei: Cristo è sacerdote non per discendenza carnale, ma “alla maniera di Melchisedech” (Eb 6,20). La tradizione cristiana vide in Melchisedech una profezia di Cristo e nell’offerta del pane e del vino la profezia dell’Eucaristia.
Etimologia: Melchisedech = il Re, cioè Dio, è giustizia
Emblema: Pane e vino
“Melchisedech, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abramo con queste parole: Sia benedetto Abramo dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici”. Così il libro della Genesi (14,18-20) cita questo misterioso personaggio, vissuto verso il secondo millennio avanti Cristo, re cananeo di Salem, nome arcaico della futura città di Gerusalemme e capitale del re Davide, ed al tempo stesso sacerdote della divinità locale el-\’eljòn, cioè “Dio altissimo”.
I segni del pane e del vino, che Melchisedech presentò al patriarca biblico Abramo, per il cristiano divennero segno di un più alto mistero, quello dell’Eucaristia. Proprio in tale nuova luce l’episodio di Melchisedech acquista un nuovo significato rispetto a quello originario. Per l’autore della Genesi infatti l’offerta di pane e vino ad Abramo ed alle sue truppe affamate, di passaggio nel territorio del re di Salem tornando da una spedizione militare contro i quattro sovrani orientali per liberare il nipote Lot, è intesa quale segno di ospitalità, di sicurezza e di permesso di transito. Il territorio di Salem e quindi Gerusalemme saranno infatti strappati come è assai noto ai Gebusei solo secoli dopo dal re Davide. Abramo accettò il benevolo gesto di Melkisedech e ricambiò con la decima del bottino di guerra, così da attuare un sorta di patto bilaterale.
La seconda citazione antico testamentaria è data dal Salmo 110,4, nel quale a proposito del re davidico si dice: “Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melkisedech”, forse per assicurare anche al sovrano di Gerusalemine una qualità sacerdotale, differente dal sacerdozio levitino, in quanto Davide ed i suoi successori appartennero alla tribù di Giuda anziché a quella sacerdotale di Levi.
Sin qui il cuore storico del racconto, per altro non esente da interrogativi e da questioni esegetiche che dilungherebbero però eccessivamente la presente trattazione. E’ invece interessante evidenziare la simbologia che il re di Salem ha acquisito dalla successiva tradizione cristiana. Nel Nuovo Testamento la Lettera agli Ebrei (cap. 7) iniziò infatti ad intravedere in Melchisedech il profilo Gesù Cristo, sacerdote perfetto. Infatti l’autore neotestamentario di tale libro, volendo presentare Cristo come sacerdote in modo unico e nuovo rispetto all’antico sacerdozio ebraico, decise di ricorrere proprio all’antica figura di Melkisedech. Questo nome significa infatti “il Re, cioè Dio, è giustizia”, mentre “re di Salem” vuol dire “re di pace”. Si coniugano così nel re-sacerdote i due doni messianici per eccellenza: la giustizia e la pace.
Rimarcando poi il fatto che Abramo si sia lasciato benedire da lui, riconoscendone perciò la supremazia, afferma implicitamente la superiorità del sacerdozio di Melkisedech rispetto a quello di Levi discentente di Abramo. Non resta dunque così che concludere che Cristo, discendente davidico, è “sacerdote in eterno alla maniera di Melkisedech”, proprio come predetto dal Salmo 110. È dunque in questa luce che la tradizione cristiana non esitò a riconoscere nel pane e nel vino offerti dal re di Salem ad Abramo una profezia dell’Eucaristia.
Il celebre padre Turoldo, religioso e poeta del XX secolo, cantò infatti: “Nessuno ha mai saputo di lui, donde venisse, chi fosse suo padre; questo soltanto sappiamo: che era il sacerdote del Dio altissimo. Era figura di un altro, l’atteso, il solo re che ci liberi e ci salvi: un re che preghi per l’uomo e lo ami, ma che vada a morire per gli altri; uno che si offra nel pane e nel vino al Dio altissimo in segno di grazie: il pane e il vino di uomini liberi, dietro Abramo da sempre in cammino”.
In quest’ottica Melchisedech entrò a far parte anche del patrimonio liturgico latino, tanto da meritarsi una citazione nel cosiddetto Canone Romano, cioè dopo il Concilio Vaticano II la Preghiera Eucaristica I: “Tu che hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l’oblazione pura e santa di Melchisedech, tuo sommo sacerdote, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno”. Ciò comporto una certa influenza anche nell’ambito iconografico ed in tale direzione sono da segnalare i mosaici della basilica romana di Santa Maria Maggiore, risalenti al V secolo, in cui la scena di Melchisedech è stata collocata nei pressi dell’altare al fine di meglio sottolineare il legame intrinseco con l’Eucaristia.
Inoltre sulla parete interna della facciata della cattedrale di Reims, XIII secolo, è raffigurato l’incontro tra Abramo e il re sacerdote proprio come se si trattasse della comunione eucaristica. Infine si cita Rubens che nel ‘600 inserì la scena biblica in un arazzo intitolato “Il trionfo dell’Eucaristia”. Il pane e il vino sono infatti ormai definitivamente intesi come quelli deposti sulla tavola dell’ultima cena da Gesù e la spiegazione del loro valore è costituita dalle parole che Cristo stesso pronunziò nella sinagoga di Cafarnao: “Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. [...] Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me i o in lui” (Gv 6,51.56).
Venerato come santo, Mechisedech viene ricordato l’8 settembre nel calendario della Chiesa Etiopica, mentre il nuovo Martyrologium Romanum ha inserito in data 26 agosto la “Commemorazione di San Mechisedech, re di Salem e sacerdote del Dio altissimo, il quale benedicendo salutò Abramo che ritornava vittorioso dalla guerra. Offrì a Dio un santo sacrificio, una vittima immacolata. Viene visto come figura di Cristo re di giustizia, di pace e eterno sacerdote, senza genealogia”.
(Autore: Fabio Arduino, www.santiebeati.it)
** DOC. 2.a
A lezione di dialogo da Lessing
Karl-Josef Kuschel rilegge il «Nathan» e sottolinea che tra i tre monoteismi ci può essere un solo conflitto: la volontà di eccellere nell’amore
di Massimo Giuliani (Avvenire, 06.06.2006, p. 29)
Nella disputa contemporanea tra gli accusatori postmoderni dell’Illuminismo e i difensori della «ragion pubblica», tipica dell’età dei Lumi, l’opera teatrale di Gotthold Ephraim Lessing, Nathan il saggio (1779), rischia di essere rimossa dai primi come mero manifesto di un generico ecumenismo tra le religioni e dai secondi acriticamente esaltata come vessillo ideologico non solo del pluralismo ma anche del relativismo religioso.
Una lettura più teologica e attenta al contesto come L’ebreo, il cristiano e il musulmano si incontrano? di Karl-Josef Kuschel offre una prospettiva nuova. Si tratta infatti, secondo Kuschel, del primo tentativo fatto in Occidente di ragionare sugli effetti negativi degli scontri di civiltà di epoca medioevale e moderna, onde superarli non in chiave di mera tolleranza della religione, come amerebbe vedere una superficiale lettura filo-illuminista, ma piuttosto di reciproco riconoscimento teologico delle tre religioni storico-rivelate.
Il volume è originale per le puntuali ricostruzioni storico-letterarie e comparative sulle fonti e le tradizioni parallele e analoghe del famoso apologo dei tre anelli; ma il suo valore riposa soprattutto sullo spessore delle tesi religioso-teologiche, radicalmente innovative per il XVIII secolo. Il Nathan di Lessing non propone infatti di superare giudaismo, cristianesimo e islam in una generica religione naturale, ma di «mettere in evidenza la parte del veramente umano presente in tutte le religioni». Ciò è possibile proprio quando dalla semplice tolleranza si passa alla rivalutazione delle fedi diverse dalla nostra e all’autocritica nei confronti degli effetti prodotti dalla nostra stessa religione.
Il testo si spinge a proporre idee nuove come quella di una tolleranza non più basata sullo scetticismo ma sul geocentrismo, e sul fatto che la diversità religiosa tra ebrei, cristiani e musulmani fa parte del mistero stesso del progetto di Dio sul mondo. Il Nathan, da questo punto di vista, è un tentativo di far superare al cristianesimo una visione negativa del giudaismo e dell’islam. Anzi, dice il teologo Kuschel, proprio il carattere radicalmente filo-musulmano di quest’opera, più ancora che quello filo-ebraico, costituisce una radicale novità e una rottura - nel cuore del XVIII secolo - con le contemporanee rappresentazioni del profeta Maometto.
Offrire una visione positiva del sultano musulmano oltre che di un mercante ebreo serviva a Lessing per testimoniare che la tolleranza non è un valore esclusivo della cultura occidentale. Una testimonianza, nel senso che Lessing fu colpito in tal senso dal suo viaggio in Italia (1775) e dalla tappa a Livorno, città in cui aveva constatato che una pacifica convivenza tra frequentatori di sinagoga, chiesa e moschea era possibile anche si suoi tempi, quando l’immaginario collettivo soggiaceva al terrore dei «turchi». Anzi, tale esperienza lo convinse ancor di più che l’unica competizione accettabile tra i seguaci delle tre fedi non è quella della verità esclusiva ma quella dell’emulazione nell’amore e nel rispetto reciproco.
«Con la sua parabola - commenta Kuschel - Lessing smonta precisamente questo modello di argomentazione: nessuno può e deve più richiamarsi a Dio per sostenere che la propria sia la religione migliore. Dio stesso ha voluto la pluralità delle religioni, non la tirannia di una di esse». Oggi, in un’Europa con dodici milioni di musulmani, la lezione di Lessing andrebbe ristudiata.
 Karl-Josef Kuschel
Karl-Josef Kuschel
 L’ebreo, il cristiano
e il musulmano s’incontrano?
Il «Nathan il saggio» di Lessing
L’ebreo, il cristiano
e il musulmano s’incontrano?
Il «Nathan il saggio» di Lessing
 Queriniana. Pagine 312. Euro 23,50
Queriniana. Pagine 312. Euro 23,50
___
Doc. 2.b
Melchisedech: I TRE ANELLI di G. BOCCACCIO
(dal “Decamerone”, novella della “prima giornata”)
Il Saladino, il valore del qual fu tanto che non solamente di piccolo uomo il fe’ di Babilonia Soldano, ma ancora molte vittorie sopra li Re saracini e cristiani li fece avere, avendo in diverse guerre, et in grandissime sue magnificenze, spese tutto il suo tesoro, e, per alcuno accidente sopravvenutogli, bisognandogli una buona quantità di danari, né veggendo donde così prestamente, come gli bisognavano, aver li potesse, gli venne a memoria un ricco giudeo, il cui nome era Melchisedech, il quale prestava ad usura in Alessandria, e pensossi costui avere da poterlo servire quando volesse; ma si era avaro che di sua volontà non l’avrebbe mai fatto, e forza non gli voleva fare: per che, stringendolo il bisogno, rivoltosi tutto a dover trovar modo come il giudeo il servisse, s’avvisò di fargli una forza da alcuna ragion colorata (violenza con apparenza di ragione).
E fattolsi chiamare, e familiarmente ricevutolo, seco il fece sedere, et appresso gli disse: - Valente uomo, io ho da più persona inteso che tu se’ savissimo, e nelle cose di Dio senti molto avanti; e per ciò io saprei volentieri da te, quale delle tre Leggi tu reputi la verace, o la giudaica, o la saracina, o la cristiana.
Il giudeo, il quale veramente era savio uomo, s’avvisò troppo bene che il Saladino guardava di pigliarlo nelle parole, per dovergli muovere alcuna quistione, e pensò non potere alcuna di queste tre più l’una che l’altra lodare, che il Saladino non avesse la sua intenzione. Per che, come colui il qual parea aver bisogno di risposta per la quale preso non potesse essere, aguzzato lo ‘ngegno, gli venne prestamente avanti quello che dir dovesse, e disse:
 Signor mio, la quistione la qual voi mi fate è bella, et a volerne dire ciò che io ne sento, mi vi convien dire una novelletta, qual voi udirete. Se io non erro, io mi ricordo aver molte volte udito dire che un grande uomo e ricco fu già, il quale, intra l’altre gioie più care che nel suo tesoro avesse, era uno anello bellissimo e prezioso; al quale per lo suo valore e per la sua bellezza volendo fare onore, et in perpetuo lasciarlo ne’ suoi discendenti, ordinò che colui dei suoi figliuoli appo il quale, sì come lasciatogli da lui fosse questo anello trovato, che colui s’intendesse essere il suo erede, e dovesse da tutti gli altri essere, come maggiore, onorato e reverito.
Signor mio, la quistione la qual voi mi fate è bella, et a volerne dire ciò che io ne sento, mi vi convien dire una novelletta, qual voi udirete. Se io non erro, io mi ricordo aver molte volte udito dire che un grande uomo e ricco fu già, il quale, intra l’altre gioie più care che nel suo tesoro avesse, era uno anello bellissimo e prezioso; al quale per lo suo valore e per la sua bellezza volendo fare onore, et in perpetuo lasciarlo ne’ suoi discendenti, ordinò che colui dei suoi figliuoli appo il quale, sì come lasciatogli da lui fosse questo anello trovato, che colui s’intendesse essere il suo erede, e dovesse da tutti gli altri essere, come maggiore, onorato e reverito.
Colui al quale da costui fu lasciato tenne somigliante ordine ne’ suoi discendenti, e così fece come fatto avea il suo predecessore: et in breve andò questo anello di mano in mano a molti successori; et ultimamente pervenne alle mani ad uno, il quale avea tre figliuoli belli e virtuosi, e molto al padre loro obbedienti; per la qual cosa tutti e tre parimente gli amava. Et i giovani, li quali la consuetudine dell’anello sapevano, si come vaghi ciascuno d’essere il più onorato tra i suoi, ciascuno per sé, come meglio sapeva, pregava il padre, il quale era già vecchio, che, quando a morte venisse, a lui quello anello lasciasse.
Il valente uomo, che parimente tutti gli amava, né sapeva esso medesimo eleggere a qual più tosto lasciar lo volesse, pensò, avendolo a ciascuno promesso, di volergli tutti e tre soddisfare; e segretamente ad uno buono maestro ne fece fare due altri, li quali si furono somiglianti al primiero, che esso medesimo che fatti gli aveva fare, appena conosceva qual si fosse il vero.
E venendo a morte, segretamente diede a ciascuno de’ figliuoli, li quali, dopo la morte del padre, volendo ciascuno la eredità e l’onore occupare, e l’uno negandolo all’altro, la testimonianza di dover ciò ragionevolmente fare, ciascuno produsse fuori il suo anello. E trovatisi gli anelli sì simili l’uno all’altro, che qual fosse il vero non si sapeva conoscere, si rimase la quistione, qual fosse il vero erede del padre, in pendente, et ancor pende.
E così vi dico, signor mio, delle tre Leggi alli tre popoli date da Dio Padre, delle quali la quistion proponeste: ciascuno la sua eredità, la sua vera Legge, et i suoi comandamenti si crede avere a fare; ma chi se l’abbia, come degli anelli, ancora ne pende la quistione. -
Il Saladino conobbe, costui ottimamente essere saputo uscire dal laccio il quale davanti a’ piedi teso gli aveva: e per ciò dispose d’aprirgli il suo bisogno, e vedere se servire il volesse; e così fece, aprendogli ciò che in animo avesse avuto di fare, se così discretamente, come fatto avea, non gli avesse risposto.
Il giudeo liberamente d’ogni quantità che il Saladino richiese il servì; et il Saladino poi interamente il soddisfece; et oltre a ciò gli donò grandissimi doni, e sempre per suo amico l’ebbe, et in grande et onorevole stato appresso di sé il mantenne.
*** DOC. 3
UN PAPA REVISIONISTA
di Furio Colombo (L’Unità, 29.05.2006)
Per la prima volta un Papa riflette sul passato del suo Paese e del mondo con parole che non sono di religione, non sono di magistero e non sono - non vogliono essere - universali.
Benedetto XVI, cresciuto in Germania sotto il nazismo, e ieri in visita alla più tremenda reliquia dell’invasione nazista in Europa - ciò che resta dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau - ieri ha parlato da tedesco che ricorda la storia tedesca, probabilmente al modo di molti altri tedeschi della sua generazione.
Bisogna pur convivere col passato, anche quando quel passato è assurdo e impossibile da guardare in faccia come la memoria di una grande, efficiente, meticolosa macchina di sterminio. I governi tedeschi del dopoguerra, e la gran parte degli intellettuali di quel Paese, hanno scelto la strada dura del guardare in faccia l’impossibile verità, e anzi di impedire - per legge, con l’insegnamento, con intere biblioteche di testimonianza - che la tremenda verità possa essere negata. Hanno lavorato molto (più intensamente, con più tenacia di altri governi e altre culture europee) per impedire che si potesse dare una versione mite, riduttivistica del nazismo. E hanno tenuto ferma in tutti questi anni la cruda e incancellabile definizione: un regime di sterminio, una meticolosa politica di sterminio, largamente sostenuta e condivisa anche attraverso poderosi apparati di indottrinamento e di propaganda, diretta contro molti nemici ma soprattutto contro il popolo ebreo di tutta Europa.
Mai nessuno avrebbe potuto dire in Germania ciò che si è detto con disinvoltura in Italia: che i fascisti non erano poi tanto cattivi e mandavano gli avversari a prendere il sole nelle isole.
D’altra parte è probabile che molti cittadini tedeschi abbiano trovato, in privato, una scorciatoia per non convivere con un passato vergognoso e inaccettabile. Per esempio, non parlare (o parlare il meno possibile) di Shoah, per esempio mettere insieme le tante sventure di quel massacro che è stata la Seconda guerra mondiale. E - se possibile, quando è possibile - parlare più di Stalin che di Hitler.
Benedetto XVI, di fronte ai cancelli di Auschwitz e Birkenau, ha usato due sole volte la parola che rappresenta il destino assegnato dai nazisti agli Ebrei, la Shoah. Ha nominato Stalin fra i mali del mondo (ha certamente ragione, ma ha dimenticato che sono state le truppe sovietiche ad abbattere i cancelli del luogo di sterminio tedesco-nazista da cui stava parlando). Non ha mai nominato Hitler.
Ha voluto lui stesso avvertire il mondo della differenza rispetto al suo predecessore. Giovanni Paolo II era polacco. Questo Papa è tedesco. Ha parlato da cittadino medio, nato e per un po’ vissuto nell’epoca spaventosa del nazismo. Come tanti della sua generazione ha usato i due più diffusi argomenti per rendere la memoria meno invivibile, per neutralizzare l’immagine che da sessant’anni è impressa nella memoria del mondo e che è stata nitidamente rappresentata dal titolo del non dimenticabile libro di Goldenhagen, «I volenterosi carnefici di Hitler».
Evidentemente il cittadino tedesco settantanovenne Josef Ratzinger, come molti altri tedeschi della sua età, non ha apprezzato quella descrizione di un passato di cui ha fatto parte, nell’unico Paese d’Europa senza alcuna Resistenza al nazismo e al fascismo. Qualcuno ricorderà che c’è un eccezione, nella storia tedesca: il piccolo ed eroico gruppo cattolico della «Rosa Bianca» . Purtroppo quel gruppo, nel discorso del Papa, non è stato ricordato.
E allora il cittadino tedesco Ratzinger ha detto che la Germania, nel periodo che noi chiamiamo nazismo, è stata vittima di un imbroglio. Cercava onore e dignità per la patria ed è caduta nelle mani di un gruppo di criminali. È finita sotto un governo cattivo e dispotico. Ecco, secondo Ratzinger la storia della Germania e dell’Europa dal 1933 al 1945 è tutta qui. E poiché il tremendo progetto dominante di distruggere gli ebrei, fino all’ultimo vecchio, fino all’ultimo bambino (un progetto così dominate da mettere la Germania in condizioni di perdere la guerra pur di portarlo a compimento) è troppo grande da sopportare, facciamo seguire una lunga lista di tante diverse nazioni e popoli e vittime, una lista in cui gli ebrei non sono neppure al primo posto. Tutti travolti da una brutta guerra e da un governo cattivo che ha agito da solo.
Seguendo questo percorso, in cui la responsabilità è di «un gruppo di criminali» la cui cattiveria tutti noi (tedeschi e ucraini, ebrei e rom, e tanti, tanti altri) abbiamo subito, il cittadino tedesco Ratzinger si è messo accanto ad un modo di pensare raramente dichiarato, ma forse largamente condiviso da tanti altri tedeschi che hanno vissuto il nazismo e - comprensibilmente - non amano ricordarlo così come era: una perfetta e totale macchina di consenso ubbidiente.
Seguendo questo percorso Benedetto XVI non solo si è scostato dal suo predecessore, che ha guardato in faccia il male del mondo, senza distinzioni, e senza citare un male piuttosto che un altro. Benedetto XVI si è scostato da se stesso, dal suo frequente e solenne mettere in guardia contro le propagande, le persuasioni, le seduzioni pericolose.
Può il male di Auschwitz essere spiegato come una disavventura tragica ma senza altri colpevoli che alcuni criminali che lo hanno voluto?
Il cittadino tedesco Ratzinger con una memoria spiegabilmente solidale con la sua patria e con tanti suoi coetanei concittadini, ha preso e guidato, per un momento la mano di un Papa. Dal Papa, da quel luogo e in quel giorno tanti nel mondo si aspettavano parole più grandi.
E così una giornata nata per essere memorabile (un Papa tedesco ad Auschwitz) non lo è stata.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Omaggio di Federico La Sala per i settanta anni di Vattimo e l’evento a Silvana Mansio: "VAN-GELO" E "MALA EDUCACION": L’ EU-ATTIMO (non fuggente) e il FESTIVAL DELLA FILOSOFIA
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
 "DEUS CARITAS EST": LA VERITA’ RECINTATA!!!
"DEUS CARITAS EST": LA VERITA’ RECINTATA!!!
 AI CERCATORI DEL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota sulla "lettera" perduta.
AI CERCATORI DEL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota sulla "lettera" perduta.
FLS
Forum
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- IL CIELO VISTO TRA I GIGANTI DELLA SILA: DUE PAROLE E DISPARI DALL’ALTOPIANO DELLA SILA.4 settembre 2024, di Federico La Sala
DUE PAROLE E DISPARI DALL’ALTOPIANO DELLA SILA
Una nota di commento al testo di Emiliano Antonino Morrone:
"[ ...] l’arte e la cultura toccano lo spirito, dunque giovano alla salute, reindirizzano lo sguardo, trasformano il corpo umano e sociale e producono cambiamenti impensabili nella direzione della libertà e della pacificazione. Ecco perché è giunta l’ora di ripensare e reinventare un territorio periferico come la Sila, di ricollocarlo in un’altra posizione levandolo dall’ombra dell’ignoto [...]".
*
- UN OMAGGIO A GIOACCCHINO DA FIORE:
IL CIELO VISTO TRA I GIGANTI DELLA SILA.
GEOLOGIA, MEMORIA, STORIA, ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA:
"L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (SHAKESPEARE).
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. Per i ‘Settanta’ di VATTIMO --- TORINO: CHIESA STRACOLMA PER L’ULTIMO SALUTO. “La carità, diceva Gianni in Credere di credere, non è secolarizzabile, non ha fine nella storia" (di Cristina Palazzo).23 settembre 2023, di Federico La Sala
Chiesa stracolma per l’ultimo saluto a Vattimo a Torino. L’abbraccio di Caminada e l’affetto di colleghi, allievi, parenti e amici
- Chiesa stracolma per l’ultimo saluto a Vattimo a Torino. L’abbraccio di Caminada e l’affetto di colleghi, allievi, parenti e amici
- Il feretro avvolto da un grande mazzo di rose rosse e altri fiori bianchi. Fuori dalla chiesa sono rimaste le bandiere NoTav
di Cristina Palazzo (la Repubblica/Torino, 23 settembre 2023)
“Gianni nella sua vita ha cercato di amare e ha tanto desiderato di essere amato. Che ora possa godere del sentirsi abbracciato dall’amore infinito di Dio in modo assoluto e senza più rischio di fine”. Cosi il rettore don Giovanni Ferretti questa mattina ha dato l’ultimo saluto commosso a Gianni Vattimo filosofo e padre del pensiero debole, “amico Gianni” ricordato nella sua “intelligenza acuta sempre in ricerca, alla sua militanza sociale e politica e soprattutto alla fede cristiana che lo ha ispirato”.
La bara questa mattina ha lasciato la camera ardente allestita nell’Università di Torino per raggiungere la chiesa di San Lorenzo, in piazza Castello nel cuore di Torino. Era la chiesa che amava e “frequentava con discrezione”. Accanto al feretro che era avvolto da un grande mazzo di rose rosse e altri fiori bianchi, è entrato in chiesa l’assistente e compagno di vita Simone Caminada: tra le sue mani il copricapo da docente di Vattimo.
Al primo banco della chiesa gremita anche il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessore Jacopo Rosatelli e l’assessore regionale Andrea Tronzano, tra i banchi tanti volti istituzionali e della comunità accademica, come Maurizio Ferraris, Massimo Cacciari, Elsa Fornero, Franco Debenedetti. la sociologa Chiara Saraceno, il direttore del dipartimento di filosofia Graziano Lingua e tanti ex studenti del filosofo. Molti commossi per il saluto al maestro. Fuori dalla chiesa sono rimaste le bandiere NoTav: nei giorni scorsi il movimento lo ha salutato con una lettera di Nicoletta Dosio, presente anche al funerale.
Il sacerdote, filosofo e già rettore dell’Università di Macerata, legato a Luigi Pareyson, molto vicino a Vattimo - è stato lui a dargli l’estrema unzione - lo ha ricordato con la sua fede che “ha cercato di ripensare con rigore critico”. Gianni Vattimo, ha ripercorso si è “impegnato a superare la visione sacrificale del cristianesimo che lo aveva tormentato in Gioventù. Egli ha giustamente scoperto e sostenuto che essa non corrisponde al Vangelo di Gesù. Ed è giunto a sentire la tanto desiderata vicinanza di Dio che ci ama e ci vuole felici”.
Due i testi scelti per il funerale pensando “alla sua figura umana generosa, l’inno alla Carità e la Beatitudine secondo Matteo, testi non casuali ma che hanno ispirato il filosofo e che ricordano importanti aspetti della sua fede. “La carità, diceva Gianni in Credere di credere, non è secolarizzabile, non ha fine nella storia - riprende il sacerdote -. Ci fa vivere oltre la morte. Mentre le beatitudini hanno ispirato l’impegno culturale e politico di Gianni per la giustizia sociale e l’emancipazione di poveri ed oppressi che gli stava a cuore”. Le ultime due parole della cerimonia, però, sono arrivate dalla comunità di Vattimo, quella che attorno al suo pensiero di era costruita negli anni: “Ciao Maestro” e lo hanno salutato con un grande applauso.
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, L’AUTOIRONIA, E LA "CHARITAS": UNA NUOVA "FILOSOFIA DELL’AVVENIRE".22 settembre 2023, di Federico La Sala
IL SOGGETTO, LA MASCHERA, E LA SOCIETÀ TRASPARENTE.
Alcune note su "che cosa ha veramente detto GIANNI VATTIMO". *
AUTOIRONIA, "Auto-chiarificazione (filosofia critica)", e Charitas: queste poche parole, forse, possono essere dei segnavia per non perdersi l’essenziale (e, in qualche modo, per distinguere prima e unire poi, quanto ritenuto accoglibile) nel mare della ricchissima produzione culturale e professionale di Vattimo.
UNA NUOVA "FILOSOFIA DELL’AVVENIRE". "«L’uomo è ciò che mangia, ma soprattutto quel che beve». Così Gianni Vattimo, scomparso il 19 settembre scorso, trasformò il celebre motto di Ludwig #Feuerbach, bevendo un calice di rosso della Sila. Di origini calabresi e fama mondiale, il filosofo torinese era autoironico, alleggeriva i discorsi, amava scherzare e porsi con umiltà." (cfr. Emiliano Antonino Morrone, "La ricerca (infinita) della verità e il pensiero “forte” di Vattimo per la sua San Giovanni in Fiore", Corriere della Calabria, 22.09.2023).
Rimettendo storicamente e antropologicamente accanto all’ironia (della dialettica platonico-socratica), anche l’autoironia di Gianni Vattimo, forse, a omaggio delle sue "AVVENTURE DELLA DIFFERENZA" (1980)", in un mondo dove la lanterna è in mano ai #ciechi, è più che opportuno richiamare alla memoria la figura di Diogene di Sinope.
RIPARTIRE DALLA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA DELL’ATTUALE PRESENTE STORICO. Se nel "processo dell’avvento del valore di scambio come metro di misura totalizzante si nasconde il trionfo dell’homo oeconomicus e della tendenza all’illimitazione del capitalismo", e, ancora, come ricorda Francesco Fistetti, "il recupero del valore d’uso e di un progetto di demercificazione dei mondi vitali va reimpostato a quest’altezza ", come è possibile svegliarsi dal #sonnodogmatico (Kant)?
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. Come mi sembra di capire, non è proprio il caso di re-interrogarsi sul tema del "soggetto e della maschera" (Vattimo, 1974) e riprendere la indicazione kantiana del 1784 (riafferrata per i capelli, da #MichelFoucault nel 1984), della questione antropologica e ripartire dal "#sàpereaude!", "dal coraggio di servirsi della propria intelligenza"? All’ordine del giorno, oggi, per ri-"orientarsi nel pensiero" (Kant) e per una seconda rivoluzione copernicana (Th. W. Adorno), è augurabile che venga ripresa la lettura dello "Spaccio della bestia trionfante" di Giordano Bruno e del "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano" del Galileo Galilei, senza queste opere l’uscita dal letargo claustrofilico e terrapiattistico è impensabile.
IL MATERIALISMO DIALETTICO. Superato Kant dialettica-mente (con la hegeliana astuzia della ragione "mascherata" - già di Platone e Cartesio, sia atea sia devota, sia idealistica sia materialistica), si è perso anche il senso e il sottotitolo stesso del lavoro di Marx sul "Capitale" e, con esso, ogni possibilità di portare avanti la stessa "critica dell’economia politica": si tenga presente che per John Dewey, la rivoluzione di Kant è "un ritorno a un sistema di tipo ultra-tolemaico").
LA "COSCIENZA MISTICA", IL "SOGNO DI UNA COSA", E "IL PROBLEMA DELLA LIBERAZIONE". Paradossalmente, e probabilmente, se avessimo letto di più e meglio sia Giambattista Vico sia Kant a questa ora, in occasione della riflessione sul percorso filosofico di Gianni Vattimo, forse, potremmo capire di più la sua reale vicinanza e consonanza con la "Critica dell’idealismo" della "Critica della Ragion Pura" (1787) e il programma giovanile di Marx, il #sognodiunacosa (1843) : "Sarà chiaro come non si tratti di tirare una linea retta tra passato e futuro, ma di realizzare le idee del passato. Si vedrà infine come l’umanità non incominci un lavoro nuovo, ma venga consapevolmente a capo del suo antico lavoro."("Annali franco-tedeschi"). Uno dei più importanti contributi in tale direzione di Gianni Vattimo, a mio parere, è proprio il saggio del 1974: "Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione" (Bompiani, 1974). Negli stessi anni, nelle infinite analisi sul rapporto tra il marxismo ed Hegel, correva il ripescaggio del "sapiente" Bovillus e della sua "rinascimentale" antropologia piramidale.
*
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- GIANNI VATTIMO, NIETZSCHE, E IL CRISTIANESIMO. La terza metamorfosi dello spirito: «La magia è avere dentro di sé il bambino che eri». Intervista di Antonio Gnoli ("Robinson").28 febbraio 2023, di Federico La Sala
Straparlando
GIANNI VATTIMO. Che fatica trovarsi a un millimetro dalle parole.
di Antonio Gnoli (la Repubblica, Robinson, 25 febbraio 2023, pp. 38-39).
La vecchiaia di un celebre filosofo, come tutte le vecchiaie verrebbe da aggiungere, andrebbe protetta dalle bagarre mediatiche. Quelle che da alcuni anni hanno visto coinvolto Gianni Vattimo. Era da un po’ che con Gianni non ci si vedeva e quando gli ho telefonato l’ho sentito disponibile all’idea che sarei andato a trovarlo. Ci siamo visti per pranzare nella sua grande e accogliente casa di via Po. Dove tutto è come l’ultima volta.
Tranne il gatto fulvo che non c’è più. Ci sono i libri, la grande televisione dove il professore segue a volume piuttosto alto un telegiornale. Le immagini corrono davanti a una specie di indifferenza dello sguardo. Mi riceve Simone Caminada. Presenza per molti ingombrante, per alcuni necessaria. Il giorno dopo la visita, una sentenza giudiziaria lo condanna a due anni di carcere per circonvenzione. In pratica avrebbe approfittato della fragilità del filosofo per mettere le mani sul suo patrimonio. Non entro nella questione che è stata già ampiamente trattata dai giornali. Mi limito a osservare la padronanza con cui Caminada - un adulto di 40 anni di Salvador Bahia - gestisce il rapporto con Vattimo.
 Perché sono qui? Perché al Circolo dei lettori di Torino, su iniziativa del centro studi Pareyson, Lopera completa di Vattimo (edita dalla Nave di Teseo) ed era appunto un’occasione vederlo qualche ora prima, parlargli, intervistarlo fuori da ogni clamore giudiziaario. Poche settimane fa Gianni ha compiuto 87 aqnni. E’ smagrito. Guardo i suoi occhi di una fissità vaga e ascolto i suoi prolungati silenzi. Non so bene da dove iniziare. Forse dal fatto che l’antico allievo Maurizio Ferraris si sia rappacificato con il maestro.
Perché sono qui? Perché al Circolo dei lettori di Torino, su iniziativa del centro studi Pareyson, Lopera completa di Vattimo (edita dalla Nave di Teseo) ed era appunto un’occasione vederlo qualche ora prima, parlargli, intervistarlo fuori da ogni clamore giudiziaario. Poche settimane fa Gianni ha compiuto 87 aqnni. E’ smagrito. Guardo i suoi occhi di una fissità vaga e ascolto i suoi prolungati silenzi. Non so bene da dove iniziare. Forse dal fatto che l’antico allievo Maurizio Ferraris si sia rappacificato con il maestro.Ho letto l’articolo che Ferraris ha scritto su di te.
«Non credo di averlo capito bene quell’articolo».
Cosa hai pensato?
«A una mozione di affetti, e che alla fine si torna un po’ bambini. Senza più l’obbligo di dover capire tutto».
Che vuoi dire?
«Non lo so, mi sento un po’ bambino. Sono accudito come un bambino. Lo vedi, di mio faccio poco».
Perché non puoi o non vuoi?
«Non posso, è chiaro. Parlo a fatica, a volte sono a un millimetro dalle parole».
Dalle parole per esprimerti e spiegarti?
«Avverto il suono e il senso di quelle altrui. Le mie escono strane».
Strane come?
«Come se la mia voce fosse cambiata. si strozzano in gola, poi escono come un sospiro pesante».
Vorrei tornare all’articolo di Ferraris.
«Ti ho detto, quell’articolo uscito sul Corriere della sera, non l’ho ben capito».
Dice che sei un cattolico, ma io ti vedo poco come cattolico.
«No, no. Lo sono».
Sei dentro il cristianesimo.
«Sono cattolico apostolico romano».
Non te l’ho mai sentito dire in modo così netto.
«Per me il cristianesimo è il cattolicesimo romano».
Il cristianesimo è molto di più.
«Ma sono nato qui. Fossi nato altrove sarei probabilmente un’altra cosa».
La Chiesa è tutt’altro che salda.
«Principi e la gerarchia non mi interessano».
E cosa ti interessa?
«Vivere la mia condizione periferica».
Di Ratzinger che cosa pensi?
«Mi pare sia morto».
Sì ma che giudizio ne dai?
«Negativo. La sua rinuncia, per quel che si è scritto, è stato un gesto bello. Ma troppa teologia impositiva».
Faceva il suo mestiere.
«Fin dall’inizio mi è parso respingente».
E di Papa Francesco cosa dici?
«Una grande figura. È la sola che mi interessa. So che ha letto alcuni miei libri. Prima della pandemia ci sentimmo telefonicamente».
Cosa vi diceste?
«Non lo ricordo».
Posso dirtelo io. Gli era piaciuto il tuo “Essere e dintorni”.
«Un libro che non chiude la mia opera, la lascia aperta».
L’opera aperta mi fa pensare al tuo amico Umberto Eco.
«Come me veniva dal mondo cattolico».
Vi ha condizionati questa educazione?
«Penso di sì. Un’educazione è una forma di disciplina. Ne restano tracce difficilmente cancellabili. Si sarebbe laureato su San Tommaso o avrebbe scritto Il nome della rosa senza quella educazione?».
Quanto a te?
«Ho sostenuto un cristianesimo senza verità».
Un cristianesimo debole, intendi dire?
«Debole, certo. Al punto che dovendo scegliere tra Gesù e la verità sceglierei lui. Era una strepitosa battuta di Dostoevskij».
Ma non si dice che Gesù sia la verità?
«Certo, ma quale? Non la verità che abbiamo ereditato dalla tradizione filosofica. Gesù ci ha liberati da quella verità. Ci ha chiesto di aderire al suo messaggio. Che è anche un messaggio profondamente politico».
Hai scritto molto di politica.
«È così».
Così come?
«La mia ermeneutica - il modo di interpretare i testi, gli eventi, la vita - si serviva dello sguardo politico. Non puoi limitarti a interpretare il mondo, devi provare a cambiarlo».
Pensi di esserci riuscito?
«Ho i miei dubbi. Anzi la certezza di avere fallito».
E’ il destino degli intellettuali, dei filosofi. Da Platone in poi. Vogliono dare la linea. «Ma non volevo servire i politici. Che sono per lo più penosi. Volevo muovermi nell’ordine di un mondo fatto in parte di esclusi».
Segui ancora la politica?
«Guardo i telegiornali. La politica non mi interessa più. Non saprei da che parte collocarmi. Sapevo stare dal lato dei più deboli. Ma chi sono i deboli oggi?».
Beh, sfruttati, emarginati, poveri non mancano, il discorso sulle disuguaglianze è più che mai attuale.
«Si sono riempite biblioteche di testi, io stesso vi ho contribuito. Ho spinto perché la sinistra, oltre che ai vecchi diritti pensasse anche ai nuovi. È una sinistra senza contenuti. Dovrebbe occuparsi degli ultimi».
Gli ultimi del messaggio evangelico? «Chi se no? ».
De André, in una canzone, scritta con De Gregori, parlava di un francescanesimo a puntate.
«Che vuol dire?».
Una carità automatica, seriale, esibita, con il tornaconto.
«Va bene, sono contro la carità pelosa».
A favore di cosa?
«Dei diritti, di tutti i diritti. Ricordo che contro l’inquinamento acustico nelle città, anni fa proposi alla sinistra di farsi sostenitrice del diritto del silenzio».
Forse c’è anche molto rumore mediatico.
«Assordante, non c’è dubbio».
Tu come lo hai vissuto, come lo vivi?
«Con fastidio. Si sono dette troppe cose. E il processo che mi ha riguardato è sembrata una cosa arbitraria».
C’era chi temeva per il tuo patrimonio.
«Dei miei soldi faccio quello che voglio. Si sono create troppe aspettative attorno a me. Non è giusto finire sui giornali per fatti che riguardano la mia vita privata».
Ti ha tolto serenità?
«Un po’ sì, ma neanche tanto. Vorrei essere più autonomo, più libero. Ma sono in queste condizioni di semi immobilità. Ho bisogno di aiuto. E Simone svolge il compito egregiamente».
È qualcosa di più di un assistente?
«Lo considero il mio compagno».
Simone mi ha detto che il tuo Parkinson è una balla. Un’invenzione.
«Ti ha detto questo? Non lo so. So che mi muovo a fatica e che debbo usare la carrozzina per spostarmi».
Ha aggiunto che se mai ci sia stato è regredito.
«Forse un po’ è regredito, chi lo sa».
Sono anche regredite le polemiche sulla tua filosofia.
«Non so se considerarlo un bene, Mi divertivano quelle accese discussioni. Credo di aver rotto le scatole a tanti conclamati filosofi».
Ormai sei considerato quasi un classico.
«Toglierei il quasi. Lo sono. È il solo diritto di cittadinanza che mi riconosco».
Le polemiche sul postmoderno e il pensiero debole sono ormai tramontate.
«Restano i libri, i miei, quelli di Rorty e di Lyotard».
A quale dei tuoi scritti ti senti più legato?
«Ai primi, in particolare a Il soggetto e la maschera. E’ quello in cui mi riconosco. Il più organico nella visione».
Uscì a metà anni Settanta. Il pamplet sul Pensiero debole, scritto con Pier Aldo Rovatti, nel 1983.
«I detrattori pensavano che debole volesse dire arrendevole, superficiale, stolto. Pensavano che la nostra filosofia fosse adatta ai gagà e ai bellimbusti».
E invece?
«Fu un modo per togliere il peso opprimente ai concetti, dar loro quella leggerezza necessaria dopo la deflagrazione concettuale della metafisica. Quella roba lì, che da Platone in poi era stata predicata, non funzionava più».
Ricordi il tuo esordio in pubblico?
«Credo di averne avuti più d’uno».
Mi riferisco a te poco più che venticinquenne mentre tieni una lezione all’università di Torino.
«Sinceramente non ricordo, dammi qualche indizio».
Era il novembre del 1960 e tu parlavi per la prima volta davanti a una schiera di autorevoli professori torinesi.
«Chi c’era?».
Tra gli altri c’erano Guzzo, Abbagnano, Chiodi, Bobbio e il tuo maestro Pareyson.
«Ero fresco della lettura dei seminari di Heidegger su Nietzsche che erano usciti quell’anno. Allora ero un dirigente dell’Azione cattolica e parlare di Nietzsche e Heidegger poteva sembrare una stravaganza».
Quale dei due è stato più importante per te?
«Oggi ti risponderei Heidegger. Nietzsche ha svolto il ruolo di accompagnatore. Ha funzionato da melodia».
Come vivi questa fase finale?
«Provo a non pensarci, le conseguenze sono pesanti».
Hai fatto testamento biologico?
«No c’ho pensato. Ne dedurrai che sono un ottimista».
E lo sei?
«Lo ero, qualcosa è rimasto di quell’ottimismo».
Forse la gentilezza e il saper accogliere gli altri.
«La chiamerei predisposizione cristiana».
Com’è una tua giornata?
«Mi alzo tardi, faccio fisioterapia, la colazione, leggo i giornali e poi l’attesa del pranzo. Guardo le notizie in televisione leggo qualche libro. Sono molto noioso».
Che libri leggi?
«Narrativa poliziesca, non vado molto più in là».
Ti manca il non poter scrivere come vorresti?
«Moltissimo. Avrei voglia di scrivere, di continuare a lavorare alle mie cose. Ma non ce la faccio».
Ti rassegni?
«A volte mi dispero, ma so che è inutile. E mi rassegno».
Oltre alla scrittura cos’altro ti manca?
«I compagni che non ci sono più, i miei».
Intendi i tuoi genitori?
«Mio padre praticamente non l’ho conosciuto. Mi manca mia madre. Una figura importante per me».
Una volta mi raccontasti del suo lavoro da sarta e che ti insegnò a cucire.
«È vero. Ero un bambino cresciuto con le conseguenze della guerra. La fame e le bombe. Un misto di paura e precarietà. L’aiutavo a confezionare abiti».
Hai detto all’inizio di questo nostro incontro che si torna quasi sempre bambini.
«La magia è avere dentro di sé il bambino che eri».
Pensi di averlo conservato in te?
«Penso che quello che sono diventato lo devo a quello che fui. E se lo so è perché è ancora dentro di me».
NOTA: MESSAGGIO EVANGELICO E INFANZIA: COME SI RI-NASCE?! Se si dimentica l’essere stati bambini ("ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi") e di essere stati al-levati, dell’essere ri-nato grazie a tutta la comunità, come è più possibile vivere?!
***
LE "TRE #METAMORFOSI" DELLO #ZARATHUSTRA DI #NIETZSCHE E IL #SAPEREAUDE! DELL’ILLUMINISMO DI #KANT. Appunti... [...] *
PSICOLOGIA E FILOSOFIA. Carl Gustav #Jung ha fatto un brillantissimo lavoro su «Lo Zarathustra di Nietzsche. Seminario 1934-39», ma alla fine la sua stessa ombra gli ha impedito di giungere a fondo e a capo dell’enigma di #Edipo, della domanda (la "question") di #Amleto, della "#visione e l’#enigma di Zarathustra e, infine, di accogliere il #bambino nato dalla metamorfosi del cammello e del leone (cfr. Federico La Sala, "La #menteaccogliente. Tracce per una #svolta_antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991).
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- iNTERVISTA ESCLUSIVA A GIANNI VATTIMO: "NUTRO UNA FORTE SPERANZA" SULLA BEATIFICAZIONE DI GIOACCHINO DA FIORE (di Emiliano Morrone).11 febbraio 2023, di Federico La Sala
INTERVISTA ESCLUSIVA
Vattimo: «Ma quale circonvenzione di incapace... Caminada mi ha salvato dai miei pessimi amici»
Il filosofo commenta la sentenza che ha condannato il suo convivente. «Contro di noi un accanimento senza prove, ho visto una discriminazione invalidante. Vorrei tanto tornare in Calabria, nelle un...
di Emiliano Morrone (Corriere della Calabria, 11/02/2023)
«Il professor Vattimo, che è stato il più grande filosofo italiano del Novecento, non può permettersi di avere i problemi comuni legati all’età». È un passaggio della requisitoria del pubblico ministero di Torino Dionigi Tibone, che per il trentottenne Simone Caminada, assistente e compagno di vita di Gianni Vattimo, aveva chiesto quattro anni di carcere ritenendolo colpevole di circonvenzione di incapace. Il tribunale ha poi condannato l’imputato a due anni, addebitandogli d’aver condizionato la psiche del padre del “pensiero debole”, che lo scorso 4 gennaio aveva spento 87 candeline, in modo da diventarne erede unico. Vedremo se l’accusa reggerà in Appello.
Nella sua casa nel centro di Torino, ubicata alle spalle della Mole Antonelliana, Vattimo vive da tempo insieme a Caminada, che l’ha sempre seguito sin dal secondo mandato del filosofo al Parlamento europeo, svolto dal 2009 al 2014. Cittadino italiano da quasi 38 anni, Caminada ha il diploma in Arte ed è un creativo, uno che sa ragionare alla pari con politici ed intellettuali. Non fa il ballerino nei night club, come spesso di legge in giro. È una persona che si è presa cura del professore, accompagnandolo nelle sue conferenze in Italia e all’estero, dandogli aiuto, sostegno e conforto nei momenti più difficili della vecchiaia. Non è facile fare i conti con la senescenza, soprattutto per uno come Vattimo: allievo di mostri sacri del pensiero come Luigi Pareyson, Karl Löwit e Hans-Georg Gadamer; caposcuola del “pensiero debole” e noto in tutto il mondo per le sue opere; parlamentare europeo per due legislature; già celebrato ospite di Fidel Castro e Hugo Chavez e maestro, tra gli altri, di due figure di primo piano della cultura italiana, cioè Maurizio Ferraris e Alessandro Baricco. In questa intervista che Vattimo ha rilasciato al Corriere della Calabria, abbiamo discusso del suo rapporto con Caminada, dei possibili limiti della giustizia, dell’attesa beatificazione di Gioacchino da Fiore, dei progetti del filosofo per il futuro e del proprio legame con la Calabria, di cui egli è originario e in cui era ritornato con l’obiettivo di diventare sindaco di San Giovanni in Fiore, provando, recita la sua biografia, a «sconfiggere la degenerazione intellettuale che affliggeva» quel Comune.
Conosco Vattimo dal 2005. Ci lega una profonda amicizia filosofica e personale, perciò ho scelto di dargli del Tu, anzitutto per correttezza verso i lettori del Corriere della Calabria, che il prossimo lunedì 13 febbraio uscirà con un’intervista a Simone Caminada per fornire un’informazione completa sul caso della “strana” coppia, intenzionata, nonostante la vicenda giudiziaria in corso, a contrarre matrimonio.
Gianni, tu hai sempre difeso Simone Caminada, che conosci bene da tanti anni. Che cosa pensi di lui? Credi che il procedimento penale a carico del tuo assistente sia sintomatico di una patologia della giustizia italiana? Fino a che punto la magistratura può spingersi dentro la vita privata delle persone? «Tutto il bene possibile e sto benissimo con lui. Mi sta vicino e, se non ha cambiato idea quando miei finti amici l’hanno accusato, spero che continui il nostro rapporto come è sempre stato.
 In questo caso Vattimo-Caminada, ma purtroppo storicamente non solo in questo, vedi la cattura a casa propria del latitante Messina Denaro, il sistema della giustizia italiana non fa una bella figura.
In questo caso Vattimo-Caminada, ma purtroppo storicamente non solo in questo, vedi la cattura a casa propria del latitante Messina Denaro, il sistema della giustizia italiana non fa una bella figura.
 Certo, la magistratura può e deve entrare nella vita privata delle persone, se fatti concreti ne determinano il bisogno. Se no, quando? Ovviamente ci sono o ci dovrebbero essere dei limiti. Per esempio, davanti al fine vita, che da anni difendo, e in tanti altri casi, si potrebbe dire, di pietas e umanità».
Certo, la magistratura può e deve entrare nella vita privata delle persone, se fatti concreti ne determinano il bisogno. Se no, quando? Ovviamente ci sono o ci dovrebbero essere dei limiti. Per esempio, davanti al fine vita, che da anni difendo, e in tanti altri casi, si potrebbe dire, di pietas e umanità».Giustizia e libertà sono idee, concetti, ambiti spesso contrastanti. La vicenda del tuo legame con Caminada, giudicata in primo grado dal Tribunale di Torino, può servire a riaprire il dibattito, anche a livello politico, su una più ampia riforma della giustizia?
«Certo. Molti problemi della giustizia di oggi fanno parte di annosi dibattiti che ancora non hanno trovato soluzioni e stancamente si trascinano. Per esempio, secondo te è giusto smanicarsi per il così detto “politicamente corretto”, scrivere leggi, fare propaganda politica eccetera, quando poi cittadini italiani di diversa nazionalità d’origine, come Simone, vengono indicati dai giornali come “brasiliano”, “zingaro” ed altro ancora, dando implicitamente adito al più inconscio e becero razzismo? Più che pensare ad una riforma della giustizia o parlare il politicamente corretto, bisognerebbe ritornare al precetto cristiano dell’amare il prossimo come se stessi».
Ritieni che la dialettica politica sulla giustizia sia oggi dominata dallo schema giustizialisti contro garantisti e viceversa? Tu ha un’altra visione in proposito?
«Diciamo che non so bene da che parte schierarmi e in fondo puoi comprendermi, visto che sai perfettamente che cosa penso delle verità assolute. Non so nemmeno se ho un’opinione che venga da miei pensamenti più o meno liberi, dal mondo che mi circonda, da ciò che sono, leggo, faccio, vedo e dico. Chi di noi si può dire del tutto libero di pensare?».
Professore, come stai? Ti senti vittima di circonvenzione?
«Sto abbastanza bene, a parte qualche piccolo acciacco passeggero. Tutto sommato, ora che ho anche dei medici fidati, non avverto più tanti problemi che lamentavo diversi anni fa. Tengo a precisare che il 99 per cento dei medici cui mi affidavo non era costituito da gente che voleva i miei soldi o da loro amici. Ora mi sono reso conto che avevo dei pessimi amici. Mi riferisco ai testimoni dell’accusa, e non solo a loro. Quindi mi dovrei sentire una vittima, una loro vittima loro e non certo di Simone. Anzi, se penso che Simone, o uno come lui, poteva non esserci nella mia vita, inorridisco immaginando come sarei finito male in preda ai loro sorrisi costosi».
Sei arrabbiato perché la stampa nazionale ha raccontato a fondo il tuo rapporto con Caminada e si è occupata molto meno delle tue opere, del tuo grande contributo alla filosofia?
«Non ne faccio colpa ad alcuno. Era quasi ovvio che se ne sarebbe parlato, dati i presupposti da romanzetto a puntate. Certamente avrei preferito leggere, come prima, dei contenuti; pure di filosofia e di ciò che mi ha sempre riguardato. Vedere l’accanimento su di noi senza prove, e con una certa perfidia, non è stato piacevole. Né è stato bello sentirmi in difetto perché alla mia età ho usato qualche volta la carrozzina per degli spostamenti. Ho visto una discriminazione invalidante, non tanto per me, quanto per il giornalismo italiano».
Di che cosa ti stai occupando in ambito filosofico?
«Emiliano, purtroppo in questi anni ho dovuto badare più a queste sciocchezze che a ciò che mi interessa davvero. Devo ammettere, però, che la produzione di libri, convegni e dibattiti negli ultimi anni è andata via via riducendosi, anche per colpa delle chiusure delle Regioni, dei lockdown causa Covid. Ora che la situazione sembra normalizzarsi, mi piacerebbe provare a pensare, filosoficamente parlando, a quanto l’esperienza della pandemia, del tutto straordinaria, abbia colpito i giovani e le fasce più deboli».
Ti senti incompreso, fuori del tempo, un pesce fuor d’acqua, un povero cristiano perseguitato, un pensatore fuori moda? Credi che il sistema pubblico ti stia facendo pagare il tuo desiderio di libertà?
«Mi aspettavo, anche se tanto ovvio pare non essere, maggiore rispetto per le mie condizioni di anziano. Non mi riferisco al rispetto in quanto giornalista, professore universitario ed ex parlamentare europeo. Mi bastava solo quello alla persona, ai suoi diritti e alle sue lecite debolezze umane, nonché a quelle fisiologiche dovute dall’età.
 La battaglia che con Simone stiamo portando avanti è molto attuale. È l’ennesimo caso in cui si scoperchia il vaso di Pandora del classismo e del razzismo che alberga in chi si crede migliore di qualcun altro per censo o per nascita. Nel caso di Simone, ma non solo nel suo, il razzismo è dipeso dal colore della pelle. Però, vedi, c’è anche tutto il discorso, da difendere, di chi come me ha una pensione un po’ più ricca della media e qualche soldino da parte. Pensa che oggi molti settantenni e ottantenni sono ex professionisti che vivono non più solo dei frutti dell’orto ma anche di pensioni di un certo livello. Ecco, queste persone domani dovranno temere che un parente, ma non è assolutamente il mio caso, o qualche medico possa certificare di trovarsi di fronte a un “malato di vita” e quindi dare luogo a sciocchezze, pure senza portar prove».
La battaglia che con Simone stiamo portando avanti è molto attuale. È l’ennesimo caso in cui si scoperchia il vaso di Pandora del classismo e del razzismo che alberga in chi si crede migliore di qualcun altro per censo o per nascita. Nel caso di Simone, ma non solo nel suo, il razzismo è dipeso dal colore della pelle. Però, vedi, c’è anche tutto il discorso, da difendere, di chi come me ha una pensione un po’ più ricca della media e qualche soldino da parte. Pensa che oggi molti settantenni e ottantenni sono ex professionisti che vivono non più solo dei frutti dell’orto ma anche di pensioni di un certo livello. Ecco, queste persone domani dovranno temere che un parente, ma non è assolutamente il mio caso, o qualche medico possa certificare di trovarsi di fronte a un “malato di vita” e quindi dare luogo a sciocchezze, pure senza portar prove».Tu sei originario della Calabria. Che ricordo ne conservi?
«Io sono di Cetraro e ne ho un ottimo ricordo. Poi, venuto a Torino, ero bollato come “terrone”. Ma questo è durato relativamente poco e va bene così, insomma.
 Ora come sarà Cetraro? Prima del Covid, Simone e io avevamo compiuto diversi viaggi di lavoro in Calabria. Mi piacerebbe tantissimo tornare in quei luoghi, come San Giovanni in Fiore o Soverato. E mi piacerebbe visitare le università calabresi, piene di studenti, ragazze e ragazzi, umanamente belli. Tutte queste città, compresa la mia Cetraro, sono nel mio cuore. Magari riuscirò un giorno a rivederle».
Ora come sarà Cetraro? Prima del Covid, Simone e io avevamo compiuto diversi viaggi di lavoro in Calabria. Mi piacerebbe tantissimo tornare in quei luoghi, come San Giovanni in Fiore o Soverato. E mi piacerebbe visitare le università calabresi, piene di studenti, ragazze e ragazzi, umanamente belli. Tutte queste città, compresa la mia Cetraro, sono nel mio cuore. Magari riuscirò un giorno a rivederle».Nel 2005 ti candidasti per diventare sindaco di San Giovanni in Fiore, affascinato dalla figura dell’abate Gioacchino. A 18 anni da quell’esperienza, che cosa ti senti di dire a quei giovani, ormai adulti, che ti sostennero con l’idea di cambiare la politica dal basso?
«Ragazzi resistete, siate “deboli” e non accettate mai le verità che vogliono opprimere le bellezze che sono dentro di voi. Non accettate chi inneggia alle differenze, chi vuol spingervi alla ricerca del denaro come fonte di felicità e successo. Beh, certo, tanto infelici a volte il denaro non fa! Ribellatevi sempre e comunque a chi mercanteggia sulla vostra pelle e su quella dei vostri cari. Insomma, non siate indifferenti: parteggiate, siate partigiani. Non ve lo dico io, ve lo dice Gramsci e certamente Gioacchino da Fiore».
Nel 2021 proponesti un accostamento tra la figura di Papa Francesco e quella di Gioacchino da Fiore. Nutri qualche speranza sulla beatificazione di Gioacchino da parte del Pontefice?
«Assolutamente sì, nutro una forte speranza. Il momento è buono e Papa Francesco è un rivoluzionario come lo era Gioacchino».
-
> «Con questo Papa non mi vergogno a dirmi cattolico». Papa Francesco telefona a Gianni Vattimo, il filosofo del “pensiero debole”9 luglio 2018, di Federico La Sala
Papa Francesco telefona a Gianni Vattimo, il filosofo del “pensiero debole”
Lo studioso italiano invia una copia del suo ultimo libro a Francesco che lo chiama per ringraziarlo. Una conversazione breve e piacevole sulla Chiesa e la filosofia: «Con questo Papa non mi vergogno a dirmi cattolico».
di ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZU (La Stampa, Vatican Insider, 09/07/2018)
CITTÀ DEL VATICANO. Una conversazione spontanea, breve ma piacevole. Così è stata la chiacchierata tra Papa Francesco e Gianni Vattimo, avvenuta qualche giorno fa via telefono. Il Pontefice ha voluto ringraziare il filosofo italiano, ex politico di sinistra e “padre” del cosiddetto pensiero debole, per un libro regalatogli tramite un amico comune. «Questo Papa mi toglie la “vergogna” di dichiararmi cattolico», dice lo studioso a Vatican Insider a cui racconta alcuni dettagli della conversazione con il Papa, con il quale condivide anche l’anno di nascita (1936).
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- Parco della Sila: “Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco”, si chiude l’iter di valutazione.30 ottobre 2016
Parco della Sila: patrimonio Unesco, si chiude l’iter di valutazione *
Si avvia verso la conclusione l’itinerario valutativo del Parco Nazionale della Sila per il riconoscimento del Parco quale “Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco”
Si avvia verso la conclusione l’itinerario valutativo del Parco Nazionale della Sila ad opera del valutatore dell’Iucn (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), Gerhard Heiss, chiamato a redigere una relazione accurata mirata a costituire lo strumento di analisi per il riconoscimento del Parco quale “Patrimonio Mondiale dell’Umanita’ dell’Unesco”. La terza giornata di sopralluoghi sul campo si e’ chiusa nella Sila Grande con delle tappe tra i monti silani nelle localita’:Gallopane, Golia Corvo, Arboreto del Parco, Macchialonga, Cozzo del Principe, Serra Ripollata, Pietre Bianche, Zarella e Cupone.
 Tutto questo e’ stato fatto in compagnia del Commissario del Parco, Sonia Ferrari, e del direttore, Michele Laudati, con la vicinanza e la consulenza del gruppo di lavoro che ha predisposto il dossier di riconoscimento del Parco Nazionale della Sila quale “Patrimonio Mondiale dell’Umanita’”, composto da botanici, zoologi, geologi, forestali, i quali hanno spiegato, attraverso un confronto di analisi, i principali elementi che conferiscono ai territori designati un valore eccezionale a livello mondiale per quanto riguarda gli aspetti geologici e geomorfologici.
Tutto questo e’ stato fatto in compagnia del Commissario del Parco, Sonia Ferrari, e del direttore, Michele Laudati, con la vicinanza e la consulenza del gruppo di lavoro che ha predisposto il dossier di riconoscimento del Parco Nazionale della Sila quale “Patrimonio Mondiale dell’Umanita’”, composto da botanici, zoologi, geologi, forestali, i quali hanno spiegato, attraverso un confronto di analisi, i principali elementi che conferiscono ai territori designati un valore eccezionale a livello mondiale per quanto riguarda gli aspetti geologici e geomorfologici.
 La straordinaria storia geologica - hanno sottolineato i componenti del comitato di lavoro autore del dossier - ha fatto della Sila un luogo particolarmente ricco e significativo dal punto di vista dell’evoluzione di molte specie di importanza internazionale e degli habitat cui esse sono legate.
La straordinaria storia geologica - hanno sottolineato i componenti del comitato di lavoro autore del dossier - ha fatto della Sila un luogo particolarmente ricco e significativo dal punto di vista dell’evoluzione di molte specie di importanza internazionale e degli habitat cui esse sono legate.In particolare, il suo ruolo di rifugio di specie durante le glaciazioni, dovuto all’isolamento geografico, specie che poi sono tornate a popolare altri territori settentrionali, ha fatto della Sila un importante serbatoio di biodiversita’ per aree molto piu’ vaste e lontane. L’aver ospitato processi microclimatici e macroclimatici unici spiega come sia oggi un hotspot nel Mediterraneo, quindi di interesse internazionale, e come si rinvengono tutt’oggi specie con altissima diversita’ genetica all’interno delle rispettive popolazioni locali.
 Tutto cio’ ha costituito e costituisce tutt’ora argomento di interesse per un numero crescente di studi scientifici di rilievo internazionale che dimostra come molti aspetti siano ancora oggetto di ricerca per gli specialisti di vari paesi. I territori dell’area proposta al riconoscimento conservano un singolare e apprezzato paesaggio forestale mediterraneo; il suo valore eccezionale e’ prima di tutto legato alla presenza di quasi tutta la popolazione mondiale di pino calabro, a boschi con caratteristiche di vetusta’ e ad alberi monumentali.
Tutto cio’ ha costituito e costituisce tutt’ora argomento di interesse per un numero crescente di studi scientifici di rilievo internazionale che dimostra come molti aspetti siano ancora oggetto di ricerca per gli specialisti di vari paesi. I territori dell’area proposta al riconoscimento conservano un singolare e apprezzato paesaggio forestale mediterraneo; il suo valore eccezionale e’ prima di tutto legato alla presenza di quasi tutta la popolazione mondiale di pino calabro, a boschi con caratteristiche di vetusta’ e ad alberi monumentali.
 Le foreste di pino nero di Calabria rappresentano l’elemento ecologico e paesaggistico silano piu’ iconico e il loro attuale stato di conservazione e’ il risultato di attivita’ selvicolturale condotte da lungo tempo per favorire il mantenimento di questi ecosistemi forestali naturali e semi-naturali. Le unicita’ presenti nei suoi territori, sia in termini geologici e geomorfologici, sia dal punto di vista delle caratteristiche biologiche ed ecologiche, conferiscono al Parco Nazionale della Sila un valore che supera in gran parte la dimensione locale e nazionale, per assumere una rilevanza mediterranea ed internazionale. (AGI)
Le foreste di pino nero di Calabria rappresentano l’elemento ecologico e paesaggistico silano piu’ iconico e il loro attuale stato di conservazione e’ il risultato di attivita’ selvicolturale condotte da lungo tempo per favorire il mantenimento di questi ecosistemi forestali naturali e semi-naturali. Le unicita’ presenti nei suoi territori, sia in termini geologici e geomorfologici, sia dal punto di vista delle caratteristiche biologiche ed ecologiche, conferiscono al Parco Nazionale della Sila un valore che supera in gran parte la dimensione locale e nazionale, per assumere una rilevanza mediterranea ed internazionale. (AGI)* Fonte: Zoom 24, 0610.2016
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- INTERROGAZIONI SUL CRISTIANESIMO. Vattimo: «Quelle sue parole sono di origine divina».3 luglio 2013, di Federico La Sala
Vattimo: «Quelle sue parole sono di origine divina»
di Gianni Vattimo (Avvenire, 03 luglio 2013)
- Nel volume «Interrogazioni sul cristianesimo. Cosa possiamo ancora attenderci dal Vangelo?» il filosofo GIanni Vattimo e il teologo Pierangelo Sequeri, si confrontano con il contraddittorio atteggiamento del nostro tempo verso la religione e, in particolare, con il ruolo del messaggio cristiano e della Chiesa nella società postmoderna. "Io ritengo che Gesù venga da Dio perché le cose che dice sono davvero di origine divina, cioè sono davvero il meglio, il più divino che ho trovato nella mia storia. Quello che mi impressiona è la perfezione del suo messaggio, prima e più che i suoi miracoli".
Io ritengo che Gesù venga da Dio perché le cose che dice sono davvero di origine divina, cioè sono davvero il meglio, il più divino che ho trovato nella mia storia. Quello che mi impressiona è la perfezione del suo messaggio, prima e più che i suoi miracoli. Non mi faccio impressionare, ad esempio, dalla risurrezione di Lazzaro, perché tutto dipenderebbe dalla fede che presto agli scritti che me ne parlano: infatti, chi mi parla della risurrezione di Lazzaro? È difficile pensare all’esistenza di altri documenti antichi, oltre ai Vangeli, in cui si parli di uno che ha risuscitato un tale di nome Lazzaro...
Credo che Schleiermacher non si esprimesse in termini molto diversi (anche se più attenuati dei miei) quando scriveva che Gesù Cristo è l’uomo che ha realizzato il più possibile la vicinanza e il senso di dipendenza da Dio: Gesù sarebbe l’esempio più grande, sotto questo profilo, e noi ci salveremmo in quanto in contatto storico-sacramentale con lui (mediante i Vangeli, il culto) come massimo eroe della coscienza religiosa dell’umanità.
Io non seguirei per intero il percorso di Schleiermacher, ma nemmeno mi interessa granché stabilire se Gesù sia di natura divina o di natura umana, se in lui vi siano due nature e una persona, o tutte le altre questioni in cui si avviluppa la teologia di oggi. (...)
Io credo nella divinità di Gesù Cristo soprattutto per ciò che lui mi ha detto; anzi, posso persino ammettere che egli sia resuscitato sulla base del fatto che tutte le altre cose che mi dice sono così attraenti che non posso non credergli. Insomma, è come se, avendolo visto, mi sia innamorato di lui e sia quindi divenuto capace di dargli ascolto. Del resto è proprio san Paolo ad affermare che la fede è sempre fides ex auditu. Non è quindi inverosimile pensare alla propria fede come all’essere presi da un messaggio affascinante - per dirla con un aggettivo certamente inadeguato - insomma capace di prenderti. (...)
Se qualcuno mi chiedesse perché preferisco Gesù Cristo a Buddha, risponderei: «Perché sono stato educato nel cristianesimo». E se mi si obiettasse che questo è un limite, risponderei che non posso certo cavarmi gli occhi per vedere meglio. Io ho una tradizione e vivo al suo interno: anzi, per proseguire con l’esempio della preferenza a Cristo anziché a Buddha, direi che il buddhismo ancora non l’ho giudicato perché non è una religione positivamente dogmatica, e che piuttosto solo nel cristianesimo trovo le ragioni per interessarmi anche al buddhismo e ad altre tradizioni.
Sono quindi convinto, in primo luogo, che la mia fedeltà al Vangelo è anche (o soprattutto, chi lo sa?) fedeltà a una tradizione umanistico- culturale- politica che è la tradizione europea; non riesco a separare nettamente queste due realtà, quasi esistesse un cristianesimo esterno all’Occidente e ad esso invece non profondamente avviluppato.
Sono poi convinto che la verità dell’Occidente è il cristianesimo, e, viceversa, che la verità del cristianesimo è oggi l’Occidente (non necessariamente in senso per così dire eterno, ma considerando che il «cristianesimo » è anche la «cristianità », al cui interno peraltro il fermento cristiano opera criticamente, rimettendo in discussione assetti stabiliti, invitando all’ascolto di altre tradizioni religiose, ecc.).
In definitiva io non ho scelto di stare nella tradizione cristiana: vi sono dentro, prendendo atto dell’esistenza di una quantità di cose che ho pensato come separate da questa tradizione mentre in realtà ad essa mi riconducono. Di ciò prendo atto anche criticamente, ovvero senza alcun esclusivismo o integralismo, quasi che ora si dovesse smettere di leggere tutti gli autori contemporanei e fermarsi solo al Vangelo o a certi contenuti dell’insegnamento della Chiesa.
Piuttosto, io rimango nella tradizione cristiana perché ritengo che anche Voltaire si trovava al suo interno, e, con lui, tutta la democrazia moderna. Semmai contrappongo talvolta un brano di questa tradizione - che a me sembra dotato di qualche autenticità - ad altri che magari trovo più autoritari, dogmatici; in ogni caso, è sempre all’interno di questa tradizione che mi muovo. Per me essere cristiano è come accettare la mia finitezza, peraltro descritta dalla Sacra Scrittura.
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. ---- IL RINASCIMENTO E LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA. 2013: DA BOCCACCIO, UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA.24 maggio 2012, di Federico La Sala
 LA GRECIA, LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA, E IL RINASCIMENTO ITALIANO ED EUROPEO. In memoria di Barlaam (Bernardo) e di Leonzio Pilato ...
LA GRECIA, LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA, E IL RINASCIMENTO ITALIANO ED EUROPEO. In memoria di Barlaam (Bernardo) e di Leonzio Pilato ...
 PER BOCCACCIO, NEL 2013, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA!!! Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico. Materiali sul tema
PER BOCCACCIO, NEL 2013, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA!!! Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico. Materiali sul tema
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. ---- "DOMINUS IESUS": ALLA FINE DELLA STORIA, LA VITTORIA DI CRISTO RE (di Benedetto XVI).19 novembre 2011, di Federico La Sala
Note sul tema:
- PER UNA NUOVA TEOLOGIA E PER UNA NUOVA CHIESA. L’INDICAZIONE DI GIOVANNI XXIII E DI GIOVANNI PAOLO II: LA RESTITUZIONE DELL’ANELLO DEL PESCATORE A GIUSEPPE. (Federico La Sala)
UDIENZA DEL MERCOLEDI’
Alla fine della storia, la vittoria di Cristo Re
di Benedetto XVI *
Cari fratelli e sorelle,
vorrei oggi terminare le mie catechesi sulla preghiera del Salterio meditando uno dei più famosi "Salmi regali", un Salmo che Gesù stesso ha citato e che gli autori del Nuovo Testamento hanno ampiamente ripreso e letto in riferimento al Messia, a Cristo. Si tratta del Salmo 110 secondo la tradizione ebraica, 109 secondo quella greco-latina; un Salmo molto amato dalla Chiesa antica e dai credenti di ogni tempo. Questa preghiera era forse inizialmente collegata all’intronizzazione di un re davidico; tuttavia il suo senso va oltre la specifica contingenza del fatto storico aprendosi a dimensioni più ampie e diventando così celebrazione del Messia vittorioso, glorificato alla destra di Dio.
 Il Salmo inizia con una dichiarazione solenne:
Il Salmo inizia con una dichiarazione solenne: Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra
Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra
 finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi» (v. 1).
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi» (v. 1).Dio stesso intronizza il re nella gloria, facendolo sedere alla sua destra, un segno di grandissimo onore e di assoluto privilegio. Il re è ammesso in tal modo a partecipare alla signoria divina, di cui è mediatore presso il popolo. Tale signoria del re si concretizza anche nella vittoria sugli avversari, che vengono posti ai suoi piedi da Dio stesso; la vittoria sui nemici è del Signore, ma il re ne è fatto partecipe e il suo trionfo diventa testimonianza e segno del potere divino.
La glorificazione regale espressa in questo inizio del Salmo è stata assunta dal Nuovo Testamento come profezia messianica; perciò il versetto è tra i più usati dagli autori neotestamentari, o come citazione esplicita o come allusione. Gesù stesso ha menzionato questo versetto a proposito del Messia per mostrare che il Messia è più che Davide, è il Signore di Davide (cfr Mt 22,41-45; Mc 12,35-37; Lc 20,41-44). E Pietro lo riprende nel suo discorso a Pentecoste, annunciando che nella risurrezione di Cristo si realizza questa intronizzazione del re e che da adesso Cristo sta alla destra del Padre, partecipa alla Signoria di Dio sul mondo (cfr Atti 2,29-35). È il Cristo, infatti, il Signore intronizzato, il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio che viene sulle nubi del cielo, come Gesù stesso si definisce durante il processo davanti al Sinedrio (cfr Mt 26,63-64; Mc 14,61-62; cfr anche Lc 22,66-69). È Lui il vero re che con la risurrezione è entrato nella gloria alla destra del Padre (cfr Rom 8,34; Ef 2,5; Col 3,1; Ebr 8,1; 12,2), fatto superiore agli angeli, seduto nei cieli al di sopra di ogni potenza e con ogni avversario ai suoi piedi, fino a che l’ultima nemica, la morte, sia da Lui definitivamente sconfitta (cfr 1 Cor 15,24-26; Ef 1,20-23; Ebr 1,3-4.13; 2,5-8; 10,12-13; 1 Pt 3,22). E si capisce subito che questo re che è alla destra di Dio e partecipa della sua Signoria, non è uno di questi uomini successori di Davide, ma solo il nuovo Davide, il Figlio di Dio che ha vinto la morte e partecipa realmente alla gloria di Dio. È il nostre re, che ci dà anche la vita eterna.
Tra il re celebrato dal nostro Salmo e Dio esiste quindi una relazione inscindibile; i due governano insieme un unico governo, al punto che il Salmista può affermare che è Dio stesso a stendere lo scettro del sovrano dandogli il compito di dominare sui suoi avversari, come recita il versetto 2:
 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
 domina in mezzo ai tuoi nemici!
domina in mezzo ai tuoi nemici!L’esercizio del potere è un incarico che il re riceve direttamente dal Signore, una responsabilità che deve vivere nella dipendenza e nell’obbedienza, diventando così segno, all’interno del popolo, della presenza potente e provvidente di Dio. Il dominio sui nemici, la gloria e la vittoria sono doni ricevuti, che fanno del sovrano un mediatore del trionfo divino sul male. Egli domina sui nemici trasformandoli, li vince con il suo amore.
Perciò, nel versetto seguente, si celebra la grandezza del re. Il versetto 3, in realtà, presenta alcune difficoltà di interpretazione. Nel testo originale ebraico si fa riferimento alla convocazione dell’esercito a cui il popolo risponde generosamente stringendosi attorno al suo sovrano nel giorno della sua incoronazione. La traduzione greca dei LXX, che risale al III-II secolo prima di Cristo, fa riferimento invece alla filiazione divina del re, alla sua nascita o generazione da parte del Signore, ed è questa la scelta interpretativa di tutta la tradizione della Chiesa, per cui il versetto suona nel modo seguente:
 A te il principato nel giorno della tua potenza
A te il principato nel giorno della tua potenza
 tra santi splendori;
tra santi splendori;
 dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato.
dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato.Questo oracolo divino sul re affermerebbe dunque una generazione divina soffusa di splendore e di mistero, un’origine segreta e imperscrutabile, legata alla bellezza arcana dell’aurora e alla meraviglia della rugiada che nella luce del primo mattino brilla sui campi e li rende fecondi. Si delinea così, indissolubilmente legata alla realtà celeste, la figura del re che viene realmente da Dio, del Messia che porta al popolo la vita divina ed è mediatore di santità e di salvezza. Anche qui vediamo che tutto questo non è realizzato dalla figura di un re davidico, ma dal Signore Gesù Cristo, che realmente viene da Dio; Egli è la luce che porta la vita divina al mondo.
Con questa immagine suggestiva ed enigmatica termina la prima strofa del Salmo, a cui fa seguito un altro oracolo, che apre una nuova prospettiva, nella linea di una dimensione sacerdotale connessa alla regalità. Recita il versetto 4:
 Il Signore ha giurato e non si pente:
Il Signore ha giurato e non si pente:
 «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek».
«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek».Melchìsedek era il sacerdote re di Salem che aveva benedetto Abramo e offerto pane e vino dopo la vittoriosa campagna militare condotta dal patriarca per salvare il nipote Lot dalle mani dei nemici che lo avevano catturato (cfr Gen 14). Nella figura di Melchìsedek, potere regale e sacerdotale convergono e ora vengono proclamati dal Signore in una dichiarazione che promette eternità: il re celebrato dal Salmo sarà sacerdote per sempre, mediatore della presenza divina in mezzo al suo popolo, tramite della benedizione che viene da Dio e che nell’azione liturgica si incontra con la risposta benedicente dell’uomo.
La Lettera agli Ebrei fa esplicito riferimento a questo versetto (cfr. 5,5-6.10; 6,19-20) e su di esso incentra tutto il capitolo 7, elaborando la sua riflessione sul sacerdozio di Cristo. Gesù, così ci dice la Lettera agli Ebrei nella luce del salmo 110 (109), Gesù è il vero e definitivo sacerdote, che porta a compimento i tratti del sacerdozio di Melchìsedek rendendoli perfetti.
Melchìsedek, come dice la Lettera agli Ebrei, era «senza padre, senza madre, senza genealogia» (7,3a), sacerdote dunque non secondo le regole dinastiche del sacerdozio levitico. Egli perciò «rimane sacerdote per sempre» (7,3c), prefigurazione di Cristo, sommo sacerdote perfetto che «non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile» (7,16). Nel Signore Gesù risorto e asceso al cielo, dove siede alla destra del Padre, si attua la profezia del nostro Salmo e il sacerdozio di Melchìsedek è portato a compimento, perché reso assoluto ed eterno, divenuto una realtà che non conosce tramonto (cfr 7,24). E l’offerta del pane e del vino, compiuta da Melchìsedek ai tempi di Abramo, trova il suo adempimento nel gesto eucaristico di Gesù, che nel pane e nel vino offre se stesso e, vinta la morte, porta alla vita tutti i credenti. Sacerdote perenne, «santo, innocente, senza macchia» (7,26), egli, come ancora dice la Lettera agli Ebrei, «può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio; egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore» (7,25).
Dopo questo oracolo divino del versetto 4, col suo solenne giuramento, la scena del Salmo cambia e il poeta, rivolgendosi direttamente al re, proclama: «Il Signore è alla tua destra!» (v. 5a). Se nel versetto 1 era il re a sedersi alla destra di Dio in segno di sommo prestigio e di onore, ora è il Signore a collocarsi alla destra del sovrano per proteggerlo con lo scudo nella battaglia e salvarlo da ogni pericolo. Il re è al sicuro, Dio è il suo difensore e insieme combattono e vincono ogni male.
Si aprono così i versetti finali del Salmo con la visione del sovrano trionfante che, appoggiato dal Signore, avendo ricevuto da Lui potere e gloria (cfr v. 2), si oppone ai nemici sbaragliando gli avversari e giudicando le nazioni. La scena è dipinta con tinte forti, a significare la drammaticità del combattimento e la pienezza della vittoria regale. Il sovrano, protetto dal Signore, abbatte ogni ostacolo e procede sicuro verso la vittoria. Ci dice: sì, nel mondo c’è tanto male, c’è una battaglia permanente tra il bene e il male, e sembra che il male sia più forte. No, più forte è il Signore, il nostro vero re e sacerdote Cristo, perché combatte con tutta la forza di Dio e, nonostante tutte le cose che ci fanno dubitare sull’esito positivo della storia, vince Cristo e vince il bene, vince l’amore e non l’odio.
È qui che si inserisce la suggestiva immagine con cui si conclude il nostro Salmo, che è anche una parola enigmatica.
 lungo il cammino si disseta al torrente,
lungo il cammino si disseta al torrente,
 perciò solleva alta la testa (v. 7).
perciò solleva alta la testa (v. 7).Nel mezzo della descrizione della battaglia, si staglia la figura del re che, in un momento di tregua e di riposo, si disseta ad un torrente d’acqua, trovando in esso ristoro e nuovo vigore, così da poter riprendere il suo cammino trionfante, a testa alta, in segno di definitiva vittoria. E’ ovvio che questa parola molto enigmatica era una sfida per i Padri della Chiesa per le diverse interpretazioni che si potevano dare. Così, per esempio, sant’Agostino dice: questo torrente è l’essere umano, l’umanità, e Cristo ha bevuto da questo torrente facendosi uomo, e così, entrando nell’umanità dell’essere umano, ha sollevato il suo capo e adesso è il capo del Corpo mistico, è il nostro capo, è il vincitore definitivo (cfr Enarratio in Psalmum CIX, 20: PL 36, 1462).
Cari amici, seguendo la linea interpretativa del Nuovo Testamento, la tradizione della Chiesa ha tenuto in grande considerazione questo Salmo come uno dei più significativi testi messianici. E, in modo eminente, i Padri vi hanno fatto continuo riferimento in chiave cristologica: il re cantato dal Salmista è, in definitiva, Cristo, il Messia che instaura il Regno di Dio e vince le potenze del mondo, è il Verbo generato dal Padre prima di ogni creatura, prima dell’aurora, il Figlio incarnato morto e risorto e assiso nei cieli, il sacerdote eterno che, nel mistero del pane e del vino, dona la remissione dei peccati e la riconciliazione con Dio, il re che solleva la testa trionfando sulla morte con la sua risurrezione. Basterebbe ricordare un passo ancora una volta del commento di sant’Agostino a questo Salmo dove scrive: «Era necessario conoscere l’unico Figlio di Dio, che stava per venire tra gli uomini, per assumere l’uomo e per divenire uomo attraverso la natura assunta: egli è morto, risorto, asceso al cielo, si è assiso alla destra del Padre ed ha adempiuto tra le genti quanto aveva promesso ... Tutto questo, dunque, doveva essere profetizzato, doveva essere preannunciato, doveva essere segnalato come destinato a venire, perché, sopravvenendo improvviso, non facesse spavento, ma fosse preannunciato, piuttosto accettato con fede, gioia ed atteso. Nell’ambito di queste promesse rientra codesto Salmo, il quale profetizza, in termini tanto sicuri ed espliciti, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che noi non possiamo minimamente dubitare che in esso sia realmente annunciato il Cristo» (cfr Enarratio in Psalmum CIX, 3: PL 36, 1447)
L’evento pasquale di Cristo diventa così la realtà a cui ci invita a guardare il Salmo, guardare a Cristo per comprendere il senso della vera regalità, da vivere nel servizio e nel dono di sé, in un cammino di obbedienza e di amore portato "fino alla fine" (cfr. Gv 13,1 e 19,30). Pregando con questo Salmo, chiediamo dunque al Signore di poter procedere anche noi sulle sue vie, nella sequela di Cristo, il re Messia, disposti a salire con Lui sul monte della croce per giungere con Lui nella gloria, e contemplarlo assiso alla destra del Padre, re vittorioso e sacerdote misericordioso che dona perdono e salvezza a tutti gli uomini. E anche noi, resi, per grazia di Dio, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa» (cfr 1 Pt 2,9), potremo attingere con gioia alle sorgenti della salvezza (cfr Is 12,3) e proclamare a tutto il mondo le meraviglie di Colui che ci ha «chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa» (cfr 1 Pt 2,9).
Cari amici, in queste ultime Catechesi ho voluto presentarvi alcuni Salmi, preziose preghiere che troviamo nella Bibbia e che riflettono le varie situazioni della vita e i vari stati d’animo che possiamo avere verso Dio. Vorrei allora rinnovare a tutti l’invito a pregare con i Salmi, magari abituandosi a utilizzare la Liturgia delle Ore della Chiesa, le Lodi al mattino, i Vespri alla sera, la Compieta prima di addormentarsi. Il nostro rapporto con Dio non potrà che essere arricchito nel quotidiano cammino verso di Lui e realizzato con maggior gioia e fiducia. Grazie.
* Avvenire, 16 novembre 2011
- PER UNA NUOVA TEOLOGIA E PER UNA NUOVA CHIESA. L’INDICAZIONE DI GIOVANNI XXIII E DI GIOVANNI PAOLO II: LA RESTITUZIONE DELL’ANELLO DEL PESCATORE A GIUSEPPE. (Federico La Sala)
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- LEZIONE DI "NATHAN IL SAGGIO": CHE ILLUSIONE AF-FIDARSI DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA. Una recensione di Gianfranco Ravasi, di una nuova edizione a cura di Leo Lestingi.3 agosto 2010, di Federico La Sala
CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA-CATTOLiCA:
Che illusione affidarsi al «concordismo»di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 01.08.2010)
«Molti anni fa un uomo, in Oriente, possedeva un anello inestimabile, un dono caro. La sua pietra, un opale dai cento bei riflessi colorati, aveva un potere segreto: rendere grato a Dio e agli uomini chiunque la portasse...». Comincia così la parabola che Nathan, un saggio ebreo gerosolimitano, narra al sultano Saladino nel 1192, durante una parentesi delle lotte tra musulmani e cristiani in Terrasanta. Questa parabola è nota a tutti nel suo esito finale, anche perché secoli prima che Ephraim Lessing nel 1779 la incastonasse nel suo poema drammatico Nathan il saggio, fatto di 3.849 pentapodie giambiche, il nostro Boccaccio l’aveva messa in bocca a "Melchisedech giudeo" nella terza novella della prima giornata del suo Decameron.
L’anello, lasciato in eredità di generazione in generazione, «giunse alla fine a un padre di tre figli, tutti e tre ugualmente obbedienti e da lui amati allo stesso modo... Così, con affettuosa debolezza, egli promise l’anello a tutti e tre». Ma come alla fine assegnarlo? La soluzione è nota: ne fece cesellare altri due identici e, in punto di morte, chiamò i figli uno per uno e a ciascuno consegnò un anello. Nessuno dei tre sapeva quale fosse quello vero.
La metafora è sciolta da Lessing nello spirito della tipica liberalità illuministica, che animava il nostro autore tedesco e che sarà celebrata anche dal famoso elogio della tolleranza intessuto da Voltaire.
I tre monoteismi, incarnati dai tre anelli, devono coesistere in spirito ecumenico e armonico. Sarà ciò che espliciterà il giudice a cui i tre figli ricorrono per dirimere la questione dell’autenticità e, quindi, del primato: «Ognuno di voi ebbe l’anello da suo padre, ognuno di voi sia sicuro che esso è quello vero. Egli vi ha amati ugualmente tutti e tre; non volle, infatti, umiliare due di voi per favorirne uno solo. Sforzatevi di imitare il suo amore incorruttibile e senza pregiudizi! Ognuno faccia a gara per dimostrare alla luce del giorno la virtù della pietra del suo anello! E aiuti questa virtù con la dolcezza, con indomita pazienza, con la carità e con profonda devozione a Dio».
Giustamente nella nuova edizione di questo "dramma di idee", il curatore Leo Lestingi appaia alle parole del giudice un passo del Corano molto significativo di cui il testo di Lessing sembra essere quasi una «riscrittura laica»: «Se Dio avesse voluto, avrebbe fatto una comunità unica, ma ciò non ha fatto per provarvi in quello che vi ha dato. Gareggiate, allora, nelle opere buone perché tutti a Dio tornerete e in quel momento Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora siete in discordia» (5, 46-48).
Non è ora nostro compito illustrare la tesi di Lessing, secondo il quale la vera religione è quella che rende migliore l’uomo, adottando così un parametro veritativo esistenziale, etico e antropologico. Come osserva Lestingi, per lo scrittore tedesco «ciò che conta non è il fatto di essere cristiani, ebrei o musulmani, se ciò porta a oscurare la dignità umana, ma è l’essere uomini; decisivi sono i valori e i compiti di un umanitarismo qualitativo».
Questa concezione esalta, certo, il pluralismo, ribadisce che ogni religione ha un suo frammento di verità, ma anche introduce consequenzialmente una sorta di soggettivismo e persino di relativismo.
Infatti, i tre devono adattarsi a considerare come autentici tutti e tre gli anelli, ignorando la realtà oggettiva per la quale uno solo è l’anello vero. A questo proposito desidererei accennare molto sinteticamente a una questione più attuale e più complessa nelle sue formulazioni teoriche e pratiche.
Intendo riferirmi al dialogo interreligioso che ai nostri giorni ha un rilievo straordinario, soprattutto con l’irruzione della globalizzazione e con l’affacciarsi impetuoso di un monoteismo, quello islamico, nelle nostre città cristiane. Il dialogo tra le religioni è diventato, quindi, anche un nuovo capitolo della teologia contemporanea. Anzi, aveva ragione il teologo Heinz R. Schiette quando, già nel 1963, nel suo saggio Le religioni come tema della teologia osservava che «ci si trova di fronte a un terreno dogmaticamente nuovo, paragonabile alle zone in bianco degli antichi atlanti».
Al tradizionale paradigma dell’ “esclusivismo” (extra ecclesiam nulla salus) si è sostituito quello dell’ “inclusivismo”, suggerito soprattutto dal famoso teologo tedesco Karl Rahner, mentre il Concilio Vaticano II ha dato impulso «al dialogo e alla collaborazione dei cristiani coi seguaci delle altre religioni» (Nostra Aetate 2), così come si sono tentate mediazioni ulteriori tra i due paradigmi citati attraverso la proposta di un cristianesimo "relazionale".
Si è, però, corso anche il rischio di procedere verso la deriva di un pluralismo che in pratica faceva perdere l’identità alla teologia cristiana stingendone, se non estinguendone, il volto proprio. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto paradigma "geocentrico" proposto dal teologo presbiteriano britannico John Hick nelle sue opere Dio e l’universo delle fedi (1973) e Dio ha molti nomi (198o), destinato a cancellare la speciticità cristologica. In sede meno teorica e più etico-politica - e, quindi, con minore assertività - si è mosso anche il noto Progetto per un’etica mondiale, elaborato nel1990 da Hans Küng (in italiano fu tradotto da Rizzoli nel 2001) e adottato dal "Parlamento delle religioni" di Chicago nel 1993: esso si basava su un consenso morale minimo verso cui le grandi tradizioni culturali e religiose dovevano convergere per essere al servizio dell’humanum, così da creare un mondo «giusto, pacifico e sostenibile».
È significativo notare che Küng rimandava proprio a Lessing, affermando che la bontà o meno di una religione, e quindi la sua "verità", dipende dalla sua promozione autentica della dignità dell’uomo e del bene comune.
Se è vero che il fondamentalismo etnocentrico e integralistico è la negazione esplicita del dialogo interreligioso e dell’ecumenismo, lo sono però anche le forme di sincretismo e relativismo, che più facilmente tentano civiltà stanche e divenute meno identitarie come quelle occidentali.
Anche questo atteggiamento - come quello che propone vaghe religioni "unitarie" su pallidi e inoffensivi denominatori comuni (ne sono esempi le tesi dello storico inglese Arnold Toynbee o del pensatore indiano Vivekananda) - si oppone al vero dialogo. Esso, infatti, suppone nei due soggetti un confronto di identità e di valori, certo per un arricchimento reciproco, ma non per una dissoluzione in una generica confusione o in un appiattimento.
Come l’eccesso di affermazione identitaria può diventare duello non soltanto teorico, ma anche armato, così il concordismo generico può degenerare in un incolore uniformismo o in una "con-fusione" relativistica. Conservare l’armonia della diversità nel dialogo e nell’incontro, come accade nel duetto musicale (che crea armonia pur nella radicale differenza dei timbri di un basso e di un soprano), è la meta di una genuina e feconda esperienza multiculturale, interculturale e interreligiosa.
Lestingi è, comunque, convinto che Lessing «non abbia mai voluto sfilarsi di dosso il cristianesimo come una vecchia tunica logorata, ma ha inteso interpretarlo in maniera nuova e ardita facendogli fare un salto in avanti». Un salto, però, piuttosto rischioso che ha sotto di sé anche il vuoto di uno smarrimento della specificità e dell’autenticità teologica.
Gotthold Ephraim Lessing, «Nathan il saggio», a cura di Leo Lestingi, Palomar, Bari, (via Nicolai, 47), pagg. 246, € 24,00.
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- AL DI LA’ DEL PANTANO "NOSTRUM". RILEGGERE FREUD E "L’UOMO MOSE’ E LA RELIGIONE MONOTEISTICA".23 aprile 2010, di Federico La Sala
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- Laici e sacerdoti oggi (di Luigi Bettazzi).25 aprile 2010, di Federico La Sala
Laici e sacerdoti oggi
di Luigi Bettazzi (L’Osservatore Romano, 25 aprile 2010)
Quando si parla di "vocazione", nella Chiesa si intende normalmente la chiamata (in latino vocatio) al sacerdozio, o, quasi per affinità, la chiamata alla vita religiosa. E questo corrisponde alla mentalità diffusa che i sacerdoti sono l’espressione tipica, qualificata, della Chiesa. Lo si vede oggi anche dal clamore che si fa come sfida alla Chiesa per le mancanze di suoi sacerdoti. V’è quasi l’idea che "la Chiesa sono i preti" (tanto più i vescovi), mentre la massa dei fedeli costituirebbe l’insieme dei beneficiari dell’azione (magisteriale e ministeriale) della gerarchia.
Ora, è vero che la gerarchia è indispensabile per la garanzia della vita della Chiesa, per la certezza della dottrina e l’efficacia della trasmissione della grazia; e per questo dobbiamo pregare perché il Signore chiami tanti alla vita sacerdotale (e religiosa) e perché chi vi è chiamato risponda con generosità.
Tutto questo però poneva la condizione del clero su di un livello di superiorità, che si traduceva poi in una specie di promozione o di difesa di "casta". Forse certi silenzi e coperture di cui si parla anche oggi corrispondono a questo atteggiamento di difesa e di riguardi, evidente anche nella espressione che si usava per il sacerdote che lasciava la sua condizione e che veniva "ridotto allo stato laicale". Il concilio Vaticano II ha richiamato una verità che è tipica della Rivelazione, che nel Nuovo Testamento parla di Gesù come l’unico mediatore tra Dio e l’umanità, il sommo ed eterno sacerdote. Se ogni cristiano, col battesimo, viene inserito in Gesù Cristo, morto e risorto, dobbiamo concludere che ogni cristiano è sacerdote, portatore del divino nel mondo e consacratore della realtà creata. Perché questo si realizzi, e in modo sempre più pieno, ci sarà bisogno di un sacerdozio ministeriale, continuatore ed estensore del ministero degli Apostoli, ma l’efficacia della loro funzione sarà proporzionale alla comprensione e alla dedizione del loro servizio (in latino ministerium).
Questa precisione di visuale è sollecitata dall’impostazione stessa che i Padri conciliari hanno voluto per la costituzione sulla Chiesa (la Lumen gentium): mentre la prima stesura dopo una riflessione sulla natura della Chiesa affrontava il tema della gerarchia e al terzo posto quello dei fedeli laici, i vescovi del concilio hanno voluto che, dopo la trattazione sulla natura della Chiesa (come "mistero" che attinge la Santissima Trinità) si parlasse invece dell’intero popolo di Dio, e al terzo posto della gerarchia, che è appunto al servizio del popolo di Dio. È così che il "magistero" dovrà sentirsi in funzione non solo o non tanto dell’esattezza delle formule dogmatiche quanto della "profezia" dei cristiani, della loro comprensione della Parola di Dio e della loro coerenza nel viverla, come ci è stato raccomandato dalla costituzione Dei Verbum. E il sacerdozio ministeriale non dovrà solo guardare alla solennità e all’esattezza della liturgia, ma dovrà preoccuparsi che essa diventi realmente la preghiera vissuta della gente, "culmine e sorgente della vita cristiana", come dice la costituzione sulla liturgia (Sacrosanctum Concilium). Questo farà sì che la gerarchia colga sempre più l’invito conciliare alla "collegialità" che, se si esprime compiutamente nella collaborazione dei vescovi col Papa e dei vescovi tra di loro, si ritrova a ogni livello della Chiesa nello spirito e nella prassi della "comunione". La costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (la Gaudium et spes) ci invita peraltro a considerare quanti "semi del Verbo" ci sono nel mondo, quanta diffusione di grazia ci sia nel creato anche al di fuori delle strutture ecclesiali.
La presenza di dialogo e di confronto col "mondo" qualifica la "vocazione" dei cristiani laici, a cui il battesimo affida il compito di lievitare la società e l’intera umanità verso il "regno di Dio", cioè verso un mondo di coscienza e di amore quale Dio lo vuole. E questo qualifica anche la "vocazione presbiterale" in ordine a una missione aperta e fiduciosa, che valuti il primato delle persone sulle strutture (pure indispensabili nella loro funzionalità), e che dia la priorità - come fece Gesù - non ai vertici sociali, ai notabili, fossero anche quelli esteriormente più in vista (com’erano allora i farisei e i dottori della Legge), bensì ai piccoli, ai poveri, ai sofferenti, agli emarginati. Con felice intuizione la Conferenza episcopale italiana, nel 1981, affermava che bisogna "partire dagli ultimi".
Tutto questo non attenua l’impegno di santificazione dei presbiteri. Al contrario, se una guida autoritaria, fatta in prevalenza di comandi, si basa sul valore delle cose comandate e sulla prevalenza del comando, una guida autorevole, basata cioè sulla persuasione e sull’esempio, esige in chi guida "un supplemento di umanità e di santità".
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- A Barcellona, il 7 e l’8 giugno 2010, un vertice dell’Unione per il Mediterraneo. “L’idea mediterranea include l’islam”. Intervista a Henry Laurens*, a cura di Jean-Christophe Ploquin7 maggio 2010, di Federico La Sala
“L’idea mediterranea include l’islam”
 intervista a Henry Laurens*, a cura di Jean-Christophe Ploquin
intervista a Henry Laurens*, a cura di Jean-Christophe Ploquin
 in “La Croix” del 7 maggio 2010
in “La Croix” del 7 maggio 2010
 (traduzione: www.finesettimana.org)
(traduzione: www.finesettimana.org)Un vertice dell’Unione per il Mediterraneo si terrà il 7 e l’8 giugno a Barcellona. Da quanto il mar Mediterraneo è percepito come un elemento che unisce?
È una delle idee tardive, apparsa nella seconda metà del XIX secolo. A lungo, il nome Mediterraneo è stato applicato solo allo spazio occidentale. Nelle lingue arabe si parlava di Mare Bianco, in opposizione al Mar Nero. Lo si chiamava anche il mare dei Roums, dei Romani, termine che indicava i Bizantini. In Europa, per indicare l’est del Mediterraneo si parlava del Levante, che cominciava dall’Adriatico, e della Barbarie per designare il Maghreb. Con le indipendenze balcaniche e la conquista francese nell’Africa del Nord, queste nozioni hanno perso importanza e si sono imposte delle rappresentazioni nuove, in particolare quella della latinità.
Di che cosa si trattava?
Questo discorso è apparso, da un lato, come reazione all’affermazione abbastanza trionfante della germanità, in una concorrenza intraeuropea per attribuirsi l’eredità greco-romana; dall’altro, come giustificazione della colonizzazione nell’Africa del Nord. È l’epoca in cui si riscoprono dei siti archeologici dell’antichità sul perimetro mediterraneo. La latinità permette di affermare, in qualche modo, che gli europei non sono stranieri e che semplicemente riconquistano una terra. Napoleone III dirà agli arabi dell’Algeria: “Voi siete i nostri Galli, noi siamo i vostri Romani.”
Quando s’impone l’idea di Mediterraneo?
Segue l’emancipazione delle popolazioni del Mediterraneo orientale e la perdita del monopolio della modernità da parte dell’Europa. Quando gli arabi cessano di essere orientali, diventano mediterranei. Ci sarà anche una corrente che difende l’idea mediterranea come protesta contro l’America, la cui società tecnologica spaventa.
Qual è il futuro dell’Unione per il Mediterraneo, che sembra già prigioniera del conflitto israelo-palestinese?
Ci sono due problemi. Quello di Israele e quello della penisola arabica. I paesi del Golfo Persico sono come l’Europa del Nord: non giungono alle sue rive, ma appartengono al secondo cerchio del Mediterraneo. Sono presenti finanziariamente ovunque su entrambe le sponde e sono una potente pompa aspirante di manodopera mediterranea. La mia visione personale è che l’Unione per il Mediterraneo dovrebbe includere i paesi del Golfo ed escludere Israele, che invece potrebbe beneficiare di un partenariato privilegiato con un livello di partecipazione più alto negli organismi europei. Bisogna accettare il fatto che questo paese è ancora incapace di integrarsi regionalmente nel Medio Oriente e che rischia di restarlo a lungo.
Come articolare l’Unione per il Mediterraneo e l’Unione Europea?
L’ambizione mediterranea dell’Unione Europea parte da una realtà semplice: per la prima volta dalla fine dell’Impero romano, tutta la riva nord si sta unificando. L’Unione Europea è un impero per consenso, che crea un immenso scarto di potenza e di ricchezza tra le due rive del Mediterraneo. Questo squilibrio deve essere affrontato, ma il modo di farlo dipenderà dalla sorte riservata alla Turchia. Sarà nell’Unione Europea o fuori? Questo dipenderà da come si definisce l’UE. Geograficamente, l’Europa non ha senso: c’è l’Eurasia, punto e basta! Culturalmente, gli ideologi fanno ancora finta di credere che l’Europa si definirebbe con una sequenza che parte dall’eredità greco-romana, i barbari, poi gli strati del Medio Evo, del Rinascimento, del barocco, del classicismo, dell’illuminismo, del romanticismo... Ma questa sequenza è stata interrotta con l’entrata della Grecia, quella della Bulgaria e, domani, quella della Serbia... Questi popoli, infatti, si sono uniti al concerto europeo solo con il romanticismo. Prima, facevano parte dell’Impero Ottomano. Ciò depone a favore di una definizione di Europa come una patria di cittadini. Allora, si potrebbe accettare la Turchia. E, sul lungo periodo, ciò vorrebbe dire che nel 2070 tutto il Mediterraneo potrebbe essere nell’Unione!
Come sarebbe?
Attenendosi, per l’adesione, a dei criteri democratici e di cittadinanza, si aprirà la possibilità di una Unione euro-mediterranea. Invece, se bloccheremo l’entrata della Turchia, fisseremo l’Unione Europea a Nord. Questa è la vera posta in gioco. Il futuro è aperto: l’Unione Europea può essere o una tappa, o un punto d’arresto.
Oggi è assolutamente impensabile. Gli europei temono i flussi migratori che arrivano dal Sud.
Sì, ma il serbatoio si sta per prosciugare. Nel 2050 0 nel 2070, la struttura demografica dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia sarà dello stesso tipo di quella europea. Già oggi, la natalità francese è superiore alla natalità tunisina. Nei fatti, il Maghreb diventa la linea di confine, il “limes” europeo.
La religione non è un fattore bloccante?
Non appare come un elemento che unisce. Una delle ragioni è il concetto identitario di giudeocristianesimo. È un concetto che è comparso come una reazione estremamente positiva alla Shoah, quando le Chiese cristiane hanno detto che l’antisemitismo era un abominio e hanno affermato la loro fraternità con gli ebrei. Purtroppo, affermare oggi una civiltà giudeo-cristiana viene inteso come una logica di esclusione da parte dei musulmani. Al contrario, l’idea mediterranea include l’islam, che è uno degli eredi della cultura greca. Quanto alla bagarre sul velo, sul burqa, sull’apparenza, sul corpo vi è in tutto questo un problema estremamente complesso, che riguarda tutti e tre i grandi monoteismi, che è il rapporto tra il religioso e il femminile. La modernità pare loro incontrollata nella questione del corpo femminile e in quella della procreazione. Oggi, la laicità rinvia alla questione femminile e non, come prima, al rapporto con la politica.
* Henry Laurens è storico, professore al Collège de France
-
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE --- MOSE’, GESU’, MAOMETTO: TRE ANELLI? NO, TRE IMPOSTORI. La favolosa storia del trattato sui profeti bugiardi (di Adriano Prosperi).30 gennaio 2010, di Federico La Sala
Il libro maledetto
La favolosa storia del trattato sui profeti bugiardi
Minois ripercorre la leggenda del celebre testo su Gesù, Mosè e Maometto Un’opera contro la religione, prima immaginata poi scritta per davvero
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 30.01.2010)
Questa è la storia di un libro maledetto e desiderato, temuto e accanitamente ricercato: un libro che prima di diventare reale fu piuttosto una fantasia, una testa senza corpo, un embrione di libro. All’inizio ci fu un’idea, un titolo: i tre impostori. Ma che titolo: i tre impostori erano Mosé, Gesù Cristo e Maometto. E l’idea era quella di attribuire l’origine delle tre religioni monoteistiche mediterranee all’impostura dei fondatori. Come quell’embrione sia nato e si sia sviluppato lo racconta Georges Minois (Il libro maledetto. La storia straordinaria del Trattato dei tre profeti impostori, Rizzoli, traduzione di Sara Arena, pagg. 320, euro 17,50).
Minois è uno storico abituato a scavare nei sedimenti dell’immaginario religioso. Sue sono tra l’altro una storia del diavolo e una storia dell’inferno. Lo zolfo d’inferno circola anche in questa storia. Da lì affiorano le ombre di Federico II di Svevia e del suo ministro Pier delle Vigne, convinti - secondo l’accusa di papa Gregorio IX (1239) - che il mondo intero fosse stato ingannato da tre impostori, Gesù Cristo, Mosé e Maometto.
In quell’inferno la tradizione cristiana collocò anche Averroè. A lui, un infedele e dunque un comodo capro espiatorio, fu attribuita la tesi che le tre religioni monoteistiche fossero state fondate da tre imbroglioni. L’idea che la storia dell’uomo e del mondo raccontata dalle tre religioni fosse frutto di un’abile mistificazione poteva nascere solo in quel bacino del Mediterraneo dove tre monoteismi si scontravano con l’insanabile odio di un rapporto fraterno.
Ma perché si pensasse alla religione come impostura e inganno deliberato era stato necessario il contributo dell’intelligenza greca e della sapienza politica romana. Erodoto aveva raccontato l’inganno di un fondatore di religione, lo schiavo trace di Pitagora, Salmoxis. E Tito Livio aveva descritto i finti convegni notturni di Numa Pompilio con la ninfa Egeria. Il poema di Lucrezio aveva accusato la religione di fondarsi sulla paura. E fu dalla lettura di Lucrezio e di Tito Livio e dall’esperienza dei tempi suoi che Niccolò Machiavelli ricavò le sue osservazioni sulla funzione della religione per il potere politico e per la forza dello stato.
Intanto con le scoperte geografiche la comparazione tra religioni si allargava a scala mondiale; e con la comparazione si sviluppava la capacità di critica e di relativizzazione e la tendenza a considerare la religione - ogni religione - una creazione umana, modellabile con la forza e con l’astuzia. E il libro dei tre impostori? La convinzione della sua esistenza condivideva con la fede in Dio delle religioni positive un carattere comune: era sostanza di cose sperate, terrore di cose temute. Finché a un certo punto ci fu chi lo scrisse davvero. Ma tutta questa storia, dalla lunghissima gestazione alla nascita, ha ancora lati oscuri e passaggi incerti su cui si affaticano gli studiosi: il che contribuisce a conferirle il fascino che appartiene alle cose nascoste, ai sogni e alle immaginazioni.
La violenza dei dispositivi di chiese e stati obbligava al nascondimento e nello stesso tempo aggiungeva forza di argomenti a chi parlava di impostura. Fu allora che la figura dell’ateo cessò di essere uno spauracchio apologetico e prese corpo e caratteri moderni. E fu con gli apporti dei libertini eruditi, di Hobbes e soprattutto di Spinoza che venne lievitando l’idea centrale di quel libro: che intanto, detestato e ricercato, dichiarato esistente senza essere visto, restava come avvolto nell’alone di quella che era la sua materia: l’impostura. Quando prese corpo in stampe e non in una ma in più versioni, una in latino e una in francese, fu per opera delle correnti dell’Illuminismo radicale, decise a voltar pagina rispetto a una cultura elitaria che non riteneva il popolo capace di tollerare la verità.
La versione su cui giustamente Minois si concentra comparve all’Aia nel 1719 dall’editore Levier. E il lettore curioso potrà verificare sull’eccellente edizione che del testo da lei scoperto ha pubblicato Silvia Berti (Trattato dei tre impostori, Einaudi, 1994) se è vero, come scrive Minois, che quel trattato è deludente: di più, se è vero che all’epoca in cui comparve avesse perduto la sua forza dirompente.
Una cosa è certa: non c’è l’inferno in quelle pagine, non vi sono le sulfuree empietà su cui avevano speculato trafficanti e stampatori. Al loro posto c’è una ferma fiducia nella retta ragione, «la sola luce che l’uomo deve seguire». E c’è in più un salto rivoluzionario rispetto ai tempi delle cabale segrete e dei libertini eruditi: la convinzione «che il popolo non è così incapace di fare uso /della ragione / come si cerca di fargli credere». Era finita un’epoca, un’altra cominciava che ancora non è finita.
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. ---- Relativismo, una maschera del nulla (di Claudio Magris - su Giorello, Antiseri, e Perlini).12 dicembre 2008, di Federico La Sala
 Filosofia e religione non possono rinunciare alla ricerca della verità: ma in democrazia nessuno può vantarsi di possederla
Filosofia e religione non possono rinunciare alla ricerca della verità: ma in democrazia nessuno può vantarsi di possederla
 Un libro del credente Antiseri e dell’ateo Giorello
Un libro del credente Antiseri e dell’ateo GiorelloRelativismo, una maschera del nulla
Oggi l’«incultura dell’optional» mette tutto sullo stesso piano, dalla pornografia alla fede
di Claudio Magris (Corriere della Sera 12.12.2008)
In una delle sue ultime interviste, Horkheimer - fondatore, con Adorno, di quella Scuola di Francoforte che, col suo marxismo critico e autocritico, è tuttora fondamentale per capire la nostra realtà - dice che il mondo finito e contingente in cui viviamo è l’unico di cui possiamo parlare, ma non è necessariamente l’unico esistente e comunque non basta. Esso è l’unico oggetto di una onesta conoscenza razionale, ma la sua finitezza evoca quell’inattingibile altrove, quell’irriducibile Altro che danno senso al nostro confronto con esso, con le sue mancanze che chiedono di essere colmate, con le sue ferite che domandano di essere sanate, con le sue esigenze di giustizia e di felicità sempre deluse eppur mai cancellate.
Per la tradizione ebraica, che nutre il pensiero di Horkheimer, il Messia non è ancora venuto, ma anche chi ritiene che non verrà non può comprendere veramente la realtà umana senza fare i conti con il senso e con l’esigenza di quell’attesa, di quella promessa di redenzione. Ogni filosofia che rinuncia a essere ricerca della verità e del significato si riduce a un mero protocollo di un bilancio societario; d’altronde un pensiero che pretenda di essersi impossessato della verità come ci si impossessa di un oggetto o della formula di un esperimento è una retorica menzognera.
Di Dio, dicono tutti i grandi mistici, non si può dire nulla, perché lo si degraderebbe a misura umana, bestemmiando la sua assolutezza; si può solo sentirsi avvolti dalla sua oscurità, mentre ci si occupa onestamente delle singole cose che si possono vedere.
Quelle parole di Horkheimer, alieno da qualsiasi fede positiva, indicano come la fede, contrariamente a ciò che spesso si dice, non sia un ombrello che ripara da dubbi e incertezze, bensì un violento squarcio del consueto sipario quotidiano che ci protegge con tutte le convinzioni e le convenzioni passivamente acquisite, uno squarcio che ci espone a venti ignoti. Gesù o Buddha non sono venuti a fondare una religione, perché già allora ce n’erano troppe, bensì a cambiare la vita, con tutto il rischio e lo smarrimento che ciò comporta e che Gesù ha provato nel Getsemani; secondo le sue parole, solo chi è disposto a perdere la propria vita la salverà e perdere la vita - ossia tutto il suo corredo di convinzioni, abitudini, valori, legami, buoni sentimenti e comportamenti assennati - significa non sapere a cosa si va incontro.
Nel suo dialogo con Giulio Giorello - Libertà. Un manifesto per credenti e non credenti - Dario Antiseri ha sottolineato come la fede, proprio perché afferma di credere in una verità e non di sapere cosa sia la verità, si offre al dialogo senza la pretesa di possedere la chiave dell’assoluto. Inoltre la fede, a differenza di tante ideologie, impedisce di innalzare falsamente ad assoluto qualsiasi realtà umana, storica, sociale, politica, morale, religiosa, ecclesiastica; essa è una difesa contro ogni idolatria e dunque contro ogni totalitarismo, che si presenta sempre come un (falso) assoluto, un idolo che esige cieca obbedienza e magari sacrifici di sangue.
Come Giorello, ammiro più la preghiera a schiena diritta che quella in ginocchio, ma inginocchiarsi solo dinanzi all’assolutamente Altro aiuta a non inginocchiarsi davanti a ogni potere che pretende di essere Dio o il suo unico autorizzato rappresentante e di parlare a suo nome. I fondamentalismi di ogni genere - anche e soprattutto quelli religiosi, di ogni religione e di ogni Chiesa, nessuna esclusa - sono spesso i primi a commettere questo peccato di blasfema e violenta idolatria.
Il dialogo fra Giorello e Antiseri è nato anche dalle ripetute condanne del relativismo pronunciate da Benedetto XVI e dalle polemiche da esse provocate.
Un intenso approfondimento di questa tematica, inteso a sfatare da posizioni laiche la fallace identificazione del relativismo col pluralismo e con la libertà, è costituito dal volume Verità relativismo relatività (ed. Quodlibet), curato da Tito Perlini, autore dell’affascinante saggio che lo apre.
Interprete e seguace del marxismo critico della Scuola di Francoforte, sulla quale ha scritto pagine fondamentali, figura intellettuale di rilievo nella sinistra minoritaria italiana e aperto a quell’«assolutamente Altro» di cui parlava Horkheimer, Perlini è una delle intelligenze che hanno capito più a fondo le trasformazioni epocali degli ultimi decenni.
Pago di capire, pronto a prendere atto con tranquillo disincanto del fallimento di molte sue aspettative politiche, riluttante ad apparire (non per sdegnosa o schiva riservatezza, bensì piuttosto per sana ancorché esagerata pigrizia), Perlini è stato sempre restio a ridurre i suoi acutissimi e torrenziali saggi, sin dalla sua voluminosa tesi di laurea sul Doktor Faustus, che ben più di mezzo secolo fa sfondò lo zaino in cui l’aveva messa il suo maestro Guido Devescovi, l’amico e compagno di classe di Scipio Slataper, per portarsela a leggere in montagna.
Nel suo saggio, Perlini combatte il rifiuto dell’idea di verità e della sua ricerca, che da Nietzsche in poi domina il pensiero occidentale. Benedetto XVI, condannando il relativismo sul piano etico e teoretico, ne riconosce la validità sul piano politico quale fondamento della democrazia, basata sul presupposto che nessuno possa pretendere di conoscere e tanto meno di imporre la strada giusta. Certamente più democratico di Benedetto XVI, Perlini è tuttavia ben più radicale nella critica non della democrazia, in cui crede, bensì della sua attuale degenerazione: una politica che ha abdicato a ogni visione del mondo e si è ridotta a mera gestione - talora a indebita appropriazione - dell’esistente, declassando la democrazia a «dittatura dell’opinione pubblica manipolata che legittima ogni forma di demagogia posta al servizio degli interessi dominanti sul piano economico e finanziario».
È un ritratto perfetto dell’Italia di oggi. Alle classi tradizionali è subentrato un gelatinoso «ceto medio» che non ha nulla della classica borghesia e che produce e consuma - scrive Perlini riprendendo un’osservazione di Goffredo Fofi - una colloidale «cultura media» che avviluppa come un chewing gum i giornali, l’università, la televisione, l’editoria, il dibattito intellettuale, livellando ed equiparando tutti i valori in una melassa sostanzialmente uniforme e facilmente digeribile, che smussa ogni reale contraddizione e scarta o disarma ogni elemento capace di mettere realmente in discussione l’ordine imperante - ogni scandalo e follia della croce, per citare il Vangelo.
Questa medietà non è la modesta e onesta tappa in cui quasi tutti noi mediocri siamo ovviamente costretti a fermarci nel cammino verso l’alto, ma è la totalitaria eliminazione di ogni tensione fra l’alto e il basso, l’ordine e il caos, la vita e la morte, il senso e il nulla. Il relativismo è il presupposto di questa (in) cultura dell’optional, che ammannisce un po’ di tutto mettendo tutto insieme sullo stesso piano e sullo stesso piatto, pornografia e prediche sui valori familiari, fumisterie esoteriche e pacchiane superstizioni, un etto di cristianesimo e un assaggio di buddhismo, volgarità plebea e volgarità pseudoaristocratica di spregiatori delle masse graditi a quest’ultime, Madonne di gesso che piangono e veline che discutono con filosofi, abbronzature di famosi su belle isole e pii cadaveri dissotterrati e messi impudicamente in mostra.
Questo relativismo, in cui tutto è interscambiabile, non ha niente a che vedere col rispetto laico dei diversi valori altrui accompagnato dal fermo proposito di contestarli rispettosamente ma duramente in nome dei propri; è il trionfo dell’indifferenza, collante di una solidale e inscalfibile egemonia. Così il relativista, scrive Perlini, è intollerante verso ogni ricerca di verità, in cui vede un pericolo per la propria piatta sicurezza, che egli si convince sia l’esercizio della ragione.
L’autentico illuminismo, fondamento della nostra civiltà inviso ai fondamentalisti clericali e anticlericali, è quello espresso da Lessing nella sua famosa parabola dei tre anelli: nessuno sa quale sia quello vero, perché l’occhio umano non può distinguerlo, ma si sa che uno è vero, che c’è la verità e che vivere significa cercarla pur sapendo di non poter mai esser certi di averla raggiunta. Il relativismo - scrive Perlini - è uno stimolo salutare all’interno della ricerca della verità, per impedire che essa si snaturi, come è avvenuto e avviene spesso, nell’intollerante dogmatismo.
Altrimenti il relativismo è l’altra faccia del fondamentalismo sicuro di sé, poca importa se trionfalmente ateistico o trionfalmente bigotto, muro di supponenza che un io debole e timoroso della vita si costruisce per tenerla lontana. Finché c’è il muro, il timore dei fantasmi è forte. Ma come dice la vecchia storia? «La paura bussa alla porta. La fede va ad aprire. Fuori non c’è nessuno».
*
 «Verità relativismo relatività» (Quodlibet, pp. 224, e 18) è il titolo dell’ultimo fascicolo, curato da Tito Perlini, dell’«Ospite ingrato», rivista del Centro studi Franco Fortini.
«Verità relativismo relatività» (Quodlibet, pp. 224, e 18) è il titolo dell’ultimo fascicolo, curato da Tito Perlini, dell’«Ospite ingrato», rivista del Centro studi Franco Fortini. Il libro di Dario Antiseri e Giulio Giorello «Libertà. Un manifesto per credenti e non credenti» (pp. 180, e 17) è edito da Bompiani.
Il libro di Dario Antiseri e Giulio Giorello «Libertà. Un manifesto per credenti e non credenti» (pp. 180, e 17) è edito da Bompiani. -
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. Per i ‘Settanta’ di VATTIMO: 1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA A SILVANA MANSIO (CS) - ---- Gerusalemme. La città dove tutti dicono «io qui sono nato» e che non è rimasta, nello scorrere dei secoli, esclusiva di una sola religione. Ebraismo, cristianesimo e islam oggi vi coesistono: sono tutti radicati in lei. La città di Dio è come Dio: per tutti. Nessuno può avere Dio in esclusiva, nessuno può avere la città di Dio in esclusiva e privarne l’altro. Gerusalemme è la dimora di Dio, aperta a tutti; è la dimora dello Spirito, sorgente di santità e di dignità per ogni persona (di Michel Sabbah, patriarca latino di Gerusalemme).13 febbraio 2008, di Maria Paola Falqui
Il patriarca latino di Gerusalemme, Michel Sabbah, rilancia il dialogo: «Oggi è la città di due popoli: tutti e due devono poter viverci con gli stessi doveri e gli stessi diritti»
Terra Santa, la pace è possibile
«Palestinesi e israeliani sono chiamati a questa responsabilità davanti a Dio: devono sforzarsi di trovare uno statuto speciale che rispetti le speranze dei due popoli e delle tre religioni»
DI MICHEL SABBAH (Avvenire, 13.02.2008) *
Ci domandiamo oggi se la pace è possibile in Terra Santa. In concreto ci sono segni di speranza, ma soprattutto sembrano prevalere paure, esitazioni, oppressioni e instabilità. E le sofferenze continuano. Costruire la pace in Terra Santa, come ovunque, è impresa sempre più difficile.
Numerosi sono i conflitti nel mondo in cui la violenza, il disprezzo della persona umana e dell’immagine di Dio nell’uomo sono praticati non solo da individui, ma da gruppi e a volte da governi responsabili. La pace in Medio Oriente sarà certamente frutto di accordi tra capi di governo e responsabili politici; ma prima di tutto coinvolgerà nel profondo i rapporti tra le comunità e tra i singoli. Ogni palestinese e ogni israeliano dovranno vedere nell’altro non più un nemico da odiare e da combattere, ma un fratello e un amico con cui costruire finalmente le nuove società palestinese e israeliana. La pace in Medio Oriente comincia a Gerusalemme.
Qui si manifesta il più profondo mistero di Dio per la storia dell’umanità: ha scelto questa città per raggiungere, attraverso il popolo eletto, tutti i popoli della terra. Gerusalemme: città in cui la fede in Dio unisce popoli e nazioni e città in cui i credenti, in nome di Dio, lungo i secoli e fino a oggi, si sono posti in conflitto. Città della riconciliazione, sorgente di pace per i pellegrini che la raggiungono, ma deserto di divisione per i suoi abitanti. La città dove tutti dicono «io qui sono nato» e che non è rimasta, nello scorrere dei secoli, esclusiva di una sola religione. Ebraismo, cristianesimo e islam oggi vi coesistono: sono tutti radicati in lei. La città di Dio è come Dio: per tutti. Nessuno può avere Dio in esclusiva, nessuno può avere la città di Dio in esclusiva e privarne l’altro. Gerusalemme è la dimora di Dio, aperta a tutti; è la dimora dello Spirito, sorgente di santità e di dignità per ogni persona.
Gerusalemme era ed è ancora il centro dell’ebraismo: era ed è il centro del cristianesimo. Dal sesto secolo fu per l’islam la «santa» città, il «santuario di Dio». Oggi, come nel passato, ci sono credenti, ebrei, musulmani e cristiani, amati da Dio di un amore speciale, che in questa terra, al di là delle divisioni e dei conflitti quotidiani, sono uniti nell’intimità della preghiera. Per loro intercessione Dio non permette che maggiori mali cadano su Gerusalemme. Altri credenti, e sono sfortunatamente la maggioranza, danno rilievo all’espressione esterna della loro fede, accentuando le differenze religiose che sono conseguentemente sfruttate da ambizioni e interessi umani.
Ogni giorno viviamo nei nostri cuori e nei nostri corpi la tragedia della divisione, dell’odio e della morte. La città della riconciliazione, la città di Dio, appare tragicamente lontana da Dio. Gerusalemme ha bisogno di pace e di riconciliazione, come d’altronde tutta le regione. Oggi Gerusalemme è la città di due popoli: tutti e due devono poter viverci con gli stessi doveri e gli stessi diritti. La Gerusalemme palestinese deve essere realmente palestinese, e l’israeliana israeliana. È una grande responsabilità amministrare la città di Dio rispettandone il Suo disegno, cioè con lo stesso amore e la stessa giustizia per tutti i suoi figli. Perciò palestinesi e israeliani, oggi chiamati a questa responsabilità davanti a Dio, devono sforzarsi di trovarle uno statuto speciale che rispetti le speranze dei due popoli e delle tre religioni presenti.
Gerusalemme è la chiave della pace nella regione e ogni soluzione imposta con la forza, che non rispetti i diritti e i doveri di tutti, può portare solo a una tregua, ma non a una pace definitiva. Una soluzione ingiusta o imposta rimarrà una minaccia permanente alla pace.
Soltanto la via della giustizia può condurre alla pace. Con la violenza si può vincere una guerra o una battaglia. Uno Stato può essere creato con la forza, ma la pace no. La realtà che stiamo vivendo in Terra Santa lo prova: con la forza Israele ha vinto battaglie e guerre ed ha creato uno Stato. Ma la ricerca della pace con i palestinesi non è ancora finita. Il dialogo tra le parti coinvolte è l’unica via, purché gli accordi non rimangano mere firme sulla carta.
Vedremo la vera vittoria solo quando avremo giustizia per tutti. Io, vescovo in questa Terra Santa e martoriata, chiedo una pace che garantisca tutti i diritti a tutte le parti in conflitto.
Desidero una pace che sia in grado di garantire la sicurezza ai palestinesi, agli israeliani e a tutti i popoli della regione; una pace che rispetti la dignità, la libertà, la sovranità e i diritti di ogni persona e di ogni popolo.
Bisogna riconoscere che la religione, in questa parte del mondo, ha una grande responsabilità nella ricerca della giustizia e della pace: è anzitutto la fede nell’unico Dio creatore e nell’amore per tutte le sue creature. Evidentemente questo amore deve conciliarsi con il diritto di difendersi e di difendere la dignità di ogni persona, nonché con il rifiuto di ogni forma di oppressione e di ingiustizia. In Oriente la religione compenetra e anima tutte le attività private e pubbliche. Tutto viene posto sotto il nome di Dio.
Tutto incomincia e finisce nel suo nome: la guerra, come la pace.
Perciò i leader religiosi possono avere un’influenza decisiva sui fedeli, in un senso come nell’altro: possono incitare alla guerra e alla violenza o esortare alla pace. Purtroppo, in nome di Dio, gli uomini hanno causato nel corso della storia molte guerre e conflitti. Oggi, in nome di una fede meglio compresa e meglio vissuta, i leader religiosi hanno la responsabilità di cambiare il comportamento dei fedeli, di aprire una nuova via che conduca il mondo verso la pace, per testimoniare l’appello di Dio all’umanità: Dio è creatore di tutti e vuole il bene di tutti.
*
L’ANTICIPAZIONE
Nato a Nazaret nel 1933, Michel Sabbah (nella foto) è il primo palestinese a essere nominato, nel 1987, patriarca latino di Gerusalemme. Ordinato sacerdote nel 1955 e conseguita la laurea in Filologia della lingua araba a Beirut, ha ottenuto il dottorato in Filosofia alla Sorbona di Parigi ed è stato preside dell’Università di Betlemme.
Presidente della Conferenza episcopale dei vescovi latini della regione araba, dal 1999 al 2007 è stato anche presidente di Pax Christi International. Deciso fautore del dialogo fra le religioni, è una figura di spicco nelle relazioni interreligiose con gli ebrei e i musulmani della Terra Serra. Un impegno ribadito nel volume «Voce che grida dal deserto», del quale anticipiamo qui uno stralcio, curato da Nandino Capovilla e presentato dal cardinale Carlo Maria Martini (Paoline, pagine 138, euro 11,00).
-
> MELCHISEDECH A SAN GIOVANNI IN FIORE, TRA I LARICI “PISANI”. --- Forum cattolico-musulmano - il testo della dichiarazione comune firmata a conclusione dell’incontro.7 novembre 2008, di Federico La Sala
Pubblichiamo in una nostra traduzione italiana il testo della dichiarazione comune firmata a conclusione dell’incontro del forum cattolico-musulmano. *
Il forum cattolico-musulmano è stato creato dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e da una Delegazione dei 138 firmatari musulmani della Lettera aperta intitolata Una Parola Comune, alla luce di tale documento e della risposta di Sua Santità Benedetto XVI tramite il suo segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone.
Il suo primo seminario si è svolto a Roma dal 4 al 6 novembre 2008. Sono intervenuti 24 partecipanti e cinque consiglieri di ciascuna delle due religioni. Il tema del seminario è stato "Amore di Dio, amore del prossimo". Il dibattito, condotto in un caldo spirito conviviale, si è concentrato su due grandi temi: "fondamenti teologici e spirituali", "dignità umana e rispetto reciproco".
Sono emersi punti di similitudine e di diversità che riflettono lo specifico genio distintivo delle due religioni.
1. Per i cristiani la fonte e l’esempio dell’amore di Dio e del prossimo è l’amore di Dio per suo Padre, per l’umanità e per ogni persona. "Dio è amore" (1 Giovanni, 4, 16) e "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna" (Giovanni, 3, 16). L’amore di Dio è posto nel cuore dell’uomo per mezzo dello Spirito Santo. È Dio che per primo ci ama permettendoci in tal modo di amarlo a nostra volta. L’amore non danneggia il prossimo nostro, piuttosto cerca di fare all’altro ciò che vorremmo fosse fatto a noi (cfr. 1 Corinzi, 13, 4-17). L’amore è il fondamento e la somma di tutti i comandamenti (cfr. Galati, 5, 14). L’amore del prossimo non si può separare dall’amore di Dio, perché è un’espressione del nostro amore verso Dio. Questo è il nuovo comandamento "che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati" (Giovanni, 15, 12). Radicato nell’amore sacrificale di Cristo, l’amore cristiano perdona e non esclude alcuno. Quindi include anche i propri nemici. Non dovrebbero essere solo parole, ma fatti (cfr. 1 Giovanni, 4, 18). Questo è il segno della sua autenticità.
Per i musulmani, come esposto nella lettera Una Parola Comune, l’amore è una forza trascendente e imperitura, che guida e trasforma il rispetto umano reciproco. Questo amore, come indicato dal Santo e amato profeta Maometto, precede l’amore umano per il Dio uno e trino. Un hadit mostra che la compassione amorevole di Dio per l’umanità è persino più grande di quella di una madre per il proprio figlio (Muslim, Bab al-Tawba: 21). Quindi esiste prima e indipendentemente dalla risposta umana dell’unico che è "amorevole". Questo amore e questa compassione sono così immensi che Dio è intervenuto per guidare e salvare l’umanità in modo perfetto, molte volte e in molti luoghi, inviando profeti e scritture. L’ultimo di questi libri, il Corano, ritrae un mondo di segni, un cosmo meraviglioso di maestria divina, che suscita il nostro amore e la nostra devozione assoluti affinché "coloro che credono hanno per Allah un amore ben più grande" (2: 165) e "in verità il Compassionevole concederà il suo amore a coloro che credono e compiono il bene" (19: 96). In un hadit leggiamo che "Nessuno di voi ha fede finquando non ama il suo prossimo come ama se stesso" (Bukhari, Bab al-Iman: 13).
2. La vita umana è un dono preziosissimo di Dio a ogni persona, dovrebbe essere quindi preservata e onorata in tutte le sue fasi.
3. La dignità umana deriva dal fatto che ogni persona è creata da un Dio amorevole per amore, le sono stati offerti i doni della ragione e del libero arbitrio e, quindi, le è stato permesso di amare Dio e gli altri. Sulla solida base di questi principi la persona esige il rispetto della sua dignità originaria e della sua vocazione umana. Quindi ha diritto al pieno riconoscimento della propria identità e della propria libertà di individuo, comunità e governo, con il sostegno della legislazione civile che garantisce pari diritti e piena cittadinanza.
4. Affermiamo che la creazione dell’umanità da parte di Dio presenta due grandi aspetti: la persona umana maschio e femmina e ci impegniamo insieme a garantire che la dignità e il rispetto umani vengano estesi sia agli uomini sia alle donne su una base paritaria.
5. L’amore autentico del prossimo implica il rispetto della persona e delle sue scelte in questioni di coscienza e di religione. Esso include il diritto di individui e comunità a praticare la propria religione in privato e in pubblico.
6. Le minoranze religiose hanno il diritto di essere rispettate nelle proprie convinzioni e pratiche religiose. Hanno anche diritto ai propri luoghi di culto e le loro figure e i loro simboli fondanti che considerano sacri non dovrebbero subire alcuna forma di scherno o di irrisione.
7. In quanto credenti cattolici e musulmani siamo consapevoli degli inviti e dell’imperativo a testimoniare la dimensione trascendente della vita attraverso una spiritualità alimentata dalla preghiera, in un mondo che sta diventando sempre più secolarizzato e materialistico.
8. Affermiamo che nessuna religione né i suoi seguaci dovrebbero essere esclusi dalla società. Ognuno dovrebbe poter rendere il suo contributo indispensabile al bene della società, in particolare nel servizio ai più bisognosi.
9. Riconosciamo che la creazione di Dio nella sua pluralità di culture, civiltà, lingue e popoli è una fonte di ricchezza e quindi non dovrebbe mai divenire causa di tensione e di conflitto.
10. Siamo convinti del fatto che cattolici e musulmani hanno il dovere di offrire ai propri fedeli una sana educazione nei valori morali, religiosi, civili e umani e di promuovere una attenta informazione sulla religione dell’altro.
11. Professiamo che cattolici e musulmani sono chiamati a essere strumenti di amore e di armonia tra i credenti e per tutta l’umanità, rinunciando a qualsiasi oppressione, violenza aggressiva e atti terroristici, in particolare quelli perpetrati in nome della religione, e a sostenere il principio di giustizia per tutti.
12. Esortiamo i credenti a operare per un sistema finanziario etico in cui i meccanismi normativi prendano in considerazione la situazione dei poveri e degli svantaggiati, siano essi individui o nazioni indebitate. Esortiamo i privilegiati del mondo a considerare la piaga di quanti sono colpiti più gravemente dall’attuale crisi nella produzione e nella distribuzione alimentare, e chiediamo ai credenti di tutte le denominazioni e a tutte le persone di buona volontà di cooperare per alleviare la sofferenza di chi ha fame e di eliminare le cause di quest’ultima.
13. I giovani sono il futuro delle comunità religiose e delle società in generale. Vivranno sempre di più in società multiculturali e multireligiose. È essenziale che siano ben formati nelle proprie tradizioni religiose e ben informati sulle altre culture e religioni.
14. Abbiamo concordato di prendere in considerazione la possibilità di creare un Comitato cattolico-musulmano permanente, che coordini le risposte ai conflitti e ad altre situazioni di emergenza, e di organizzare un secondo seminario in un Paese a maggioranza musulmana ancora da definire.
15. Attendiamo dunque il secondo seminario del Forum cattolico-musulmano che si svolgerà entro due anni, in un Paese a maggioranza musulmana ancora da definire.
Tutti i partecipanti sono stati grati a Dio per il dono di questo tempo trascorso insieme e per questo scambio proficuo. Alla fine del seminario, Sua Santità Papa Benedetto XVI e, dopo gli interventi del professor Seyyed Hossein Nasr e del Grand Mufti Mustafa Ceric, ha parlato al gruppo. Tutti i presenti hanno espresso soddisfazione per i risultati del seminario e la loro aspettativa di un dialogo più proficuo.
*
-