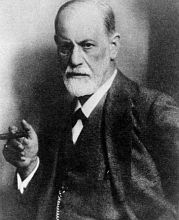
IDENTITA’, SESSUALITA’, E BI-CURIOSITA’ DEGLI ADOLESCENTI: MUTAMENTI ANTROPOLOGICI E INTERROGATIVI. Sulle ricerche in corso di psicologi, sociologi, e medici, un resoconto di Maria Novella De Luca e il parere di un endocrinologo, raccolto da Arnaldo D’Amico - a cura di Federico La Sala
- [...] Un fenomeno così vasto e dichiarato, un outing così collettivo, che ormai da diversi mesi psicologi, sociologi, medici (ma anche cacciatori di tendenze) hanno messo il fenomeno dei teenager bisex sotto la lente di ingrandimento. Per capire se qualcosa è davvero cambiato nella sessualità dei giovani. O se invece gli adolescenti non abbiano semplicemente smesso di nascondere la loro indefinitezza sessuale. In una recente ricerca dell’Istituto di ortofonologia di Roma, è stato calcolato che tra gli undici e i sedici anni il 35 per cento delle ragazze, e addirittura il 60 per cento dei ragazzi, si è avvicinato o ha provato l’esperienza omosessuale. [...]
 Sempre più adolescenti sperimentano l’omosessualità e
Sempre più adolescenti sperimentano l’omosessualità e
 esplorano orgogliosamente territori di confine. Lontani
esplorano orgogliosamente territori di confine. Lontani
 da scuola e famiglia, le loro confidenze viaggiano su
da scuola e famiglia, le loro confidenze viaggiano su
 Internet. E ora gli specialisti si chiedono:
Internet. E ora gli specialisti si chiedono:
 specchio dei tempi o semplice moda
specchio dei tempi o semplice moda
 IDENTITA’ SESSUALE
IDENTITA’ SESSUALE
 Sotto il segno dell’ambiguità è la generazione "bi-curious"
Sotto il segno dell’ambiguità è la generazione "bi-curious"
 "La bisessualità nell’adolescenza è sempre esistita,
"La bisessualità nell’adolescenza è sempre esistita,
 solo che ora non è più un tabù"
solo che ora non è più un tabù"
 di Maria Novella De Luca (la Repubblica, 09.03.2010)
di Maria Novella De Luca (la Repubblica, 09.03.2010)
Mutano, si nascondono, giocano con l’ambiguità. Ragazzi nell’età incerta, che scoprono se stessi, la sessualità, il corpo che cambia, e sperimentano sempre più territori di confine. Non solo "etero" dunque, ma anche "omo" e soprattutto "bisex". Hanno tra i quattordici e i diciotto anni e fanno parte di un movimento young-adult che in tutto il mondo ha fatto dell’ambiguità il proprio modo di amare. Le ragazze camminano mano nella mano, provano baci e carezze, i maschi si fermano ad abbracci più virili ma più espliciti di un tempo: più che bisex molti si definiscono bi-curious, curiosi doppiamente, si vestono con stile androgino, si ispirano all’inquieto movimento "Emo", si incontrano e si confidano in una galassia di siti e blog dove raccontano la loro ambiguità.
Un fenomeno così vasto e dichiarato, un outing così collettivo, che ormai da diversi mesi psicologi, sociologi, medici (ma anche cacciatori di tendenze) hanno messo il fenomeno dei teenager bisex sotto la lente di ingrandimento. Per capire se qualcosa è davvero cambiato nella sessualità dei giovani. O se invece gli adolescenti non abbiano semplicemente smesso di nascondere la loro indefinitezza sessuale. In una recente ricerca dell’Istituto di ortofonologia di Roma, è stato calcolato che tra gli undici e i sedici anni il 35 per cento delle ragazze, e addirittura il 60 per cento dei ragazzi, si è avvicinato o ha provato l’esperienza omosessuale.
Ma, al di là dei numeri, per Francesca Sartori, docente di Sociologia del genere all’università di Trento, tutto questo è la spia di un «forte cambiamento culturale». «L’adolescenza è l’età dell’onnipotenza, del voler provare tutto. La novità è che questa generazione sembra voler fare della propria ambiguità un modo di essere, una bandiera. Del resto questi teenager sono i figli di una società dove i ruoli tradizionali sono caduti, dove la confusione è forte, dove la moda, proprio sfruttando queste tendenze giovanili, propone immagini efebiche di maschi glabri e femmine senza seno, quasi indistinguibili. A mio parere però - aggiunge Sartori - è un azzardo parlare di gioventù bisex, perché è soltanto un’avanguardia trasgressiva che gioca con questi ruoli. E tra qualche anno capiremo se si tratta di "effetto età" o di un vero cambiamento. È certo, però, che gli adolescenti sperimentano una nuova libertà, ma anche un nuovo modo di non definirsi».
L’ultimo rapporto della Sigo, la Società italiana di ginecologia e ostetricia, segnala che gli adolescenti hanno le loro prime esperienze sessuali tra i quattordici e i sedici anni. Ed è in quel momento che la sperimentazione sessuale abbraccia più strade e più forme. E dove la scuola funge da terreno di conoscenza.
Un tema a cui Federico Batini, ricercatore di Pedagogia all’università di Perugia, ha dedicato L’identità sessuale a scuola. «La bisessualità nell’adolescenza è sempre esistita, ma adesso non è più un tabù. Però il vero problema è che ai ragazzi mancano gli strumenti per decodificare ciò che gli accade, della sessualità sanno ciò che scoprono su Internet, spesso in modo grossolano e non selezionato. In famiglia il discorso non viene affrontato e a scuola non se ne parla affatto. La verità - conclude - è che non esiste per i giovani una alfabetizzazione sessuale».
Legge invece il diffondersi della bisessualità tra gli adolescenti come un problema legato al riconoscimento di sé Simonetta Putti, psicologa e psicoterapeuta, curatrice di un saggio a più voci dal titolo: Chirone, dinamiche dell’identità di genere. «Il disagio esistenziale è oggi un dato diffuso anche tra adolescenti e ragazzi. E se la sessualità non costituisce più un’area di divieto da parte dei genitori, è l’area dell’affettività e del sentimento ad essere in difficoltà, e sempre più "tecnomediata" da Internet, mail, sms. E infatti, dietro questa crisi dell’identità di genere, c’è a mio parere la forte crisi di identità di questa generazione».
 L’ENDOCRINOLOGO
L’ENDOCRINOLOGO
 Dalle ricerche l’allarme sulle sostanze che disturbano gli ormoni sessuali
Dalle ricerche l’allarme sulle sostanze che disturbano gli ormoni sessuali
 “Ma in realtà la confusione dei ragazzi dipende dalle sofferenze psicologiche"
“Ma in realtà la confusione dei ragazzi dipende dalle sofferenze psicologiche"
 di Arnaldo D’Amico (la Repubblica, 09.03.2010)
di Arnaldo D’Amico (la Repubblica, 09.03.2010)
Adolescenti confusi, è colpa degli ormoni? La domanda spunta dalle ultime ricerche che stanno scoprendo anche nella specie umana le influenze sulla fertilità, sui caratteri sessuali ma anche sul comportamento, osservati da tempo nel mondo animale. Sono causati dalla diffusione nell’ambiente di una particolare categoria sostanze - su cui la Food and Drug Administration americana la scorsa settimana ha lanciato l’allarme - che interferiscono negli equilibri degli ormoni sessuali.
Dai pesci di un fiume del Colorado in cui aumenta la percentuale di femmine passando dalle sorgenti alla foce, dove l’acqua è piena di scarichi industriali, alle rane di un lago africano in estinzione perché i maschi rimangono castrati chimicamente da un fitofarmaco diffuso nell’acqua. Sino alla ricerca di due settimane che ha scoperto una tendenza androgina su adolescenti maschi del nord Italia: riduzione delle dimensioni medie di pene e testicoli, aumento dei casi di "micropene", distribuzione del grasso tendente a quella di tipo femminile ed aumento di statura dovuto soprattutto ad allungamento delle gambe.
«Scoperta che non sorprende - dice il responsabile della Uo di Endocrinologia dell’Età evolutiva dell’ospedale Cervello di Palermo, Piernicola Garofalo, presidente dell’Associazione medici endrocrinologi, Ame - ci voleva solo più tempo perché gli effetti visti sugli animali si scoprissero anche nella specie umana: queste sostanze agiscono già in dosi minime, ma con tempi lunghi, di decenni. Si chiamano "interferenti endocrini" proprio perché, pur se nati con scopi diversi, come additivi delle plastiche, pesticidi, fitofarmaci, ecc, casualmente hanno la capacità di bloccare l’azione degli ormoni, in particolare gli androgeni, una volta nel corpo».
Quando agiscono e che effetto hanno?
«Agiscono durante lo sviluppo sessuale che inizia nel grembo materno e si conclude intorno ai venti anni, con fasi più o meno intense. In questo periodo gli organi riproduttivi si differenziano in maschili e femminili e poi maturano. Si acquisiscono i caratteri sessuali esterni corrispondenti, distribuzione dei peli, del grasso corporeo, tono della voce e dimensioni degli organi sessuali. Il tutto è scritto nei geni che plasmano il corpo in senso maschile o femminile attraverso gli ormoni sessuali. Ma gli interferenti endocrini, contrastando l’azione degli ormoni sessuali, frenano tutto il processo di sviluppo sessuale».
Influenzano anche il comportamento?
«Certo, il carattere maschile e femminile sono determinati dall’azione dei rispettivi ormoni sessuali sul cervello, soprattutto nelle prima fasi di sviluppo quando maggiore è la neuroplasticità».
Quindi le confusioni sulla identità sessuale degli adolescenti possono dipendere da squilibri ormonali?
«Il teoria si, perché in animali di laboratorio si può arrivare ad "invertire" l’aspetto sessuale con dosi massicce di ormoni del sesso opposto a quello dei geni. In pratica no, per due motivi. Primo, gli interferenti endocrini riducono i caratteri sessuali maschili e basta, non stimolano quelli femminili. E’ il fenomeno della androginia. Secondo, gli adolescenti che stanno a disagio nel proprio sesso hanno profili ormonali e tutto il resto perfetti 9 volte su 10. La causa sta in sofferenze psicologiche e esistenziali che si focalizzano sulla identità sessuale, che pertanto è solo un bersaglio. Parola di endocrinologo».
Sul tema, da un punto di vista antropologico-filosofico, si cfr.:
 COSTITUZIONE E ORIENTAMENTO SESSUALE.
COSTITUZIONE E ORIENTAMENTO SESSUALE.
 IL LETTO DI PROCUSTE DELLA GERARCHIA VATICANA, L’ONU E L’ORIENTAMENTO SESSUALE DELLE PERSONE.
IL LETTO DI PROCUSTE DELLA GERARCHIA VATICANA, L’ONU E L’ORIENTAMENTO SESSUALE DELLE PERSONE.
Forum
-
>MUTAMENTI ANTROPOLOGICI E INTERROGATIVI --- "THE TIME IS OUT OF THE POINT" (AMLETO). LA PSICOANALISI E "IL LATO FLUIDO DELL’IDENTITÀ DI GENERE". Il genere è letteralmente uscito dai binari (di Luca Bruno).20 gennaio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI, E METATEATRO:
- "THE TIME IS OUT OF THE POINT" (Shakespeare, "Amleto", I.5). Il genere è letteralmente uscito dai binari...*
IL LATO FLUIDO DELL’IDENTITÀ DI GENERE
di Luca Bruno (#Spi-web, 10/01/2023->https://www.spiweb.it/la-cura/il-lato-fluido-dellidentita-di-genere-l-bruno/] )
Ci troviamo di fronte a una consistente trasformazione culturale, umana, identitaria, all’interno della quale osserviamo che il genere è passato da uno stato più solido (il binarismo) ad uno liquido (la fluidità, il non-binary). Il genere è letteralmente uscito dai binari, per prendere una strada a più vie, una “poli-via” che presenta ancora soste obbligate, cambi di carreggiata, limitazioni di velocità e a volte attese in coda e rischi di tamponamenti, a causa di lavori in corso.
Le posizioni che sta cercando di assumere la psicoanalisi risentono di pensieri divergenti, che si collocano lungo un continuum che va dall’iper-accoglienza al rifiuto, dalle posizioni confusive dello “aboliamo il maschile e il femminile anche nel nostro linguaggio” verso quelle conservative e talora intrise di persecutorietà del “vogliono negarci di poter continuare a pensare al binarismo e al nostro bagaglio teorico?”. Siamo in quel pezzetto della storia dell’uomo che va dall’antropocene all’androginocene?
Le persone che presentano varianze sessuali e di genere costituiscono un gruppo eterogeneo, che oggi sempre più frequentemente cerca un aiuto psicologico.
Le psicoanalisi di questi pazienti non sono quasi mai richieste per una sofferenza identitaria. In genere, alla questione identitaria ci si arriva per gradi e attraverso l’esercizio di molto tatto e cautela da parte del terapeuta. Capacità negativa, attesa, sospensione nell’incertezza, ascolto rispettoso.
L’identità di genere rientra nella più ampia e complessa sfera dell’identità sessuale. In essa, sesso, genere e orientamento sessuale possono non essere allineati. Per molti individui è una parte di Sé relativamente stabile, definita e in accordo con il sesso biologico, anche se va incontro a parziali fluttuazioni, che risentono dei complessi fenomeni identificatori (sia col femminile, che con il maschile). Queste identificazioni si stratificano nella nostra mente e nel corpo e risultano in parte legate alla fondamentale bisessualità psichica, ai fenomeni psichici determinati dalle dinamiche del complesso edipico e sono modulate dai fantasmi originari che riguardano la passività, la scena primaria, la seduzione, la castrazione. La costruzione del senso nucleare dell’identità di genere risente inoltre dell’influsso dei desideri e delle fantasie inconsce dei genitori, dei lasciti transgenerazionali e dell’ambiente culturale.
L’identità di genere si trova in questa epoca particolarmente esposta a tensioni conflittuali, al crocevia tra natura, cultura e l’indomabile spinta delle pulsioni.
Comprendere i significati, la storia e l’evoluzione degli aspetti che compongono l’identità di genere e come si combinano con altri elementi della vita inconscia è tra i compiti di ogni lavoro analitico. Un compito che risulta particolarmente delicato quando il paziente è un/una adolescente.
In adolescenza è più complesso discriminare aspetti psichici già maggiormente definiti e strutturati da altri ancora compresi all’interno di un’area di estrema mutevolezza e cambiamento, talora realmente soggettivi, talaltra in assonanza con influenze gruppali e culturali. Il funzionamento mentale in adolescenza evoca una miscela di liquidi di natura e di densità diverse, che si mescolano in modo temporaneo prima che ciascun liquido riprenda il suo posto (Green, 1986). Si tratta di condizioni nelle quali l’impatto di processi arcaici, primari, sul lavoro psichico è molto intenso e può causare discontinuità e talora rotture nel processo di ricerca identitaria e di soggettivazione.
L’adolescente è combattuto tra il riemergere di questioni edipiche e l’emergenza del nuovo, è alle prese con il lutto dei legami infantili e nello stesso tempo la necessità di governare forze e spinte inaugurali (Chan, 1998). Si tratta di un lavoro psichico complesso, che investe l’asse narcisistico e quello oggettuale, tra permanenza e cambiamento, nel quale l’identità subisce importanti rimaneggiamenti e transizioni.
Esiste un’ampia parte di terapeuti che tende a considerare i pazienti transgender e gender fluid, senza particolari riserve, quali espressioni di una profonda psicopatologia narcisistica, perversa o psicotica, nella quale l’esame di realtà risulta in parte compromesso.
L’analista al lavoro con questi pazienti deve affrontare aspetti che intrecciano l’estraneo al familiare, sperimentando il sentimento del perturbante (Freud, 1919) e deve prestare particolare attenzione al controtransfert, inteso come macchia cieca, ostacolo nella comprensione di alcune dinamiche del paziente che incontrano aspetti conflittuali o parzialmente irrisolti della mente dell’analista stesso.
L’analista, in modo probabilmente più intenso e conflittuale rispetto al lavoro con pazienti cisgender eterosessuali, si trova a rivisitare il proprio sessuale infantile, la propria bisessualità psichica e la capacità di integrare le identificazioni maschili e femminili in conflitto con gli aspetti binari del sesso biologico. Vengono sollecitati in maniera particolare e massiccia sia il sessuale dell’analista, quel “sessuale” che Laplanche (2003) sottolinea essere molteplice e che trova il suo fondamento nell’infantile e nell’inconscio, sia un particolare ascolto del corpo che si interfaccia con le angosce connesse alla passività che Freud (1937) collocò nel concetto di “roccia basilare o biologica”, limite oltre il quale spesso l’analisi non riesce ad addentrarsi nel suo lavoro esplorativo ed elaborativo.
Le condizioni di cui stiamo trattando richiedono all’analista un lavoro identificatorio che può risultare particolarmente complesso e conflittuale. Può dimostrare aspetti contraddittori di fronte ad aspetti corporei e somatopsichici del paziente transgender e non essere in grado di riconoscerlo/a, non riuscendo ad accordare pronomi e aggettivi secondo l’identità di genere del paziente o stabilendo un “progetto identitario”, più o meno consapevolmente, che corrisponderebbe a quello che per lui sarebbe più indicato per il paziente.
Non dovremmo trascurare una tra le più importanti indicazioni di Freud (1914) a proposito dell’importanza di non sottrarre la libertà al paziente, di non imporgli nostri ideali e di non desiderare che si conformi alla nostra immagine o ai nostri modelli teorici.
La psicoanalisi dovrebbe guardarsi dal convergere con le ideologie (o le pressioni sociali) che rischiano di inibire il suo pensiero, ma deve anche guardarsi dall’irrigidirsi su posizioni teoriche che potrebbero non essere adatte alla singola condizione umana e psichica, rischiando di farne un uso difensivo e potenzialmente iatrogeno o anti-sviluppo per il paziente (McDougall, 1995).
Nella prospettiva che fa appello a una topica degli spazi, tra “dentro” e “fuori” esiste uno spazio intermedio, che li separa e li unisce, un’area che Winnicott (1953) chiama “transizionale“. E’ uno spazio interstiziale, deputato al gioco, alla fantasia, alla creatività e all’illusione. Su di esso confidiamo, per aiutare i nostri pazienti a sviluppare capacità di simbolizzazione e di interiorizzazione che possano prevalere sul ricorso sintomatico all’agire e che possano permettere un reale lavoro di integrazione di parti di Sé sconosciute e tenute separate, isolate, dissociate o scisse. Ma questo non può esaurire la complessità della questione, quando si pensa alla necessità di inscrivere la nostra identità anche nel corpo e in un corpo che possa corrispondere al genere a cui il paziente sente di appartenere. Il nostro compito dovrebbe rimanere quello di aiutare il paziente ad accostarsi a una più ampia conoscenza di sé, ricercando autenticamente sé e il proprio desiderio per vivere una vita sufficientemente appagante, nella capacità di tollerare l’inevitabile umana infelicità.
I pazienti transgender o che presentano un’identità di genere fluida non solo possono non presentare aspetti psicopatologici, ma non necessariamente chiederanno il cambio di sesso attraverso le cure ormonali e gli interventi chirurgici.
E’ importante sollevare la questione del ruolo occupato dal masochismo. Ma occorre anche chiedersi: è masochistico per la persona sottoporsi a complessi e dolorosi interventi medici e chirurgici o all’esposizione di aggressioni sociali o è masochistico abdicare alle proprie spinte identitarie e identificatorie, che richiedono unitarietà tra psiche e corpo? Perché il corpo, sia psichico che reale, ha un ruolo importante nell’organizzazione dell’identità.
Come sempre dovremmo evitare delle prese di posizione, non solo ideologiche, ma anche eccessivamente monolitiche, come “i transgender mettono in campo un diniego della realtà e sono sospinti da fantasie onnipotenti di autogenerazione”: è proprio così? È così per tutti?
Sarebbe necessario offrire uno spazio di ascolto e di riconoscimento al dolore e al conflitto che molte di queste persone vivono nel loro percorso di ricerca identitaria, spesso sofferto e combattuto, fragile e incerto, che può essenzialmente contenere l’umanissimo desiderio di “essere chi si è” (non era forse questa l’originaria meta dell’analisi?) anche nel corpo.
Sarebbe importante se il “genere” di cui ci occupiamo fosse quello “umano”. Il genere umano.
Quando chiesi a Eugenio Gaburri quale tipo di analista fosse, mi rispose: “sono stato freudiano, kleiniano, winnicottiano, bioniano... adesso credo di essere umano”.
Siamo dentro la necessità di fare i conti con un cambiamento, anche come analisti. Senza euforia maniacale e senza scissioni o dinieghi. Anche come analisti, accettando i nostri limiti, aspirando a quote sempre più raffinate del nostro percorso di assunzione della posizione sanamente depressiva.
Siamo in transizione. E siamo di passaggio.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Cahn (1998). L’adolescente nella psicoanalisi. L’avventura della soggettivazione. Borla, Roma, 2000.
Freud S. (1914). Osservazioni sull’amore di traslazione. O.S.F., 7, Torino, Bollati Boringhieri.
Freud S. (1919). Il perturbante. O.S.F. 9, Torino, Bollati Boringhieri.
Freud S. (1937). Analisi terminabile e interminabile. O.S.F., 11, Torino, Bollati Boringhieri.
Green A. (1986). Interv. In: Baranes J.J., Cahn R. et al., Psychanalyse, adolescence et psychose. Parigi, Payot.
Laplanche J. (2003), Il genere, il sesso, il sessuale. In: Sexuale. La sessualità allargata nel senso freudiano, Milano, Mimesis, 2019.
McDougall J. (1995). Eros. Le deviazioni del desiderio. Milano, Raffaello Cortina, 1997.
Winnicott D. (1953). Oggetti transizionali e fenomeni transizionali. In: Dalla pediatria alla psicoanalisi. Firenze, Martinelli, 1975.
* QUESTIONE ANTROPOLOGICA, FILOSOFIA "PLATONICA", E "FUMETTO": "Abbracciatevi, moltitudini" (Schiller/Bethoven).
- Ariel Vittori - Little Waiting. Libro per un pubblico adulto, 2022:
"[...] Little waiting, la graphic novel di cui stiamo parlando, è un piccolo capolavoro sulla molteplicità. Molteplicità irriducibile di corpi, organi, fluidi. Un molteplice che sovverte le strutture della differenza sessuale e che sfida le epistemologie consolidate a una nuova comprensione. Ma è geniale perché lo fa con una storia d’amore.
Di più. Con una storia d’amore romantica. Amore con la A maiuscola. A parte il fatto che i due protagonisti ne sovvertono completamente il costrutto e il codice: una storia bella, giocosa, delicata, quella che si dispiega in questo fumetto che racconta le identità di genere e le pratiche BDSM (Bondage Sado Maso), in maniera dolce, quotidiana.
Il fumetto si apre con un grande classico. L’immagine a letto di lei e di lui. I due protagonisti, Talhita e Aki, sono immersi in questo loro trasporto amoroso senza riserve: ci credono in maniera incondizionata. E noi lettori ci chiediamo stupefatti, non sanno che è tutto molto più complicato? Non sanno che non ci si incontra mai davvero completamente? Forse non hanno letto Lacan o se lo hanno letto non condividono la tesi che “il rapporto sessuale non esiste”. E non sanno che crederci comporta l’assunzione di un enorme dose di rischio? Nel dubbio, sembrano dirsi (e dirci) i due, diamoci giù di brutto, almeno per tutto il tempo del fumetto. [...]" (* asterisco, "L’insostenibile leggerezza della sfida queer - Buoncristiani e Romani", Centro Psicoanalitico di Roma->https://centropsicoanaliticodiroma.it/linsostenibile-leggerezza-della-sfida-queer-c-buoncristiani-e-t-romani])
***
"LA GAIA SCIENZA. Si deve imparare anche l’amore *
 Si deve imparare ad amare. Ecco quel che ci accade nella musica: si deve prima imparare a udire una sequenza e una melodia in genere, a enuclearla nell’ascolto e a distinguerla isolandola e delimitandola come se avesse una vita propria; quindi bisogna sforzarci e impiegare la nostra buona volontà per sopportarla, malgrado la sua estraneità, bisogna fare un esercizio di pazienza di fronte al suo sguardo e alla sua espressione, considerare con benevolenza quel che c’è di inusitato in essa - finalmente arriva un momento in cui ne abbiamo preso l’abitudine, in cui l’attendiamo, in cui si ha il presentimento che ne sentiremmo la mancanza, se non ci fosse più; e così essa continuamente dispiega la sua violenta suggestione e il suo incantesimo, finché non si sia diventati i suoi umili ed estasiati amanti, per cui non v’è più niente di meglio da chiedere al mondo se non la melodia e ancora la melodia.
Si deve imparare ad amare. Ecco quel che ci accade nella musica: si deve prima imparare a udire una sequenza e una melodia in genere, a enuclearla nell’ascolto e a distinguerla isolandola e delimitandola come se avesse una vita propria; quindi bisogna sforzarci e impiegare la nostra buona volontà per sopportarla, malgrado la sua estraneità, bisogna fare un esercizio di pazienza di fronte al suo sguardo e alla sua espressione, considerare con benevolenza quel che c’è di inusitato in essa - finalmente arriva un momento in cui ne abbiamo preso l’abitudine, in cui l’attendiamo, in cui si ha il presentimento che ne sentiremmo la mancanza, se non ci fosse più; e così essa continuamente dispiega la sua violenta suggestione e il suo incantesimo, finché non si sia diventati i suoi umili ed estasiati amanti, per cui non v’è più niente di meglio da chiedere al mondo se non la melodia e ancora la melodia.
 Questo ci accade però non soltanto con la musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore.
Questo ci accade però non soltanto con la musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore.* F. Nietzsche, "La gaia scienza" (IV, fr. 334).
FLS
-
> IDENTITA’, SESSUALITA’, E BI-CURIOSITA’ DEGLI ADOLESCENTI: MUTAMENTI ANTROPOLOGICI E INTERROGATIVI. -- La “disforia” dell’identità sessuale (di Sarantis Thanopulos).14 luglio 2019, di Federico La Sala
La “disforia” dell’identità sessuale
di Sarantis Thanopulos (Psychiatry on Line, 14 luglio, 2019)
“La Repubblica” ha ospitato recentemente il confronto tra due psicoanalisti, Lorena Preta e Vittorio Lingiardi, sul tema della “disforia” dell’identità sessuale -il sentirsi incastrati nel sesso/corpo sbagliato- in bambini prepuberi.
La disforia, che rientra spontaneamente nella grande maggioranza dei casi, è diventata fonte di ansia per molti genitori. Preta ha posto l’accento sui medici compiacenti che, somministrando farmaci capaci di bloccarne lo sviluppo, attuano una “sospensione” della definizione sessuale, preambolo di una “riattribuzione di genere”. Collegando il disagio identitario a istanze inconsce non immediatamente decifrabili, che richiederebbero il tempo di un’elaborazione, Preta ha deplorato l’attitudine a offrire a un malessere individuale e sociale soluzioni tecniche.
Lingiardi ha messo l’accento sul rispetto della condizione individuale, invocando una psicoanalisi accogliente, non spaventata dalle metamorfosi delle identità sessuali. Piuttosto che privilegiare un modello di cura, in mezzo a concezioni contrastanti sull’origine del malessere, sarebbe opportuno seguire un approccio cooperativo, con un ascolto attento rivolto al singolo caso e alla soggettività.
La scienza, la filosofia, la psicoanalisi non sono, in effetti, canoni di vita. Ognuno deve sentirsi libero di gestire (con i mezzi a sua disposizione) il proprio modo di essere nel mondo. Tuttavia molte condizioni esistenziali sono oggi dettate dalla negazione del lutto e il corpo contraffatto si sta equiparando al corpo vero. Interferire con lo sviluppo psicocorporeo nell’infanzia, bloccandolo o modificandolo medicalmente, sulla base di convinzioni o comportamenti ancora da evolvere, che così si rendono definitivi, è un abuso. I genitori non devono reprimere il disagio identitario del loro bambino, né assumerlo come un dato di fatto (fato), ma cercare di comprendere cosa sta accadendo tra loro e lui, allargando, il più possibile, l’area del confronto.
La concezione dell’identità sessuale come combinazione tra anatomia e cultura, estromette l’essenziale: il legame tra psiche e corpo, la materia pulsionale del gesto erotico - che nessuna tavola anatomica può catturare ed è l’oggetto reale del condizionamento culturale.
Ginevra Bompiani, intervenuta nel dibattito dalle pagine di questo giornale, ha parlato di intreccio tra immaginario e dato corporeo e dell’invenzione creativa che il primo opera sul secondo. La manipolazione sociale dell’immaginario annulla l’invenzione.
Bompiani ha colto il punto: la manipolazione dell’immaginario conduce alla manipolazione del corpo. Sostenere che l’anatomia non debba essere un destino, per poi compiacere la costruzione di un’anatomia fittizia (la peggiore delle normalizzazioni e il più irremovibile dei destini), è una forte incoerenza che lascia spazio all’onnipotenza: la creazione artificiale di stereotipie identitarie. Ha ragione Bompiani nel dire che la scelta identitaria contestata non deve diventare una corazza da indossare.
Si può rispettare, accogliere i transessuali, senza compatirli, né assecondare la loro visuale. Della loro condizione si può “prendere cura”, se sono interessati, a partire dal reciproco lutto che è necessario fare. La dissociazione tra il dato corporeo e la rappresentazione psichica del proprio sesso interferisce con lo sviluppo del corpo erotico e limita seriamente la profondità del coinvolgimento e della soddisfazione sessuale. Una perdita significativa (più radicale nel caso dell’asportazione chirurgica dei genitali) che andrebbe elaborata insieme alla rinuncia alla nostra pretesa di una connessione senza falle tra corpo e psiche nella determinazione dell’identità sessuale.
-
> IDENTITA’, SESSUALITA’, E BI-CURIOSITA’ DEGLI ADOLESCENTI: MUTAMENTI ANTROPOLOGICI E INTERROGATIVI. --- Un sondaggio: quasi la metà dei giovani non si ritiene più soltanto “etero” ma neanche gay o bisex (di Enrico Franceschini)6 gennaio 2016, di Federico La Sala
Sesso
Con lei, lui o tutti e due così gli under 30 non hanno più tabù
Un sondaggio sul nuovo eros a geometrie variabili: quasi la metà dei giovani non si ritiene più soltanto “etero” ma neanche gay o bisex
Un’identità in evoluzione che è anche frutto della caduta di molti pregiudizi sull’omosessualità
di Enrico Franceschini (la Repubblica, 04.01.2016)
LONDRA LUI ama lei. Lei ama lei. Lui ama lui o lei: contemporaneamente, alternativamente, indifferentemente. Va’ dove ti porta il cuore - o un altro organo. La nuova regola dell’attrazione per i più giovani è che non ci sono più regole. In gergo si chiama “sexual fluidity”, fluidità sessuale: ovvero libertà di pendere da una parte, dall’altra, di tornare alla precedente o di mescolarle insieme con leggerezza, e così via a seconda delle circostanze, della disponibilità, della predilezione del momento.
Un fenomeno fotografato da un recente sondaggio di YouGov: quasi metà degli inglesi fra i 18 e i 30 anni, un terzo degli americani e percentuali analoghe negli altri Paesi occidentali non si definiscono né completamente eterosessuali, né completamente gay. Ma neppure bisessuali, poiché anche quella è una scelta, un’identità. Il nuovo orientamento per gli under 30 è piuttosto il contrario: non avere un’identità, andare con la corrente, navigare a vista. Come viene, viene.
Non a caso sta avendo grande successo un’applicazione chiamata 3ender (il nome riecheggia volutamente Tinder, l’app popolarissima fra ventenni-trentenni che consente di individuare chi è interessato a una relazione, di solo sesso o d’amore si vedrà, nelle immediate vicinanze: il bancone di un bar, una discoteca, un quartiere) con cui trovare coetanei di qualunque sesso desiderosi di un rapporto a tre: due lui e una lei, due lei e un lui o variazioni sul tema.
Lanciata quest’estate in Inghilterra, è passata in tre mesi da 70mila a 700mila iscritti. I sessuologi parlano di “pan-erotismo”. Con il suo linguaggio più crudo ed esplicito, la cantante Miley Cyrus, simbolo della generazione dei “Millennials” e specializzata nell’arte di scandalizzare, riassume così il concetto: «Mi va di fare a letto qualunque cosa con chiunque di qualunque sesso e di qualunque orientamento, basta che siano atti consenzienti, esclusi animali e minorenni».
Sulla cosiddetta “scala Kinsey”, dal nome dello studioso americano autore negli anni ‘60 del primo grande rapporto sulla sessualità, zero rappresenta chi è esclusivamente eterosessuale, 3 chi è egualmente eterosessuale e omosessuale, 6 chi è esclusivamente omosessuale. Ebbene, nel sondaggio di YouGov, pubblicato dal Guardian, il 49% degli inglesi fra i 16 e i 24 anni non ha scelto né zero né 6, posizionandosi a metà circa della scala Kinsey.
E non si tratta solo delle nuove generazioni: persone di tutte le età oggi accettano l’idea che «l’orientamento sessuale esiste lungo una linea flessibile piuttosto che fissato su una scelta netta», concorda il 60% degli eterosessuali e il 73% degli omosessuali. Ciò non significa, naturalmente, che la maggior parte della popolazione, in Europa o negli Stati Uniti (dove simili indagini danno più o meno gli stessi risultati), sia attivamente bisessuale o meglio ancora cambi orientamento a seconda di come tira il vento.
In effetti, l’89% dei britannici continua a definirsi etero. Ma lo studio di YouGov rivela una crescente apertura mentale sull’argomento: il 35% di quanti si identificano con 1 sulla scala Kinsey, dunque appena un gradino al di sopra di un’identità «esclusivamente eterosessuale», afferma di poter immaginare di avere un rapporto omosessuale, se la persona giusta si facesse avanti al momento giusto. Del resto, nel 2008 solo il 48% degli americani considerava le relazioni gay «moralmente accettabili»; ora la percentuale è salita al 63% tra la popolazione in generale e al 79 nella fascia di età fra i 18 e i 34 anni.
In parte questa nuova fluidità è certamente il risultato di una maggiore accettazione dell’omosessualità, rafforzata dalla legge che consente il matrimonio gay in Gran Bretagna, Irlanda e molti Paesi d’Occidente. Se gli omosessuali possono sposarsi e avere figli come gli eterosessuali, non appaiono più “diversi”.
Una propensione che in passato veniva trattata come conseguenza della genetica, dell’ambiente, se non addirittura di traumi infantili, e considerata da alcuni perfino una malattia, è rientrata nella norma a termini di legge: e dunque l’amore gay può diventare interscambiabile con quello che si era sempre vantato di rappresentare la presunta normalità, l’amore etero. Lui va con lui o con lei con la stessa disinvoltura con cui andrebbe con una bionda o una bruna; e viceversa.
Un modo di essere, di vivere e di amare che sta prendendo piede tra i giovanissimi; ma presto saranno gli adulti di domani, ed è presumibile che porteranno con sé il medesimo orientamento. Non è strettamente necessario consumare un rapporto per sentire il richiamo di questa fluidità: sul web spopola il blog “19 cose leggermente lesbiche che puoi fare con la tua migliore amica” (in inglese l’acronimo “Bff”, Best friends forever), e su 19 non ce n’è una strettamente sessuale. È un modo di stare insieme felicemente tra femmine a base di confidenze, carezzine, selfie e risatine alle spalle dei maschi. Basta un’occhiata alle pagine Facebook delle adolescenti per capire che non c’è bisogno di dichiararsi gay o bisex per avere relazioni di questo genere.
In fondo è un ritorno alle radici, considerato che nell’era classica la distinzione non era così netta come è stata in seguito, sotto il peso della morale religiosa e dei suoi condizionamenti. «L’attrazione è attrazione e non le serve un’etichetta», taglia corto Charles Blow, columnist del New York Times. Dunque siamo o diventeremo sempre più “fluidi”, termine coniato nel 2009 dalla psicologa americana Lisa Diamond, l’autrice di “Sexual fluidity: understanding women’s love and desire”, il libro che ha aperto il dibattito sostenendo che le etichette tradizionali per il desiderio sono inadeguate e che la società contemporanea dovrebbe spingersi oltre. Non etero, non omo, non bisex, bensì “pansessuali”, come si dichiara con l’abituale spregiudicatezza Miley Cyrus. Liberi di sperimentare, di cambiare, di avere un’identità in perenne movimento. Di andare dovunque ci porta il cuore. O un altro organo.
-
> IDENTITA’, SESSUALITA’, E BI-CURIOSITA’ DEGLI ADOLESCENTI ---- Il mea culpa di Robert Spitzer. «Un errore la ricerca sui gay da curare»(di Alessandra Farkas - Le scuse dello psichiatra).19 maggio 2012, di Federico La Sala
 Le scuse dello psichiatra
Le scuse dello psichiatra
 «Un errore la ricerca sui gay da curare»
«Un errore la ricerca sui gay da curare»di Alessandra Farkas (Corriere della sera, 19.05.2012)
NEW YORK - «L’omosessualità di gay e lesbiche può essere curata». Era il 2001 quando, a un convegno della American psychiatric association (Apa) il dottor Robert Spitzer illustrò la sua controversa tesi secondo cui è possibile, per alcuni individui estremamente motivati, cambiare il proprio orientamento sessuale da gay a eterosessuale. Il fatto che a pronunciare quelle parole fosse il celeberrimo docente della Columbia University, considerato dai manuali il padre della psichiatria moderna e lo psichiatra più influente del 20° secolo, contribuì solo ad accreditare la legittimità di tale provocatoria argomentazione. Nessuno poteva accusarlo di pregiudizio anti-gay.
Nel 1973 era stata proprio la crociata personale dell’allora 41enne Spitzer a indurre l’Apa a rimuovere l’omosessualità dalla lista dei «disturbi mentali». Poi, nel 2001, quello studio bollato come «un tradimento» dai gay di tutto il mondo. Undici anni più tardi, lo psichiatra ha chiesto loro scusa per l’errore commesso. Cercando persino, senza riuscirvi, di pubblicare una ritrattazione sulla stessa rivista scientifica che nel 2001 aveva ospitato il saggio originale, denunciato come «pericoloso» dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Il mea culpa di Spitzer, oggi 80enne e gravemente malato di Parkinson, è avvenuto in un’intervista al New York Times. «Giacevo sveglio nel letto alle 4 del mattino, quando ho deciso che era giunto il momento di farlo», afferma Spitzer, «mi alzai annaspando nel buio e con enorme difficoltà, data la mia condizione, raggiunsi la scrivania dove presi carta e penna». Quando il direttore della rivista Archives of Sexual Behavior si rifiutò di pubblicare la sua ritrattazione, Spitzer ha chiamato il Times. «Dovevo chiedere scusa alla comunità gay per i miei studi che sostengono tesi fasulle sull’efficacia delle terapie riparatorie», incalza, «e voglio anche chiedere scusa a tutte le persone gay che hanno perso tempo ed energia sottoponendosi per colpa mia a tali inutili terapie».
-
>MUTAMENTI ANTROPOLOGICI E INTERROGATIVI. ---- Curare i gay? Un libro smentisce le pretese scientifiche delle teorie «riparative» mettendone in luce la volontà distruttiva nei confronti dell’omosessualità.13 febbraio 2012, di Federico La Sala
 I gay? Non esistono
I gay? Non esistono Un libro smentisce le pretese scientifiche delle teorie «riparative» mettendone in luce la volontà distruttiva nei confronti dell’omosessualità
Un libro smentisce le pretese scientifiche delle teorie «riparative» mettendone in luce la volontà distruttiva nei confronti dell’omosessualità l’Unità 13.2.12
l’Unità 13.2.12Curare i gay? Piuttosto «liberarli». Sono davvero «terapie» le cure per i gay? Per nulla: traducono in termini pseudo scientifici i pregiudizi popolari e nel vano tentativo di modificare l’orientamento sessuale alimentano il disprezzo del paziente verso se stesso e della società verso l’omosessualità, colpendo al cuore la democrazia degli affetti.
A smontare gli assunti dei terapisti «riparativi», mostrandone fragilità e inefficacia e indicando le nuove linee delle terapie affermative, è un testo fresco di stampa dal titolo Curare i gay? (Cortina) scritto da Paolo Rigliano, Jimmy Ciliberto, Federico Ferrari. Un testo scientifico non privo di fervore politico, secondo il quale la questione centrale oggi rispetto all’omosessualità è favorire la liberazione del paziente nell’ottica del diritto di ciascuno di vivere in maniera legittima la propria affettività e del diritto-dovere della società di essere equa e rispettosa.
CHI SONO ALLORA?
L’assunto da cui partono i riparativi è invece la negazione degli omosessuali, i quali semplicemente non esisterebbero. Chi sarebbero allora? «Eterosessuali con problemi di omosessualità». L’unione tra persone dello stesso sesso sarebbe solo un atto sessuale compulsivo, qualcosa di secondario, e quindi una deviazioe da correggere rispetto al vero progetto biologico che vede Natura e volontà divina coincidere. È questo il credo dei fondamentalisti impegnati a trasformare la psicoterapia in una teopsicologia e ad appoggiare il più retrivo conservatorismo.
«L’unione eterosessuale rimane il progetto di Dio per l’Umanità», dice uno degli assertori tesi a parlare soprattutto di omosessualità maschile. Opposto è l’atteggiamento degli autori del testo che, passando al setaccio le terapie riparative, ne mostrano i presupposti di oppressione. Fanno riferimento tra gli altri agli assunti dell’American Psychological Association: non solo dal 1973 a oggi l’omosessualità è considerata una variante normale e positiva dell’orientamento sessuale umano, ma essa non va vista come un elemento isolato, un gusto, qualcosa che si aggiunge, e che si può «togliere». Invece coinvolge l’interezza della persona, a partire dal nucleo centrale fino all’atto sessuale più concreto. L’omosessualità ha pari dignità rispetto all’eterosessualità, ed è anche parimenti preferibile.
Eppure, nata circa venti anni fa in America, l’associazione Narth è capofila di tentativi per modificare l’orientamento sessuale di pazienti afflitti da un sistema sociale e familiare svalutante, le cui sofferenze andrebbero alleviate e che si vedono sottoposti a mortificazioni per raggiungere al massimo l’esito repressivo di limitare qualcuno dei comportamenti.
Dopo aver smontato la tentazione di alcuni terapeuti di promettere impossibili conversioni, il libro indica alla comunità scientifica nuove strade mettendo a nudo la passione civile che lo anima. «L’obiettivo primo del paziente deve essere la sua liberazione». La relazione terapeutica offre al paziente l’occasione per sperimentare la fiducia in sé e nel proprio sentimento d’amore e di erotismo. Questa stessa ottica spinge gli autori a valorizzare nella terapia con le persone omosessuali credenti l’esperienza di molte realtà cristiane di base e le letture alternative del messaggio cristiano che parla di amore, di comunione, e di realizzazione piena di sé nel consorzio umano.
L’obiettivo è quello di costruire con il paziente omosessuale un’apertura «su un orizzonte di valori» di giustizia e di eguaglianza. In ballo c’è per la comunità scientifica la sfida di liberare e sostenere il paziente dentro un orizzonte sociale e politico che tuteli la persona e legittimi la pluralità delle identità sessuali.
-
> IDENTITA’, SESSUALITA’, E BI-CURIOSITA’ DEGLI ADOLESCENTI: MUTAMENTI ANTROPOLOGICI E INTERROGATIVI. ---- I giovani, l’amore, il sesso viaggio nell’Italia anni ’60 (di Mchel Foucault - rec. di "Comizi d’amore" di P.P. Pasolini).27 aprile 2010, di Federico La Sala
 L’ANTICIPAZIONE / Ecco la recensione scritta da Michel Foucault nel 1977 al film-inchiesta del regista di "Comizi d’amore". Un ritratto del Paese e dei suoi cambiamenti
L’ANTICIPAZIONE / Ecco la recensione scritta da Michel Foucault nel 1977 al film-inchiesta del regista di "Comizi d’amore". Un ritratto del Paese e dei suoi cambiamenti PIER PAOLO PASOLINI.
PIER PAOLO PASOLINI.
 I giovani, l’amore, il sesso viaggio nell’Italia anni ’60
I giovani, l’amore, il sesso viaggio nell’Italia anni ’60 Qualcuno si decide, risponde esitando Si avvicinano, borbottano, le braccia sulle spalle, volto contro volto. Risa e tenerezza
Qualcuno si decide, risponde esitando Si avvicinano, borbottano, le braccia sulle spalle, volto contro volto. Risa e tenerezza
 Qualcuno manifesta anche il timore che molti comportamenti ora verranno tollerati Verrà meno una specie di ecosistema
Qualcuno manifesta anche il timore che molti comportamenti ora verranno tollerati Verrà meno una specie di ecosistemadi Michel Foucault(la Repubblica, 27.04.2010)
Come nascono i bambini? Li porta la cicogna, da un fiore, li manda il buon dio, o arrivano con lo zio calabrese. Guardate il volto di questi ragazzini, invece: non danno affatto l’impressione di credere a ciò che dicono. Con sorrisi, silenzi, un tono lontano, sguardi che fuggono a destra e sinistra, le risposte a tali domande da adulti possiedono una perfida docilità; affermano il diritto di tenere per sé ciò che si preferisce sussurrare. Dire "la cicogna" è un modo per prendersi gioco dei grandi, per rendergli la loro stessa moneta falsa; è il segno ironico e impaziente del fatto che il problema non avanzerà di un solo passo, che gli adulti sono indiscreti, che non entreranno a far parte del cerchio, e che il bambino continuerà a raccontarsi da solo il "resto". Così comincia il film di Pasolini.
Enquête sur la sexualité (Inchiesta sulla sessualità) è una traduzione assai strana per Comizi d’amore: comizi, riunioni o forse dibattiti d’amore. È il gioco millenario del "banchetto", ma a cielo aperto sulle spiagge e sui ponti, all’angolo delle strade, con bambini che giocano a palla, con ragazzi che gironzolano, con donne che si annoiano al mare, con prostitute che attendono il cliente su un viale, o con operai che escono dalla fabbrica. Molto distanti dal confessionale, molto distanti anche da quelle inchieste in cui, con la garanzia della discrezione, si indagano i segreti più intimi, queste sono delle Interviste di strada sull’amore. Dopo tutto, la strada è la forma più spontanea di convivialità mediterranea.
Al gruppo che passeggia o prende il sole, Pasolini tende il suo microfono come di sfuggita: all’improvviso fa una domanda sull’"amore", su quel terreno incerto in cui si incrociano il sesso, la coppia, il piacere, la famiglia, il fidanzamento con i suoi costumi, la prostituzione con le sue tariffe. Qualcuno si decide, risponde esitando un poco, prende coraggio, parla per gli altri; si avvicinano, approvano o borbottano, le braccia sulle spalle, volto contro volto: le risa, la tenerezza, un po’ di febbre circolano rapidamente tra quei corpi che si ammassano o si sfiorano. Corpi che parlano di loro stessi con tanto maggior ritegno e distanza quanto più vivo e caldo è il contatto: gli adulti parlano sovrapponendosi e discorrono, i giovani parlano rapidamente e si intrecciano. Pasolini l’intervistatore sfuma: Pasolini il regista guarda con le orecchie spalancate. Non si può apprezzare il documento se ci si interessa di più a ciò che viene detto rispetto al mistero che non viene pronunciato. Dopo il regno così lungo di quella che viene chiamata (troppo rapidamente) morale cristiana, ci si poteva aspettare che nell’Italia di quei primi anni sessanta ci fosse un certo qual ribollimento sessuale. Niente affatto. Ostinatamente, le risposte sono date in termini giuridici: pro o contro il divorzio, pro o contro il ruolo preminente del marito, pro o contro l’obbligo per le ragazze a conservare la verginità, pro o contro la condanna degli omosessuali. Come se la società italiana dell’epoca, tra i segreti della penitenza e le prescrizioni della legge, non avesse ancora trovato voce per raccontare pubblicamente il sesso, come fanno oggi diffusamente i nostri media.
«Non parlano? Hanno paura di farlo», spiega banalmente lo psicanalista Musatti, interrogato ogni tanto da Pasolini, così come Moravia, durante la registrazione dell’inchiesta. Ma è chiaro che Pasolini non ci crede affatto. Credo che ciò che attraversi il film non è l’ossessione per il sesso, ma una specie di timore storico, un’esitazione premonitrice e confusa di fronte a un regime che allora stava nascendo in Italia: quello della tolleranza. È qui che si evidenziano le scissioni, in quella folla che tuttavia si trova d’accordo a parlare del diritto, quando viene interrogata sull’amore. Scissioni tra uomini e donne, contadini e cittadini, ricchi e poveri? Sì, certo, ma soprattutto quelle tra i giovani e gli altri. Questi ultimi temono un regime che rovescerà tutti gli adattamenti, dolorosi e sottili, che avevano assicurato l’ecosistema del sesso (con il divieto del divorzio che considera in modo diseguale l’uomo e la donna, con la casa chiusa che serve da figura complementare alla famiglia, con il prezzo della verginità e il costo del matrimonio). I giovani affrontano questo cambiamento in modo molto diverso: non con grida di gioia, ma con una mescolanza di gravità e di diffidenza perché sanno che esso è legato a trasformazioni economiche che rischiano assai di rinnovare le diseguaglianze dell’età, della fortuna e dello status. In fondo, i mattini grigi della tolleranza non incantano nessuno, e nessuno vede in essi la festa del sesso. Con rassegnazione o furore, i vecchi si preoccupano: che fine farà il diritto? E i "giovani", con ostinazione, rispondono: che fine faranno i diritti, i nostri diritti? Il film, girato quindici anni fa, può servire da punto di riferimento. Un anno dopo Mamma Roma, Pasolini continua su ciò che diventerà, nei suoi film, la grande saga dei giovani. Di quei giovani nei quali non vedeva affatto degli adolescenti da consegnare a psicologi, ma la forma attuale di quella "gioventù" che le nostre società, dopo il Medioevo, dopo Roma e la Grecia, non hanno mai saputo integrare, che hanno sempre avuto in sospetto o hanno rifiutato, che non sono mai riuscite a sottomettere, se non facendola morire in guerra di tanto in tanto. E poi il 1963 era il momento in cui l’Italia era entrata da poco e rumorosamente in quel processo di espansione-consumo-tolleranza di cui Pasolini doveva redigere il bilancio, dieci anni dopo, nei suoi Scritti corsari. La violenza del libro dà una risposta all’inquietudine del film. Il 1963 era anche il momento in cui aveva inizio un po’ ovunque in Europa e negli Stati Uniti quella messa in questione delle forme molteplici del potere, che le persone sagge ci dicono essere "alla moda". E sia pure! Quella "moda" rischia di rimanere in voga ancora per un po’ di tempo, come accade in questi giorni a Bologna.
Traduzione dal francese di Raoul Kirchmayr