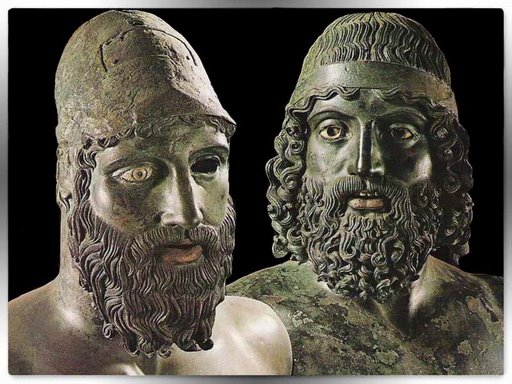
Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione
È in corso il rientro degli emigrati. Vanno a nord. Un flusso notevole, rapido, incisivo.
Dopo le vacanze, in Calabria lo svuotamento s’avverte subito. A settembre, nelle strade dei paesi, specie quelli interni, regna la quiete ordinaria. In giro si respira aria d’attesa; palpabile, consueta, condizionante. Come se dovesse arrivare un Godot capace di restituire fiducia alle comunità, segnate dalle partenze, dalla disoccupazione e dall’incedere del tempo. Come se un evento esterno, mancato troppo a lungo, potesse cambiare stati, dinamiche e destino d’un popolo, colpito dalle dominazioni, dalla mancanza di lavoro e dalla disgregazione sociale.
Per certi versi, le scene di questi giorni riportano al senso del Dialogo d’un venditore d’almanacchi e di un passeggere, di Giacomo Leopardi. Mi riferisco alla proiezione della nostra gente rispetto al futuro, la quale, partiti parenti e amici fuori sede, assume i connotati d’una speranza sommessa e vincolata, ciclica.
C’è la coscienza corale, giusto all’esodo degli emigrati, del ritorno allo statu quo ante: alle scuole, che non di rado registrano meno iscrizioni, alla spesa alimentare, alla preoccupazione per il guardaroba, alle provviste, al silenzio desolante dell’inverno, all’abitudine e alla precarietà sociale.
La realtà è più complessa, perfino altra nelle città degli uffici; ma il racconto dell’appennino calabrese, dell’interno, cioè, spesso declassato col bollo transeunte di «provincia», è ancora limitato alle sagre, alle celebrazioni e alle scaramucce della politica.
Il problema dell’emigrazione - benché drammatico, intanto nelle zone di montagna - non è centrato, non ne è colta la portata reale, non se ne valutano abbastanza gli effetti in ambito culturale, economico, sociale ed anche politico: pregiudizi, timori, chiusure, depauperamento del patrimonio pubblico, diminuzione della domanda di beni, carenza di servizi, aumento dei disagi, permanenza di potentati et coetera.
Di là da sbrigative negazioni e oltre la retorica sul villaggio globale, entro il quale è ritenuto pacifico spostarsi per lavoro, lo spopolamento - purtroppo crescente, nonostante i recenti “rimpatri” indotti dalla crisi - comporta una caduta su tutti i fronti e alimenta l’affezione per folklore e consumismo, strumenti privilegiati della conservazione.
Il primo dipende da un’esigenza di compensare la perdita della memoria, avvenuta negli anni con la distruzione dei segni della storia; sicché, nella definizione dell’identità collettiva, sono stati accentuati elementi secondari od esterni. A San Giovanni in Fiore (Cosenza), per esempio, prevalgono, quali emblemi propri, alcune pietanze e usanze della tradizione, in vero manco tra le più antiche. Mentre va colpevolmente a dissolversi la presenza spirituale dell’abate Gioacchino - testimoniata da leggende popolari (apparizioni di fantasmi in località Junture, che potrebbero essere suggestioni, tramandate, del Visio admiranda de gloria Paradisi, opera riconducibile al profeta). Il consumismo come valore origina, invece, dalla sostituzione della cultura della partecipazione solidale - caratteristica della vita contadina e, anche per causa dei traumi psicologici delle migrazioni, speciale nel dopoguerra - con l’esposizione del superfluo, che in un tempo serve ad apparire e nascondere.
Nella «società liquida» del mercato, emigrare non è ancora, in Calabria, una scelta libera: in generale, il contesto obbliga a cercare altrove occasioni che qui sono precluse. Non c’è una responsabilità del momento, di una parte politica da processare. Piuttosto, si tratta di un’evidenza: se tanti giovani si trasferiscono altrove, dopo gli studi, significa che non confidano nella possibilità di trovare occupazione a casa propria.
Di solito, le controdeduzioni, a riguardo, sono due: i cambiamenti economici e antropologici prodotti dalla globalizzazione e la diffusa incapacità, in Calabria, di rischiare nell’impresa. A questo proposito, l’allargamento delle reti di produzione e commercio e la condivisione di saperi e conoscenze non hanno emancipato la nostra terra dai rapporti di forza tipici; sul presupposto che l’attesa sia più utile della reazione. Dunque, per essere concreti, innanzi all’assistenza a fondo perduto di masse proletarie, non c’è stata un’analisi partecipata delle conseguenze nel lungo periodo, né l’indicazione dell’alternativa radicale. In merito all’imprenditoria, poi, molte volte il successo di un’impresa non si basa, da noi, sulla bontà di un’idea o sull’intraprendenza di chi ci investe soldi e tempo.
Se quanto detto si riscontra, è ora di rinunciare all’attesa e alla rassegnazione; è ora di superare l’emigrazione come esperienza dolorosa - così la descriveva, all’inizio degli anni Novanta, l’etnopsichiatra Salvatore Inglese. È ora di cercare le ragioni che uniscono e di rimuovere quelle che dividono. È ora di ricordare, senza l’illusione o la mitologia dello «zio d’America», che veniamo da migranti, il cui sacrificio ed esempio dimostra il valore d’un popolo intero, sovente reietto in luoghi stranieri ma più spesso smembrato in terra madre.
Forse, il motivo principale per convergere è fermare ulteriori partenze.
Emiliano Morrone e Carmine Gazzanni
Forum
-
> Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione5 settembre 2011, di John MazzeiJohn Mazzei Ciao Emiliano, amico caro...L’emigrazione e’ una brutta bestia. Si puo’ prendere un toro per le corna ma! (Come si fa’ a prendere le corna della brutta bestia "dell’emigrazione"? Comunque buona idea sia sociale che politica ed umanitaria per l’amore del paese e di tutti i paesani stessi. (CONTINUA) ciao
-
> Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione ---- riannodare i fili tra chi è partito e chi è rimasto (e tra chi è rimasto e tra chi è partito)4 settembre 2011, di Federico La Sala
Caro Emiliano
a mio modesto parere, il problema oggi non è più quello di fermare ulteriori partenze, ma riannodare i fili tra chi è partito e chi è rimasto (e tra chi è rimasto e tra chi è partito). Per chi è rimasto e per chi è partito oggi il problema è lo stesso: riprendere ovunque noi siamo il cammino interrotto del sogno di Gioacchino - tutti e tutte insieme - uomini e donne del pianeta - navigare nell’oceano cosmico in spirito di carità ("charitas").
Considera il tuo stesso movimento!
Partire, tornare, ripartire, e tornare ancora....
Dov’è la tua casa? Fatti non fummo per viver come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza - Gioacchino come Dante e come Galilei e come Kant non hanno camminato invano con Ulisse, oltre le colonne degli Ercole del passato come del presente!
Buona permanenza e buon rientro - a casa! Sul pianeta Terra, nell’oceano cosmico!
Molti saluti e buona-navigazione!!!
Federico La Sala
-
> Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione ---- riannodare i fili tra chi è partito e chi è rimasto (e tra chi è rimasto e tra chi è partito)5 settembre 2011, di emiliano
Grazie mille, Prof.
Come sempre, il tuo pensiero illumina e invita a interrogarsi. Questa è filosofia.
Un grande abbraccio,
emiliano
-
> Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione ---- riannodare i fili tra chi è partito e chi è rimasto (e tra chi è rimasto e tra chi è partito)5 settembre 2011, di John Mazzei
Come se un evento esterno...Si! l’evento c’era; era nel proposito di gioacchino ma! Haime’ non e’ riuscito...come anche non e’ riuscito ad avverarsi anche “l’evento e speranze di Obama...citando varie volte nella sua campagna l’ettorale e parlando e conversando con il Governatore...rieletto ancora ad un turno pochi mesi fa’ ...dicevo il Governatore Dello Stato del West Vinginia Joy Mancini.
La differenza e’ solo nel tempo! L’evento che si doveva avverare per adempiere la promessa di: (Yes We Can) Non ci vuole uno scienziato a capire che le promesse non si sono avverate in questi pochissimi anni...Come anche le promesse e le speranze di vedere un paese “auto sufficiente” con lavoro e unita’ di pensiero sia sociale che poilitico e religioso...specializazione di Gioacchino di un grande fallimento e da aggiungere anche (Lungo tempo di fallimento).
-
> Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione ---- riannodare i fili tra chi è partito e chi è rimasto (e tra chi è rimasto e tra chi è partito)7 settembre 2011, di John Mazzei
mancato troppo a lungo...Nei secoli dei secoli e cosi’ sia (Per-SGF) Pochissimi difatti sono quelli che le loro parole vengono sempre ricordate e il loro esempio apprezzato ed imitato...sia nei leader religiosi che politici.
Molti Re anche pre cristiani ed essendo di gerarchia di un popolo che aveva l’approvazione di Dio...fallirono e diedero un cattivo esempio essendo tirannici e persecutori dei loro stessi connazionali (dell’approvata Nazione o POPOLO di Dio) Quindi figuriamocci proprio adesso in questi “Ultimi giorni di questo vecchio sistema di cose” Se un nuovo sistema sara’ mai estaurato sara’ per volonta’ ed intento di Dio (Solamente)
L’uomo ha’ dominato l’uomo a suo proprio danno nei passati 6 mila anni e se! Dio non interverra’ passeranno altri migliaia d’anni.
Avoglia per gli USA stanpare sempre piu’ soldi con il permesso delle famiglie piu’ ricche del mondo...Rockchil- rockfeller ma! La Cina non ne e’ contenta; come anche tante altre nazioni. Comunque Emiliano le “(PAROLE”) Valgono piu’ della carta come denaro o anche oro. Continua a parlare a denunciare ed organizzare.
-
> Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione ---- riannodare i fili tra chi è partito e chi è rimasto (e tra chi è rimasto e tra chi è partito)8 settembre 2011, di John Mazzei
Mi trovo qui’... nella Casa Bianca. Forse; credo che sara’ meglio che ripeta dove in realta’ mi trovi!
Nella CASA BIANCA in Wachington USA; (The White House)
Come ben sapete di gia’; non c’e’ piu’ Busch... ora c’e’ Barack Obama.
L’elegante; colui che cammina ...coordinando il movimento delle braccia al giusto modo...insomma non cammina come un pinguino.
Siamo quasi all’inizio della primavera dell’anno 2009. Immagino che esigete e volete delle spiegazioni...be! anche io le vorrei e se mi darete il tempo e l’opportunita’ vi diro’ perche’ mi trovo qui’ e le ragioni d’esserlo.
Era gia dall’anno scorso che sono venuto a sapere, del fatto che il Senatore Obama aveva avuto qualche contatto con una delegazione Sangiovannese, approvata dal Sindaco;
A. Nicoletti; Primo Cittadino...nel tempo che scrivo del nostro paese; il primo fu’ L’Abate Gioacchino.
La meta della delegazione era quella di visitare piu’ famiglie possibile nello Stato del West Virginia.
Credo che il Senatore Obama avrebbe fatto molta propaganda politica nel West Virginia ed e’ proprio in questo Stato che; la delegazione ebbe in qualche modo oscuro o! preciso di come Obama sia venuto a contatto con la delegazione stessa. Il nostro paese vanta d’avere molti emigranti Sangiovannesi venuti dopo la prima guerra mondiale e altri; addirittura anche prima della guerra.
Gli era stato dato del materiale stampato....ad Obama inerente alla fondazione del nostro paese e del suo Fondatore; L’Abate Gioacchino da Fiore.
Sara’ stato il Governatore Mancini stesso del West Virginia a dirgli al Senatore Obama che una delegazione sarebbe venuta dal suo paese d’origine...in questa stessa estate del 2008?.
Il Governatore gli aveva raccontato tante cose della sua visita al paese d’origine, la bella accoglienza e L’abbazia Florense,
L’arco e la Cittadinanza Onoraria offritagli come dono-d’onore per il fatto d’avere un’antenato...Sangiovannese.
Comunque; non c’e’ da escludere che il Senatore stesso abbia letto di gia’ qual’cosa di Gioacchino da Fiore...in qualche strano e misterioso modo.
Dante stesso aveva citato queste parole al suo riguardo: (“Lucemi da lato lo Calavrese Abate Gioacchino di spirito profetico dotato”)
Molti lavoravano in questo Stato nella miniera di Monongah ed e’ proprio qui’ che un gruppetto di paesani morirono in una traggedia mineraria...nel 1907 e al nostro paese le abbiamo dedicato un monumento per ricordarli.
Obama, avra’ contattato qualche Italo- Americano, Politicante o anche qualche businnes-man d’origine Italiana che li avra’ fatto qualche discorsetto.
La scintilla! nessuno lo sa’ da dove e come sara’ accesa; comunque una cosa e’ certa che; come il Big Bang; NON... attacca o convince...qualche contatto con dei paesani ci sara’ stato.
Prime pagine del mio libro...(Gioacchino Obama ed Io) John Mazzei--- Brurb.com
-
> Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione ---- riannodare i fili tra chi è partito e chi è rimasto (e tra chi è rimasto e tra chi è partito)9 settembre 2011, di John Mazzei
potesse cambiare stati, dinamiche e destino d’un popolo... Come facciamo a cambiare, stati, dinamiche e destino...difficile per il nostro gran bel paese SGF.
Quanti pochi cambiamenti si sono visti accadere...Quanti pochi veramente pochissimi.
Le dinamiche; sempre quelle! Senza un fine, le programmazioni, senza esito e neanche i piu’ grandi scioperi hanno cambiato tanto le cose. Io ho’ paetecipato a quello di Zappa, sotto il bacile ( la necessita’ di avere una strada Variante che vietasse i mezzi di trosporto pesanti e troppo grandi di passare fra il paese...ricordo che cucinammo pasta di tante spece dentro una "Quarara" nel tardi pomeriggio per il fatto che tanti, erano affamati; dopo che avevano usato pico e pala; tutto il giorno, per scavare le tracce della nuova strada Variante e il grande ponte tanto necessaria al nostro paese.
Destino...Io non saprei cosa dire so solo che dal 13 secolo da che il paese fu fondato ...Nessun destino si e’ avverato.
Non so se ci servissero altri due fratelli Bandiera o uno solo bastasse; ma! CHI?
Comunque Emiliano ; Vai avanti, Vai avanti-- Schalom
-
> Calabria: rinunciare alle divisioni per fermare l’emigrazione ---- riannodare i fili tra chi è partito e chi è rimasto (e tra chi è rimasto e tra chi è partito)10 settembre 2011, di emiliano morrone
Un caro abbraccio, amico John.
emiliano
-
-
-
-
-