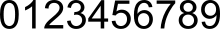
SUL NUMERO "ZERO": UNA RISCOPERTA ARCHEOLOGICA E UN VECCHIO "ELOGIO". Una nota di Laura Anello e una pagina da un libro di Piergiorgio Odifreddi
- [...]
Finora si è creduto che la prima testimonianza dello 0 «posizionale» fosse custodita in India, nel tempio indù Chatur-bhuja (dio a quattro braccia) della città di Gwalior, a sud di Delhi. Un’iscrizione datata intorno al 900 dopo Cristo. Adesso invece il primo 0 del mondo si è palesato in Cambogia, ed è di due secoli precedente a quello di Gwalior, precisamente del 683.
 A scoprire l’iscrizione K-127, citata da alcuni testi a cavallo tra Ottocento e Novecento ma poi scomparsa nel nulla, è stato il matematico e divulgatore scientifico americano di origine ebraica Amir Aczel [...]
A scoprire l’iscrizione K-127, citata da alcuni testi a cavallo tra Ottocento e Novecento ma poi scomparsa nel nulla, è stato il matematico e divulgatore scientifico americano di origine ebraica Amir Aczel [...]
Una lapide a Angkor dimostra che lo zero è nato in Oriente
Riscoperta da uno studioso americano dopo che era andata perduta al tempo di Pol Pot, toglie agli arabi la paternità del sistema decimale
di Laura Anello (La Stampa, 25.11.2014)
Secondo il matematico russo Tobias Dantzig, l’autore de Il numero, il linguaggio della scienza, «nella storia della cultura, la scoperta dello zero si ergerà sempre come una delle più grandi conquiste individuali del genere umano». Un libro che, scriveva Einstein, «è il più interessante sull’evoluzione della matematica che mi sia mai capitato tra le mani». Ecco perché la scoperta - o forse meglio dire la riscoperta - della prima iscrizione al mondo che riporta il segno 0 non è questione che attenga soltanto agli specialisti.
Su quel cerchietto usato in senso posizionale (cioè in grado di determinare il significato di un numero a seconda della sua posizione, per esempio 605, 650, 6500, 6050, 6005) è costruito tutto il nostro sistema decimale. Quello che ci consente di aggiungerlo in coda a una cifra e moltiplicarla per dieci, quello che ci ha permesso di affrancarci dal sistema romano, e poi medievale, che metteva in fila le lettere dell’alfabeto. Ma anche quello che ha dato nuova identità filosofica e concettuale allo 0, lontana dall’idea di «nulla» babilonese e greco.
Finora si è creduto che la prima testimonianza dello 0 «posizionale» fosse custodita in India, nel tempio indù Chatur-bhuja (dio a quattro braccia) della città di Gwalior, a sud di Delhi. Un’iscrizione datata intorno al 900 dopo Cristo. Adesso invece il primo 0 del mondo si è palesato in Cambogia, ed è di due secoli precedente a quello di Gwalior, precisamente del 683.
A scoprire l’iscrizione K-127, citata da alcuni testi a cavallo tra Ottocento e Novecento ma poi scomparsa nel nulla, è stato il matematico e divulgatore scientifico americano di origine ebraica Amir Aczel, che si è messo sulle tracce di testimonianze sommerse per arrivare nella città di Angkor, l’antica capitale del regno Khmer, nel laboratorio di restauro dove l’Università di Palermo guida un progetto internazionale chiamato Trinacria che ha consentito di salvare oltre cento opere.
E tra queste l’iscrizione con il numero d’inventario K-127, originariamente collocata sulla porta del tempio pre-angkoriano di Sambor, vicino al fiume Mekong.
Un’iscrizione rituale di 21 righe in lingua Kmher antica che alla quarta riga riporta il numero 605. «L’era Chaka ha raggiunto 605 il quinto giorno della luna calante», c’è scritto. «Sappiamo che l’era Chaka era iniziata nel 78 dopo Cristo, quindi l’anno di inserimento nel nostro calendario si ricava dall’addizione 605 + 78, cioè 683. Il primo zero che abbiamo mai trovato», chiosa Aczel.
E la questione va ben oltre il semplice primato tra India e Cambogia. Perché è la pietra di suggello sul fatto che lo 0 come base del sistema decimale (perché altri sistemi sono molto più antichi e risalgono indietro nel tempo fino ai babilonesi) sia stato scoperto in Oriente, e non in Occidente, e che gli arabi lo abbiano portato sì da una parte all’altra del mondo: ma da lì a qui, e non il contrario. Affermazione oggi consolidata nella comunità scientifica, ma che agli inizi del 1900 era rivoluzionaria quasi quanto la rivoluzione galileiana.
L’idea diffusa era che lo avessero inventato gli europei. Il matematico britannico George K. Kaye sparava a zero contro l’ipotesi della primazia indiana, contestando allo 0 del tempio di Gwalior di trovarsi in una zona che nel IX secolo dopo Cristo era un califfato arabo. Chi poteva sostenere che non lo avessero portato lì commercianti arabi, dall’Occidente culla di ogni sapere?
Fu proprio l’iscrizione cambogiana del tempio di Sambor, la K-127 ora ritrovata, a demolire la visione «occidentocentrica». L’aveva rinvenuta tra le rovine del tempio del VII secolo, nel 1891, lo studioso francese Adhemard Leclère. Nel 1931 l’archeologo francese Georges Coedes l’aveva tradotta e l’aveva datata a un tempo in cui l’impero arabo non si era ancora esteso fino alla Cambogia. Se quello 0 c’era, scolpito sulla pietra, significava che era stato scoperto lì.
Ma il primato cambogiano era stato dimenticato, così come l’iscrizione era scomparsa nel buco nero dei massacri di Pol Pot, con il suo 1 milione e 700 mila vittime (quasi un terzo della popolazione del Paese) e con le sue 10 mila opere d’arte distrutte. Nessuno ne aveva più memoria, e lo 0 del tempio indiano di Gwalior continuava a essere considerato dalla letteratura scientifica internazionale come il primo 0 «posizionale» del mondo.
Fino a quando quell’iscrizione non è ricomparsa nei laboratori di Angkor. «Ci era stata segnalata dalle autorità cambogiane come un’opera di particolare rilievo - racconta Giovanni Rizzo dell’Ateneo di Palermo - ma si era persa memoria della sua reale importanza, fino a quando il ricercatore dell’Università di Boston Aczel non è arrivato a riscoprirla».
Vista da Aczel, una vera caccia al tesoro. «Sono partito grazie all’appoggio della Sloan Foundation di New York, nonostante tanti testimoni mi raccontassero che la distruzione dei Khmer Rossi era stata troppo radicale per ritenere che esistesse ancora. Ho deciso di fare appello al governo cambogiano, finché il direttore generale del ministero della Cultura e delle Arti Hab Touch mi ha detto che era stata spostata in un compound vicino alla città di Siem Reap, pure saccheggiata alla fine del 1990 in una recrudescenza della violenza. Ho guidato fin lì, ho trovato la struttura chiamata Angkor Conservation, mi sono messo a cercare tra migliaia e migliaia di manufatti archeologici collocati a terra in grandi capannoni. Finché, era un tardo pomeriggio, l’ho trovata. Un’emozione incredibile».
Elogio dello Zero
il volto nichilista della matematica
Dall’arte alla fisica, il valore “esistenziale” dei numeri nel libro di Piergiorgio Odifreddi
 Il nulla ha sempre affascinato la letteratura lo dimostra anche un passo dell’Odissea
Il nulla ha sempre affascinato la letteratura lo dimostra anche un passo dell’Odissea
 L’insieme vuoto è al centro della teoria degli insiemi: ricorda Ibsen e Pirandello
L’insieme vuoto è al centro della teoria degli insiemi: ricorda Ibsen e Pirandello
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 24.11.2014)
- IL SAGGIO Questo testo è tratto da Il museo dei numeri di Piergiorgio Odifreddi (Rizzoli, pagg. 428, euro 22) In libreria dal 26
LO zero, primo elemento della lista dei numeri interi, è in realtà l’ultimo arrivato sulla scena. Gli uomini avevano già effettuato difficili calcoli aritmetici, risolto complicate equazioni algebriche e dimostrato profondi teoremi geometrici per secoli e millenni, prima che gli Indiani e i Maya introducessero in matematica un analogo di concetti quali il nulla, l’assenza, il silenzio, il buio, il non-essere e il vuoto, che erano già stati considerati, più o meno timidamente, in altri campi.
In letteratura, lo zero aveva fatto la sua prima apparizione nell’episodio dei Ciclopi dell’ Odissea, quando Ulisse dichiarò a Polifemo di chiamarsi Nessuno. Molti altri personaggi in seguito ebbero nomi analoghi, dal capitano Nemo di Jules Verne (1870) al Nowhere man dei Beatles (1965).
Se poi si passa alle metafore letterarie del nulla, il discorso si allarga. Una quasi scontata è l’assenza, e le opere che parlano di qualcuno, o qualcosa, che non c’è, o non arriva, abbondano: da Aspettando Godot di Samuel Beckett (1952) a La scomparsa di Georges Perec (1969). Altrettanto immediata è la metafora dell’ombra, che in molte storie si stacca dal rispettivo corpo e acquista vita propria, come per il Casella dantesco e Peter Pan.
C’è poi la metafora del buco, che ha vari archetipi naturali nell’essere umano. La bocca spalancata a voragine, ad esempio, che diede il nome al Caos nella Teogonia di Esiodo (-700 circa). O la vagina, che gli elisabettiani chiamavano in codice “nulla”: di qui l’ammiccante titolo Molto rumore per nulla di William Shakespeare (1599).
Se assenze, ombre e buchi alludono più o meno indirettamente al nulla, la sua realizzazione letterale è il silenzio, a cui hanno incitato, parlando, i mistici di ogni tempo, da Lao Tze a Ludwig Wittgenstein. Il silenzio può anche iniziare un’opera, come la “pausa accentata” che precede il “bussare del destino” della Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven (1808).
La più nota composizione silente è invece 4’ 3-3” di John Cage (1952), articolata in tre movimenti di 30”, 2’23” e 1’40”: un silenzio di 273 secondi in tutto, che richiamano esplicitamente la temperatura di - 273° dello zero assoluto.
Una delle più note metafore concettuali del nulla è il nichilismo: un termine inizialmente introdotto da Ivan Turgenev in Padri e figli (1862), per indicare quel radicale rifiuto dei valori stabiliti che caratterizza il conflitto generazionale. Nell’Ottocento il nichilismo raggiunse la sua massima espressione artistica nei romanzi filosofici di Fëdor Dostoevskij, incarnandosi in personaggi quali Raskolnikov di Delitto e castigo ( 1866), Stavrogin dei Demoni (1873), e Ivan dei Fratelli Karamazov (1879).
Nel Novecento assunse poi varie metamorfosi, dalla “generazione perduta” di Gertrude Stein alla “gioventù bruciata” di James Dean. E culminò infine nella letteratura esistenzialista francese di metà secolo, da La nausea di Jean-Paul Sartre (1938) a Lo straniero di Albert Camus (1942).
Anche la filosofia ha una sua specifica versione di nichilismo, che consiste nell’affermazione di quel genere di nulla che è il non-essere. A farlo venire in essere fu Parmenide, che inventò nel secolo - VI uno dei primi paradossi della storia: quello secondo cui il non-essere non può essere niente, per sua natura, ma allo stesso tempo è qualcosa, cioè appunto il non-essere.
In seguito, più o meno negli stessi anni di Turgenev e Dostoevskij, Friedrich Nietzsche iniziò nel Crepuscolo degli idoli (1888) una rilettura della storia della filosofia post-kantiana. E la interpretò come una progressiva affermazione del nichilismo, nel senso della scoperta della mancanza di senso e del carattere caotico del mondo.
Nella fisica il nulla può essere inteso in due sensi complementari: negativamente, come assenza della materia, e positivamente, come presenza del vuoto. La fisica moderna ha però introdotto un concetto di vuoto energetico più generale, definito come lo stato di energia minima di un campo.
Nel 1929 Paul Dirac immaginò il vuoto quantistico come costituito da un mare di elettroni, in tutti i possibili stati di energia negativa. Se uno di questi elettroni lascia il suo posto a causa di un aumento di energia, il buco da esso lasciato viene percepito come un “antielettrone”, con la stessa massa dell’elettrone, ma carica opposta. Questa nuova particella, chiamata positrone, fu poi scoperta nel 1932. In parte il ritardo per l’introduzione dello zero in matematica è derivato dal rifiuto del nonessere e del vuoto nel pensiero filosofico e scientifico.
Ma, una volta introdotto, esso ha acquistato un’ovvia valenza simbolica che è poi stata sfruttata a fondo, letteralmente e metaforicamente. Basta pensare a espressioni come “zero via zero”, “zero assoluto”, “sentirsi uno zero”. Il più noto uso di quest’ultima metafora si trova forse nel Re Lear di Shakespeare (1606), quando il Buffone apostrofa il re ormai senza corona, dicendogli: «Ora sei uno zero senza valore. Io sono meglio di te: sono un buffone, ma tu non sei niente».
In matematica esiste anche l’insieme vuoto, che non contiene nessun elemento. L’insieme vuoto è l’analogo di una scatola vuota. Ma mentre di scatole vuote ce ne sono molte, perché nella vita il contenitore conta, di insiemi vuoti ce n’è uno solo, perché in matematica conta solo il contenuto. E come la geometria degli antichi è costruita a partire dai punti, così la teoria degli insiemi dei moderni si costruisce a partire dall’insieme vuoto. Essa si riduce dunque letteralmente a un edificio di pure forme, che si dissolve in ultima analisi nel nulla: una visione, questa, molto vicina alla shunyata buddhista, per la quale le cose non sono solo contenitori vuoti, ma sono vuote apparenze di contenitori. Allo stesso modo, si rimane con niente in mano se si cerca l’essenza della cipolla pelandola, come nel Peer Gynt di Henrik Ibsen (1867), o in Vestire gli ignudi di Pirandello (1922). O se si cerca l’essenza del carciofo sfogliandolo, come nelle Ricerche filosofiche di Wittgenstein (1953).
Forum
-
> SUL NUMERO "ZERO" -- Caccia allo zero. La testimonianza più antica in Cambogia. Le radici filosofiche in India. L’elaborazione più raffinata degli studiosi musulmani. Fibonacci lo portò in Europa.7 febbraio 2016, di Federico La Sala
Il primo zero
 La testimonianza archeologica più antica è in Cambogia
La testimonianza archeologica più antica è in Cambogia
 Ma le radici filosofiche sono in India
Ma le radici filosofiche sono in India
 E l’elaborazione più raffinata si deve agli studiosi musulmani che inventarono l’algebra
E l’elaborazione più raffinata si deve agli studiosi musulmani che inventarono l’algebra
 Finché il giovane pisano Leonardo Fibonacci non lo portò in Europa
Finché il giovane pisano Leonardo Fibonacci non lo portò in Europadi Amedeo Feniello (Corriere della Sera, La Lettura, 07.02.2016)
L’uomo, nella sua storia, di rivoluzioni ne ha viste tante. Una, però, stupisce più delle altre. Talmente grande che, ai nostri occhi, quasi svanisce. Perché ormai banale. Scontata. La rivoluzione dei numeri. Una rivoluzione tutt’altro che rapida. Ma lenta e tortuosa. Capace di avviluppare, nel corso dei secoli, tre continenti: Asia, Africa ed Europa. Regalandoci nove cifre e, con esse, lo zero. Il tutto, ben combinato, rende possibile l’impossibile. Rappresentare - e calcolare - qualunque tipo di numero di qualunque grandezza, minima quanto incommensurabile. Con grazia. Con facilità. Brevi linee che, per parafrasare Shakespeare, mescolate tra loro permettono a semplici sgorbi di trasformarsi in milioni di miliardi. Tendenti all’infinito.
Dove comincia questa storia? Non nell’Impero romano, in cui l’idea dello zero era assente e l’elaborazione del calcolo arcaica e farraginosa. Ma lontano. In un Oriente magnifico, fantastico, semisconosciuto. Ma di preciso? L’itinerario è vasto. Va dalla Mesopotamia all’India fino alla Cambogia. Là dove, racconta Amir D. Aczel nel suo libro Caccia allo zero (Raffaello Cortina), a Sambor Prei Kuk negli anni Venti del Novecento il francese Cdès portò alla luce la prima testimonianza archeologica dello zero, che anticipa almeno di due secoli quella indiana di Gwalior, risalente al IX secolo della nostra era.
Tracce archeologiche. Evidenti. Che ci riportano al nostro Medioevo. Ma il cammino è tanto più antico. A partire proprio dalla penisola indiana. Dove il cuore di tutto è lo Shunya . Che in indiano significa zero. Termine legato all’idea buddhista di nulla, che viene definito infatti Shunyata . Insomma, lo zero, il numero e il nulla buddhista - lo scopo della meditazione e un ideale cui aspirare per raggiungere il Nirvana o illuminazione - sono una cosa sola. Figli dello stesso concetto filosofico. Profondo, ricco di simboli e di implicazioni. È lì la matrice di ogni ragionamento.
Nella pratica, il nuovo sistema che nasce si basa su tre idee chiave: le notazioni per le cifre, il valore posizionale e lo zero. Sistema che viene elaborato nel Brahmasphuta Siddhanta di Brahmagupta (VII secolo), che, per primo, descrive lo zero come il risultato che otteniamo quando sottraiamo un numero da se stesso. Ma se dottrina filosofica e matematica si fondono nel mondo indiano, è la concretezza dei mercanti dell’economia-mondo musulmana altomedievale che mette in moto questa macchina fatta di cifre facili da adoperare nelle transazioni. Con una raffinatezza di calcolo che si accentua di momento in momento, di anno in anno. Attraverso elaborazioni che prevedono percentuali, frazioni, risoluzioni algebriche, progressioni ecc.
Un’onda che secoli prima del Mille conquista Bagdad e l’intero Nord Africa. Con matematici straordinari. Tra i più grandi? Al-Khwarizmi, vissuto probabilmente tra il 750 e l’850, dal cui nome volgarizzato in latino deriva il termine algoritmo. L’autore dell’ Al-Kitab , il trattato su quella che noi oggi chiamiamo l’algebra, nel quale è presente un approccio sistematico alla soluzione delle equazioni lineari, con un’ampia spiegazione di come si risolvano quelle polinomiali fino al secondo grado. Un mondo in cui lo zero espande la sua influenza e gli vengono conferiti attributi per sottrarlo all’opacità della sua essenza di Niente che, aggiunto a qualcosa come un numero, si trasforma in Tutto. Attributi che fioccano: lo chiamano il Nulla o il Vuoto o il Vento: Sifr, termine che designa la cifra per eccellenza. Parola derivata verosimilmente da Zephirus, da cui zero.
Per l’Europa, la storia dello zero e dei suoi nove compagni comincia molto dopo. E lontano dalle sue coste. Si parte dalla città nordafricana di Bugia di Barberia, dove, alla fine del XII secolo, un giovane pisano, Leonardo Fibonacci, come racconta lui stesso nel Liber abaci, viene istruito fin dall’infanzia da maestri musulmani «nell’abaco al modo degli Hindi» e a conoscere le «nove figure dei numeri usati dagli indiani».
Va detto che Leonardo non era il primo occidentale a conoscere questa numerazione. In realtà, altri avevano assorbito dalla Spagna musulmana la conoscenza delle nuove cifre. Basti pensare al Codex Vigilanus, del 976. Oppure a Gerberto d’Aurillac, Papa Silvestro II, che, circa negli stessi anni, cerca di migliorare l’efficienza dell’abaco, usando simboli che adoperano una forma primitiva di cifre indo-musulmane.
Tuttavia, prima di Fibonacci nessuno in Occidente aveva compreso le potenzialità dei numeri indo-musulmani da applicare in maniera costante sia al mondo del commercio sia nella vita quotidiana. È a partire da lui che si comincia a sfruttare al meglio questa innovazione, trasformandola in qualcosa di eccezionale. Però, non fu una passeggiata. Per Guglielmo di Malmesbury i numeri non sono altro che pericolosa magia saracena. Firenze, alla fine del Duecento, ha paura dello zero, cifra oscura e segreta, e lo proibisce. Un pregiudizio che dura a lungo: ad esempio all’Università di Padova i bibliotecari erano tenuti a scrivere i prezzi dei libri «non per cifras sed per litteras claras». Nel 1494 il sindaco di Francoforte ancora dava istruzioni ai suoi capi contabili di «astenersi dal calcolare con le cifre». Addirittura nel 1549 un canonico di Anversa ammoniva i mercanti a non usare i numeri nei contratti e negli affari.
Ma si tratta di scorie, in una società dove avanza a grandi passi la razionalità contabile delle compagnie internazionali italiane ed europee. E l’intuizione, nata nelle foreste della Cambogia e dell’India, ha ormai mutato pelle, in profondità: non più patrimonio di pochi iniziati, avvezzi ai simboli e alle pratiche filosofico-numeriche, ma strumento rivoluzionario di conoscenza e di controllo della realtà. Emblema della nuova epoca rampante, inarrestabile e aggressiva del capitalismo e dell’egemonia occidentale.
-
> SUL NUMERO "ZERO": UNA RISCOPERTA ARCHEOLOGICA E UN VECCHIO "ELOGIO". --- Due neuroni per uno zero (di Giorgio Vallortigara).17 gennaio 2016, di Federico La Sala
- ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
Due neuroni per uno zero
Una nuova scoperta mostra cosa succede nel cervello quando percepiamo l’insieme vuoto: è visto sia come un numero tra gli altri numeri posti in una scala sia come uno scarto tra nulla ed esistenza di qualcosa
di Giorgio Vallortigara (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.01.2016)
- Okuyama, S. et al. Representation of the numerosity «zero» in the parietal cortex of the monkey , Scientific Reports, 5, 10059; doi: 10.1038/srep10059
Provate a chiedere a un bambino di quattro, cinque anni, quando già sa recitare impeccabilmente la sequenza dei numeri naturali, «zero, uno, due, tre...», quale sia il numero più piccolo: molto probabilmente vi risponderà che è l’uno e non lo zero. C’è una fase dello sviluppo cognitivo in cui l’uso del simbolo «zero» per indicare l’assenza di qualcosa non è ancora accompagnato da una piena comprensione delle relazioni d’ordine tra lo zero e gli altri numeri. Lo sviluppo storico del pensiero matematico sembra ricapitolare queste difficoltà. L’introduzione di una notazione simbolica per lo zero è relativamente recente. L’impiego dello zero come un vero numero, manipolabile aritmeticamente, compare, in India, tra il terzo e il sesto secolo (i Babilonesi usavano lo zero solo con funzione di segnaposto, e lo stesso pare abbiano fatto i Maya e gli antichi Cinesi).
In questi ultimi anni, però, abbiamo imparato che creature del tutto prive di un simbolo per lo zero, come gli animali delle altre specie o i bambini più piccoli, possono nondimeno cogliere l’idea di un insieme vuoto e rappresentarselo come un’autentica entità numerica. Per farlo impiegano quello che gli scienziati definiscono «sistema approssimato del numero» o, in termini più colloquiali, «senso del numero».
Il segno distintivo del senso del numero è l’«effetto distanza». Si fa prima e si commettono meno errori a decidere, per esempio, se sia più grande «otto» o «diciotto», che non «otto» e «dodici». La prestazione è cioè tanto migliore quanto più i due numeri sono distanti. Lo stesso accade se anziché usare simboli come i numeri arabi si mostrano sullo schermo di un computer degli insiemi di pallini di differenti numerosità. E’ notevole che nei due casi succeda la stessa cosa.
Con i simboli, infatti, molti aspetti diversi potrebbero causare confusione: ad esempio, il fatto che i simboli si assomiglino fisicamente («otto» e «diciotto» hanno l’«otto» in comune, che invece «otto» e «dodici» non hanno) oppure che si assomiglino i suoni che produciamo per pronunciarli (i suoni per «otto» e «diciotto» si somigliano di più dei suoni per «otto» e «dodici»). Eppure tutto ciò non importa: è come se, per eseguire il confronto, i suoni o i segni dei simboli fossero convertiti automaticamente nel cervello nei valori delle rispettive quantità.
Il senso del numero è ubiquo nel mondo animale, si ritrova nei pesci e negli uccelli, nei mammiferi e negli anfibi, forse perfino negli insetti come le api, e supporta una matematica approssimata che consente di effettuare le operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni, divisioni).
Adesso immaginate un semplice esperimento nel quale si debbano ordinare delle quantità non simboliche, come appunto dei pallini sullo schermo di un computer. Compaiono sullo schermo, poniamo, un insieme di otto pallini e uno di dodici pallini; poi uno di otto e uno di diciotto... e così via. Ogni volta la consegna è di ordinare le due quantità, pigiando su un touch screen prima il numero più piccolo e poi quello più grande. è un compito che può imparare facilmente un bambino di età prescolare, ma anche una scimmia.
Che accade se, quando l’apprendimento è ormai ben consolidato, sullo schermo vengono presentate delle coppie nelle quali uno dei due insiemi di pallini è pari a «zero» (cioè costituito di nessun pallino)? I bambini, ma anche le scimmie, rispondono correttamente: prima pigiano in corrispondenza dell’insieme vuoto e poi del numero (lo fanno anche quei bambini che quando sono interrogati verbalmente su quale sia il numero più piccolo nella serie dei numeri rispondono che è l’uno anziché lo zero). E siamo certi che questa dell’insieme vuoto sia davvero una rappresentazione numerica, perché anche qui fa la sua apparizione la firma caratteristica del senso del numero: l’effetto distanza. Si fa prima a dire che zero pallini è più piccolo di dodici pallini che non a dire che zero pallini è più piccolo di quattro pallini (e non c’entra quanta area occupano i pallini, perché l’effetto della distanza si osserva anche quando quattro pallini grandi occupano un’area maggiore di quella occupata da dodici pallini piccoli). Ma a cosa corrisponde, nel cervello, questa rappresentazione primitiva dell’insieme vuoto, dello zero pre-simbolico?
Già si sapeva che in una porzione posteriore del lobo parietale nella scimmia (e, con ogni probabilità, anche nella specie umana) ci sono neuroni la cui frequenza di scarica è modulata dalla numerosità. Ad esempio, ci sono neuroni che hanno un picco massimo di risposta quando l’animale vede cinque pallini o cinque quadratini o sente cinque suoni... insomma quando percepisce la «cinquità» di un insieme di elementi. La codifica della numerosità è continua e non discreta, così come ci si aspetta dal senso del numero: il neurone che risponde a «cinque» in maniera ottimale risponde un po’ meno al «sei» e al «quattro», ancor meno al «sette» e al «tre» e così via.
Ora però Okuyama e colleghi dell’Università Tohoku, in Giappone, hanno osservato che vi sarebbero due diversi tipi di neuroni per lo zero, neuroni a risposta «continua» che, come per le altre numerosità, hanno un massimo di frequenza di scarica per l’insieme vuoto (nessun pallino) e frequenze via via digradanti per le altre numerosità (un po’ di risposta a un pallino, un po’ meno a due pallini... e così via) e neuroni a risposta «esclusiva» che invece aumentano la frequenza di scarica solo quando c’è lo zero (l’assenza di pallini) e non presentano alcuna variazione di risposta per qualsiasi altra numerosità (un pallino, due pallini...).
Lo zero sta per il nulla, l’assenza anziché la presenza e, forse, possiede per questa ragione una rappresentazione neurale un poco speciale. Se poi il nulla sia qualcosa o non lo sia è un problema sul quale molto si sono affaticati i logici e filosofi medievali, e che non considereremo qui. Invece vale la pena notare che tra nulla e qualcosa, tra esistenza e non esistenza, potrebbe sussistere un’asimmetria cognitiva.
Alcuni esperimenti della psicologa cognitiva Karen Wynn hanno mostrato che infanti di otto mesi che vedono un oggetto occultato da uno schermo si meravigliano assai quando all’abbassarsi dello schermo l’oggetto appare essere scomparso. Gli infanti, cioè, ritengono che anche se non lo vedono più, l’oggetto continui ad esistere dietro lo schermo. Tuttavia quel che vale per l’assenza non sembra esser vero per la presenza. Se vedono che un oggetto è stato sottratto da dietro uno schermo che l’occultava, non si meravigliano poi di vederlo «magicamente» ricomparire quando lo schermo viene abbassato. Difficile asserire se per loro sia un nuovo oggetto, un sosia, o lo stesso oggetto.
Su Tlön, il pianeta immaginato da Borges in Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (http://24o.it/pPjzyY), le cui nazioni «sono - in maniera congenita - idealiste» non è infrequente la duplicazione degli oggetti perduti: «Due persone cercano una matita, la prima la trova e non dice nulla; la seconda trova una seconda matita, non meno reale, ma più conforme alle sue aspettative».
Sul nostro pianeta, invece, fino a una certa età, la rappresentazione della presenza di un oggetto sembra slegata da quella della sua assenza: gli oggetti non possono magicamente scomparire, ma possono magicamente apparire. Forse i neuroni che segnalano lo zero come entità continua si sviluppano prima o in modo distinto da quelli che segnalano l’assenza in modo discreto. Così quando vi sono elementi da contare i bambini intuiscono che zero è un numero: il valore minimo nel continuo rappresentato dal sistema analogico del senso del numero. Ma se non c’è una quantità contabile, allora resta solo la rappresentazione del subitaneo assurgere all’esistenza di un «qualcosa» o, forse, tramite i neuroni a risposta discreta, di quel qualcosa la vertiginosa assenza.
-
> SUL NUMERO "ZERO": UNA RISCOPERTA ARCHEOLOGICA --- Maya batte Khmer zero a zero. Lo zero è il risultato di due invenzioni indipendenti (di Antonio Aimi).17 dicembre 2014, di Federico La Sala
Maya batte Khmer zero a zero
Questo numero era in uso nelle civiltà mesoamericane già nel I secolo a.C.: molto prima della traccia ritrovata in Cambogia, che uno studioso Usa giudica la più antica
di Antonio Aimi
 Professore di Civiltà precolombiane all’Università degli Studi di Milano *
Professore di Civiltà precolombiane all’Università degli Studi di Milano *Pochi giorni fa tutto il mondo scientifico è stato sorpreso da un articolo che annuncia l’imminente pubblicazione di un libro sull’«origine del numero zero« (ne ha parlato La Stampa del 25 novembre). Nell’articolo, apparso sulla prestigiosa rivista della Smithsonian Institution, Amir Aczel, un matematico e divulgatore statunitense, racconta con enfasi (lo stesso autore parla della sua ricerca come di una «ossessione») di aver trovato a Sambor, nella giungla della Cambogia, un monumento del 683 d.C. che documenta la più antica traccia dello zero. Ma è proprio vero che quello è lo zero più vecchio del mondo?
Con buona pace di Aczel occorre dire chiaramente che l’antichità dello zero di Sambor è ben poca cosa rispetto a quello delle culture mesoamericane che avevano inventato e usavano questo numero alcuni secoli prima del 683 d.C. Vuol dire che la notizia è una bufala? Certamente no. Anzi, al netto dei toni molto sopra le righe, la notizia, se sarà confermata dalla comunità scientifica, sembra importante e merita l’attenzione di tutti.
Le date sul Conto Lungo
Come è possibile? È possibile perché lo stesso Aczel da un lato non esita a sparare il «primato mondiale» di Sambor, dall’altro riconosce lo zero dei Maya (per lui sminuito dal fatto di non aver mai «lasciato l’America») e spiega che la sua ricerca si limita allo studio dello zero del nostro sistema numerale (quello di numeri cosiddetti arabi). Cercando di non trasformare la questione dell’origine dello zero in una sorta di gara, sembra importante chiarire la situazione, perché conoscere la matematica, i numeri e il loro uso nelle culture precolombiane è un importante passo in avanti per capirle dall’interno.
«Anche in Mesoamerica, come a Sambor», ci spiega l’epigrafista Raphael Tunesi, «le date scritte sui monumenti sono i documenti fondamentali da cui partire per verificare la presenza dello zero. Qui, però, basta una data del Conto Lungo [il ciclo calendariale di 5125,3661 anni di cui si è tanto parlato a sproposito nel 2012, ndr] per dimostrare l’esistenza dello zero, perché questo calendario funziona con lo zero e senza lo zero non esiste.
Il Conto Lungo, infatti, era composto da cinque numeri che rappresentavano cinque cicli correlati [quello dei k’in (giorni), degli uinal (mesi di 20 giorni), dei tun (anni di 18 uinal, cioè di 360 giorni), dei katun (periodi di 20 tun, cioè di 7.200 giorni) e dei baktun (periodi di 20 katun, cioè di 144.000 giorni)] che andavano da zero a 19 e, in un caso, da zero a 17 e poi si azzeravano facendo aumentare di una unità il ciclo superiore».
A quanto dichiara Tunesi si possono aggiungere due osservazioni importanti:
 1) i numeri del Conto Lungo avevano un valore posizionale e potevano essere usati per far di conto, come ha mostrato la recente scoperta della «lavagna» (in realtà, un muro bianco) dello scriba di Xultun;
1) i numeri del Conto Lungo avevano un valore posizionale e potevano essere usati per far di conto, come ha mostrato la recente scoperta della «lavagna» (in realtà, un muro bianco) dello scriba di Xultun;
 2) se si considera che il Conto Lungo, prima di essere adottato dai Maya, era stato inventato dalle culture epiolmeche negli ultimi decenni del primo secolo a.C., appare evidente di quanto l’America precolombiana abbia anticipato il Vecchio Mondo.
2) se si considera che il Conto Lungo, prima di essere adottato dai Maya, era stato inventato dalle culture epiolmeche negli ultimi decenni del primo secolo a.C., appare evidente di quanto l’America precolombiana abbia anticipato il Vecchio Mondo.Invenzioni indipendenti
Limitandosi, infine, alle date mesoamericane che effettivamente mostrano lo zero, tra quelle che precedono il monumento di Sambor, si può segnalare l’iscrizione del verso della Stele 31 di Tikal, che si apre con la data del Conto Lungo 9.0.10.0.0 (10 dicembre 435) e che fu eretta durante il regno di Sihyaj Chan K’awiil (411- 456 d.C.). Pur non volendo trattare la questione dell’origine dello zero come una gara, pare evidente che il primato di Epiolmechi e Maya è indiscutibile.
Tuttavia, dato che la ricerca di Aczel non si limita solo a questa questione, ma prende in esame anche la questione della diffusione del numero dalla Cambogia all’India, agli Arabi, a Fibonacci, è interessante osservare che in America non ci fu nessun processo del genere, perché, al di fuori della Mesoamerica, le culture precolombiane mostrano non solo di non aver recepito l’invenzione dello zero, ma nemmeno quella della scrittura di cui i numeri erano parte fondante.
È noto, infatti, che nell’Area peruviana, che ebbe contatti abbastanza regolari ma indiretti con la Mesoamerica, il sistema di calcolo era totalmente differente e che, in quechua, la lingua degli Inca, non esisteva una parola per indicare lo zero. Non solo, ma anche nella Mesoamerica il Conto Lungo cessò di essere usato dagli stessi Maya alla fine del Periodo Classico e non fu mai adottato dalle altre culture mesoamericane.
Quindi, contro le favole di un facile diffusionismo, occorre riconoscere che ogni cultura ha le sue idiosincrasie e non è affatto detto che l’arrivo di un’invenzione potenzialmente utile (lo zero, la scrittura, ecc.), porti ad accettarla.
Volendo, però, fare l’avvocato del diavolo, si potrebbe riconoscere che rimane aperta una questione. Visto che lo zero della Mesoamerica è più antico di quello della Cambogia, è possibile che, al contrario di quanto generalmente si pensa, abbia attraversato il Pacifico e sia andato dall’America all’Asia? Premesso che risposte certe, ovviamente, non ci saranno mai, occorre dire con chiarezza che:
 1) oggi come oggi non c’è uno straccio di dato a favore di questa ipotesi;
1) oggi come oggi non c’è uno straccio di dato a favore di questa ipotesi;
 2) lo scenario di un contatto diretto o attraverso intermediari tra la Cambogia e l’Area Maya è inconsistente.
Pertanto, occorre prendere atto che, quasi certamente, lo zero è il risultato di due invenzioni indipendenti.
2) lo scenario di un contatto diretto o attraverso intermediari tra la Cambogia e l’Area Maya è inconsistente.
Pertanto, occorre prendere atto che, quasi certamente, lo zero è il risultato di due invenzioni indipendenti.* La Stampa 17.12.2014
-
> SUL NUMERO "ZERO": UNA RISCOPERTA ARCHEOLOGICA E UN VECCHIO "ELOGIO". Una nota di Laura Anello e una pagina da un libro di Piergiorgio Odifreddi30 novembre 2014, di Auguste RussellCara autrice, credo che la scoperta dello "0" in Cambogia sia l’ennesima Bufala. A tale proposito le invio il mio commento alla dichiarazione del Prof. Giovanni Rizzo su "Miracolo Italiano di Radio 2 GR2 del 29/11/2014). La "bufala" dello "0" Cambogiano (Commento a Miracolo Italiano GR2) Cari conduttori, questa mattina, 29 Nov, ho ascoltato il commento del prof. Rizzo, dell’università di Palermo, in merito allo scoperta dello 0 su lapide Cambogiane (K127). Innanzitutto ci terrei a dire che la (K127) è una scoperta non recente ed ampiamente documentata dagli storici della scienza come il prof. Georges Ifrah, dell’Università di Parigi, che nella sua "Enciclopedia universale dei numeri" - Mondadori 2008 - cita a pagina 790 e 791 la lapida (K127), e non solo, che commenta così: "Come si è visto, le differenti cifre utilizzate nel Sud-Est asiatico non erano state in fondo nient’altro che varianti paleografiche di quelle di origine indiana, anch’esse nate dall’antica notazione "Brahmi" delle prime nove unità." E poi, " D’altra parte, oltre all’uso della numerazione con termini sanscriti (lingua colta della civiltà indiana), tutte queste iscrizioni vernacolari rivelano che le date corrispondenti erano state indicate esclusivamente, per molti secoli, seguendo un calendario di cui nessuno avrebbe potuto contestare l’origine indiana: l’era "Shaka" degli astronomi dell’India"; e ancora, " Questi fatti sono tanto più importanti in quanto riguardano le civiltà indiane dell’indocina e dell’indonesia (Cambogia, Champa, Giava, Bali e Malesia), di cui si conosce la forte indianizzazione dai primi secoli della nostra era, in ragione, da un lato, della grande espansione dello Shivaismo e del Buddismo e, dall’altro del grande ruolo di intermediari da loro rivestito nel commercio di spezie, seta e avorio tra l’india e la cina".... Il Prof. Ifrah, conferma quindi, nella sua tesi, che lo "0" ha origine Indiana. Altra conferma arriva dal prof. Agostino Agrillo, presidente del " Museo degli strumenti per il calcolo di Torino" che nella sua pubblicazione sulla "Storia degli strumenti per il calcolo", conferma la tesi di Georges Ifrah sull’origine dello "0". Rif. Sito: http://museostrumenticalcolo.altervista.org/joomla/
-
> SUL NUMERO "ZERO": UNA RISCOPERTA ARCHEOLOGICA E UN VECCHIO "ELOGIO". Una nota di Laura Anello e una pagina da un libro di Piergiorgio Odifreddi22 marzo 2015
Dopo aver letto ’Finding zero’ in cui Amir D. Aczel racconta la sua fortunata e fortunosa caccia al primo Zero della storia (Maya esclusi, come riconosce lo stesso autore), vorrei fare alcune puntualizzazioni:
Amir Aczel sostiene non di aver scoperto, ma solo RIscoperto il primo ZEro, il cui vero scopritore (più volte citato nel testo fu Coedes)
L’autore non sostiene che lo zero sia ’nato’ in Cambogia, ma semplicemente che,vista la datazione dell’iscrizione K127, le sue origini non possano essere ne’ arabe, ne’ tanto meno europee.
Il libro (cap 22) mette in cattiva luce gli archeologi dell’Universita’ di Palermo (Pellegrino e Taormina) e di Torino (Rava), non solo perché avrebbero tentato di attribuirsi la scoperta ma anche per il loro modo d’insegnare le tecniche del restauro ai loro allievi cambogiani, descritto nei dettagli da Aczel e da lui stesso definito (giustamente se la sua descrizione è veritiera) travesty (farsa).
A questo proposito non sono a conoscenza di repliche da parte dei ricercatori italiani.
-