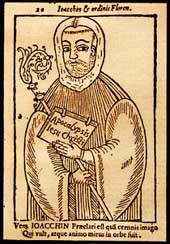
Antimafia: Calabria, utopia di Gioacchino da Fiore, Genchi, De Magistris, Stato di polizia, fuga dei cervelli, Paolo Borsellino, movimento culturale
domenica 24 ottobre 2010.Basta partire dall’Italia, anche per pochi giorni, per stimare con raffronti il nostro grado di libertà, civiltà e democrazia.
Io credo che ognuno di noi, in un modo o nell’altro, si sia abituato alla quotidianità nazionale; fatta di polizia, controlli, squilibrio tra i poteri dello Stato, terrore, speculazioni e propaganda.
Penso che pure nell’antimafia civile esista la convinzione che il Belpaese sia bello e comodo, tutto sommato, colmando delle lacune. Se così non fosse, non mi spiegherei il perché di frequenti "scaramucce tra poveri". Mi riferisco, nello specifico, a inopportune divergenze interne, spesso cariche di partecipazione emotiva. Fabrizio De Andrè diceva che "si accontenta di cause leggere la guerra del cuore".
Ritengo che una piena coscienza della situazione italiana sfugga alla maggioranza della società, a partire dal sottoscritto. Soprattutto, non abbiamo cognizione delle cause del degrado generale né delle soluzioni possibili.
Proprio in seno ai "nostri" movimenti, s’è diffusa l’idea che la politica sia un affare sporco e che farla, piuttosto che subirla, significhi aderire a una lobby di imbrogli, illegalità, sopraffazioni e malaffare.
In questi giorni, ho letto vari commenti sulla candidatura al parlamento europeo dell’ex pm di Catanzaro Luigi De Magistris. Qualcuno (di noi) c’è rimasto male per non aver ricevuto la notizia dal magistrato, tramite telefonata o breve messaggio di testo. Per questo, ha sentito il bisogno di esternare il suo disappunto alla stampa e in rete. Altri (fra di noi) hanno interpretato la scelta di De Magistris come "segnale preoccupante".
Io non mi pronuncerò, persuaso che la decisione di De Magistris vada rispettata e che nel suo contesto non si possa considerare un atto eticamente riprovevole o contraddittorio.
Chiedo, piuttosto, se il problema italiano sia la candidatura di Luigi De Magistris o di chi, come Sonia Alfano, ha manifestato dissenso in tante occasioni, aspirando civilmente a una giustizia terrena.
Da anni, "la Voce di Fiore" divulga, tentando di attualizzarlo, il messaggio di speranza dell’esegeta Gioacchino da Fiore, "di spirito profetico dotato" nel Paradiso di Dante Alighieri. L’abate riteneva che la giustizia si vedesse qui, dopo l’"Età del Figlio"; così divergendo dallo schema tipico del cattolicesimo, neoplatonico, per cui premio o condanna individuale avvengono nell’altro mondo.
A proposito di profetismo, prima di noi, e con eccezionale autorevolezza, don Peppe Diana scriveva, rivolgendosi alla Chiesa: "Che non rinunci al suo ruolo ’profetico’ affinché gli strumenti della denuncia e dell’annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici e civili".
Probabilmente, il nostro riferimento all’asceta calabrese, che non ha significato e senso solo per la Calabria, è stato sbrigativamente bollato come esercizio filosofico; quasi il frutto d’un intellettualismo fine a se stesso, lontano dalla realtà e dalla dilagante corruzione italiana. Parallelamente, giornalisti seri e impegnati hanno insistito a lungo sul valore risolutivo delle manette, delle carceri, delle pene; riprendendo argomenti e linguaggio d’una parte politica che scommette in largo sul valore taumaturgico della repressione.
Pur riconoscendo l’importanza del lavoro svolto da questi colleghi, io non credo che l’Italia tornerà ad essere una Repubblica democratica, fondata anzitutto sul lavoro, col mero inasprimento delle sanzioni. Ciò non è sufficiente. Addirittura, per molti versi peggiora le cose. In proposito, davvero si dovrebbero ricuperare le lezioni di politica penale del compianto Federico Stella, che faceva riflettere i suoi studenti sulla concezione utilitaristica della pena (Cesare Beccaria).
L’Italia è già uno Stato di polizia. Lo dimostrano chiaramente le traversie di Gioacchino Genchi, Luigi De Magistris e colleghi, le migliaia di telecamere in varie città italiane, la moltiplicazione dei militari, la presenza di vigilanti armati nelle metropolitane e i divieti di vivere gli spazi urbani con musica e poesia. A questo possiamo aggiungere i limiti alla libertà di informazione, l’uso dissuasivo delle querele e, a sostegno dell’isolamento del Palazzo, i meccanismi di voto, la compressione delle intercettazioni telefoniche e altro.
Chiaramente, in ogni Stato di polizia che si rispetti, i cittadini devono essere ridotti all’osso; devono portarsi dietro, a vita, debiti personali e pubblici. Mentre le banche, che si giovano di sovvenzioni prodotte dalle nostre fatiche, continuano a dissanguarci in piena regola o, in tanti casi, fuori della legge, muto lo Stato.
Io sono certo, pronto a ricredermi se sbaglio, che un simile ordine delle cose non è soltanto il frutto dell’azione di poteri più o meno occulti, di una politica affaristica quanto padrona. E sono certo che dobbiamo farci un’idea diversa sulla criminalità organizzata. Spesso tendiamo a identificarla con un gruppo di soggetti spietati, feroci e privi di scrupoli, capaci di spostare tonnellate di tritolo e importare od esportare armi devastanti; capaci di penetrare nelle istituzioni e modificare scelte finanziarie o di intervento pubblico.
L’affermazione della criminalità, intesa in senso classico o alla luce delle verità che emergono, per esempio, da Palermo e Catanzaro, ha molto a che fare con la perdita individuale e collettiva di identità e dignità. Ha da vedere, in sintesi, con la rivoluzione culturale, sospinta dai media, per la quale i giovani sono diventati consumatori di polvere - in tutti i sensi. Ha da vedere, in sostanza, con la creazione di nuovi modelli culturali e antropologici, nell’Italia di Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Antonio Vivaldi, Enrico Fermi, Luigi Pirandello, Carlo Rubbia, Rita Levi Montalcini, Dario Fo, Tommaso Campanella e Gioacchino da Fiore.
Questo elenco è puramente rappresentativo: potrebbe essere interminabile. L’Italia, crocevia di popoli e fucina d’arte, cultura e civiltà, s’è trasformata in una caricatura perpetua, nella fabbrica dell’omologazione, nel laboratorio televisivo dei "nuovi mostri", nella chiesa che loda l’idiozia, l’arroganza, la violenza, la sopraffazione, la volgarità, l’indecenza, la spavalderia, l’illegalità, l’assenza di contenuti. La religione nazionale si sostanzia nell’idolatria del brutto, della stoltezza, della deficienza, della frode e della ripetitività. Il genio italiano è stato annientato: prosegue, a ritmo incessante, la fuga di cervelli e talenti. Emigrazione necessaria, di cui la Calabria è assieme emblema e paradigma.
Occorre riflettere sulla memoria e sul valore della nostra cultura, che è nella storia, nelle opere, nel pensiero. A mio modesto parere, riprendere l’attualità delle grandi testimonianze e utopie maturate in Italia è fondamentale.
Se ci impegniamo in questo senso, possiamo determinare una politica che restituisca l’Italia agli italiani, ristabilendo certe priorità, lavoro, Questione meridionale e lotta alle mafie, sostituite da un’ambigua tutela della sicurezza pubblica e da un federalismo nebuloso, funzionale al dominio definitivo del Mezzogiorno.
Se vogliamo essere efficaci nell’antimafia, invece che lasciarci sedurre dal circo mediatico e rimproverarci all’interno, dobbiamo intendere, legati a Paolo Borsellino, l’importanza di quel "movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità".
Emiliano Morrone e Carmine Gazzanni
Forum
-
>Calabria, utopia di Gioacchino da Fiore --- «Chi fa antimafia non può delegittimare la Giustizia» (di Emiliano Morrone)20 gennaio 2018, di Federico La Sala
«Chi fa antimafia non può delegittimare la Giustizia»
di Emiliano Morrone*
Sino a prova del contrario sono impulsive e gratuite le recenti affermazioni di Adriana Musella e Maria Teresa Russo sull’inchiesta che le tocca da vertici dell’associazione antimafia “Riferimenti-Gerbera Gialla”. Le due, ha ricordato il “Corriere della Calabria”, sono a vario titolo indagate per abuso d’ufficio, appropriazione indebita e malversazione ai danni di ente pubblico.
La prima ha scritto: «Restituiamo allo Stato i beni a noi affidati, nell’impossibilità di poter continuare nel nostro impegno. Hanno voluto così e così sia». E poi, in crescendo: «Questa non è la nostra sconfitta, ma quella dello Stato di diritto. A questo Stato e alla causa, siamo coscienti di avere già dato e tanto, forse troppo. Lo abbiamo fatto perché abbiamo creduto. Oggi non crediamo più».
La seconda ha parlato, nella scuola di cui è preside e davanti agli studenti, di un «tentativo di delegittimazione, operato da apparati dello Stato che hanno redatto informative con falso ideologico artatamente costruito».
La libertà di manifestazione del pensiero è sancita dalla Costituzione repubblicana all’articolo 21. Questo non significa che si possa dire ciò che si vuole, senza tenere conto del peso, degli effetti delle proprie esternazioni.
È banale ripetere quanto invano suggerisce il buon senso: ci si difende sempre nel singolo procedimento, in uno Stato democratico. Soprattutto gli esponenti dell’antimafia civile, dunque, non possono delegittimare la giustizia penale con tesi, come quelle di Musella e Russo, che alludano al complotto. Non è bello, non è giusto, non è coerente con lo specifico di ruoli e attività svolti, nella fattispecie con fondi pubblici.
La logica e la cultura antimafiosa impongono di riferire e circostanziare, nel caso in cui si conoscano o presumano trame a danno della propria storia, della propria immagine e credibilità. Perciò le vie sono due: o Musella e Russo sanno chi, come e perché a loro dire sta provando a screditarle, e quindi spieghino come d’obbligo, oppure non hanno elementi a sostegno delle loro dichiarazioni e pertanto tacciano.
Ora è il momento peggiore per la Calabria: regna una confusione senza precedenti ed è complicato orientarsi, distinguere, vivere in pace e libertà. Una parte della politica è dentro la ’ndrangheta e viceversa, la massoneria deviata gestirebbe l’accademia per candidati dell’antistato, su pezzi dell’antimafia civile gravano sospetti di tradimento della missione statutaria e alla Chiesa tocca combattere contro l’inquinamento di sacrestie, parrocchie e oratori.
Impossibile uscirne se non ci facciamo Stato, se, cioè, non cominciamo ad assumere posizioni culturali, politiche e morali che preservino le istituzioni di governo e controllo dall’illegalità e dalla corruzione dilaganti.
La sfida per la Calabria richiede la volontà di pulizia nelle forze politiche; l’indipendenza e la correttezza dell’informazione; il radicamento della cultura dei diritti e delle regole da parte delle agenzie formative, intanto nell’istruzione pubblica; la pratica del vangelo dei poveri e degli ultimi negli ambiti religiosi; la trasparenza dentro le pubbliche amministrazioni; la (non più rinviabile) discesa in trincea degli intellettuali e attori sociali; la garanzia di un reddito adeguato a singoli e famiglie emarginati.
Nel dominio del capitalismo finanziario e dei consumi, stiamo perdendo di vista l’obiettivo principale, cioè la costruzione di un futuro migliore per i più giovani, oggi senza lavoro e certezza di pensione. In Calabria si sfruttano a oltranza il patrimonio comune e il bisogno delle masse, la responsabilità e le funzioni del potere, le postazioni d’influenza e l’ignoranza generale sulla gestione dei soldi e degli uffici pubblici, compensata da forme di appagamento virtuale ed effimero che non ribaltano lo stato comatoso dei servizi, dell’economia e della tutela dei diritti. Intanto molta politica punta alla propria sopravvivenza, come dimostrano le trattative romane per le imminenti elezioni. E tace, immobile, sui vecchi problemi che producono emigrazione, astensionismo, sfiducia nel palazzo e solidarietà meccanica verso i potentati criminali.
*Giornalista
* CORRIERE DELLA CALABRIA, 19.01.2018 (ripresa parziale, senza immagini).
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
’NDRANGHETA. SIGNIFICATO DELLA PAROLA. Alcune pagine dalla Relazione del Presidente della Commissione Parlamentare, Francesco Forgione
ALLA REGIONE CALABRIA UNO SPIRITO NUOVO, A PARTIRE DALLA PAROLA: DARE ALLE COSE IL LORO NOME!!!
Alle radici della Calabria, dove il Paese si gioca il futuro. Indagine su una regione al di sotto di ogni sospetto. Reportage di Cesare Fiumi (Corriere della Sera/Sette, 42 - 19.10.2012).
-
> Antimafia: Calabria, utopia di Gioacchino da Fiore, Genchi, De Magistris, Stato di polizia, fuga dei cervelli, Paolo Borsellino, movimento culturale11 aprile 2009, di ireneEsulto per l’esito del processo a Genghi e credo che questo sia il risultato di un giustizia che esiste e su cui noi tutti possiamo contare, prodotta da persone integerrime che credono nel loro lavoro e vanno avanti nonostante tutto. Tutti dobbiamo avere voce in capitolo, ogniuno deve poter dire la sua, nessuno deve perdere il vizio di ragionare con la propria testa altrimenti finiamo per vivere all’ombra di qualcuno. La tecnolgia è al servizio del cittadino e della giustizia. Se può servire ad evitare processi inutili, a concentrarsi sui veri colpevoli, a far emergere prove indiziare schiaccianti (non una ma tante), non capisco perchè bisogna limitarne l’uso... perchè bisogna limitare l’uso delle intercettazioni telefoniche e delle telecamere.... penso che chi si nasconde ha effettivamente qualcosa da nascondere.... behh a quel punto è necessario controllare!