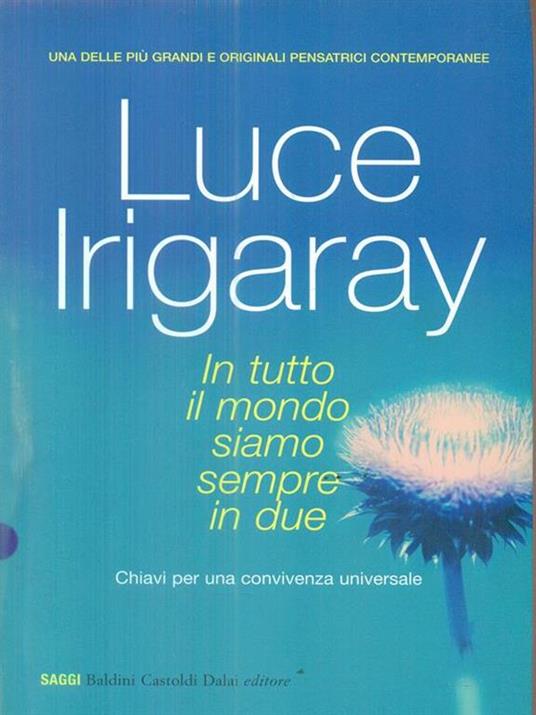
UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! A Mantova, Luce IRIGARAY rilancia la questione, ma - incompresa - viene "snobbata"!!!
- [...] «Si è fatto di questo pensiero della differenza un pensiero solo delle donne e fra le donne. Non l’ho mai detto. Questa era una tappa necessaria per strutturare il soggetto femminile, ma la finalità resta una cultura a due soggetti. E’ una cultura a due soggetti che ci permette di entrare nel multiculturalismo, essendo la differenza uomo-donna la prima differenza» [...]
 A colloquio con la teorica femminista ospite del Festivaletteratura di Mantova che si è aperto ieri. -Celebre il suo saggio “Speculum” dal quale prese le mosse il pensiero della differenza di genere.
A colloquio con la teorica femminista ospite del Festivaletteratura di Mantova che si è aperto ieri. -Celebre il suo saggio “Speculum” dal quale prese le mosse il pensiero della differenza di genere.
 Al pubblico ha presentato l’ultimo libro “In tutto il mondo siamo sempre in due”
Al pubblico ha presentato l’ultimo libro “In tutto il mondo siamo sempre in due”
 Luce Irigaray, filosofa convertita allo spiritualismo
Luce Irigaray, filosofa convertita allo spiritualismo
 di Maria Vittoria Vittori (Liberazione, 07.09.2006)
di Maria Vittoria Vittori (Liberazione, 07.09.2006)
Mantova. Con la maglietta del Festivaletteratura e lo sguardo vispo, Luce Irigaray gioca a fare la ragazza. E non solo per l’aspetto: «Sono fuori dall’istituzione» ama ripetere. Ma poi racconta delle ragazze - quelle vere - che «scelgono di fare il dottorato sulle mie opere, e spesso sono molto sole. Per loro conduco da alcuni anni, in Inghilterra, un seminario internazionale. E penso di trasformare questa esperienza in un libro: Luce Irigaray teacher.
Il dettaglio intenerisce, ma non evita una domanda. Questa: dov’è finita la ragazza di un tempo? Dove la filosofia che con Speculum. L’altra donna ha segnato un passaggio significativo nel pensiero e nell’approccio relazionale e politico? L’intenzione di confrontarsi con il percorso critico di un’intellettuale multiforme - filosofa, linguista, psicoanalista - che è stata capace, all’inizio degli anni Settanta, di elaborare una nuova cultura, deve fare i conti con una conversazione continuamente interrotta. E’ sulla difensiva, Luce Irigaray, venuta qui a Mantova per parlare del suo nuovo libro, In tutto il mondo siamo sempre in due (Baldini Castoldi Dalai, pp. 414, euro 17,50); ha timore di non essere compresa a sufficienza, di essere fraintesa.
Nemmeno la sua presentazione nelle note biografiche le garba molto. «Sono stupefatta nel vedere che sono presentata come un’allieva di Lacan, che si parla di me soltanto come l’autrice di Speculum. Mi stupisce sentir dire che ho ricevuto molto dal movimento delle donne: scrivere Speculum è stato come attraversare il deserto. E ancora, che non sono mai stata veramente coinvolta nel movimento delle donne. Per questo libro, non dimentichiamolo, sono stata buttata fuori dall’Università».
Glissa sulle domande relative al pensiero della differenza, e alla sua evoluzione, anche qui giocando di rimessa, attenta a ribadire i confini del “suo” pensiero. «Si è fatto di questo pensiero della differenza un pensiero solo delle donne e fra le donne. Non l’ho mai detto. Questa era una tappa necessaria per strutturare il soggetto femminile, ma la finalità resta una cultura a due soggetti. E’ una cultura a due soggetti che ci permette di entrare nel multiculturalismo, essendo la differenza uomo-donna la prima differenza».
Proviamo a trasferire la conversazione sul piano politico. «Il problema non è far entrare le donne, è portare alla politica i valori specifici delle donne. Quelli legati ad un’identità relazionale più precoce, più sviluppata, più creativa. Mi sembra che il primo valore da promuovere nelle città sia proprio il valore della relazione. Ancora, le donne hanno a cuore la salvaguardia della natura, e la natura, dal canto suo, ha più che mai bisogno di loro; sono interessate all’abitare, alla salute, sono più predisposte ad accogliere l’altro».
Nel trasloco di argomenti che si sta effettuando, dai fermenti utilmente contraddittori del pensiero e del movimento delle donne al rapporto con la natura, la Irigaray appare più rilassata. Il motivo lo spiega lei stessa quando si tocca il tema che le sta veramente a cuore: la spiritualità. E già, perché dalla felicità come finalità ultima della politica, che affiorava nelle opere più recenti, la filosofia si è trasferita ai piani alti della dimensione spirituale. E’ di questo che desidera parlare: della cultura del respiro che, in alcuni saggi contenuti nel suo ultimo libro, assume a volte quelle indistinte tonalità che virano al mistico e profumano di New Age.
E’ qui che la Irigaray, abbandonando ogni reticenza, dà il meglio della sua nuova identità di guru. Maturata attraverso l’assidua pratica dello yoga. «A poco a poco la pratica dello yoga ha cambiato il mio modo di pensare e di vivere. La cultura dello yoga è la cultura del respiro, che è fonte di vita, e ha bisogno di riferimenti spirituali per alimentarsi. Nella cultura occidentale abbiamo criticato i valori spirituali ma siamo ricaduti nell’ideologia e nel conformismo. Invece credo che sia necessario scoprire un cammino di spiritualità che ti renda autonomo. Non è criticare l’altro che ti rende autonomo, ma coltivare il tuo proprio respiro. Questo ti dà libertà, autonomia, responsabilità, la possibilità di passare da una cultura all’altra. La questione è: dobbiamo sfruttare il respiro degli altri o condividere il respiro con gli altri?» Annuncia, la nuova e più che mai feconda Luce, nuove iniziative e nuovi progetti: e se alcuni rientrano nel suo precedente percorso - un libro che raccoglie le conferenze tenute in Italia, che uscirà tra breve da Liguori, un altro intitolato
Condividere il mondo, di prossima uscita in Inghilterra, che si muove «tra la differenza sessuata e il multiculturalismo» -, altri si preannunciano sorprendenti. Come la raccolta di interviste La vita dell’amore, e un libro di poesie che si intitola Preghiere quotidiane.
Lui, lei e la natura. Caldamente consigliato dalla vostra Luce. Spirituale.
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, DIRITTO, E CIVILTA’. Alcune cit. per riflettere:
- "SESSI E GENEALOGIE. "Corpo a corpo con la madre:
- “[...] Quanto a noi, è urgente che ci rifiutiamo di sottometterci ad un ruolo sociale de/soggettivato, quello di madre, richiesto da un ordine sottoposto alla divisione del lavoro - produttore/riproduttrici - che ci chiude in una semplice funzione. E’ mai stato chiesto ai padri di rinunciare ad essere uomini? cittadini? Non dobbiamo rinunciare ad essere donne per essere madri. E’ necessario anche che noi scopriamo ed affermiamo che siamo sempre madri dal momento che siamo donne. Mettiamo al mondo qualcosa di diverso dai figli, generiamo qualcosa che non è il bambino: amore, desiderio, linguaggio, arte, società, politica, religione, ecc. Ma questa creazione da secoli ci è stata vietata e bisogna che noi ci riappropriamo questa dimensione materna che ci appartiene in quanto donne.
 La questione se avere o non avere figli dovrebbe sempre porsi sullo sfondo di un’altra generazione, di una creazione d’immagini e di simboli, per non diventare traumatica o patologica. Le donne e i loro figli se ne troverebbero infinitamente meglio.
La questione se avere o non avere figli dovrebbe sempre porsi sullo sfondo di un’altra generazione, di una creazione d’immagini e di simboli, per non diventare traumatica o patologica. Le donne e i loro figli se ne troverebbero infinitamente meglio.
 Dobbiamo essere attente a un’altra cosa: a non riuccidere la madre che è stata immolata all’origine della nostra cultura. Si tratta di ridarle la vita, a questa madre, in noi e tra noi. Dobbiamo rifiutare che il suo desiderio sia annientato dalla legge del padre.
Dobbiamo essere attente a un’altra cosa: a non riuccidere la madre che è stata immolata all’origine della nostra cultura. Si tratta di ridarle la vita, a questa madre, in noi e tra noi. Dobbiamo rifiutare che il suo desiderio sia annientato dalla legge del padre.
 Dobbiamo darle il diritto al piacere, al godere, alla passione, renderle il diritto alla parola, e talvolta al grido, alla collera. Dobbiamo inoltre trovare, ritrovare, inventare le parole, le frasi che dicono il rapporto più arcaico e più attuale con il corpo della madre, con il nostro corpo, le frasi che traducono il legame con il suo corpo, il nostro, quello delle nostre figlie. E’ necessario anche, se non vogliamo essere complici dell’uccisione della madre, che affermiamo che esiste una genealogia di donne. C’è una genealogia di donne nella nostra famiglia: abbiamo una madre, una nonna, una bisnonna materna e delle figlie. Di questa genealogia di donne, dato il nostro esilio nella famiglia del padre-marito, tendiamo a dimenticarne la singolarità e perfino a rinnegarla. Cerchiamo di situarci in questa genealogia femminile per conquistare e custodire la nostra identità. Non dimentichiamo nemmeno che abbiamo già una storia, che certe donne, anche se era culturalmente difficile, hanno segnato la storia, e che troppo spesso noi non ne abbiamo conoscenza”. (LUCE RIGARAY, Sessi e genealogie, Baldini e Castoldi Dalai, 2007 [1989])
Dobbiamo darle il diritto al piacere, al godere, alla passione, renderle il diritto alla parola, e talvolta al grido, alla collera. Dobbiamo inoltre trovare, ritrovare, inventare le parole, le frasi che dicono il rapporto più arcaico e più attuale con il corpo della madre, con il nostro corpo, le frasi che traducono il legame con il suo corpo, il nostro, quello delle nostre figlie. E’ necessario anche, se non vogliamo essere complici dell’uccisione della madre, che affermiamo che esiste una genealogia di donne. C’è una genealogia di donne nella nostra famiglia: abbiamo una madre, una nonna, una bisnonna materna e delle figlie. Di questa genealogia di donne, dato il nostro esilio nella famiglia del padre-marito, tendiamo a dimenticarne la singolarità e perfino a rinnegarla. Cerchiamo di situarci in questa genealogia femminile per conquistare e custodire la nostra identità. Non dimentichiamo nemmeno che abbiamo già una storia, che certe donne, anche se era culturalmente difficile, hanno segnato la storia, e che troppo spesso noi non ne abbiamo conoscenza”. (LUCE RIGARAY, Sessi e genealogie, Baldini e Castoldi Dalai, 2007 [1989])
- «Per rifondare su basi democratiche una comunità civile, abbiamo bisogno di partire da relazioni orizzontali e da dialoghi nella differenza. Quindi da due, un due che non equivale solo a una coppia nell’intimità della casa, ma che è anche una coppia in un senso e un contesto civili e politici, la società essendo tessuta da una molteplicità di coppie a diversi livelli. Potremmo così tornare al molteplice - che si tratti di razze, età, culture, tradizioni, ecc. - senza ripartirlo in modo gerarchico.» (LUCE IRIGARAY, In tutto il mondo siamo sempre in due Baldini Castoldi Dalai, 2006).
- LUCE #IRIGARAY, "In tutto il mondo siamo sempre in due. Chiave per una convivenza universale":
- "[...] «Si tratta di compiere un progresso nel divenire umano, in particolare grazie a una differenziazione più compiuta rispetto all’immediatezza naturale, per la donna ma anche per l’uomo, e anche grazie al #riconoscimento dell’altro come altro e alla pratica di una relazione con lui, o con lei, non sottoposta all’istinto. Senza dominio, dunque, senza possesso [...]».(cit., cfr. GIULIA DAVID, "Differenti ma equivalenti. Lettura critica del pensiero di Luce Irigaray", UNIVE 2014/2015)
Perché il pianeta donna non è stato ancora esplorato a fondo
La parità con gli uomini non è un traguardo. Anche la definizione della de Beauvoir ,il secondo sesso, implica comunque una posizione subalterna. L’umanità non è neutra e la differenza sessuale ha un senso: proprio per questo serve la massima autonomia
di LUCE IRIGARAY (la Repubblica, 7 marzo 2004, p. 33)
Non sono sicura che l’importanza della cosiddetta liberazione delle donne sia stata bene percepita. Eppure l’espansione così rapida delle lotte femminili in tutto il mondo ne è una testimonianza.
Ma siccome si tratta di un passaggio epocale della storia dell’umanità, la cosa è difficile da immaginare. Ognuna, ognuno ne coglie un aspetto solo, inoltre a partire da sé e da oggi. Bisognerebbe anzi saltare in un altro tempo, o anticipare il futuro. E non solo come nella fantascienza ma come un altro mondo possibile, non nell’aldilà ma quaggiù.
Diventare degli uomini. L’interpretazione più immediata della liberazione femminile corrisponde alla sua identificazione con l’uguaglianza all’uomo. Questo non ha bisogno di nessun cambiamento nel modo di pensare, di nessuna (r)evoluzione culturale. Basta far entrare la donna in una categoria esistente - gli operai, gli schiavi, gli oppressi. Rimaniamo così nella stessa logica padrone-schiavo, con il volere dello schiavo di diventare il padrone e, al massimo, con una certa accondiscendenza del padrone rispetto allo schiavo, a meno che accada un capovolgimento del rapporto. Ma siamo sempre nella stessa economia, un’economia a cui le donne accettano di partecipare, sacrificando la loro libertà per perpetuarla, e ricevere per questo qualche compenso dal padrone.
- Ma lei non parla di uguaglianza - mi obietterete. Vi chiederò allora di dimostrare che la strada dell’uguaglianza possa sfuggire alla logica padrone-schiavo. Vi suggerirò anche di comprarvi, per festeggiare l’otto marzo, un album Mafalda (fumetti dello scrittore argentino Dino). Mafalda è una maestra in liberazione femminile! Se siete fortunati, troverete in questo album la risposta di Mafalda a suo padre che sostiene che «l’occhio di Dio ci vede tutti uguali»: «Ma chi è il suo oculista?» lei gli chiede.
Notate, in questa occasione, che, per argomentare a proposito dell’esistenza dell’uguaglianza, il padre ha bisogno di ricorrere a Dio - quello con cui la parità rimane sempre impossibile. In ogni caso, prendere l’uomo come modello della propria liberazione non è una scelta che testimonia una grande autonomia né immaginazione. Il successo dell’uguaglianza è basato sul fatto che il metodo già esiste, che fa parte di una cultura al maschile e che è mantenuto dal risentimento fuori da un reale cambiamento, cosa indispensabile per compiere la liberazione delle donne.
Diventare delle donne. La cosa è già più complessa perché difettiamo di mezzi culturali per compiere questa evoluzione. Inoltre essa richiede che le donne preferiscano essere donne e non uomini. E’ il primo, e più decisivo, passo per incamminarsi verso la propria liberazione. Ma poche donne l’hanno già superato, nemmeno sospettato. Per esempio, le famose parole di Simone de Beauvoir: non si nasce donna ma si diventa donna, non manifestano una grande stima per l’identità femminile, che sarebbe soltanto il risultato di stereotipi sociali imposti alle donne. Lo stesso vale nell’affermare che l’altro è necessariamente il secondo rispetto all’uno, come attesta il titolo Il secondo sesso. Non voglio con questo disprezzare il lavoro che Simone de Beauvoir ha compiuto ma dire che esso non basta per assicurare la liberazione della donna in quanto tale.
E’ necessario capire che: se sono nata donna, devo anche diventare la donna che sono, e che questa donna è differente, ma non seconda, rispetto all’identità maschile. Certo, diventare donna, sviluppare un’altra identità umana non può ridursi a trasferire nei luoghi pubblici tutti gli affetti e passioni che avevano luogo in casa, in parte perché la donna non godeva di altri mezzi di espressione.
Si tratta di elaborare un’identità culturale nuova, che permetta alla donna di fare sbocciare tutte le sue capacità, sia nell’intimità che nella vita pubblica. La prima mediazione indispensabile è il diritto a un’identità civile appropriata. E’ il mezzo che può assicurare la svolta dallo statuto naturale, in cui la donna è stata confinata, a uno statuto civile che consenta alla donna di essere riconosciuta come libera e autonoma nella vita pubblica - cioè che conferisce alla donna un diritto paritetico, pur essendo differente, alla cittadinanza. Una piattaforma civile appropriata alle donne è anche ciò che permette di costruire una democrazia mondiale al femminile.
Diventare degli umani. Questo passaggio dalla naturalità alla civiltà è pure necessario per superare la parte di animalità che troppo spesso regola le relazioni uomo(ini) donna(e). Se queste si fondano solo sull’istinto - sia a livello dell’attrazione sessuale che su quello della procreazione - non possono essere realmente umane. E’ vero nei rapporti amorosi e parentali ma anche nel resto della vita. E’ dunque decisivo che le donne sfuggano a uno stato di semplice naturalità non solo per loro ma per l’insieme dell’umanità. D’altronde chiedere cambiamenti a livello economico e sociale senza modificare i rapporti sessuali non conduce a un granché. Si constata, per esempio, che in certi paesi dove la parità sociale è migliore che altrove, le donne sono più violentate. Manca il riconoscimento della donna come persona, per di più portatrice di valori diversi.
Ma quali sono questi valori, domandano quelli e quelle che pensano che l’essere umano è unico e che la sua cultura è necessariamente al neutro (per non dire al maschile)? Per rispondere a questa interrogazione, ho raccolto tante parole e disegni di ragazze e ragazzi, di donne e uomini. L’analisi di questo materiale non permette nessun dubbio sul fatto che fra i sessi esiste una differenza. Questa differenza non è solo biologica o sociale, come si è immaginato. Si tratta piuttosto di un modo diverso di essere in relazione con sé, con l’altro, con il mondo.
Questa identità relazionale propria di ciascun sesso corrisponde a una maniera specifica di costruire passaggi fra natura e cultura. Non è il sintomo di un’alienazione, come ho sentito dire a proposito del discorso delle ragazze. Questo discorso si dimostra, d’altronde, molto più precoce e creativo che quello dei ragazzi, una ricchezza che si può spiegare per il fatto che la vita relazionale della ragazza è più vivace di quella del ragazzo. La differenza fra identità relazionali interviene nell’attrazione fra i sessi in un modo più umano che la semplice attrazione fisica. Essa rappresenta una fonte di energia, di creatività, di cultura che merita di essere considerata e coltivata per lo sviluppo e la felicità dell’umanità.
FLS
Forum
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" --- FILOLOGIA E PSICOANALISI. «Che cos’è, o uomini ["anthropoi"], che volete ottenere l’uno dall’altro?» (Platone - Efesto).12 gennaio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA FILOSOFIA PSICOANALISI
"ABBRACCIATEVI, MOLTITUDINI" (F. SCHILLER, "INNO ALLA GIOIA", 1785): "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" (S. FREUD, 1899) DEI NIPOTINI E DELLE NIPOTINE DI PLATONE...
«Che cos’è, o uomini ["anthropoi"], che volete ottenere l’uno dall’altro? [...] Forse è questo che volete: diventare la medesima cosa l’uno con l’altro, in modo che non vi dobbiate lasciare né giorno, né notte? Se è questo che desiderate, io voglio fondervi e unirvi insieme nella medesima cosa, in modo che diventiate da #due che siete #uno solo, e finché vivrete, in quanto venite ad essere in questo modo uno solo viviate insieme la vita, e quando morirete, anche laggiù nell’Ade, invece di due siate ancora uno, uniti insieme anche nella morte. Orsù vedete se è questo che volete e se vi farebbe lieti ottenerlo...» (Platone, "Simposio", 192 d-e)
PLATONISMO E TECNOCRAZIA. Dopo interi millenni di letargo, non è meglio svegliarsi e capire che l’intenzione di "Platone" (e di Efesto) è pure lodevole, ma molto, molto artigianale (demiurgica), il suo amore è avido e cieco (Cupìdo) e il suo fare "di due che siete uno solo" sembra voler correggere la divisione fatta da Zeus, ma alla fine fa tutto all’incontrario e fa solo un campo di sterminio, un deserto. All’altezza del 2023, come scriveva Nietzsche, siamo ancora ignoti a noi (stessi e stesse).
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. Forse conviene riprendere il filo da ELEUSI (quest’anno è una delle capitali europee della cultura: Eleusis2023) e cercare di capire il segreto dei misteri eleusini, come nascono i bambini, e, finalmente, scoprire (immergendosi, battesimalmente, nel) l’acqua calda, che ognuno e ognuna è già uno, una, in due; ripartire da sé e riprendere il cammino: "Sàpere aude! (Kant, 1784 - Michel Foucault, 1984). Ricominciare a contare da due, non da uno (dei due, che fa il furbo): "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia). In principio era il Logos - non il logo di una "fattoria degli animali"!
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- SUL PIANETA TERRA, UNO SGUARDO "EXTRATERRESTRE".28 gennaio 2022, di Federico La Sala
VITA "EXTRATERRESTRE" E SGUARDO NUOVO. Tracce per una svolta_antropologica...
- Nota a margine dell’articolo di Martina Shalipour Jafari,
- Filosofia della scienza: un ritorno al passato per guardare al futuro
- In che modo un background filosofico può aiutarci ad essere scienziati migliori ("Future Brain", 28.01.2022).
IL PRESENTE. Come è possibile "guardare al futuro" se torniamo al passato? Grazie al "passato", siamo arrivati al "presente" ("futuro" del passato). Ma "un ritorno al passato", cosa può dirci di diverso da quanto già sappiamo, se ancora camminiamo e pensiamo come in "passato"?!
IL PASSATO. Un vento fortissimo viene dal passato e questo vento (ricordare Walter Benjamin) a noi, che siamo spinti sempre più avanti e che continuiamo a guardare ipnotizzati il "passato", quale "futuro" mostra? Un crescere oceanico di macerie e rifiuti...
Filosofia, Scienza, e DisagiodellaCiviltà (Freud, 1929). Il problema è proprio quello di liberare l’epistemologia dalla caverna platonica e ripartire da un ulteriore sguardo nel gorgo claustrofilico (Elvio Fachinelli, Claustrofilia, 1983) e soprattutto da un fatto inaudito e impensato: nascere, diventare un essere umano extraterrestre e aprire gli occhi sul ... SorgeredellaTerra.
Federico La Sala
MUSICA, MUSE, PROFETI E SIBILLE, ANTROPOLOGIA, E "MOS-ART" DI SALUTE E LIBERAZIONE:
- UNO STRAORDINARIO ESEMPIO DI EFETTO MOZART - DELLA "MOS-ART" ("arte di Mosè"):
- “THE SHAWSHANK REDEMPTION” (1994). Una breve sequenza dal #film “Le Ali della Libertà”, con
- "Sull’Aria..." da "Le Nozze di Figaro" .
DISAGIO DELLA CIVILTA’ (FREUD, 1929). Il problema, a mio parere, è che la ricerca e i risultati di Alfred A. Tomatis (Nizza, 1º gennaio1920 - Carcassonne, 25 dicembre2001) sono talmente innervati con la nostra non-volontà di sapere di sé che, pur comprendendo che già il solo "parlare è suonare il proprio corpo" (Alfred Tomatis), alle accademiche platoniche orecchie (cieche e sorde e zoppe, come quelle di Edipo) il messaggio non arriva o arriva assolutamente distorto.
DANTE 2021: MEMORIA DI APOLLO E DELLE MUSE
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- METTERE AL MONDO IL MONDO. Silvia Vegetti Finzi: «Non facciamo più figli, stiamo vivendo un’eutanasia culturale». Intervista (i R. Scorranese).26 gennaio 2022, di Federico La Sala
Silvia Vegetti Finzi: «Non facciamo più figli, stiamo vivendo un’eutanasia culturale»
La psicologa tra maternità (disimparata) e virilità oggi intesa come violenza
di Roberta Scorranese (Corriere della Sera, 18 settembre 2020)
Non facciamo più figli.
«Ma la colpa è anche nostra».
Si spieghi meglio.
«Io ho ottantadue anni, sono entrata nel movimento femminista tardi, nel 1980, ma sono poi stata molto attiva. E la mia generazione ha sbagliato a non proporre una nuova idea di maternità alle giovani donne di allora, oggi ultra quarantenni».
Avete insistito troppo sulla realizzazione professionale?
«Vi abbiamo insegnato ad essere figlie e non madri. A fare carriera e non a costruire un nuovo modello di maternità. Vi abbiamo spinto a cercare madri simboliche, da Virginia Woolf ai modelli più attuali, cercando di tenervi sempre in una condizione “filiale” e non “generatrice”. Non vi abbiamo passato il libretto delle istruzioni. Così oggi ci sono migliaia di quarantenni che non hanno avuto figli e quando chiedo loro il perché di questa scelta la risposta è quasi sempre “Perché c’erano altre priorità”».
Non solo. Negli anni Ottanta c’è stata una corrente di pensiero che ha provato a demolire la maternità.
«Che grave errore che abbiamo commesso, è il momento di riconoscerlo».
- Silvia Vegetti Finzi, psicologa, ha scritto numerosi libri importanti sull’adolescenza, sul femminile, sulla maternità. È anche autrice di una delle più articolate storie della psicoanalisi mai scritte in Italia. Ci incontriamo nella sua luminosa casa milanese, dove si è trasferita nel 2018 dopo la morte del marito, Mario Vegetti, al quale è stata legata per sessantadue anni. Due figli e tre nipoti.
Però si deve a voi se oggi tante ragazze non hanno paura di confrontarsi con i colleghi uomini a scuola, all’università e sul lavoro.
«Certo, ma sappiamo quello che succede: sono bravissime negli studi, si laureano meglio e prima degli uomini, magari cominciano a lavorare presto ma poi? Poi, scompaiono. Spariscono nel percorso della carriera e nella crescita professionale. Spesso per il cosiddetto «soffitto di cristallo», ma spesso anche perché non riescono a conciliare la maternità con il lavoro. Quello che avremmo dovuto fare è elaborare una maternità migliore, non cancellarla».
Così, mentre l’idea di famiglia in qualche modo si recupera - pensiamo alle famiglie allargate o a quelle costruite sul senso di comunità -, la maternità è difficilmente recuperabile nella sua natura simbolica.
«Esatto. È una perdita anche culturale. Pensiamo solo all’Italia: siamo il paese delle madri, dalla forma più discutibile come il “mammismo” a quella più nobile, cioè quella delle grandi rappresentazioni iconografiche della maternità religiosa. Eppure la sa una cosa? Ogni volta che ho proposto alle femministe una riflessione sulle annunciazioni nella pittura, mi hanno risposto molto freddamente».
Le annunciazioni sono uno scrigno di simboli materni: la paura, il coraggio, la dedizione, la crescita personale.
«Aggiungo una cosa. In molte rappresentazioni mariane non c’è solo Gesù, c’è anche il piccolo Giovanni. I due bambini vengono raffigurati come coetanei ma fisicamente diversi: il Cristo è delicato e angelico, Giovanni è materico, ricciuto, a volte vestito di pelli di animali. Io ci vedo un messaggio di profondità straordinaria: il bambino del giorno e il bambino della notte. Quello reale e vissuto e quello non vissuto e non elaborato. Pensi quanto sarebbe importante per il femminile studiare ed assimilare tutto questo. Invece nulla. E allora che cosa vediamo? Maternità conflittuali, difficoltà ad integrare i ruoli e, per riflesso, una paternità debolissima».
Il «mammo»?
«Che errore. Noi abbiamo bisogno di padri, non di mammi. La dissimmetria è un valore, io amo l’altro non il mio simile. Ma d’altra parte questo è il risultato di una maternità confusa. Il padre, simbolicamente, non esiste finché la madre non lo indica come tale. È sempre la madre che definisce la figura paterna e, al tempo stesso, ne trae forza. Bisogna capire che distilliamo potenza dalla differenza».
Lei lo ha sempre detto: sposiamo il padre ideale per i nostri figli, quello che cambia i pannolini e che cucina, ma poi non lo desideriamo più.
«Mettiamola così: molte donne sposano l’uomo che non è proprio l’oggetto del desiderio ma è grazie a lui che tante mogli potranno, come Rossella O’Hara, continuare a desiderare “l’altro”. Io e mio marito siamo stati assieme per sessantadue anni perché abbiamo riconosciuto le differenze ma ci siamo sforzati entrambi di integrarle. Ci siamo adattati alle stagioni della vita senza pretendere di rimanere nello stadio iniziale dell’incanto. Lui ha accettato di fare, qualche volta, il principe consorte accompagnandomi per convegni e io ho fatto altrettanto».
Perché ha anteposto il cognome di suo marito (Vegetti) al suo?
«Perché all’epoca era obbligatorio firmare così nei documenti pubblici, ci siamo sposati nel 1960. Poi ho mantenuto il doppio cognome. Un po’ come era obbligatorio, per una coppia sposata, esibire il certificato di matrimonio al momento di prenotare una stanza d’albergo. Di passeggiare mano nella mano non si parlava, ma pensi che una volta, era il 1963, fui costretta a scendere da un tram a Milano: indossavo un abito senza maniche. Oggi tutto questo sembra assurdo, ma quando mi sono iscritta all’Università Cattolica, nel 1963, il bidello dovette prestarmi la sua giacca perché una donna non poteva entrare in segreteria con le braccia scoperte».
È vero che c’erano due corridoi distinti, uno per gli uomini e uno per le donne?
«Certo, e così facendo si erotizzava tutto, anche la cosa meno pruriginosa come camminare per un corridoio universitario. Ma quello che non dimenticherò mai è uno specchio: recava la scritta “La donna che si depila le sopracciglia è una donna che mente”. Lo aveva voluto lo stesso padre Gemelli».
Il Sessantotto cambiò tutto?
«Sì, ma non è che nel Sessantotto le donne ebbero questo grande ruolo di protagoniste in Italia. Facevano le fotocopie dei volantini e nacquero così gli “angeli del ciclostile”. Poi vede, non era facile. Se una donna prendeva la parola in un’assemblea con centinaia di persone lo sguardo maschile era molto più presente e condizionante di quanto lo sia oggi. E lo sguardo maschile - ricordiamocelo - è sempre giudicante. Con una sua logica binaria: vecchia/giovane, brutta/bella, ribelle/docile. È stato difficilissimo affermarsi».
Soprattutto per una donna che si occupava di psicoanalisi, disciplina che in Italia venne ostacolata sia dal marxismo che dalla Chiesa cattolica.
«Mi dispiace dirlo ma il momento in cui la psicoanalisi divenne un vero fenomeno culturale coincise, in Italia, con le lezioni di Armando Verdiglione. Un personaggio molto discusso ma finalmente nei suoi incontri la psicoanalisi diventava il canale attraverso il quale leggere la cultura e il nostro tempo. Oggi io penso che solo con Massimo Recalcati questa disciplina assume un peso culturale che va oltre il mero significato terapeutico. Sono grata a Recalcati per questo, me lo faccia dire».
È d’accordo con la lettura che Recalcati ha fatto dell’assassinio di Willy Monteiro Duarte a Colleferrro (violenza contro la «parola di pace» che Willy tentava di portare in una rissa, ndr.)?
«Sì, anche se io l’avrei incentrata di più sul femminile».
Cioè?
«Penso che questi parossismi di mascolinità siano una reazione alla paura della femminilità. Donald Winnicott nei primi anni Trenta sosteneva che in ogni società persiste una grande paura delle donne. Si spiega con la dipendenza che si prova nei primi due anni di vita: senza una madre un neonato non sopravvive. E in questo mancato “grazie” alla madre risiede una violenza che tenta di abbattere quella dipendenza. E così, senza un’adeguata educazione, la virilità in molti casi cambia pelle, si confonde con la durezza e alla fine con la violenza. Specie contro le donne».
Alla base, dunque, c’è sempre una paura di essere sopraffatti.
«Winnicott poi lega questo ragionamento alla politica e dice che le tirannie sono il risultato di questa paura: diventiamo devoti ad un essere che non dipende da nessuno, un tiranno, appunto, un potere assoluto».
Torniamo ad una mancata - o monca - elaborazione della maternità.
«Lo dico da sempre: se dessimo alla maternità il giusto peso, saremmo molto più liberi».
Professoressa, lei è nata il 5 ottobre del 1938: esattamente un mese dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia.
«Sì, con un padre ebreo e una madre cattolica. Pensi che beffa: per i nazisti io avrei potuto rientrare nei “gentili”, ma per i fascisti no. Però la nostra origine ebraica non venne elaborata in famiglia, nessuno mi aveva mai detto che io ero ebrea così da bambina sentivo montare una paura folle quando ascoltavo certe dichiarazioni senza che l’oggetto della mia paura fosse ben chiaro. Una cosa terribile».
Nel suo libro Una bambina senza stella lei dipinge una non-madre.
«Mia madre è stata durissima con me. Ho vissuto a modo mio l’isolamento, il sentirmi invisibile e un’identità incerta. Però qualche anno fa sono stata invitata ad una serata dalle sue ex alunne, oggi anziane, che mi hanno dipinto una donna completamente diversa: una maestra dolcissima, amorevole, che si prendeva cura “delle sue bambine”. Le do atto di questo, devo farlo. Però con lucidità devo anche riconoscere che non sono stata amata. Fa bene fare i conti con il proprio passato».
Oggi qual è il suo rapporto con la fede?
«È strettamente legato al riconoscimento dei miei limiti. Vorrei fare tante cose ma non riesco, vorrei capire ma non ce la faccio. È allora che entro in un territorio diverso, quello del sacro. La fede per me è capire che siamo destinati alla finitezza».
E se si guarda indietro che cosa vede?
«Tanti errori, primo tra tutti quello di aver troppo spesso fornito “soluzioni precotte” ai miei figli, quando avrei dovuto lasciarli andare. Ma trovo anche tanta ricchezza: di amici, colleghi, dell’amore di mio marito. E mi lasci dire una cosa per chiudere: credo che oggi la vera grande povertà non sia quella dello spirito, la vera miseria è il tempo che ci manca e che non riusciamo a trovare mai».
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
Silvia Vegetti Finzi, Mettere al mondo il mondo ( Festival di Filosofia, Modena 16 settembre 2017)
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- EPIFANIA 2022, QUESTIONE ANTROPOLOGICA, E CATECHESI PAPALE. Udienza Generale: "Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli" (Papa Francesco, 5 gen. 2022)..5 gennaio 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. EPIFANIA 2022. Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri....
PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE
Aula Paolo VI
Mercoledì, 5 gennaio 2022
Catechesi su San Giuseppe: 6. San Giuseppe, il padre putativo di Gesù *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi mediteremo su San Giuseppe come padre di Gesù. Gli Evangelisti Matteo e Luca lo presentano come padre putativo di Gesù e non come padre biologico. Matteo lo precisa, evitando la formula “generò”, usata nella genealogia per tutti gli antenati di Gesù; ma lo definisce «sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù detto il Cristo» (1,16). Mentre Luca lo afferma dicendo che era padre di Gesù «come si riteneva» (3,23), cioè appariva come padre.
Per comprendere la paternità putativa o legale di Giuseppe, occorre tener presente che anticamente in Oriente era molto frequente, più di quanto non sia ai nostri giorni, l’istituto dell’adozione. Si pensi al caso comune presso Israele del “levirato” così formulato nel Deuteronomio: «Quando uno dei fratelli morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, con un estraneo. Suo cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il primogenito che ella metterà al mondo, andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele» (25,5-6). In altre parole, il genitore di questo figlio è il cognato, ma il padre legale resta il defunto, che attribuisce al neonato tutti i diritti ereditari. Lo scopo di questa legge era duplice: assicurare la discendenza al defunto e la conservazione del patrimonio.
Come padre ufficiale di Gesù, Giuseppe esercita il diritto di imporre il nome al figlio, riconoscendolo giuridicamente. Giuridicamente è il padre, ma non generativamente, non l’ha generato.
Anticamente il nome era il compendio dell’identità di una persona. Cambiare il nome significava cambiare sé stessi, come nel caso di Abramo, il cui nome Dio cambia in “Abraham”, che significa “padre di molti”, «perché - dice il Libro della Genesi - sarà padre di una moltitudine di nazioni» (17,5). Così per Giacobbe, che viene chiamato “Israele”, che significa “colui che lotta con Dio”, perché ha lottato con Dio per obbligarlo a dargli la benedizione (cfr Gen 32,29; 35,10).
Ma soprattutto dare il nome a qualcuno o a qualcosa significava affermare la propria autorità su ciò che veniva denominato, come fece Adamo quando conferì un nome a tutti gli animali (cfr Gen 2,19-20).
Giuseppe sa già che per il figlio di Maria c’è un nome preparato da Dio - il nome a Gesù lo dà il vero padre di Gesù, Dio - il nome “Gesù”, che significa “Il Signore salva”, come gli spiega l’Angelo: «Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Questo particolare aspetto della figura di Giuseppe ci permette oggi di fare una riflessione sulla paternità e sulla maternità. E questo credo che sia molto importante: pensare alla paternità, oggi. Perché noi viviamo un’epoca di notoria orfanezza. È curioso: la nostra civiltà è un po’ orfana, e si sente, questa orfanezza. Ci aiuti la figura di San Giuseppe a capire come si risolve il senso di orfanezza che oggi ci fa tanto male.
Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri. «Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti» (Lett. ap. Patris corde). Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell’adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l’affetto familiare con chi ne è rimasto privo. Non bisogna avere paura di scegliere la via dell’adozione, di assumere il “rischio” dell’accoglienza. E oggi, anche, con l’orfanezza, c’è un certo egoismo.
 L’altro giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti ... Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e - come diceva uno un po’ umoristicamente - “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la verità.
L’altro giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti ... Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e - come diceva uno un po’ umoristicamente - “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la verità.
 Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore.
Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore.
 Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore. Tempo fa ho sentito la testimonianza di una persona, un dottore - importante il suo mestiere - non aveva figli e con la moglie hanno deciso di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne hanno offerto loro uno e hanno detto: “Ma, non sappiamo come andrà la salute di questo. Forse può avere qualche malattia”. E lui disse - lo aveva visto - disse: “Se lei mi avesse domandato questo prima di entrare, forse avrei detto di no. Ma l’ho visto: me lo porto”. Questa è la voglia di essere padre, di essere madre anche nell’adozione. Non abbiate paura di questo.
Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore. Tempo fa ho sentito la testimonianza di una persona, un dottore - importante il suo mestiere - non aveva figli e con la moglie hanno deciso di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne hanno offerto loro uno e hanno detto: “Ma, non sappiamo come andrà la salute di questo. Forse può avere qualche malattia”. E lui disse - lo aveva visto - disse: “Se lei mi avesse domandato questo prima di entrare, forse avrei detto di no. Ma l’ho visto: me lo porto”. Questa è la voglia di essere padre, di essere madre anche nell’adozione. Non abbiate paura di questo.Prego perché nessuno si senta privo di un legame di amore paterno. E coloro che sono ammalati di orfanezza vadano avanti senza questo sentimento così brutto. Possa San Giuseppe esercitare la sua protezione e il suo aiuto sugli orfani; e interceda per le coppie che desiderano avere un figlio. Per questo preghiamo insieme:
San Giuseppe,
 tu che hai amato Gesù con amore di padre,
tu che hai amato Gesù con amore di padre,
 sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia
sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia
 e desiderano un papà e una mamma.
e desiderano un papà e una mamma.
 Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli,
Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli,
 aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande.
aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande.
 Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame,
Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame,
 una persona che si prenda cura di lui o di lei;
una persona che si prenda cura di lui o di lei;
 e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita,
e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita,
 perché spalanchi il cuore all’amore.
perché spalanchi il cuore all’amore. Saluti [...]
Saluti [...]* Fonte: Vatican.va, 05.01.2022 (ripresa parziale).
NOTA:
ANTROPOLOGIA ED #EPIFANIA. "A un uomo e a una donna che non sviluppano il senso della paternità e della maternità manca qualcosa di fondamentale". Che cosa? "#Eccehomo. Come si diventa ciò che si è" (#Nietzsche): sapere #come nascono i bambini.
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! -- "Nascere. Genesi di un nuovo essere umano" l’ultimo libro di Luce Irigaray (di Giorgia Salatiello).)6 gennaio 2020, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E SOCIETA’. COME SONO NATI I NOSTRI "GENITORI".... *
Scheda editoriale
Luce Irigaray
Nascere
Genesi di un nuovo essere umano
Traduzione di Antonella Lo Sardo
Bollati Boringhieri, 2019, pp. 183, 15 e.
- Il tema è universale. Forse non c’è tema più universale di questo: che cosa significa per noi umani nascere. Non ci sviluppiamo dalle radici come una pianta, e non siamo neppure autosufficienti come Dio. Così, siamo gli unici viventi che mancano di un’origine, e ne vanno sempre alla ricerca. Privi di un «essere» originariamente identificabile, dobbiamo assumerci la responsabilità della nostra esistenza e del nostro destino. Come? «In primo luogo, coltivando il nostro respiro, una risorsa che troppo passivamente abbiamo attribuito a un Dio estraneo alla nostra esistenza terrena, sebbene il respiro sia ciò che ci permette non solo di vivere autonomamente, ma anche di trascendere la mera sopravvivenza, di superare il livello della mera vitalità, così da essere in grado di portare a compimento un’esistenza umana. Incaricarci di incarnare la nostra appartenenza sessuata è il secondo elemento che ci rende capaci di adempiere la nostra esistenza naturale, pur trascendendola». La sessuazione compensa l’assenza di radici attraverso la spinta all’unione tra due esseri: «Dove prima non c’era nulla tra loro, se non l’aria, a partire dalla loro attrazione e dalla loro capacità di assumere il negativo della loro differenza nasce il germe di un nuovo essere umano e di un mondo in cui possiamo davvero dimorare». La potenza di pensiero di Luce Irigaray si muove con «con passi di colomba» - direbbe Nietzsche - e vince ogni scetticismo circa l’arditezza di un compito di trasformazione che riparta dall’istanza incondizionata della vita in sé, e non dagli «assoluti sovrasensibili che troppo spesso sono il risultato della nostra incapacità di vivere».
Il libero respiro e la tecnologia
La genesi di un nuovo essere umano nell’ultimo libro di Luce Irigaray
di Giorgia Salatiello (L’Osservatore Romano, 11 giugno 2019)
Sarebbe molto difficile, e forse anche inutile, cercare di fare una classica recensione dell’ultimo libro di Luce Irigaray, Nascere. Genesi di un nuovo essere umano (Torino, Bollati Boringhieri 2019, pagine 192, euro 15), in considerazione della molteplicità e della complessità dei temi che vi si intrecciano, condensando tutti i motivi più rilevanti delle opere precedenti.
Sembra, quindi, più utile stabilire una specie di dialogo con l’autrice, incentrando la riflessione intorno ad alcune parole-chiave che ritornano spesso in quella che si può definire come una fenomenologia della vita umana, dal suo inizio fino alla sua compiuta fioritura.
La prima parola è quella che compare anche nel titolo, ovvero “nascere”, e qui il pensiero della Irigaray rivela tutta la sua profondità e la sua articolazione perchè per lei la nascita non indica solo il preciso istante del venire al mondo, ma tutto quel lungo e faticoso percorso che dovrebbe consentire ad un essere umano il suo pieno sviluppo, ma che quasi sempre la nostra cultura occidentale blocca e distorce.
Sulla scorta delle sue conoscenze delle filosofie e delle religioni orientali l’autrice attribuisce importanza centrale al respiro (ecco un’altra parola-chiave) che consente di uscire da sé, ma anche di rientrare nell’intimità di se stessi e, su questo punto, forse, le si potrebbe chiedere di distinguere di più tra le differenti dimensioni, quella corporea, quella psicologica e quella spirituale della quale parla, ma che dovrebbe essere ulteriormente specificata nella sua peculiarità.
Compaiono, quindi, le due parole più significative di tutto il libro cioè quelle del desiderio e dell’amore, nella loro chiara distinzione, ma anche nella loro indispensabile congiunzione. Il desiderio e l’amore ai quali Irigaray si riferisce sono, innanzi tutto, le due fondamentali risorse che consentono alla vita umana di non decadere al livello del vegetale o, addirittura, dell’essere inanimato, ma essi sono, nella loro più genuina specificità, legati all’attrazione reciproca di uomo e di una donna, dotata di un forte potenziale generativo che non si esaurisce nella sola riproduzione biologica.
Se tutto il volume, come si è detto, è una fenologia della vita umana, qui ci si trova di fronte ad una vera e propria fenomenologia dell’amore che non è appiattito soltanto su alcune delle sue componenti, ma è indagato in tutta la sua ricchezza. La fioritura che l’amore consente, tuttavia, nella nostra cultura, ed ecco altre due parole chiave, è sempre minacciata dalla tecnica e dalla tecnologia che impongono i loro ritmi e le loro finalità all’esistenza. È degno di nota che, a questo proposito, Luce Irigaray non proponga un impossibile e nostalgico ritorno al passato, ma inviti alla riappropriazione del nostro destino umano sul quale la tecnica e la tecnologia non devono avere il sopravvento.
Si giunge, così, all’ultima parola, trascendere, che ritorna lungo tutto il testo rivelando il suo spessore, ma anche la sua ambiguità che pone al lettore un preciso interrogativo. Da una parte, infatti, e questo è pienamente condivisibile, il trascendimento è quel movimento che porta continuamente al di là di se stessi, impedendo la chiusura ed il ripiegamento solipstico, ma non si trova traccia della netta distinzione tra il trascendimento solo orizzontale, verso gli altri e verso il mondo, e quello verticale che può aprire l’essere umano all’assoluto ed, ultimamente, a Dio. Certamente, questo secondo tipo di trascendimento esula dalla prospettiva della Irigaray che, anzi, è molto critica verso tutte quelle che indica come proiezioni in un mondo sovrasensibile, prodotto dal soggetto medesimo.
Tuttavia, proprio in questo risiede il limite della pur valida e significativa proposta dell’autrice, perché solo un trascendimento verticale potrebbe realmente garantire quell’apertura e quel respiro libero, dei quali avverte profondamente l’esigenza per dare all’umanità il suo vero volto, spesso soffocato da una cultura e da un pensiero opprimenti e riduttivi.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SICFR.:
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA.
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO è DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! -- Concepire un mondo nuovo: "Nascere. Genesi di un nuovo essere umano"(di Luce Irigaray).29 gennaio 2020, di Federico La Sala
NASCERE. Costruire una cultura adatta alla nostra incarnazione...
- Concepire un mondo nuovo (di Luce Irigaray)*
Non vi è alcun dubbio che una certa epoca della nostra cultura sia al termine: quella della metafisica, che alla fine si è incarnata in un’era tecnica e scientifica che da allora in poi è la nostra. In effetti, o l’umanità e il mondo in cui dimora sono destinati a scomparire, o noi troviamo il modo di tornare o ritornare a ciò che significa essere umano per riflettere a fondo su di esso, in quanto primo agente del nostro destino, e sulla possibilità di giungere a una parola di cui la tecnica e le tecnologie non possono privarci, riducendoci a una sorta di meccanismo meno performante di quelli che siamo in grado di fabbricare.
È in noi stessi, in quanto esseri umani incarnati, che possiamo trovare un modo di pensare come sfuggire al dominio della tecnica e delle tecnologie senza sottovalutarne i vantaggi. Invitandoci a liberarci dalla soggezione a ideali sovrasensibili, Nietzsche ci indica, almeno in parte, verso quale direzione volgerci. Ma il suo insegnamento è innanzitutto critico, ed è quello che ha ispirato la decostruzione della metafisica occidentale portata avanti, dopo di lui, da Heidegger e dai suoi seguaci. Se Nietzsche ha intuito giustamente che dobbiamo ricominciare da zero, iniziando in particolare dalla nostra appartenenza fisica per passare dal vecchio uomo occidentale a una nuova umanità, egli non ha avuto il tempo di aprire il cammino o di costruire il ponte per raggiungere questo obiettivo. Temo che anche la «volontà di potenza» e l’«eterno ritorno», in un modo o nell’altro, rimangano nell’orizzonte della nostra logica passata. Agiscono come strumenti della sua interpretazione, ma forniscono una prospettiva che ci consente di liberarci da essa. Tuttavia, le «intuizioni ispirate» di Nietzsche, come le chiama Heidegger, non ci forniscono la struttura di cui abbiamo bisogno per costruire una cultura adatta alla nostra incarnazione.
Questa struttura - Heidegger talvolta la chiama «ispezione» -, che rende possibile l’avvento di una nuova epoca della verità e della cultura, d’ora in poi deve risiedere nel nostro corpo, dal momento che è una struttura adatta a esso, tramite la quale può dirsi di nuovo fin quando il mondo e tutti gli elementi che vi prendono parte sono coinvolti. Questo tipo di struttura esiste e si esprime già, anche in modo inconscio, nella nostra concezione passata del reale e del linguaggio che ne parla - corrisponde alla sessuazione della nostra identità. In quello che è stato chiamato «essere umano» è rimasto ignorato un aspetto che ne determina la natura e che contribuisce a sottrarlo a una neutralità disincarnata che non gli permette di manifestarsi così com’è, e che riemerge, sebbene la presunta verità del mondo e delle cose non gli corrisponda.
Il rischio rappresentato dalla neutralizzazione degli umani in quanto esseri viventi adesso sta diventando evidente a causa della trasformazione in robot di diversi elementi del mondo, tramite l’organizzazione prodotta dalla mente umana a partire dal potenziale di meccanismi, di cui, però, è diventata schiava, esiliata dalla sua appartenenza vivente. Qualunque sia il loro potenziale performativo, gli esseri umani eccedono già quello della macchina a diversi livelli. La loro salvezza può venire soltanto dalla percezione del rischio e dalla maniera di superarlo, attribuendogli significato, e tramite un ritorno al proprio essere come specifici esseri viventi. Per superare una concezione del mondo dominata da un modo di pensare e di agire tecnico, dobbiamo trovare un’altra configurazione o struttura grazie alla quale gli esseri umani possano sfuggire a tale dominio riconoscendo e interpretando la natura del suo potere. Dobbiamo liberarci dal predominio tecnico e scientifico sulla nostra epoca e garantire la salvaguardia del significato tramite una nuova incarnazione dell’essere.
*Luce Irigaray, "Nascere. Genesi di un nuovo essere umano", TecaLibri.
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" --- ALL’INIZIO, LEI ERA. Intervista con Luce Iragaray (di Egle Santolini).8 giugno 2013, di Federico La Sala
 Intervista con Luce Iragaray
Intervista con Luce Iragaray
 “Ma l’umanità ha bisogno di infinite carezze”
“Ma l’umanità ha bisogno di infinite carezze”
 «Il desiderio è una fonte di energia di cui il nostro corpo ha bisogno per crescere e fiorire»
«Il desiderio è una fonte di energia di cui il nostro corpo ha bisogno per crescere e fiorire»
 «I tablet ora magnificano il “touch screen”, ma la cultura dell’Occidente ha sempre privilegiato la vista»
«I tablet ora magnificano il “touch screen”, ma la cultura dell’Occidente ha sempre privilegiato la vista»di Egle Santolini (La Stampa TuttoLibri, 08.06.2013)
- Un pamphlet della filosofa elogia il “toccare” “Dobbiamo restituire all’altro la nostra pelle, fino a raggiungere un’intima comunione”
 Luce Irigaray «Elogio del toccare» il Melangolo pp. 80, € 7
Luce Irigaray «Elogio del toccare» il Melangolo pp. 80, € 7
L’ultimo saggio di Luce Irigaray, la pensatrice belga che negli Anni Settanta infiammò la scena filosofica e psicanalitica con Speculum e la teoria della differenza, è un libro piccolo e densissimo appena tradotto in Italia dal Melangolo.
Signora Irigaray, nell’«Elogio del toccare» lei denuncia la perdita di significato del tatto nella cultura occidentale, dominata dal «logos» maschile: secondo lei, siamo dunque una grande testa che continua a pensare ma che ha dimenticato la pelle?
«E’ così. Il fatto che l’uomo abbia costruito la propria cultura attraverso la dominazione della propria origine naturale e della prima relazione con la madre gli ha impedito di coltivare la dimensione sensibile dell’identità umana. E dunque il tatto non è stato considerato un modo di entrare umanamente in comunicazione con l’altro(a), di restituire all’altro(a) la propria pelle attraverso le carezze, di avvicinarsi l’uno(a) all’altro fino a un’intima comunione grazie al tocco delle mucose».
Poi sono arrivati i computer, le macchine che si frappongono ai corpi. Ci si guarda attraverso gli schermi e ci si relaziona in modo virtuale. Eppure, i modelli più richiesti di tablet e cellulare si definisco no proprio «touch» e metto no l’accento sulle proprie qualità tattili. Non lo trova paradossale?
«L’ industria lo fa per motivi commerciali, per dare l’idea di un contatto da lontano immediato e permanente. Certo il privilegio della vista nell’elaborazione della cultura occidentale non ha contribuito a una coltivazione del tatto. E l’uso della tecnica per dominare la natura ha trascinato con sé lo sviluppo di tutte le tecnologie che ci allontanano sempre più dal toccarci reciprocamente».
Che cosa è successo quando, per i postumi di un incidente, ha cominciato a fare yoga?
«Lo yoga e le tradizioni orientali mi hanno riportato ad abitare il corpo da cui la tradizione occidentale mi aveva invece esiliata, sia riducendomi a una semplice naturalità a disposizione di una cultura al maschile sia attraverso la sottomissione della mia energia corporea a valori soprasensibili. La pratica dello yoga, specialmente la cura del respiro, mi ha aiutata a superare a poco a poco la scissione fra corpo e mente, corpo e anima, dalla quale si è elaborata la tradizione occidentale. Il respiro è ciò che ci permette di passare da una vitalità soltanto naturale a una vitalità e perfino a una possibile condivisione spirituali, che restano radicate nel corpo e lo trasformano in un corpo spirituale che può fare da mediatore tra di noi. La pratica dello yoga mi ha perfino portata a un’interpretazione del messaggio cristiano dell’incarnazione che non mi era stata insegnata, benché sia fedele a parole del Vangelo. Ho in parte reinterpretato in questo modo l’evento dell’Annunciazione nel piccolo libro Il mistero di Maria (ed. Paoline 2010). Ma già in Amante Marina alludo all’importanza della fedeltà alla natura e del toccare nella vita del Cristo stesso, il mediatore fra appartenenza naturale e appartenenza divina».
La salvezza sta ancora nel desiderio?
«Il desiderio è una fonte di energia naturale di cui il nostro corpo ha bisogno per crescere e fiorire. E’ come un sole interiore che si manifesta e si irradia attraverso il nostro corpo: per mantenere e portare a compimento la nostra vita dobbiamo coltivarlo, anche prendendoci cura della nostra bellezza naturale». Come lei scrive, «trasformare il proprio corpo in un’opera d’arte, non con voluttà narcisistica, ma per rendere possibile un’umana condivisione di bellezza con l’altro».
Eppure lei, che tanto ama la cultura greca e che si è addirittura identificata nella figura di Antigone, conclude che coltivare la propria differenza coincide con un destino tragico.
«Rispettare la propria appartenenza sessuata implica sempre una parte di tragedia perché ognuno di noi deve assumerla e coltivarla nella solitudine. Per di più il desiderio aspira all’infinito e all’assoluto, mentre dobbiamo incarnarci in un mondo e una storia che sono finiti. Inoltre, dobbiamo rinunciare alla soddisfazione immediata del nostro desiderio per rispettare la differenza tra le nostre identità sessuate, e anche opporci alla riduzione della nostra identità sessuata all’universalità di un individuo neutro. Sono le due chiavi del tragico insegnamento di Antigone, che come ricordo nel libro All’inizio, lei era, appena uscito da Bollati Boringhieri, prima di unirsi al fidanzato Emone deve dare sepoltura al fratello Polinice. Obbedendo a un ordine più alto, a leggi non scritte che il nuovo ordine rappresentato da Creonte intende abolire. Ma forse l’attuale nostalgia di un ritorno alla cultura greca significa un voler tornare al nostro sé, un sé da cui la nostra tradizione ci ha sempre di più esiliati(e). Si tratta allora di tornare a un’autoaffezione di cui l’età d’oro della Grecia ci aveva già privati(e) sottoponendo il nostro essere globale a una dominazione del mentale. Ora l’autoaffezione ci è necessaria come il pane, perché è la prima condizione della dignità umana».
- Un pamphlet della filosofa elogia il “toccare” “Dobbiamo restituire all’altro la nostra pelle, fino a raggiungere un’intima comunione”
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- LUCE IRIGARAY A CESENA, OSPITE DELLA RASSEGNA "CIO’ CHE CI RENDE UMANI" (di Teatro Valdoca - Comunicato Stampa)25 ottobre 2012, di Federico La Sala
COMUNICATO STAMPA
 Teatro Valdoca
Teatro Valdoca Comune di Cesena
Comune di Cesena CIÒ CHE CI RENDE UMANI
CIÒ CHE CI RENDE UMANI
 poesia filosofia arti
poesia filosofia arti 18 ottobre - 11 novembre 2012
18 ottobre - 11 novembre 2012
 Cesena
CesenaDomenica 28 ottobre 2012 alle ore 18 presso la Sala Conferenze del Palazzo del Ridotto di Cesena continua con un’ospite internazionale la rassegna CIÒ CHE CI RENDE UMANI, organizzata dal Teatro Valdoca insieme al Comune di Cesena, con il contributo di UniCredit.
Lo spazio, allestito teatralmente da Cesare Ronconi come cavea per l’ascolto, accoglierà Luce Irigaray, direttrice di ricerca in filosofia presso il Centre national de la recherche scientifique di Parigi, filosofa francese tra le più note esponenti del pensiero della differenza di genere, in cui nella costruzione di una cultura a due soggetti, il maschile e il femminile sono portatori di valori differenti ma di equivalente importanza per l’elaborazione di legami e di civiltà.
Linguista e psicoanalista, legata al movimento femminista degli anni Settanta, nella sua formazione multidisciplinare ha avuto un ruolo fondamentale negli ultimi trent’anni la pratica dello yoga.
L’incontro sarà introdotto da una breve lettura in versi di Mariangela Gualtieri e presentato da Lorella Barlaam, giornalista e intellettuale vicina al Valdoca.
È nella pratica dell’ incrociare una cultura del respiro con una cultura dell’amore che Luce Irigaray vede una possibile via per un’evoluzione positiva dell’umanità.
Così afferma: “La nostra cultura troppo spesso ha fatto dell’amore un imperativo morale o religioso e non il mezzo e il luogo più determinanti perché l’umanità possa sbocciare. È accaduto perché non ci siamo abbastanza preoccupati di coltivare la vita, anzitutto la nostra vita umana, a cominciare dalla linfa che l’alimenta, che le permette di crescere e di fiorire. Questa linfa risulta da un’energia al contempo naturale e spirituale che si acquista proprio mediante la coltivazione consapevole del respiro... La pratica dello yoga mi ha rivelato un modo di amare che la tradizione occidentale non mi aveva insegnato”.
L’ingresso all’incontro è libero e gratuito. In caso di pubblico eccedente verrà allestita una proiezione in diretta all’interno dell’Aula Magna di Vicolo Carbonari 2.
All’interno della Galleria Comunale d’Arte, nella sala sottostante del Palazzo del Ridotto, sarà possibile visitare la mostra De Visu dell’artista cesenate Erich Turroni, anch’essa inserita all’interno del programma di Ciò che ci rende umani, curata da Marisa Zattini e organizzata da IL VICOLO - Sezione Arte.
La rassegna continuerà domenica 4 novembre con Massimo Cacciari in De Anima e durante la settimana, il 30 e 31 ottobre e l’1 novembre con il laboratorio Scuola temporanea sul corpo sottile - How to grow a lotus, condotto da Francesca Proia.
-
> Luce IRIGARAY. Intervista. La studiosa racconta perché le passioni vanno coltivate fin dall’infanzia. Bisogna imparare a rispettare l’altro, la sua trascendenza (di Luciana Sica - Lezioni di cuore).28 agosto 2012, di Federico La Sala
 Lezioni di cuore
Lezioni di cuore
 Luce Iragaray: l’educazione sentimentale andrebbe insegnata a scuola
Luce Iragaray: l’educazione sentimentale andrebbe insegnata a scuola
 La studiosa racconta perché le passioni vanno coltivate fin dall’infanzia
La studiosa racconta perché le passioni vanno coltivate fin dall’infanzia
 Bisogna imparare a rispettare l’altro, la sua trascendenza
Bisogna imparare a rispettare l’altro, la sua trascendenza
 Per questo sono necessari parole e gesti diversi
Per questo sono necessari parole e gesti diversidi Luciana Sica (la Repubblica, 28.08.2012)
Più o meno tutti sappiamo chi è Luce Irigaray: grande teorica della differenza sessuale, psicoanalista per quanto critica di Freud e soprattutto di Lacan, direttrice di ricerca in filosofia presso il Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi. Nella sua formazione multidisciplinare, non solo la linguistica ha avuto un ruolo fondamentale, ma anche lo yoga che pratica da più di trent’anni: s’intitola Una nuova cultura dell’energia un saggio uscito l’anno scorso da Bollati Boringhieri, l’editore italiano di tutti i suoi libri principali. Tanti, e alcuni di gran successo come quell’Amo a te dedicato a sorpresa a Renzo Imbeni.
Se però le chiedi cosa può aver significato nella sua vita il sindaco di Bologna, agli inizi degli anni Novanta, la risposta avrà tutt’altro che un carattere personale.
Perché lei si esprime così: «Ho voluto dare un esempio di relazione sessuata civile, rispettosa sia dell’uomo che della donna. Volevo insegnare, ai giovani in particolare, che per vivere anche carnalmente una relazione amorosa, è indispensabile passare attraverso un atteggiamento civile. Inoltre un uomo politico che pretende di essere un democratico deve mostrarsi capace di un comportamento corretto verso una donna, una modalità che deve essere reciproca... Ho indicato per iscritto, e nelle numerose presentazioni del libro fatte insieme, i diversi mezzi per raggiungere quest’atteggiamento civile che sia sessuato, non sedicente neutro ma conforme alla nostra identità reale».
Più o meno tutti sappiamo chi è Luce Irigaray, dell’importanza che assegna all’amore, eppure ignoriamo tutto delle sue scelte sentimentali. Ha un riserbo talmente radicale da somigliare anche un po’ a una civetteria. Per esempio, è difficile negare che sia nata in Belgio, dove ha preso una prima laurea in Filosofia all’università di Lovanio («Belga? Io sono francese! », dice lei...). Ma sarà nata nel maggio del 1930, come si legge ovunque? «Quella data, le assicuro che è sbagliata. La data giusta si saprà solo quando sarò morta...». Va bene, signora Irigaray, ma non se la prenda così a cuore con l’anagrafe e con quei cialtroni di Wikipedia.
In un’intervista sull’amore, non dovrebbe essere vietato chiedere qualcosa sul modo in cui si declinano e si vivono i sentimenti. Lei però non ha mai voluto parlare di sé... Non crede che una qualche conoscenza della sua vita privata la renderebbe più “umana”, senza sminuirne il ruolo intellettuale?
«So che è di moda raccontarsi, cosa che si può spiegare nel solco di una tradizione che ha mirato a un’esistenza ideale piuttosto che alla nostra vita quotidiana. Non ritengo però che la mia vicenda personale possa realmente interessare gli altri. Cerco piuttosto di partire dalle mie esperienze e di tradurle a un livello condivisibile. Inoltre nella mia vita sono coinvolte altre persone e non mi sembra opportuno svelare qualcosa di loro. Altro punto importante: i sentimenti hanno bisogno di riservatezza, di segretezza, l’intimità esclude la dimensione pubblica. Potrei anche aggiungere che troppo spesso le donne sono state ridotte alla dimensione affettiva o erotica: un motivo in più per mantenere nascosta la mia vita privata».
Alla lettura dei suoi libri, l’amore risulta un’esperienza cruciale non solo per le persone, ma per la cultura e la politica. Può dire in breve perché?
«Vede, la nostra tradizione si è troppo preoccupata della vita relazionale, del modo in cui ci riferiamo a noi stessi, al mondo, all’altro o agli altri. Ora è forse proprio la maniera di vivere queste relazioni che può distinguerci dagli altri esseri viventi, al livello delle relazioni amorose ma anche delle relazioni pubbliche. Siamo ben lontani da una pratica adeguata della nostra vita relazionale e spesso ci comportiamo in modo peggiore degli animali... Penso che sviluppare una cultura dell’amore possa contribuire al divenire dell’umanità in quanto tale, per non parlare della realizzazione di una democrazia che non si limiti a problemi di danaro. Per di più, praticare l’amore corrisponde al modo d’incarnare il divino, secondo la tradizione cristiana prevalente nell’Occidente».
Amo a te, è il suo libro più celebre. Come a dire: non amo te in una condizione speculare, ma amo “a te”, un altro radicalmente diverso da me...
«Il successo di Amo a te indica la necessità di questo discorso, che ho continuato a sviluppare in altri miei libri più recenti come La via dell’amore e Condividere il mondo. Ovviamente l’amore non può rimanere un affetto solo immediato e quasi istintivo. La lettera “a” di Amo a te ricorda il lavoro necessario che richiede l’amore per rivolgersi realmente all’altro. Significa che prima di poter dire “ti amo” è indispensabile soffermarsi a considerare chi è l’altro, senza sottomettersi o sottometterlo solo ai propri impulsi. Vuol dire: amo “a” ciò e “a” chi tu sei, e cerco di creare una relazione d’amore con te in quanto persona e non solo in quanto oggetto o supporto dei miei sentimenti personali».
Dal possesso dell’altro al rispetto dell’altro, senza perdere la propria identità... Bisogna imparare ad amare, ma questa lezione come e dove si apprende? Può aiutare l’analisi?
«Senza dubbio, l’amore si deve imparare. Sarebbe l’insegnamento scolastico più importante fra tutte le materie in programma, e non a caso suscita un grande interesse da parte dei bambini, degli adolescenti e anche degli adulti - come ho verificato nelle esperienze condotte nelle scuole italiane. Ma i punti principali da insegnare non sono gli stessi per i maschi e le femmine: i primi spesso trasformano in oggetto la persona che amano, mentre le seconde hanno la tendenza a un atteggiamento fusionale con l’altro. Ciascuno deve dunque imparare in modo diverso a rispettare l’alterità dell’altro, la sua trascendenza, direi, per poter amare. Sono necessari altri gesti e parole, rispetto a quelli che ci sono consueti... Quanto alla psicoanalisi, se può aiutare a una presa di coscienza di ciò che proiettiamo di noi stessi sull’altro, temo che non si sia interrogata abbastanza sulle carenze della nostra cultura riguardo lo sviluppo e la condivisione dell’amore».
Attraverso la pratica dello yoga, nella sua accezione più spirituale, non esclude la possibilità di trasformare ognuno di noi in un ponte tra Oriente e Occidente... Ma c’è davvero un rapporto tra la capacità di respirare e la possibilità di amare?
«La nostra cultura troppo spesso ha fatto dell’amore un imperativo morale o religioso e non il mezzo e il luogo più determinanti perché l’umanità possa sbocciare. È accaduto perché non ci siamo abbastanza preoccupati di coltivare la vita, anzitutto la nostra vita umana, a cominciare dalla linfa che l’alimenta, che le permette di crescere e di fiorire. Questa linfa risulta da un’energia al contempo naturale e spirituale che si acquista proprio mediante la coltivazione consapevole del respiro... A me lo yoga ha senz’altro rivelato un modo di amare che la tradizione occidentale non mi aveva insegnato. Incrociare una cultura del respiro con una cultura dell’amore sarebbe una pratica davvero utile per un’evoluzione positiva dell’umanità ».
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! ---- IL SILENZIO DI MARIA. E’ essenziale partire da, e tornare a, l’unione fra le due parti di sé prima di essere capace di vivere la relazione in due con un altro differente (di L. Irigaray - Il mistero di Maria)24 ottobre 2010, di Federico La Sala
PER UNA COMPRENSIONE DELLE PAGINE CITATE DAL LIBRO DI IRIGARAY, FORSE, NON E’ MALE LEGGERE L’ARTICOLO CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE:
 [...] Ci illudiamo di essere tutti e tutte delle grandi ‘volpi’, degli eroi (Ulisse) e delle eroine (Penelope), ma in fondo stiamo solo illudendoci sulla nostra condizione: in verità, siamo solo e ancora degli esseri umani ‘preistorici’, con un solo occhio, un solo orecchio, una sola mano, un solo piede, una sola bocca, una sola testa, e ... un solo genere sessuale - degli esseri ciclopici, che hanno paura di aprire tutti e due gli occhi e pensare davvero con una sola testa - all’altezza del nostro presente storico! Nutriti da ‘bibliche’ e ‘platoniche’ illusioni, continuiamo a vivere come dei bambini e delle bambine che non vogliono crescere e, da millenni, a cantare il ritornello di questa ‘visione’ ballando su un solo piede (non solo a livello del senso comune, ma anche e soprattutto della scienza e della filosofia). [...] (Federico La Sala).
[...] Ci illudiamo di essere tutti e tutte delle grandi ‘volpi’, degli eroi (Ulisse) e delle eroine (Penelope), ma in fondo stiamo solo illudendoci sulla nostra condizione: in verità, siamo solo e ancora degli esseri umani ‘preistorici’, con un solo occhio, un solo orecchio, una sola mano, un solo piede, una sola bocca, una sola testa, e ... un solo genere sessuale - degli esseri ciclopici, che hanno paura di aprire tutti e due gli occhi e pensare davvero con una sola testa - all’altezza del nostro presente storico! Nutriti da ‘bibliche’ e ‘platoniche’ illusioni, continuiamo a vivere come dei bambini e delle bambine che non vogliono crescere e, da millenni, a cantare il ritornello di questa ‘visione’ ballando su un solo piede (non solo a livello del senso comune, ma anche e soprattutto della scienza e della filosofia). [...] (Federico La Sala).
Il silenzio di Maria[ Luce Irigaray. Il mistero di Maria, Paoline 2010, pp. 26-32] *
Nella cultura occidentale parlare è più valutato che non tacere. Chi parla manifesta le sue capacità mentre chi tace dimostra la sua impotenza o la sua sottomissione. Il valore della parola rispetto al silenzio è inverso in certe tradizioni, per esempio orientali. Per un filosofo come Hegel, la fine del nostro cammino dovrebbe essere una sintesi di tutti i discorsi possibili, e il nostro Dio è colui che detiene la chiave del senso della parola. Invece Budda è il saggio capace di pervenire al silenzio. In un caso è alla parola che dobbiamo mirare, nell’altro al silenzio. Il silenzio, allora, non significa un’assenza di un qualcosa, specialmente di vocaboli, ma il compimento di sé, la realizzazione di una perfetta interiorità. Certe rappresentazioni di Budda esprimono l’attuazione di un tale silenzio sbocciando in un sereno raccoglimento dell’intero essere. Budda appartiene a una cultura meno maschile della nostra, in cui il fare, il creare o il dire al di fuori da sé è più apprezzato che non un cammino interiore.
Il silenzio di Maria è spesso interpretato in modo negativo, in particolare dalle donne. Un simile giudizio è determinato da valori occidentali in prevalenza maschili. Il silenzio di Maria può essere inteso in un altro modo. Può significare un mezzo di preservare l’intimità con sé, l’auto-affezione, per non perdersi, segnatamente in un discorso che non è il proprio.
Il silenzio che accompagna le labbra che si toccano l’un l’altro non è necessariamente negativo ma può rappresentare, al contrario, un luogo privilegiato di custodia di sé mediante un ri-toccarsi che segna la soglia fra il dentro e il fuori, le mucose e la pelle. Giungere le labbra - come giungere le mani, ma anche le palpebre - è una via di adunare le due parti di sé per raccogliersi, e dimorare o tornare in sé.
Provare un simile raccoglimento di sé con sé, attraverso le due parti di sé che si toccano l’un l’altra è necessario affinché sia possibile vivere un affetto nella relazione con l’altro senza perdervi se stessa. E’ essenziale partire da, e tornare a, l’unione fra le due parti di sé prima di essere capace di vivere la relazione in due con un altro differente. In mancanza di una tale auto-affezione, di questo raccoglimento di sé con sé, esiste continuamente il rischio di confondere l’altro con una parte di sé o di confondersi, almeno in parte, con l’altro.
Nella mitologia greca possiamo osservare un’evoluzione negativa della posizione delle labbra nelle sculture della giovane dea Korè fra il momento in cui è un’adolescente vergine e il momento in cui è rapita e sposata per forza al dio degli inferni: le sue labbra sono armoniosamente chiuse, toccandosi l’un l’altro, prima del rapimento di Ade, poi sono deformate e, infine, la bocca non si richiude completamente, le labbra rimanendo aperte. Korè-Persefone ha perso l’intimità con se stessa, la possibilità di tornare a sé dopo il suo rapimento.
Il ruolo delle labbra chiuse per custodire un raccoglimento con se stessa spiega anche la reazione di rifiuto della giovane Dora quando il signor K. vuole baciarla allorché stanno assistendo insieme al passaggio di una processione. Freud interpreta un tale gesto come una manifestazione nevrotica quando, invece, mi appare come una volontà del tutto legittima e sana di preservare un’intimità con se stessa - in particolare al momento di un evento religioso - rispetto a un uomo che intende costringere la ragazza ad amarlo, affermando che lei lo desidera senza volerlo riconoscere. Cosa che equivale a una maniera di costringerla, di violentarla, non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico, spirituale.
L’importanza del conservare le labbra chiuse, che si toccano l’un l’altro, ci è anche insegnata dalla sillaba sacra om. L’ultima lettera di questa sillaba, la cui pronuncia richiede che le labbra si chiudano, è supposta salvaguardare ciò che non si è ancora manifestato, e si dice che essa corrisponda al colore nero. Il silenzio di Maria non è, quindi, necessariamente assenza di parole ma riserva di parole o eventi futuri la cui manifestazione è ancora sconosciuta. Maria - come ogni donna? - sarebbe colei che porta in sé il mistero del non ancora accaduto, al di là di ciò che è già apparso. Cosa che sarebbe vera non solo a livello di una generazione naturale ma anche di una generazione spirituale. Partorire un bambino divino significa portare alla luce una nuova epoca della storia dell’umanità. E a una donna che colui che designiamo con il nome di Dio chiede di compiere una tale opera.
Una simile interpretazione è possibile ed essa affida alla donna un ruolo fondamentale nell’incarnazione del divino sulla terra. Molte donne, nella nostra tradizione, sono incapaci di riconoscere che hanno un compito privilegiato da assumere per l’avvento del divino nel mondo. Il carattere molto maschile della nostra cultura le impedisce di valutare a loro ruolo fondatore nel divenire spirituale dell’umanità, un ruolo che trascurano, e perfino disprezzano, in favore di un incarico ecclesiale, più sociale e più visibile, che spetta piuttosto agli uomini.
(Luce Irigaray. Il mistero di Maria, Paoline 2010, pp. 26-32)
«L’angelo apre l’attenzione di Maria al fatto che lei non può generare un bambino divino senza impegnarsi a essere fedele alla verginità del suo respiro, cioè a preservare una riversa di soffio, di anima, capace di accogliere e condividere con, un altro, pur essendo fedele alla propria vita spirituale»
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! --- Irigaray, "Il mistero di Maria" (rec di Annarosa Buttarelli - Studi su Maria nell era del post-patriarcato)23 ottobre 2010, di Federico La Sala
Studi su Maria nell era del post-patriarcato
di Annarosa Buttarelli (il manifesto, 23.10.2010)
In un delizioso libriccino da tenere in tasca come quelli destinati alla meditazione quotidiana, Luce Irigaray scrive una delle tappe più significative della sua ricerca intorno al divino di segno femminile. Il testo, un’intensa riflessione su Maria di Nazaret e madre di Gesù, scritto con la semplicità accurata di chi vuole arrivare al cuore di molti e di molte, si muove per soccorrere un’umanità che ha fatto a pezzi sé e il pianeta dove vive, che non ha quasi più la capacità di alimentare lo spirito e di conservarsi un accesso alla trascendenza, prima ancora di una qualche confessione religiosa.
 Con Il mistero di Maria, la filosofa incoraggia l’accelerazione di un processo
di rispiritualizzazione dell’umano, proponendo un cambiamento generale della forma mentis
occidentale verso una «cultura della saggezza».
Con Il mistero di Maria, la filosofa incoraggia l’accelerazione di un processo
di rispiritualizzazione dell’umano, proponendo un cambiamento generale della forma mentis
occidentale verso una «cultura della saggezza».Si può provare la tentazione di attribuire questa mossa alle sue personali ricerche in ambito buddista e induista, ma rimane lo stupore per la finezza con cui queste ricerche mirino a collocare Maria di Nazaret al centro della nostra vita politica e spirituale. Riprendendo il suo fondamentale Sessi e genealogie, Irigaray ci chiede di mettere al cuore del cambio di civiltà in corso la Madonna cristiana cattolica, in modo da avvalerci della sua opera di «co-redentrice del mondo», insieme a suo figlio Gesù.
Se il senso profondo di questa proposta fosse già stato recepito, potremmo tirare un respiro di sollievo: significherebbe che l’intelligenza generale ha registrato che ci troviamo in pieno postpatriarcato, un tempo che non ha più punti di orientamento, che ha bisogno di un nuovo ordine simbolico da condividere, per il quale occorre trovare immagini, metafore vive, creatività, nuove dimensioni narrative, e perfino mitologiche.
Qui da noi, il cristianesimo popolare e femminile ha seguitato a coltivare il culto di Maria come virgo potens e come figura storica che merita e sostiene tutte le meravigliose attribuzioni contenute nelle Litanie lauretane. La dottrina istituzionale della Chiesa invece, scrive Irigaray, ha scelto di coltivarne la memoria come archetipo di maternità esemplare al servizio di Dio-padre e del suo progetto. La cosa non è rimasta senza conseguenze, né per la nostra cultura, né per la politica, tanto è vero che, in pieno cristianesimo realizzato (?), «di Maria non sappiamo quasi nulla», scrive Irigaray, che è da leggersi anche come un «delle donne non sappiamo e non vogliamo sapere quasi nulla».
La pretesa di Irigaray è alta: mostrare l’evidenza di una correzione teologica improcrastinabile. Colei che è cara a chi «ha fame e sete di giustizia» può essere la figura di una nuova era, di un pensiero incarnato, così come lo è stata per l’inizio dell’era cristiana con il suo consenso a concepire il messaggio d’amore incarnato in suo figlio Gesù. Dice Irigaray che Maria è protagonista consapevole di una novità: il concepimento di una nuova umanità non può essere solo emotivo o fisico (Maria non è mai solo corpo materno), ma accade se si trovano parole nuove, se si parla con l’angelo.
Ci viene ricordato che ogni concepimento è simultaneamente nel corpo, spirito, pensiero e parole e che ogni nuovo inizio ha bisogno di parole vere incarnate e sessuate. Correggendo l’incauto errore di Eva, Maria insegna che non si può pretendere di diventare divini prima di avere portato a compimento la propria umanità, prima di assumerla avendola accettata.
L’autorità simbolica di Maria viene dalla sua misteriosa verginità, fraintesa dalla Chiesa al punto che Luce Irigaray la accusa di minare «i fondamenti stessi del cristianesimo» - ma forse le è sfuggito che già uno dei nomi della Madonna sia «Spirito Santo».
Tuttavia la filosofa respinge la teologia della mediazione dello Spirito Santo (nel mettere incinta Maria, n.d.r) che rappresenta l’amore tra il Padre e il Figlio della Trinità cristiana. «Maria avrebbe concepito senza partecipare!».
La cifra della verginità di Maria (non la castità) starebbe invece a significare che, alle radici stesse del cristianesimo, il legame diretto delle donne con Dio, non è mediato da alcun uomo, né da alcunché di maschile.
Maria appare così anche l’affrancamento, fin dall’origine, dall’identificazione con lo stato di natura in cui la cultura filosofica occidentale ha invitato le donne a rincantucciarsi. Il suo «gesto etico» non consiste solo «nel rispettare, ma anche nel dare» la vita, a un altro differente da lei, mostrando la capacità femminile di «rispettare la trascendenza dell’altro, di cui pochi uomini sono effettivamente capaci». In continuità con la sua ricerca sui «trascendentali sensibili» nella vita di relazione (Etica della differenza sessuale), Irigaray presenta Maria come «la prima figura divina del tempo dell’incarnazione».
Fatta eccezione per la mistica, l’autrice polemizza con l’esito di una cultura cristiana anestetizzata, che considera trascendente solo ciò che «sfugge alle nostre percezioni sensibili, solo ciò che è disincarnato». Maria, concependo e crescendo nel suo corpo l’invisibile divino, mostra la realtà del divino dentro l’umano e testimonia la necessità di coltivare le percezioni sensibili interiori ed esteriori, una «cultura del toccare» sensibile e carnale versus le politiche dell’immunizzazione, dell’astrazione e dell’indifferenza.
Luce Irigaray, Il mistero di Maria, Paoline, pp. 58, Euro 11,50
-
> UOMO-DONNA ---- Siamo stati educati a seguire modelli culturali preesistenti piuttosto che a edificare insieme un nuovo mondo grazie alle fecondità delle nostre differenze (di Luce Irigaray - Paura. Le nostre vite espsote all’incertezza).1 aprile 2009, di Federico La Sala
 Paura
Paura
 Le nostre vite esposte all’incertezza
Le nostre vite esposte all’incertezza
 Un sentimento che oggi ha preso il sopravvento
Un sentimento che oggi ha preso il sopravvento La filosofa e psicoanalista francese: non riguarda solo i bambini, è la vita reale che spaventa gli adulti
La filosofa e psicoanalista francese: non riguarda solo i bambini, è la vita reale che spaventa gli adulti
 Ed è dentro di noi che
dobbiamo trovare la causa del suo potere
Ed è dentro di noi che
dobbiamo trovare la causa del suo potere
 È indispensabile tornare a una cultura più complessiva del nostro essere
È indispensabile tornare a una cultura più complessiva del nostro essere
 Essere fedeli alla nostra singolarità esige di sviluppare le relazioni con l’altro, gli altri
Essere fedeli alla nostra singolarità esige di sviluppare le relazioni con l’altro, gli altri di Luce Iragaray
(la Repubblica, 01.04.2009)
di Luce Iragaray
(la Repubblica, 01.04.2009)La paura è sempre esistita, ma essa assume caratteri particolari nella nostra epoca. Anzitutto la paura è generale e ovunque. La paura di respirare un’aria inquinata e di mangiare un cibo tossico; la paura di essere contaminati da qualche virus, sennò da qualche ideologia; la paura di perdere il lavoro ma pure i beni acquisiti grazie al lavoro; la paura che non ci sia un domani: per la salute, per l’amore, per i viveri o l’acqua, per il pianeta; la paura di stare a casa ma anche di uscire di casa dove una qualsiasi violenza potrebbe colpirci.
La paura, quindi, non è solo un affare di bambini non ancora cresciuti e che hanno bisogno di adulti per essere aiutati a entrare nella vita reale. La stessa vita reale oggi spaventa prima gli adulti che sono consapevoli del carattere precario e pericoloso della nostra esistenza attuale, che sono pure capaci di prevedere l’incertezza dell’avvenire per l’umanità. La paura non è più un problema che si può curare con l’età, nemmeno con una terapia.
Risulta da fenomeni oggettivi che si sommano e creano un ambiente di vita che ci rende vulnerabili e in un certo modo malati. Ma si tratta di una malattia che nessun medico né nessuna medicina possono guarire? Certo, ci sono medici che prescrivono neurolettici o antidepressivi, ma non curano perciò la paura. Ci sono anche persone che fanno uso di droghe meno legali per trovare conforto, ma diventano tossicodipendenti senza aver superato la soggezione alla paura, piuttosto l’hanno raddoppiata.
Superare la paura generalizzata che corrisponde ormai all’atmosfera della vita quotidiana richiede il passaggio a un’altra epoca. Cerchiamo ancora di imputare qualche altro - individuo o cultura - della causa della paura. Questa risulterebbe da una certa sorta di terrorismo, dalle forme assunte da tale e tal altra religione, o dal modo di comportarsi di un altro popolo o di un’altra generazione.
Addossare a qualcun altro la responsabilità della paura non ci può aiutare a superarla. È piuttosto in noi stessi e nel nostro modo di vivere che dobbiamo trovare la causa dell’onnipresenza della paura e del suo potere. Se la nostra tradizione si fosse curata un po’ meglio di coltivare il respiro e l’energia, saremmo più capaci di rimanere in noi e di resistere alla paura. Ci siamo tanto allontanati da noi che non abbiamo un luogo in cui ripararci, qualcosa in noi a cui appoggiarci per sfuggire alla pressione ambientale. La quale incita una gran parte di noi a rifugiarsi nel divertimento, come accade spesso nei tempi incerti. Ma un simile comportamento, che corrisponde a una sorta di droga, contribuisce ad alimentare l’incertezza!
Tornare a una cultura più complessiva del nostro essere è indispensabile, non solo per sopravvivere ma anche per tentare di aprire nuovi orizzonti. Oltre al fatto che sia stata una cultura del fra simili, che affronta le differenze in un modo quasi soltanto quantitativo e gerarchico, la nostra tradizione ha favorito un’educazione delle facoltà mentali a discapito di una formazione più globale. Questi caratteri culturali ci hanno resi abbastanza deboli e poco capaci di convivere nella differenza, cioè di adattarci alle realtà del nostro tempo.
Siamo stati educati a seguire modelli culturali preesistenti piuttosto che a edificare insieme un nuovo mondo grazie alle fecondità delle nostre differenze. Ora, questo è il lavoro che spetta a noi di compiere oggi. Un tale lavoro esige da noi di essere più autonomi e creativi di quanto siamo.
Infatti, abbiamo ancora da superare la dipendenza da quelli che crediamo conoscano meglio di noi quali siano il nostro bene o il nostro male. Adulti, restiamo anche bambini a causa di una simile aspettativa riposta in quelli che sostituiscono l’autorità parentale. Fidarci del loro parere e della loro parola senza rimanere all’ascolto delle nostre percezioni e della nostra esperienza, ci rende fragili e recettivi alla paura, di cui, per altro, certi usano per stabilire un loro potere. Ci fanno credere che se non rispettiamo i loro consigli, rischiamo di danneggiare il nostro corpo, il nostro statuto sociale, perfino la nostra anima.
Sfortunatamente non ci svelano che cosa perdiamo fidandoci della loro autorità senza essere fedeli al nostro proprio sentire. Una condizione necessaria per costruire una vita adulta autonoma.
Essere fedeli alla nostra singolarità e incaricarci di farla fiorire deve accompagnarsi con il rispetto della singolarità dell’altro e l’aiuto portato al suo proprio compimento. Questo ci richiede di crescere come adulti autonomi capaci di proseguire il proprio cammino senza rinunciare a esso per qualsiasi paura. Esige anche di sviluppare le relazioni con l’altro, gli altri, non solo in quanto figli di una stessa particolare famiglia - naturale, culturale, politica, nazionale, eccetera - i figli che sono radunati in nome di una specifica appartenenza, e che formano un tutto che, almeno in parte, si richiude a partire dall’esclusione dell’altro in quanto differente. Figli che sono più o meno in competizione per essere il capo, il primo, il più bravo, il più competente, il più amato eccetera. Abbiamo piuttosto da crescere fino a raggiungere una maturità che ci consenta di comporre una famiglia umana di fratelli e di sorelle di cui le differenze si intrecciano e si fecondano in nome di un’appartenenza naturale universale e della libera volontà di ciascuno e di ciascuna di costruire insieme un mondo che corrisponda all’epoca in cui viviamo e abbiamo da convivere nella dignità, nella pace e, per quanto difficile questo talvolta sia, nella felicità.
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! ---- LE IPOCRISIE SULL’AMORE (di Luce Irigaray).6 novembre 2008, di Maria Paola Falqui
Le ipocrisie sull’amore
di LUCE IRIGARAY (la Repubblica, 16 settembre 2008)
Cercando nel dizionario Robert l’etimologia della parola "prostituire" o "prostituirsi", ho scoperto che il suo primo senso e’: esporre in pubblico cose che richiedono un po’ di riservatezza, un po’ di discrezione. Il significato della parola anzitutto conosciuto da noi oggi e’, infatti, piu’ tardo, cioe’ il suo riferimento alla prostituzione del corpo per rapporti sessuali con una, o generalmente parecchie persone, in cambio di denaro.
Stranamente, il primo senso della parola dovrebbe svanire quando si tratta di sessualita’. Anche se e’ per natura pubblica, la prostituzione dovrebbe allora rimanere invisibile. Ma come una cosa pubblica puo’ esercitarsi in modo nascosto? Questo e’ il paradosso legato alla prostituzione: esiste a condizione che non si sappia e che non si veda che esiste. Di conseguenza, e’ cacciata da tutti i luoghi pubblici in cui si potrebbe sapere o vedere che si esercita: le case di tolleranza, le strade, eccetera. Non c’e’ nulla di strano in tale contraddizione.
La prostituzione partecipa della sorte riservata alla sessualita’ nella nostra cultura: esiste a patto che non si sappia, che non si manifesti in quanto tale. Nulla nei programmi scolastici tiene conto della necessaria educazione sessuale dei bambini, dei ragazzi e adolescenti. I programmi scolastici si fermano a insegnamenti relativi agli organi di riproduzione senza abbordare la questione dell’attrazione sessuale e delle vie per condividere il desiderio a un livello corporeo.
L’istruzione si limita a descrizioni naturaliste degli organi sessuali da una parte, e dall’altra all’esposizione delle sventure amorose vissute dai personaggi della nostra letteratura. Si puo’ capire che i ragazzi cerchino presso le prostitute un’educazione un po’ piu’ adeguata a cio’ che provano. Sfortunatamente, visto il disprezzo della sessualita’ nella nostra tradizione, e pure l’etica della stessa prostituzione, questi maschi in cerca di educazione sessuale ricadono in rapporti sessuali piuttosto naturalisti, senza desiderio ne’ amore, che si svolgono in luoghi spesso sordidi e in cambio di denaro.
Una simile iniziazione alla sessualita’ non favorisce gli abbracci amorosi futuri fra amanti; e’ piuttosto incitamento a mostrare le proprie capacita’ in un rapporto venale fondato su una certa schiavitu’. Questo non contribuisce allo sviluppo della personalita’ del ragazzo, in particolare nella sua dimensione affettiva e relazionale, per la quale ha tanto bisogno di un’istruzione appropriata.
La ragazza, da parte sua, non ha quasi mai l’opportunita’ di un’iniziazione sessuale scelta da lei. Diviene il piu’ delle volte una sorta di prostituta involontaria, anche nello stesso matrimonio, e l’attrazione sessuale che prova si fa sogno sentimentale in attesa di qualche principe o signore, forse estraneo alla nostra vita terrena. Si possono immaginare i problemi e le delusioni dei primi abbracci amorosi.
Ora l’attrazione sessuale e’ cio’ che ci puo’ facilitare il passaggio dai bisogni individuali legati alla sopravvivenza a una condivisione con l’altro. E’ cio’ che ci puo’ aiutare a trascendere il nostro corpo come materia attraverso il desiderio, un desiderio che fa da ponte e mediazione tra corpo e anima, e anche fra l’altro e noi stessi. Questa spiritualizzazione del corpo e dell’amore carnale e’ resa impossibile per mancanza di una cultura della sessualita’, per la sua repressione e riduzione a un bisogno, sessuale e perfino procreativo, che non ha piu’ nulla di propriamente umano.
*
 Fonte: NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE.
Fonte: NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE.
 Supplemento settimanale del giovedi’ de "La nonviolenza e’ in cammino"
Supplemento settimanale del giovedi’ de "La nonviolenza e’ in cammino"
 Numero 218 del 6 novembre 2008
Numero 218 del 6 novembre 2008
Sull’argomento, si cfr (cliccare sul rosso per leggere l’articolo ->):
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! ---- "La via dell’amore", l’ultimo saggio della filosofa...Luce Irigaray intervistata da Maria Serena Palieri.17 giugno 2008, di Federico La Sala
Una nuova democrazia? Fondiamola sull’amore
Luce Irigaray intervistata da Maria Serena Palieri (l’Unità, 17.06.2008)
Se alla parola «filosofia» dessimo il significato di «saggezza dell’amore» anziché «amore della saggezza» come si è fatto per duemila anni?
 Oggi i cittadini sono come bambini in ascolto del Capo. La trappola è nel fatto che il Capo è stato eletto da noi stessi. Nostra è la colpa
Oggi i cittadini sono come bambini in ascolto del Capo. La trappola è nel fatto che il Capo è stato eletto da noi stessi. Nostra è la colpa Ségolène e Hillary candidate alle massime cariche sono una vera rottura col passato? Senza un programma «da» donne c’è il rischio di screditare il nostro sesso
Ségolène e Hillary candidate alle massime cariche sono una vera rottura col passato? Senza un programma «da» donne c’è il rischio di screditare il nostro sesso «Chiedere l’uguaglianza, come donne, mi sembra un’espressione sbagliata per un obiettivo reale. A chi o a che cosa vogliono essere uguali le donne? Agli uomini? A una retribuzione? A un impiego pubblico? Uguali a quale modello?
Perché non uguali a se stesse?»
«Chiedere l’uguaglianza, come donne, mi sembra un’espressione sbagliata per un obiettivo reale. A chi o a che cosa vogliono essere uguali le donne? Agli uomini? A una retribuzione? A un impiego pubblico? Uguali a quale modello?
Perché non uguali a se stesse?» Si intitola La via dell’amore l’ultimo saggio della filosofa che, dal 1974 e dallo «scandalo» di Speculum, è punto di riferimento del pensiero femminile. Un testo che propone una provocazione radicale. Lei stessa ce la spiega
Si intitola La via dell’amore l’ultimo saggio della filosofa che, dal 1974 e dallo «scandalo» di Speculum, è punto di riferimento del pensiero femminile. Un testo che propone una provocazione radicale. Lei stessa ce la spiegaFilosofia: parola composta, dal greco, a partire da due altre, «amore» e «saggezza». Ma queste due, una volta mescolate, a quale terzo nuovo senso danno luogo? Da due millenni e mezzo diciamo che filosofia significa «amore della saggezza». E se, invece, significasse «saggezza dell’amore»? Cosa sarebbe successo, insomma, se nella storia umana la saggezza fosse stata regolata dall’amore?
Luce Irigaray, filosofa e psicanalista, dopo trentaquattro anni di cammino tenace - è del 1974 lo «scandaloso» successo di Speculum, il saggio con cui decostruiva Freud, Platone e Hegel, tra gli altri, per indagare nel continente ignoto dell’identità e della sessualità femminile, del 1984 il saggio che poneva un primo mattone della sua originale teoria successiva, Etica della differenza sessuale, del 1992 quello in cui cominciava a saggiare l’idea di una «polis» aperta ai due sessi, Io, tu, noi, per una cultura della differenza - è arrivata in questo 2008 nelle nostre librerie, per Bollati Boringhieri, con un testo dal titolo magnificamente innocente, La via dell’amore. Di innocente, in questo pamphlet, c’è lo sguardo con cui Irigaray, studiosa settantottenne, partendo da quello slittamento di senso di una parola bimillenaria, «filosofia», finisce per leggere con incandescente radicalismo il nostro tempo. «La tradizione occidentale ha privilegiato la sapienza a discapito dell’amore. E l’uomo occidentale ha confuso poi la sapienza col dominio sulla natura, compresa la natura propria e quella dell’altro. Perché l’ha fatto? Perché doveva emergere dal mondo materno, inteso come natura, e invece di risolvere la cosa in termini di relazione nella differenza, ha scelto la via del dominio sul mondo naturale, mondo materno compreso»: così Irigaray riassume, per noi, quel mistero delle origini. «Forse in un primo tempo non poteva fare altrimenti» aggiunge. «E la mia ipotesi è che l’uomo abbia bisogno ora che la donna si individui in quanto donna per aiutare lui, l’uomo, ad uscire dal mondo materno». Nell’ultimo decennio alcuni studiosi (uomini) si sono avventurati a parlare di «fine della storia»: stop, l’evoluzione umana è arrivata al capolinea. Per Luce Irigaray sembra sia vero il contrario: siamo a un inizio. Con un’avvertenza: «La liberazione femminile, se avviene solo “contro” gli uomini, non servirà a granché. Anche i separatismi, che pure hanno avuto una funzione storica, sono da superare, salvo che come strategia puntuale per ottenere certi diritti» osserva.
In un momento in cui la democrazia collassa fare un discorso sulla saggezza dell’amore e la relazione a due può sembrare un lusso. Lo è? Oppure quella che Irigaray propone è un’altra idea di democrazia, una democrazia radicale?
«Nella cosiddetta democrazia, secondo me, la gente è diventata troppo dipendente, i cittadini sono come bambini, in ascolto di quanto decide il capo. La trappola è nel fatto che il capo è stato eletto da noi stessi. Così, i disastri della democrazia sarebbero comunque colpa nostra. Dunque, cerco di dire che la gestione della città, la gestione di noi stessi e dei rapporti tra di noi, invece, deve essere a carico nostro. La politica è compito di noi tutti e tutte, non solo dei politici. La politica, e in particolare la democrazia, spesso, hanno lavorato più a separare i cittadini che ad avvicinarli. Il mio discorso punta a riannodare queste relazioni, facendo leva sulla potenza estrema - per chi la sa vedere - della differenza. L’amore è alla nostra portata e rifondare la società civile è compito di noi tutti e tutte. Intendo la parola “amore” in senso forte, non debole, non paternalistico né sentimentale, amore come rispetto dell’umano, nella sua totalità. La mia perdita di fiducia nella politica risale a molti anni fa. È allora che ho deciso che, anziché criticare e aspettare, dissipando così salute ed energia, da subito potevo usarle, invece, per creare legami. Ho cominciato, cioè, a lavorare sul “due”. Rifondare la relazione a due è il mezzo per rifondare la società civile. Puoi farlo ogni giorno, dieci volte al giorno, e a sera hai fatto qualcosa».
Il saggio affronta anche il rapporto tra religione e filosofia. La questione religiosa è, in questo momento, scabrosa. Lei come la intende?
«Io vivo in Francia. Sono politicamente laica. Trovo che l’avanzata dei fondamentalismi, e le crisi politiche che ne conseguono, derivino dal fatto che la filosofia, come detto all’inizio, si sia disinteressata dell’amore, a favore della sapienza governata dal Logos. Ma, siccome l’amore fa parte dell’umano, esso è finito delegato alla religione. E questo ha creato un disastro. Sia nella religione, che in politica».
Il saggio ha come bersaglio polemico anche il nuovo universo, informatico, nel quale viviamo. E quello che lei ha definito «capitalismo intellettuale». Perché?
«Non definisco l’informatica in quanto tale come capitalismo intellettuale, ma l’uso che alcuni ne possono fare e le conseguenze di un uso generalizzato di essa. Il linguaggio dell’informatica deriva dalla logica occidentale che ha creato un mondo parallelo a quello della vita, dove esistono le differenze. L’informatica, con la sua logica binaria, estranea alla vita, appartiene a questo mondo parallelo. Per sfuggire a questo dominio dobbiamo cercare di tornare a un linguaggio concreto, carnale, fatto di rispetto della stessa natura e di relazione tra noi. Prendiamo il silenzio: l’informatica non sa cosa sia, il silenzio è qualcosa che non è né bene né male, ma è un luogo dove ci si può incontrare, nel rispetto delle nostre differenze, ed elaborare un mondo comune, a partire da trasformazioni dei rispettivi mondi. L’informatica non sa cosa sia il silenzio, nemmeno l’intimità. La nostra logica occidentale corrisponde a un linguaggio che nomina il reale per appropriarsene, ma così lo immobilizza, lo uccide in qualche modo. Noi diciamo “un albero” e, nel dirlo, cancelliamo la vita, le trasformazioni che un albero vive in primavera, in autunno, in inverno. La logica occidentale è anzitutto un padroneggiare il mondo in una maniera mentale: ad esempio dire “un castagno” parla prima al cervello, invece parlare di “questo castagno qui in fiore” si rivolge a tutto il nostro essere. Insomma, io cerco di tornare a, o di inventare, un linguaggio carnale, che tocchi, che corrisponda al nostro essere totale e che ci consenta di comunicare in quanto viventi».
Lei contrappone «familiarità» a «intimità». Valorizzando la seconda a scapito della prima. Perché?
«La familiarità è ciò che ci unisce in un passato comune attraverso abitudini, costumi: io e te siamo dello stesso paese, condividiamo la nostra casa di famiglia, abbiamo vissuto insieme quell’evento... La familiarità è legata al passato. Ci incarcera nel nostro modo di vivere, nella nostra propria lingua. Ci impedisce quindi di avvicinarci all’altro: all’altro sesso, all’altra generazione, allo straniero. Ci impedisce di creare intimità con l’altro, attraverso le differenze». Nel suo saggio parla anche della «fabbricazione di bellezza» e della «fabbricazione di erezione». Insomma, parlando di «saggezza dell’amore» si finisce a parlare di lifting e Viagra... «Non andiamo perfino verso la fabbricazione dello stesso corpo? La nostra sapienza prima ha voluto dominare la natura, ora vuole fabbricare la natura al posto di lasciarla essere e crescere. Per la natura non c’è più posto. Se si fosse coltivata un po’, invece, la saggezza dell’amore, di tutto questo non ci sarebbe bisogno: la relazione carnale basterebbe per farci apprezzare i nostri corpi come sono, dei corpi che sarebbero d’altronde più seducenti perché più vivi, come si può verificare nelle culture che coltivano il respiro, l’energia della vita al posto di inventare artifici per mascherarla».
Ma l’informatica, che ci dona l’ubiquità, così come la velocità che ci consente di raggiungere ogni angolo del pianeta, non accentuano la vicinanza? Non aiutano a comunicare?
«Lo crede? Ha visto il numero di persone che parlano ormai da sole per strada? E che si arrabbiano se tu interrompi il loro parlare da soli? E che, quando non parlano da soli per strada parlano a casa col loro computer? In fedeltà a una nostra tradizione occidentale, le persone si parlano sempre più in assenza di una presenza carnale: le dita toccano molto i tasti del computer ma poco il corpo dell’altro. In noi esseri umani, poi, ci sono ritmi diversi: i ritmi di digestione, cuore, respiro, parola, pensiero. Le macchine ci stanno riducendo a un ritmo uniforme, a un ritmo perfino solo mentale. E questo è pericoloso...».
Luce Irigaray cosa pensa di questo mondo del 2008, in cui ci sono state donne candidate a cariche mai avute prima: Ségolène Royal all’Eliseo, Hillary Clinton alla Casa Bianca?
«Alle donne che si candidano chiedo di presentare un programma “da” donne. Altrimenti temo che facciano perdere credibilità al nostro sesso. Vedo molte donne che vogliono diventare uomini, per entrare in politica. Ho paura che le donne stiano lentamente omologandosi. Il totalitarismo più sottile, oggi, è l’omologazione. E se perdiamo l’ultima carta della differenza sessuale, da dove rifonderemo la democrazia? Io vedo fondamentalismi, denaro, violenza. Per la democrazia abbiamo bisogno di differenze. Puntare solo sull’uguaglianza è sbagliato. È molto impegnativo costruire una cultura rispettosa delle differenze, partendo dalla differenza tra noi, perché questo richiede una rivoluzione nel nostro modo di pensare. Tuttavia è necessario farlo oggi: è la vita stessa che è a rischio, in particolare perché ci manca la possibilità di sperare in un futuro. Bisogna riaffidare a ciascuno e ciascuna il compito di costruire un futuro possibile per l’umanità».
E un programma politico da donne in cosa dovrebbe consistere?
«Io penso che il mio modo di pensare e di parlare siano fedeli alla mia appartenenza al sesso femminile, sono basati sulla mia esperienza di donna. Dopo aver lavorato per anni sulla sessuazione del discorso ho capito che, in modo più colto, sono fedele alla ragazza che sono stata: privilegio, cioè, il dialogo fra soggetti, fra due soggetti differenti, senza considerare genealogie o gerarchie, e preferisco il presente e il futuro al passato. Fare una politica “da”, “di” donna esige per prima cosa di cambiare il modo tradizionale di parlare,per esprimersi come donna pur rispettando la differenza dell’altro. Significa entrare in un’altra logica, in cui la relazione con l’altro, nella sua singolarità, prevale sulla relazione con l’oggetto, con il denaro. Ciò richiede di scoprire e utilizzare un linguaggio che rimane sensibile, toccante, senza cancellare però i limiti delle rispettive identità o mondi. Bisogna curare l’aspetto creativo, performartivo della parola».
È anche da qui che passa la «via dell’amore»?
«In effetti una politica “di” donne potrebbe corrispondere a una saggezza dell’amore. È una saggezza che le donne devono acquistare e coltivare, sia a livello pubblico che privato. Ovviamente essa non può limitarsi a imporre nella vita pubblica le sole cose consentite alle donne nella nostra tradizione: sentimenti più o meno infelici e rivendicativi. Importa che scopriamo, invece, una libertà positiva e non solo negativa, cioè non l’essere libere malgrado o contro gli uomini, ma esserlo per noi stesse e per un’opera che corrisponda al nostro essere. È un peccato che le donne spendano tuttora la loro energia nel litigare con gli uomini o nel diventare uomini. Non sarebbe meglio affermare i propri valori ed elaborare una nuova cultura, una cultura che cerchi di dialogare con l’altro, con tutte le forme di altri?».
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! A Mantova, Luce IRIGARAY rilancia la questione, ma - incompresa - viene "snobbata"!!! --- "La via dell’amore", il nuovo saggio di Luce Irigaray (di U. Galimberti).13 aprile 2008, di Federico La Sala
"La via dell’amore", il nuovo saggio di Luce Irigaray
di Umberto Galimberti *
E se "filo-sofia" non volesse dire " amore della saggezza" ma "saggezza dell’amore", così come "teo-logia" vuol dire discorso di Dio e non parola di Dio, o come "metro-logia" vuol dire scienza delle misure e non misura della scienza? Perchè per "filo-sofia" questa inversione nella successione delle parole? Perchè in Occidente la filosofia si è strutturata come una logica che formalizza il reale, sottraendosi al mondo della vita, per rinchiudersi nelle università dove , tra iniziati, si trasmette da maestro a discepolo un sapere che non ha alcun impatto sull’esistenza e sul modo di condurla? Sarà per questo che da Platone, che indica come condotta filosofica " l’esercizio di morte",ad Heidegger, che tanto insiste suill’essere-per-la morte , i fillosofi si sono innamorati più del saper morire che del saper vivere?
Questa è la provocazione di Luce Irigaray che, nel suo ultimo libro: La via dell’amore, denuncia l’atteggiamento tipico e totalmente irriflesso del filosofo che, nella cura della purezza del logos, trascura il dia-logo con uno o più soggetti differenti, come le donne, per esempio, onde evitare i delicati problemi relazionali che nascono dal confronto con l’altro. E’ saggio tutto questo? O è semplicemente il sintomo di una paura o di una incapacità di entrare in relazione con l’altro?
Con questa provocazione Irigaray non intende distruggere l’edificio concettuale che la filosofia ha costruito in Occidente, ma denunciarne il carattere parziale, dovuto al fatto che si è preferito coltivare la purezza delle idee piuttosto che il rapporto intersoggettivo tra gli uomini, tutti portatori di idee, amputando così la verità, l’etica, la teologia stessa dei suoi valori di base, per privilegiare un monologo solipsistico, sempre più lontano dal reale.
Tutto ciò non corrisponde a una saggezza umana, ma piuttosto a un esilio circondato da fortificazioni dove il filosofo si ripara, servendosi soprattutto di una lingua difficilmente accessibile e più preoccupata di " parlare di" invece che di " parlare con" gli altri e così apprendere che non c’è una sola verità, una sola bellezza, una sola scienza.
E questo vale soprattutto oggi dove, per effetto della globalizzazione sperimentiamo che la diversità non è solo tra l’uomo e la donna, e più in generale fra i soggetti, ma tra le differenti culture, ciascuna delle quali è portatrice di un’oggettività difficilmente catalogabile con le nostre categorie, oltre che di una simbolica e di una sensibilità che richiedono di essere non solo comprese, ma pensate.
Qui più del logos conta il dia-logo, che è possibile solo quando riconosco che l’altro possa avere un gradiente di verità superiore al mio. Questa è l’essenza della tolleranza che le religioni, nonostante il gran parlare che ne fanno, misconoscono. Perchè non si può dialogare con chi si ritiene depositario di una verità assoluta. Questo la filosofia deve dire alle religioni, ma solo se si presenta non tanto come amore per la saggezza quanto come saggezza dell’ amore. Perchè è proprio dell’amore il riconoscimento dell’alterità dell’altro.
Bisogna allora passare dalla "trascendenza verticale" proposta dalle religioni alla "trascendenza orizzontale" che riconosce l’altro non nel Grande Altro ma nell’altro che ogni giorno incontriamo e che invoca un discorso per elaborare non la città ideale di Platone che sta nell’iperuranio, ma un universo che sia da tutti il più possibile condiviso. Meno filosofia del logos e più pratica filosofica attenta al mondo della vita. Questo forse oggi è necessario se non addirittura urgente.
 LUCE IRIGARAY,
LUCE IRIGARAY,
 La via dell’amore,
La via dell’amore,
 Bollati Boringhieri
Bollati Boringhieri
 Traduzione di Roberto Salvatori
Traduzione di Roberto Salvatori
 Pagg. 117,
Pagg. 117,
 Euro 14
Euro 14* La Repubblica/Almanacco dei libri, 12.04.2008.
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! A Mantova, Luce IRIGARAY rilancia la questione, ma - incompresa - viene "snobbata"!!!28 maggio 2007, di LAURA TUSSI
IL FUTURO E’ DONNA? ...nelle problematiche attuali
di LAURA TUSSI
Riconoscere la soggettività della donna corrisponde a riconoscere anche la differenza: la pari dignità non viene stabilita sulla base di una omogeneizzazione dei due sessi, ma sulla identificazione della differenza come valore. Non si vuole qui fare l’elogio del pensiero della differenza sessuale (che è comunque un momento alto della partecipazione femminile all’elaborazione culturale) ma sottolineare ancora una volta che la rilevazione della differenza sessuale come positività dà diritto di cittadinanza culturale a tutte le altre differenze (etnica, culturale appunto, ma anche di età, di salute, di stato sociale ecc.). Ciò sembra importante soprattutto in un momento in cui le differenze etniche-culturali stanno spaccando nazioni, anche da lungo tempo costruite sull’unione di etnie diverse, in tanti piccoli satelliti. Rimane certamente un problema quello delle varie forme di discriminazione e di violenza sulle donne e sulle bambine. Una questione grave è il precariato sul lavoro, il cosiddetto mobbing e la precedenza data al licenziamento, o alla messa in cassa integrazione, delle donne nelle situazioni di chiusura totale o di de-localizzazione delle aziende. Legati al fenomeno dell’immigrazione ci sono i problemi dello sfruttamento e del traffico di donne. Di crescente rilievo sociale, giuridico e morale è la piaga culturale che riguarda quelle donne immigrate le quali, lavorando in particolare quali badanti o infermiere nelle nostre case e nei nostri ospedali, fanno partecipi le nostre famiglie dello stato di disagio in cui si trovano le loro stesse famiglie rimaste nei paesi di provenienza: prive di madri, figlie, sorelle... La sfida del ricongiungimento del nucleo familiare ci coinvolge nel nostro più intimo vissuto quotidiano. Partire dai diritti umani delle donne e delle bambine porta a considerare con mente nuova la pratica della socialità, della politica, dell’economia, dell’educare e del formare per un avvenire globale completo. Alla fine non può non scattare una più avvertita consapevolezza del valore della centralità della famiglia, del rilievo e della irrinunciabilità degli essenziali servizi sociali, della necessità di politiche pubbliche sostanziate di adeguate risorse. E’ stato grande l’apporto femminile nella crescita globale dell’attenzione e responsabilizzazione verso i soggetti più deboli (bambini, anziani, handicappati) che, essendo un tempo gestiti individualmente dalle donne nell’ambito familiare, poi non venivano presi in responsabilità dal sistema sociale. Altrettanto grande è stato il contributo femminile alla sensibilizzazione verso le tematiche ecologiche, alla tutela e preservazione dell’ambiente, legata anche all’antica consuetudine, come donne, della gestione del quotidiano. Al femminile è la presa di coscienza dei grandi temi della pace, del ripudio della guerra, delle denunce alla violazione dei diritti umani in ogni realtà. Non vi è dubbio che per portare avanti un impegno in prima istanza individuale, una presa di coscienza, e poi collettiva, le donne devono innanzitutto conoscere e riconoscere se stesse per poter chiedere all’alterità un corrispondente riconoscimento. In questo senso le donne devono compiere ancora lunghi percorsi di emancipazione. In alcuni casi debbono creare e ricreare immagini di sé che non hanno avuto, non limitandosi ad un inventario dell’esistente, della realtà di fatto, del contingente.
Le culture si sono sviluppate sui tentativi successivi degli umani di superare le diversità, di colmare lo scarto, di rendere realizzabile l’utopico. La rivelazione della differenza sessuale come positività, attribuisce diritto di cittadinanza culturale a tutte le altre differenze, etniche, culturali, ma anche di età, intergenerazionali, di salute, di stato sociale. Questo è importante soprattutto in un momento in cui le differenze etnico-culturali sgretolano nazioni, anche da lungo tempo costruite sull’unione di etnie diverse, in tanti piccoli satelliti. La differenza di sesso è forse attualmente quella che subisce i maggiori attacchi. Anche le scienze dimostrano che riconoscersi in un sesso è un processo culturale oltre che fisiologico e psichico. Le elaborazioni del neofemminismo hanno dimostrato che la partecipazione delle donne ai processi culturali è stata di notevole spessore, anche se sotterranea, tacita, priva di protagonismi, quasi ignorata dalle donne stesse.
Proprio nella quotidianità e non nelle orchestrazioni metafisiche si gioca il senso più rilevante della nostra esistenza, anche come donne. In questo senso Hannah Arendt scriveva con evidente lucidità: “E’ vano cercare un senso nella politica o un significato nella storia quando tutto ciò che non sia comportamento quotidiano o tendenza automatica è stato scartato come irrilevante”. Abbiamo come donne forza, tenacia, creatività, capacità di resistenza anche in situazioni di tensione. Abbiamo anche una certa “innocenza” che deriva dal fatto di essere state lontane dai luoghi di potere.
Abbiamo dimestichezza con le origini della vita e della morte: “sappiamo” per retaggio atavico. Eros e Tanatos trovano ricomposizione nella nostra stessa esistenza. Dobbiamo innanzitutto riuscire ad utilizzare le forze positive che si liberano nell’inevitabile conflitto tra i “diversi”, per sesso, per età, per cultura, come stimoli a cambiare, a crescere, neutralizzando la parte negativa del conflitto che si esprime in prevaricazione, ricerca di possesso dell’altro, tentativo di omologazione dell’altrui diversità ad un modello costruito a nostra immagine e somiglianza o per nostro tornaconto. Il conflitto sessuale non è a se stante, ma partecipa di una conflittualità che permea tutto il reale, perché è un atto creazionale, proiettato nell’avvenire.
Laura Tussi
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! A Mantova, Luce IRIGARAY rilancia la questione, ma - incompresa -viene ’snobbata’!!!9 settembre 2006, di Federico La Sala
SULL’IMPORTANZA DELLA INDICAZIONE di IRIGARAY, come di Laura LILLI, come di Franca Ongaro Basagla (ricordo la sua straordinaria "voce": DONNA, nella Enciclopedia EINAUDI), ricordo che .....
Che cecità!!! Allo stesso modo fu liquidata l’indicazione, sorprendente e coraggiosa, di Elvio Fachinelli (La mente estatica, Adelphi, Milano 1989), nel solco della lezione freudiana, di un soggetto (in questo già anticipato filosoficamente dalle intuizioni kantiane di un soggeto attivo e recettivo) bi-sessuale (maschile e femminile) - dal punto di vista psichico, senza n-e-g-a-r-e la differenza dei vari sessi !!! Sull’argomento cfr. IL PUNTO DI SVOLTA. L’INDICAZIONE di FACHINELLI E LA SUA IMPORTANZA (in: Federico La Sala. La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani Editore, Roma 1991, pp.138-161 - in rete: www.ildialogo.org/filosofia, 06.01.2006).
Federico La Sala
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! A Mantova, Luce IRIGARAY rilancia la questione, ma - incompresa -viene ’snobbata’!!!8 settembre 2006, di Federico La Sala
PER NON BANALIZZARE ... E APPROFONDIRE, RICORDO IL CONTESTO E LA FONTE DELLA CITAZIONE DELLA INDICAZIONE DI LAURA LILLI: "E’ evidente che ormai, alle soglie del Duemila, siamo alla vigilia di una svolta epocale: i soggetti sono due, e tutto è da ripensare"(L. Lilli, Contro Wojtyla, "La Repubblica" del 24.11.1993).
Sul tema, per riflettere di più e ancora, allego un intervento di Monica Lanfranco. Federico La Sala
La libertà delle donne
di Monica Lanfranco (www.carta.org, 8 settembre 2006)
Il nuovo mensile Carta Etc in edicola da sabato 9 settembre è dedicato in gran parte ai fondamentalismi. Sul tema scrivono anche Monica Lanfranco con questo editoriale e Pierluigi Sullo nella lettera inviata ad Hamza Piccardo dell’Ucoii e pubblicata nel settimanale in edicola dal 9.
Razzismo, sessismo, xenofobia, omofobia: sono alcune delle piaghe più atroci che affliggono il mondo globalizzato di oggi. Nonostante l’informazione apparentemente libera, disponibile e moltiplicata all’infinito dalle nuove tecnologie, nessun luogo e nessuna cultura può dirsi davvero immune da questi frutti malati e orrendi generati da due elementi indissolubili, quando si tratta di confrontarsi con l’altro, o l’altra da sé: paura e ignoranza. Non serve scomodare la psicoanalisi per riconoscere che senza la conoscenza non ci può essere incontro, e che solo con la pazienza e l’ascolto si può sconfiggere il pregiudizio, aprendo conflitti anche forti sulle differenze, ma non cedendo alla guerra e alla violenza. E’ altrettanto innegabile che esistano visioni del mondo e dei rapporti umani molto diverse, spesso lontane, talvolta ingiuste, su questo pianeta. E’ altrettanto vero che dove c’è violenza, ineguaglianza, ingiustizia, sopraffazione e impari accesso alle risorse non si possono affermare allo stesso tempo la libertà e la pace. Temi enormi, terribili realtà che si incarnano nelle vite di donne e uomini che soffrono, vivono esistenze dimidiate, muoiono senza aver realmente vissuto. In molte parti del mondo le ingiustizie hanno origini complesse, ma sempre presente c’è un fattore umanissimo e devastante, che spesso regola scelte collettive e individuali: l’intreccio tra patriarcato e fondamentalismo religioso, che purtroppo è presente in ogni credo, nessuno escluso.
Su questo nodo la rivista Marea, trimestrale di cultura e politica di genere, ha provato a riflettere con un appuntamento internazionale dal titolo "La libertà delle donne è civiltà - donne e uomini che lavorano contro i fondamentalismi religiosi, per l’autodeterminazione e la cittadinanza", che si è svolto a Genova il 26 e 27 maggio scorsi, i cui materiali in gran parte vi proponiamo nello speciale mensile settembrino di Carta [Carta Etc. in edicola da sabato 9 settembre]. Si è voluto di proposito usare il concetto di "civiltà", proprio perché è ormai difficile disgiungerlo da quello di scontro, mentre invece è proprio nel necessario legame tra civiltà e incontro che l’appuntamento genovese ha acceso i riflettori.
Quale civiltà? Per noi quella che origina il suo dispiegarsi nel percorso di liberazione degli esseri umani: quella che ha visto, per esempio, nell’occidente che oggi rischia di chiudersi a fortezza contro la disperazione degli ultimi di buona parte di ogni sud, nascere nel secolo scorso i movimenti per la dignità del lavoro, della liberazione delle donne dal giogo patriarcale, della piena autodeterminazione e l’inviolabilità del corpo e delle scelte riproduttive e sessuali. Tutte conquiste che sono ancora chimere in molti paesi, risultati mai acquisiti e scontati del tutto dove sono leggi e senso comune, perché costantemente minacciati, appunto, dal rigurgito fondamentalista, che si configura come emergenza planetaria. In Italia, proprio nell’ultimo terribile scorcio di estate, si è manifestata la violenza contro le donne in maniera pesantissima: la recrudescenza di stupri, l’aumento delle violenze in famiglia (famiglie italiane e cattoliche), accanto al disvelarsi della sudditanza di molte donne nelle comunità migranti, con l’omicidio della giovane Hiina, pachistana, e il suicidio dell’indiana Kaur.
Ciò che emerge è che i fondamentalismi religiosi non hanno semplicemente una "vocazione" misogina: sono una visione politica il cui profilo è senza esitazioni definito fascista (ben prima e con ben altre motivazioni rispetto alla battuta di Bush) dalla rete internazionale Women living under muslim laws: "Il fondamentalismo è la forma attuale del fascismo. Come il nazismo in Germania, esso emerge da un contesto di crisi economica e di impoverimento, si costruisce sul malcontento della popolazione, manipola i settori più poveri, esalta i loro valori morali e la loro cultura (l’identità ariana in Germania, il glorioso passato di Roma in Italia), si ammanta della benedizione del loro Dio (le SS portavano sulla loro cintura la scritta "Gott Mit Uns" - Dio è con noi), vuole convertire o sottomettere il mondo, eliminare e sradicare gli oppositori politici così come gli untermensch. Lontani dall’essere oscurantisti ed economicamente arretrati, i fondamentalismi sono modernisti e capitalisti. L’altra faccia della globalizzazione è la frammentazione delle comunità secondo i binari della religione, dell’etnicità o della cultura. È questa la situazione sfruttata dai fondamentalismi".
Ma c’è un altro fantasma da affrontare: quello dell’indifferenza . In ogni caso di violenza e di discriminazione che coinvolge le donne proprio dntro il luogo più intimo, la famiglia, registriamo la solitudine delle vittime. Una solitudine sociale, nella quale le donne in generale e quelle straniere in particolare vivono grazie anche alle posizioni ’progressiste’ che usano l’alibi del multiculturalismo per non affrontare uno dei nodi centrali del disagio creato nel nostro tempo dalle differenze culturali e politiche: quello del conflitto tra i generi. Da una parte c’è la soluzione razzista e leghista che vede tutti gli stranieri come un indistinto malefico,e li vuole fuori dalla fortezza di un occidente che mostra il peggio di sè; dall’altra c’è chi, per non apparire razzista e leghista, minimizza il problema della mancanza di libertà delle donne nella visione di alcune comunità straniere. Come scrive Pragna Patel, femminista del Southall Black Sister, che opera a Londra tra le comunità indiane e africane "il multiculturalismo fa spazio ai rappresentanti non eletti delle comunità, in genere maschi e appartenenti a gruppi religiosi, ma anche appartenenti alla classe degli uomini di affari, i quali determinano i bisogni della comunità e mediano fra la comunità e lo stato. Neanche a dirlo, questi leader hanno scarso o nullo interesse nel promuovere la giustizia sociale o l’eguaglianza delle donne. Anche se gli interessi della comunità sono spesso declinati nel nome dell’anti-razzismo o dei diritti umani, ciò include molto raramente il riconoscimento dei diritti individuali delle donne o di altri sotto-gruppi all’interno della comunità. La maggior parte della vita religiosa istituzionale nelle comunità delle minoranze deve ancora passare attraverso il processo di liberalizzazione e democratizzazione che le istituzioni religiose della società mondiale sono state costrette a subire. Nelle comunità appartenenti a minoranze, le istituzioni religiose sono dominate da un’agenda religiosa conservatrice, misogina ed omofobica, e nonostante ci siano isole liberali all’interno delle comunità delle minoranze, le loro voci sono marginali".
Tacere su questa rimozione non solo fa fare a noi occidentali di sinistra e al femminismo un gigantesco passo indietro nella storia del percorso dell’emancipazione e dell’autodeterminazione, ma infligge un colpo mortale a quanti, donne e uomini in paesi e culture dove ancora la religione e il patriarcato sono leggi, anche dello stato, vorrebbero modificare questo stato di cose. Irshad Manji, nel suo "Quando abbiamo smesso di pensare", ci chiede anche di assumerci questa responsabilità.
CARTA ETC n. 08/2006
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! A Mantova, Luce IRIGARAY rilancia la questione, ma - incompresa -viene ’snobbata’!!!2 febbraio 2007, di Federico La Sala
IL PRIVATO E IL POLITICO. QUESTIONE FEMMINILE.
DONNE ALL’OMBRA DEL PUBBLICO POTERE
di Luce Irigaray (la Repubblica/DIARIO 47, 02.02.2007)
 EMANCIPAZIONE.
EMANCIPAZIONE.
 I movimenti di liberazione delle
I movimenti di liberazione delle
 donne hanno rappresentato uno
donne hanno rappresentato uno
 dei momenti in cui la distinzione
dei momenti in cui la distinzione
 pubblico e privato vacilla‘‘
pubblico e privato vacilla‘‘ STORIA.
STORIA.
 L’uomo occidentale, nonostante i
L’uomo occidentale, nonostante i
 suoi sforzi, non è ancora riuscito
suoi sforzi, non è ancora riuscito
 a emanciparsi dalla madre. Ha
a emanciparsi dalla madre. Ha
 elaborato una cultura “tra uomini”
elaborato una cultura “tra uomini”In nome di che cosa si può decidere della separazione dell’ambito privato e dell’ambito pubblico? E chi può prendere una simile decisione?
Forse è una delle questioni più sottili che dobbiamo affrontare. Ma generalmente ci sfugge perché è risolto, a nostra insaputa, dal costume, dalla tradizione. Sembra naturale che debba essere così. Salvo che si resta talvolta un po’ perplessi davanti a certi eventi, certi incontri, con altre culture e anche con altre generazioni. I limiti non sono sempre stabiliti allo stesso posto, nello stesso modo. Si fanno in pubblico delle cose che si facevano solo in casa, e non si sa più come comportarsi, dove passa la separazione tra vita privata e vita pubblica.
I movimenti per l’emancipazione e la liberazione delle donne hanno rappresentato uno di questi momenti in cui le certezze rispetto a che cosa è il privato e quale altra il pubblico hanno vacillato. E questo terremoto non ha finito di sconvolgere i nostri punti di riferimento. Probabilmente perché il posto dove una donna può stare è stato una delle chiavi che è servita per assicurare la chiusura dell’ambito privato rispetto a quello pubblico.
Ma se le donne escono dalla casa, dove si sposta la separazione? E che cosa, infatti, definiva prima la vita privata? Il mantenimento della donna a disposizione del capo famiglia per soddisfare le sue necessità?
Forse sarebbe interessante esaminare le diverse necessità a cui la donna in casa doveva corrispondere per capire qualcosa della definizione del privato rispetto al pubblico.
La donna in casa era una casalinga indispensabile per assicurare i bisogni della vita del cittadino che lavorava fuori casa. Ma questo non necessita di una parete tra privato e pubblico tranne per nascondere il possibile sfruttamento della lavoratrice. È vero che il lavoro della casalinga non è regolamentato da un codice del lavoro che controlla gli orari, le assicurazioni sociali, i congedi per malattia, le ferie, l’età della pensione, eccetera. Il privato qui servirebbe a coprire la deregolamentazione del lavoro in casa. Ora questo lavoro sostiene l’insieme del mercato lavorativo, e non è chiamato in causa senza comportare problemi allo stesso Stato. Deve inventare diversi mezzi per sostituire la permanenza della donna in casa.
Un’altra funzione della sfera privata sarebbe collegata alla procreazione. Ma questo aspetto della vita generalmente si esibisce più che nasconderlo, oltre al fatto di non appartenere in senso stretto alla sfera privata. L’ambiguità della separazione tra privato e pubblico è particolarmente evidente su questo punto. Si sostiene che la casa familiare non deve essere di dominio pubblico ma lo Stato non smette di intervenire sulla regolamentazione delle nascite.
Lo fa attraverso la legislazione, penale più che positiva è vero, lo fa anche attraverso diversi vantaggi concessi a coloro che accettano di procreare i futuri cittadini e lavoratori. Si deve notare che, se i figli sono esibiti come la testimonianza della potenza maschile, non si parla altrettanto delle diverse prove di cui necessita la maternità dalla parte delle donne. Sembra andare da sé, che questo corrisponde al lavoro femminile, alla conquista della sua umana dignità da parte della donna.
I numerosi commenti sulle fatiche del lavoratore non si sono molto soffermati su quella del lavoro materno. Questo deve rimanere un affare privato che, appena ragazza, una donna si suppone capace di portare a buon fine quasi da sola. Potrà dimostrare le sue capacità presentandosi, sorridente, in pubblico con il bambino in braccio. È vero che si tratta della più bella opera che si possa compiere, ma a quale prezzo! Fortunatamente la stessa natura è qui di aiuto...
Il privato è dunque un posto dove la donna fa da casalinga, procrea e cura i figli. Finora l’uomo non è ancora molto intervenuto nella definizione del settore privato. Sembra che il suo ruolo sia legato alla proprietà: della terra, della casa, dei beni e perfino della donna e dei figli. Sarebbe questa relazione con la proprietà che crea la separazione tra il pubblico e il privato. Una separazione che si accompagna con la divisione tra natura e civiltà, e, in parte, tra diritto naturale e diritto civile.
L’esistenza della proprietà privata è anche collegata in qualche modo alla monogamia, almeno legale e in linea di principio. E questo non va senza ambiguità per la donna: da un lato sembra più protetta, dall’altro si trova più isolata e divisa dalle altre donne, cosa che la rende più vulnerabile all’influenza e al potere dell’uomo.
Ma perché una donna in casa a disposizione del marito? Oltre ai punti già considerati, siamo di fronte a un processo di individuazione non ancora compiuto dall’umanità. Quale siano i suoi sforzi per differenziarsi dalla madre, assimilata alla natura, l’uomo occidentale non è ancora riuscito a emanciparsi dalla madre.
Ha elaborato una cultura, una società, una politica, del “tra-uomini” per emergere dal mondo materno, ma ha tuttora bisogno di un luogo privato per proseguire nell’impresa dell’affermazione di un’identità maschile, e questo lontano dallo sguardo degli altri maschi. Questo processo di individuazione maschile trasforma la donna in un sostituto materno, e l’ambito privato in un luogo di familiarità e di confronto con la natura che non deve contaminare l’ambito pubblico né essere controllato da esso.
Una volta di più, sono le donne a perturbare l’ordine stabilito. Ma questo può essere la probabilità di una ripresa di un processo di individuazione per l’umanità. A patto che la donna sia capace di riuscire nel proprio passaggio dall’identità naturale all’identità civile e culturale, e che divenga così quella che aiuta l’uomo a uscire dal mondo materno.
L’individuazione umana si conquista in due, nel rispetto delle reciproche differenze. È un passo ancora da compiere, che sposta il limite tra privato e pubblico attraverso l’apprendimento di un’intimità che possa sostituire una familiarità indifferenziata e incolta, che sta ora minacciando la nostra vita civile e culturale.
-
> UOMO-DONNA: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE" (Laura Lilli, 1993)!!! ---- WANDA TOMMASI PRESENTA "OLTRE I PROPRI CONFINI" DI LUCE IRIGARAY.20 luglio 2008, di Maria Paola Falqui
WANDA TOMMASI PRESENTA "OLTRE I PROPRI CONFINI" DI LUCE IRIGARAY *
L’ultimo libro di Luce Irigaray, Oltre i propri confini (Baldini Castoldi Dalai, Milano 2007), raccoglie conferenze e dialoghi fra la pensatrice francese e intelocutrici/interlocutori italiani: il titolo allude al tentativo dell’autrice di oltrepassare i propri confini (nazionali, culturali, linguistici), per intrecciare della relazioni con la cultura e con il femminismo italiani, che, specialmente nelle pratiche e nel pensiero della differenza sessuale, ha raccolto e sviluppato in modo fecondo l’eredita’ della pensatrice francese.
Nell’introduzione, Irigaray auspica un ritorno all’entusiasmo del ’68, a quello "stato divino" che aveva segnato il femminismo degli anni ’70, quando molte donne, uscite dall’isolamento in cui le aveva confinate la cultura patriarcale, avevano trovato una parola pubblica condivisa ed erano state toccate dalla grazia e dalla gioia dell’incontro fra loro, al di la’ delle differenze fra i percorsi singolari di ciascuna.
Allora, cio’ che univa era piu’ forte di cio’ che poteva dividere le donne fra loro: oggi, a quasi trent’anni di distanza da quel felice inizio, al di la’ dei numerosi conflitti, delle ferite e di molto negativo che spesso ha reso difficili le relazioni fra donne, pur accomunate da un ideale condiviso, Irigaray auspica che si riesca nuovamente ad attingere alla freschezza degli inizi e a trovare la forza - la grazia? - per porre le basi di una nuova cultura e civilta’, a partire dalla consapevolezza che "in tutto il mondo siamo sempre in due".
Fra le diverse piste di lettura che questo libro suggerisce, ne scelgo tre: in primo luogo l’idea che la differenza sessuale e’ il migliore passaporto per varcare ogni confine, per entrare in contatto con tutte le altre differenze; in secondo luogo, il tema del desiderio femminile, e infine l’incrocio fra l’amore dell’altro essere umano e l’amore dell’Altro divino.
Lascio volutamente sullo sfondo, in questo mio percorso di lettura, le questioni che riguardano "una democrazia da ripensare" (p. 56). Non che queste ultime non siano importanti, a partire dalla basilare affermazione che "imporre lo stesso modello ugualitario a tutti e tutte non tiene conto dell’ideale della democrazia" (p. 63), ma ho l’impressione che, in questo campo, le intuizioni migliori di Irigaray siano negli accenti profetici e utopici, indubbiamente molto suggestivi, ma difficilmente traducibili in proposte politiche concrete. Sorrette da grandi interrogativi, del tipo "come aiutare il divenire umano delle donne, dei giovani e degli stranieri" (p. 63), e dall’intento di fondo di favorire una cultura del desiderio, queste indicazioni convergono verso un "abbozzo di una politica rispettosa delle differenze" (p. 67), obiettivo che e’ sicuramente auspicabile ma, a mio parere, non altrettanto facilmente realizzabile.
*
Mi concentro dunque innanzitutto sulla prima delle questioni che ho scelto di trattare, cioe’ la differenza sessuale come apertura privilegiata per entrare in contatto con tutte le altre differenze: nel ribadire che la differenza fra i sessi e’ il primo, "il piu’ fondamentale e universale incrocio da rispettare" (p. 116), Iragaray rilancia innanzitutto il senso della differenza sessuale come intreccio di natura e cultura o, con le sue parole, come "specifica articolazione fra corpo e parola" (p. 117), come alfabeto di base di ogni cultura e civilta’. Mentre la tradizione occidentale ha privilegiato il soggetto unico e ha operato sempre nel senso della riconduzione dell’altro/a al Medesimo, una cultura che metta al centro la differenza di essere donna/uomo e la relazione, inscritta nello stesso corpo femminile e quindi particolarmente legata a quel soggetto costitutivamente relazionale che la donna e’, puo’ porre le basi di un dialogo con l’altro (l’uomo), e, a partire da li’, con ogni altra differenza (naturale, linguistica, culturale, ecc.). Una cultura della differenza sessuale e’ un invito a uscire dal proprio orizzonte per costruire un mondo nuovo che lasci spazio a tutte le altre differenze: alla sua base, vi e’ la necessita’ di disegnare i primi confini, quelli legati al fatto che siamo donne oppure uomini, confini che dobbiamo al tempo stesso rispettare e aprire per incontrare l’altro. In questa prospettiva, che a mio parere e’ pienamente condivisibile e che dischiude per il pensiero e per le pratiche della differenza un grande compito politico nel presente, Irigaray parla spesso di "differenza sessuataî" piuttosto che di "differenza sessuale". Il motivo di questa scelta terminologica deriva dalla convinzione che occorra anteporre cio’ che accomuna tutte le donne - cioe’ la differenza femminile, nel suo significato sia naturale sia culturale - a cio’ che potrebbe invece dividerle, come gli orientamenti sessuali. Secondo Irigaray, l’espressione "differenza sessuale" suggerisce qualcosa che ha a che fare con le scelte sessuali, mentre la scommessa dell’autrice e’ di altro tipo. Essa e’ duplice: si tratta di tenere insieme natura e cultura, e al tempo stesso di evitare inutili divisioni fra donne dovute a diversi modi di vivere la sessualita’. Di fatto, proprio questo e’ cio’ che intende anche Diotima con il pensiero della differenza sessuale; quindi, a mio avviso, si tratta di una divergenza nelle scelte terminologiche piuttosto che di una questione di sostanza.
Analogo discorso si puo’ fare a proposito dell’identita’, che apparentemente delinea un’altra divergenza rispetto a Diotima: l’autrice parla di identita’ sessuata, mentre io penso, con altre di Diotima, che occorra puntare non sull’identita’, ma sempre sulla differenza, nel suo gioco, da rilanciare sempre, con l’identita’ umana. L’identita’ umana e’ formata dal differire, naturale e culturale, di donne e uomini, dal gioco sempre rinnovato della differenza sessuale. Ho riluttanza a parlare, ad esempio, di identita’ femminile, perche’ temo che l’identita’ rischi di diventare una gabbia in cui la donna sia nuovamente rinchiusa, e preferisco affidarmi al libero gioco della differenza. Irigaray ritiene tuttavia che l’identita’ femminile consista in una propensione alla relazione, in un’apertura all’altro, che impedisce ogni staticita’ e ogni fissazione in un ruolo. Dunque, nella sostanza, fra noi e Irigaray anche su questo punto la distanza non e’ grande, nonostante la divergenza terminologica. Nella scelta del termine identita’ da parte di Irigaray, pesa inoltre l’esigenza di sottolineare la necessita’ di una certa oggettivita’, anche per la differenza femminile, affinche’ la donna possa ritornare a se’ senza perdersi nell’altro, affinche’ possa rientrare nei suoi propri confini e rendersi cosi’ disponibile a un autentico incontro.
*
Il secondo filo conduttore che vorrei far risaltare in questo testo e’ il tema del desiderio femminile: dopo aver attraversato la questione della crudelta’ delle donne, di un’aggressivita’ a lungo repressa, ma che attualmente si esprime apertamente, spostandosi nella sfera pubblica e facendo spesso corpo con le rivendicazioni emancipazioniste, promosse dallo stesso femminismo, Irigaray si sofferma sulla difficile arte di condivisione del desiderio: "Il desiderio rappresenta un in-piu’ di vita che si ricava dalla relazione con l’altro" (p. 92).
Anziche’ scaricare l’energia nata dall’incontro, cosa che propone in generale la nostra cultura (valga come esempio Freud), l’autrice suggerisce tre vie possibili per condividere il desiderio, e anche per educarlo e coltivarlo: si tratta, in particolare per le donne, di acquietare la propria avidita’ nei confronti dell’altro/a, e di venire a capo del circolo vizioso di rabbia e aggressivita’, incentivato dalla sensazione di dipendenza e dalla mancanza di autonomia. Cose queste molto difficili da realizzare nella pratica: nel proprio percorso personale, Irigaray dice di averle apprese appunto attraverso delle pratiche, in particolare lo yoga e il respiro consapevole. Indica infatti come strade per venire a patti con la violenza del desiderio e per fare di quest’ultimo qualcosa di condiviso, in primo luogo la condivisione del respiro: cantare insieme o respirare insieme la stessa aria in campagna sono modi semplici di rendersi conto che e’ possibile "condividere nella differenza senza distruggere nessuno/a" (p. 93). La seconda strada di condivisione del desiderio e’ quella che si puo’ sperimentare nel creare insieme: un "fare insieme grazie all’energia nata dal desiderio comune" (p. 93). Molte pratiche di donne, legate al pensiero della differenza, in Italia e non solo, vanno proprio in questa direzione.
Infine, la terza strada di condivisione e’ quella del "desiderio per l’altro in quanto tale" (p. 94): e’ la piu’ promettente, ma anche la piu’ difficile da praticare, dal momento che la relazione amorosa si e’ declinata nella nostra cultura o come tendenza a fare uno, in una fusionalita’ che non rispetta l’essere due, oppure nella coppia attivo/passiva, soggetto/oggett(a).
*
Con questo, siamo gia’ passati alla terza pista di lettura che propongo in questo mio itinerario, cioe’ al tema dell’amore. A questo proposito, Irigaray parla dell’incrocio fra l’amore dell’altro umano e l’amore dell’Altro divino: "Amare l’altro come noi stessi equivarrebbe, secondo i comandamenti cristiani, ad amare l’Altro. Questo mistero del cristianesimo non e’ stato realmente inteso. Implica, mi pare, che la singolarita’ della persona sia sempre considerata e rispettata prima dell’interesse collettivo.
Anteporre l’istituzione cristiana al divenire divino di ciascuno/a di noi non fa parte del messaggio cristiano, secondo me. E questo impedisce a ognuno di camminare fino ai confini della terra, che lui, o lei, e’" (p. 126). Un amore dell’altro con la minuscola che consenta, in particolare alla donna, di ritornare a se stessa, senza perdersi ne’ perdere i propri confini, e’ la condizione per avvicinarsi all’Assoluto, lasciandosene toccare. Come gia’ in Etica della differenza sessuale, in cui Irigaray elaborava il concetto di trascendentale sensibile, si auspica qui il diventare parola della carne, e si fa riferimento all’esperienza delle mistiche, in cui il lasciarsi toccare dalla grazia e’ al tempo stesso un toccare il divino, una carezza data e al tempo stesso ricevuta.
*
Trattando dell’amore per l’altro essere umano, l’autrice fra anche riferimento al negativo, che viene in primo luogo inteso come mistero, come territorio inappropriabile fra me e l’altro/a. Questo mistero va rispettato e conservato: "L’esistenza di un mistero salvaguarda l’uno e l’altro" (p. 35). E’ questo un significato di negativo che rimanda, implicitamente e polemicamente, a Hegel: mentre in Hegel il negativo e’ un modo di appropriarsi dell’altro e di ricondurlo al Medesimo, invece in Irigaray il negativo serve precisamente a preservare l’alterita’ dell’altro, il mistero della sua singolarita’.
Un altro significato del negativo che compare nel testo e’ quello che nasce dalla negazione maschile della madre, dal matricidio originario che, secondo Irigaray, e’ all’origine della cultura patriarcale. Questa seconda accezione di negativo e’ piu’ vicina a quanto l’autrice affermava diversi anni fa nel saggio "Il corpo a corpo con la madre", in Sessi e genealogie.
Richiamo questi due significati del negativo perche’ la riflessione di Diotima, negli ultimi due libri (La magica forza del negativo e L’ombra della madre), si e’ molto interrogata sul negativo: sia quello che capita nelle nostre vite e che, se non viene lasciato fare il suo lavoro, rischia di andare a male, e quello che spesso interviene pesantemente nelle relazioni fra donne, facendole ammalare. Dietro quest’ultimo aspetto del negativo, noi di Diotima abbiamo intravisto l’oscuro materno, i nodi non risolti della relazione con la madre, un’ombra che pesa sui rapporti fra donne e che provoca molti conflitti e sofferenze.
*
Su quest’ultimo nodo, cruciale per la politica delle relazioni fra donne, Irigaray aveva detto cose molto importanti gia’ in Etica della differenza sessuale. In quest’ultimo libro, la questione e’ ripresa quando si parla della crudelta’ delle donne, ma in generale l’attenzione dell’autrice va, piuttosto che in direzione del negativo, verso il compito, che si puo’ definire etico, di coltivare la felicita’, con accenti che volutamente privilegiano il desiderio e il piacere, nella convinzione che solo una cultura dell’energia, necessaria sul piano sia vitale sia spirituale sia intellettuale, possa consentire alle donne di trovare una via d’uscita rispetto alle molte, troppe ferite e sofferenze che nella storia passata esse hanno ricevuto.
*
 Fonte:
Fonte:
 LA DOMENICA DELLA NONVIOLENZA
LA DOMENICA DELLA NONVIOLENZA Supplemento domenicale de "La nonviolenza e’ in cammino"
Supplemento domenicale de "La nonviolenza e’ in cammino"
 Direttore responsabile: Peppe Sini.
Direttore responsabile: Peppe Sini.
 Redazione: strada S. Barbara 9/E,
Redazione: strada S. Barbara 9/E,
 01100 Viterbo,
01100 Viterbo,
 tel. 0761353532,
tel. 0761353532,
 e-mail: nbawac@tin.it
e-mail: nbawac@tin.it
 Numero 173 del 20 luglio 2008
Numero 173 del 20 luglio 2008[Dalla rivista della comunita’ filosofica femminile Diotima "Per amore del mondo", fascicolo della primavera 2008 col titolo "Un certain regard", disponibile nel sito www.diotimafilosofe.it, riprendiamo la seguente recensione....].
-
-