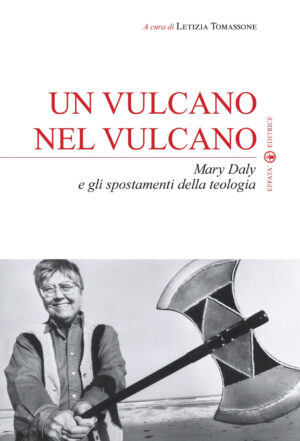
AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. In onore di Mary Daly, un convegno presso la Facoltà valdese di teologia di Roma. Un resoconto di Marta D’Auria - a cura di Federico La Sala
- [...] La sua famosa affermazione: «se dio è maschio, il maschio è dio» si inserisce in una riflessione sulla legittimazione del potere maschile nel nostro orizzonte culturale. Mary Daly propone di non attribuire a Dio un’immagine fissa e oggettivante che ne ingabbia l’agire, ma di riferirsi al divino non come sostantivo ma come verbo in un continuo divenire [...]
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Convegno presso la Facoltà valdese di teologia in onore di Mary Daly
Un vulcano nel vulcano
Tre lezioni di alto profilo e una tavola rotonda hanno introdotto il complesso e dinamico pensiero di Mary Daly, filosofa e teologa, considerata la madre della teologia femminista
Il 28 maggio alla Facoltà valdese di Teologia (Roma) si è tenuto un convegno di studi in onore della filosofa e teologa Mary Daly, morta il 3 gennaio 2010. «Un vulcano nel vulcano. Mary Daly e gli spostamenti della teologia» è stato il titolo suggestivo dell’intensa giornata che ha visto la partecipazione di più di una trentina di persone venute da diverse città d’Italia. L’incontro si è aperto con i saluti del prof. Daniele Garrone, decano della Facoltà. «Questo convegno - ha detto - rientra nella più ampia iniziativa di istituire un corso di “studi femministi e di genere” obbligatorio per tutti gli studenti e le studentesse che intraprendono il percorso di studi nella nostra Facoltà».
di MARTA D’AURIA
 “Riforma. L’Eco delle Valli Valdesi”, n. 25, 25 giugno 2010.
“Riforma. L’Eco delle Valli Valdesi”, n. 25, 25 giugno 2010.
LA prima lezione è stata affidata alla teologa Elizabeth Green che ha introdotto ai presenti il complesso e dinamico pensiero di Mary Daly attraverso un attento excursus delle sue opere (in tutto sette libri pubblicati, trascurando i numerosi articoli ed escludendo la tesi di dottorato su Jacques Maritain, Natural Knowledge of God in the Philosophy of Jacques Maritain - Roma, 1966).
Green ha ricostruito il «vulcanico» pensiero di colei che è considerata la madre della teologia femminista, sottolineando il vigore del suo linguaggio, vicino alla qualità del magma incandescente, e il suo continuo capovolgere e ricomporre alchemicamente i significati delle parole (fino ad arrivare alla compilazione, con Jane Caputi, di un dizionario, il Webster’s First New Intergalactic Wickedary of the English Language,1987).
Il testo che ha lasciato più tracce nel pensiero della teologia è senza dubbio Al di là di Dio padre (Editori Riuniti, 1985). Mary Daly ebbe a dire in seguito che il titolo sarebbe potuto essere semplicemente «Al di là di Dio». Infatti lei mostra come la costruzione stessa di un divino trascendente crei simbolicamente una piramide in cui alcuni dominano e altri sono sottoposti. È soprattutto l’identificazione di Dio con il maschio a creare una piramide sessuata.
La sua famosa affermazione: «se dio è maschio, il maschio è dio» si inserisce in una riflessione sulla legittimazione del potere maschile nel nostro orizzonte culturale. Mary Daly propone di non attribuire a Dio un’immagine fissa e oggettivante che ne ingabbia l’agire, ma di riferirsi al divino non come sostantivo ma come verbo in un continuo divenire.
L’idea di pensare Dio come una forza dinamica e mobilitante è alla base della critica alla cristologia compiuta dalla Daly. Su questo in particolare si è soffermata la pastora Letizia Tomassone nella sua lezione. In Al di là di Dio Padre Mary Daly critica la cristologia la quale, nel mettere al centro un eroe che da solo ha il compito di salvare tutti, non riconosce che la redenzione si realizza solo se c’è uno sforzo collettivo. Daly, dunque, smonta la cristologia come una menzogna che allontana il Cristo dal resto dell’umanità, la quale risulta così privata della possibilità di pensarsi capace di redimere e di trasformare il mondo.
A partire da questa critica profonda dell’immaginario cristiano, Daly parla della Nuova Venuta delle donne, identificando l’attesa escatologica della nuova venuta del Cristo in un rovesciamento di valori: non più uno solo ma una presenza collettiva, non più un divino connotato al maschile ma la sorellanza come forza trascendente.
La terza lezione, che ha concluso i lavori della mattinata, è stata affidata alla pastora Daniela Di Carlo che ha presentato il libro Quintessenza. Realizzare il futuro arcaico (Venexia, 2005). Il testo si presenta con la struttura di un saggio che è insieme anche un romanzo: alcune donne che vivono nell’era «Biofila», anno 2048, grazie alla «Ginergia» (energia femminile primordiale, non più imbrigliata nei lacci patriarcali, che rende possibile lo scavalcamento delle barriere spazio-temporali), richiamano Daly a raccontare loro del miserevole stato in cui vivono le donne nella precedente era «Necrofila».
In particolare il vecchio mondo descritto da Daly è diviso in due zone: «l’avanscena», generata dal patriarcato, e il «retroscena», il regno della realtà selvaggia (libera dal patriarcato), la patria del sé delle donne. Bisogna passare attraverso la cosiddetta «avanscena» (patriarcale), rovesciando il senso dei suoi miti, analizzando ciò che tiene oppresse le donne, per penetrare nel «retroscena» (background) del l’essere dove le donne si riconnettono con la propria creatività.
In tutta la storia patriarcale, gli uomini hanno fatto di tutto per evitare che le donne potessero «rimembrare» che il mondo è altro dalla violenza e dalla manipolazione di corpi, anime e menti. È tempo, sottolinea l’autrice, di nominare le atrocità e di raccogliere il coraggio necessario per fronteggiarle e sconfiggerle.
Se le donne riusciranno a scorgere e a nominare le interconnessioni tra l’oppressione sessuale, quella razziale e quella politica, esse lavoreranno per la vita, parteciperanno alla creazione della vita ora e nel futuro.
Il recepimento delle idee controverse
Nel pomeriggio nell’aula Magna della Facoltà valdese si è svolta una tavola rotonda a più voci. La teologa Elizabeth Green ha esplorato la relazione di Mary Daly con il Cristianesimo (dal quale la teologa fuoriuscì), in particolare interrogandosi sul significato del pensiero della teologa per coloro che scelgono di rimanere all’interno della tradizione cristiana, e nello specifico nel protestantesimo.
Lucia Vantini, dottoranda nella Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, ha invece illustrato il modo in cui la teologia cattolica ha recepito negli anni l’opera di Mary Daly. Luciana Percovich, docente della Libera Università delle donne di Milano, ha letto e commentato un capitolo dell’ultimo libro della Daly, Amazon Grace: Re-calling the courage to sin big (2006), mentre Chiara Zamboni, docente di Filosofia del linguaggio all’Università di Verona, ritornando sul testo Al di là di Dio Padre, si è soffermata sul significato della parola «Dio» nel pensiero teologico e filosofico di Mary Daly.
Nel susseguirsi degli interventi al convegno è stata netta la sensazione di aver appena sfiorato una figura poderosa: Mary Daly, donna dal pensiero indomito, «selvaggio», creativo, ironico, che ha segnato la teologia degli ultimi quarant’anni e che meriterebbe ulteriori approfondimenti.
Sebbene sia uscita dal cristianesimo, la lettura e l’investigazione dei suoi testi possono offrire ancora alle chiese interessanti spunti di riflessione non solo relativamente a un linguaggio che provi a esprimere Dio fuori dalle categorie patriarcali, ma anche in merito all’impegno contro la violenza della guerra che inizia con l’opprimere le donne per poi comprendere l’intero creato. (m.d.a.)
"QUINTESSENZA" DI MARY DALY
di Letizia Tomassone (Il manifesto - 12 Novembre 2005)
La forza che viene dal sapere di avercela fatta e’ quella nota di gioia che Mary Daly ci regala con il suo ultimo libro: Quintessenza. Realizzare il futuro arcaico.
Se infatti i suoi testi dagli anni ’70 in poi erano osservatori privilegiati per esprimere la "rabbia selvaggia" delle donne per la miseria, la cancellazione in cui vivono nel mondo patriarcale, e se molti suoi testi sono stati occasioni per rendere visibile, nominandola, la violenza contro le donne e la loro oppressione fisica e simbolica, questo volume edito con coraggio, in Italia, da Luciana Percovich, mostra come la "rabbia" puo’ diventare consapevolezza e possibilita’ di vita piu’ intensa, e dar luogo al "salto nel futuro arcaico". Scrive Daly:
- "Quando una Cercatrice Vede, Nomina e Agisce Vegliarda-mente i suoi Momenti/Movimenti nel Tempo, la sua conoscenza della Quarta Dimensione e’ ravvivata e lei Stessa diventa piu’ Viva. Si riempie di Ginergia (l’energia femminile, ndr) ed e’ mossa dalla Brama di Balzare in avanti. E’ spinta a Volare oltre nel Futuro Arcaico per Irrompere nella Quinta Dimensione, dove/quando puo’ essere Presente in modo sempre piu’ consapevole partecipando alla Danza Abbagliante dell’Universo - l’Armonia Cosmica, la Quintessenza".
Parole che rivelano da subito come Daly lavori profondamente sul linguaggio per svelarne dimensioni occultate e ribaltarne i significati. Svelando come la cultura patriarcale abbia spesso rovesciato in negativo termini che esprimevano forza e liberta’ femminile, come "Vegliarde", "Donne Selvagge", "Ammaliatrici"...
*
Mary Daly era gia’ nota in Italia soprattutto per questo lavoro sul linguaggio e sul nominare la realta’ e Dio. Con saggi come La Chiesa e il secondo sesso (Rizzoli, ’82) e Al di la’ di Dio Padre (Editori Riuniti, ’91), gli unici tradotti in italiano e purtroppo ormai fuori catalogo. Centrale per la ricerca delle teologhe femministe e’ la sua affermazione che il "nominare Dio" al femminile (per esempio come Madre) non sposta i rapporti simbolici e materiali tra donne e uomini se questo nome resta un sostantivo. Il nominare che trasforma le relazioni e’ una "dinamica dell’essere" e puo’ essere espresso solo con un verbo.
"Nell’idea di Mary Daly l’essere e’ apertura, rilancio, movimento squilibrante e la’ dove si mostra la differenza di essere donne e uomini come squilibrio, e se ne da’ testimonianza, si partecipa di tale movimento - scrive Chiara Zamboni in Parole non consumate, Liguori 2001 -. Altrimenti il linguaggio puo’ dire la differenza sessuale come costruzione storica, puo’ usare i generi grammaticali femminili, e introdurre la parola "Dea" nel cristianesimo, ma se non c’e’ una esposizione dinamica della nostra compromissione, il linguaggio rimane statico, solo sostantivo e non verbo, scollegato dal movimento dell’essere. C’e’ parola di verita’ e di vita la’ dove c’e’ esposizione di noi, la’ dove simbolico e testimonianza sono legate".
Ma il lavoro di Daly sul linguaggio e’ continuato con un suo praticare in modo sempre piu’ vorticoso parole ri-dette, fino ad arrivare alla compilazione, con Jane Caputi, di un Dizionario (il Websters’ First New Intergalactic Wickedary of the English Language, ’87). La qualita’ di Quintessenza non sta quindi nel suo linguaggio, linguaggio sperimentato e praticato con radicalita’ fin dagli anni ’80, ma dalla visione dell’incontro con le "Compagne del Futuro Arcaico".
Naturalmente il Futuro puo’ essere Arcaico solo se richiama una "brama" intensa di realizzare del nuovo e se dice qualcosa non solo di cio’ che vogliamo costruire, ma di cio’ che ci precede. Anzi, in un certo senso, e’ proprio perche’ c’e’ stato un passato "fuori dal patriarcato" che ci e’ possibile incontrare un "futuro libero".
*
Quintessenza racconta dell’incontro fra le donne dell’Era Biofila e Mary Daly, la quale viaggia tra il 2048, in cui loro vivono, e la vecchia realta’ datata 1998. L’incontro costituisce il presente che fonda il futuro e trasmette forza alle Viaggiatrici nell’era necrofila, cioe’ nel patriarcato. Ed e’ narrato a due voci. Quella di Daly che nel ’98 denuncia l’oppressione delle donne attraverso le violenze, le guerre, le spiritualita’ patriarcali, le biotecnologie e le tecniche di procreazione assistita, cioe’ tutte quelle cose che distruggono la differenza e l’armonia della vita e fanno avvizzire la nostra mente e la nostra immaginazione. E quella di Anonima che, nata all’inizio dell’"Era Biofila", e’ piena di curiosita’ per queste antenate costrette a sviluppare la loro resistenza e la loro "Indocilita’" in una situazione cosi’ violenta e triste. Anonima arrivare ad evocare Mary Daly per incontrarla. -E’ dunque in gioco il desiderio. Il desiderio di realizzare la propria integrita’ spinge Daly al "Salto nella Quinta Dimensione", e il desiderio di capire spinge Anonima a creare le condizioni perche’ il "Qui" diventi luogo di incontro.
Quello raccontato in Quintessenza e’ un incontro profondo tra generazioni, mosso dal desiderio reciproco. Daly lo sa, ed esprime anche la frustrazione che accompagna questo tipo di incontro nell’era patriarcale, quando a ogni generazione bisogna ricominciare daccapo, perche’ la "Memoria della Donne Selvagge" e’ continuamente cancellata. E "nominare connessioni, in modo che potessimo continuare a fare le nostre analisi piu’ in profondita’ e raggiungere la radice dei problemi" e’ esattamente il compito che Daly assegna al suo lavoro.
Connessioni tra passato e futuro per il qui del presente. Nell’era necrofila, scrive Daly, "divenne difficile per molte nominare le connessioni tra la crescente oppressione delle donne da parte dei movimenti e dei regimi fondamentalisti sparsi nel mondo e la violazione e la distruzione delle donne e della natura da parte dell’impero nectec (di tecnologia necrofila, ndr)". L’opera del patriarcato necrofilo appare infatti in Quintessenza come un’opera continua di cancellazione della "Vita" e dell’esistenza delle donne e le donne, nella loro "Giusta Rabbia", possono superare queste cancellazioni "Spiraleggiando Via". Nel "Continente Ritrovato", un luogo di armonia e sincronia con natura e animali che e’ anche, pero’, l’immagine di quella Quinta Dimensione o Quinta regione che diventa il centro di espansione della "Presenza" delle creature "Biofile".
*
Il testo di Daly, impregnato di spiritualita’, e’ quindi profondamente politico. Le Antenate del Futuro sono per noi risorsa e occasione di ricordare che il mondo e’ altro dalla violenza e manipolazione di corpi, anime e menti, e che ogni forza empatica degli umani (delle donne) con gli altri esseri viventi puo’ trasformare la realta’ e farci fare un balzo nello "Stato di Grazia Naturale". "Man mano che le Capricciose Donne Vagabonde si radicano sempre di piu’ nello Stato di Grazia Naturale, riconosciamo la consapevolezza delle sincronicita’/Sin- crone -citta’ come un segno che stiamo entrando in armonia con le altre creature Elementali, stiamo cioe’ scoprendo la Quintessenza, che e’ l’Integrita’ Supremamente Armoniosa dell’Universo e Fonte di Estasi".
Mary Daly,
Quintessenza.
Realizzare il Futuro Arcaico
di Luciana Percovich *
Quintessenza è un libro molto complesso, che si presta a essere letto in modi diversi, stimolando i diversi livelli di consapevolezza di chi legge e veicolando messaggi a più livelli. Si presenta con la struttura di un saggio che è insieme anche un romanzo: essenzialmente è una visione, che non appartiene al piano ordinario del reale proprio per la sua natura quintessenziale, quella del Quinto Elemento, l’etere, lo spirito, la sostanza insomma di cui sono fatte le anime.
Cercherò di darvi un’idea di cosa sia questo libro, solo un’idea però, perché non si presta facilmente a essere riassunto ma occorre leggerlo e sperimentarlo direttamente su di sé. Perché produce effetti in chi lo legge. Reazioni di adesione totale o di rifiuto. “Salti quantici”. Per la forza del suo linguaggio, della capacità di Nominare attraverso parole il cui significato comune viene di continuo scomposto e ricomposto alchemicamente.
La “trama” (Tramare e Tessere sono le attività primarie delle Tessitrici che operano nella Quintessenza): in un momento imprecisato tra il 1998 e il 2048 c’è stato un enorme cataclisma - più forte e ripetuto di quelli a cui già oggi ci stiamo abituando. La terra si è infine risvegliata, stanca di sopportare i minuscoli ma fastidiosi parassiti che la tormentano, noi umani. Un disastro ecologico, terremoti e tsunami, uno spostamento dell’asse terrestre. La fisionomia del pianeta è cambiata: molte terre si sono inabissate, un intero continente (che qui si chiama Continente Perduto e Ritrovato) è riemerso. I governi del mondo e le loro economie sono collassati ovunque. E con loro il patriarcato, che ne costituiva l’ossatura. Le donne di tutti i continenti - le Streghe Viaggianti e le Veggenti, le Donne Selvagge e le Vecchie Sagge, le Luminose - come uccelli migratori si sono dirette, guidate da un impulso comune, nel Continente Perduto e Ritrovato, sono tornate a casa. E ora stanno “Centrando, Equilibrando, Mettendo a Fuoco, riguadagnando l’Integrità Originale che sembrava essere stata fatta a pezzi nello Stato della Diaspora”(cioè il nostro oggi).
Mary, che vive, scrive e pubblica Quintessenza nel 1998, viene Evocata da una Sorella del Futuro, Anni, che vuole ripubblicare il libro tanto amato nel Cinquantenario della prima edizione. Anni è una studiosa del mondo pre-catastrofe, vuole capire meglio la realtà di quel periodo, come vivevano donne e uomini e che posizioni aveva assunto il femminismo di fine millennio di fronte ai problemi tanto gravi che si andavano accumulando, un tempo che ora sembra così assurdo e irreale, e vuole saperlo da Mary. Mary - che non sembra sconvolta più di tanto da ciò che le sta capitando - è a sua volta assai curiosa di sapere cosa è successo in questi cinquanta anni.
Il racconto di Anni e le spiegazioni di Mary formeranno così i Commenti del 2048 che verranno aggiunti a ogni capitolo di Quintessenza.
Il libro si presenta quindi con una struttura a chiasmo - o forse meglio sarebbe dire a X, la forma del cromosoma femminile: ogni capitolo ha una parte di scrittura saggistica e una parte romanzesca; tra le forti emozioni suscitate dalla disperazione più nera sboccia la Speranza, dal senso di estraneità ed esclusione l’Appartenenza, dalla rabbia e dalla paralisi il coraggio di Parlare, Agire, Ridere, Gioire, partecipando al continuo Divenire dell’Essere. Chiasmo, X o meglio ancora la forma della labrys, la doppia ascia, la doppia lama del simbolo della dea cretese fin dalla notte dei tempi. Una lama taglia via, l’altra apre una nuova strada.
In questa struttura narrativa si opera la trasfigurazione alchemica: la cupa necrofilia del presente vira di colpo in energia creativa, trasformativa, in senso pieno dell’Esserci.
Con Quintessenza Mary Daly continua il suo dissacrante e ironico riattraversamento dei generi letterari: il saggio filosofico (in Gyn-Ecology. The Metaethics of Radical feminism,1978, Pure Lust: Elemental Feminist Philosophy, 1984), il dizionario (Webster’s First New Intergalactic Wickedary of the English language, 1987), l’autobiografia (Outercourse: the Be-Dazzling Voyage,1992) e qui la Science Fiction, con i suoi viaggi nel tempo.
Nell’Introduzione, parlando del “titolo di questo libro”, dice che potrebbe sembrare un titolo piuttosto minaccioso. “Inoltre, il suo rapporto col sottotitolo, Un Manifesto Femminista Elementale Radicale può non essere immediatamente chiaro a chi legge. Diventa tutto comprensibile per le Donne Astute quando noi iniziamo a capire le disperate condizioni in cui lottiamo per sopravvivere e crescere. Alla fine del xx secolo- alla svolta del millennio- dobbiamo affrontare la ripugnante manipolazione genetica e la probabilità di una definitiva estinzione, non solo del nostro corpo/mente (noi Stesse), ma di tutta la natura.
Proprio mentre scrivo queste parole nel 1998, monotone voci di dissenso mi ronzano intorno... ‘Attenta! Ti stai facendo prendere la mano. Non essere così violenta!”. Poi do uno sguardo alla prima pagina del giornale, un giornale qualsiasi, o accendo la televisione, lottando per decodificare la disinformazione, e mi sento soffocare dallo smog delle bugie e delle informazioni fuorvianti...... Stanno invadendo e distruggendo gli spazi inesplorati e incontaminati della genetica e dello spazio. L’ingegneria molecolare (la nanotecnologia) minaccia di ridurre qualsiasi cosa in un mucchio di polvere molecolare, e questa tecnologia è sotto controllo di scienziati pazzi e crudeli. Sembra che niente riesca a fermarli: corrono sempre più veloci senza sapere verso cosa.
La vita è distrutta in modo irreversibile: le foreste sono morte o stanno morendo; gli oceani stanno morendo; ogni minuto che passa si assiste all’estinzione di altre specie di piante e animali. Le balene e i delfini avranno un loro motivo per arenarsi. Tutto è rivoltato e capovolto. Quando inaspettatamente arriva un tornado e scaglia una Ford attraverso il muro di una casa facendola atterrare sul letto di qualcuno nel centro della Florida, la voce di quelli che continuano a negare questa verità non smette di gracchiare: ‘Non c’è niente di nuovo sui tornado e El Nino c’era anche prima’. ....Le cose continuano ad accadere sempre più rapidamente.....”
Occorre non dimenticare che il libro è stato concepito tra il 1992 e il 1998, durante la guerra nei Balcani, ben prima dunque del crollo delle Due Torri, dell’Afganistan, dell’Irak, dello tsunami, del boom della genetica, di Katrina e Rita....
Io l’ho letto tra il 2000 e il 2001, mi ha colpito come un refolo di vento e, come vedete, ci sono voluti altri quattro anni prima di trovare l’editrice e tradurlo e stamparlo...Ma l’incontro con Mary - che da allora è già venuta due volte in Italia e tra poco sarà di nuovo a Bologna per festeggiare la traduzione italiana, si è rivelato una vera e propria sin-cronicità, nel senso che dà lei alla parola (incontro quintessenziale di vecchie sagge, ingl. Crone, invece che dal dio Kronos...)
I temi che vengono affrontati in Quintessenza vanno dalla guerra (i genocidi cui assistiamo derivano tutti per necessità logica dal primo ginocidio, la sopraffazione delle donne che fonda le civiltà patriarcali) alla pornografia, dalla diaspora (delle donne e dei popoli) al fondamentalismo cristiano americano e vaticano, dalla genetica e dalle più recenti tecnologie alla manipolazione delle coscienza attraverso il continuo Rovesciamento delle verità...
Quello che distingue la voce di Mary Daly è il suo indomito Coraggio di Nominare senza nessun addolcimento ciò che tutte/i sentiamo e pensiamo a sprazzi, ma non riusciamo/vogliamo credere fino in fondo che sia vero: che questa nostra società/cultura/progresso sia arrivato a un punto di non-ritorno, che “viviamo” in una civiltà “necrofila” che onora e dà potere a chi dà la morte, non a chi dà la vita (come già nel 1957 scriveva Simone de Beauvoir ne Il Secondo Sesso).
Da un punto di vista filosofico (non dimentichiamo che Mary Daly è filosofa e teologa), nel libro viene definitivamente abbandonata l’opposizione ontologica propria del pensiero occidentale, che separa nettamente l’Essere e il Divenire. Il Verbo proprio del Femminile è Be-ing, Essere in divenire, ossia come si manifesta l’Essere del Quinto Elemento. Utilizza altri quattro verbi nella forma in -ing (che in inglese indica sempre un’azione in atto, in divenire, la soglia tra il verbo e il sostantivo, tra il farsi e il suo compimento), Be-longing, Be-speaking, Be-laughing e Be-dazzling, che rispettivamente indicano il manifestarsi sul piano ontologico dell’Essere del Desiderare, Nominare, Ridere e Abbagliare. Queste azioni/modi di essere delle Donne Selvagge - così definite in quanto non rispettano le leggi del patriarcato - smontano la schiavitù e l’inesistenza simbolica e permettono quel salto quantico che inaugura il loro/nostro gioioso Esserci nel farsi della nuova Creazione.
Il libro è un rigoglio di invenzioni linguistiche e di immagini potenti.
Qui ricordo solo l’Avanscena e il Retroscena, cruciali per comprendere la prospettiva da cui il mondo viene guardato. Noi siamo quotidianamente condizionati a vedere (e quindi a scambiare per la realtà) solo ciò che viene illuminato dalla luce artificiale dei mass media sulla piccola porzione dell’Avanscena costruita ad arte, mentre la vita reale si svolge fuori dalle luci della ribalta, e là fuori, là dietro tutto acquista una proporzione e un significato diverso, spesso addirittura capovolto.
Rimembrare significa sì ricordare ( e “ri-cordare” in italiano significa percepire attraverso il cuore), ma nel senso di ricomporre ciò che è stato smembrato e fatto a pezzi e di risvegliare la memoria vera del nostro passato nascosta nelle nostre cellule.
E le Sorelle Antenate del passato, se non facciamo resistenza, passano attraverso di noi alle Sorelle Antenate del futuro, in un continuum spazio-temporale che il patriarcato cerca in continuazione di negare.
“Noi siamo l’incarnazione dei sogni delle nostre antenate, le sorelle del futuro saranno ciò che noi abbiamo saputo/osato sperare e immaginare”.
Le Donne Radicali Elementali riscoprono le radici, radici attraverso cui comunichiamo e che continuano a crescere e a germogliare anche dopo che gli alberi sono stati abbattuti o bruciati in superficie. Radici che ci accomunano sotterraneamente a tutti gli elementi del cosmo, alle piante e agli animali. Così possiamo partecipare alla Nemesi in atto, ma movendo oltre la re-azione contro le ingiustizie, nella pienezza vorticosa delle spirali della Quinta Galassia, che hanno la stessa forma e sostanza del DNA..
Da qui l’importanza più volte ribadita nel testo del “qui e ora”, in ogni piccolo gesto, pensiero, energia; e dell’irriducibilità, della non complicità con il mondo falso e morto dell’avanscena.
Quintessenza è una utopia mistica moderna, un libro visionario e metamorfico, che ha il potere di cambiare la nostra visione e ci Tira verso la “Causa Ultima, che è l’inizio non la fine del divenire. E’ la Prima causa e la Causa delle cause, che dà all’agente la motivazione per Agire”, per continuare e non per esaurire la Creazione.
“Niente di quello che facciamo è insignificante quando è visto alla Luce della Quintessenza. La quantità non è importante né lo è la distanza tra gli esseri separati che partecipano all’Armonia Cosmica. A contatto con la Quintessenza, le Donne Elementali diventano più che mai simili agli alberi e agli Angeli. Estendendo le nostre radici più in profondità, siamo libere di espanderci e partecipare alla creazione dell’universo”.
Il libro finisce con queste parole.
- Mary Daly
- Quintessenza. Realizzare il Futuro Arcaico
- Ed.Venexia, Roma, 2005.
Mary Daly (1928), di famiglia irlandese, filosofa, teologa, femminista radicale, è tra le più potenti creatrici di pensiero, linguaggio e visione, generate dal Movimento Femminista degli anni settanta.
Conseguito il primo Ph.D. in Religione presso il Saint Mary’s College a Notre Dame, Indiana, per specializzarsi in teologia - studio ancora precluso alle donne in quegli anni negli Stati Uniti - si iscrisse all’Università di Friburgo, in Svizzera, dove ottenne una seconda laurea (summa cum laude) in Teologia. Rimase ancora a Friburgo per conseguire la sua terza laurea in Filosofia. Tornata negli Stati Uniti, ebbe l’incarico di Assistant Professor al Boston College, gestito dai Gesuiti.
Dopo la pubblicazione, nel 1968, di La Chiesa e il Secondo Sesso, fu licenziata nella primavera del 1969. Quattro mesi di proteste studentesche, una petizione firmata da 2.500 persone, una tavola rotonda di sette ore, la decorazione notturna con brillanti graffiti rossi dell’edificio dell’ amministrazione centrale del Boston College, provocarono la revoca del licenziamento e il suo rientro con la promozione a ordinario di cattedra nel giugno dello stesso anno.
Seguirono le pubblicazioni di: Al di là di Dio Padre. Verso una filosofia della Liberazione delle donne (1973), Gyn/Ecology: the Metaethics of Radical Feminism (1978), Pure Lust: Elemental Feminist Philosophy (1984), Websters’ First New lntergalactic Wickedary of the English Language (1987), Outercourse: the Be-Dazzling Voyage (1992) e Quintessenza... Realizzare il Futuro Arcaico (1998).
Licenziata definitivamente nel 1998, continua a scrivere e a viaggiare negli Stati Uniti e in Europa, tenendo conferenze e presentando le traduzioni dei suoi libri. Nel 2006 è prevista l’uscita di Amazon Grace.
* UNIVERSITA’ DELLE DONNE, 03/10/2005
- «Una donna che chiedesse la parità nella Chiesa potrebbe essere paragonata a un nero che chiedesse la parità nel Ku Klux Klan»(Mary Daly, La Chiesa e il secondo sesso, prefazione alla 2ª edizione, 1975)
- Un vulcano nel vulcano.
 Mary Daly e gli spostamenti della teologia
di Lucia Vantini, Chiara Zamboni, Luciana Percovich, Elizabeth Green, Daniela Di Carlo, Cristina Simonelli e Letizia Tomassone (ed.)
Mary Daly e gli spostamenti della teologia
di Lucia Vantini, Chiara Zamboni, Luciana Percovich, Elizabeth Green, Daniela Di Carlo, Cristina Simonelli e Letizia Tomassone (ed.)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
 LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
Forum
-
> AL DI LA’ DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- LA TEOLOGIA DI DIO COME "UOMO SUPREMO" E L’OPERA "AVE MARY". La ricerca e la fede. Michela Murgia e quella sete di assoluto (di Alessandro Zaccuri).14 agosto 2023, di Federico La Sala
QUESTIONE AANTROPOLOGICA E CRISTOLOGICA: LA TEOLOGIA DI DIO COME "UOMO SUPREMO" E L’OPERA "AVE MARY" (M. Murgia, 2011). *
La ricerca e la fede. Michela Murgia e quella sete di assoluto
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, venerdì 11 agosto 2023)
Era credente, e non ne aveva mai fatto mistero. Non le dispiaceva definirsi "teologa". La sua simpatia per papa Francesco non aveva niente di ideologico. Il ricordo di chi l’ha conosciuta da vicino
- [Foto] La scrittrice Michela Murgia - Ansa
L’ultima volta che ci siamo visti, Michela Murgia aveva appena donato a papa Francesco una copia della rivista di cui era stata direttrice per un solo numero. In copertina c’era lei, elegantissima e sorridente come sempre appariva da quando, nel maggio scorso, aveva deciso di rendere pubblica la fase terminale della sua malattia. “Aspetta, ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, aveva detto mentre cercava uno sgabello. Era affaticata ma orgogliosa: di quel giornale che era diventato un manifesto delle sue convinzioni (“La famiglia è di tutti”, annunciava il titolo principale) e del fatto di averlo potuto consegnare nelle mani del Papa che proprio lei, conosciuta come iconoclasta, aveva difeso dalle accuse piovutegli addosso all’indomani dell’elezione (a proposito di titoli, quel “Bergoglio e pregiudizio” scelto per sintetizzare le sue posizioni resta memorabile).
Michela Murgia era credente e non ne aveva mai fatto mistero. Fin dal suo libro di esordio, Il mondo deve sapere del 2006, non le dispiaceva definirsi teologa, una qualifica poi rivendicata in modo militante attraverso i suoi saggi, in particolare Ave Mary del 2011 e il controverso “catechismo femminista” God Save The Queer del 2022. Non erano mere provocazioni, anche se come tali si è cercato di farle passare. Tutto sommato, anche a Michela Murgia sarebbe convenuto metterla sul piano del paradosso intellettuale, dell’esagerazione argomentativa. Alla peggio, la si poteva buttare in politica, che in certi casi è il modo migliore per chiudere il discorso. Il punto è che la narratrice di Accabadora (il suo libro più celebre e compiuto, pervaso da un’incombenza del sacro per la quale è difficile trovare corrispettivi nella recente letteratura italiana) non si limitava a essere orgogliosa. Era anche una persona esigente, con gli altri e con sé stessa, con la propria scrittura e con le proprie convinzioni, sempre messe alla prova. Prendeva sul serio la fede e proprio per questo si aspettava molto dalla Chiesa.
La sua simpatia nei confronti di Francesco non aveva niente di ideologico. Era la condivisione intima e istintiva di una dottrina della misericordia dalla quale nessuno, per nessun motivo, può sentirsi escluso. Su questi, che erano i temi che più le stavano a cuore, sapeva essere polemica come sono a volte gli adolescenti, che alzano la voce e sbattono le porte solo per essere sicuri di essere amati nonostante tutto, senza condizioni. A volte esagerano, d’accordo, ma hanno dalla loro la certezza che un amore che ponga condizioni semplicemente non è amore.
Di tutto il resto si può discutere, ma a questo desiderio di assolutezza non si può né si deve aggiungere nulla. “Ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, diceva Michela Murgia l’ultima volta che ci siamo visti. Ne abbiamo bisogno tutti, sempre, solo che spesso non abbiamo il coraggio di ammetterlo. Lei, invece, non ha voluto nascondere la sua fragilità finale. “Voglio andare avanti così, fino alla fine”, ripeteva. “Riesco a scrivere solo quando mi sento minacciata, quando il cuore mi impazzisce per la paura”, aveva confidato in un’altra occasione. Non so se fosse intenzionale, ma stava citando san Paolo, Seconda lettera ai Corinzi, “quando sono debole, è allora che sono forte”. È una bella definizione della fede. Senz’altro, è la definizione migliore per la fede di Michela Murgia, che sorrideva al Papa e si aspettava tanto - tutto - dalla Chiesa.
*
LA TEOLOGIA DI DIO COME "UOMO SUPREMO" E L’OPERA "AVE MARY" (M. Murgia, 2011). Una citazione dalla recensione di Natalia Aspesi del saggio di Michela Murgia:
- (...) una frase molto pericolosa pronunciata nel 1978 da quel povero Giovanni Paolo I dal brevissimo papato: «Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile: è papà, più ancora è madre». Panico in Vaticano, terrore di uno spaventoso abisso teologico e simbolico, subito sepolto con la morte di papa Luciani. Ma Joseph Ratzinger quando era ancora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ci ricorda l’implacabile credente devota Murgia, «si espresse con molta chiarezza in merito alla questione del Dio Madre che ancora si aggirava per i corridoi vaticani come una patata bollente: "Non siamo autorizzati a trasformare il Padre Nostro in una Madre Nostra: il simbolismo usato da Gesù è irreversibile, è fondato sulla stessa relazione uomo-Dio che è venuto a rivelarci"» (N. Aspesi, “Eva e Maria, così la Chiesa ha sacrificato la donna", la Repubblica, 12.05.2011).
Federico La Sala
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- RIPENSARE COSTANTINO: LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), IL "DE PACE FIDEI" DI NICCOLO’ CUSANO (1453), E LA "MADONNA SALTING" DI ANTONELLO DA MESSINA (1460).17 novembre 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA, STORIA, E INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (E DEI SEGNI):
LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), IL "DE PACE FIDEI" DI NICCOLO’ CUSANO (1453), E LA "MADONNA SALTING" DI ANTONELLO DA MESSINA (1460).
Un segnavia per "arrivare" a Eleusis nel prossimo 2023.
ARTE E SOCIETÀ: LA MADONNA SALTING. A mio parere, l’influenza maggiore sulla produzione della "Madonna #Salting" di Antonello da Messina appare decisamente essere di scuola fiamminga. Tuttavia, essendo Antonello originario di Messina, forse, è da riguardare con particolare attenzione il senso simbolico della melagrana già aperta in mano al Bambino e, insieme, del cinturino annodato intorno al corpo del Figlio con i due fiocchetti (due piccole "#melagrana"), messi in una zona di chiara evidenza, che rimandano decisamente ai frutti del melograno in via di maturazione e alla fecondità della Madre, tutta vestita e "punteggiata" da infiniti "chicchi".
IPOTESI: QUESTIONE CRISTOLOGICA (ANTROPOLOGICA). Dato che il quadro è del 1460 circa, forse, potrebbe essere una "indicazione" di un discorso ancora sul nascere, di un dibattito all’ordine del giorno sul problema del Figlio, cioè sul tema decisivo dell’epoca (la caduta di Costantinopoli è del 1453 e il cardinale Niccolò Cusano cerca la via della pace della fede, nel 1453)": il nodo è proprio quello del Figlio (... e del "Presepe", e del "Natale"), quello dell’interpretazione teologico e antropologica della figura di Cristo (un tema ancora all’ordine del giorno), in un’ottica ecumenica.
CONSIDERATO CHE la "Dotta Ignoranza" di Cusano (1440) è del tutto segnata dalla tradizione filosofica e scientifica aristotelico-platonica (come sarà ancora per gli aristotelici dell’epoca di Galileo Galilei), la figura e il tema del bambino-homunculus è la parola chiave per comprendere non solo la teologia e l’anatomia dell’epoca, ma anche l’arte e l’antropologia, forse, è OPPORTUNO "RIPENSARE COSTANTINO": "IN HOC SIGNO VINCES". Proprio la caduta di Costantinopoli (1453), infatti, porterà l’Europa a svegliarsi dal letargo, a muoversi militarmente, e a prendere sotto la guida della Spagna la strada della riconquista (Granada,1492), della cacciata dei Mori e degli Ebrei (1492), della conquista dell’America (1492), e dell’avvio della prima globalizzazione teologico-politica del Pianeta Terra.
A) ANTONELLO DA MESSINA, "MADONNA SALTING".
B) BOSCH (1453-1516), ALL’ESCORIAL (1593). "Il Giardino delle delizie (o Il Millennio) è un trittico a olio su tavola (220×389 cm) di Hieronymus Bosch, databile 1480-1490 circa e conservato nel Museo del Prado di Madrid.[...]".
C) ELEUSIS 2023. Una delle capitali europee della cultura del 2023 è Eleusi: una buona opportunità storica per ripensare la figura della Terra-Madre, Demetra, della figlia, Persefone, e del tema dei misteri eleusini, e, al contempo, anche del melograno, e della melagrana, dell’agricoltura, delle stagioni, ecc.
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- MEMORIA DI UNA "RISPOSTA" DI PORTATA STORICA. «Non sono donna a sua disposizione»(Rosy Bindi).24 gennaio 2022, di Federico La Sala
STORIA E MEMORIA
- Franceschini: «parole volgari». Melandri: «Lui è più alto che educato» Berlusconi insulta la Bindi, lei risponde
- Berlusconi insulta la Bindi, lei risponde
- Il premier a "Porta a porta": «Più bella che intelligente».
- E l’ex ministro: «Non sono donna a sua disposizione» *
MILANO - «Ravviso che lei è sempre più bella che intelligente». La frase di Silvio Berlusconi rivolta a Rosy Bindi durante la puntata di Porta a Porta dedicata alla bocciatura del lodo Alfano getta ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche divampate dopo la decisione della Corte Costituzionale. Il premier, in collegamento telefonico, aveva accusato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affermando che avrebbe dovuto, «con la sua influenza», garantire un voto dei giudici costituzionali favorevole al lodo Alfano. Parole che hanno provocato la dura reazione dell’esponente del Pd: secondo la Bindi, quelle del premier sono frasi gravissime. «Ravviso che lei è sempre più bella che intelligente» ha replicato secco Berlusconi, citando, non si sa quanto volontariamente, Vittorio Sgarbi che ebbe già modo di definire così l’ex ministro prodiano e che ora, parlando con Corriere.it, assicura di non voler chiedere i diritti d’autore al premier (ASCOLTA). «Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce» ha scandito Berlusconi.
 Una «cortesia» che la stessa Rosy Bindi non ha lasciato cadere nel vuoto: «Sono una donna che non è a sua disposizione» ha replicato (riferimento neanche troppo velato alla vicenda delle escort che vede coinvolto il Cavaliere) «e ritengo molto gravi le sue affermazioni».
Una «cortesia» che la stessa Rosy Bindi non ha lasciato cadere nel vuoto: «Sono una donna che non è a sua disposizione» ha replicato (riferimento neanche troppo velato alla vicenda delle escort che vede coinvolto il Cavaliere) «e ritengo molto gravi le sue affermazioni».«REAGIRE DAVVERO» - La stessa Bindi, interpellata in mattinata da Radio Popolare, ha poi voluto precisare che «ho reagito non per difendere me dalle offese di Berlusconi che non mi sfiorano minimamente, mi sono sentita di reagire perché penso di doverlo fare in nome di tutte le donne». «Questo Presidente del Consiglio- ha aggiunto - ha una concezione strumentale delle donne, veicola messaggi pericolosi a questo Paese ed è arrivato il momento che le donne reagiscano davvero».
IL PRECEDENTE - Lo stesso Berlusconi, in ogni caso, aveva già avuto modo in passato di usare parole praticamente simili nei confronti della Bindi. Era l’8 aprile 2003 e il Cavaliere era andato a Brescia per sostenere la candidatura a sindaco di Viviana Beccalossi. Parlando della giovane esponente di An, il premier aveva spiegato che nei suoi occhi «si legge tutta la passione politica necessaria in questa sfida. È più brava che bella, il contrario di Rosy Bindi». Ma quell’intervento divenne più famoso per un’altra (involontaria?) gaffe dell’allora leader della Cdl: chiudendo il suo intervento incoraggiò infatti la portacolori del centrodestra con un equivocabile: «Forza Viviana, fagliela vedere!».
«PIÙ ALTO CHE EDUCATO» - All’indomani del battibecco negli studi di Bruno Vespa, il segretario del Partito Democratico, Dario Franceschini, ha telefonato a Rosy Bindi per esprimere alla vicepresidente della Camera la sua solidarietà per le «offese volgari e maleducate» a lei rivolte dal presidente del Consiglio. Anche Giovanna Melandri, responsabile Cultura del Pd, in una nota ha preso le difese di Rosy Bindi: «Berlusconi ha fatto gravissime affermazioni nei confronti delle istituzioni, attaccando il presidente della Repubblica e la magistratura. Altrettanto indegna è stata la frase con cui ha apostrofato Rosy Bindi: in queste offensive parole c’è tutto il ’Berlusconi-pensiero’ nei confronti delle donne: l’idea che la donna non abbia il diritto di prendere la parola se non per compiacere l’ego smisurato del sultano di Arcore. Il presidente del Consiglio ha dimostrato di essere più alto che educato». «Credo che le parole che Berlusconi ha pronunciato nei confronti di Rosy Bindi si commentino da sole nella loro profonda volgarità - ha aggiunto Anna Finocchiaro, presidente del Pd al Senato - e credo anche che una dirigente politica come Rosy non abbia certo bisogno di essere difesa. Rosy non è certamente a disposizione del Presidente del Consiglio, ma per fortuna è a disposizione e al servizio delle donne, del Pd e della democrazia del nostro Paese».
«C’E’ CONCITAZIONE, PUO’ SUCCEDERE» - Un tentativo di smorzare i toni arriva da Paolo Bonaiuti, sottosegretario della presidenza del Consiglio e portavoce di Berlusconi, in un intervento a Radio 2: «Questi sono momenti di estrema concitazione, questo può succedere. Una cosa sono i momenti asprezza politica, altra i momenti di vita normale». In precedenza, però, Bonaiuti aveva detto: «È sempre la solita storia del cane cattivo, prima lo attaccano, lui si difende. Evidentemente una difesa da una serie di attacchi mediatici che vanno avanti da mesi e mesi».
* Fonte: Corriere della Sera, 08 ottobre 2009 (ultima modifica: 09 ottobre 2009) (ripresa parziale).
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- UNA QUESTIONE DI LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA: l’EVERYMAN DI DANTE NON E’ QUELLO DELLA COSMOTEANDRIA.3 gennaio 2022, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA, LOGICA PSICOANALISI E COSTITUZIONE: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS" (non il Logo di una fattoria).
- La storia delle parole
- Bereshìt. È la prima parola della Torah, in principio. Ma perché c’è la Bet come prima lettera e non l’Aleph? C’è una storiella simpatica nello Zohar: Dio giocò duemila anni con le lettere che presero confidenza con lui. Ognuna di loro chiese di essere la prima. La Tav (l’ultima ed era a forma di croce fenicia inizialmente) iniziò col dire che lei era il sigillo della parola Emet (verità), e si meritava quell’onore. Via via le altre, fino alla Bet che disse che lei indicava il verso giusto del cammino ed era la lettera di Benedizione. A Dio piacque l’idea e scelse Bet. Chiese poi all’Alef perché non avesse cercato di convincerlo e lei rispose "perché non metto in discussione quello che hai già deciso" Dio la osservò e poi le disse "inizierò con Bet, ma tu sarai la prima dell’alfabeto".
DIO E LE LETTERE DELL’ALFABETO. Questa storiella dello Zohar "nasconde" una grande lezione di logica e matematica, antropologia e teologia (e, a mio parere, offre la chiave per meglio capire il senso stesso del riferimento di Baruch Spinoza al detto Homo Homini Deus Est e il messaggio dell’ impresa di Dante Alighieri).
Quando si comincia a contare, da dove bisogna cominciare, per iniziare bene ed essere gà a metà dell’opera?! Chi è che conta e da dove inizia. Perché (come qui, nella storiella dello Zohar) dalla Bet?
Premesso che le lettere dell’alfabeto ebraico sono anche numeri e, quindi, hanno un valore numerico, è opportuno ricordare che alef vale zero (= 0) e che bet vale uno (= 1); e, quando si comincia a contare, si comincia a contare da uno (= 1), appunto, da bet.
Per non perdere la #bussola e, ancor di più, per non lasciarsi sopraffare dalla narcisismica terremotante tentazione di truccare le carte e il conto, però, occorre tenere ben presente che al "Dio" che conta, in un altro testo decisivo della tradizione biblica (Apocalisse di Giovanni), è attribuita la seguente importantissima frase: "Io sono l’alfa e l’omega" (greco koinè: "ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω"). La precisazione è decisiva...
Amore è più forte di Morte (Ct., 8.6). A ben riflettere sull’apocalittica frase, si apre la porta di una chiara #comprensione sul Chi (= X) lega e sa legare "il principio e la fine" (Apocalisse 21:6, 22:13) e, al contempo, sul buon messaggio stesso della "Divina Commedia": "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145).
L’alfa (il principio) e l’omega (la fine), e la bet ("la prima lettera dell’alfabeto), la lettera che indica ""il verso giusto del cammino"!
Bet, la lettera di Benedizione ....
LA PIETRA FONDAMENTALE E LA PIETRA ANGOLARE: "ECCE HOMO". Ogni Uno (=1), Ognuno (ogni Eva e ogni Adamo, ogni Maria e ogni Giuseppe), Ogni Essere umano (Everyman, così Dante Alighieri per Ezra Pound), è antropologicamente e linguistica-mente la lettera dell’alfabeto, la Bet, la lettera di Benedizione e Bereshìt, la Parola che sta "Nel Principio": "Nel Principio era il Logos". L’amor che move il sole e le altre stelle....
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- LA "DIVINA COMMEDIA" E IL "DE POSSEST". Note a margine delle "tre eresie di Cusano" (di Maurizio Morini).30 novembre 2021, di Federico La Sala
#DIVINACOMMEDIA (#DANTE2021)!
IL CARDINALE #CUSANO CERCA DI PENSARE L’#INCARNAZIONE MA FA UN PASSO AVANTI E #TRE INDIETRO, VERSO LA #DIALETTTICA COSMOTEANDRICA DELL’#ASSOLUTO DI #HEGEL *
Le tre eresie di Cusano
di Maurizio Morini (Ritiri Filosofici, 21 Novembre 2021)
«Quando entra nel campo del potere-che-è, ossia nel campo dove il potere è in atto, l’intelletto va a caccia di un cibo estremamente nutriente». Con questa promessa, Cusano inizia la descrizione del secondo campo nel quale cercare la sapienza. La linea argomentativa è quella per cui ciò che non può essere, non è: quod esse potest non est. Ne discende una scoperta che Cusano definisce non di poco conto: e cioè che il non essere non è una creatura. In termini parmenidei si direbbe che il nulla non è pensabile e che la domanda “perché l’essere e non il nulla” non ha nemmeno senso perché il nulla non può mai essere. Di fatto, come dirà in altre opere, esiste solo ciò che può essere in quanto ciò che è impossibile non si realizza. Come conseguenza, noi vediamo l’attualità assoluta in virtù della quale le cose che sono in atto sono ciò che esse sono: hinc actualitatem conspicimus. Tutte queste affermazioni implicano uno scontro con le posizioni della tradizione filosofica aristotelico-tomistica.
Nel Possest la coincidenza di possibilità e necessità
Aristotele aveva stabilito il principio secondo cui l’atto è anteriore alla potenza. La potenza infatti, in quanto principio del divenire, non è sufficiente a realizzare il divenire in quanto è necessario che ci sia una causa che trasformi la potenza in atto. Ma questa causa, che Aristotele definisce come causa efficiente, deve necessariamente essere già in atto.
Cusano non accoglie lo schema aristotelico dell’anteriorità dell’atto sulla potenza in quanto né l’attualità né la possibilità possono avere una precedenza: se l’attualità precedesse la possibilità, allora essa non sarebbe più attualità (che attualità sarebbe infatti quella che si risolvesse in una non attualità?); se la possibilità precedesse l’attualità si avrebbe invece un regresso all’infinito (perché ogni attualità richiederebbe sempre una possibilità che la porta all’atto e via di seguito).
La conseguenza di questo ragionamento è quella di ammettere la coincidenza di possibilità e necessità. Tale coincidenza ha bisogno di un nome e Cusano inventa il neologismo possest, termine che nasce dalla composizione di due termini, posse-est, traducibile con l’espressione il poter essere che è. Con questo termine egli indica la coincidenza, nell’assoluto, del poter essere con l’essere in atto. Tutte le cose, nella realtà indicata da questo termine, sono complicate, perché tutto ciò che esiste, per esistere, deve poter esistere, e dunque deve esistere in quello che è il potere allo stato puro. Ma in questo potere assoluto, che è un potere che è, nel quale l’essere coincide con il potere e la possibilità con l’attualità, devono essere incluse (cioè complicate nel linguaggio cusaniano) tutte le cose. Nel termine possest il Cardinale conia un termine che esprime la congiunzione della potenza di divenire e della potenza divenuta. Poter essere è dunque poter essere in atto, per cui siccome questo poter essere è considerato in atto, si dice che questo poter essere è un posse. Si tratta di una conclusione talmente forte che, prima di proseguire, Cusano la nasconde dietro tre affermazioni che, con l’apparenza di essere devote, contengono altrettante eresie le quali, ad altri pensatori, in altri tempi e in altri modi, sono costate la libertà e la vita.
Un Dio glorioso che non compie miracoli
Quello che noi consideriamo come Dio nella nostra tradizione, afferma Cusano, non è altro che la coincidenza dell’atto puro e della potenza pura. Nonostante egli chiami questa coincidenza Dio glorioso, l’affermazione si risolve in una vera e propria eresia rispetto al pensiero ortodosso, perché la potenza pura era da sempre stata considerata il prodotto dell’atto: ad esempio, come applicazione di questo schema, la prima cosa che Dio produce è la materia la quale, nella tradizione scolastica, non ha niente a che vedere con Dio, il quale era considerato piuttosto come una sostanza costituita da un’essenza diversa da quella che possiede la sostanza materia. Cusano cancella un simile quadro teorico perché quello che era un effetto, la materia, lo inserisce nella causa, che egli chiama Dio, considerata simultaneamente come un soggetto di contrari.
Il risultato di questo ragionamento produce una seconda eresia consistente nel rifiuto del concetto di eminenza. Con questo termine la tradizione aveva designato un modo di esistenza in cui, ciò che si dà attualmente nel mondo, è presente in modo diverso nell’idea di Dio. Questo significa che la creatura è contenuta nella mente del creatore in modo qualitativamente diverso rispetto a quello della creatura: in Dio (ad esempio) anche il mio gatto esiste, ma non esiste così come esiste in sé o come esiste nella mia mente: esiste in un modo diverso (diversità intesa come perfezione) in quanto la sua vera natura non è attingibile dalla nostra conoscenza.
Come conseguenza di questo approccio teorico della Scolastica, la potenza di Dio poteva essere concepita contemporaneamente in due modi: potenza assoluta e potenza ordinata. In quanto Dio è Dio, la potenza di Dio è assoluta; se invece si considera la potenza di Dio espressa nel mondo, la potenza ordinata, questa potenza non è assoluta, perché si ritiene che il mondo non sia tutto ciò che Dio poteva creare e che esso sia una tra le creature di Dio. Nel caso del gatto, esso esiste ed è stato creato; ma il gatto non solo non poteva non essere stato creato ma esistono nella mente di Dio tutta una serie di gatti che, trattenuti nella sua mente, non sono stati creati. Si ritiene cioè che non tutto ciò che è nell’intelletto di Dio è stato da lui creato: la sua volontà infatti avrebbe fatto da filtro rispetto all’infinità delle idee che sono in Dio, idee che solo in parte si sono tradotte nel mondo.
Anche in questo caso Cusano liquida la tradizione perché il concetto di Dio coincide con la possibilità attuata in cui non vi è più alcun residuo di possibilità da esplicare. Se la creazione deriva dalla natura di Dio (e non dalla volontà), se questa natura è infinita, anche l’effetto è infinito, e quindi dobbiamo dire che nel mondo c’è la piena e totale espressione della potenza di Dio. Dire ciò significa anche abolire il principio dei miracoli, ovvero che Dio non può, a partire dalla sua volontà, porre in essere qualcosa che prima era nella sua mente.
La materia è parte di Dio
La coincidenza di possibilità e necessità provoca un mutamento anche nel concetto di materia e ciò dà luogo alla terza eresia, sicuramente quella più scandalosa. Nella Dotta ignoranza, Cusano aveva già spiegato che il concetto della possibilità coincideva con quello della materia. Il problema è che la tradizione aristotelica era giunta a quel concetto nella modalità del non sapere, pensandola come possibilità eretta come principio assoluto e che coesisteva con lo stesso Dio (il quale era pensato in termini puramente spirituali). I platonici chiamarono la possibilità assoluta mancanza, in quanto essa manca di ogni forma. Gli aristotelici la definivano “quasi niente”, perché la materia aveva soltanto in minimo grado le qualità della sostanza. Di conseguenza, essi sostenevano che le forme sono presenti nella materia solo allo stato di possibilità. concludendo poi con la tesi che nella possibilità è presente la totalità delle cose. Cusano stabilisce invece che è impossibile che vi sia una possibilità assoluta, non congiunta cioè con l’atto, perché altrimenti bisognerebbe ammettere conseguenze assurde, come riconoscere un’infinità che parte dalla mancanza: cosa del tutto contraria a Dio perché semmai, in lui, l’infinità non può che partire da un’abbondanza.
Nasce il modello della causalità immanente
Come osserva un interlocutore del cardinale, si deve dire che Dio è in tutte le cose in modo tale da non poter essere altro quello che è. Questa, dice Cusano, è una dottrina da sostenere nel modo più fermo perché la coincidenza nell’assoluto di potenza ed atto consente di spiegare altrimenti la sua dottrina della complicatio. Dio infatti è tutte le cose in modo tale da non essere una di esse più di quanto non sia un’altra. Dio è sole ma non secondo il modo di essere del sole, il quale non è tutto ciò che può essere. Se questa prospettiva si può definire panteistica, non si deve dimenticare il modo esatto in cui essa si qualifica. Nel potere-che-è sono complicate tutte le cose e nessun grado di conoscenza riesce a coglierlo. Ma, soprattutto, «il potere, considerato in senso assoluto, è ogni potere. Pertanto se io vedessi che ogni potere è in atto non resterebbe più nulla. Se infatti restasse qualcosa, si tratterebbe pur sempre di qualcosa che potrebbe essere, per cui non resterebbe se prima non fosse già stata compresa nel potere». La conseguenza di questo discorso è che qualcosa, per essere qualcosa, deve avere la potenza di essere ciò che è e quindi, se non c’è il poter essere, non esiste nulla. Così come non si porta un’onda fuori del mare, è necessario che tutte le cose che sono, siano esistite da sempre nell’eternità: ciò che è stato creato è sempre esistito nel poter essere. Tutte le cose che sono e che si muovono, sono e si muovono nel possest.
*
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
- DANTE2021: #INTREARSI (Par XIII, 55-57). #FILOSOFIA E #ANTROPOLOGIA, #oggi: LA #DOTTAIGNORANZA (1440) E L’#IDIOTA (1450). Ripartire da #NiccoloCusano, riprendere la strada della #divinacommedia e #voltaire pagina
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. CON MARX E FREUD. Una "ipotesi di rilettura della DIVINA COMMEDIA"
Federico La Sala
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- COSMOTEANDRIA E MESSAGGIO EVANGELICO. La solennità di "Cristo Re" e l’enciclica "Quas primas" di Pio Xi (1925).21 novembre 2021, di Federico La Sala
Santo del giorno: 21 novembre
Solennità di Cristo Re *
Il Papa Pio XI, istituendo nell’anno Giubilare 1925 la nuova solennità di Cristo Re, pubblicava la sapientissima enciclica «Quas primas». Ne riportiamo i punti principali.
«Avendo concorso quest’Anno Santo non in uno ma in più modi, ad illustrare il regno di Cristo, ci sembra che faremo cosa quanto mai consentanea al Nostro apostolico ufficio, se, assecondando le preghiere di moltissimi Cardinali, Vescovi e fedeli fatte a Noi, sia da soli, sia collettivamente, chiuderemo questo stesso Anno coll’introdurre nella sacra Liturgia una festa speciale di Gesù Cristo Re. Da gran tempo si è usato comunemente di chiamare Cristo con l’appellativo di Re, per il sommo grado di eccellenza che ha in modo sovraeminenie fra tutte le cose create. In tal modo infatti, si dice che Egli regna nelle menti degli uomini, non solo per l’altezza del suo pensiero e per la vastità della sua scienza, ma anche perché Egli è la Verità, ed è necessario che gli uomini attingano e ricevano con obbedienza da lui la verità. Similmente Egli regna nelle volontà degli uomini sia perché in Lui alla santità della volontà divina risponde la perfetta integrità e sottomissione della volontà umana, sia perchè con le sue ispirazioni influisce sulla libera volontà nostra, in modo da infiammarci verso le più nobili cose. Infine Cristo è riconosciuto Re dei cuori, per quella sua carità che sorpassa ogni comprensione umana e per le attrattive della sua mansuetudine e benignità ».
La regalità di Gesù Cristo « consta di una triplice potestà: la prima è la potestà legislativa. È dogma di fede che Gesù Cristo è stato dato agli uomini quale Redentore in cui essi debbono riporre la loro fiducia e nel tempo stesso come Legislatore, a cui debbono ubbidire. In secondo luogo egli ebbe dal padre la potestà di giudicare il cielo e la terra, non solo come Dio, ma ancora come uomo. Infine diciamo che Gesù Cristo ha pure il diritto di premiare o punire gli uomini anche durante la loro vita ».
Dove si trova il regno di N. S. Gesù Cristo? Di quali caratteri particolari è dotato? Come si acquista? Il regno di N. S. Gesù Cristo « ha principalmente carattere soprannaturale e attinente alle cose spirituali. Infatti quando i Giudei e gli stessi Apostoli credevano per errore che il Messia avrebbe reso la libertà al popolo ed avrebbe ripristinato il regno di Israele, Egli cercò di togliere loro dal capo queste vane attese, e questa speranza ». Così pure quando la folla, presa da ammirazione per gli strepitosi prodigi da lui operati, voleva acclamarlo re, egli miracolosamente si sottrasse ai loro sguardi e si nascose: ed a Pilato che l’aveva interrogato sul suo regno rispose: « Il mio regno non è di questo mondo ». L’ingresso in questo regno soprannaturale, si attua mediante la penitenza e la fede, e richiede nei sudditi il distacco dalle ricchezze e dalle cose terrene, la mitezza dei costumi, la fame e la sete di giustizia ed inoltre il rinnegamento di se stessi per portare la croce dietro al Signore. Ecco il programma di ogni cristiano che vuole essere vero suddito di Gesù Cristo Re!
* Fonte: Santo del giorno, 21 novembre 2021 (ripresa parziale).
Note:
Martirologio Romano: Solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo: a Lui solo il potere, la gloria e la maestà negli infiniti secoli dei secoli:
 "[...] Questa festa fu introdotta da papa Pio XI, con l’enciclica “Quas primas” dell’11 dicembre 1925, a coronamento del Giubileo che si celebrava in quell’anno.
"[...] Questa festa fu introdotta da papa Pio XI, con l’enciclica “Quas primas” dell’11 dicembre 1925, a coronamento del Giubileo che si celebrava in quell’anno.
 È poco noto e, forse, un po’ dimenticato. Non appena elevato al soglio pontificio, nel 1922, Pio XI condannò in primo luogo esplicitamente il liberalismo “cattolico” nella sua enciclica “Ubi arcano Dei”. Egli comprese, però, che una disapprovazione in un’enciclica non sarebbe valsa a molto, visto che il popolo cristiano non leggeva i messaggi papali. Quel saggio pontefice pensò allora che il miglior modo di istruirlo fosse quello di utilizzare la liturgia. Di qui l’origine della “Quas primas”, nella quale egli dimostrava che la regalità di Cristo implicava (ed implica) necessariamente il dovere per i cattolici di fare quanto in loro potere per tendere verso l’ideale dello Stato cattolico: “Accelerare e affrettare questo ritorno [alla regalità sociale di Cristo] coll’azione e coll’opera loro, sarebbe dovere dei cattolici”. Dichiarava, quindi, di istituire la festa di Cristo Re, spiegando la sua intenzione di opporre così “un rimedio efficacissimo a quella peste, che pervade l’umana società. La peste della età nostra è il così detto laicismo, coi suoi errori e i suoi empi incentivi”.
È poco noto e, forse, un po’ dimenticato. Non appena elevato al soglio pontificio, nel 1922, Pio XI condannò in primo luogo esplicitamente il liberalismo “cattolico” nella sua enciclica “Ubi arcano Dei”. Egli comprese, però, che una disapprovazione in un’enciclica non sarebbe valsa a molto, visto che il popolo cristiano non leggeva i messaggi papali. Quel saggio pontefice pensò allora che il miglior modo di istruirlo fosse quello di utilizzare la liturgia. Di qui l’origine della “Quas primas”, nella quale egli dimostrava che la regalità di Cristo implicava (ed implica) necessariamente il dovere per i cattolici di fare quanto in loro potere per tendere verso l’ideale dello Stato cattolico: “Accelerare e affrettare questo ritorno [alla regalità sociale di Cristo] coll’azione e coll’opera loro, sarebbe dovere dei cattolici”. Dichiarava, quindi, di istituire la festa di Cristo Re, spiegando la sua intenzione di opporre così “un rimedio efficacissimo a quella peste, che pervade l’umana società. La peste della età nostra è il così detto laicismo, coi suoi errori e i suoi empi incentivi”.
 Tale festività coincide con l’ultima domenica dell’anno liturgico, con ciò indicandosi che Cristo Redentore è Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. Egli è l’Alfa e l’Omega, come canta l’Apocalisse (Ap 21, 6). Gesù stesso, dinanzi a Pilato, ha affermato categoricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”, il Divino Redentore rispose: “Tu lo dici, io sono re” (Gv 18, 37).
Pio XI insegnava che Cristo è veramente Re. Egli solo, infatti, Dio e uomo - scriveva il successore Pio XII, nell’enciclica “Ad caeli Reginam” dell’11 ottobre 1954 - “in senso pieno, proprio e assoluto, ... è re”. [...]" (cfr. "Santi e beati": Francesco Patruno).
Tale festività coincide con l’ultima domenica dell’anno liturgico, con ciò indicandosi che Cristo Redentore è Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. Egli è l’Alfa e l’Omega, come canta l’Apocalisse (Ap 21, 6). Gesù stesso, dinanzi a Pilato, ha affermato categoricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”, il Divino Redentore rispose: “Tu lo dici, io sono re” (Gv 18, 37).
Pio XI insegnava che Cristo è veramente Re. Egli solo, infatti, Dio e uomo - scriveva il successore Pio XII, nell’enciclica “Ad caeli Reginam” dell’11 ottobre 1954 - “in senso pieno, proprio e assoluto, ... è re”. [...]" (cfr. "Santi e beati": Francesco Patruno).PIO XI, LETTERA ENCICLICA QUAS PRIMAS, 11 dicembre 1925
FLS
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- CHI E’ IL "FIGLIO DELL’UOMO"; UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, NON ANDROLOGICA.30 settembre 2021, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA (NON ANDROLOGICA): "ECCE HOMO".
LA GIUSTIFICAZIONE PER FEDE E IL PROBLEMA CRISTOLOGICO: CHI E’ GESU’?!? E CHI IL SUO E NOSTRO "PADRE"?!
- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. IL "FIGLIO DELL’UOMO": "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου"] deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).
- MESSAGGIO EVANGELICO: CHI E’ COME DIO? (QUIS UT DEUS?): "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" ("Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito ... Dio è amore" (1 Gv.: 4. 1-16).
- IL PROGRAMMA DI ANTROPOLOGIA ANDRO-LOGICA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- DEUS CHARITAS O DEUS CARITAS?!: LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- PAPA FRANCESCO
 UDIENZA GENERALE
UDIENZA GENERALE
 Mercoledì, 29 settembre 2021
Mercoledì, 29 settembre 2021
Catechesi sulla Lettera ai Galati: 9. La vita nella fede *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel nostro percorso per comprendere meglio l’insegnamento di San Paolo, ci incontriamo oggi con un tema difficile ma importante, quello della giustificazione. Cos’è, la giustificazione? Noi, da peccatori, siamo diventati giusti. Chi ci ha fatto giusti? Questo processo di cambiamento è la giustificazione. Noi, davanti a Dio, siamo giusti. È vero, abbiamo i nostri peccati personali, ma alla base siamo giusti. Questa è la giustificazione. Si è tanto discusso su questo argomento, per trovare l’interpretazione più coerente con il pensiero dell’Apostolo e, come spesso accade, si è giunti anche a contrapporre le posizioni. Nella Lettera ai Galati, come pure in quella ai Romani, Paolo insiste sul fatto che la giustificazione viene dalla fede in Cristo. “Ma, io sono giusto perché compio tutti i comandamenti!”. Sì, ma da lì non ti viene la giustificazione, ti viene prima: qualcuno ti ha giustificato, qualcuno ti ha fatto giusto davanti a Dio. “Sì, ma sono peccatore!”. Sì sei giusto, ma peccatore, ma alla base sei giusto. Chi ti ha fatto giusto? Gesù Cristo. Questa è la giustificazione.
Cosa si nasconde dietro la parola “giustificazione”, che è così decisiva per la fede? Non è facile arrivare a una definizione esaustiva, però nell’insieme del pensiero di San Paolo si può dire semplicemente che la giustificazione è la conseguenza della «misericordia di Dio che offre il perdono» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1990). E questo è il nostro Dio, così tanto buono, misericordioso, paziente, pieno di misericordia, che continuamente dà il perdono, continuamente. Lui perdona, e la giustificazione è Dio che perdona dall’inizio ognuno, in Cristo. La misericordia di Dio che dà il perdono. Dio, infatti, attraverso la morte di Gesù - e questo dobbiamo sottolinearlo: attraverso la morte di Gesù - ha distrutto il peccato e ci ha donato in maniera definitiva il perdono e la salvezza. Così giustificati, i peccatori sono accolti da Dio e riconciliati con Lui. È come un ritorno al rapporto originario tra il Creatore e la creatura, prima che intervenisse la disobbedienza del peccato. La giustificazione che Dio opera, pertanto, ci permette di recuperare l’innocenza perduta con il peccato. Come avviene la giustificazione? Rispondere a questo interrogativo equivale a scoprire un’altra novità dell’insegnamento di San Paolo: che la giustificazione avviene per grazia. Solo per grazia: noi siamo stati giustificati per pura grazia. “Ma io non posso, come fa qualcuno, andare dal giudice e pagare perché mi dia giustizia?”. No, in questo non si può pagare, ha pagato uno per tutti noi: Cristo. E da Cristo che è morto per noi viene quella grazia che il Padre dà a tutti: la giustificazione avviene per grazia.
L’Apostolo ha sempre presente l’esperienza che ha cambiato la sua vita: l’incontro con Gesù risorto sulla via di Damasco. Paolo era stato un uomo fiero, religioso, zelante, convinto che nella scrupolosa osservanza dei precetti consistesse la giustizia. Adesso, però, è stato conquistato da Cristo, e la fede in Lui lo ha trasformato nel profondo, permettendogli di scoprire una verità fino ad allora nascosta: non siamo noi con i nostri sforzi che diventiamo giusti, no: non siamo noi; ma è Cristo con la sua grazia a renderci giusti. Allora Paolo, per avere una piena conoscenza del mistero di Gesù, è disposto a rinunciare a tutto ciò di cui prima era ricco (cfr Fil 3,7), perché ha scoperto che solo la grazia di Dio lo ha salvato. Noi siamo stati giustificati, siamo stati salvati per pura grazia, non per i nostri meriti. E questo ci dà una fiducia grande. Siamo peccatori, sì; ma andiamo sulla strada della vita con questa grazia di Dio che ci giustifica ogni volta che noi chiediamo perdono. Ma non in quel momento, giustifica: siamo già giustificati, ma viene a perdonarci un’altra volta.
La fede ha per l’Apostolo un valore onnicomprensivo. Tocca ogni momento e ogni aspetto della vita del credente: dal battesimo fino alla partenza da questo mondo, tutto è impregnato dalla fede nella morte e risurrezione di Gesù, che dona la salvezza. La giustificazione per fede sottolinea la priorità della grazia, che Dio offre a quanti credono nel Figlio suo senza distinzione alcuna.
Perciò non dobbiamo concludere, comunque, che per Paolo la Legge mosaica non abbia più valore; essa, anzi, resta un dono irrevocabile di Dio, è - scrive l’Apostolo - «santa» (Rm 7,12). Pure per la nostra vita spirituale è essenziale osservare i comandamenti, ma anche in questo non possiamo contare sulle nostre forze: è fondamentale la grazia di Dio che riceviamo in Cristo, quella grazia che ci viene dalla giustificazione che ci ha dato Cristo, che ha già pagato per noi. Da Lui riceviamo quell’amore gratuito che ci permette, a nostra volta, di amare in modo concreto.
In questo contesto, è bene ricordare anche l’insegnamento che proviene dall’apostolo Giacomo, il quale scrive: «L’uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede - sembrerebbe il contrario, ma non è il contrario -. [...] Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta» (Gc 2,24.26). La giustificazione, se non fiorisce con le nostre opere, sarà lì, sotto terra, come morta. C’è, ma noi dobbiamo attuarla con il nostro operato. Così le parole di Giacomo integrano l’insegnamento di Paolo. Per entrambi, quindi, la risposta della fede esige di essere attivi nell’amore per Dio e nell’amore per il prossimo. Perché “attivi in quell’amore”? Perché quell’amore ci ha salvato tutti, ci ha giustificati gratuitamente, gratis!
La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza, che mostra la giustizia di Dio: di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti e lo ha fatto per grazia, attraverso il dono di Gesù Cristo, della sua morte e risurrezione. Alcune volte ho detto com’è il modo di agire di Dio, qual è lo stile di Dio, e l’ho detto con tre parole: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Sempre è vicino a noi, è compassionevole e tenero. E la giustificazione è proprio la vicinanza più grande di Dio con noi, uomini e donne, la compassione più grande di Dio verso di noi, uomini e donne, la tenerezza più grande del Padre. La giustificazione è questo dono di Cristo, della morte e risurrezione di Cristo che ci fa liberi. “Ma, Padre, io sono peccatore, ho rubato...”. Sì, ma alla base sei un giusto. Lascia che Cristo attui quella giustificazione. Noi non siamo condannati, alla base, no: siamo giusti. Permettetemi la parola: siamo santi, alla base. Ma poi, con il nostro operato diventiamo peccatori. Ma, alla base, si è santi: lasciamo che la grazia di Cristo venga su e quella giustizia, quella giustificazione ci dia la forza di andare avanti. Così, la luce della fede ci permette di riconoscere quanto sia infinita la misericordia di Dio, la grazia che opera per il nostro bene. Ma la stessa luce ci fa anche vedere la responsabilità che ci è affidata per collaborare con Dio nella sua opera di salvezza. La forza della grazia ha bisogno di coniugarsi con le nostre opere di misericordia, che siamo chiamati a vivere per testimoniare quanto è grande l’amore di Dio. Andiamo avanti con questa fiducia: tutti siamo stati giustificati, siamo giusti in Cristo. Dobbiamo attuare questa giustizia con il nostro operato.
*UDIENZA GENERALE, Mercoledì, 29 settembre 2021 (ripresaparziale).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
Federico La Sala
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- DANTE 2021. USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA CADUTA: "UN VULCANO NEL VULCANO". Riprendere il filo di Mary Daly.4 luglio 2021, di Federico La Sala
#DANTE 2021.
USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA
#CADUTA:
#ANTROPOLOGIA #TEOLOGIA
E
#CRITICA DELL’#IMMAGINARIO DEL
#CRISTIANESIMO STORICO.
Riprendere il filo di #Mary Daly...
*
"Mary Daly ebbe a dire in seguito che il titolo sarebbe potuto essere semplicemente «Al di là di Dio»"
*
#Mary Daly:
"Quando pubblicai la prima edizione di «Al di là di Dio Padre»...
il vero titolo doveva essere «Al di là di Dio»...
La parola «Padre» è ridondante"
 così quello di Madre,
così quello di Madre,se non c’è
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- La memoria di una sollecitazione di lunga durata a finirla con "il farisaico rispetto della legge".31 marzo 2021, di Federico La Sala
#ACHEGIOCOGIOCHIAMO?! #TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA.
#EUROPA #SPAGNA #DUE ANNI DOPO LA MORTE DI #CARLOV nel 1560, in #Italia, a #Roma si pubblica il testo di #Anatomia di #GiovanniValverde: si riconosce il ruolo attivo della donna nella #concezione del problema #comenasconoibambini
La sollecitazione di #Michelangelo (1512), #GiovanniValverde (1560), #LuigiCancrini (2005) e #MarioDraghi (2021) a finirla con "il farisaico rispetto della #legge"
#VITAEFILOSOFIA. #COMENASCONOIBAMBINI (#ENZOPACI). Fermare il #giogo, #uscire dall’orizzonte della #tragedia e imparare a #contare
FLS
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA: MESSAGGIO EVANGELICO E "NUOVA ALLEANZA" DI "MARIA E GIUSEPPE". Note27 gennaio 2021, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E LA "NUOVA ALLEANZA" DI "MARIA E GIUSEPPE". EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA.... *
- ARTE E "MITOLOGIA GRECO-ROMANA". Trittico di Mérode: L’Annunciazione (1427).
La biblista francese.
Pelletier: «Donne, Chiesa polifonica»
Per la studiosa occorre «ritrovare una struttura consonante a quanto presenta Paolo, cioè la Chiesa come corpo, dove l’istituzione si fonda su doni particolari assegnati agli uni e agli altri»
di Lorenzo Fazzini (Avvenire, mercoledì 27 gennaio 2021)
- [Foto] La biblista francese Anne-Marie Pelletier
Anne-Marie Pelletier non è solo una sagace esegeta e una brillante docente universitaria. Già Premio Ratzinger per la teologia, l’intellettuale francese diventa anche una paladina delle donne, dentro e fuori la Chiesa, quando affronta il tema dell’odierna condizione femminile.
 «Un club di uomini anziani, vestiti in modo strano, che dicono alla gente come si deve comportarsi a letto». Con questa sarcastica definizione Timothy Radcliffe illustra come, a suo dire, la gente vede la Chiesa. Perché non viene invece riconosciuto il grande apporto delle donne alla vita della Chiesa?
«Un club di uomini anziani, vestiti in modo strano, che dicono alla gente come si deve comportarsi a letto». Con questa sarcastica definizione Timothy Radcliffe illustra come, a suo dire, la gente vede la Chiesa. Perché non viene invece riconosciuto il grande apporto delle donne alla vita della Chiesa?
 Le parole di Radcliffe sono impietose ma esprimono bene la realtà. La visibilità della Chiesa cattolica resta incontestabilmente quella della sua gerarchia, esclusivamente composta da uomini. E questa visione non è un effetto ottico.
Le parole di Radcliffe sono impietose ma esprimono bene la realtà. La visibilità della Chiesa cattolica resta incontestabilmente quella della sua gerarchia, esclusivamente composta da uomini. E questa visione non è un effetto ottico.
 È sufficiente aprire la porta di una chiesa durante una celebrazione per constatare che il presbiterio è uno spazio che appartiene agli uomini, in via maggioritaria se non esclusiva. Inoltre, l’autorità viene collegata al sacerdozio ministeriale. E per molti questo tipo di sacerdozio resta la chiave di volta del corpo ecclesiale. Anzi, passa l’idea che ne costituisca l’espressione suprema.
È sufficiente aprire la porta di una chiesa durante una celebrazione per constatare che il presbiterio è uno spazio che appartiene agli uomini, in via maggioritaria se non esclusiva. Inoltre, l’autorità viene collegata al sacerdozio ministeriale. E per molti questo tipo di sacerdozio resta la chiave di volta del corpo ecclesiale. Anzi, passa l’idea che ne costituisca l’espressione suprema.
 Da qui le reiterate denunce di clericalismo da parte di papa Francesco.
Da qui le reiterate denunce di clericalismo da parte di papa Francesco.Cosa va perso in questa visione maschio-centrica?
Il dramma è che la verità della Chiesa viene nascosta. Infatti, la Chiesa non è innanzitutto la sua gerarchia, ma prima di tutto un corpo, che questa gerarchia ha la funzione di servire. Questo corpo è composto da uomini e donne che, nei loro diversi stati di vita, si riconoscono convocati dalla parola di Cristo. Questo popolo di battezzati dona carne e presenza al Vangelo nel mondo, spesso silenziosamente ma in modo autentico. E bisogna ammettere che le donne, in questo corpo, hanno un posto eminente, anzi dominante perché, in molti luoghi e circostanze, sono loro il volto e la mano della Chiesa per i nostri contemporanei. Io perdo un po’ la pazienza quando sento ripetere che ’bisogna fare spazio alle donne’ quando, invece, la prima cosa da fare è riconoscere il posto che esse occupano nelle parrocchie, nella catechesi, nelle missioni. Senza di loro, la Chiesa sarebbe già sparita.
Altrove lei ha sottolineato come l’attenzione della Chiesa con Francesco verso le donne non sia una questione nuova: da 50 anni i Papi prestano un’attenzione crescente al mondo femminile con diversi documenti. Allora è la Chiesa che ha fallito, rispetto all’uguaglianza uomo-donna, se ancora oggi viene percepita come maschile?
Si tratta di un dato impressionante. Dagli anni Sessanta il magistero ha prestato alle donne un’attenzione inedita. Non si era mai visto un elogio tale della donna da parte delle autorità della Chiesa. Eppure, nella Chiesa cattolica, le donne - in gran numero - hanno continuato a sentirsi emarginate, vedendosi assegnate a posti secondari, trattate con accondiscendenza, talvolta disprezzate da un mondo clericale che si arroga ogni decisione. Al punto da far sorgere l’opinione che molte poche cose sarebbero potute cambiare. Il problema di fondo non è semplicemente parlare delle donne, né parlare alle donne, ma lasciarle esistere, farle parlare a nome proprio nella Chiesa, far sì che siano esse a giudicare i problemi della vita e le questioni della fede, di cui hanno esperienza tanto quanto gli uomini.
In un suo testo su ’Vita e Pensiero’ lei scrive: «Il futuro dell’istituzione ecclesiale è intrinsecamente legato, nel cattolicesimo, a una riflessione polifonica ovvero alla condivisione della ricerca della verità, sempre più grande di quanto siamo capaci di cogliere». Può essere una riforma solo ’intellettuale’ sufficiente per far progredire il posto delle donne nella Chiesa? Oppure serve anche una riforma strutturale?
Per me è chiaro che una vera riforma della Chiesa deve incarnarsi nelle strutture della sua vita e nell’organigramma della sua governance. In questo senso non bastano tante belle parole. Il punto focale è che noi, uomini e donne, ci troviamo insieme nella responsabilità verso il Vangelo e nella missione della Chiesa. Rispetto al motu proprio recente, esso ritorna su un testo del 1972 che apriva il lettorato e il servizio di accolitato ai laici, a condizione che fossero uomini: in questo caso il magistero permette di metter fine ad un’aberrazione che squalifica la Chiesa. Resta il fatto che sarebbe troppo poco cercare solo di ridistribuire i poteri in una struttura immutata. Sono convinta che siamo in un momento cruciale in cui l’istituzione ecclesiale deve reinventarsi. Si deve tornare all’ecclesiologia. Non si significa fossilizzarsi su un’attività astrattamente intellettuale. Anzi, qui c’è la leva per un vero cambiamento di fondo. In questo senso mi piace comprendere la messa in guardia di papa Francesco di non attenersi alle semplici ’funzioni’. Per questo, mi trovo a disagio quando si pensa che l’accesso al sacerdozio femminile costituirebbe la soluzione della questione. Piuttosto vi constato un modo per ricondurre e confermare l’intero ordine ecclesiale al primato del sacerdozio ministeriale. Invece, penso che si debba uscire da questo schema per ritrovare una struttura consonante a quanto Paolo presenta, cioè la Chiesa come corpo, dove l’istituzione si fonda su doni particolari assegnati agli uni e agli altri per il servizio di tutti. E così la Chiesa si ridisegna come una comunità di battezzati, dove il sacerdozio battesimale, condiviso da tutti, ritorna ad essere il più importante.
Nel suo libro Una comunione di uomini e donne lei ha parlato di un «machismo diventato il marchio di fabbrica della Russia putiniana e dell’America trumpiana». Perché l’avversione all’emancipazione femminile è così forte nel sovranismo?
Le donne oggi si ritrovano ad essere sotto la minaccia di regimi autoritari che proliferano e che hanno un’aria di dejà vu, i cui leader sono esclusivamente uomini. La Russia vive sotto il comando di un dirigente che esalta la virilità brutale, che mostra mediaticamente i suoi muscoli e che porta avanti una repressione impietosa delle opposizioni: la guerra in Cecenia ne é un sinistro esempio. Non è un caso che una delle maggiori oppositrici di questa ideologia sia una donna, il premio Nobel Svetlana Aleksievic, che ha scritto un libro intitolato La guerra non ha volto di donna. -Quanto al populismo di Donald Trump o Jair Bolsonaro e altri, sappiamo bene come questi uomini disprezzino le donne, sia nei loro discorsi che nella loro vita privata. Non dimentichiamo che le più grandi manifestazioni nella storia degli Usa sono state quelle delle donne che denunciavano il machismo insolente di Donald Trump nel 2016.
I movimenti per l’emancipazione delle donne sono un segno dei tempi. Come far sì che diventino positivi per l’intera società e non restino relegati ad essere - per quanto giuste - solo proteste?
É indubbio che i femminismi, per natura, sono movimenti protestatari e militanti. Come stupirsi che, per denunciare le violenze che pesano di esse e gli asservimenti cui sono costrette, le donne scendano in piazza e brandiscano lo stendardo della rivolta? Ma l’obiettivo dovrebbe essere quello di uscire dalla guerra tra sessi, per arrivare ad un’auspicabile stima reciproca, fino a un’alleanza felice per la pienezza degli uni e delle altre. Non è certo quello che intendono quante oggi riesumano i testi di Valérie Solanas, l’intellettuale americana che sognava l’eliminazione del maschio dall’umanità. Un atteggiamento oltranzista, questo, che non opera per il bene delle donne ostaggio della miseria, delle povertà e del machismo che prospera su questo terreno.
*
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
- GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!!
HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
FLS
- ARTE E "MITOLOGIA GRECO-ROMANA". Trittico di Mérode: L’Annunciazione (1427).
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" (di Patricia Klindienst).1 marzo 2019, di Federico La Sala
 PIANETA TERRA. Tracce per una svolta antropologica...
PIANETA TERRA. Tracce per una svolta antropologica... MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours"). Un testo di Patricia Klindienst (trad. di Maria G. Di Rienzo) -
MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours"). Un testo di Patricia Klindienst (trad. di Maria G. Di Rienzo) - OVIDIO. La tela di Aracne apre il libro sesto delle "Metamorfosi", la storia di Filomela lo chiude (...) Prima che la dea adirata Atena (Minerva) stracci la stoffa tessuta da Aracne, la tessitrice, donna mortale, racconta su di essa una storia molto particolare (...)
OVIDIO. La tela di Aracne apre il libro sesto delle "Metamorfosi", la storia di Filomela lo chiude (...) Prima che la dea adirata Atena (Minerva) stracci la stoffa tessuta da Aracne, la tessitrice, donna mortale, racconta su di essa una storia molto particolare (...) -
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. In onore di Mary Daly --- Quanto è atavica la mentalità maschile. Una "risposta" di U. Galimberti.26 giugno 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!!:
- “De Testicoli delle donne”.Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap.15 dell’ ANATOMIA di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli delle donne”(p. 91).
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Lettere
Quanto è atavica la mentalità maschile
La donna che non genera è esposta a un dubbio logorante.
Ed è guardata ancora con sospetto
Risponde Umberto Galimberti *
- Si parla tanto di femminismo e parità dei sessi, ma io mi trovo all’età di 43 anni a dubitare che questa parità possa esistere davvero. Sostenuta da una famiglia in cui padre e madre hanno sempre avuto ruoli intercambiabili e paritari, pur essendo donna ho vissuto sempre secondo quello che i miei valori e il mio carattere mi avrebbero dettato, senza piegarmi, e ho considerato sopportabile un giusto prezzo da pagare per l’indipendenza. Finché non ho messo piede in quell’età in cui "l’orologio biologico" ticchetta più velocemente e tutti intorno a te si affrettano ad accoppiarsi e a riprodursi. E in un attimo gli amici di una vita spariscono e ti ritrovi davanti a una decisione incombente da cui sembra dipendere tutta la tua vita, la tua identità, il tuo futuro. Eppure tra mille dubbi senti che per te quella strada non funziona, che hai ancora molto da studiare, dare, fare e vedere, e che il tuo corpo intanto è invecchiato e non si convince dell’idea del "puoi avere figli senza rinunciare a niente" venduta dalla società della maternità romanticizzata e idealizzata.
 Concludo che l’idea della parità è una chimera. Arriva un momento in cui l’identità di una donna si arena davanti al bivio madre/non-madre. Qualunque altra cosa tu faccia come donna e come persona, sbiadisce, viene sminuita. Se non desideri essere madre, diventi una non-madre, prima di tutto. Non so perché scrivo a lei, che è un uomo, ma nelle sue risposte e nei suoi libri leggo una visione del mondo e delle cose che illumina ed evolve invece di auto-ribadirsi.
Concludo che l’idea della parità è una chimera. Arriva un momento in cui l’identità di una donna si arena davanti al bivio madre/non-madre. Qualunque altra cosa tu faccia come donna e come persona, sbiadisce, viene sminuita. Se non desideri essere madre, diventi una non-madre, prima di tutto. Non so perché scrivo a lei, che è un uomo, ma nelle sue risposte e nei suoi libri leggo una visione del mondo e delle cose che illumina ed evolve invece di auto-ribadirsi.
 virginial@email.it
virginial@email.it
Alla parità tra maschi e femmine non si arriverà mai, perché, non essendo in grado di generare, i maschi capiscono del mondo femminile unicamente quello che loro ritengono sia proprio della donna, e precisamente ciò che per natura a loro non è concesso. Svincolati dai ritmi della natura, i maschi, per occupare il tempo e non morire d’inedia nell’ozio, hanno inventato la storia, e in questa storia hanno inserito la donna come generatrice, madre dei loro figli, prostituta per le loro soddisfazioni sessuali e, a sentire Lévi-Strauss, il più grande antropologo del ’900, come merce di scambio nei loro traffici.
Un altro antropologo, Bronislaw Malinowski, riferisce che gli abitanti delle numerose tribù da lui visitate ignoravano il ruolo maschile nella generazione, e pur tuttavia, le donne da lui interrogate, rispondevano che tutti i figli assomigliano al padre, mentre la madre, genitrice riconosciuta dai suoi figli, non ha con essi alcuna somiglianza. La coppia parentale, "paritetica" nella riproduzione sessuale, diventa "gerarchica" nella rappresentazione sociale. A questo schema non sfugge neppure Aristotele per il quale "la femmina offre la materia e il maschio la forma", e neanche il mito cristiano di Maria Vergine, che con il suo corpo mette al mondo il figlio di Dio che di sé dice: "Io e il Padre siamo una sola cosa" (Gv. 10,30).
Questo impianto ideologico, che affonda negli abissi del tempo e della storia, governa ancora la mentalità maschile, che da qui prende spunto per esercitare il suo potere sul mondo femminile ridotto al rango di "materia", a proposito della quale Aristotele scrive: "La femmina desidera il maschio come la materia desidera la forma, il brutto desidera il bello".
A questo punto il dominio dell’uomo sulla donna appare come perfettamente "naturale", perché non c’è niente di più naturale e di più evidente del suo corpo fatto apposta per la generazione. Ebbene, proprio nella differenza tra il corpo dell’uomo e il corpo della donna si trova la prova inconfutabile del dominio del primo sulla seconda, di cui sono convinti non solo gli uomini, ma anche le donne che per secoli hanno trovato naturale il dominio esercitato su di loro da parte dell’uomo. Com’è noto, infatti, il potere non sta tanto nell’esercizio della sua forza, ma nel consenso dei dominati alla propria subordinazione.
È da questo consenso, quello dei subordinati, che lei si deve liberare. E liberandosi potrà persuadere la mente di qualche uomo e di qualche donna che la donna non è solo materia per la generazione e i piaceri sessuali, ma al pari dell’uomo può generare anche a un altro livello, quale può essere la realizzazione di sé nel mondo lavorativo, in quello culturale, persino in quello sessuale senza doversi ridurre alla pura e semplice opacità della materia. E se sente sopra di sé la disapprovazione di molti tra quanti le stanno intorno, sappia che dobbiamo fare a meno di mezzo mondo per poter generare il nostro mondo, che non è deciso solo dalla biologia al servizio della specie, perché la specie, come sappiamo, è interessata agli individui unicamente per la sua sopravvivenza. E dopo che hanno generato, nella sua crudeltà innocente, li destina alla morte, perché altri individui, nascendo e generando, le assicurino la sua vita.
-
> "AL DI LA’ DI DIO PADRE" E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. -- LA TEOLOGA DI BETANIA. Dalla Bibbia la lezione delle donne.19 dicembre 2016, di Federico La Sala
Per una teologia delle escluse.
Dalla Bibbia la lezione delle donne *
DOC-2829. SAN PIETRO IN CARIANO (VR)-ADISTA. Da quando, nel 1968, Mary Daly pubblicò il suo The Church and the Second Sex - pietra miliare del pensiero teologico femminista - il cammino verso la riscoperta del cristianesimo come movimento egualitario di uomini e donne ha fatto passi da gigante. In questo lungo percorso, di cui le donne sono state protagoniste, c’è chi si è occupata in primo luogo di recuperare la memoria di alcune figure bibliche, restituendo loro il ruolo che la Chiesa patriarcale aveva nei secoli occultato: pensiamo a Maria di Magdala, prima testimone della resurrezione, in seguito identificata come la peccatrice penitente; o a Giunia, che dal XII secolo fino all’attuale traduzione interconfessionale è citata con il nome maschile Junias; o a Maria, che da soggetto biblico è diventata un oggetto di devozione; o infine ad Eva, che da madre originaria è diventata la peccatrice originaria. C’è poi chi si è occupata di affermare il volto femminile di Dio, cercando nuovi modi di esprimere il divino. E anche chi, per andare “Al di là di Dio Padre”, ha ritenuto che fosse da superare questo approccio, poiché celerebbe quel dualismo - che vuole uomini e donne complementari, attribuendo loro caratteristiche che sarebbero proprie del sesso di appartenenza (e da cui derivano distinti ruoli sociali) - creato e utilizzato dal patriarcato per il mantenimento dello status quo.
Pensiamo a tutte quelle teologhe, come Elizabeth A. Johnson, che «sostengono che le donne sono in grado di rappresentare nella sua pienezza il mistero di Dio allo stesso modo, adeguato e inadeguato, in cui lo hanno fatto per secoli le immagini maschili».
Di questo percorso costituisce un tassello importante anche la ricostruzione della voce delle donne che emerge dai testi biblici. Un processo cui dà un contributo prezioso il volume La teologia delle donne alle quali Dio ha rivelato i suoi misteri di Sandro Gallazzi e Anna Maria Rizzante (Gabrielli Editori, pp. 314, euro 18; il libro può essere acquistato anche presso Adista, scrivendo ad abbonamenti@adista.it; telefonando allo 06/6868692; o attraverso il nostro sito internet, www.adista.it).
Sandro e Anna Maria vivono in Brasile, a Macapá, alla foce del Rio delle Amazzoni. Lui è membro del movimento biblico latinoamericano e del Centro Ecumenico di Studi Biblici (CEBI) e insieme ad Anna Maria lavora nella Commissione Pastorale della Terra a servizio dell’organizzazione dei movimenti sociali, difendendo l’ambiente e i diritti dei poveri.
Una prospettiva “dal basso” che è anche la cifra del volume, il quale nasce, come spiega nella prefazione Maria Soave Buscemi, teologa missionaria in Brasile, dalle «letture popolari e femministe frutto del cammino di liberazione che Sandro e Anna Maria hanno percorso tra i Poveri della Terra». Alle «teologie che diventarono teocrazie per legittimare re e sommi sacerdoti ed esigere tributi, offerte e sacrifici per alimentare santi e potenti, considerati, contemporaneamente, rappresentanti, mediatori e bocche, parlanti e mangianti, di un dio potente, altissimo e sempre insaziabile», Sandro e Anna Maria contrappongono, come spiegano nell’introduzione al volume, una «teologia che viene dalla “rivelazione”, che viene da un Dio che si lascia vedere, si lascia conoscere»: «È quello che Gesù ha detto, andando, come sempre, al contrario della logica ufficiale dei sacerdoti e dei dottori della legge: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai saggi ed agli esperti e le hai rivelate ai piccolini (Mt 11,25-26; Lc 10.21-22)”».
«Noi teologi/ghe non dobbiamo correre dietro a visioni di iniziati né a speculazioni di saggi», scrivono Sandro e Anna Maria: «Dobbiamo, semplicemente, aprire le nostre orecchie a quello che dicono, molte volte anche senza parole, coloro che una società escludente e ingiusta ritiene un avanzo, il “resto” che non serve più a niente. La teologia, così come la profezia, nascono dalla fedeltà al Dio dei poveri e dalla fedeltà ai poveri di Dio. Questa duplice e indissolubile fedeltà - proseguono - ci ha portato ad ascoltare con attenzione e con entusiasmo la sempre sorprendente e indescrivibile ricchezza della voce delle donne che esce dai testi biblici. Le donne, madri, sorelle, amanti, complici della vita, sono state capaci di conoscere e di parlarci di un altro Dio. A loro - scrivono Sandro e Anna Maria - dobbiamo tutte le maggiori e più belle rivelazioni sul “nostro” Dio. Gli uomini, dopo, hanno organizzato e sistematizzato queste rivelazioni e, stando al potere, molte volte, le hanno sfigurate, deturpate, hanno cercato di dimenticarle».
Ed è proprio il cammino di «de-costruzione di tutto il “potere sopra”, arrogante, violento e patriarcale», scrive Buscemi nella prefazione, il filo rosso che tiene insieme la ricchezza delle esegesi e delle ermeneutiche: «Un cammino - conclude Buscemi - che siamo invitati a compiere anche nelle nostre realtà di società e di chiese». Di seguito, uno dei capitoli che compongono il volume. (ingrid colanicchia)
LA TEOLOGA DI BETANIA
di S.Gallazzi e A. M. Rizzante
Betania è un bel nome, è la casa del povero. Un piccolo villaggio a pochi chilometri da Gerusalemme, dove si ospitavano i pellegrini che, come Gesù e i suoi amici, non potevano permettersi di soggiornare negli ostelli della città.
L’imperialismo romano sta dominando la terra di Israele. Il tempio, nelle mani dei sadducei, ne è complice silenzioso. La sinagoga degli scribi e dei farisei continua a incolpare il popolo per la sua incapacità di praticare tutte le norme della legge, ritardando così l’arrivo della salvezza sperata.
Condottieri popolari organizzano insurrezioni contro i governanti (At 5,36-37). La gente vive aspettando l’avvicinarsi della fine dei tempi e l’avvento dell’“unto” che porti la libertà (Mt 21,9; Gv 6,15; Mc 13,21-22).
Gesù di Nazareth, in questa situazione, ha annunciato un regno che è “già arrivato” e appartiene ai poveri e a coloro che sono perseguitati. Sconvolge ogni discriminazione, strappa tutte le barriere e proclama una vita di servizio, fratellanza e lotta contro tutte le forze demoniache del male.
Betania è il suo posto, nella casa di amici, come Lazzaro, Marta e Maria o come Simone il lebbroso. Da lì, la mattina presto, esce per andare a Gerusalemme e denunciare l’imperialismo romano, l’ipocrisia della sinagoga e la rapina legittimata dal tempio. La decisione dei potenti è stata presa: bisogna uccidere quest’uomo.
All’antivigilia della Pasqua, il tempio e la sinagoga decretano la condanna di Gesù (Mc 14,1-2). La morte di Gesù sarà facilitata da Giuda che lo consegnerà ai capi dei sacerdoti (Mc 14,10-11).
È in questo contesto di morte, decisa nella casa dei sommi sacerdoti (gli unti), che Marco inserisce la memoria della donna della casa di Betania. Nel cuore di questa memoria ci sono i poveri. Dopo tutto, questo è il vero motivo per il quale Gesù sarà condannato. La casa scelta è quella di Simone il lebbroso, qualcuno che ha sperimentato il rifiuto e l’emarginazione totale.
Mentre tutti sono a tavola, entra una donna. Non dice una parola; lei non ha neanche un nome. Arriva per ultima, senza essere invitata, non si siede al tavolo, ma la sua figura cresce sino ad arrivare all’altezza di quella di Gesù. D’ora in poi, quando sarà annunciato il Vangelo in tutti gli angoli del mondo, si dovrà parlare di lei e di quello che lei ha fatto (Mc 14,9).
Quello che questa donna ha fatto è il Vangelo, la buona notizia annunciata ai poveri!
Ma che cosa ha fatto? Ha rotto un vaso di alabastro che conteneva profumo di nardo puro, molto costoso, ed ha versato il profumo sul capo di Gesù.
Nella casa dei poveri si discute su cosa fare con i poveri. Molti ritengono che c’è stato uno spreco evidente. Sembra che siano stati buttati via trecento denari (lo stipendio di un anno di servizio di un lavoratore a giornata). Dopo tutto, se il profumo è buono, poche gocce bastano. Si scandalizzano. Si poteva vendere, raccogliere soldi e distribuirli ai poveri. Ottima idea! Potremmo anche essere d’accordo. Uomini di cuore buono preoccupati per i poveri.
Perciò questionano la donna, la censurano e, nel frattempo, mangiano! Lo sguardo di Gesù è più profondo. Prende la difesa della donna, chiede che la lascino in pace.
Perché? Perché lei ha fatto un’opera buona! Lei ha “unto” Gesù. Anche se la parola qui usata da Marco indica, soprattutto il “profumare” più che l’“ungere”, il gesto della donna ricorda l’“unzione” di re e sacerdoti (1Sam 10,1;16,13; 1Re 1,39; Es 29,7 Sal 133,2). Il riferimento al profumo puro e costoso, ricorda l’olio costoso dell’unzione sacerdotale (Es 30,22-33).
Ci sono due modi di rapportarsi ai poveri che avremo sempre con noi: cercare qualche ricco che possa comprare il nostro profumo, o utilizzare il nostro profumo per “ungere” i poveri.
Nel primo caso faremo elemosina e continueremo ad avere bisogno dei ricchi per aiutare i poveri e dei poveri per fare qualcosa per loro. I poveri saranno l’oggetto del nostro aiuto. Nel secondo, come ci ha insegnato la donna, annunceremo loro la buona notizia. Questo è tutto quello che possiamo fare.
I poveri “unti” recuperano così la coscienza di essere i prescelti e gli inviati a servizio del Regno. Diventano il soggetto della liberazione. Essi non devono essere liberati, sono loro i liberatori!
La donna riconosce nel povero Gesù, uomo povero di Galilea, l’unto, il messia che morirà per la salvezza di tutti. Mentre gli uomini sono preoccupati dei soldi. Il denaro del profumo non risolverà il problema dei poveri. Questa è un’illusione. Il testo si conclude con Giuda che riceverà “denaro” per consegnare il povero alla morte.
Bisogna saper “ungere” i poveri, proclamare e riconoscere che i poveri sono gli eletti di Dio, per realizzare il suo progetto.
Questa è la Buona Novella. È la stessa Buona Novella proclamata dal secondo Isaia nei cantici del Servo di Yahweh, la stessa Buona Novella proclamata in Isaia 61,1-3, la stessa buona notizia assunta e resa attuale da Gesù (Lc 4,18): Lo Spirito del Signore Jahweh è su di me, perché YHWH mi ha unto e mi ha mandato ad annunciare la buona novella ai poveri.
Pertanto, il Regno dei Cieli è loro, da adesso. Perché ci sono persone che, obbedendo allo Spirito, cercano prima di tutto il regno e la sua giustizia. Perché ci sono persone che, per questo, sono perseguitate fino alla morte.
Quando il povero è unto, vuol dire che è arrivato a noi il regno di Dio. Questa è la fede della donna che, nella casa dei poveri, unge Gesù e lo invia a compiere la sua missione fino alla fine, fino alla tomba, se necessario.
Questo è il bene che dobbiamo fare ai poveri che avremo sempre con noi. Questa è la sfida che la donna di Betania getta alla nostra fede.
Non basta credere nel Dio dei poveri; dobbiamo credere nei poveri di Dio. Tocca a noi e alle nostre ecclesiae scegliere “come” fare un’opera buona per loro.
Quando Giovanni ha raccontato questa storia (Gv 12,1- 8) si è preoccupato di modificare vari dettagli. È chiaro che il messaggio che la comunità di Giovanni ci ha voluto lasciare come Vangelo, sta proprio in questi cambiamenti. Cambia la data: “Sei giorni prima della Pasqua”. La Pasqua sarà il settimo giorno di una settimana che si aprirà nella casa di Betania. È la vigilia dell’entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme.
Cambia il luogo: è la casa di Lazzaro che Gesù ha appena fatto risorgere dai morti e che ora siede a tavola con Gesù. Cambia il contesto: è l’ora della cena e Marta sta servendo, mentre Maria è ai piedi di Gesù, nella sua mano c’è una libbra (325 grammi) di olio profumato di nardo puro, molto costoso.
E, soprattutto, cambia il gesto: unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli: e la casa si riempì della fragranza del profumo (Gv 12,3).
Non ci risulta che ci sia un altro testo nel Primo Testamento che metta in evidenza il gesto dell’unzione dei piedi. Il cambiamento è fondamentale: chi è venuto fuori con la testa unta è la donna, è Maria. E questo, come vedremo presto, in una realtà ecclesiale che stava mettendo a tacere le donne, togliendo loro tutto lo spazio nella comunità e nelle assemblee: non permetto a nessuna donna di insegnare o di avere autorità sull’uomo, ma stia in silenzio (1Tm 2,12).
Le donne che avevano “autorità” saranno esautorate per far posto a uomini unti: vescovi, diaconi e presbiteri, «in modo che la parola di Dio non sia bestemmiata» (Tt 2,5). In questo contesto, il Vangelo di Giovanni ci presenta una donna che, ponendosi come discepola ai piedi di Gesù, ha la sua testa unta. La discepola che ama è la vera autorità. Seguendo il suo esempio, Gesù, in un’altra cena, si metterà ai piedi dei suoi amici per lavare loro i piedi.
La narrazione di queste due cene finisce parlandoci del traditore (Gv 12,5;13,21). Tradimento, nella comunità, è quello di fraintendere e dimenticare la lezione di servizio e di amore offerta da questa donna. Qualsiasi altra autorità, da qualunque parte provenga, è un tradimento, anche se viene dal celebrare la cena. Non dimentichiamo che nel Vangelo di Giovanni l’unico che mangia il pane è Giuda (Gv 13,26-27). La cena di Betania è seguita dalla decisione dei sommi sacerdoti (unti sotto la benedizione dei Romani) di uccidere non solo Gesù, ma anche Lazzaro.
I due progetti, quello di Betania e quello del tempio, non possono convivere. Il tempio cercherà, sempre, di farci dimenticare Betania e la donna unta e i poveri unti. Il denaro nelle nostre tasche potrà essere lo strumento per realizzare questa distruzione. È Giovanni che, quando ci parla delle cene di Betania e di Gerusalemme, ci ricorda che il traditore «teneva la borsa del denaro» (Gv 12,6; 13,29).
Luca non ricorda l’episodio di Betania. Ci dice qualcosa, ma in contesti diversi. Ci racconta di un’altra casa, di Simone il fariseo che l’aveva invitato. Una peccatrice si avvicina, si prostra ai piedi di Gesù, comincia a piangere ed esprime il suo grande affetto baciando i suoi piedi, asciugandoli con i capelli e versando il profumo su di essi. È lo scandalo. Una peccatrice al nostro tavolo!
Dall’altra parte ci siamo noi, farisei, falsi, osservanti esternamente della legge, ma incapaci di amare, di abbracciare, di dare affetto. Luca ci vuole proprio provocare.
Questa donna, che doveva essere disprezzata da tutti, essere lo zimbello di tutti, è indicata da Gesù come esempio di qualcuno che “ha molto amato”. Un amore pieno di tenerezza e di pentimento annulla una moltitudine di peccati. I tuoi peccati sono perdonati! Altro scandalo per i farisei che siamo. Per ricevere il perdono dei peccati dobbiamo compiere i riti prescritti dalla legge. Per Gesù basta solo il pentimento ed un immenso affetto.
«La tua fede ti ha salvato, vai in pace». Questa è la lezione della donna. La fede non significa assenza di peccato. Se fosse così, nessuno di noi avrebbe fede. Fede è avere tanto amore. Amore sufficiente a coprire i nostri numerosi peccati. L’amore di questa peccatrice, l’amore delle donne che seguivano Gesù, l’amore di Maddalena, Giovanna, moglie del procuratore di Erode, l’amore di Susanna che mette le sue risorse a disposizione degli altri. Queste donne, insieme con i dodici sono il popolo di Gesù (Lc 8,1-3).
Luca ci ricorda anche che Marta accolse Gesù nella sua casa. Come in Giovanni, Marta stava facendo molti servizi e Maria stava seduta ai piedi di Gesù (Lc 10,38- 42). Il testo, tuttavia, parla di “un certo villaggio”, senza specificare che si tratta di Betania e non ricorda alcuna unzione fatta da Maria; osserva che lei stava “ascoltando la parola” con l’atteggiamento attento del discepolo.
Il mondo culturale greco-ebraico non prendeva in considerazione il fatto che una donna potesse essere discepola di qualche maestro. Discepolato, scuola erano solo per gli uomini; per le donne il meglio che si poteva pensare era un buon servizio nella casa degli uomini: questa era la donna ideale (Pr 31), questa era Marta. Lei richiama Gesù, perché non chiede a Maria di compiere il suo ruolo, di stare al suo posto di donna. Ai piedi di Gesù, ascoltando il suo insegnamento, dovevano esserci gli uomini. Se ai piedi di Gesù ci fosse stato Lazzaro, Marta non avrebbe avuto niente da ridire.
Maria, infatti, ha scelto la buona parte che non le sarà tolta (Lc 10,42). Nella casa di Marta la donna deve superare i condizionamenti sociali di una società maschilista e patriarcale e capire che il posto buono è quello di Maria. Questo è il buon lavoro che la donna deve fare. Questa è la parola esplicita di Gesù alle donne. Il resto lo sapremo stando seduti ai suoi piedi.
E Betania? Luca non ha dimenticato la casa del povero. Al contrario: Betania in Luca, sarà l’ultimo luogo dove Gesù ci conduce, dopo averci fatto capire le scritture ed averci dato le ultime istruzioni:
 Allora aprì loro la mente per capire le Scritture. Ed aggiunse:
«Così sta scritto: il Cristo doveva patire e il terzo
giorno risuscitare dai morti; nel suo nome saranno predicati
a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati.
Voi sarete testimoni di tutto questo, cominciando da Gerusalemme.
Ed ecco che io manderò su di voi quello che il
Padre mio ha promesso. Voi però restate in città, fino a
quando non sarete rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse
fuori, verso Betania e, alzate le mani, li benedì.
Allora aprì loro la mente per capire le Scritture. Ed aggiunse:
«Così sta scritto: il Cristo doveva patire e il terzo
giorno risuscitare dai morti; nel suo nome saranno predicati
a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati.
Voi sarete testimoni di tutto questo, cominciando da Gerusalemme.
Ed ecco che io manderò su di voi quello che il
Padre mio ha promesso. Voi però restate in città, fino a
quando non sarete rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse
fuori, verso Betania e, alzate le mani, li benedì.Mentre li benediceva, si separò da loro e veniva portato nel cielo (Lc 24,45-51). Gesù ci lascia a Betania. Da lì egli ritorna al cielo. Betania è il punto di contatto tra il cielo e la terra, tra Dio e noi. Da Betania Gesù può allontanarsi da noi, perché sa che a Betania lo troveremo sempre. Ogni volta che vogliamo stare con Gesù, basta andare a Betania, nella casa dei poveri, perché chi ha capito tutte le scritture, chi ha conosciuto il mistero di Cristo, chi vuol essere suo testimone in tutte le nazioni, sa che questo è il posto giusto.
 Le nostre chiese non devono mai allontanarsi da lì.
Le nostre chiese non devono mai allontanarsi da lì.* Adista Documenti, 24 DICEMBRE 2016 • N. 45
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- DIO NON E’ COSI’. Il guaio è che ben pochi tra le gerarchie ecclesiastiche sembrano rendersi conto di tutto ciò (di Vito Mancuso).5 ottobre 2015, di Federico La Sala
"DIO E’ SPIRITO": MA QUALE SPIRITO?!:
- "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-8).
 CARISSIMI, NON PRESTATE FEDE A OGNI SPIRITO ... DIO E’ AMORE (1 Gv., 4. 1-8)
CARISSIMI, NON PRESTATE FEDE A OGNI SPIRITO ... DIO E’ AMORE (1 Gv., 4. 1-8)
- KANT E SAN PAOLO. (federico la sala)
Cercando il vero Dio in un’immagine
Dopo la morte filosofica di Dio annunciata da Nietzsche e rilanciata da Heidegger, occorre constatare anche una morte estetica di Dio?
di Vito Mancuso (la Repubblica, 04.10.2015)
Rappresentare il creatore biblico è sempre stata la principale sfida nella storia dell’arte occidentale Dopo la morte filosofica di Dio annunciata da Nietzsche e rilanciata da Heidegger, occorre constatare anche una morte estetica di Dio? Credo sia sufficiente percorrere in senso cronologico un museo per rendersi conto del declino, per non dire tracollo, dell’arte sacra in occidente. All’inizio nei secoli medievali quasi ogni dipinto è una raffigurazione religiosa, poi con l’avvento del rinascimento compaiono anche soggetti profani, ma la religione rimane ancora la protagonista indiscussa: impossibile pensare Raffaello, Michelangelo o Caravaggio senza i loro soggetti religiosi.
Il Settecento con l’illuminismo segna la svolta, così che, anche quando l’interesse per la religione si ravviva con il romanticismo, l’iconografia tradizionale ormai non sa più parlare al sentimento contemporaneo e i tentativi di rivitalizzarla producono solo opere artificiali, in modo analogo alla neoscolastica nel campo del pensiero. Osservava in quegli anni Oscar Wilde: «Ogni imitazione, nella morale come nella vita, è errata». Quando poi la visita al museo ci avrà condotto alle sale del Novecento e della contemporaneità, i soggetti religiosi appariranno delle eccezioni.
Ma il punto è che anche l’arte sacra guidata dalle migliori intenzioni non raffigura quasi più i soggetti dove più risplende la gloria del divino, come Dio Padre o la Trinità. Ci si concentra quasi solo su Cristo, ma insistendo sulla sua dimensione umana, non su quella divina: Cristo è colui che soffre e che muore, non più il Pantokrator che domina il mondo come nella cattedrale di Monreale o nel duomo di Cefalù. Perché? Perché le immagini religiose di un tempo oggi appaiono estremamente improbabili nel loro comunicare Dio. Anzi, proprio mentre pretendono di rappresentare al sommo grado la gloria del divino dipingendo Dio Padre con il triangolo luminoso sulla testa, ne sono palesemente lontane. Fanno venire in mente il titolo di un celebre saggio teologico di John Robinson del 1963: Dio non è così.
Il punto è che “Dio è spirito”, come dice il vangelo (Giovanni 4,24) e come sostengono i grandi pensatori che hanno seriamente riflettuto al riguardo tra cui Platone, Aristotele, Origene, Agostino, Maimonide, Tommaso d’Aquino, Cusano, Hegel, e non è per nulla semplice, anzi è sostanzialmente impossibile, raffigurare lo spirito. Per questo osservava Montaigne: «È difficile portare le cose divine sulla nostra bilancia, senza che esse non ne soffrano un calo». Da qui l’implausibilità di tutte le opere artistiche che, a dispetto di ciò, cercano di rappresentare Dio.
Eppure il cristianesimo gioca gran parte del suo destino nell’impresa estetico-teologica. Esso infatti è la religione del Dio resosi visibile in forma umana e per questo, a differenza dell’ebraismo e dell’islam, ha sempre creduto nella possibilità di rappresentare il divino. Anche quando la Riforma protestante diede avvio a una sistematica distruzione delle immagini religiose, il cattolicesimo non smise mai di incoraggiare l’immaginazione artistica: nel nord Europa si distruggevano le immagini sacre, da noi Michelangelo dipingeva il Giudizio universale!
Nella capacità di tornare a esprimere in modo credibile la gloria del divino si determina in non piccola parte il futuro del cattolicesimo: se tornerà cioè a saper incidere nell’anima contemporanea, non solo in senso etico spingendola a essere buona, ma prima ancora in senso estetico, affascinandola per la sua bellezza e per la sua gloria. Il guaio è che ben pochi tra le gerarchie ecclesiastiche sembrano rendersi conto di tutto ciò.
- "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-8).
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- Ave Maria laica (di Vito MancusoI3 settembre 2013, di Federico La Sala
Ave Maria laica
di Vito Mancuso (la Repubblica, 2 settembre 2013)
Dopo l’Inchiesta su Gesù con Mauro Pesce (2006) e sul Cristianesimo con Remo Cacitti (2008), Corrado Augias giunge al tema delicatissimo di Maria, l’umile donna diventata con il tempo Madonna, cioè Mea Domina, Mia Signora, termine di origine aulica che prima di entrare nel lessico religioso ricorreva nella poesia cortese della Scuola siciliana e del Dolce Stil Novo. La guida cui Augias si affida per districarsi nel labirinto di testi sacri, dogmi, apparizioni e devozioni mariane è Marco Vannini, noto studioso di mistica e autore di numerosi saggi che sfidano la concezione tradizionale della religione.
Ho parlato di labirinto perché in effetti questa è la condizione della lussureggiante costruzione teologica e devozionale cresciuta nei secoli sulla base dei pochi passi evangelici concernenti la madre di Gesù. In singolare contrasto con la sobrietà biblica, la tradizione cattolica ha infatti elaborato la massima «de Maria numquam satis», «su Maria mai abbastanza», generando così più di 30 celebrazioni mariane all’anno, 4 dogmi, le 150 avemarie del Rosario (di recente diventate 200 con l’aggiunta di nuovi “Misteri”), le 50 Litanie lauretane e una serie sterminata di altre devozioni, chiese, ordini religiosi, antifone, musiche, immagini, santuari.
Leggendo il libro (che esce poco prima dell’arrivo a Roma, il 13 ottobre prossimo, della statua della Madonna di Fatima, una delle più celebri Madonne accanto a quelle di Loreto, Lourdes, Czestochowa, Guadalupe, Medjugorje) pensavo spesso al padre domenicano Yves Congar (1904- 1995), benché nel libro non sia nominato. Teologo stimatissimo, creato cardinale da Giovanni Paolo II per la preziosità del suo pensiero, Congar annotava nel diario tenuto durante il Vaticano II e pubblicato postumo nel 2002: «Mi rendo conto del dramma che accompagna tutta la mia vita: la necessità di lottare, in nome del Vangelo e della fede apostolica, contro lo sviluppo, la proliferazione mediterranea e irlandese, di una mariologia che non procede dalla Rivelazione ma ha l’appoggio dei testi pontifici » (22.9.61). Eccoci al punto critico: la vera fonte della proliferazione mariologica non è la Rivelazione, ma un singolare connubio tra potere pontificio e devozione popolare. Maria è sì «una madre d’amore voluta dal popolo» come scrive Augias, ma tale volontà popolare è stata sistematicamente utilizzata dal potere ecclesiastico per rafforzare se stesso: tra mariologia ed ecclesiologia il legame è d’acciaio.
Congar proseguiva: «Questa mariologia accrescitiva è un cancro» (13.3.64), «un vero cancro nel tessuto della Chiesa» (21.11.63). Il protestante Karl Barth aveva definito la mariologia «un’escrescenza, una formazione malata del pensiero teologico», il cattolico Congar indurisce l’immagine. Come spiegare il paradosso? Il fatto è che quanto più crescono il desiderio di onestà intellettuale, la fedeltà al dettato evangelico, la volontà di reale promozione della donna all’interno della Chiesa, tanto più decresce l’afflato mariologico con la sua tendenza baroccheggiante.
E ovviamente viceversa. Prova ne sia che nel protestantesimo, dove la dottrina su Maria è contenuta nei limiti indicati dal Vangelo, il ruolo della donna nella Chiesa è del tutto equivalente a quello del maschio (è di questi giorni la notizia che alla presidenza della Chiesa luterana degli Stati Uniti è giunta una donna), e viceversa nel mondo cattolico i più devoti a Maria sono anche i più contrari al diaconato e al sacerdozio femminile, basti pensare a Giovanni Paolo II.
Ma non era solo Congar, anche il giovane Ratzinger, allora teologo dell’università di Tubinga, scriveva nell’Introduzione al Cristianesimo del 1967: «La dottrina affermante la divinità di Gesù non verrebbe minimamente inficiata quand’anche Gesù fosse nato da un normale matrimonio umano», parole da cui appare che il dogma della Verginità di Maria non è per nulla necessario al nucleo della fede cristiana, e ovviamente meno ancora lo sono i dogmi recenti dell’Immacolata Concezione e dell’Assunzione. È l’opinione anche di teologi del livello di Rahner e di Küng.
Eppure sembra non ci sia nulla da fare: Ratzinger cambiò presto idea giungendo a fare della Verginità di Maria «un elemento fondamentale della nostra fede» e anche papa Francesco farà arrivare a Roma la statua della Madonna di Fatima consacrando il mondo al Cuore immacolato di Maria come già fecero Pio XII nel 1942, Paolo VI nel 1964, Giovanni Paolo II nel 1984, con i risultati, per quanto attiene al mondo, che ognuno può valutare da sé.
Tornando al libro in oggetto, la sua forza consiste nella ricchezza della documentazione e nella piacevolezza con cui viene offerta: i testi biblici vengono scandagliati con competenza filologica, si analizza lo sviluppo del culto mariano, i quattro dogmi, le preghiere tradizionali, i nessi con il culto mediterraneo della Grande Madre e con le altre religioni, la lettura femminista, le altre Marie dei Vangeli e in particolare la Maddalena, le apparizioni e in particolare quella di Lourdes del 1858 con le guarigioni miracolose attestate ancora oggi e quella di Fatima del 1917 con i famigerati tre segreti. Vi sono anche due dotti capitoli finali su Maria nell’arte, nella poesia, nella musica, nel cinema.
Il libro è solido dal punto di vista dei testi. Vengono citati Sant’Agostino in latino, l’esegesi dei testi del Vaticano II, si ricorda persino la setta di un certo Valesio sconosciuto ai principali dizionari teologici, anche se poi gli autori scrivono che nelle Scritture «nessun riferimento si fa mai alla sua miracolosa maternità verginale», dimenticando Matteo 1,18 secondo cui Maria «si trovò incinta per opera dello Spirito Santo» e Luca 1,35 che ribadisce il messaggio.
Ma il risultato dell’inchiesta alla fine qual è? La demolizione della dottrina tradizionale. Avversata da Augias fin dall’inizio, da Vannini è sì difesa («la devozione a Maria è segno di maturità spirituale») ma in modo inaccettabile per il cattolicesimo. Per esso infatti vi è una connessione inscindibile tra fatto storico-biologico e significato spirituale, mentre a Vannini interessa unicamente il secondo, per lui la verginità e maternità di Maria sono «non una storia esteriore ma una realtà interiore», e Maria è «l’anima che ha rinunciato all’amore di sé». Con ciò egli si colloca volutamente, come recita il titolo del suo ultimo saggio, oltre il Cristianesimo. Ne viene il paradosso di un libro sulla più cattolica delle dottrine scritto da un non credente e da un “oltrecristiano”! Ma questo, lungi dall’essere un difetto, è stata la condizione che ha concesso loro obiettività nel presentare lucidamente lo sterminato materiale sulla «fanciulla che divenne mito» e di offrire uno strumento utile e soprattutto onesto per ritornare alla verità evangelica su Maria.
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- Qual è il «sesso di Dio» spiegato ai bambini? Il ministro per la Famiglia tedesco, Kristina Schröder: «Dio diventi neutro: basta con il maschile»22 dicembre 2012, di Federico La Sala
 «Dio diventi neutro: basta con il maschile»
«Dio diventi neutro: basta con il maschile»
 Berlino, lite sul sesso di Dio
Berlino, lite sul sesso di Dio
 La ministra: «Sia neutro»
La ministra: «Sia neutro» di Paolo Lepri (Corriere, 22.12.2012)
di Paolo Lepri (Corriere, 22.12.2012)- «Dio deve diventare neutro: basta indicarlo con il maschile». Il ministro per la Famiglia tedesco, Kristina Schröder, cristiano-democratica, nota per le battaglie contro il femminismo, in un’intervista ha detto di trovarsi in imbarazzo con la sua piccola Lotte, un anno e mezzo, parlando di Dio.
BERLINO - Qual è il «sesso di Dio» spiegato ai bambini? Non si tratta di un dibattito teologico-grammaticale che potrebbe escludere quel 16 per cento della popolazione mondiale che secondo un recente studio del «Pew Forum on Religion and Public Life» si professa non credente.
È qualcosa di più, e riguarda tutti coloro che hanno figli piccoli, perché il problema del «genere» nell’educazione infantile è ormai all’ordine del giorno in molti Paesi europei. Lo dimostra la proposta del governo francese di inserire nel libretto di famiglia la dizione «genitore 1» e «genitore 2» al posto del padre e della madre, e il riaffacciarsi in Svezia del pronome neutro per sostituire il «lui» e il «lei» nell’asilo.
In Germania, è stato il ministro per la Famiglia, Kristina Schröder, cristiano-democratica, nota per le sue battaglie contro il «femminismo storico», a fare discutere tutti. In questo caso, si è iniziato a parlare di religione, ma il vero scontro è sulla figura dell’uomo e della donna nell’immaginario dei bambini.
In un’intervista al settimanale Die Zeit, Kristina Schröder ha detto di trovarsi in imbarazzo con la sua Lotte (un anno e mezzo) parlando di Dio al maschile, come avviene nella lingua tedesca, e ha aggiunto che sarebbe meglio usare l’articolo «das», con cui si precedono i nomi di genere neutro. «Ciascuno - ha detto - dovrebbe decidere per conto proprio». Una riflessione, questa, che è stata accompagnata da critiche al «sessismo» delle fiabe e della letteratura per bambini in cui «raramente si trovano figure positive di donne».
Le parole della Schröder sono state accolte con una raffica di proteste. Christine Haderthauer, ministro per gli Affari sociali della Baviera, le ha definite una «sciocchezza intellettualistica». Un altro esponente cristiano-sociale, il parlamentare Stefan Müller, ha osservato che «Dio appare a noi come il Padre di Cristo e così dovrebbe rimanere». Secondo un eminente teologo cattolico, padre Wilhelm Imkamp, l’idea di rendere neutro il Padreterno è «stupida, insolente e testimonianza di opportunismo».
L’unico a gettare acqua sul fuoco è stato Klaus-Peter Willsch, parlamentare della Cdu nell’Assia (il Land dove Kristina Schröder sarà capolista nelle elezioni del prossimo autunno), suggerendo che «per chi cerca una figura di genere neutro, c’è Gesù Bambino». Alla parola Christkind, infatti, si accompagna «das». «Per chi crede in Dio l’articolo è indifferente», ha risposto il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert, durante il consueto briefing del governo.
Secondo un collaboratore di Kristina Schröder, Benedetto XVI «ha scritto che Dio non è né uomo né donna» e quindi «i critici del ministro non dovrebbero essere più "papali" del Papa». E lei, la diretta interessata? Ha ricordato alla Bild che si stava riferendo ad una bambina e non ai tanti adulti «inciampati» sulle sue parole. Ma non è detto che tutto finisca qui.
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- E DEL BIOLOGISMO TEOLOGICO POLITICO. I legami biologici sono (ancora!) il modello sul quale sono concepite le relazioni di genitorialità (di Sylviane Agacinski - Due madri = un padre?).3 febbraio 2013, di Federico La Sala
Due madri = un padre?
di Sylviane Agacinski*
in “Le Monde” del 3 febbraio 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
Nulla illustra meglio la coriacità della dissimmetria dei sessi del modo in cui ognuno affronta la questione della procreazione. Come tutti, anche gli omosessuali affrontano tale questione e, fino ad ora, non avevano altra possibilità che rivolgersi ad una persona dell’altro sesso.
Ciò che è cambiato, al punto da far emergere la nozione di omogenitorialità, è la possibilità, almeno apparente, di far a meno dell’altro sesso per “avere” dei figli, come si sente dire così spesso alla radio: l’attrice celebre tal dei tali “ha avuto dei figli con la sua compagna”. Quasi si dimentica ciò che questa meravigliosa “performance” deve alle tecniche biomediche e al donatore di sperma anonimo che ha dato il suo contributo in Belgio o in California.
Ma il dono di sperma e l’inseminazione artificiale sono da tempo praticati in Francia per coppie “classiche” nel quadro della procreazione medicalmente assistita (PMA) senza che questo turbi più di tanto o che ci si interroghi sulla trasformazione delle persone che danno la vita con semplici materiali biologici anonimi mentre i figli diventano prodotti fabbricati su richiesta e, di conseguenza, in certi paesi, delle merci. Oggi conosciamo gli effetti devastanti che possono esserci sui figli in seguito alla decisione deliberatamente assunta di mantenere il segreto sulla persona del loro genitore, anche quando un padre legale esiste ed ha svolto pienamente il suo ruolo.
Così, la prima riflessione che si impone alle nostre società moderne, prima di qualsiasi costruzione legislativa sulle modalità della filiazione, riguarda la distinzione, fondamentale nel diritto, tra le persone e le cose. Il filosofo Hans Jonas considerava la responsabilità degli esseri umani nei confronti della loro progenitura come l’archetipo della responsabilità. I donatori di sperma e le donatrici di ovociti sono innanzitutto degli esseri umani: si dice che donano delle cellule ad “una coppia”, in realtà contribuiscono a dare la vita ad un figlio, e quest’ultimo un giorno lo saprà e ne chiederà conto.
Non per avere o non avere sofferto nell’infanzia, ma perché, essendo egli stesso persona, vorrà sapere da quali persone proviene e qual è la sua storia umana. Per questo è necessario intraprendere una riflessione globale sul ruolo della medicina procreativa e sulle condizioni etiche delle sue pratiche, indipendentemente dalle coppie a cui sono destinate queste pratiche. Un progetto di legge sulla famiglia non può certo sostituire tale riconsiderazione totale. Rivolgendosi al Comitato consultivo nazionale di etica, il presidente della Repubblica va nella giusta direzione. Il problema è diverso per gli uomini - a causa della dissimmetria sessuale -, perché la procreazione omogenitoriale necessita di un dono di ovociti e dell’uso di “gestanti per altri” (“madri in affitto”).
Anche qui, la pratica non riguarda solo le coppie gay. Ma sono loro che militano più attivamente per la sua legalizzazione, ad esempio tramite il gruppo Homosexualité et socialisme o le associazioni LGBT (lesbiche, gay, bi e trans). A questo riguardo, le posizioni del governo sembrano chiare. Esso esclude ogni legalizzazione dell’uso di donne come “gestanti per altri”, consapevole della mercificazione del corpo che inevitabilmente comporta, con lo sfruttamento di donne socialmente fragili, come avviene in altri paesi.
Ma allora è inquietante e incoerente che Dominique Bertinotti, la ministra delegata per la famiglia, si ostini ad annunciare che continuerà ad esaminare tale questione; o che la ministra della giustizia, in una circolare almeno inopportuna, conceda un certificato di nazionalità ai figli nati da “gestanti per altri” all’estero. Bisogna sapere che i bambini nati in questo modo hanno uno stato civile emesso dal paese in cui sono nati, che non sono affatto sprovvisti di documenti di identità e che possono condurre una vita familiare normale. Non si potrebbe comprendere il fatto che, per vie indirette, si dia alla fine ragione a coloro che aggirano deliberatamente la legislazione in vigore.
Ma non spetta innanzitutto agli stessi futuri genitori interrogarsi sul loro percorso e sul loro progetto? E innanzitutto alle donne, poiché esse possono fin d’ora ordinare su internet dei campioni di sperma. Le tariffe delle “banche di sperma” sono disponibili on line, con le foto e le caratteristiche dei donatori. Un altro campo di riflessione riguarda l’omogenitorialità come nuovo modello di filiazione. Il principio di un matrimonio aperto a tutte le coppie unisce ampiamente i francesi, mentre il principio dell’omogenitorialità li divide.
Uno statu quo conservatore non avrebbe senso. Sì, è possibile istituire un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questa innovazione è auspicabile poiché contribuirà ad assicurare un pieno riconoscimento sociale alle coppie omosessuali che lo attendono. Ma trasforma il significato dell’antico matrimonio, nella misura in cui il suo principale effetto era la presunzione di paternità dello sposo, che non ha senso per una coppia dello stesso sesso.
La presunzione di paternità non è scomparsa dal matrimonio moderno, ma esso è profondamente cambiato. Ad esempio, i diritti di tutti i figli si basano ormai sulla definizione della loro filiazione civile, cioè sul collegamento con i genitori che li hanno concepiti e/o riconosciuti, sposati o no. La colonna vertebrale della famiglia è così la filiazione, mentre il matrimonio dei genitori diventa in qualche modo accessorio.
In questo contesto, ci si chiede se la vera uguaglianza non sarebbe applicare a tutti gli stessi diritti: quello di sposarsi per gli adulti e, per tutti i bambini, una filiazione stabilita secondo gli stessi criteri e le stesse regole. Ma non sarebbe così nel caso in cui si distinguesse una “omogenitorialità” ed una “eterogenitorialità”, ossia due genitori dello stesso sesso o di sessi diversi.
La capacità di chiunque di essere un “buon genitore” non è evidentemente in discussione. Del resto, molti omosessuali hanno figli con un partner dell’altro sesso, e non pretendono di fondare la loro paternità o la loro maternità sulla loro omosessualità. Al contrario, l’omogenitorialità significherebbe che l’amore omosessuale fonda la genitorialità possibile e permette di sostituire l’eterogeneità sessuale del padre e della madre con l’omosessualità maschile o femminile dei genitori.
Le formule, divenute correnti, di genitori gay e lesbici significano la stessa cosa. E quando la ministra della famiglia annuncia che bisognerà interrogarsi sulle “nuove forme di filiazione sia eterosessuali che omosessuali, sostituisce anche al carattere sessuato dei genitori il loro orientamento sessuale. Così, si tratta proprio di creare un nuovo modello di filiazione.
Secondo il modello tradizionale, un figlio è unito ad almeno un genitore, generalmente la madre che lo ha messo al mondo, e se possibile a due, padre e madre. Anche nell’adozione, la filiazione legale riproduce analogicamente la coppia procreatrice, asimmetrica ed eterogenea. Ne mantiene la struttura, o lo schema, ossia quello della generazione biologica bisessuata.
In questo modo si può comprendere l’antropologo ed etnologo Claude Lévi-Strauss quando scrive che “i legami biologici sono il modello sul quale sono concepite le relazioni di genitorialità”. Ora, si noterà che questo modello non è né logico, né matematico (del tipo: 1+1), ma biologico, e quindi qualitativo (donna + uomo) perché i due non sono intercambiabili. È la sola ragione per la quale i genitori sono due, o formano una coppia.
Anche se questa forma non è sempre soddisfatta (ad esempio quando un bambino ha un solo genitore o è adottato da una sola persona), la differenza sessuale è simbolicamente indicata, cioè nominata dalle parole “padre” o “madre” che designano persone e posizioni distinte. Questa distinzione inserisce il bambino in un ordine in cui le generazioni si succedono grazie alla generazione sessuata, e la finitezza comune gli è così significata: poiché nessuno può generare da solo facendo sia da padre che da madre.
Allora, si pone la domanda di sapere che cosa viene significato al bambino unito, per ipotesi a due madri o a due padri. Un cumulo simile significa che due padri possono sostituire una madre? Che due madri possono sostituire un padre? Una lesbica militante, che non vuole aggiungere un padre alla sua coppia femminile, dichiara in un negozio: “Due genitori bastano”. E un’altra: “Io non voglio sobbarcarmi un padre per essere madre”. Come non sentire qui un diniego virulento della finitezza e dell’incompletezza di ciascuno dei due sessi?
Il timore che si può esprimere qui, è precisamente che due genitori dello stesso sesso simbolizzino, ai loro occhi, come a quelli dei loro figli adottivi (e ancor di più a quelli che sarebbero procreati con l’aiuto di materiali biologici), un diniego del limite che ciascuno dei due sessi è per l’altro, limite che l’amore non può cancellare.
* Sylviane Agacinski: filosofa, ha insegnato alla Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales dal 1991 al 2010. Ha lavorato sulla questione della differenza sessuale e della controversia sessuale nella democrazia (“Politique des sexes”, Seuil 2002), nella teologia (“Métaphysique des sexes”, Seuil 2005) e nel teatro (“Drame des sexes”, Seuil 2008). Con “Corps en miettes” (Flammarion, 2009) critica la mercificazione del corpo umano e contesta la riduzione del sesso al genere in “Femmes entre sexe et genre” (Seuil, 2012).
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- IL DISEGNO DI RATZINGER: IL SOGNO DI UNA "COSA" DI BENEDETTO XVI13 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- L’alleanza si è rotta. La Chiesa non abbia paura delle donne (di Emma Fattorini)11 febbraio 2012, di Federico La Sala
-L’alleanza si è rotta La Chiesa non abbia paura delle donne
di Emma Fattorini (l’Unità, 11 febbraio 2012)
La donna è più predisposta a quell’unità di vita tra piccolo e grande, tra dentro e fuori, tra interiorità ed esteriorità che è il modo contemporaneo in cui Cristo ci appare oggi. In un tempo come il nostro nel quale è forte la scissione tra le affermazioni di principio e i comportamenti pratici, anche tra i cristiani che tanta fatica fanno a raggiungere una unità di vita.
Però, come non credo all’inferiorità femminile, non credo neanche ad una superiorità della donna neppure nel rapporto con Gesù. Credo invece, profondamente, in un’assoluta parità della donna con l’uomo, ma una parità così radicale da consentire una sua altrettanto radicale differenza con lui. Una differenza anche nel loro rapportarsi a Dio. Una differenza che purtroppo gli uomini, tutti, anche quelli di Chiesa hanno tradotto, banalmente, con inferiorità. Un errore, ma direi di più: un vero e proprio peccato che non solo Gesù non commise mai, ma dal quale proprio e solo lui, in tutta la storia umana, ha aiutato davvero ad affrancarci, cambiandone il segno.
Questo non è ciò che avviene nella Chiesa. Le suore oggi sono consapevoli dell’assurdità di questa posizione, dell’errore enorme, della perdita secca che, non loro, ma il mondo maschile della Chiesa subisce nel non valorizzare il femminile. Qualcosa che non può dominare, controllare e che pure sarebbe una ricchezza e una benedizione per lui e per la Chiesa.
Credo che la Chiesa rischi di perdere l’occasione storica di una grande, potente, alleanza con il genere femminile. La Chiesa, lungo la sua storia, si è alleata tante volte con le donne: nei momenti in cui si è sentita sconfitta, ad esempio dopo la rivoluzione francese, o in i tutti i passaggi cruciali del processo di secolarizzazione, si è sempre alleata con quel senso di pietà religiosa che la donna riusciva a fare vivere in casa comunicandola ai propri uomini, ai figli, al proprio marito sempre più lontani dalle pratiche religiose. Si trattava di una devozione mai disgiunta da un profondo e rigoroso cambiamento interiore, fatto di onestà, formazione del carattere e coerenza. Ecco allora, ancora una volta, la capacità femminile di tenere uniti il dentro e il fuori.
Poi, con il processo di emancipazione femminile, dalla fine dell’Ottocento in poi, questa alleanza si è spezzata: la donna è diventata sempre di più veicolo e metafora della modernità vista solo nei suoi pericoli, in primo luogo la libertà dell’individuo.
Oggi questo processo è giunto agli esiti più estremi. Quello che papa Wojtyla ha chiamato svolta antropologica, che non è quella bandiera ideologica rinfacciata su tutti i fronti. Lui l’assume, fin dal tempo in cui, lavorando al Concilio contribuì al n. 22 della Gaudium et Spes in questi termini:
Cristo svela pienamente l’uomo all’uomo, perché solo nel mistero del Verbo anche il mistero dell’uomo incarnato trova vera luce. Dio ha posto nell’uomo un seme di eterno. Cioè Cristo aiuta l’uomo ad essere pienamente uomo e qui Wojtyla aggiunge che, in questo passaggio, la cooperazione femminile è fondamentale, essenziale. È fondativa, non accessoria o secondaria.
Oggi la libertà soggettiva e i diritti individuali sono la cultura dominante, come a fine Ottocento fu la questione sociale. E come allora la Chiesa riuscì a farsene carico con una dottrina sociale capace di rispondere in avanti alle domande del collettivismo socialista e dell’individualismo liberale, così deve fare ora con il tema delle libertà individuali.
E la donna da minaccia suprema potrebbe essere la più preziosa alleata.
Vorrei dire molto serenamente ai nostri sacerdoti e alle nostre gerarchie: non dovete avere paura del rapporto vero con le donne. E questo significa in primo luogo che, quando si parla giustamente e inevitabilmente di valori irrinunciabili, l’etica, che ne è il fondamento, si può fondare solo sull’amore e non sullo scambio politico: quello, lo sappiamo bene, ci vuole, sarebbe dannosamente ingenuo ignorarlo. Ma non è mai, assolutamente mai il patteggiamento politico a dovere avere l’ultima parola. E questo non per purismo imbelle ma perché, semplicemente, non funziona. Le donne possono essere il centro propulsore di una sorta di nuova costituente antropologica, in cui in nome di un comune umanesimo, che non può esistere se non è anche un umanesimo femminile, si possono trovare più ragioni comuni con i non credenti che argomenti di divisione. Due sono i vizi da evitare perché questo sia possibile: la colpevolizzazione o il moralismo, ne abbiamo avuti tanti esempi in questi dieci anni e abbiamo visto come siamo finiti.
Nel nuovo protagonismo dei cattolici nella politica italiana le donne possono essere centrali, quale ponte e dialogo con i non credenti, possono essere pilastri di una nuova cooperazione. E, invece, come sono apparse le donne sulla scena pubblica nell’ultimo ventennio? O come corpi mercificati, o come fattori divisivi dei valori non negoziabili.
Eppure è altro lo spazio per le donne.
È chiaro ormai per tutti che la crisi del mondo occidentale è etica prima che economica. Ma se nuove regole, una stessa nuova etica non cresce e matura dall’interiorità, dalla maturità complessiva delle persone non potremo mai risollevarci. È irrealistico, prima che sbagliato, pensare ai bisogni dei giovani, i più penalizzati dalla crisi, come pure opportunità di occupazione. Lo so, sembra da pazzi, eppure è proprio adesso, quando la situazione materiale si fa più difficile, che la forza interiore dell’amore e della generosità diventa potente per sperare e progettare, per essere onesti e generosi. Un sentire che dobbiamo comunicare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di un Occidente ormai neppure più sazio ma solo disperato.
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- VERGINI MADRI MARTIRI O SUORE.17 giugno 2011, di Federico La Sala
- DAL DISAGIO ALLA CRISI DELLA CIVILTA’: FINE DEL "ROMANZO FAMILIARE" EDIPICO DELLA CULTURA CATTOLICO-ROMANA.
Vergini, madri martiri o suore
di Natalia Aspesi (la Repubblica/Velvet, n. 56, luglio 2011)
Che uomini e donne siano diversi lo sappiamo, e ne siamo contentissime; però dovrebbe essere scontato che abbiano gli stessi diritti (e doveri), ma in realtà non è ancora così, questo lo sappiamo, sulla nostra pelle.
Michela Murgia nel nuovo bel libro “Ave Mary” ci ricorda che, nella Mulieris Dignitatem, Giovanni Paolo II, esaltando l’originalità femminile, ha confermato che comunque l’uomo e la donna sono pari in dignità davanti a Dio. Menomale. Questa dignità è intaccata, secondo me non credente, dal modo in cui la Chiesa, negando l’uguaglianza, intende la differenza, che non è quella sostenuta da una parte del femminismo.
E’ chiaro che le donne continuano ad essere imbarazzanti, poco gestibili, per la Chiesa, soprattutto per i papi. Non so quante donne, in questo caso credenti, aspirino alla santità, ma se ce ne sono, sappiano che la strada sarà meno ampia che per gli uomini. Per esempio, durante 27 anni di pontificato, Giovanni Paolo II ha canonizzato 482 persone, di cui 248 laici: fondatori di banche e associazioni caritatevoli, politici, eroici carabinieri e altri beatificati o nominati servi di Dio. Tutti maschi.
Papa Wojtyla, scrive la Murgia, “ha elevato agli altari molte donne, soprattutto martiri, ma anche suore comuni e fondatrici di ordini religiosi. Solo una non aveva preso voti ...”. Gianna Beretta Molla, qualificata dal sito del Vaticano come “madre di famiglia”, santa nel 2004: medico, cattolica praticante come il marito, madre di tre bambini, nel ’61, a 39 anni, durante la quarta gravidanza, le fu riscontrato un voluminoso tumore benigno che richiedeva l’asportazione immediata, il che avrebbe comportato l’interruzione della gravidanza. La signora rifiutò, anche se in un caso come il suo la Chiesa, pur giudicando l’aborto un male, l’avrebbe considerata incolpevole: nacque una bellissima bambina e la madre morì. Esaltando con la canonizzazione il martirio che lasciava un padre solo con quattro figli, si mostrava che la nuova via alla santità femminile era la maternità, soprattutto se costava la vita. Non si conoscono maschi fatti santi per aver accettato di essere padri sino al sacrificio di sé.
Più facile diventare sante in quanto suore, com’è stato per Madre Teresa di Calcutta, cui è stato assegnato il Nobel per la Pace ’79, per aver dedicato la vita ai poveri e agli ultimi del mondo. Quanto alla santità, certo è stata affrettata dalla sua guerra ad aborto, contraccezione, divorzio. Comunque la santificazione femminile privilegia le “morte in verginità”, le donne che, per difendersi dallo stupro, sono state ammazzate. Ovviamente Maria Goretti, non più indicata alle adolescenti come modello, e Antonia Mesina, “martire della purezza”, sedicenne sarda fatta fuori a colpi di pietra dall’assalitore, e altre.
La santità delle donne laiche, e non quella degli uomini, passa insomma attraverso la morte, eventuali opere di bene contano niente.
- DAL DISAGIO ALLA CRISI DELLA CIVILTA’: FINE DEL "ROMANZO FAMILIARE" EDIPICO DELLA CULTURA CATTOLICO-ROMANA.
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!!27 maggio 2011, di Federico La Sala
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- "AVE MARY". Michela Murgia e il suo saggio: dalle Madonne di ieri e di oggi (di Natalia Aspesi) - Quando le italiane si ripresero il corpo e la storia cambià (di Miriam Mafai)12 maggio 2011, di Federico La Sala
Michela Murgia e il suo saggio: dalle Madonne di ieri e di oggi fino agli stereotipi patriarcali
Madre nostra dove sei nei cieli?
“Eva e Maria, così la Chiesa ha sacrificato la donna"
"Ave Mary" intreccia Sacre scritture e vita. E ricorda come una certa teologia ignori le immagini femminili di Dio
La scrittrice sarda, che è credente, smitizza Madre Teresa di Calcutta e cita Giovanni Paolo I
di Natalia Aspesi (la Repubblica, 12.05.2011)
Pare di sentire il sussurro di decine di computer con cui geniali signore stanno scrivendo libri sugli errori e gli orrori del mondo verso le donne, e la fonte di tali orrori-errori, perpetrati ovviamente dagli uomini, sembra inesauribile: è un boom attuale che aveva già trionfato negli anni del femminismo militante e vincente, e poi si era spento verso la metà degli anni ’90, quando una valanga di altre intrepide signore, adattandosi all’intorpidimento generale, si era messa a scrivere sulle meraviglie del mondo verso le donne, tipo come fare shopping, come non restare single, come assomigliare alle top model, cosa fare proficuamente a letto.
Da un paio di anni per fortuna c’è stato un risveglio di brontolii femminili colti, intelligenti, creativi, appassionanti, impeccabili, sotto forma di saggi di successo, che entusiasmano i maschi più maschilisti (tanto sanno che non cambia nulla) e vengono regolarmente massacrati dai talk-show rimasti ancorati alla necessità di banalizzare sia l’esposizione del corpo delle donne che la loro lapidazione, per essere sicuri di fare audience.
In questo fervore di scrittura femminile molto terrena, che chiama in causa i poteri contemporanei, la politica, la televisione, la pubblicità, le escort e le ministre col tacco a spillo, appare finalmente il personaggio più inaspettato, umano e celestiale, antico ed eterno, celebre e sconosciuto, mitico ed universale, da imitare e inimitabile: la Madonna, Maria di Nazareth, per Michela Murgia semplicemente Mary: Ave Mary, come si intitola il suo nuovo libro (Einaudi Stile libero), sottotitolo "E la chiesa inventò la donna".
Si sa che la scrittrice sarda, 39 anni, che con il suo romanzo Accabadora ha vinto il Campiello, il SuperMondello e il Dessì, è una credente «organica, non marginale», come si definisce lei, che rivendica il diritto di critica dall’interno della Chiesa che, con gli ultimi due papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, sta vivendo una lunga continuità conservatrice. E mentre racconta l’uso spesso distorto che è stato fatto e si continua a fare di Maria di Nazareth, la placida e ferrea signora di Cabras ricorda quanto sia ancora difficile per le Mary di oggi, credenti e no, fuori e dentro la Chiesa, sfuggire agli stereotipi incongruentemente patriarcali, essere davvero libere.
Per secoli la Madonna ritratta dagli artisti è stata una giovane madre bellissima, talvolta anche carnale, addirittura a seno nudo, riccamente abbigliata, con in braccio il suo bambino: vengono per esempio in mente la rinascimentale Adorazione dei magi di Jan Gossaert attualmente nella mostra dedicata all’artista cinquecentesco fiammingo alla National Gallery di Londra; oppure la meravigliosa Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, una affascinante popolana dall’abito scollato, che incrociando le gambe e tenendo in braccio il suo piccino, si affaccia curiosa da una porta. Poi, dalla metà del XIX secolo, con i nuovi dogmi mariani e i veggenti di Lourdes e di Fatima, Maria smise di essere madre, lasciò da qualche parte il suo piccino, si vestì solo di bianco e azzurro, adombrando il viso dentro un velo, si sistemò su una nuvola con le mani raccolte in preghiera, rivolse gli occhi al cielo e assunse un’espressione afflitta, quella della Mater Dolorosa, che in altre raffigurazioni luttuose si sarebbe inginocchiata ai piedi del figlio crocefisso.
Finalmente si era trovato il vero destino delle donne, un’ascesa verginale alla solitudine e alla sofferenza, per accollarsi la sofferenza degli altri, prendersene cura e nel caso personale di Maria, assistere al sacrificio del figlio, in un moltiplicarsi di drammatiche Pietà che, come quelle di Michelangelo, non intaccano la giovinezza della Madre, rimasta sedicenne, ad accogliere sul suo grembo il corpo martoriato del figlio trentenne. Non esistono immagini della Madonna vecchia, (e neppure morta) se non di sfuggita in qualche film non convenzionale, e non si vorrebbe essere blasfemi imputando anche a questa scelta santa il fatto che pure oggi, anzi soprattutto oggi, invecchiando le donne sembrano scomparire nel nulla, perdere senso e potere.
Ancora è difficile capire per quale ragione a un certo punto della storia del mondo le donne furono considerate nemiche del genere umano, e per terrorizzarci Murgia cita l’incazzatissimo apologeta Tertulliano, vissuto tra il II e il III secolo: «Ogni donna dovrebbe camminare come Eva nel lutto e nella penitenza...La condanna di Dio verso il tuo sesso permane ancora oggi... Tu sei la porta del demonio! A causa di ciò che hai fatto il figlio di Dio è dovuto morire!».
Ogni fregatura femminile nei secoli è dunque partita dalla disubbidiente Eva (e infatti le donne ancora oggi si sentono dire dai maschi di famiglia, ubbidisci!, segue gestaccio da parte delle signore) e dal suo peccato originale, che fece cacciare Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre e condannò l’uomo a lavorare con sudore e la donna a partorire con dolore. Quando dalla metà dell’800 la scienza cominciò a studiare la possibilità di separare il parto dal dolore con l’anestesia (e dal 1930 con l’epidurale), il dibattito teologico, tutto maschile, si fece rovente; come osava la scienza eliminare la punizione divina obbligatoria per le donne? Finalmente nel 1956 Papa Pio XII definì "non illecito" il parto indolore, anche se la maternità dolorosa restava la maledizione specifica per le figlie di Eva. A me pare che nessun teologo andò in crisi quando il diffondersi delle macchine aiutò gli uomini a non faticare e quindi a non sudare.
Michela Murgia ha una cultura teologica vasta e una avventurosa esperienza di vita: ha lavorato in un call center e ha fatto il portiere di notte, l’insegnante di religione, la venditrice di multiproprietà, l’animatrice dell’Azione Cattolica, la dirigente di una centrale termoelettrica, è stata per anni lo scandalo del suo paese andando a vivere col suo fidanzato, (ignominia!) poi sposandolo civilmente (che è sempre peccato!), infine, cristianamente convinta, in chiesa.
Ave Mary intreccia sapienza e ironia, Sacre Scritture e vita, non dando tregua a tutti gli errori e le stupidaggini che credenti chic e atei devoti hanno scritto e soprattutto diffuso attraverso la televisione. Smitizza Madre Teresa di Calcutta, premio Nobel per la Pace, beatificata, essenziale esempio di femminilità sacrificale, che per la Chiesa cattolica «non rappresentava solo una campionessa di carità, era soprattutto una vestale della sua dottrina morale sulla vita, quella che maggiormente interferiva con la libertà delle donne di disporre di sé stesse».
Rilegge per noi Mulieris Dignitatem, il documento del 1988 in cui Giovanni Paolo II usa per la prima volta l’espressione "genio femminile": e rifiutando l’eguaglianza tra uomo e donna, sceglie la differenza, come una parte importante del femminismo, però riconfermando la subordinazione sociale e familiare della donna, «non più enunciata in nome di una inferiorità di genere, ma fondata su una pretesa superiorità di ruolo spirituale...».
Darà certamente fastidio al rumoroso e ingombrante divismo dei nostri atei devoti, la grazia con cui ricorda come la Chiesa abbia deliberatamente ignorato nella Bibbia le decine di immagini femminili di Dio, «privando le donne del diritto di riconoscersi immagine di Dio, in un Dio che fosse anche a loro immagine». E il modo malizioso in cui rispolvera una frase molto pericolosa pronunciata nel 1978 da quel povero Giovanni Paolo I dal brevissimo papato: «Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile: è papà, più ancora è madre». Panico in Vaticano, terrore di uno spaventoso abisso teologico e simbolico, subito sepolto con la morte di papa Luciani. Ma Joseph Ratzinger quando era ancora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ci ricorda l’implacabile credente devota Murgia, «si espresse con molta chiarezza in merito alla questione del Dio Madre che ancora si aggirava per i corridoi vaticani come una patata bollente: "Non siamo autorizzati a trasformare il Padre Nostro in una Madre Nostra: il simbolismo usato da Gesù è irreversibile, è fondato sulla stessa relazione uomo-Dio che è venuto a rivelarci"».
Quando le italiane si ripresero il corpo e la storia cambiàdi Miriam Mafai (la Repubblica, 12.05.2011
La vittoria del "no" che nel maggio del 1981 confermava, con il voto popolare, la legge che tre anni prima aveva abolito il reato di aborto e rendeva possibile, a determinate condizioni, l’interruzione volontaria delle gravidanza, resta un momento cardine nella storia delle donne e del nostro Paese. La campagna elettorale fu durissima, conobbe toni da vera e propria crociata.
Il Paese aveva già votato, pochi anni prima, nel 1974, a favore della legge sul divorzio anch’essa sottoposta a referendum e condannata dalla Chiesa. Ma la questione dell’aborto appariva, e senza dubbio era, più delicata e controversa. E più incerto appariva l’esito del referendum. A favore del mantenimento della legge sul divorzio, ad esempio, si erano pronunciati pubblicamente, nel corso della campagna elettorale, anche personalità e gruppi cattolici che evitarono, invece, di esprimersi a proposito della legge sull’aborto
Massimo fu l’impegno del Vaticano e delle gerarchie, prima per impedire l’approvazione della legge (ricordo un discorso del Papa a Piazza S. Pietro ed una manifestazione allo stadio S. Siro di Milano affollato di almeno centomila persone), poi perché la legge venisse bocciata dal voto popolare. Nel corso dei comizi e degli incontri in parrocchia, le madri che avessero pensato di abortire e quelle che avessero votato a favore della legge venivano indicate, senza pietà, come assassine.
E tuttavia, alla fine, a favore del mantenimento della legge votò la maggioranza degli italiani e delle italiane, al Nord come al Sud. Votarono a favore della legge le donne che per abortire andavano all’estero o in qualche disponibile clinica privata, votarono a favore della legge le donne che per abortire erano costrette a far ricorso alle cosiddette "mammane" che intervenivano introducendo un ferro o un gambo legnoso di vegetale là dove una vita indesiderata stava germinando. Votarono insomma a favore della legge l’80% degli elettori e delle elettrici, al Nord come al Sud, in Veneto come in Sicilia, sordi ai richiami alla disciplina della Chiesa e delle organizzazioni cattoliche scese in campo contro la legge assieme alla Dc e al Msi.
Nel giro di pochi anni dunque, con la vittoria del referendum, diventava realtà una delle parole d’ordine più audaci di quel movimento femminista che aveva investito la nostra società a cavallo degli anni Settanta: «L’utero è mio e lo gestisco io». Non è esagerato dire che si apriva così anche nel nostro Paese una nuova fase della storia delle donne all’insegna della loro piena libertà, della piena padronanza del proprio corpo. La donna sarà ancora il "recipiente del seme maschile", come dall’inizio della storia aveva raccontato Eschilo («soltanto chi getta il seme nella terra fertile è da considerarsi genitore, la madre coltiva, ospite all’ospite, il germoglio...»). Ma di quel seme è lei ormai la responsabile, è lei che decide della possibilità e della prosecuzione della sua gravidanza, sottraendola al caso, alla inevitabilità della natura e persino (fu uno degli aspetti più controversi della legge) alla volontà del partner.
Non è esagerato dunque dire che entriamo da questo momento in una nuova storia dell’umanità, segnata dalla piena libertà e autonomia della donna sul proprio corpo.
E tuttavia, a distanza di tanti anni, vale la pena di ricordare l’ammonimento di un cattolico "laico" come Pietro Scoppola che ci invitava a leggere il risultato di quel voto non solo come la legittima affermazione di diritti civili, ma anche come «volontà della maggioranza di non essere inquietati da problemi morali e di principio», espressione di un pericoloso "vuoto etico", un processo sotterraneo che verrà pienamente alla luce nel corso degli anni Ottanta.
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- Il "Dizionario delle teologie femministe", "L’Evangelo delle donne", e il "carisma" del teologo. Una recensione di Gianfranco Ravasi.13 settembre 2010, di Federico La Sala
 RATZINGER ’A SCUOLA’ DEL VISIONARIO SWEDENBORG. Una nota di Leonard Boff e una di Immanuel Kant
RATZINGER ’A SCUOLA’ DEL VISIONARIO SWEDENBORG. Una nota di Leonard Boff e una di Immanuel Kant
Carisma da teologa
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2010)
Edith Piaf la cantava con la sua voce appassionata e calda nel 1942, proprio quando io nascevo. Ma, cresciuto, l’avevo forse sentita risuonare anche nell’eco screziata e frusciante della radio o del vinile e persino nel canticchiare di mia madre durante il lavoro domestico: La vie en rose è, certo, l’emblema di un’epoca, di un modello esistenziale, di un’atmosfera. Tuttavia, vedere l’intera vita con lenti rosa alla fine stanca e fin sconcerta. Questa sensazione mi accompagnava mentre percorrevo qua e là le pagine del Dizionario di teologie femministe, curato da due teologhe americane del Connecticut ed edito in italiano dall’alacre Claudiana di Torino con la consulenza di una teologa e di un teologo del nostro paese (in questa materia incandescente è necessario usare sempre il linguaggio "inclusivo").
Intendiamoci, il volume è molto utile e quasi indispensabile per conoscere di prima mano la teologia femminista, sulla quale per altro siamo intervenuti più di una volta su queste pagine, consapevoli che la questione femminile ha registrato una presenza importante nella trama della storia recente del pensiero teologico (e non soltanto nell’orizzonte sociale, psicologico o filosofico).
Non è il caso, infatti, di documentare quanto una concezione maschilistica o patriarcale abbia pesantemente rivestito e condizionato il pensiero religioso del passato, a partire dalle stesse Scritture Sacre, immerse in un contesto "sessista". Tanto per esemplificare, Qohelet non esita a proclamare la donna «amara più della morte, tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia; chi è gradito a Dio la sfugge, ma chi fallisce ne resta catturato...» (7,26). E il suo collega Siracide va anche più avanti, certo com’è che «è meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna» (42,14).
È, quindi, ovvio che una grande e faticosa operazione di rilettura ermeneutica di quelli e di altri testi religiosi, così come una revisione delle prospettive e degli stili pastorali siano necessarie. In questo senso il monito continuo presente nelle voci di questo Dizionario non è da sbeffeggiare o da smitizzare in modo radicale, ma da considerare un po’ come una spina nel fianco delle stesse Chiese. Molto cammino al riguardo è stato compiuto, sia pure nella differente calibratura dottrinale e pastorale delle diverse confessioni cristiane, ma un altro è ancora aperto, anche perché non è con un semplice decreto o con un pronunciamento pur autoritativo che si cancellano concrezioni secolari fatte di ideologia, di prassi e di costumi.
Che c’entra, allora, La vie en rose? C’entra nell’esasperata e parallela unilateralità di certe teologie femministe che colorano tutto di rosa (forse rigettando persino l’assegnazione di questo colore come "esclusivo"), nell’ansia di trasformare una deprecata his-story in una her-story. Così, se prendiamo la prima voce, «Abbà/Padre», è ovvio che bisogna subito "salvare" Gesù, che usava indubbiamente questo appellativo: ma egli lo faceva in un «contesto antipatriarcale», «affermando un significato non-patriarcale» e «rovesciando l’idea stessa per porla al servizio della critica femminista del patriarcato e delle sue divinità». La «Nascita verginale» di Gesù, tanto per proseguire negli esempi, «nelle teologie femministe o è rifiutata in quanto mito cristiano androcentrico che sostiene il patriarcato e denigra le donne» o, al contrario, è «l’inizio della fine dell’ordine patriarcale». Persino l’apparentemente asettica «Archeologia» non svilupperà la sua vera identità «finché non saranno superati i suoi preconcetti tradizionali ed elitari» che puntano a «esaminare strutture e manufatti pubblici e monumentali, in cui predomina l’impronta maschile... dirigendo la maggior parte delle sue energie verso i prodotti dell’atti vità maschile» e non ai contesti domestici (che, però, si riconosce essere ora fmalmente oggetto di analisi), tuttavia inesorabilmente scoprendo in essi la subordinazione al primato androcentrico.
È scontato che ben più incandescente sia la voce sui «Ministeri ecclesiastici e il culto», molto articolata ma con una netta opzione di principio: «Le femministe stanno mettendo in discussione tutte le forme gerarchiche, i ruoli tradizionali di leadership, la distinzione tra clero e laici, le forme, il linguaggio, le immagini di culto e spiritualità che non siano inclusive. Sono oggetto di critica anche le definizioni della vita familiare e dei ruoli sessuali che stanno alla base dell’educazione religiosa». E qui bisognerebbe invitare il lettore a seguire alcuni temi scottanti connessi - tutti destinatari di un lemma proprio - come famiglia, educazione religiosa, sacramenti, cura pastorale, ministero, liturgia e soprattutto le varie voci dedicate al "genere" (gender), sul quale però si deve registrare una notevole polimorfia di approcci, meno automatici rispetto all’impostazione del celebre asserto «On ne naît pas femme, on le devient» della de Beauvoir, che considerava il sesso come una mera costruzione socio-culturale e non biologico-naturale.
La notevole questione del «Linguaggio inclusivo» a cui sopra accennavamo, pur nell’indiscussa istanza che propone, tende a trascendere verso estremismi che scardinano i concetti e le verità teologiche sottese (è noto che il mezzo linguistico non è mai neutro e inoffensivo rispetto al contenuto). Queste esasperazioni giungono al punto di avanzare perplessità anche nel chiamare Dio «Madre» oltre che «Padre»: «Ci si chiede, infatti, se Madre è sufficiente come unico nome femminile di Dio, dal momento che tale uso implica che le donne sono come Dio solo quando partoriscono e allevano figli». Ripetiamo: «Numerosi sono i contributi positivi provenienti dall’esegesi, dalla teologia e dall’ermeneutica femminista» (e questa frase è desunta da un documento cattolico ufficiale, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa della Pontificia Commissione Biblica). Soprattutto Giovanni Paolo II ha ribadito la necessità di una conversione della comunità ecclesiale nei confronti della donna e del suo "carisma" (in senso teologico). Ripetiamo pure che questo Dizionario, nella sua qualità fenomenologica, è un sussidio significativo per conoscere il variegato orizzonte delle teologie femministe.
Detto questo, rimane l’impressione di essere di fronte a una sorta di sessuologia teologica che corre il rischio di procedere in modo parallelo all’approccio adottato dal detestato patriarcalismo fallocratico, scivolando in eccessi unilaterali, in parzialità smodate, in visioni che calzano appunto solo occhiali a lenti rosa, cadendo talora in quelle trappole che si denunciano. Ha ragione la pastora battista Lidia Maggi quando scrive, nel suo Evangelo delle donne, un volumetto che esce in contemporanea al Dizionario e che è dedicato a una quarantina di figure femminili neotestamentarie: «La riscoperta della presenza femminile non venga appiattita quale strumento per rivendicare quote rosa all’interno delle Chiese: percorso legittimo, che dà voce all’altra metà del cielo, troppo spesso messa a tacere. Ma la posta in gioco è ben più alta, di tipo teologico: custodire e difendere la rivelazione evangelica nella sua integralità... C’è un’eccedenza dell’evangelo rispetto al nostro desiderio di essere valorizzate da Gesù. Eccedenza non vuol dire che l’evangelo rema contro, ma che va oltre: anche oltre il riconoscimento del ruolo delle donne».
 Letty M. Russell e J. Shannon Clarkson (a cura di), «Dizionario di teologie femministe», edizione
italiana a cura di Gabriella Lettini e Gianluigi Gugliermetto, Claudiana, Torino, pagg. 546, € 47,00;
Letty M. Russell e J. Shannon Clarkson (a cura di), «Dizionario di teologie femministe», edizione
italiana a cura di Gabriella Lettini e Gianluigi Gugliermetto, Claudiana, Torino, pagg. 546, € 47,00;
 Lidia Maggi, «L’Evangelo delle donne», Claudiana, Torino, pagg. 136, € 12,00.
Lidia Maggi, «L’Evangelo delle donne», Claudiana, Torino, pagg. 136, € 12,00. -
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. --- LEGGE ELETTORALE ("PORCELLUM") E PROSTITUZIONE: ANGELA NAPOLI LANCIA L’ALLARME. Accusa shock della deputata di Futuro e Libertà, conseguenza di una legge elettorale che costringe le donne, per essere in lista, "ad assecondare il padrone di turno".8 settembre 2010, di Federico La Sala
-
> AL DI LA’ DI DIO PADRE E DELLA VECCHIA CRISTOLOGIA. ---- STATO E CHIESA: IL CROCIFISSO E IL TOTALITARISMO MASCHERATO. Da Bagnasco a Berlusconi, da Bertone a Napolitano... (di Marco Politi - Laicità in croce).25 giugno 2010, di Federico La Sala
Laicità in croce
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2010)
Da Bagnasco a Berlusconi, da Bertone a Napolitano: in attesa della sentenza definitiva della Corte europea sul crocifisso si moltiplicano gli interventi. Sorge artificialmente lo spettro di giudici decisi a conculcare il sentimento religioso italiano. Ha detto il capo dello Stato che le sentenze europee “devono essere comunque accettate”. Ma ha soggiunto che la “laicità dell’Europa non può essere concepita e vissuta in termini tali da ferire sentimenti popolari e profondi”. In realtà la Corte di Strasburgo, a novembre scorso, ha sancito un principio pacifico in tanti altri Paesi: l’esposizione nelle aule scolastiche del simbolo religioso (per di più unico simbolo esposto) rappresenta una “violazione della libertà dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni”.
Da allora sono partite pressioni molteplici perché il secondo grado della Corte di Strasburgo sconfessi la prima sentenza. Si è mobilitata la Cei, si è mosso il governo, si sono allertato l’associazionismo cattolico, facendo un gran parlare di identità, tradizioni, libertà. Berlusconi proclama che la decisione “inaccettabile per la stragrande maggiorana degli italiani”, il cardinal Bagnasco chiede il “rispetto della libertà religiosa”, il cardinale Bertone definisce la croce “espressione identitaria, strettamente connessa con la storia e la tradizione dell’Italia come pure dei popoli europei”. In realtà non un solo argomento, portato in campo in questi mesi per difendere la presenza obbligatoria del crocifisso nelle aule e nei tribunali, ha un fondamento. L’Unione europea
 tranne la pattuglia isolata di Polonia, Irlanda, Italia e Malta - respinse a schiacciante maggioranza
dei suoi 27 stati la menzione delle “radici cristiane” nella propria costituzione. Non fu negazione del
ruolo del cristianesimo nella storia europea, bensì rifiuto che da un generico richiamo costituzionale
potessero scaturire, direttamente o indirettamente, situazioni di privilegio per una religione.
tranne la pattuglia isolata di Polonia, Irlanda, Italia e Malta - respinse a schiacciante maggioranza
dei suoi 27 stati la menzione delle “radici cristiane” nella propria costituzione. Non fu negazione del
ruolo del cristianesimo nella storia europea, bensì rifiuto che da un generico richiamo costituzionale
potessero scaturire, direttamente o indirettamente, situazioni di privilegio per una religione.Che l’Europa sovranazionale sia laicista o antireligiosa è falso: infatti il trattato costituzionale prevede un “dialogo permanente” con le varie Chiese. Falso è anche dire che la sentenza respingerebbe la fede nell’ambito angusto del “recinto privato”. Il cristianesimo, come ogni altra fede, è totalmente libero di esprimersi collettivamente e visibilmente nello spazio pubblico e sociale dei paesi Ue. Parlare in Italia di un cristianesimo che rischia di essere conculcato, è una gag.
Ciò che indica la prima sentenza della Corte europea è, correttamente, l’impossibilità che in uno spazio istituzionale come la scuola (o i tribunali) vi sia un simbolo religioso che visivamente rappresenti il supremo principio ispiratore dell’educazione (o della giustizia). Non ci può essere nella società pluralistica contemporanea il dito indice di una sola religione, che all’interno di un’istituzione segni la via da seguire. Perché non è vero che il crocifisso sia nelle aule o nei tribunali “per tradizione”. La croce nei luoghi istituzionali è il retaggio dei secoli in cui il cattolicesimo era religione di stato. E il tentativo di imporne la presenza, anche oggi che la Costituzione e il Concordato hanno eliminato qualsiasi riferimento ad una religione di stato, non ha più nessuna base giuridica. Meno che mai è giustificato il tentativo surrettizio delle gerarchie ecclesiastiche di creare e crearsi uno status privilegiato di “religione di maggioranza”. Peraltro i giovani italiani, come dimostra l’ultima indagine Iard riportata dall’Avvenire, si sentono “cattolici” soltanto al 52 per cento.
Neanche è vero che il cattolicesimo sia un tratto universale dell’identità italiana. Ogni cittadino ha la sua storia, la sua cultura, le sue credenze. Sul piano istituzionale è certo che un solo simbolo, il Tricolore, rappresenta tutti (con buona pace di Bossi) e una sola immagine rappresenta nei luoghi pubblici l’unità della nazione, quella del presidente della Repubblica (Berlusconi se ne faccia una ragione). Da questo punto di vista rimane insuperabile la chiarezza del principio costituzionale americano (nazione assai religiosa e spesso citata da Benedetto XVI come esempio di laicità positiva), secondo cui lo Stato non può “né favorire né contrastare una religione”. Nelle scuole americane c’è la bandiera a stelle e strisce, non il crocifisso.
C’è un accenno interessante nel recente intervento di Napolitano. Il richiamo ad una una laicità “inclusiva”, disponibile ad accogliere ed amalgamare le “tradizioni più diverse”. Se è così, si abbia il coraggio di lasciare scegliere gli alunni se nella propria classe vogliono una parete neutrale oppure tale da accogliere la pluralità dei simboli religiosi e filosofici, che ciascuno sente consono.
O si rispetta la libertà di coscienza come astensione volontaria da qualsiasi marchio o si lascia libera l’espressione di tutti. Decidere, invece, di imporre un simbolo dichiarato unilateralmente valido per tutti è totalitarismo mascherato.