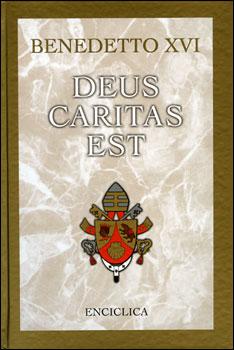
TEOLOGIA "CATTOLICA", POLITICA, E FILOSOFIA "PAGANA". IL TEOLOGO FRANCESCO BRANCATO CERCA DI "INQUIETARE" I FILOSOFI ITALIANI (Cacciari, Givone, Natoli, Severino, Sgalambro, Vattimo e altri) E DI PORTARLI NELLA RICCA E SFARZOSA CASA DEL "DEUS CARITAS" DI PAPA RATZINGER. Un’intervista di Roberto Righetto - a cura di Federico La Sala
sabato 12 luglio 2008.- [...] «Ciò che accomuna i diversi filosofi, alcuni dei quali comunque si sono professati o si professano credenti, è la diffusa consapevolezza dell’insuperabile finitezza dell’uomo e del pensiero umano. Partendo da qui essi sono giunti, ciascuno seguendo una propria direzione, a guardare all’uomo nella sua realtà di essere finito e tuttavia di mistero insondabile, realmente presente nel suo mondo e nel suo tempo, ma non per questo schiacciato nel suo ’qui ed ora’. La teologia deve sempre più imparare ad accostarsi con più umiltà e minore presunzione all’uomo concreto e alle sue domande fondamentali, senza cadere nel rischio di fornirgli soluzioni astratte e surrettizie, scontate e sorde al suo grido di dolore e di sofferenza. Dal confronto con questi autori in particolare, probabilmente la teologia giungerà alla convinzione che la prospettiva della finitezza non è l’unica possibile: piuttosto che una barriera insuperabile, essa può essere letta come un confine e una ’soglia’ che lo apre all’infinito. Se saprà fare questo, per citare una felice espressione di Joseph Ratzinger, allora riuscirà ancora a ’inquietare’ il cuore di chi continua a dire con sempre maggiore insistenza che ’forse non è vero...’, con la possibilità reale che ’forse è vero’, è proprio vero che in Cristo risorto è stata offerta all’uomo una ’speranza affidabile’» [...]
 intervista
intervista
 Oltre nichilismo e politeismo, nei pensatori italiani contemporanei c’è una ripresa d’attenzione verso temi religiosi, ma con diverse ambiguità: parla lo studioso Francesco Brancato
Oltre nichilismo e politeismo, nei pensatori italiani contemporanei c’è una ripresa d’attenzione verso temi religiosi, ma con diverse ambiguità: parla lo studioso Francesco Brancato
Uno sguardo che tocca anche Givone, Rella, Ruggenini, Quinzio. «Molti pongono domande incessanti alla teologia e al pensiero cristiano, che non si possono evitare»
 Cacciari
Cacciari
 «Dalla sua filosofia emerge una dimensione tragica dell’esistenza umana: un’inquietudine del pensiero che interroga la fede»
«Dalla sua filosofia emerge una dimensione tragica dell’esistenza umana: un’inquietudine del pensiero che interroga la fede»
 Natoli
Natoli
 «La sua etica del finito fa continui riferimenti al mondo biblico e alla tradizione ebraico-cristiana, che ritiene ineludibili»
«La sua etica del finito fa continui riferimenti al mondo biblico e alla tradizione ebraico-cristiana, che ritiene ineludibili»
 Severino
Severino
 «Lo spazio possibile per un discorso intorno al destino ultimo dell’uomo e alla vita eterna appare privo di senso. Impossibile»
«Lo spazio possibile per un discorso intorno al destino ultimo dell’uomo e alla vita eterna appare privo di senso. Impossibile»
 Sgalambro
Sgalambro
 «Nei suoi libri muove un attacco duro e diretto alla speranza cristiana, ritenuta grossolana e ingannevole»
«Nei suoi libri muove un attacco duro e diretto alla speranza cristiana, ritenuta grossolana e ingannevole»
 Vattimo
«In sostanza, ha ridotto la sua fede originaria in filosofia e pensiero, tanto da giungere a confessare di ’credere di credere’ quale ultima spiaggia»
Vattimo
«In sostanza, ha ridotto la sua fede originaria in filosofia e pensiero, tanto da giungere a confessare di ’credere di credere’ quale ultima spiaggia»
E il filosofo torna a guardare all’aldilà
di ROBERTO RIGHETTO (Avvenire, 11.07.2008)
In uno scenario etico ove il nichilismo pare aver dichiarato la sua sfida totale, quale spazio può configurarsi per un nuovo rapporto fra pensiero e cristianesimo? E come intuire una soluzione che non vada nella direzione della riscoperta del politeismo (il nietzschiano «Dioniso contro il crocifisso»), che sembra meglio adattarsi al bisogno spirituale di un’epoca che vuole annullare ogni valore come assoluto? A queste e altre domande cerca di rispondere lo studioso Francesco Brancato in un saggio appena uscito e intitolato Il De novissimis dei laici. Le realtà ultime e la riflessione dei filosofi italiani contemporanei (edizioni Giunti, pagine 480, euro 12,50).
Brancato, docente di Teologia della creazione ed escatologia presso lo Studio teologico San Paolo di Catania, esamina alcuni dei principali filosofi italiani contemporanei. L’abbiamo intervistato.
Secondo lei si può parlare di una ripresa di attenzione da parte dei filosofi italiani verso il tema dell’aldilà e dei Novissimi in particolare?
«Da diverso tempo si è potuta registrare un’attenzione tutta particolare, sebbene critica, dei filosofi laici italiani per il messaggio cristiano, ma anche per il mondo biblico e religioso in genere. Attenzione non perfettamente ricambiata da molta teologia nostrana. Per quanto siano stati affrontati diversi temi nel dialogoconfronto tra teologi e filosofi italiani, non è stato dato spazio adeguato all’indagine di questo punto essenziale della fede cristiana, ovvero il destino dell’uomo, del mondo e della storia, la questione escatologica. Leggendo invece le principali opere dei filosofi italiani che maggiormente si sono impegnati nella riflessione intorno a queste questioni, ho sempre più compreso che le domande ultime dell’uomo sul proprio personale destino come sul destino del mondo intero, nonché sul senso della propria esistenza finita e sul significato della vita e della morte, sono la spina dorsale che regge il loro intero pensiero filosofico».
Lei si occupa di pensatori credenti ma soprattutto non credenti: in che senso si può parlare di un ritorno delle cose ultime nel loro pensiero?
«Credo che l’attenzione alle questioni cosiddette ultime da parte della filosofia non si sia mai affievolita del tutto. Alcuni filosofi italiani contemporanei, e qui mi riferisco in particolare ad autori come Severino, Sgalambro, Vattimo, Cacciari, Givone, Natoli, per non dimenticare Rella e Ruggenini, hanno puntato la loro attenzione su queste problematiche, accostandosi in maniera critica - in alcuni casi in maniera piuttosto violenta - , alla prospettiva offerta dal cristianesimo e dalla teologia cattolica. Diversi filosofi, infatti, e qui penso in particolare a Severino e Sgalambro, nella loro filosofia hanno voluto denunciare l’inconsistenza e le aporie insanabili insite, a loro modo di vedere, nel messaggio escatologico del cristianesimo e in sostanza nel cristianesimo stesso. Sgalambro, in particolare, i cui libri possono attirare l’attenzione più per la violenza del linguaggio e delle immagini che per la profondità delle riflessioni, muove un attacco diretto e duro alla speranza cristiana ritenuta grossolana e ingannevole, una sorta di speranza da vermi, inoculata nel cuore e nella mente di persone deboli impaurite di fronte all’inesorabile e insensato avanzare della morte e della distruzione del tutto. C’è dunque una maggiore ripresa di attenzione da parte dei filosofi italiani verso quelle che la teologia definirebbe ’realtà ultime’, ma al fine - qui ho in mente specialmente Natoli - di riscrivere l’attesa escatologica cristiana in chiave intramondana, operando un serrato programma di secolarizzazione degli ultimi articoli del Simbolo di fede. In molti di loro, piuttosto che un vero avvicinamento alle cose ultime, si registra il tentativo, non del tutto celato, di sostituire alla speranza cristiana il sentimento greco della vita, la visione pagana del mondo e della storia, per una sana riconciliazione con il mondo e con la finitudine dell’uomo, la sua mortalità. In realtà la maggior parte di loro ha voluto costruire il proprio pensiero in espressa reazione all’escatologia cristiana».
Lei ha accennato ad Emanuele Severino, il quale si mostra piuttosto ostile verso il mondo delle fedi...
«L’attenzione di Severino verso il messaggio cristiano non è generica o estrinseca, ma investe il contenuto stesso dell’annuncio e tutta la sua essenzialità. Per lui la scelta del divenire provoca nell’umanità occidentale un sentimento di angoscia di fronte al niente, di fronte alla morte. Tutto dunque è eterno. Solo in superficie si crede che le cose vengano dal nulla e che nel nulla alla fine precipitino. Lo si crede perché nel profondo si è convinti che quel breve segmento di luce che è la vita è esso stesso nulla. È questa la natura vera del nichilismo. È l’omicidio primario, l’uccisione dell’essere. Da queste brevi, ma credo anche indicative affermazioni, si comprendono le ragioni per cui lo spazio per un possibile discorso intorno al destino ultimo dell’uomo e del mondo, intorno alla vita eterna e alla speranza escatologica, sia praticamente privo di senso e, dal mio punto di vista, assolutamente impossibile ».
E veniamo a Salvatore Natoli, il filosofo cui lei sembra mostrare più interesse, sia per il suo costante riferimento al pensiero cristiano sia per le domande radicali che sembra porre nelle sue riflessioni...
«Salvatore Natoli è uno dei filosofi italiani che si è maggiormente impegnato nella riflessione intorno a queste questioni. Egli fa ricorso a categorie il più delle volte mutuate prevalentemente dal mondo biblico e dalla tradizione ebraico-cristiana, come anche il fatto che egli si intrattenga con attenzione nell’analisi di testi della Scrittura e della tradizione patristica e teologica, non disdegnando in alcuni casi neppure la familiarità con la testimonianza dei grandi mistici cristiani. Nella sua filosofia propone una saggia riconciliazione con la vita, anche se profondamente pagana; una saggezza, cioè, che si misura sull’esperienza presente e che si concentra sul presente, facendo a meno di un futuro assoluto, escatologico, e soprattutto di una meta ultima, conclusiva, di un salvatore atteso. Natoli ammette che qualunque cosa si pensi del cristianesimo, un confronto con esso non è eludibile sul piano della storia e della cultura, in quanto senza il cristianesimo potremmo capire ben poco di ciò che siamo. L’etica del finito secondo Natoli è propria dell’uomo quale essere finito chiamato a venire a capo della finitezza di volta in volta. Sta qui la radice e la sostanza del neopaganesimo di Natoli il quale rinuncia al salto della fede e alle prospettive che la speranza cristiana dischiude, per rivolgere il proprio sguardo verso la naturalità - non certo la creaturalità - del finito e quindi la felicità di questa vita. Nessuna prospettiva verso l’Altro, dunque, ma solamente verso l’altro fatto ’oggetto’ della custodia. È questo l’aspetto del cristianesimo che Natoli accoglie e fa proprio: il Gesù del discorso della montagna, ma non il Cristo risorto. Ciò non meraviglia affatto, poiché è stato lo stesso Natoli che a più riprese ha affermato con estrema onestà, in tutti i passaggi possibili delle sue opere, che il non credente si sente tanto più interrogato dal cristianesimo quanto più esso appare nella sua radicalità e paradossalità».
Lei pare dimostrare una simpatia anche maggiore verso il cosiddetto ’pensiero tragico’, rappresentato soprattutto da Luigi Pareyson e poi da Sergio Givone e Massimo Cacciari: anche le opere di questi filosofi sono intrise di cristianesimo...
«Sergio Givone, specialmente nel suo denso e avvincente racconto Favole delle cose ultime, conduce il lettore attraverso quelle che egli stesso definisce ’stazioni e trame da cui si levano domande sulle cose ultime’. Domande sulla verità, sulla morte, sulla colpa, su Dio e il male, sull’eterno, sul senso e sul nonsenso, sul giudizio finale. Domande sulle cose che, come denuncia lo stesso Givone, sembrano farsi sempre più estranee al discorso filosofico e ’trovare un estremo rifugio nello specchio di un passato prossimo già diventato favola’. Da parte sua Cacciari pare cogliere tutta la drammaticità della domanda di Cristo nel Vangelo di Luca: ’Quando tornerà il Figlio dell’Uomo troverà fede sulla terra?’; vale a dire, troverà quella stessa luce e vita che egli è? A questa domanda è appesa l’intera riflessione filosofica di Cacciari, la sua ’escatologia’: la sua è una filosofia da cui emerge la dimensione tragica e agonica dell’esistenza dell’uomo, sempre più ricco di domande e sempre più povero di risposte. Una mancanza che tuttavia non frena il bisogno di sapere insito nell’uomo stesso, per cui la filosofia, in particolare quella di Cacciari, si comprende come inquietudine del pensare, nella misura in cui, però, il pensare è rivolgersi alle questioni fondamentali dell’uomo, agli interrogativi legati alla sua vita e alla sua morte».
Lei poi accomuna in una sezione due intellettuali piuttosto lontani, Vattimo e Quinzio: forse perché entrambi debole’?
«Sono sì due filosofi molto distanti tra di loro, ma tuttavia, ciascuno a suo modo, nella loro irriducibile distanza, hanno parlato di un ’eschaton possibile’, o perché reso presente e sperimentabile nell’agape fraterna, nella pietas per il più debole e per l’escluso, o perché tenacemente invocato e impazientemente atteso; o perché ’letto’ tra le pieghe della storia, o perché chiamato ancora, nonostante la sua scandalosa assenza. Non ci sono molti legami tra questi due diversissimi filosofi, questo è proprio vero. Se infatti Vattimo, in sostanza, ha ridotto la sua fede originaria in filosofia e pensiero, tanto da giungere a confessare di ’credere di credere’ quale ultima spiaggia della sua ricerca, Quinzio ha costantemente ricondotto la sua filosofia alla fede, una fede crocifissa e trafitta dallo scandalo dell’inaudito ritardo della venuta finale di Cristo. Le domande che Quinzio si è poste e con coraggio ha posto anche alla riflessione credente e alla Chiesa, ma prima ancora alla stessa testimonianza della Scrittura, non riguardano tanto l’attualità ecclesiale, la sua morale o la sua liturgia, quanto piuttosto il contenuto profondo del messaggio rivelato: perché Gesù non è tornato? Perché nonostante la redenzione da lui operata continuiamo a subire ingiustizie e a soccombere sotto i colpi del male? Perché continuiamo a morire anche dopo la resurrezione di Gesù dai morti? Perché i morti non risorgono? Egli avrebbe voluto concludere il suo cammino intellettuale e umano con l’affermazione secondo cui la fede è puramente illusoria, ma ha sentito di non poterlo fare perché ha compreso che in mezzo alla confusione e alle contraddizioni della storia, ’qualcosa ha senso’ e questo senso, la croce di Cristo, è il giudizio sul mondo che deve essere distrutto per far spazio a Dio e al Suo regno di giustizia e di pace. La Chiesa deve annunciare tutto ciò, senza lasciarsi sopraffare da ciò che Quinzio ama definire ’superbi sbadigli’ che non sono altro se non il segno più estremo della sua stanchezza e della sua stessa morte. In lui prevale tuttavia la speranza sull’angoscia ».
Infine, come bilancio, quali opportunità può trarre il pensiero cristiano dalle provocazioni di questi filosofi non credenti?
«Ciò che accomuna i diversi filosofi, alcuni dei quali comunque si sono professati o si professano credenti, è la diffusa consapevolezza dell’insuperabile finitezza dell’uomo e del pensiero umano. Partendo da qui essi sono giunti, ciascuno seguendo una propria direzione, a guardare all’uomo nella sua realtà di essere finito e tuttavia di mistero insondabile, realmente presente nel suo mondo e nel suo tempo, ma non per questo schiacciato nel suo ’qui ed ora’. La teologia deve sempre più imparare ad accostarsi con più umiltà e minore presunzione all’uomo concreto e alle sue domande fondamentali, senza cadere nel rischio di fornirgli soluzioni astratte e surrettizie, scontate e sorde al suo grido di dolore e di sofferenza. Dal confronto con questi autori in particolare, probabilmente la teologia giungerà alla convinzione che la prospettiva della finitezza non è l’unica possibile: piuttosto che una barriera insuperabile, essa può essere letta come un confine e una ’soglia’ che lo apre all’infinito. Se saprà fare questo, per citare una felice espressione di Joseph Ratzinger, allora riuscirà ancora a ’inquietare’ il cuore di chi continua a dire con sempre maggiore insistenza che ’forse non è vero...’, con la possibilità reale che ’forse è vero’, è proprio vero che in Cristo risorto è stata offerta all’uomo una ’speranza affidabile’».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI...
Forum
-
> TEOLOGIA "CATTOLICA", POLITICA, E FILOSOFIA "PAGANA". -- "Quanto è vero Dio. Perché non possiamo fare a meno della religione". Rec. di Sonia Gentili.29 agosto 2018, di Federico La Sala
Un «salto» verso le contraddizioni dell’esistenza
 Filosofia. Sergio Givone: “Quanto è vero dio”, Solferino editore
Filosofia. Sergio Givone: “Quanto è vero dio”, Solferino editoredi Sonia Gentil (il manifesto, 29.08.2018)
Con Quanto è vero Dio. Perché non possiamo fare a meno della religione (Solferino editore, pp. 186, euro 16) Sergio Givone, noto e importante filosofo contemporaneo, affronta il grande tema dell’irrinunciabilità del pensiero religioso per la tradizione filosofica occidentale che ha affermato la morte di Dio. È una grande questione «russa» (in Tolstoj, Dostoevskij, Bulgakov il mistero del finalismo cristiano segna il limite dialettico del fine comunista progettato dall’uomo e per l’uomo) del tutto attuale: la lettura apocalittica di regimi novecenteschi intesi come occasione di svelamento di una verità e di un fine diversi, quando non opposti, rispetto a quelli previsti e programmati dalla ragione umana è stata resa in anni recenti da Massimo Cacciari e da Giorgio Agamben. Givone si richiama a questa lettura del momento politico, e siccome essa presuppone e non risolve il problema del male nella storia, sorretto da secoli di teologia razionalistica il filosofo affronta il rapporto tra Dio e il male risolvendolo col principio di non contraddizione: poiché Dio è amore, dire che Dio vuole il male significherebbe dire che «è l’Amore a odiare, il che è palesemente contraddittorio», scrive l’autore.
L’ARGOMENTO chiede e merita di essere preso sul serio; propongo dunque qualche spunto per future discussioni. È ammissibile l’applicazione al divino di categorie logiche umane? Davvero Dio è costretto - cioè «necessitato» - dal principio di non contraddizione? Il più geniale interprete novecentesco del mistero divino, Karl Barth, ci ricorda che la trascendenza di Dio è anzitutto radicale irriducibilità alla ragione umana.
IL CARATTERE anti-logico o alogico o paradossale del mistero divino comporta il suo essere non sintesi ma simultanea coesistenza: in questo senso Dio, spiega Gregorio di Nazianzo (sec. IV d.C.), Dio è pelagos ousìas, cioè «mare di essere» (di qui Dante in Paradiso, I, 112-13: «onde si muovono a diversi porti / per lo gran mar dell’essere»). Il mistero di Dio è insomma anche quello della compresenza di opposti che si fondano reciprocamente recando in questo fondamento non solo il principio della reciproca sussistenza ma anche quello della reciproca negazione. Inoltre, anche ammettendo l’applicazione a Dio di categorie logiche, proprio sul piano logico l’essenza correlativa di due termini che si negano a vicenda e non sussistono l’uno senza l’altro costituisce il punto debole del principio di non contraddizione: il concetto non sussiste se non autocontraddicendosi, cioè implicando nel suo sussistere ciò che lo delimita e lo nega. Applichiamo il ragionamento a Dio: se è amore, implica in sé il principio di delimitazione del bene, cioè comporta e permette il correlativo sussistere del male.
CONCLUSIONE: la relazione tra Dio e il male o è, a norma di logica, positiva e sostanziale, o è, a norma di irriducibilità divina alla ragione umana, inconoscibile. È solo questa seconda opzione a lasciar spazio al «salto» della fede, cioè all’accettazione del mistero e alla «scommessa» sul bene, oppure al «salto» etico e laico di Albert Camus: poiché la sostanzialità del male è innegabile, combatterlo è una inconcludente fatica di Sisifo eppure è necessario per l’uomo «immaginare Sisifo felice»: agire e combattere come se il male fosse eliminabile. Alla possibilità generale - e perciò, in sostanza, astratta - che il male sia nell’uomo e coincida con una sua colpa, quella cioè del peccato originale ripresa da Luigi Pareyson con la celebre domanda sul perché «un essere malvagio e meschino come l’uomo dovrebbe avere un qualche diritto alla felicità», Camus avrebbe risposto che di fronte alla sofferenza concreta di un singolo innocente - di questo o quel bambino, per dire - non c’è ragionamento che tenga. Conoscere attraverso la sofferenza significa riconoscere la propria colpa, dice Givone (è l’intuizione di Antigone secondo cui «poiché soffriamo, capiamo che abbiamo sbagliato»), ma quanto si è detto comporta una conclusione opposta e non meno tragica, in base alla quale Antigone direbbe: poiché soffriamo essendo innocenti, capiamo che c’è un errore, e non è il nostro.
-
> TEOLOGIA "CATTOLICA", POLITICA, E FILOSOFIA "PAGANA". -- "Quant’è vero Dio. Perché non possiamo fare a meno della religione". Setgio Givone riflette sull’insopprimibile ricerca del trascendente22 giugno 2018, di Federico La Sala
La necessità del sacro nell’età del disincanto
I nodi dell’etica e del rapporto tra fede e vita: nel saggio «Quant’è vero Dio» (Solferino) Sergio Givone riflette sull’insopprimibile ricerca del trascendente
di Umberto Curi (Corriere della Sera, 22.06.2018)
«È più vicino a Dio chi fa professione di ateismo, ma tiene ferma la verità, di chi nega la verità in nome di Dio». È questa - in estrema sintesi - la tesi principale che è alla base del libro di Sergio Givone, appena uscito presso la casa editrice Solferino, Quant’è vero Dio. Perché non possiamo fare a meno della religione. Un testo strano e affascinante.
 Strano per il coraggio, ai limiti della temerarietà, con il quale argomenta la necessità di Dio, in controtendenza rispetto a una fase storica caratterizzata dall’abusiva identificazione del disincanto con l’ateismo.
Strano per il coraggio, ai limiti della temerarietà, con il quale argomenta la necessità di Dio, in controtendenza rispetto a una fase storica caratterizzata dall’abusiva identificazione del disincanto con l’ateismo.
 Affascinante per il rigore e la freschezza di un modo di condurre il ragionamento, insensibile alla moda deteriore che vorrebbe imporre l’equazione fra oscurità criptica del discorso e profondità del pensiero. Con un valore aggiunto, tutt’altro che trascurabile, soprattutto in confronto alla sciatteria di tanta saggistica pseudofilosofica: una scrittura sapida e limpida al tempo stesso, evidentemente filtrata dalle non poche felici esperienze narrative dell’autore, al quale si devono alcuni romanzi rivelativi di un sicuro talento (Favola delle cose ultime, 1998; Nel nome di un dio barbaro, 2002; Non c’è più tempo, 2008; tutti editi da Einaudi).
Affascinante per il rigore e la freschezza di un modo di condurre il ragionamento, insensibile alla moda deteriore che vorrebbe imporre l’equazione fra oscurità criptica del discorso e profondità del pensiero. Con un valore aggiunto, tutt’altro che trascurabile, soprattutto in confronto alla sciatteria di tanta saggistica pseudofilosofica: una scrittura sapida e limpida al tempo stesso, evidentemente filtrata dalle non poche felici esperienze narrative dell’autore, al quale si devono alcuni romanzi rivelativi di un sicuro talento (Favola delle cose ultime, 1998; Nel nome di un dio barbaro, 2002; Non c’è più tempo, 2008; tutti editi da Einaudi).Ma queste pur non pleonastiche annotazioni relative allo «stile» del libro non devono trarre in inganno. Nelle pagine scritte da Givone non vi è alcun indugio meramente «letterario», né alcuna concessione a una variante «debole» dell’interrogazione filosofica, così come è totalmente assente, d’altra parte, ogni concezione «reazionaria» del rapporto fra la permanenza del sacro e l’età della secolarizzazione. Piuttosto, l’autore dimostra - e in maniera particolarmente convincente - che è possibile aver imparato la lezione di Kierkegaard e Nietzsche, essersi misurati con la sfida della morte di Dio, aver attraversato il deserto della trasvalutazione di tutti i valori, non cancellando, ma al contrario recuperando l’ineliminabilità del sacro, inteso come quell’originario «sì», che resiste quale fondamento inconcusso all’offensiva concentrica di agnosticismo, scetticismo e fideismo - di quel «fideismo irreligioso» che poco o nulla ha a che fare con la laicità autentica.
In questo quadro generale (qui inevitabilmente ridotto a uno schema ipersemplificato), si collocano alcune questioni di grande rilievo strettamente filosofico, che Givone affronta per così dire a viso aperto, senza alcuna remora puramente tattica, in maniera perfino imprudente: il rapporto fra legge e giustizia, il confine mobile e reversibile fra bene e male, i limiti della manipolazione tecnica (e biotecnologica) della natura, al di fuori di ogni moralismo ecologistico, il transito apparentemente inesorabile dall’umano al postumano.
 Come risulta dai titoli stessi dei capitoli che compongono il libro (fra gli altri: «Un pensiero di altri mondi», «Tempo intermedio e Apocalisse», «Potere spirituale e potere temporale»), Givone affronta i nodi teoretici decisivi per una riflessione sul sacro che, come accade in questo testo, risponda all’ambizione esplicitamente dichiarata di non riproporre ipotesi speculative già dissolte dall’irrompere della modernità, preferendo la strada certamente più arrischiata, ma anche incomparabilmente più feconda, della ricerca di un vero e proprio «nuovo inizio».
Come risulta dai titoli stessi dei capitoli che compongono il libro (fra gli altri: «Un pensiero di altri mondi», «Tempo intermedio e Apocalisse», «Potere spirituale e potere temporale»), Givone affronta i nodi teoretici decisivi per una riflessione sul sacro che, come accade in questo testo, risponda all’ambizione esplicitamente dichiarata di non riproporre ipotesi speculative già dissolte dall’irrompere della modernità, preferendo la strada certamente più arrischiata, ma anche incomparabilmente più feconda, della ricerca di un vero e proprio «nuovo inizio».Impossibile dar conto in termini analitici, come pure sarebbe necessario, del ricco ordito di problemi sapientemente annodato da Givone. Ma almeno alcuni spunti, suggeriti senza alcuna arroganza, ma anche senza alcun preventivo accomodamento diplomatico, meritano di essere citati: l’impossibilità dell’etica, certamente nella versione kantiana, ma anche nella variante utilitaristica, in un orizzonte dal quale Dio sia scomparso, e dunque perda ogni senso l’essere o il non essere al mondo.
 Un modo di concepire la laicità secondo il quale laico non è chi rivendica la sua indifferenza alla religione, ma proprio al contrario chi prende la religione sul serio, riconoscendo che i contenuti essenziali con cui è chiamato a fare i conti vengono proprio dalla religione. Un approccio ai problemi della vita - della nascita e della fine - affrancato dalle pretese prescrittive della bioetica di stretta osservanza confessionale, immobile nell’astratta rivendicazione della sacralità della vita, e ricondotto piuttosto al più maturo contesto concettuale di una riflessione libera da impacci dottrinari.
Un modo di concepire la laicità secondo il quale laico non è chi rivendica la sua indifferenza alla religione, ma proprio al contrario chi prende la religione sul serio, riconoscendo che i contenuti essenziali con cui è chiamato a fare i conti vengono proprio dalla religione. Un approccio ai problemi della vita - della nascita e della fine - affrancato dalle pretese prescrittive della bioetica di stretta osservanza confessionale, immobile nell’astratta rivendicazione della sacralità della vita, e ricondotto piuttosto al più maturo contesto concettuale di una riflessione libera da impacci dottrinari.
 Pur trattandosi di temi di indubbio rilievo, le questioni ora semplicemente accennate (e altre ancora, qui necessariamente espunte), nel libro di Givone sono riportate all’interrogativo di fondo, richiamato anche dal titolo. Si incontra Dio, in queste pagine, non come ciò che residua dalla devastazione indotta da un pensiero refrattario a ogni idolo, quale è il pensiero contemporaneo, né come conclusione di un freddo e astratto sillogismo, bensì come approdo e insieme come presupposto, senza il quale «dovremmo riconoscere che il nulla ha vinto».
Pur trattandosi di temi di indubbio rilievo, le questioni ora semplicemente accennate (e altre ancora, qui necessariamente espunte), nel libro di Givone sono riportate all’interrogativo di fondo, richiamato anche dal titolo. Si incontra Dio, in queste pagine, non come ciò che residua dalla devastazione indotta da un pensiero refrattario a ogni idolo, quale è il pensiero contemporaneo, né come conclusione di un freddo e astratto sillogismo, bensì come approdo e insieme come presupposto, senza il quale «dovremmo riconoscere che il nulla ha vinto».- L’incontro al «Corriere» con Givone
Sergio Givone sarà a Milano giovedì 28 giugno alle 18 nella sede del «Corriere» (Sala Buzzati, via Balzan 3) per un incontro organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera. Con lui, Remo Bodei e Armando Torno (ingresso libero con prenotazione a rsvp@fondazionecorriere.it).
Sil tema, nel sito, si cfr.:
FILOSOFIA E MESSAGGIO EVANGELICO. IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA (LOGOS): AMORE ("Charitas"), NON "MAMMONA" ("Caritas")!!!
 IL MONITO DI PASCAL A SERGIO GIVONE: NON CONFONDERE IL NOME DEL MIO DIO ("charité") CON IL NOME DEL DIO ("caritas") DEI VESCOVI E DI PAPA RATZINGER.
IL MONITO DI PASCAL A SERGIO GIVONE: NON CONFONDERE IL NOME DEL MIO DIO ("charité") CON IL NOME DEL DIO ("caritas") DEI VESCOVI E DI PAPA RATZINGER.GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> TEOLOGIA "CATTOLICA", POLITICA, E FILOSOFIA "PAGANA". IL TEOLOGO FRANCESCO BRANCATO CERCA DI "INQUIETARE" I FILOSOFI ITALIANI (Cacciari, Givone, Natoli, Severino, Sgalambro, Vattimo e altri) E DI PORTARLI NELLA RICCA E SFARZOSA CASA DEL "DEUS CARITAS" DI PAPA RATZINGER. Un’intervista di Roberto Righetto - a cura di Federico La Sala1 maggio 2009, di Liviu AnastaseNei tempi remotissimi della Septuaginta, la Torah ebbe una certa influenza sulla filosofia greca del tempo. Figuriamoci oggi. Comunque, l’interdisciplinarietà è benefica sia per la teologia che per la filosofia. Forse la grandezza di un filosofo o di un teologo è data, in definitiva, anche dal rapporto (se non di inclusione - laddove lo si può fare - almeno di complementarità) che sa mantenere con le altre discipline.
-
> TEOLOGIA "CATTOLICA", POLITICA, E FILOSOFIA "PAGANA". IL TEOLOGO FRANCESCO BRANCATO CERCA DI "INQUIETARE" I FILOSOFI ITALIANI (Cacciari, Givone, Natoli, Severino, Sgalambro, Vattimo e altri) E DI PORTARLI NELLA RICCA E SFARZOSA CASA DEL "DEUS CARITAS" DI PAPA RATZINGER. --- Un massacro della scuola, della ricerca, e la fine dello stupore e la fine dell’Università.12 luglio 2008, di Federico La Sala
l’Unità 12.07.2008
La fine dello stupore e la fine dell’Università
di Michele Ciliberto
Se un filosofo dovesse dire quale è uno dei segni più tipici della crisi che sta attraversando il nostro paese potrebbe dire, a mio giudizio, che è la fine dello stupore, della capacità di sorprendersi, che come è noto è la prima sorgente della filosofia. In Italia, oggi tutto è ricondotto nei parametri dell’ordinario, del quotidiano, del feriale: anche le cose più inconcepibili, fino a poco tempo fa, sono digerite, assorbite, metabolizzate senza alcuna difficoltà. Si è persa l’abitudine a dire di no, ad alzarsi in piedi: e di questo è una paradossale conferma il fatto che quando si protesta si usano toni esagitati, addirittura volgari, proprio perché protestare - dire no - è diventata un’eccezione, non più la norma di un comune vivere civile. Questo accade anche quando si tratta delle regole che devono strutturare la vita istituzionale politica e sociale del paese.
È un altro segno della crisi profonda che attraversa l’Italia: le regole appaiono una sorta di optional che il potere può trasformare come meglio gli conviene, a seconda della situazione e perfino dei propri interessi privati. Si tratta di un tratto tipico del dispotismo, quale è già delineato in pagine straordinarie di Tocqueville nella Democrazia in America: il dispotismo si esprime attraverso una prevaricazione dell’esecutivo sugli altri poteri e con un ruolo sempre più ampio assunto dall’amministrazione, che diventa il principale motore dell’intera vita di un popolo. Le strutture dispotiche, infatti sono incontrollabili: una volta messe in movimento invadono progressivamente tutte le sfere della vita sociale ed intellettuale, compresa ovviamente l’alta cultura e le istituzioni attraverso cui essa si organizza.
È precisamente quello che è accaduto in queste ultime settimane con il decreto del 25 giugno del 2008: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria». In esso è compresa una serie di disposizioni che muta profondamente l’assetto della Università pubblica italiana accelerandone la crisi e la definitiva decadenza. Si tratta, dunque, di disposizioni che avrebbero dovuto sollevare, se non uno scandalo, una discussione assai vivace; mentre invece, a conferma di quanto sopra dicevo, con poche eccezioni, il mondo dell’Università è rimasto silenzioso e seduto.
Solo in questi ultimi giorni stanno cominciando ad affiorare prese di posizione più nette come quella del rettore dell’Università di Ferrara o del Preside della Facoltà di Scienze dell’Università di Pisa, il quale ha rotto il muro del silenzio scrivendo una lettera aperta dal titolo: «L’università non è in svendita». Qualche protesta, in verità c’era stata già prima, ma aveva riguardato il fatto che il decreto interviene sugli scatti di carriera di tutti i docenti trasformandoli da biennali in triennali. Il problema è però ben più vasto e riguarda direttamente la costituzione interiore della Università italiana ponendo anche delicati problemi di ordine costituzionale. Mi limito a segnalare quelli che a mio giudizio sono i punti più importanti.
Le Università possono costituirsi, su base volontaria, come fondazioni di diritto privato, si dice nel Decreto, venendo incontro sul piano legislativo a un’istanza proveniente già da molto tempo soprattutto da settori industriali. Su Il Sole 24 Ore il provvedimento è stato infatti presentato da Giovanni Toniolo come «un’ottima notizia, la migliore che abbia sentito in quarant’anni di vita accademica». Personalmente, non ho dubbi che sul tema delle fondazioni si debba discutere ed aprire un forte dibattito, ma sapendo che - se non ben governata - questa è la via dell’integrale privatizzazione dell’Università italiana, con il rischio effettivo sia di ledere il principio della libertà dell’insegnamento sia di ritrovarsi in una situazione come quella americana nella quale accanto alle top ten esistono migliaia di università di livello inferiore ai nostri licei.
Ma che l’Università pubblica sia al centro di un vero e proprio attacco in queste disposizioni è dimostrato anche da altri elementi. È bloccato il turn over: si prevedono infatti assunzioni nei limiti del 20% per il triennio 2009-2011 e del 50% a partire dal 2012. Né è difficile anche in questo caso immaginare gli effetti di questa disposizione sull’Università in generale, specie su quelle medio - piccole e anche su quelle scuole di eccellenza che si giovano di un corpo di docenti limitato. Privatizzazione, da un lato; ricostituzione di una forte dimensione centralistica ,dall’altro: all’Università infatti resterà in cassa soltanto il 20% delle «quote» dei docenti andati in pensione, tutto il resto andrà all’amministrazione centrale la quale ha già tagliato il finanziamento di Euro 500.000.000 in tre anni.
Privatizzazione, centralizzazione (nonostante tutta la retorica sul federalismo) e, infine, colpi durissimi al personale docente per il quale si prevede una sorta di vera e propria rottamazione. La questione dello stato giuridico dei professori universitari è annosa; il Ministro Mussi era intervenuto su questa delicata questione riducendo, e di fatto avviando alla fine, il fuori ruolo, - decisione che si può anche comprendere se si tiene conto che si tratta di una vecchia disposizione, risalente a tutt’altra situazione, la quale consentiva ai professori di continuare a godere del proprio stipendio, pure essendo fuori dai ruoli dell’insegnamento.
Ma queste disposizioni si muovono su ben altro piano colpendo sia la possibilità che i professori universitari, come ogni altro dipendente dello Stato, hanno di poter continuare a lavorare- cioè insegnare - due anni dopo l’età pensionabile (a insegnare, sottolineo); sia la stessa possibilità che possano continuare a restare nei ruoli qualora abbiano compiuto quaranta anni di insegnamento, qualunque sia la loro età (compresi dunque quelli che sono andati presto in cattedra). Ad essere sintetici: prima il biennio era una scelta del docente; ora diventa una concessione dell’amministrazione da cui dipende. Allo stesso modo è l’amministrazione che decide se rottamare un professore, oppure tenerlo in servizio fino al raggiungimento dell’età della pensione stabilita della legge, che il decreto tende invece ,surrettiziamente,ad anticipare anche di parecchi anni con una chiara lesione dei diritti costituzionali dei docenti. In entrambi i casi c’è una totale prevaricazione sulla figura dei professori da parte dell’amministrazione locale e soprattutto di quella centrale che diventa il vero arbitro della situazione. Infatti, se anche l’amministrazione universitaria locale fosse orientata a concedere il biennio o a rinviare la rottamazione, l’amministrazione centrale potrebbe costringerla a procedere in questa direzione con ulteriori, drastiche riduzioni del fondo di finanziamento ordinario.
Non si tratta di questioni sindacali, o di interesse puramente corporativo: in ballo c’è ben altro. Se queste disposizioni vanno avanti ne discenderà un controllo dispotico, e col tempo totale, dell’amministrazione centrale sulle carriere dei professori universitari e di conseguenza sull’Università italiana. Quella che dovrebbe essere il centro della libertà intellettuale e di ricerca del paese, costituzionalmente garantita, corre dunque il rischio di essere controllata e irreggimentata a tutto vantaggio delle università private che potranno darsi gli statuti più adeguati al loro sviluppo, attraendo tutti i professori che non vogliono essere sottoposti a forme di controllo centralistico destinate ad assumere - non è difficile prevederlo - connotati ideologici e politici assai precisi. Mentre nelle Università pubbliche diventerà fortissima, temo, una spinta in direzione del conformismo, della passività, dell’autocensura dei professori universitari con un colpo assai grave per quella autonomia e libertà dell’insegnamento che è esplicitamente prevista dall’art. 33 della Costituzione.
In ultima istanza,questo - la libertà di insegnamento e le forme in cui essa può e deve esplicarsi - è dunque il vero problema che il Decreto del 25 giugno 2008 pone all’Università italiana: che di fronte a tutto questo -e alla stessa forma del decreto,così impropria per decisioni di tale rilievo-non si sia ancora accesa una discussione critica e che siano pochissimi quelli che hanno deciso di alzarsi in piedi può certamente sorprendere; ma sorprende meno se si tiene conto di quello che dicevo all’inizio: il nostro paese è pronto a tutto, anche ad inghiottire in silenzio la fine dell’Università pubblica e della libertà di insegnamento.
l’Unità 12.o7.2008
 Veronesi: massacro di scuola e ricerca
Veronesi: massacro di scuola e ricerca
 L’accusa: «In queste condizioni il paese non può ripartire»
L’accusa: «In queste condizioni il paese non può ripartire»Ricerca e Scuola sono state «massacrate» da questa manovra finanziaria, «ma senza l’una e senza l’altra il Paese non può ripartire». Lo ha detto Umberto Veronesi rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione del programma del convegno internazionale “Il futuro della scienza”, che si svolgerà a Venezia dal 24 al 27 settembre. «La ricerca scientifica - ha detto l’oncologo, oggi senatore della Repubblica - ha bisogno di essere rilanciata se vogliamo rilanciare il Paese. Senza ricerca e senza scienza il Paese non cresce. Ma anche la scuola deve essere sostenuta». Per Veronesi, la scuola «deve essere prima di tutto riformata» per affrancarla dal nozionismo di oggi, per avere «una scuola che si preoccupi di formare la personalità di un ragazzo che cresce e che lo motivi alla vita e alla creatività in modo da renderlo più resistente alle devianze». Ma per far questo «occorre un grande impegno, anche economico».
«Il ragazzo - ha continuato Veronesi - deve andare a scuola con piacere, deve essere affascinato dalla scuola. Deve sentire il bisogno di andarci, perchè a scuola deve imparare, conoscere, ma deve anche divertirsi, vedere film, le opere teatrali, deve fare lui l’attore, deve scrivere articoli, commentare gli articoli del giorno, deve leggere i giornali... Insomma deve diventare un uomo consapevole del suo ruolo nella società. Se no, alimentiamo questa tendenza al rifiuto della società di oggi, che poi si manifesta nelle devianze, nella depressione o, peggio, nel suicidio». Per l’oncologo, quindi, «la scuola va rifatta. La ricerca è fondamentale. La cultura e la musica sono fondamentali per un Paese che deve crescere. Bene, tutte queste aree - ha concluso - sono state massacrate da questa manovra finanziaria».