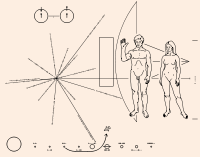
IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. Dopo il crollo della mente viaggio verso l’esternità. Una nota di Gaetano Mirabella - a c. di Federico La Sala
- [...] Questo è il tempo dell’esodo del sociale che è in fuga verso un luogo del sistema nervoso dove può interagire con i propri stati linguistici e mutare la rappresentazione delle sue stesse interazioni eidetiche-neuronali, il che significa paradossalmente che questo “viaggio”, è un viaggio linguistico verso una sorta di fine del linguaggio. La società sembra voler abbandonare il luogo dove c’era la mente e gli esseri umani si trovano alla mercè di forze che li attirano da tutte le parti. L’esodo è accompagnato e guidato dall’azione dei socialnetwork che ,come organi di risonanza, indicano il cammino da fare verso i luoghi del linguaggio. E’ iniziata la grande emigrazione verso l’esternità perché tutti siamo diventati clandestini a bordo di un pianeta inospitale [...]
Dopo il crollo della mente viaggio verso l’esternità
di GAetano Mirabella
A dieci passi prima dell’esternità, i giovani spagnoli, si sono fermati nella piazza del nuovo sole ai confini del vecchio corpo, prima di partire verso la terra della “esternità” che si sono promessi . Questi giovani fanno parte di un popolo nuovo che è in mezzo a noi. E’ un popolo senza nome, un popolo che si muove trascinando col mouse case, palazzi, strade, persone, auto, animali, reale compreso, in un movimento lento che sposta le città sotto un cielo poco probabile, sotto il quale avvertiamo che sorge, dal di dentro di noi, emergendo dal di sotto delle nostre stesse facce, un nuovo profilo che ci esalta e terrorizza al tempo stesso sciogliendo l’identità ch’eravamo, in un ritratto d’acqua.
Giovani elettrosciamani compiono questo lavoro, volontà d’acqua in corpi trasparenti sono all’opera e conducono se stessi e tutto il reale verso una terra che si sono promessi da soli.
Sono in un corpo diverso, guardano il mondo da occhi diversi, hanno una cognitività differente, anche il loro cervello e la sua chimica sono probabilmente diversi dai nostri. Sono guidati da nuovi organi che, dopo il crollo della vecchia mente, fungono da organi di risonanza e sono costituiti dai social network che hanno la funzione di costituire la mente nascente da cui raccogliere informazioni di un pensiero del “sentire”. Questi giovani non sono di destra e neanche di sinistra, sono “indignati” perché li hanno bloccati a mezz’ora di cammino dal futuro, sono incazzati e rifiutano quindi ideologie e credi politici. Intellettuali, filosofi e psicologi, brancolano nel buio e si affannano a costruire ipotesi e teorie per spiegare e capire il fenomeno.
Dopo la rivoluzione che ha acceso nel nord Africa il desiderio di democrazia, adesso tocca a noi dirci la verità sulla falsa e malata democrazia in cui viviamo. Probabilmente dalla “piazza del sole” inizierà la nostra emigrazione verso l’esternità perché, ormai sentiamo che siamo diventati clandestini a bordo di un pianeta inospitale.
I giovani di piazza del sole si sono posti l’obiettivo di uscire dal vecchio programma che ci coinvolge a livelli differenti, culturalmente e politicamente per cui ora sappiamo che abbiamo un lucchetto che va spezzato.Questi giovani sono “lo spazio che sente” e rifiutano quindi ogni etichetta e ogni apparteneza ideologica, culturale, politica. Hanno dichiarato la loro estraneità ad un sistema che vuole “prestare” loro una identità qualunque.
I giovani sono consapevoli che esiste una sorta di signoraggio identitario che (come per il signoraggio bancario) consiste in una emissione di una specialissima “moneta” che è la nostra identità. Si tratta di una identità “truccata” e provvisoria, prestata agli individui, al fine di tenere sotto controllo la vita delle persone alle quali viene “prestato” ciò che già appartiene loro ma da cui si sentono separati poiché non riconoscono più quello che riguarda il loro stesso sé.
Il progetto di mercantilizzazione e finanziarizzazione del reale, perseguito dal potere anonimo e senza volto della plutocrazia sull’esistente, si fonda su un duplice aspetto: mantenere l’impotenza (dell’uomo comune) a rendere (attiva la propria identità) ostacolando nel contempo il processo di riconoscimento che si tratta di una identità “truccata” e provvisoria. Questi nuovi esseri umani, sanno che il fine del potere è quello di tenere sotto controllo la vita delle persone alle quali viene “prestato” ciò che già appartiene loro ma da cui si sentono separati poiché non riconoscono più quello che riguarda il loro stesso sé.
Questi giovani nativi del web hanno sviluppato una sorta di pensiero del sentire che scaturisce dall’azione che le nuove tecnologie hanno avuto sulla nostra consapevolezza la quale, spostandosi sul limite esterno del corpo, ha costituito un amalgama tra il sé e l’esternità dissolvendo il vecchio “sè”. Nel mondo delle nuove tecnologie le percezioni sono veloci e il nostro “sentire” che le riceve filtrate dai social network ,le pensa come un pensiero perchè abbiamo dovuto insegnare ai nostri sensi a pensare per riconoscerci in nuove configurazioni del reale.
Questo pensiero deve essere veloce come le informazioni del mondo del web che viaggiano come spots pubblicitari. Ogni percezione conduce il nativo del web a consolidare gradualmente un neocorpo la cui vita è come un lampo perché vale solo per una volta, solo per una percezione che modifica tutto l’assetto del sistema nervoso. Passare “oltre”, passare al di là, aprire le acque del “mar Rosso” verso l’esternità promessa eludendo la nostra vecchia identità che ci segue per riagguantarci, sembra essere questa la “vocazione” profonda di questo tempo che spinge i nativi del web verso una vita “autentica” che pare rimanere impraticabile e irragiungibile.
Da qui scaturisce la scontentezza e l’impressione di non combaciare con il proprio destino esclusivo e questo induce i nativi a fuggire dall’identità come clandestini, per non incorrere nelle “persecuzioni” di eventuali tiranni. Per non farsi espropriare dal loro intento di passare il confine verso l’esternità, si fugge dal proprio nome, e ci si tutela con i neocorpi-senza-mente dei quali si va a caccia e nei quali si entra tramite una percezione più o meno profonda a seconda dell’intensità del proprio coinvolgimento. Questa diaspora moderna può valere come una riproposizione metaforica della fuga dallo stato di minorità del popolo eletto, per entrare nell’esternità promessa.
Questo è il tempo dell’esodo del sociale che è in fuga verso un luogo del sistema nervoso dove può interagire con i propri stati linguistici e mutare la rappresentazione delle sue stesse interazioni eidetiche-neuronali, il che significa paradossalmente che questo “viaggio”, è un viaggio linguistico verso una sorta di fine del linguaggio.
La società sembra voler abbandonare il luogo dove c’era la mente e gli esseri umani si trovano alla mercè di forze che li attirano da tutte le parti. L’esodo è accompagnato e guidato dall’azione dei socialnetwork che ,come organi di risonanza, indicano il cammino da fare verso i luoghi del linguaggio. E’ iniziata la grande emigrazione verso l’esternità perché tutti siamo diventati clandestini a bordo di un pianeta inospitale.
Oggi i nativi del web in questa piazza spagnola, sono ancora un poco “soggetti” e già un poco esseri umani nuovi, ma in buona parte “sono” neocorpi, o intendono diventarlo. Nel neocorpo non c’è pensiero razionale, non ci sono dubbi o incertezze: si “sa”, solamente e semplicemente: il corpo sa se ha operato la giusta scelta oppure no. In questa piazza del nuovo sole, dopo il crollo della mente, le onde del pensiero liquido lavano via l’abitudine di essere il vecchio sé neurochimico e i nativi fluttuano, scivolando dal luogo della “vecchia” ragione a quello della conoscenza silenziosa.
Permane in loro una parte della vecchia mente, per cui pensano il (vecchio) pensiero solido pur essendo anche neocorpi che non hanno mente, pensano un pensiero liquido che scaturisce dal pensiero del sentire, ovvero da un protocollo cognitivo “silenzioso” e dai sensi che hanno imparato a “pensare” una nuova realtà.
Gaetano Mirabella
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Forum
-
> IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. --- A PARTIRE DALLA LEGGE DELLA UGUAGLIANZA ("LEY DE IGUALDAD") DEL GOVERNO DI ZAPATERO ... RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE4 giugno 2011, di Federico La Sala
 RIPENSARE L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO E LA DEMOCRAZIA, A PARTIRE DALLA LEGGE DELLA UGUAGLIANZA ("LEY DE IGUALDAD") DEL GOVERNO DI ZAPATERO ...
RIPENSARE L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO E LA DEMOCRAZIA, A PARTIRE DALLA LEGGE DELLA UGUAGLIANZA ("LEY DE IGUALDAD") DEL GOVERNO DI ZAPATERO ...
 CON LA SPAGNA DI "PUERTA DEL SOL", PER LA DEMOCRAZIA "REALE": RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE.
CON LA SPAGNA DI "PUERTA DEL SOL", PER LA DEMOCRAZIA "REALE": RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE.
-
> IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. ---- ITALIA: SCENDERE IN CAMPO COME GLI INDIGNADOS SPAGNOLI. 50 mila blog chiusi per stampa clandestina? (di Enzo Di Frenna).29 maggio 2011, di Federico La Sala
50 mila blog chiusi per stampa clandestina?
di Enzo Di Frenna *
All’inizio di maggio una sentenza della prima sezione penale della Corte di Appello di Catania ha equiparato un blog ai giornali di carta. Dunque commette il reato di stampa clandestina chiunque abbia un diario in Internet e non lo registra come testata giornalistica presso il tribunale competente, come prevede la legge sulla stampa n 47 del 1948.
La vicenda è paradossale e accade in Italia. Lo storico e giornalista siciliano Carlo Ruta aveva un blog: si chiamava Accadeinsicilia e si occupava del delicato tema della corruzione politica e mafiosa. In seguito a una denuncia del procuratore della Repubblica di Ragusa, Agostino Fera, quel blog è stato sequestrato e chiuso nel 2004 e Ruta ha subito una condanna in primo grado nel 2008. Ora la Corte di Appello di Catania, nel 2011, ritiene che quel blog andava considerato come un giornale qualsiasi - ad esempio La Repubblica, Il Corriere della Sera o Il Giornale - è dunque doveva essere registrato presso il “registro della stampa” indicando il nome del direttore responsabile e l’editore. La notizia farà discutere a lungo la blogosfera italiana: cosa succederà ora?
Massimo Mantellini se la prende con Giuseppe Giulietti e Vannino Chiti per aver presentato in Parlamento la Legge 62 sull’editoria, che è stata poi approvata, con la quale si definisce la natura di prodotto editoriale nell’epoca di Internet. Ma il vero problema, a mio avviso, è la completa o scarsa conoscenza di cosa sia la Rete da parte di grandi pezzi dello Stato, incluso la magistratura. Migliaia di burocrati gestiscono quintali di carta e non sanno quasi nulla di cosa accade in Internet e nei social network. Questa sentenza, quindi, è un regalo alla politica cialtrona che tenterà ora di far chiudere i blog scomodi. Proveranno a imbavagliarci.
In Italia ci sono oltre 50 mila blog. Soltanto BlogBabel ne monitorizza 31 mila. Nel mondo esistono almeno 30 milioni di blog e forse sono anche di più. I blog nascono come diari liberi on line, può aprirne uno chiunque. Una casalinga. Uno studente. Un professore universitario. Un operaio. Un filosofo. Chiunque. Ma adesso in Italia non è più possibile e possiamo dire che inizia il Medioevo Digitale. Nel mondo arabo i blog e i social network hanno acceso il vento della democrazia, il presidente americano Barack Obama plaude il valore di Internet e la libertà d’informazione, Wikileaks apre gli archivi segreti delle diplomazie, e noi, in Italia, in un polveroso palazzo di giustizia, celebriamo la morte dei blog.
Ma la vogliamo fare una rivoluzione? Vogliamo scendere in piazza come gli Indignados spagnoli e inventarci qualcosa che faccia notizia in tutto il mondo? Vogliamo innalzare una grande scritta davanti alla Corte Costituzionale con lo slogan “Io bloggo libero, non sono clandestino!”. Eggià: perché gli avvocati di Ruta faranno appello in Cassazione e a quei giudici bisognerà far sapere che in Italia ci sono 50 mila persone libere che hanno un blog e confidano nell’articolo 21 della Costituzione, che permette la libertà di espressione con qualunque mezzo. Che ne dite? Ci proviamo?
Fonte: “Il Fatto” (edizione on-line), 28 maggio 2011
-
> IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. ---- I giovani d’Europa si svegliano sul web e si mobilitano per chiedere lavoro e dignità (di Alessandro Oppes).29 maggio 2011, di Federico La Sala
Di piazza in piazza
I giovani d’Europa si svegliano sul web e si mobilitano per chiedere lavoro e dignità
di Alessandro Oppes (il Fatto, 29.05.2011)
Madrid. Due settimane. Quasi niente, ma anche un’eternità. Soprattutto se si pensa che lo straordinario spettacolo di un movimento nato dal nulla, capace di occupare in contemporanea decine di piazze schivando pesanti ostacoli legali, e di raccogliere in un baleno mezzo milione di simpatizzanti sui social network, è un fenomeno del tutto inedito nella storia d’Europa. Tanto da aver subito provocato - in quello che qualcuno vede già come l’inizio di un inarrestabile “effetto domino” - il primo significativo contagio nel Paese che è il vero “grande malato” del continente: le migliaia di “indigna-ti” greci che da giorni protestano sulla piazza Sintagma di Atene contro le durissime misure di austerità del governo Papandreou, hanno risposto a tempo di record all’appello che arrivava dalla Puerta del Sol. “Svegliatevi”, hanno detto loro gli amici spagnoli, ormai convinti che a Madrid “stiamo riscrivendo la storia”. Non ci hanno pensato due volte: una pagina su Face-book, una martellante campagna su Twitter, e anche la Grecia si è messa in moto, senza etichette partitiche, con la consegna irrinunciabile al pacifismo, e poche idee chiare capaci di convogliare nelle piazze la rabbia popolare.
Wiki-revoluciones, dal clic alla protesta
È L’EFFETTOmiracolosodelle wiki-revoluciones, come le ha battezzate il sociologo Manuel Castells. Rivolte digitali frutto di un lavoro collettivo, dove alla fine è impossibile attribuire il merito o la colpa di quello che sta accadendoaunsingoloindividuo,oa un gruppo ristretto di persone. Senza leader, a differenza della politicatradizionale,maconuna capacità di far circolare idee e proposte a un ritmo forsennato grazie a Internet. E poi basta un clic del mouse per far scattare il passaggio dal virtuale al reale. Dal computer alla piazza. Il problema, semmai, viene dopo. E in Spagna stanno cominciando a pensarci seriamente. Perché sta tutto qui il senso della sfida, tanto grande da provocare una sensazione di vertigine a chi ci si è trovato in mezzo.
Come consolidare e rendere produttiva un’energia che nessuno immaginava potesse esplodere con la forza che si è vista in questi quindici giorni? In altre parole: cosa vogliono fare da grandi i protagonisti del movimento “15M”? Ne discutono senza sosta, giorno e notte, in decine di assemblee, non più solo nelle grandi piazze dei centri storici (proprio ieri a Madrid hanno convocato 250 riunioni in tutti i quartieri della capitale e nei comuni vicini).
Dal nucleo iniziale che ha dato vita alla protesta del 15 maggio - Democracia Real Ya - diventato ormai solo una piccola parte di un meccanismo molto più vasto e complesso, era partita una proposta di programma in otto punti,nellaconvinzionechedaquella bozza si potesse arrivare a un consenso generale. Si andava dall’eliminazione dei privilegi della classe politica, con la pubblicazione obbligatoria dei patrimoni e l’ineleggibilità per gli imputati di corruzione, a una serie di misure contro la disoccupazione, tra cui il pensionamento a 65 anni, agevolazioni per le aziendeconminorepercentuale di contratti part time e proibizione dei licenziamenti collettivi nelle imprese in attivo.
Da una serie di misure per favorire il diritto alla casa, alla soppressione di posti inutili nella pubblica amministrazione. Dai provvedimenti fiscali (aumento delle imposte sulle grandi fortune, tassa sulle transazioni internazionali) a un controllo più rigido sul sistema bancario, con la nazionalizzazionedegliistitutiin difficoltà e la proibizione dei piani di salvataggio pubblici. E poi ancora: riforma della legge elettorale in senso proporzionale e referendum vincolanti su questioni di grande interesse.
Tra happening e rivoluzione
PROGRAMMA vastissimo, forse troppo, tanto che alla fine hanno deciso di limitarlo, almeno in partenza, a quattro punti essenziali:riformaelettorale,lotta contro la corruzione, separazione effettiva dei poteri, creazione di meccanismi di controllo della cittadinanza sulle decisionidellapolitica.Ilguaioèche, con le regole snervanti della democrazia strettamente assembleare che gli indignados si sono imposti, qualcuno comincia a dubitare che si possa arrivare a decisioni concrete. Ancora è presto per capire se ci troviamo di fronte a una versione riveduta e aggiornata del Maggio francese 1968 o, al contrario, a un grande e inconcludente happening. “Meno circo e più rivoluzione”, ammonisce un grande striscione affisso alla Puerta del Sol.
Ma lì, nel cuore della protesta, tra tende da campeggio e grandi stand, banchetti per la raccolta di firme e biblioteca, ufficio informazioni e capannelli dove chiunque prende in mano un megafono ed espone le proprie ragioni - al vecchio stile dello Speaker’s Corner londinese - si vede ormai un po’ di tutto. Compreso l’angolo “dell’amore e della spiritualità”, con sessioni di yoga e tai chi, massaggi orientali e momenti di riflessione. Con le telecamere dei grandi network puntate addosso - dalla Cnn alla Bbc ad Al Jazeera - i giovani della Spanish Revolution sentono il peso di una responsabilità forse troppo grande. Dimostrare che “costruire una democrazia migliore” è possibile. I migliori sociologi osservano, in parte smarriti, e cercano di capire.
Book bloc e nuovi poveri
C’È CHI, come Javier Elzo, specialista nel comportamento e nei valori della gioventù all’Università di Deusto, si chiede: “Cos’è rimasto dell’indignazione degli studenti francesi che lo scorso anno si ribellarono contro la riforma del sistema pensionistico?”. O, per citare un caso più recente, cosa resterà della mobilitazione dei book bloc britannici, in rivolta contro l’aumento delle tasse universitarie? In Portogallo, un movimento nato appena due mesi fa, “Geraçao a rasca” (generazione nei guai) sembra aver già esaurito la sua carica innovativa. Ma lo scontento per un modello economico che crea emarginati, precari e nuovi poveri, si è ormai esteso su scala continentale. E non è più limitato ai Paesi “fanalino di coda”. Persino la solida Germania scuote alle fondamenta la classe politica. Per il momento penalizzando alle urne i cristiano-democratici della cancelliera Angela Merkel, e premiandoiVerdicomenoneramai accaduto in passato. Il futuro dirà se il vento di Madrid, con le sue raffiche per ora irregolari ma ancora poderose, sarà capace di raggiungere l’intera Europa.
-
> IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. --- Quanto è accaduto in Nord’Africa, quanto sta accadendo in Spagna dovrebbe farci riflettere (di Anna Finocchiaro - La primavera impetuosa dei ragazzi del Mediterraneo).28 maggio 2011, di Federico La Sala
La primavera impetuosa dei ragazzi del Mediterraneo
Quanto è accaduto in Nord’Africa, quanto sta accadendo in Spagna dovrebbe farci riflettere: hanno ragione loro. In base a come sapremo rispondere si giocherà anche il futuro dell’Italia
di Anna Finocchiaro (l’Unità, 28.05.2011)
È un dato acquisito che le rivoluzioni scoppiate in tanti Paesi della sponda Sud del Mediterraneo abbiano sorpreso diplomatici, intelligence, osservatori politici. Mi pare altresì evidente che l’attenzione europea ma dell’Italia voglio parlare oggi stia esorcizzando quella sensazione di spaesamento che la sorpresa sempre conduce con sé, ripiegando l’attenzione quasi esclusivamente sulle conseguenze che quei rivolgimenti producono sulle politiche nazionali, e dunque sull’ondata migratoria, sull’impegno militare, sui rapporti di forza in ambito europeo.
Questioni molto serie, ma che rischiano di sottrarre all’analisi (forse anche alla curiosità di una conoscenza piena) proprio gli elementi di cambiamento di quelle rivoluzioni che, appunto, hanno spaesato una politica irrigidita dalle categorie della realpolitik, mostrandola incapace di cogliere quanto di straordinariamente forte, vitale e credibile, correva nel solco carsico delle società tunisine, egiziane, libiche, per fermarci ad esse.
Questo spostamento di attenzione può trasformarsi in un punto di debolezza del nostro Paese (e dell’Europa) suscettibile di produrre conseguenze negative anche di lungo periodo, mentre l’attenzione che il Presidente Obama ha manifestato in questi giorni, con la proposta per il prossimo G8 di Deauville, costituisce una indiretta conferma dell’importanza strategica di una relazione con quei Paesi che non sia stretta solo sul timore e sull’apprensione che oggi segna l’atteggiamento del governo italiano, tanto più evidente quanto più pesa l’interdetto politico della Lega. Colpiva, nella sua prima relazione al Senato, che il Ministro Frattini, qualificasse Lampedusa come "l’ultima frontiera d’Europa", inconsapevole che questo punto di vista (nel senso proprio) tradisse un errore prospettico grave, poiché i recenti eventi confermano il Mediterraneo come luogo geopolitico e geoeconomico tra i più interessanti del globo (e l’Amministrazione USA ne pare, al contrario, ben consapevole), e perché capovolgere quel punto di vista, e considerare Lampedusa e il Mezzogiorno italiano come la "prima" frontiera d’Europa nel Mediterraneo potrebbe essere assai utilmente speso sul tavolo europeo, magari con maggiore efficacia e successo di quanto non sia accaduto recriminando di essere stati lasciati soli nelle remote lande dell’ultima frontiera, in quell’ "hinc sunt leones" nel quale si rifugiavano antichi e inconsapevoli geografi e, oggi, trova riparo la pavida e snervata politica italiana.
Ma c’è dell’altro. Si è liquidata con troppa fretta un’ evidenza: a suscitare la rivolta sono stati giovani uomini e giovani donne. Il resto, tutto il resto, è venuto dopo. Il gesto di rottura, coraggioso e perentorio, la sua ineluttabilità è stato dei giovani di quei Paesi. Ragazzi e ragazze che hanno studiato e hanno utilizzato e sfruttato le nuove tecnologie per informarsi, mettersi in rete, parlare al mondo. Questo è. E se questo è accaduto in Nord Africa, con una forza e una credibilità ignota e a tutt’ oggi ignorata dalla esangue politica del nostro Governo, basta girare ancora un po’ la testa verso la Spagna e guardare i suoi ragazzi "indignados" per capire cosa sta succedendo.
Il vento si sta alzando, e riempirà ognuna delle nostre piazze, ed è bene che sia così. Hanno ragione loro. Su quanto saremo capaci di vederli e capirli per davvero, su quanto saremo capaci di rispondere e offrire, su quanto sapremo lasciargli spazio e potere e responsabilità giocheremo la partita che riguarda il futuro dell’Italia e dell’Europa.Per quanto mi riguarda credo che questa dell’autonomia e della libertà delle nuove generazioni sia proprio gerarchicamente la prima questione che il Paese deve affrontare. E non sono affatto convinta che possiamo pensare che essa si risolverà "di risulta", migliorando le condizioni generali di crescita del Paese. Non è così.
Quei ragazzi non sono solo "figli", non possiamo vederli solo attraverso i loro padri e le loro madri, sono persone che reclamano autonomia, libertà e piena cittadinanza. E quello che si manifesta è un nuovo soggetto politico, maschile e femminile, vitale e arrabbiato. Non riduciamoci a temere l’ira dei giusti e a fronteggiarla. Arriviamo, per una volta, prima pronti ad ascoltarla e accoglierla. Usiamo generosità. Quello che chiedono è placarla quell’ira, per trasformarla in forza. Loro e nostra.
-
> IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. ---- @rivoluzione. Giovani contro satrapi. “Twitter e le rivoluzioni” (di Giovanna Loccatelli)27 maggio 2011, di Federico La Sala
@rivoluzione. Giovani contro satrapi
Primavera araba, il contagio corre in rete
Le rivoluzioni del mondo arabo e il ruolo dei social network raccontate attraverso i messaggi su Internet dei giovani: è il libro di Giovanna Loccatelli “Twitter e le rivoluzioni” nelle librerie da oggi.
di Giovanna Loccatelli (il Fatto, 27.05.2011)
11 gennaio 2011. Sul blog collettivo Na waat.org un giovane ventenne tunisino scrive: “Al liceo e al collegio si ha sempre paura di parlare di politica. Ci sono informatori ovunque, ci viene detto. Nessuno osa discutere in pubblico [...] Siamo cresciuti con questa paura di impegnarci [...] Ed ecco che Wikileaks rivela quello che tutti mormorano. Ecco un giovane s’immola nel fuoco. Ecco, venti tunisini vengono ammazzati in un sol giorno. E per la prima volta vediamo l’occasione per ribellarci, per vendicarci di questa famiglia reale che si è presa tutto, per rovesciare quell’ordine stabilito che ha accompagnato tutta la nostra giovinezza”. Vive in un contesto di perenne paura la generazione di ventenni, povera, istruita, digitalizzata e senza lavoro fisso che, grazie ad Internet, conosce il mondo e rivendica i diritti dei coetanei virtuali, al di là dei propri confini .
LA RIVOLUZIONE, mediatica prima e reale poi, scoppia quando un ragazzo, Mohamed Bouazizi, si dà fuoco in un paesino vicino Tunisi. Le sue ultime parole su Facebook: “Me ne vado, mamma, perdonami, mi sono perduto lungo un cammino che non riesco a controllare, perdonami se ti ho disobbedito, rivolgi i tuoi rimproveri alla nostra epoca [...]”. La polizia, corrotta, gli aveva confiscato il suo carretto di frutta. Le foto fanno il giro del mondo grazie ai social network. Al Jazeera comprende, prima di tutti gli altri media tradizionali, il valore di quel materiale e nel giro di poche ore la notizia diventa globale. Il tam tam contagia tutti i media sociali, sbarca anche su youtube. [...] E poi la rivolta, con la velocità irrefrenabile della rete, arriva in Egitto. 8 febbraio 2011. @Ghonim “Non sono un eroe: sono soltanto abile con la tastiera del computer, gli eroi reali sono quelli in strada” dichiara Wael Ghonim, 30 anni, marketing manager di Google in Medio Oriente e Nordafrica. Ha orientato le masse giovanili della rivoluzione egiziana tenendo viva l’attenzione e la discussione online. Rapito dalla polizia e liberato dopo due settimane di reclusione subitotornainstradaetwittanelsuo microblog: @Ghonim “Piazza Tahrir è bloccata. Stiamo provando ad arrivare lì. Gli egiziani stanno facendo la storia”. Secondo Time è l’uomo più influente del 2011. Tanti, come lui, hanno twittato per strada con i propri cellulari.
La diffusione dei telefonini, non a caso, ha registrato un boom storico nel 2009: 45,6 milioni circa le utenze attive nel paese, con una popolazione di circa 80 milioni di persone. C’è pure, però, chi ha twittato le voci degli egiziani in tempo reale fuori da questi paesi, chiuso nella propria stanza. È il caso di John Scott-Railton. Studente californiano che, durante il blocco della rete messo in atto dal regime di Mubarak, ha fatto sì che le notizie provenienti dal Medio Oriente arrivassero in tutto il mondo. Come? Registrando da un telefono fisso le voci di egiziani e libici per poi pubblicarle nel suo account [...].
GLI ATTIVISTI raggruppano in un archivio on line, “I’m jan 25” tutto il materiale audiovisivo della rivoluzione. Un enorme contenitore che immortala le testimonianze della sanguinosa rivolta. La consapevolezza, diffusa tra i cittadini, della potenza dei social network è tale che tra gli egiziani in festa dopo le dimissioni di Mubarak è circolata una barzelletta sui tre presidenti. La barzelletta riguarda l’incontro dei tre in paradiso. Quando Nasser e Sadat vedono arrivare Mubarak gli chiedono come sia morto. “È stato il veleno o eri sul palco?”. “Nessuna delle due - risponde Mubarak - è stato Facebook” Che in inglese rende ancora di più: “I was facebooked!”.
E poi la Libia. Anche qui i giovani si sono uniti in un gruppo, ShababLybia, voce del Movimento dei giovani per la Libia. È un gruppo nato su face-book, ricreato su Twitter, che si ispira a quanto successo in Egitto. Mohammed Nabbous ha creduto, forse più di tutti, nella forza divulgatrice di questi strumenti. All’indomani dell’insurrezione del 17 febbraio, aveva fondato la Libya Alhurra tv, esempio massimo di giornalismo partecipativo. Un sito che trasmette quotidianamente i video degli scontri, le sparatorie, le mobilitazioni, e le vittime del regime di Gheddafi. [...] Su Twitter: @Nabbous “Non temo di morire ma ho paura di perdere la mia battaglia per la libertà della Libia”. È stato freddato da un cecchino di Gheddafi mentre riprendeva le rivolte in presa diretta con il mondo. Era una fonte, autorevole, per tanti giornalisti, sparsi nel globo.
Alla luce di questo viaggio virtuale: come sta cambiano pelle l’informazione globale? Difficile rispondere, è in atto però un esperimento, di successo, che si chiama Al Jazeera talk. Non esiste una redazione fisica, non esistono giornalisti dietro un computer in un ufficio, ma, esistono oltre 300 blogger sparsi nelle zone calde nel mondo che, in tempo reale, con il cellulare e un pc raccontano in diretta la storia.
AHMED ASHOUR, direttore di questa piattaforma, racconta: “Nei giorni del blocco totale di Internet, i giovani che si erano riversati a piazza Tharir hanno fatto circolare alcuni fogliettini di carta, con sopra diversi messaggi. Era imperativo, scritto nero su bianco, l’ordine di farli circolare il più possibile da una mano all’altra”. Questa, secondo Ashour, è la mentalità dei social network che si è fatta carne ed ossa nelle rivoluzione della “primavera araba”. Funzionerà in altri contesti? Ma una cosa è certa: queste sono le prime rivoluzioni 2.0 nell’era dell’informazione globale. Nulla sarà più come prima.
 Twitter e le rivoluzioni di Giovanna Loccatelli EDITORI RIUNITI, 240 PAGINE, 16 EURO
Twitter e le rivoluzioni di Giovanna Loccatelli EDITORI RIUNITI, 240 PAGINE, 16 EURO -
> IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. --- GIOVANI, INTERNET, E AGORA’: IL DIRITTO ALLA SPERANZA E UNA DEMOCRAZIA DA RINNOVARE (di Marc Lazar - Miguel Gotor - i Javier Moreno)26 maggio 2011, di Federico La Sala
Se gli invisibili della società si trasformano in movimento
Dalla Spagna alla Gran Bretagna, dalla Grecia all’Italia, la protesta dei giovani rappresenta una richiesta di rinnovamento della politica
Non è la prima volta nella storia che una mobilitazione di massa nasce sulla base di emozioni repentine e motivi morali
Partono da questioni molto materiali che poi diventano generali e inventano uno spazio pubblico nuovo che non è più quello della televisione
di Marc Lazar (la Repubblica, 26.05.2011)
Il movimento degli indignados presenta caratteristiche tradizionali e al tempo stesso aspetti piuttosto innovativi, che hanno una portata che va al di là della penisola iberica. Gli spagnoli non sono i soli a protestare contro il deterioramento della situazione sociale. Da mesi l’austerity introdotta nei vari Paesi europei si scontra con una resistenza sempre più forte. Il risultato è un crollo di popolarità dei capi di Governo, performances elettorali negative dei loro partiti o delle loro coalizioni e scioperi e manifestazioni di vasta portata, come ad esempio in Grecia, in Portogallo o in Gran Bretagna. Il malcontento si esprime dunque secondo modalità ben note in democrazia: disaffezione verso i leader al potere, rovesci elettorali, azioni collettive classiche.
Le proteste spagnole aggiungono indubbiamente un elemento nuovo a questo scenario. Innanzitutto perché sgorgano da legami spontanei creati inizialmente da internet, che è servita da cassa di risonanza di eventi-mondo o eventi-mostro (nel senso che schiacciano gli altri): i manifestanti di Madrid si ispirano al modello egiziano. In secondo luogo perché aggregano principalmente, ma non esclusivamente, giovani, come già era successo in Italia o in Gran Bretagna. Questi mileuristas (cioè i ragazzi che guadagnano mille euro al mese) come li ha definiti la romanziera spagnola Espido Freire, esprimono la loro collera. Hanno lauree su lauree ma non trovano lavoro (in Spagna un giovane su due al di sotto dei trent’anni non ha un impiego, e il tasso di disoccupazione è al 20 per cento) o sono sottoposti a un lunghissimo precariato che incide sugli altri aspetti della loro vita, come la possibilità di avere una casa o di crearsi una famiglia. In Spagna come in altri Paesi, i baby loosers, secondo la formula del sociologo Louis Chauvel, devono farsi carico del peso dei numerosi vantaggi ottenuti dai baby boomers. La vecchia Europa rischia di andare incontro a un vero e proprio clash of generations.
Ma il movimento spagnolo ha un altro aspetto ancora, quello dell’indignazione, eco del famoso saggio Indignatevi!, di Stéphane Hessel, diventato un best seller in Europa. Che una mobilitazione nasca per motivi morali e sotto la spinta di emozioni repentine non ha nulla di strano. In Sicilia, dopo i sanguinosi attentati contro il generale Dalla Chiesa nel 1982 e contro i magistrati Falcone e Borsellino nel 1992, una parte della società civile si sollevò contro la mafia. In Francia, l’avanzata del Fronte nazionale nel 1984 suscitò una mobilitazione dei giovani contro il razzismo con lo slogan «Non toccare il mio amico». Questi due esempi illustrano la differenza con le azioni a cui stiamo assistendo. Le lotte contro la mafia in Sicilia e contro il razzismo in Francia furono rapidamente strumentalizzate dai partiti politici, la Rete di Leoluca Orlando e il Pci in Italia e il Partito socialista di François Mitterrand in Francia.
L’indignazione non basta a fare una politica. I giovani spagnoli ne sono consapevoli e infatti intrattengono un rapporto ambivalente con la politica. Si scagliano contro il Governo, ma diffidano dell’opposizione, e temono qualsiasi strumentalizzazione. Contemporaneamente, elaborano riforme della legge elettorale, del Senato e del sistema dei partiti.
Additare il loro movimento come un fenomeno di antipolitica quindi sarebbe un grande errore. Al contrario, la loro esistenza attesta che l’Europa è in preda a processi contraddittori. Da un lato registra la spettacolare avanzata di partiti populisti che accusano le presunte élites di costituire un unico blocco uniforme, stigmatizzano i partiti di Governo, tessono le lodi del popolo eretto a unico detentore di qualsiasi verità, combattono l’immigrazione, sfruttano tutte le paure, patrocinano un ripiegamento sull’ambito locale, regionale o nazionale, rivendicano una democrazia plebiscitaria fondata su referendum riguardanti le problematiche più complesse e seducono gli strati popolari. Dall’altro lato vede svilupparsi mobilitazioni di altro genere che partendo da questioni molto materiali diventano via via più generali, inventano un nuovo spazio pubblico di deliberazione che non è quello della televisione, esigono trasparenza, intendono controllare i Governi, vogliono essere ascoltati, propongono di migliorare il funzionamento dei sistemi politici, sono aperti al mondo e creano una democrazia partecipativa in cui si riconoscono prevalentemente i rappresentanti dei ceti medi.
Certo, questa seconda tendenza è ancora incerta e fragilissima, e può rivelarsi effimera (soprattutto se a Madrid gli indignados falliranno nel loro tentativo di condizionare le politiche pubbliche, com’è successo finora alle mobilitazioni tradizionali dei loro padri), può essere oggetto di manipolazioni da parte di piccoli gruppi di militanti ed è fortemente contraddittoria quando si propone di inventare un’altra politica aggirando i rappresentanti eletti e le loro organizzazioni. Ma lancia una sfida reale a tutte le persone responsabili.
Come integrare questa ricerca di un modo migliore per vivere insieme e di una democrazia rinnovata? Se le élite politiche e i partiti classici rimarranno sordi a queste grida, se si accontenteranno di riformette di facciata invece di fornire risposte istituzionali in grado di ridisegnare l’agorà moderna e consentire di soddisfare questa profonda aspirazione alla partecipazione, rischieranno di deludere e aggravare ulteriormente la crisi della rappresentanza politica.
(Traduzione di Fabio Galimberti)
Internet si dimostra essere uno strumento che aiuta, un collante che riporta "l’agorà" al centro del dibattito pubblico.
Si disegna una sfida che viene portata ai partiti tradizionali
La rivincita della piazza
di Miguel Gotor (la Repubblica, 26.05.2011)
Dalle manifestazioni virtuali a quelle "esistenziali"
Per anni ci siamo cullati nell’idea che la piazza telematica avrebbe oscurato quella reale, ma gli ultimi avvenimenti rivelano che internet rappresenta un collante in grado di riportare l’agorà al centro del dibattito pubblico. Non la piazza virtuale, bensì quella esistenziale che si riempie di corpi, di colori e di "sentimenti contro", come l’indignazione e la rabbia.
L’ultima novità propagata dalla rete globale è il movimento M-15 di Spagna che ha suscitato le ansie comparativiste di una certa Italia perché quei manifestanti sono contro il governo (meglio se socialista), sostengono di disprezzare i partiti e, soprattutto, dichiarano di non essere di sinistra né di destra formando così un impasto malleabile, buono da spendersi nelle nostre contrade del "né-né". Assomigliano ai "grillini" - dicono - dimentichi del fatto che costoro si sono rapidamente costituiti in sigla organizzata intorno al loro furbissimo guru e ambiscono, legittimamente, oggi a occupare gli scranni comunali e, domani, quelli del vituperato parlamento. Quest’aspirazione a farsi subito partito, travestita col mantello del movimentismo anti-parlamentare, costituisce un abito nazionale dalla foggia antica ma sempre di moda. Eppure, si tratta di un proposito radicalmente diverso dalle buone intenzioni della gioventù spagnola, in cui il solo elemento di originalità in comune con i "grillini", ma anche con il "popolo viola" o con le recenti manifestazioni delle donne, sta nell’uso di internet come medium aggregativo mobilitante.
Certo, non bisogna mai smarrire il senso delle proporzioni. L’ultima volta che ci siamo indignati per davvero è stato quando abbiamo visto paragonare le piazze di Madrid a quelle di Bengasi, l’autunno spagnolo alla primavera araba. Come se fosse possibile mettere sullo stesso piano il costo di un sorriso arrabbiato a favore di videocamera con il sibilo di una pallottola in fronte sparata nel buio della repressione.
Piuttosto la piazza spagnola sembra un acquario in cui il conflitto è marginalizzato dentro un recinto che lo trasforma in inquietudine teatralizzata. I manifestanti sono consapevoli di avere subito un furto di presente e di futuro poiché si è rotta la rassicurante catena dell’hidalguía tra le generazioni: gli zii e i padri di quei ragazzi hanno abbondantemente mangiato sopra le loro spalle e la linea della vita lascia presagire che continueranno a pasteggiare ancora a lungo. In Spagna come in Italia. Non resta quindi che accucciarsi nel sacco a pelo del nostro scontento, gridando una rabbia e una paura che vivono in una dimensione anzitutto sentimentale ed emotiva. Come se fossero un tatuaggio, che segna un’identità e consente di riconoscersi, nonostante tutto.
Il problema, però, rimane sempre lo stesso: come trasformare la protesta in proposta, come rendere quell’acquario di visibilità autoreferenziale, amplificato dall’onda mediatica, un progetto collettivo conflittuale, che resti non violento? In questo sforzo si incontra necessariamente la mediazione della politica e - udite, udite - anche i partiti potranno svolgere un ruolo rinnovato se sapranno aprirsi e non chiudersi, respirando insieme e non contro la società civile. Sarà un caso, ma l’Italia si è bloccata da quando la società civile e i partiti hanno iniziato a guardarsi in cagnesco, ognuno pensando di poter fare a meno dell’altro.
Come essere degni, ogni giorno sempre di più, della propria indignazione? Questa è l’autentica sfida che interroga la buona politica, a Madrid come a Roma, perché è legata agli affanni comuni della nostra democrazia e ci dice anche che, da quella rabbiosa speranza di piazza, si può sempre ripartire.
_________________________________________________________________ Chi sono i ragazzi protagonisti a Madrid
Quel diritto alla speranza
Non sono molto difficili da capire i motivi di questo malessere. Almeno per chi riesce a ragionare fuori dagli schemi di un sistema infestato dal discredito dalla corruzione, dall’inefficienza e dall’impotenza
di Javier Moreno (la Repubblica, 26.05.2011)
Ancor prima di avere il diritto di chiederci, e di chiedergli, che cosa vogliano, perché protestino, che cosa propongano e quali siano i loro progetti per il futuro, prima ancora di criticare le loro ragioni o le loro richieste, è indispensabile sapere chi siano. Solo da ciò che sono, e non da ciò che chiedono, riusciremo ad estrarre un senso a ciò che sta accadendo oggi nelle piazze di Spagna, e forse domani d’Europa, la prima grande crisi della post-democrazia sotto la pressione della crisi economica e finanziaria mondiale.
Ed enunciare chi siano quelle decine di migliaia di persone è semplice: disoccupati che tirano avanti con lavori precari, orfani del presente; impiegati che a loro volta tirano avanti con lavori precari, orfani del futuro, con salari irrisori; giovani con condizioni di vita sempre più deteriorate, senza la possibilità di accedere a una soluzione abitativa decente, senza la possibilità di mettere su una famiglia, dolorosamente consapevoli del fatto che vivranno peggio della generazione dei loro genitori; pensionati con pensioni che non bastano per mangiare e arrivare alla fine del mese; universitari che credevano di aver raggiunto i propri sogni solo per scoprire che li attendono gli uffici di collocamento (il 43% dei giovani è disoccupato) o delle condizioni di lavoro così offensive, dei salari così infimi, dei contratti così precari, a volte di qualche giorno o di qualche settimana, in posti che non hanno niente a che vedere con ciò che hanno studiato all’università, da aver abbandonato qualsiasi speranza, capiamolo bene, da aver abbandonato qualsiasi speranza che il governo, i partiti politici, il sistema politico, o chiunque sia a capo di un’istituzione abbia la capacità o l’interesse di mettere rimedio alla loro situazione, alle loro situazioni.
Ci sembra strano? No. Sono così difficili da capire i motivi del loro malessere? Sicuramente, no. Non per chiunque sia ancora capace di pensare al di fuori degli schemi riduzionisti di una politica istituzionale infestata dal discredito, dalla corruzione, dall’inefficienza e dall’impotenza nell’offrire soluzioni quando le entrate dello Stato crollano per la crisi e i mercati impongono degli aggiustamenti sociali. Gli "indignados", tuttavia, oltre a essere quello che sono, si sono riuniti nelle piazze per esibire la lista delle loro richieste, per prendere la parola, per esporre le loro esigenze, la loro critica alla totalità della politica realmente esistente, ma anche, ahimè, le loro evocazioni rielaborate di esperimenti storici liberticidi di sventurata memoria, le loro illusioni antiparlamentari la cui applicazione in passato sfociò inevitabilmente in situazioni aberranti e abusi, oltre ai consueti slogan da cortile di facoltà, abbasso l’Fmi, confisca dell’edificio vuoto di una banca perché venga messo a disposizione, no all’economia, no alla politica, sia chiaro, no a questa politica, anche senza la capacità di formularne un’altra, che non è poi compito loro.
I partiti, di sinistra e di destra, possono ignorare gli "indignados" se vogliono, e sicuramente lo faranno facilmente quando questi cominceranno a diluirsi nei prossimi giorni, dopo avere esaurito l’esplosione di libertà e di energia dei giorni che hanno preceduto le elezioni. Gli "indignados" se ne torneranno a casa e scompariranno dalle piazze, ma non lo faranno il loro malessere, il loro futuro spezzato, i loro lavori precari, le loro basse pensioni, la loro mancanza di lavoro. Insisto: i partiti possono ignorarli, ma non lo faranno mettendo a rischio esclusivamente le loro aspettative politiche, che è l’unica cosa che sembrano capire. Lo faranno mettendo a rischio la stabilità e la validità morale dell’insieme del sistema democratico.
 traduzione di Luis E. Moriones
traduzione di Luis E. Moriones -
> IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. ---- La rabbia degli “Indignatos” che contagia l’Europa (di Bernard Guetta)25 maggio 2011, di Federico La Sala
La rabbia degli “Indignatos” che contagia l’Europa
di Bernard Guetta (Repubblica, 25.05.2011)
Una rivoluzione sta sorgendo in Europa. Non è violenta, ma pacifica. Non aspira a conquistare il potere, ma contesta le logiche economiche che fanno del mercato una potenza cui i governi devono inchinarsi. Sebbene - detto in altri termini - non sappia quello che vuole, essa sa di non volere più il mercato re, questo monarca anonimo che coi suoi "timori" o la sua "fiducia" decide le sorti del mondo.
Confusa e profonda a un tempo, questa rivoluzione si estende a tutto il continente, a incominciare da Puerta del Sol, la grande piazza di Madrid dove dieci giorni fa alcune centinaia di giovani hanno piantato le loro tende per gridare la rabbia di una generazione che sotto i 25anni è disoccupata al 50%. Sostenuto dall’immediata simpatia delle famiglie, che non possono ammettere di veder precluso fino a questo punto il futuro dei loro figli, questo movimento di protesta è cresciuto in fretta, attirando un numero crescente di aderenti ed espandendosi a una sessantina di altre città. In due parole, ha attecchito a tal punto che questi "indignati" - come hanno voluto chiamarsi, con riferimento al titolo del best-seller di Stéphane Hessel - hanno creato una nuova realtà politica.
Ecco cosa dimostra il successo di questa nuova piazza Tahrir: un’economia che offre solo prospettive di regresso sociale, e condanna un governo socialista a imporre drastiche misure di austerità per evitare il "panico" dei mercati, "non funziona". «Il liberismo non funziona», sostiene questo movimento, e lo dice con lo stesso tono di tranquilla evidenza a suo tempo usato da Margaret Thatcher per dichiarare: «Il comunismo non funziona». E questa constatazione ha dato luogo a non poche evoluzioni politiche.
È questa la causa della sconfitta dei socialisti spagnoli, che alle elezioni comunali e regionali di domenica scorsa sono rimasti indietro di dieci punti rispetto alla destra; ma anche di quella della destra tedesca, che dall’inizio dell’anno sta perdendo un Land dopo l’altro; e del precipitare della disgrazia di Silvio Berlusconi alle elezioni amministrative di dieci giorni fa; e della discesa agli inferi dei liberal-democratici britannici, colpevoli di aver approvato le restrizioni di bilancio volute dai loro alleati conservatori.
Questa constatazione giustificata penalizza le maggioranze al governo, sia di destra che di sinistra, costrette a sottostare alle ingiunzioni del mercato. Ma non è tutto. La presa d’atto dell’inefficienza della mano invisibile del mercato suscita il desiderio di nuove offerte politiche; determina in Germania il sorpasso dei Verdi rispetto ai social-democratici, relegati al secondo posto tra i partiti d’opposizione; restituisce spazio ai raggruppamenti a sinistra della sinistra; accomuna nella stessa riprovazione tutte le élite, e infine risuscita, un po’ dovunque in Europa, l’estrema destra. Quest’ultima squalificata dopo la fine della guerra, ora è uscita dall’ombra, perché gli effetti perversi della globalizzazione - deindustrializzazione europea, disoccupazione, peggioramento del tenore di vita - hanno rimesso in voga il cocktail avvelenato dei primi tempi del fascismo, ove alla nostalgia per lo Stato-provvidenza si univano temi quali la difesa dei confini nazionali entro i quali era avvenuto il suo sviluppo, il nazionalismo, le accuse indiscriminate ai politici ("tutti marci"), la lotta per il mantenimento delle conquiste sociali, la xenofobia.
L’Europa sta vivendo un momento inquietante: la rabbia senza prospettive, le attese senza una speranza tangibile rischiano di precipitarla in una crisi politica di grande portata. Se non troverà i suoi punti di riferimento, la rivoluzione che sta sorgendo rischia di perdersi in una palude senza scampo. Il pericolo è tanto grande da esigere una risposta urgente.
È urgente insistere su un punto: se anche le sinistre devono inchinarsi davanti ai mercati, non è perché sono vendute o cieche, ma perché dati i rapporti di forze, non hanno scelta. Tra democrazia e mercato il rapporto di forze si è ormai rovesciato. I pubblici poteri di uno Stato nazione - le istituzioni dello Stato, il governo - non possono fare granché a fronte del denaro, che è libero di andare a cercare i rendimenti più alti dove meglio crede. Nel caso europeo, i pubblici poteri dovrebbero avere dimensioni continentali per poter fronteggiare col loro peso un mercato globalizzato. Ecco perché dobbiamo costruire un’Europa politica in grado di regolamentare il mercato. Non di abolirlo, perché il comunismo "non funziona", ma di canalizzarlo e di domarne la forza, dato che anche il liberismo "non funziona".
Il crollo di Wall Street lo aveva dimostrato. Ma dopo il salvataggio da parte degli Stati, il potere del denaro si è lanciato in un nuovo assalto contro di essi, oggi un po’ più logorati dagli sforzi per ovviare ai guasti da quello stesso potere provocati. O la sinistra è europea, o non è. A questo deve tendere oggi il nostro impegno.
 Traduzione di Elisabetta Horvat
Traduzione di Elisabetta Horvat -
> IN SPAGNA, NELLA PIAZZA DEL NUOVO SOLE. --- Crisi, pagano giovani e donne. L’Istat: sono 2,1 milioni i ragazzi che non studiano e non lavorano.“Dove l’istruzione è di qualità migliore il Pil corre di più”24 maggio 2011, di Federico La Sala
 Il 18,8% di ragazzi in Italia lascia gli studi subito dopo gli anni dell’obbligo e non cerca lavoro.
Il 18,8% di ragazzi in Italia lascia gli studi subito dopo gli anni dell’obbligo e non cerca lavoro.
 In un anno il numero dei "Neet" è salito di 134.000 unità
In un anno il numero dei "Neet" è salito di 134.000 unità Quei sedicenni annoiati che abbandonano la scuola
Quei sedicenni annoiati che abbandonano la scuola
 così cresce la marea degli "inattivi": 2,1 milioni
così cresce la marea degli "inattivi": 2,1 milionidi Maria Novella De Luca (la Repubblica, 24.05.2011)
Una generazione rassegnata alla precarietà che non dà nessun valore all’educazione Gli esperti: "Aprire le aule, siamo l’unico paese che taglia l’istruzione in tempo di crisi" Il fenomeno della dispersione scolastica è forte anche nelle regioni ricche del Nordest
ROMA - La crisi arriva tra i 16 e i 17 anni: ci si sente grandi e le regole vanno strette, la scuola appare faticosa, noiosa, staccata dalla realtà, i prof, poveracci, degli adulti che guadagnano poco e si sgolano in classe, e il lavoro poi, un miraggio, una chimera, e studiare o non studiare in fondo è lo stesso. Storie di ragazzi che un giorno hanno detto no. Che una mattina hanno deciso di non entrare più in classe. Di buttare alle ortiche libri, quaderni, interrogazioni, compiti in classe, voti, giudizi. Ma anche le cose belle della scuola, come le gite, gli amici, lo sport.
C’è un numero enorme di giovani (il 18,8%) che in Italia continua ad abbandonare gli studi, subito dopo gli anni dell’obbligo, e che a vent’anni, quando si entra nell’età adulta, si ritrova sperduto, senza nulla in mano. Perché se è vero che il diploma conta poco, e la laurea poco di più, non averli vuol dire essere fuori, diventare invisibili, drop out, pronti ad entrare nell’esercito crescente dei Neet, quegli oltre due milioni di giovani italiani tra i 15 e i 29 anni, così si legge nel rapporto Istat 2011, che non lavorano, non studiano, non hanno formazione. Sono gli esiliati. Gli sfiduciati. in una parola Neet: not in education, employment or training. In un anno oltre 134 mila giovani in più espulsi o autoespulsi dal mondo produttivo.
C’è chi si aliena davanti al computer, nello stile degli hikikomori, quegli adolescenti che decidono che il mondo è nella loro camera da letto e nei rapporti virtuali della Rete. Oppure ci sono gli altri. Come Antonio, Camilla, Sharon, Lorenzo: basta entrare in un centro commerciale per trovarli. Passano il tempo guardando le cose, le merci, gli oggetti, ma non spendono, perché i soldi non ci sono, e i pochi a disposizione servono per il cellulare. Eccoli, a Roma, Cinecittà Due, megastore vicino agli storici studi cinematografici, ma loro non ci entrano, meglio l’aria condizionata indoor, la musica diffusa, l’odore di Big Mac.
Camilla, 18 anni: «Facevo l’alberghiero, ma ero sempre l’ultima della classe. Mi annoiavo. I professori mi trattavano male. A mia madre hanno detto che non riuscivo ad apprendere. Insomma che ero cretina. Ho lasciato, mi sono iscritta al collocamento, e adesso quando capita faccio la cameriera nei bar... Tanto anche se avessi preso il diploma avrei fatto comunque la cameriera». Diversa (ma uguale) la storia di Lorenzo, che di anni ne ha 17, Ipod nelle orecchie, e fino a gennaio scorso studente del liceo scientifico "Isacco Newton". «I miei genitori dicono che sono pazzo. Che finirò male. Ma io a scuola non ce la facevo più. Non mi interessa. Non mi servirà a trovare lavoro. Mio zio ha un’officina, magari mi aiuta. Però i miei compagni li vedo: li aspetto ogni giorno alle 13,30 all’uscita e ci andiamo a prendere una birra».
Storie normali. Di ragazzi normali. Per i quali però, spiega Milena Santerini, docente di Pedagogia Generale all’università Cattolica di Milano, «la scuola ha perso completamente di significato, la spiegazione non si trova soltanto nei dati economici, nella mancanza di cultura delle famiglie d’origine, è che i giovani non capiscono più il senso di passare tanto tempo tra i banchi, tra professori che utilizzano un linguaggio anni luce lontano dal loro, in una società che anno dopo anno svaluta sempre di più il ruolo della cultura». E una fascia di giovanissimi, forse la più fragile, ormai cresciuta nella rassegnazione al precariato, aggiunge Milena Santerini, «alla prima difficoltà lascia, pensando magari di potercela fare con altri mezzi, in una visione irrealistica di sé e del mondo che li circonda».
Certo, non ci sono soltanto i potenziali Neet tra coloro che abbandonano la scuola. Perché la dispersione scolastica, il fenomeno è noto, è alta e costante anche nelle regioni ricche, dove il lavoro, seppure più scarso, c’è ancora. E allora i teenager del Nord Est mollano e vanno a bottega, racconta lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, che ne ha seguiti diversi nelle industrie del bresciano e del vicentino. «Questi ragazzi non capivano proprio perché continuare a perdere tempo all’istituto tecnico, quando potevano entrare nell’aziendina di famiglia e farsi le ossa, avendo anche un po’ di soldi in tasca. Non ho visto alcuna nostalgia della scuola in loro, ma anzi l’orgoglio di chi ha abbandonato un luogo da ragazzi, con i compiti, i prof, per entrare prestissimo nel mondo adulto... Ma questi sono i "fuggitivi" più fortunati. Chi lascia la scuola e non ha il paracadute del lavoro rischia grosso, rischia la deriva, il branco, rischia di deprimersi e chiudersi in se stesso».
E allora le famiglie corrono ai ripari. «I miei dicono che potrei fare due anni in uno privatamente, mi aiuteranno...». «Siamo l’unico paese in Europa che in tempo di crisi ha tagliato sulla scuola - dice sconfortato un pedagogista famoso, Benedetto Vertecchi - e poi ci meravigliamo se gli studenti se ne vanno. Apriamo le aule il pomeriggio, facciamoli suonare, fare teatro, laboratori, rendiamo la scuola un contenitore di vita e non soltanto di nozioni. I ragazzi non fuggiranno più. Ci hanno provato in Finlandia e il tasso di dispersione è drasticamente crollato. Perché non possiamo provarci noi?».
Intervista
Eric Hanushek. Sarà ospite oggi del convegno della Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo
“Dove l’istruzione è di qualità migliore il Pil corre di più”
L’Istat: sono 2,1 milioni i ragazzi che non studiano e non lavorano. In 800 mila senza impiego perché mamme
Crisi, pagano giovani e donne
Redditi in calo: più debiti e meno risparmi per mantenere il tenore di vita
di Tonia Mastrobuoni (La Stampa, 24.05.2011)
È uno dei maggiori studiosi al mondo del rapporto tra istruzione e crescita economica. Sarà ospite del convegno della Fondazione per la scuola della Compagnia Sanpaolo su «La sfida della valutazione» che si apre oggi a Torino. Ma l’arrivo dell’economista di Stanford Eric A. Hanushek nel giorno del rapporto dell’Istat è l’occasione per allargare il campo dalla stretta analisi sugli effetti benefici dell’istruzione a uno sguardo sul futuro del Paese.
Professore, c’è un rapporto tra la pessima media che risulta ormai ogni anno dai test Pisa Ocse sui rendimenti scolastici degli studenti italiani e il decennio di «crescita perduta», certificata dall’Istat?
«C’è un rapporto chiarissimo che rileviamo da tempo tra i tassi di crescita dei Paesi dell’Ocse e i risultati dei test Pisa. I paesi che fanno meglio, soprattutto nelle scienze, sono quelli che crescono di più. È un grande problema per l’Italia, all’inverso, avere da dieci anni risultati sotto la media Ocse. Se fosse come la Finlandia, i benefici sul Pil sarebbero di 16 miliardi di euro».
Fino agli anni Duemila il sistema scolastico finlandese era considerato pessimo. Adesso è in cima alla lista dei Paesi con i migliori rendimenti. Come ha fatto?
«A mio parere il loro segreto è l’importanza capitale che hanno assegnato alla scuola e al miglioramento dell’insegnamento, in questi ultimi anni. Così sono riusciti a conquistare per le scuole, ad esempio, i laureati migliori».
In Italia non avviene spesso.
«Infatti. E aggiungerei un altro elemento: i sindacati degli insegnanti in Finlandia lavorano assieme alle scuole per migliorare la qualità delle lezioni».
Quindi, come bisogna procedere?
«La prima cosa da fare è misurare il livello degli studenti. Poi bisogna premiare gli insegnanti che fanno bene il loro lavoro e aiutare quelli che non lo fanno bene a trovarsi un’altra occupazione...»
In Italia è inimmaginabile.
Anche negli Stati Uniti c’è un dibattito su questo. È anche un problema culturale, ovvio, oltre che sindacale. Ma per gli Usa abbiamo calcolato che se si sostituisse il 5-10% degli insegnanti peggiori con insegnanti di livello medio, le scuole americane raggiungerebbero la Finlandia. E lo stesso discorso vale per l’Italia. Si tratta di un cambiamento piccolo ma che avrebbe effetti enormi».
Come sono gli insegnanti italiani?
«Mancano troppi elementi per valutarli. Quando è stato fatto, finalmente, negli Stati Uniti, c’è stata una drammatica presa di coscienza su quanto fosse stato importante farlo...»
C’è una polemica sull’Invalsi italiano, c’è chi la sta boicottando.
«Lo so. Ma torno a dire che i test misurano cose importanti. Le persone che hanno punteggi più alti guadagneranno di più, nella vita, avranno carriere migliori. Si possono sempre migliorare, ma non bisogna mai dire che i test non contano. È falso».