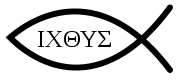
La "Caritas in Veritate" presentata senza grazia ("charis") e senza acca ("h"), il 7 luglio 2009 (avanti Cristo).
martedì 7 luglio 2009."Caritas in Veritate", Introduzione - pf. 2:
[...] Per la Chiesa - ammaestrata dal Vangelo - la carita` e` tutto perche’, come insegna san Giovanni (cfr 1 Gv 4, 8.16) e come ho ricordato nella mia prima Lettera enciclica, «Dio e` carita`» (Deus caritas est): dalla carita` di Dio tutto proviene, per essa tutto prende forma, ad essa tutto tende. La carita` e` il dono piu` grande che Dio abbia dato agli uomini, e` sua promessa e nostra speranza. [...] "Caritas in Veritate", Introduzione - pf. 2. Cfr.: testo integrale
TESTO EVANGELICO: "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST"(1 Gv., 4.1-16)
 Global Ratzinger
Global Ratzinger
 Si intitola Caritas in veritate la nuova enciclica di papa Ratzinger, presentata proprio alla vigilia del G8 e tutta incentrata sui grandi temi posti dalla globalizzazione dell’economia e dei suoi effetti sulla vita delle persone. "L’espresso" ne pubblica qui il testo integrale.
Si intitola Caritas in veritate la nuova enciclica di papa Ratzinger, presentata proprio alla vigilia del G8 e tutta incentrata sui grandi temi posti dalla globalizzazione dell’economia e dei suoi effetti sulla vita delle persone. "L’espresso" ne pubblica qui il testo integrale.
 LEGGI TUTTA L’ENCICLICA
LEGGI TUTTA L’ENCICLICA
 (l’Espresso, 07 luglio 2009)
(l’Espresso, 07 luglio 2009)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
Forum
-
> La "Caritas in Veritate" presentata senza grazia ("charis") e senza acca ("h") ---- Al prossimo G20 inviterei il Papa a esporre i problemi dell’economia mondiale, è l’unico che sembra averli capiti (di Loretta Napoleoni).28 ottobre 2009, di Federico La Sala
L’economista Napoleoni: il G20 ascolti Ratzinger
Esce a giorni il numero di novembre della rivista «Mondo e missione», diretta da Gerolamo Fazzini, interamente dedicato all’enciclica del Papa. Uno speciale di 100 pagine intitolato «Good economy» da cui qui anticipiamo la riflessione dell’economista Loretta Napoleoni.
DI LORETTA NAPOLEONI (Avvenire, 28.10.2009)
Al G20 tutti avrebbero dovuto leggere l’enciclica del Papa Caritas in veritate per capire il ruolo dell’economia nella società civile. Lo stesso che aveva prima della globalizzazione, lo stesso che ha sempre avuto e cioè di essere al servizio della comunità e non del singolo individuo.
Il Papa ci ricorda la bellezza e l’importanza del dono, è questo un linguaggio religioso che potrebbe suonare stonato a Piazza Affari, ma dietro i principi etici del cattolicesimo e di tutte le religioni ritroviamo i cardini della vita in società. Il dono si riferisce alla redistribuzione del reddito, un valore che in finanza è scomparso con l’avvento delle politiche fiscali neo-liberiste, politiche che hanno ridotto l’imposizione fiscale alle fasce più ricche della popolazione. Lo scopo era naturalmente quello di incoraggiarle a spendere e così facendo di sostenere la crescita economica. Ma la crisi del credito e la recessione hanno dimostrato che nessuno, neppure la mano magica del mercato descritta da Adam Smith, si può sostituire allo Stato: solo lo Stato, quale espressione della comunità, può vigilare che la filosofia del dono guidi l’attività economica.
Il Papa ci ricorda che aiutarci a vicenda è benefico per tutti, per la società, per i poveri ed anche per i ricchi. Un mondo dove non ci sono povertà, ingiustizia e discriminazione economica è un mondo felice. Ce lo siamo dimenticato negli ultimi anni perché in preda alla deregulation finanziaria abbiamo perseguito soltanto i nostri interessi personali. Non è vero che l’egoismo è la molla che fa crescere il mercato. Non era vero neppure ai tempi di Adam Smith. Se osserviamo la società che il padre dell’economia moderna studiava, ci rendiamo conto che non era equa. La ricchezza delle nazioni non può essere misurata con un numero, il Pil, e basta: bisogna anche tener presente come questa ricchezza è distribuita, quali opportunità crea per i meno fortunati. Se gettiamo uno sguardo oltre i nostri confini, alla periferia del villaggio globalizzato, ci accorgiamo che i sistemi economici che hanno sofferto meno a causa della crisi del credito sono proprio quelli dove il fulcro dell’economia era rappresentato dalla comunità e non dall’individuo: la finanza islamica e l’economia cinese. La prima ha schivato la crisi grazie al codice etico incorporato nella sua struttura finanziaria, un codice che s’ispira alla legge coranica, alla sharìa; la seconda ha tenuto a debita distanza l’alta finanza grazie ai principi economici del socialismo.
L’esperienza islamica e quella cinese provano che è possibile produrre un modello diverso da quello celebrato a Wall Street, che il mercato deve essere funzionale alla crescita economica equa e non può essere lasciato a se stesso. Lo scopo dell’economia non deve essere il profitto e basta, bensì l’uso della ricchezza per migliorare la società. Eppure queste verità sembrano non essere state raccolte dai potenti della terra, i quali - dopo essersi congratulati tra di loro per aver evitato una seconda grande depressione - non hanno fatto nulla per riformare il sistema economico e finanziario globale.
Le parole del Papa vanno dritte al nocciolo del problema: il sistema così com’è strutturato ha perso di vista la ragione per la quale esiste, ossia la comunità. Ecco perché le crisi economiche saranno sempre più frequenti e più serie. Quando lo Stato non è in grado di reagire, è giusto ascoltare le parole di chi protegge la nostra spiritualità. Al prossimo G20 inviterei il Papa a esporre i problemi dell’economia mondiale, è l’unico che sembra averli capiti.
-
> La "Caritas in Veritate" --- A Genova un convegno sull’enciclica «Caritas in veritate», nel Palazzo della Borsa Valori. Il testo della lectio del cardinale Bagnasco.20 settembre 2009, di Federico La Sala
A Genova un convegno sull’enciclica «Caritas in veritate»
Il primo e principale fattore di sviluppo
La saldatura tra etica sociale ed etica della vita è un imperativo categorico
Pubblichiamo integralmente il testo della lectio magistralis che il cardinale arcivescovo di Genova, che è presidente della Conferenza episcopale italiana, ha tenuto sabato 19 settembre nel Palazzo della Borsa Valori di Genova in occasione del convegno "Caritas in veritate. Lettera enciclica di Papa Benedetto XVI". All’incontro, introdotto da Davide Viziano, presidente dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti, e da Paolo Odone, presidente della Camera di Commercio di Genova, sono intervenuti anche Bernard Scholz, presidente della Compagnia delle opere, e l’economista Ettore Gotti Tedeschi.
di Angelo Bagnasco *
La terza enciclica di Benedetto XVI si snoda con coerente linearità rispetto alle due precedenti (Deus caritas est e Spe salvi) e porta alla luce una connessione che è presente già nello stesso titolo e cioè che "solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta" (n. 3). Come è noto, il Papa parte da questa persuasione per rileggere in modo critico la res sociale di oggi, che va sotto il nome di globalizzazione e che pone una sfida inedita. Infatti "il rischio del nostro tempo è che all’interdipendenza di fatto tra gli uomini non corrisponda l’interazione etica delle coscienze e delle intelligenze" (n. 9). Per questo si richiede non solo una volontà determinata, ma ancor prima un pensiero lucido che sappia proporre "una visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, culturali e spirituali" (n. 31) dello sviluppo. Insomma si richiede "l’allargamento del nostro concetto di ragione e dell’uso di essa", secondo il pressante appello che muove - sin dal suo inizio - il magistero di Benedetto XVI (cfr. Discorso di Ratisbona).
Il richiamo esplicito a Paolo vi e alla Populorum Progressio (19 67), così come quello indiretto alla Sollicitudo rei socialis (1987) di Giovanni Paolo ii, diventa nella riflessione di Benedetto XVI lo spunto per una importante affermazione di carattere generale e cioè la riaffermazione della Dottrina sociale come un "corpus dottrinale" (n. 12), che affonda le sue radici nella fede apostolica e si colloca a pieno titolo nell’alveo della Tradizione, secondo un processo di rigorosa continuità. Così facendo il Santo Padre intende chiarire il suo punto di vista, che non è ispirato da alcuna situazione sociologicamente intesa, ma rispecchia una precisa prospettiva teologica e cioè che "l’annuncio di Cristo è il primo e principale fattore di sviluppo" (n. 8).
La percezione della sfida e l’esigenza di un nuovo pensiero (non solo economico-sociale) in grado di dire al meglio la novità dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti e che proprio la recente crisi finanziaria ha ancor più aggravato, spinge a riconsiderare luoghi comuni e pregiudizi inveterati per addentrarci dentro una interpretazione originale del fatto umano della globalizzazione. Guidano la riflessione della Caritas in veritate due presupposti, da cui scaturisce una prospettiva di grande respiro per la vita della società e della Chiesa.
I due presupposti di fondo sono da un lato la convinzione che lo sviluppo non è solo una questione quantitativa, ma risponde piuttosto a una vocazione e dall’altra il fatto che la giustizia, pure necessaria, non è autosufficiente perché esige la carità, così come la ragione ha bisogno della fede. La prospettiva che emerge è dunque "una visione articolata dello sviluppo" (n. 21), che porta a ritenere come la questione sociale sia oggi inscindibilmente legata alla questione antropologica. Vorrei ora, sia pure brevemente, sviluppare questi tre aspetti per giungere a una osservazione di fondo conclusiva.
Affermare che "il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l’uomo, la persona, nella sua integrità: l’uomo infatti è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale" (n. 25) significa sottrarre a un cieco determinismo la lettura della globalizzazione e ribadire che anche questo complesso fenomeno è legato alla variabile umana. Non si dà cioè la fatalità di attenersi solo a dati ritenuti oggettivi e scientifici dimenticando quanto la componente umana giochi un ruolo decisivo nelle scelte che di volta in volta vengono prese.
Ciò fa comprendere che lo sviluppo non è un processo rettilineo, quasi automatico e di per sé illimitato, ma è determinato dalla qualità umana degli attori chiamati in causa. Per questo Benedetto XVI invita a una interpretazione che non si accontenta della semplice analisi delle strutture umane, ma rimanda a un livello più profondo. "In realtà - egli scrive - le istituzioni da sole non bastano, perché lo sviluppo umano integrale è anzitutto vocazione e, quindi, comporta una libera e solidale assunzione di responsabilità da parte di tutti. Un tale sviluppo richiede, inoltre, una visione trascendente della persona, ha bisogno di Dio: senza di Lui lo sviluppo o viene negato o viene affidato unicamente alle mani dell’uomo, che cade nella presunzione dell’autosalvezza e finisce per promuovere uno sviluppo disumanizzato" (n. 11).
Ciò richiede un preciso esame di coscienza, cui l’enciclica non si sottrae, facendo riferimento ai progressi effettivamente fatti o non fatti nella direzione auspicata dalla Populorum Progressio. Certamente molti risultati sono stati raggiunti, ma la Fao - ancora lo scorso 19 giugno - ha comunicato le sue nuove stime: la fame nel mondo raggiungerà un livello storico nel 2009 con 1,02 miliardi di persone in stato di sotto nutrizione.
La pericolosa combinazione della recessione economica mondiale e dei persistenti alti prezzi dei beni alimentari in molti Paesi ha portato circa 100 milioni di persone in più rispetto all’anno scorso oltre la soglia della denutrizione e delle povertà croniche. L’enciclica rende avvertiti che "gli attori e le cause sia del sottosviluppo sia dello sviluppo sono molteplici, le colpe e i meriti sono differenziati". Per poi aggiungere: "Questo dato dovrebbe spingersi a liberarsi dalle ideologie, che semplificano in modo spesso artificioso la realtà, e indurre a esaminare con obiettività lo spessore umano dei problemi" (n. 21). Infatti "i costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani" (n. 32).
Non si fatica d’altra parte a capire che "l’aumento massiccio della povertà... non solo tende a erodere la coesione sociale, e per questa via mette in crisi la democrazia, ma ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del "capitale sociale", ossia quell’insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza civile" (ibidem). Solo se lo sviluppo è una vocazione e non un destino si può sperare di avere ancora margini di cambiamento e soprattutto di trasformazione. Infatti "nonostante alcune sue dimensioni strutturali che non vanno negate ma nemmeno assolutizzate, "la globalizzazione, a priori, non è né buona né cattiva. Sarà ciò che le persone ne faranno". Non dobbiamo esserne vittime, ma protagonisti, procedendo con ragionevolezza, guidati dalla carità e dalla verità" (n. 42).
Ma come aiutare la ragione a non cedere a una lettura rassegnata della realtà e soprattutto come aiutarla a far emergere le potenzialità che sono dentro la risorsa che è l’uomo? Una risposta sta certamente nel fatto che già nella Deus caritas est (n. 28), la Dottrina sociale della Chiesa venga presentata come il luogo in cui la carità purifica la giustizia. Questa purificazione, peraltro, non è altro che un momento di quella più ampia purificazione che la fede è chiamata a esercitare nei riguardi della ragione.
Il concetto di "purificazione" è tutt’altro che negativo, come potrebbe sembrare a prima vista ed è agli antipodi della semplice negazione o della pura condanna. Ciò vuol dire che la giustizia è assunta ma allo stesso tempo potenziata dalla carità. Tra queste due realtà c’è insomma una relazione che va in entrambe le direzioni: per un verso non c’è carità senza giustizia perché si tratterebbe di semplice assistenzialismo, per altro verso non si dà giustizia senza carità perché si finirebbe nelle secche di un arido legalismo.
Arrivare a intuire l’eccedenza e ancor prima la necessità della carità, vista l’insufficienza della giustizia, è però il frutto di una intuizione che va ben oltre la semplice ragione. Si richiede il recupero di una categoria, quella della fraternità, che, non a caso, Benedetto XVI pone in testa alla relazione tra sviluppo economico e società civile al capitolo terzo della Veritas in caritate. La grande sfida che abbiamo davanti "è di mostrare, a livello sia di pensiero sia di comportamenti, che non solo i tradizionali principi dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma che anche nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della fraternità devono trovare posto entro la normale attività economica" (n. 36).
Nasce da qui una interessante serie di riflessioni che spaziano dentro il ruolo del non profit e alludono all’ibridazione dei comportamenti economici e delle imprese, aprendo ad approcci inabituali nell’interpretazione dei rapporti internazionali. Per arrivare a un’affermazione forte: "Lo sviluppo dei popoli dipende soprattutto dal riconoscimento di essere una sola famiglia" (n. 53). Questa chiara affermazione che dal Vaticano ii (Gaudium et spes, n. 77) è un punto fermo richiede in realtà "un nuovo slancio del pensiero" e obbliga "a un approfondimento critico e valoriale della categoria della relazione. Si tratta di un impegno che non può essere svolto dalle sole scienze sociali, in quanto richiede l’apporto di saperi come la metafisica e la teologia, per cogliere in maniera illuminata la dignità trascendente dell’uomo" (n. 53). In tal modo il Papa si fa carico, ancora una volta, di restituire dignità alla domanda su Dio e di riaprire all’interno del dibattito pubblico la questione della fede (cfr. n. 56), che è chiamata a purificare la ragione, così come la carità orienta e finalizza la giustizia, se il mondo non vuole soccombere alle sue logiche disumanizzanti.
Si comprende allora perché il Vangelo si riveli il maggior fattore di sviluppo e, di conseguenza, perché la Chiesa dia il proprio apporto allo sviluppo anzitutto quando annuncia, celebra e testimonia Cristo, quando, cioè, adempie alla propria missione di evangelizzazione.
Il punto di approdo di quanto detto sul rapporto tra giustizia e carità e la prospettiva più originale del testo pontificio è ricondurre la questione sociale alla questione antropologica, marcando la necessaria correlazione che esiste tra queste due dimensioni che stanno o cadono insieme. Per questo Benedetto XVI propone con forza il collegamento tra etica della vita ed etica sociale, dal momento che non può "avere solide basi una società che - mentre afferma valori quali la dignità della persona, la giustizia e la pace - si contraddice radicalmente accettando e tollerando le più diverse forme di disistima e violazione della vita umana, soprattutto se debole ed emarginata" (n. 15). In concreto, questo vuol dire che lo sviluppo vero non può tenere separati i temi della giustizia sociale da quelli del rispetto della vita e della famiglia e che sbagliano quanti in questi anni, anche nel nostro Paese, si sono contrapposti tra difensori dell’etica individuale e propugnatori dell’etica sociale. In realtà le due cose stanno insieme.
Un esempio eloquente è dato dalla crescente consapevolezza che la questione demografica, che attiene certamente alla dinamica affettiva e familiare, rappresenti pure uno snodo decisivo delle politiche economiche e perfino del Welfare. Aver sottovalutato l’impatto della famiglia sul piano sociale ed economico riconducendola a una questione privata, quando non addirittura ad un retaggio culturale del passato, è stata una miopia di cui oggi pagano le conseguenze soprattutto le generazioni più giovani, sempre meno numerose e sempre meno importanti. La saldatura tra etica sociale ed etica della vita è un imperativo categorico anche in altri ambiti sensibili e porta a convincersi ad esempio che l’eugenetica è molto più preoccupante della perdita della biodiversità nell’ecosistema o che l’aborto e l’eutanasia corrodono il senso della legge e impediscono all’origine l’accoglienza dei più deboli, rappresentando una ferita alla comunità umana dalle enormi conseguenze di degrado. Come sottolinea con vigore il Papa: "Se si perde la sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono" (n. 28).
Ancora una volta l’enciclica aiuta a far emergere un più profondo senso dello sviluppo che sa porre in relazione i diritti individuali con un quadro di doveri più ampio, aiutando così ad intendere correttamente la libertà individuale che deve sempre fare i conti anche con la responsabilità sociale. Taluni fenomeni di degrado politico cui assistiamo oggi e che rivelano mancanza di progettualità e resa ad interessi di corto respiro, così come recenti episodi di abbruttimento finanziario che hanno portato al collasso del sistema economico, colpendo le fasce più deboli dei risparmiatori, confermano che l’etica sociale si regge soltanto sulla base della qualità delle singole persone. Lo dice espressamente il Papa: "Lo sviluppo è impossibile senza uomini retti, senza operatori economici e uomini politici che vivano fortemente nelle coscienze l’appello del bene comune" (n. 71).
Concludo, facendo riferimento a un tema che ha colpito la pubblica opinione e che può rappresentare una sorta di controprova sperimentale della validità della lettura dello "sviluppo integrale", che Benedetto XVI propone a tutti gli uomini di buona volontà, sulla scia della grande intuizione della Populorum progressio di Paolo vi. Mi riferisco al tema dell’ambiente, cui è espressamente dedicata una parte significativa del capitolo IV (nn. 48-52) e che rileva una ricorrente preoccupazione nel magistero dell’attuale Pontefice. Scrive Benedetto XVI: "La Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l’acqua e l’aria come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di se stesso. È necessario che ci sia qualcosa come un’ecologia dell’uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della natura è infatti strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana: quando l’ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio" (n. 51).
La crisi ecologica dunque non può essere interpretata come un fatto esclusivamente tecnico, ma rimanda ad una crisi più profonda perché ai "deserti esteriori" corrispondono "i deserti interiori" (cfr. Benedetto XVI, Omelia per l’inizio del Ministero petrino, 24 aprile 2005), così come alla morte dei boschi "attorno a noi" fanno da pendant le nevrosi psichiche e spirituali "dentro di noi", all’inquinamento delle acque corrisponde l’atteggiamento nichilistico nei confronti della vita. Quando infatti l’uomo non viene considerato nell’integralità della sua vocazione e non si rispettano le esigenze di una vera "ecologia umana" si scatenano le dinamiche perverse delle povertà, compromettendo fatalmente anche l’equilibrio della Terra. Una prova ulteriore, se ce ne fosse ancora bisogno, che "il problema decisivo dello sviluppo è la complessiva tenuta morale della società" (n. 51).
La crisi in atto mette in evidenza dunque la necessità di ripensare il modello economico cosiddetto "occidentale", come, del resto, già auspicato nella Centesimus annus (1991). Ma lo sguardo dell’enciclica è tutt’altro che pessimista o fatalista. Al contrario con realismo apre al futuro con il seguente invito che intendo fare mio: "La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento presente" (n. 21).
* ©L’Osservatore Romano - 20 settembre 2009
-
> La "Caritas in Veritate" presentata senza grazia ("charis") e senza acca ("h") --- ’I 4 gatti che ascoltano il Papa’, polemica per un servizio del Tg3.14 luglio 2009, di Federico La Sala
’I 4 gatti che ascoltano il Papa’, polemica per un servizio del Tg3 *
E’ polemica per un servizio del Tg3 andato in onda ieri sera sulla partenza del Papa per le vacanze." Il Pontefice troverà il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un ombrellone sotto cui mangiare e leggere, un barbecue e due gatti", dice il vaticanista Roberto Balducci. "Gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po’ di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole". Una frase forse dall’intento ironico e certamente non offensivo, ma che ha scatenato un putiferio bipartisan.
Immediate le polemiche politiche: "E’ singolare ed inconsueto che una testata importante come il Tg3 scivoli in questa anacronistica, e volgare, deriva anticlericale", ha dichiarato il vicepresidente della vigilanza Rai, il democratico Giorgio Merlo. Ma il direttore Di bella conferma «La linea editoriale del Tg3 è stata sempre caratterizzata da grande attenzione e rispetto per il magistero della Chiesa e la figura del Pontefice».
«Prendo atto delle dichiarazioni del direttore del Tg3 Di Bella e mi auguro quindi che il telegiornale della terza rete sia sempre, come egli dice, effettivamente caratterizzato da attenzione e rispetto per la Chiesa e per la figura del papa». Lo ha detto il portavoce vaticano padre Federico Lombardi in merito al servizio del Tg3 di ieri sera sulle vacanze del papa.
Tra l’altro l’inizio delle vacanze in Val d’Aosta è stato movimentato anche da un episodio che ha avuto per protagonista un giornalista vallese accreditato, fermato e identificato per aver fatto una domanda al Pontefice. È accaduto oggi a Les Combes di Introd, durante l’arrivo di Papa Benedetto XVI, a Roberto Guscelli, giornalista pubblicista, collaboratore del settimanale valdostano La Vallee Notizie. «Quando il Papa si è avvicinato al gruppo di giornalisti accreditati - ha riferito Guscelli - gli ho chiesto se, dopo il recente G8, ritenesse che ci fosse più speranza per i paesi poveri dell’Africa».
Dopo qualche istante, ha riferito ancora il cronista, «sono stato trascinato da due gendarmi in un ufficio poco distante, dove sono stato identificato e mi è stato ritirato l’accredito. Gli agenti mi hanno spiegato che non avrei dovuto rivolgere una domanda direttamente al Papa». «Dopo l’intervento di alcuni responsabili della gendarmeria vaticana - ha proseguito il giornalista - il pass mi è stato restituito e tutto si è risolto con una stretta di mano».
* l’Unità, 13 luglio 2009
-
> La "Caritas in Veritate" presentata senza grazia ("charis") e senza acca ("h") --- QUATTRO GATTI? UN ESERCITO ... il vaticanista del Tg3, Roberto Balducci è stato rimosso dal suo incarico.14 luglio 2009, par Federico La Sala
 Papa, rimosso vaticanista Tg3
Papa, rimosso vaticanista Tg3
 dopo le polemiche su un servizio
dopo le polemiche su un servizioLES COMBES (Valle d’Aosta) - E’ stato rimosso dal suo incarico, dopo le polemiche scoppiate ieri a causa di un servizio sul Papa, il vaticanista del Tg3, Roberto Balducci. Ne danno notizia fonti della redazione del Telegiornale.
Il servizio era andato in onda domenica nell’edizione delle 19. Parlando della partenza di Benedetto XVI per le vacanze in Valle d’Aosta, il giornalista aveva dato l’impressione di ironizzare sui pochi fedeli che ancora seguirebbero il Pontefice: "Quattro gatti, forse un po’ di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole".
L’espressione usata da Balducci aveva scatenato una ridda di critiche. Il vicepresidente della Vigilanza Rai, Giorgio Merlo (Pd), aveva parlato di "deriva anticlericale" della terza rete, definendola "singolare e volgare". Il direttore del Tg3, Antonio Di Bella, aveva difeso la testata dicendo di aver chiesto chiarimenti al vaticanista che gli aveva "assicurato che non era sua intenzione ironizzare, o peggio irridere il Pontefice, come d’altronde non ha mai fatto in passato". E oggi l’ordine di servizio con cui Di Bella ha comunciato che "a partire da oggi il collega Roberto Balducci non seguirà più il Vaticano".
-
-
> La "Caritas in Veritate" ---- Due formati e 150mila copie per la prima edizione.5 luglio 2009, di Federico La Sala
Enciclica ’Caritas in veritate’. Due formati e 150mila copie per la prima edizione *
Saranno circa 150 mila le copie della prima edizione dell’Enciclica di Benedetto XVI “Caritas in veritate”, che sarà presentata in sala stampa vaticana martedì 7 luglio. Otto le lingue in cui verrà distribuita l’Enciclica: oltre all’italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e cinese. Il latino ha registrato ritardi a causa delle maggiori difficoltà dovute a neologismi e termini particolarmente complessi. Due i formati previsti - uno di circa 144 pagine, l’altro di 100 - per il documento pontificio di 6 capitolo che, nelle parole del Papa, vuole essere “un ulteriore contributo che la Chiesa offre all’umanità nel suo impegno per un progresso sostenibile, nel pieno rispetto della dignità umana e delle reali esigenze di tutti”.
SIR, Sabato 4 luglio 2009
-
> La "Caritas in Veritate" ---- GLI AFFAMATI DAL CROCIFISSO (di Gherush92).24 novembre 2009, par Federico La Sala
 Gherush92
Gherush92
 Committee for Human Rights
Committee for Human Rights
 ECOSOC Organization
ECOSOC Organization GLI AFFAMATI DAL CROCIFISSO
GLI AFFAMATI DAL CROCIFISSOLa disutile presenza del pontefice al vertice della FAO, se da una parte evidenzia l’incapacità di questo mastodontico organismo ad affrontare le tematiche della fame, dall’altra ci costringe a delle osservazioni sull’enciclica Caritas in Veritate. Il testo, richiamato più volte nel discorso del papa in plenaria, è l’apogeo di un’ideologia universalista e neo-omologazionista con la quale il cristianesimo vorrebbe costruirsi la patente di risolutore dei problemi della povertà e della fame estrema del mondo, dopo esserne stato uno degli artefici principali in Africa, in America Latina e non solo.
In verità, la Caritas in Veritate non risolve né il problema della povertà, né quello della fame, anzi le aggrava. Il difetto principale sta nel voler gestire il problema con l’assistenzialismo e l’evangelizzazione. Il titolo sintetizza la teoria: la carità nella verità ovvero nell’evangelizzazione; il corollario riepiloga il programma: la croce per un pugno di riso.
Il cristianesimo pratica e prescrive l’evangelizzazione e l’uniformità sotto forma di un unico modello culturale. La diffusione del cristianesimo non è altro che la diffusione di un prototipo universale precostituito, che ostacola la conoscenza e gli scambi fra le specie, fra i popoli e le culture. E’ un processo contro natura perché non accetta la diversità e si adopera per ricondurre le migliaia di opere e culture che incontra all’interno di uno schema precostituito, auto referenziato, ma del tutto inefficace a spiegare e interagire con l’universo, la diversità culturale e i fenomeni naturali. L’evangelizzazione, insieme con altre forme di omologazione, è la causa principale della cancellazione delle diversità, porta alla perdita di conoscenza e ha significato e provocato la scomparsa e l’assimilazione di molti popoli e culture. L’evangelizzazione è una delle principali cause della povertà, della miseria e della fame estrema, perché cancellando la diversità si elimina la conoscenza che è olistica, il bene più prezioso, il motore per la produzione di cibo e di benessere.
L’enciclica Caritas in Veritate, sulla quale si sono espressi in modo servile, ossequioso e incompetente politici e intellettuali e la FAO, è, in realtà, un guazzabuglio tuttologico che affronta i temi della globalizzazione, della cooperazione internazionale, dello sviluppo umano, dell’ambiente, dei cambiamenti climatici, della natalità, della finanza internazionale, del sindacato, usando qua è là parametri di giudizio ereditati, secondo la convenienza, da vulgate terzomondiste e neoglobal da una parte e da analisi economiche di stampo liberale dall’altra.
Tesi e opinioni sostenute con ambiguità, per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, fatte per il politicume, per accontentare i benpensanti, i teorici della banalità, i conformisti ad oltranza e, nel caso, qualche cariatide ammuffita degli organismi intergovernativi.
L’enciclica, invece, disboscata e ripulita dalle molte ed inutili incrostazioni, afferma che la salvezza dell’uomo e dei popoli viene solo “dall’unità della carità del Cristo che ci chiama tutti a partecipare in qualità di figli alla vita del Dio vivente, Padre di tutti gli uomini”.
A questo punto vogliamo affermare in maniera chiara che il diritto al cibo non può essere mediato né da Gesù Cristo né da speculazioni finanziarie né da altre presunte verità. Il diritto al cibo deve essere garantito e basta, lasciando la possibilità a ciascuno di riappropriarsi della propria conoscenza per la produzione delle proprie risorse alimentari. Sembrerebbe che il papa voglia fare concorrenza alla FAO nell’agguantare risorse finanziarie da utilizzare nell’assistenzialismo o per lo sviluppo della Caritas in Veritate, dopo averle opportunamente decurtate a proprio uso e consumo. E’ così da sempre.
Il documento parla di carità, ma non propone, come sempre, nessuna regola su come, cosa e quanto dare, su come scambiare, su come creare benessere, sulla soluzione del problema della povertà e della fame. La carità cristiana, infatti, “supera la giustizia e la completa nella logica del dono e del perdono. La “città dell’uomo” non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione.” Si tratta, viceversa, proprio di un problema di giustizia per sanare le ingiustizie sociali, economiche, ambientali e spirituali commesse nel corso dei secoli da parte del cristianesimo - con la scusa della misericordia che supera la giustizia - per appropriarsi arbitrariamente e avidamente di risorse, uomini, anime, conoscenze e spiritualità. La concezione della carità cristiana ha bisogno di uniformità umana indistinta, “universalizzata”, ridotta all’incapacità di provvedere a se stessa, quale terreno fertile per un disegno di evangelizzazione-omologazione che si perpetua da secoli.
La carità cristiana, così definita, non ha alcuna parentela con il concetto ebraico e islamico rispettivamente di Tzedaka e Sadaqah che vuol dire giustizia e si rifà ai concetti giustizia e diritto sociale e di distribuzione dei beni e che tende a considerare la povertà non uno status perenne da utilizzare per attingere proseliti, ma un incidente di percorso a cui porre rimedio in modo equo ed efficace. Secondo Maimonide esistono otto livelli di carità ma la forma più alta è quella di aiutare qualcuno ad aiutare se stesso cioè a provvedere ai mezzi per la sua riabilitazione.
D’altronde il documento incalza quando sostiene che “le povertà spesso sono generate dal rifiuto dell’amore di Dio e che l’umanità intera è alienata quando si affida a progetti solo umani, a ideologie e a utopie false........Tra evangelizzazione e promozione umana - sviluppo, liberazione - ci sono infatti dei legami profondi ”
Cosa significa tutto ciò? L’enciclica lo spiega in modo chiaro e inequivocabile in questo passaggio chiave dove affonda la lama della evangelizzazione:
“Per questo motivo, se è vero, da un lato, che lo sviluppo ha bisogno delle religioni e delle culture dei diversi popoli, resta pure vero, dall’altro, che è necessario un adeguato discernimento. La libertà religiosa non significa indifferentismo religioso e non comporta che tutte le religioni siano uguali. Il discernimento circa il contributo delle culture e delle religioni si rende necessario per la costruzione della comunità sociale nel rispetto del bene comune soprattutto per chi esercita il potere politico. Tale discernimento dovrà basarsi sul criterio della carità e della verità. Siccome è in gioco lo sviluppo delle persone e dei popoli, esso terrà conto della possibilità di emancipazione e di inclusione nell’ottica di una comunità umana veramente universale. «Tutto l’uomo e tutti gli uomini» è criterio per valutare anche le culture e le religioni. Il Cristianesimo, religione del « Dio dal volto umano », porta in se stesso un simile criterio.”
La carità non è, quindi, semplice atto di donazione ma, addirittura, metro di giudizio del cristianesimo, per stabilire quali culture e quali popoli possono essere inclusi nella “comunità universale” e quindi possono mangiare. Una nuova inquisizione, dunque, dal volto inumano, dove la scelta è: fame o conversione. Qual è il metodo migliore per convertire se non mantenere popoli e comunità in uno stato perenne di indigenza?
L’enciclica è, peraltro, in perfetta continuità con la dichiarazione Dominus Jesus dello stesso Ratzinger dove “La missione ad gentes anche nel dialogo interreligioso conserva in pieno, oggi come sempre, la sua validità e necessità ...e che il dialogo interreligioso deve avere essenzialmente lo scopo di convertire”.
L’evangelizzazione ha praticato il razzismo, lo sfruttamento di risorse ed uomini, fino alla schiavitù.
Ecco cosa significava il rifiuto della conversione nel “Requerimemiento”, il documento letto dai cristiani in spagnolo ai popoli dell’America Latina: “...Ma, se voi non vi convertite (al cristianesimo) e con malizia frapponete ritardi, io vi dichiaro che, con l’aiuto di Dio, noi faremo ingresso con la forza nel vostro paese e vi faremo guerra in tutti i modi e maniere che potremo e vi assoggetteremo al giogo e all’obbedienza della Chiesa, e prenderò le vostre persone e figli e i farò schiavi e come tali li venderò....” .
Ed ecco ancora cosa veniva sancito nel breve Dum Diversitas : “Noi concediamo per il presente atto, con la nostra Autorità apostolica, pieno e libero permesso di invadere catturare e sottomettere i saraceni e i pagani e qualunque altro infedele o nemico di Cristo, in qualunque luogo, come anche nei suoi regni ducati, contee e principati e altre proprietà... e di ridurre queste persone a schiavitù perpetua”. Il testo della bolla del papa Nicola V specifica la concessione di ridurre a schiavitù perpetua gli africani e riguarda gli abitanti di tutti i territori a partire da Capo Bojador a Capo Nun e quindi «tutte le coste meridionali fino al limite estremo». Il papa allora poteva condannare interi continenti, come l’Africa, alla cattività perpetua perché esisteva la teologia della schiavitù. Le conseguenze le conosciamo: decine e decine di milioni di morti ammazzati e di schiavi. Ecco da dove viene la povertà e la fame.
La teologia della schiavitù appare come lo sbocco inevitabile dell’evangelizzazione, la quale, definita come il motore di un processo evolutivo dell’umanità verso valori più elevati, per giustificare la propria esistenza, deve necessariamente schematizzare i rapporti fra i popoli (e fra le diverse culture o società), secondo un sistema gerarchico in cui si degradano gli altri per affermare il ruolo guida del cristianesimo. Se l’evangelizzazione è un’operazione di emancipazione, a cui si è sempre associato il significato di civilizzazione, è implicito che deve essere diretta ad emancipare e a civilizzare chi ne ha bisogno, nel caso specifico, gli Ebrei, i Mori, gli Africani e poi gli Indiani, i Roma. Questi non solo erano considerati una merce ma, secondo la teologia della schiavitù, erano destinati ad un’esistenza di subordinazione e assoggettamento ai cristiani, come metodo per evangelizzare il mondo.
Ora c’è da chiedersi che differenza epistemologica c’è tra i documenti di oggi che reiterano il ricatto dell’evangelizzazione come chiave per accedere alla “carità” e le disposizioni di cinque secoli fa che hanno messo interi popoli, allora pienamente in grado di vivere in armonia con l’ambiente, traendone risorse alimentari e il giusto godimento per la vita, sotto il giogo del crocifisso attraverso: separazioni delle famiglie, battesimi forzati, editti da fè, inculturazione, encomiendas, la tratta degli schiavi fino ad oggi con il costoso assistenzialismo perpetuo?
Si resta quindi scioccati nel vedere il massimo esponente della Chiesa Cattolica - campione dell’impoverimento e della distruzione secolare di popoli - dare lezioni alla FAO su come risolvere il problema della povertà che ha contribuito a creare. Si resta anche scioccati nel vedere la FAO senza programmi diventare succube di queste inconsistenti teorie. Nessun “mea culpa”, nessuna volontà di confrontarsi con la propria storia e di riconoscere che il processo di evangelizzazione, del passato e del presente, sia produttore e mantenitore di povertà in quanto distruttore di quella diversità culturale e ambientale data in principio dal Creatore.
Un’operazione di costante revisione e falsificazione storica in contrasto, peraltro, con la Convenzione sulla Diversità Biologica nella quale si prescrive di “rispettare, conservare e mantenere la conoscenza, le innovazioni e le pratiche delle popolazioni indigene e delle comunità locali, comprendendo gli stili di vita tradizionali come rilevanti per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica”.
Questo principio è in netto contrasto con la concezione dell’enciclica dove, invece, è continua l’ipotesi di un’omogeneizzazione del mondo verso lo status entropico del pensiero unico, del cibo unico, della cultura e religione unica.
E’ assolutamente necessario fermare l’opera degli oltre 300.000 missionari che assediano popoli e nazioni nel nome dell’uniformità e interrompere la loro attività distruttiva di cristianizzazione. E’ necessario anche contenere l’opera delle NGO che si ispirano ai principi dell’evangelizzazione e dell’assistenzialismo cristiano.
Secondo Gherush92 è necessario che vengano riaffermati i seguenti principi, senza il ricatto della conversione:
 Il principio della solidarietà - aiutare gli altri ad aiutare se stessi;
Il principio della solidarietà - aiutare gli altri ad aiutare se stessi; Il principio della riparazione - ogni danno ad un popolo provocato da razzismo e/o schiavitù deve essere compensato;
Il principio della riparazione - ogni danno ad un popolo provocato da razzismo e/o schiavitù deve essere compensato; Il principio del negoziato - ogni decisione deve essere presa in accordo con ciascun popolo;
Il principio del negoziato - ogni decisione deve essere presa in accordo con ciascun popolo; Il principio dell’extraterritorialità - ogni cultura deve avere il diritto di gestire la sua identità come un popolo e una nazione;
Il principio dell’extraterritorialità - ogni cultura deve avere il diritto di gestire la sua identità come un popolo e una nazione; Il principio della salvaguardia della diversità culturale.
Il principio della salvaguardia della diversità culturale.Svelato l’arcano ci sembra chiaro che l’annunciata visita del papa in Sinagoga sia più dannosa che utile. Chiediamo pertanto che non venga. Ad ogni buon conto non porti con se né la Dominus Jesus né la Caritas in Veritate come dono e, nella denegata ipotesi, tale regalia non sia accettata.
 NO ALLA VISITA DEL PAPA IN SINAGOGA
NO ALLA VISITA DEL PAPA IN SINAGOGA Sostieni Gherush92
Sostieni Gherush92
 Committee for Human Rights
Committee for Human Rights
 UN ECOSOC
UN ECOSOC
 gherush92@gherush92.com
gherush92@gherush92.com
-