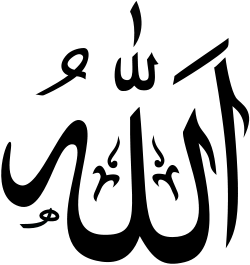
PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla ancora e solo di "guai ai vinti" e di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls
venerdì 13 luglio 2007.
- [...] Daraba in arabo significa principalmente "picchiare", "battere": è solo la terza persona di un passato, l’equivalente di un infinito per l’italiano, ma per secoli è stata, a seconda dei punti di vista, una parola d’ordine, un precetto sacro, uno spauracchio da temere. Nella Sura (capitoli, a loro volta suddivisi in versetti) 4 del Corano, "daraba" è quello che Allah, tramite Maometto, dice agli uomini di fare alle mogli che non ubbidiscono, dopo aver provato ad ammonirle e a farle dormire in luoghi separati: "Battetele" [...]
Laleh che legge il Corano
POLEMICHE
 Una nuova traduzione del libro di Allah
Una nuova traduzione del libro di Allah
 nega che Maometto predicasse di picchiare le mogli.
nega che Maometto predicasse di picchiare le mogli.
 La firma una studiosa iraniana. E negli Usa è diventata un caso
La firma una studiosa iraniana. E negli Usa è diventata un caso
di Francesca Caferri *
Laleh Bakhtiar lavorava già da due anni alla sua traduzione del Corano quando ha pensato di smettere. A bloccarla una sola parola. Anzi, un verbo: daraba. "Non sapevo davvero cosa fare", racconta oggi, "erano anni che inserivo ogni singola parola del Corano in un database, da cui poi programmavo di ripescarle a una a una e arrivare a una traduzione "scientifica" del libro sacro. Ma di fronte a daraba mi sono arenata e ho pensato di buttare via tutto". Daraba in arabo significa principalmente "picchiare", "battere": è solo la terza persona di un passato, l’equivalente di un infinito per l’italiano, ma per secoli è stata, a seconda dei punti di vista, una parola d’ordine, un precetto sacro, uno spauracchio da temere. Nella Sura (capitoli, a loro volta suddivisi in versetti) 4 del Corano, "daraba" è quello che Allah, tramite Maometto, dice agli uomini di fare alle mogli che non ubbidiscono, dopo aver provato ad ammonirle e a farle dormire in luoghi separati: "Battetele".
Per secoli, questo versetto è stato l’appiglio usato da molti musulmani per usare violenza alle mogli. "Ma io ci ho pensato. Secondo la tradizione, Maometto non ha mai picchiato nessuna delle sue mogli: quando ha avuto diverbi con loro le ha allontanate, ma mai le ha battute. E poi l’Islam è compassione: non potevo credere che Allah imponesse di usare la violenza sulle donne", spiega ancora Bakhtiar. Così, rovistando con cura tra le pagine del dizionario, ha cercato altri significati e ha trovato "mandare via". Da questa sottigliezza linguistica è nata la sua personale rivoluzione cartesiana: una nuova edizione del Corano in lingua inglese che nega agli uomini la possibilità di picchiare le donne.
Arrivata in libreria negli Stati Uniti in aprile, la traduzione del Corano di Laleh Bakhtiar ha creato non poche discussioni in America, riaprendo il dibattito su un tema molto sentito nell’Islam: è possibile "rileggere" il Corano dopo tanti secoli? C’è ancora spazio per nuove interpretazioni della parola di Allah? Secondo i tradizionalisti no: "chiusura delle porte dell’ijthiad" è l’espressione con cui gli esperti spiegano la fine della possibilità di dire qualcosa di nuovo - letteralmente, di interpretare - sul testo sacro dei musulmani. Per tradizione, questa chiusura si situa intorno al XII secolo: da allora, ripetono i sostenitori di questa idea, qualunque cosa sul Corano è già stata detta, e non è lecito discostarsi dalle interpretazioni classiche.
Negli ultimi anni molti hanno provato a riaprire le porte. Il caso più clamoroso è quello di Nasr Abu Zayd, uno dei massimi intellettuali musulmani contemporanei, costretto nel 1995 a lasciare il suo Paese dopo essere stato condannato per apostasia: la sua colpa era quella di voler inquadrare il Corano nell’epoca in cui fu scritto, per distinguere le verità assolute, quelle della fede, dalle norme relative ai tempi di Maometto e oggi non più attuali. Due casi diversi, ma che si possono inserire nella stessa tendenza: "Si tratta di applicare al Corano le norme dell’ermeneutica, per arrivare ad attualizzarne il messaggio", spiega Maria Luisa Albano, docente di lingua e letteratura araba all’università di Macerata ed esperta di letteratura islamica femminile. "È parte di un movimento riformista che sta acquistando forza fra gli intellettuali, ma non funziona in un mondo islamico ancora molto chiuso". Per Albano, così come per altri esperti, "picchiare" è il senso primario di daraba in arabo, ma questo non esclude che non ci sia spazio per altre interpretazioni.
"Più di uno studioso in America ha già detto che tradurre daraba con "mandare via", invece che "picchiare" è ammissibile", dice Margot Badran, membro del Center for Muslim-Christian Understanding alla Georgetown University, specializzata in studi di genere nelle società musulmane, "ma per me il senso più importante di questo nuovo Corano non è tanto nella singola parola, quanto nel dibattito che ha suscitato".
Per Badran il fatto che sull’opera della Bakhtiar si sia accesa una discussione tanto forte è il segno che è forte l’esigenza di ridiscutere verità per lungo tempo date per scontate. "La maggior parte delle traduzioni del Corano in inglese non rispecchiano la lingua dei nostri giorni", prosegue la docente, "molte parlano di "uomo" quando il concetto che il testo vuole esprimere è "essere umano". Ben venga dunque una traduzione attenta alle donne. È un bene, e non solo per le fedeli: questo nuovo testo spinge tutti a interrogarsi e a provare a tornare alle origini del messaggio coranico".
___
Perché Maometto non ha mai battuto le sue mogli
Lo scopo iniziale era fare una versione del Corano accessibile a tutti: musulmani e non, rendendo il messaggio del Profeta in un inglese il più possibile vicino a quello contemporaneo. Una volta completata, l’opera è diventata però oggetto di discussione, e non solo fra gli specialisti di scienze islamiche. E Laleh Bakhtiar, 68 anni, origini iraniane e passaporto americano, autrice e traduttrice di una ventina di volumi sull’Islam, si è trovata al centro di una discussione sempre più accesa, quella sulle donne e il loro rapporto con la religione del Profeta. Al telefono dal suo ufficio di Chicago spiega perché il caso attorno al suo libro fosse inatteso e come però sia ben lieta del dibattito che si è scatenato.
Come mai ha sentito l’esigenza di tradurre di nuovo il Corano? In fondo ne esistono già decine di versioni in inglese: è partita con l’idea di un approccio "femminile"?
"No, affatto. Volevo solo fare una versione accessibile a tutti. Tutte quelle che avevo letto, ed erano decine, mi erano sembrate "respingenti" nei confronti dei non musulmani, difficili, troppo letterarie: io ho voluto dare vita a una traduzione che fosse apprezzabile per tutti, non solo per chi conosce già l’Islam. Ci ho lavorato per sette anni: al secondo, quando mi sono scontrata con daraba, ho pensato di smettere. Oggi sono felice di aver proseguito".
Parliamo appunto di questa parola: come è arrivata a tradurla con "mandar via", quando invece per secoli è stata letta come "picchiare"?
"Ho guardato nelle tremila pagine del vocabolario di Edward William Lane. E ho trovato che daraba vuol dire sì picchiare, ma anche "mandare via". Ho pensato che fosse proprio questo quello che Maometto voleva dire: "mandate vie" le mogli con cui non andate d’accordo, non certo "picchiatele". Del resto, Maometto non ha mai picchiato le sue mogli".
Come di certo saprà, a marzo un giudice tedesco ha assolto un tedesco-marocchino che aveva picchiato la moglie motivando la scelta proprio con il versetto della Sura 4 del Corano. E se davvero invece di "picchiate" Maometto avesse voluto dire "allontanate"? Il giudice, e tanti prima di lui, avrebbe fatto un grosso errore...
"Niente se. Io sono certa che il Profeta non volesse dire di picchiare le donne. C’è un altro verso del Corano, nella Sura 2, di cui nessuno contesta il significato, che dice che se un marito vuole divorziare lo deve fare in modo equo e umano, e che la donna non deve subire abusi né essere trattata con la forza anche se è lei a voler divorziare. Basta leggere questo per capire il resto: se una donna che divorzia non può essere maltrattata, perché dovrebbe esserlo una moglie che disubbidisce? Se così fosse, il Corano promuoverebbe il divorzio invece del matrimonio. Quando ho riflettuto su questo, mi è stato chiaro che l’interpretazione corrente di daraba era sbagliata".
La sua interpretazione è piuttosto contestata, lo sa?
"Certo che lo so. Ma io non voglio fare nessuna rivoluzione, dico soltanto che quella parola ha 25 significati, che secoli fa è stato scelto quello che parla di violenza e che da allora è stata seguita questa traduzione: io non contesto il Corano, contesto una certa interpretazione che ne è stata data e che secondo me, dopo tanti secoli, va guardata con spirito critico, non accettata in maniera pedissequa". Perché nessuno lo ha fatto prima di lei? "In molti lo hanno fatto, su molte parti diverse del Corano. Io mi sono concentrata su questa e sono arrivata a questa conclusione. In linea generale posso dirle che molte autorità religiose non vogliono cambiare lo status quo che è stato loro insegnato e che insegnano: quindi contestano chiunque provi a interpretare il Corano in modo diverso dalla tradizione".
I suoi contestatori dicono anche che lei non parla davvero arabo.
"Io sono iraniana di origine e cittadina americana. Ho imparato l’arabo letterario anni fa, per il mio lavoro di traduttrice. Ho tradotto decine di libri: capisco e leggo senza nessun problema l’arabo classico". L’hanno criticata in tanti? "Sì, ma ho anche incontrato molte persone che mi hanno espresso gratitudine. La prima volta che ho parlato della mia traduzione, è stato a una conferenza del Wise, Women’s islamic initiative in spirituality and equity, lo scorso novembre a New York. C’erano 150 donne arrivate da tutto il mondo, la maggior parte aveva meno di trent’anni: erano credenti come me, e avevano, come me, entusiasmo e orgoglio per la nostra fede comune. Erano entusiaste del mio lavoro. Le donne sono una parte importante dell’Islam, ma hanno bisogno di spazio e voce. Molte mi hanno raccontato di essersi riavvicinate alla religione dopo l’11 settembre, perché si erano sentite insultate da persone che dicevano di agire in nome dell’Islam. È di credenti come loro che è fatto l’Islam oggi. Anche io sono credente: credo e accetto la parola di Dio e la metto in atto con più amore oggi che so che non ha mai detto di picchiare le donne. So che molte persone non sono d’accordo, ma spero che rispettino il punto di vista di una credente".
Cosa c’è di diverso nella sua versione del Corano rispetto alle altre, daraba a parte?
"Ho usato un metodo di traduzione diverso da quelli tradizionali. Per cinque anni ho tradotto una per una le parole del Corano, che sono 90mila, e creato un database: negli ultimi due anni di lavoro ho ricomposto il testo. In questa maniera ho dato a ogni parola il suo significato originario e non mi sono persa in sinonimi che alla lunga diventano fuorvianti: ho rispettato alla lettera lo spirito del testo. Ho scelto di usare termini non violenti, o non respingenti: kufar, che molti hanno tradotto come miscredenti o infedeli, io l’ho reso come ingrati. Sono sempre quelli che non accettano il messaggio di Dio, ma il termine è meno spiacevole. Ho tradotto i nomi dei profeti e degli uomini santi dell’ebraismo e del cristianesimo: Musa e Issa sono Mosè e Gesù. E ho scritto "Dio" invece di "Allah" perché questo è il significato della parola in arabo e penso che così tutti possano sentirla un po’ più vicina a loro. Infine sono stata molto attenta a trasmettere la moralità che c’è nel Corano. È quello che secondo me si perde in molte traduzioni: non riescono a rendere il disegno globale di compassione e amore del nostro libro sacro. E invece è proprio questo quello che c’è bisogno di sottolineare oggi, perché gli estremisti hanno invaso il campo e loro non danno certo un’immagine morale dell’Islam".
Non ha paura che possano prenderla di mira per queste sue parole e per la sua opera?
"Io sono credente: quindi non ho paura. Credo nella volontà di Dio".
* La Repubblica D, 16.06.2007
Sul tema, si cfr. anche:
 LA BIBBIA, IL CORANO, E LA LAPIDAZIONE: "LA" PIETRA SU CUI SI FONDA "LA" CIVILTA’!!!
LA BIBBIA, IL CORANO, E LA LAPIDAZIONE: "LA" PIETRA SU CUI SI FONDA "LA" CIVILTA’!!!
 Il ministro sottolinea come le violenze sulle donne non derivino
Il ministro sottolinea come le violenze sulle donne non derivino
 dalle religioni, ma dalle tradizioni culturali di alcuni paesi
dalle religioni, ma dalle tradizioni culturali di alcuni paesi
 Amato: "Picchiare le donne
Amato: "Picchiare le donne
 è tradizione siculo-pakistana"
è tradizione siculo-pakistana"
 Prestigiacomo: "Straparla, chieda scusa o lo querelo"*
Prestigiacomo: "Straparla, chieda scusa o lo querelo"*
ROMA - "Nessun Dio autorizza un uomo a picchiare la donna. E’ una tradizione siculo-pakistana che vuole far credere il contrario". Lo ha detto il ministro dell’Interno Amato nel suo intervento al convegno su Islam e integrazione. Amato ha più volte ricordato come solo fino agli anni ’70 si trovavano in Sicilia costumi e tradizioni non molto distanti da quelle che ora in Italia sono importate dagli immigrati di certi gruppi musulmani.
Il ministro ha sottolineato nel suo intervento che l’integrazione "passa anche di qua: attribuire alla tradizione ciò che appartiene alla tradizione che non vuol dire negare Dio" ma semmai "l’io" che domina negli atteggiamenti patriarcali e maschilisti. Dobbiamo evitare di imputare a Dio - ha ribadito - il Dio dei cristiani e dei musulmani, che in realtà è lo stesso, ciò che è da imputare invece agli uomini".
Il ministro dell’Interno ha poi sottolineato come sia necessario evitare, quando pensiamo agli immigrati e in particolare ai musulmani, di avere di fronte dei "blocchi umani" invece che singole persone. "Non esiste il concetto noi contro gli altri - ha sottolineato - se lo deve cacciare fuori di testa tutto l’occidente: ognuno di noi è diverso e questo è importante soprattutto quando si parla di Islam", ha evidenziato, ricordando come questa religione non abbia una autorità gerarchica unica ma una pluralità di voci al suo interno. "Noi siamo gelosi della nostra identità - ha concluso - e ciascuno ha diritto alla sua".
Parole che hanno scatenato l’ira dell’ex ministro delle Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo (che è di Siracusa): "Amato straparla. Chieda subito scusa ai siciliani o lo querelo". Le fa eco Ignazio La Russa, An, anche lui di origini siciliane: "Amato ha compiuto un’operazione inaccettabile per servilismo culturale". Affermazioni "molto gravi" perché "offende la Sicilia, che fa parte dell’Italia", poi perché "vengono offese le stesse donne siciliane". Alessandra Mussolini, segretario nazionale di Azione Sociale ed europarlamentare di Alternativa Sociale. Sandro Bondi, coordinatore di FI, si interroga invece sulla salute del ministro: "Lo stesso Amato profeticamente aveva sostenuto l’impazzimento dell’Italia, pensando di esserne personalmente immune".
* la Repubblica, 11 luglio 2007
Forum
-
>LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. --- "Iran, donne e rivolte", un libro di Sara Hejazi che, muovendo dalle proteste per la morte di Mahsa Amini, spiega la storia delle donne in Iran (di Matteo Zola)....16 settembre 2023, di Federico La Sala
Iran, donne e rivolte, di Sara Hejazi. Quando la libertà della donna è la libertà di un popolo
- Iran, donne e rivolte, un libro di Sara Hejazi che, muovendo dalle proteste per la morte di Mahsa Amini, spiega la storia delle donne in Iran...
di Matteo Zola (Eàst Journal, 6 Luglio 2023)
- TITOLO: Iran, donne e rivolte
 AUTORE: Sara Hejazi
AUTORE: Sara Hejazi
 EDITORE: Morcelliana Scholé
EDITORE: Morcelliana Scholé
 ANNO: 2023
ANNO: 2023
 PAGINE: 147
PAGINE: 147
 PREZZO: 14 euro
PREZZO: 14 euro
Un libro interessante e sorprendente. Iran, donne e rivolte, di Sara Hejazi (Morcelliana Scholé, 2023) è un libro che si muove su diversi piani, riuscendo magistralmente a dominarli tutti: c’è la storia del Novecento iraniano, c’è la sua società in movimento, c’è la sua mentalità in perenne contraddizione, c’è il controverso rapporto con l’Occidente ma soprattutto c’è la condizione femminile. I vari piani si intersecano, mostrando quanto il controllo sul corpo delle donne sia anche il controllo sull’intera società. La conseguenza più ovvia è che il femminismo, e in generale la lotta di liberazione della donna, sia la via per giungere alla libertà di tutti.
In questo piccolo libro Sara Hejazi - antropologa, ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento e per l’Università di Trento - offre un quadro completo della società iraniana, della sua evoluzione, della sua Rivoluzione - quella di Khomeini, nel 1979 - e delle sue controrivoluzioni, ovvero delle molte ondate di protesta che hanno, fin qui invano, sfidato il regime degli ajatollah. L’ultima di queste proteste - con il suo corollario di brutali repressioni, condanne a morte, stupri e bestiali violenze operate dalla polizia di regime - è scoppiata a seguito della morte di Mahsa Amini, giovane donna di appena ventidue anni che, arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo, è stata uccisa durante la detenzione.
Questa morte ha portato al pettine molti nodi, molte diverse oppressioni: quella della maggioranza nazionale verso le minoranze, quello degli anziani verso i giovani. quello del maschile sul femminile, quello del pubblico sul privato. La saldatura tra queste diverse istanze è infine esplosa in una nuova larghissima protesta che, tuttavia, non ha prodotto alcun effetto sul regime. Perché? Il libro di Sara Hedjazi entra nelle pieghe della società iraniana, sverlando come funziona il consenso e quali sono le sue radici e spiegando come la nuova classe media, che sfida il regime, sia anche in parte un puntello su cui il governo si appoggia.
E poi c’è il ruolo delle donne, sia di quelle che contestano il regime, sia di coloro che invece sono fedeli, zelanti ispettrici della morale femminile, nere nel loro chador, pronte a denunciare chiunque abbia una ciocca di capelli fuori posto. E proprio il taglio della ciocca è diventato il simbolo delle proteste per la morte di Mahsa Amini, simbolo di lutto ma anche simbolo «di come il corpo delle donne sia il terreno su cui viene esercitato il controllo sull’intera popolazione». Strumento di controllo sul corpo della donna è il velo, l’hijab, ossessione del regime ma anche, in passato, simbolo politico della lotta contro la dittatura di Reza Pahlavi e della Rivoluzione khomeinista. Una rivoluzione sempre descritta in Occidente come “un salto indietro” ma che era frutto delle stesse dottrine politiche e filosofiche in voga in Europa negli anni Settanta e che ha prodotto, per certi versi, una modernità con cui il regime si è poi trovato a negoziare, rifiutando oppure integrando i cambiamenti.
Ad esempio, l’emancipazione delle donne si deve proprio al regime che dopo la Rivoluzione ha aperto loro le porte delle università: «Attualmente le donne rappresentano il 60% della popolazione universitaria e sono il 70% tra gli iscritti a facoltà scientifiche», spiega l’autrice che si chiede se «uno stato religioso e un alto tasso di istruzione possano ancora convivere» o se il regime non abbia gettato le basi per la sua stessa fine. La risposta a questa domanda sta nelle pagine di questo piccolo e intelligentissimo libro.
-
> LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. --- PIANETA TERRA, RELIGIONI, E ANTROPOLOGIA. «Incapaci» per legge. Il regime egiziano mette le mani sul diritto di famiglia e le donne si mobilitano (di Chiara Cruciati).7 marzo 2021, di Federico La Sala
«Incapaci» per legge, le donne egiziane si mobilitano
Egitto. Fatta trapelare alla stampa una controversa bozza di riforma del diritto di famiglia. Servirà il permesso di un uomo per sposarsi, decidere sulla salute dei figli e viaggiare. Le organizzazioni femministe: si torna indietro di 200 anni
- [Foto]Una protesta delle donne egiziane per l’8 marzo
di Chiara Cruciati (il manifesto, 07.03.2021)
Il regime egiziano mette le mani sul diritto di famiglia e le donne si mobilitano. In un paese in cui la povertà avanza a passo spedito colpendo soprattutto le categorie economicamente più fragili, tra cui le donne, in cui l’Onu stima che il 99% di loro ha subito almeno una volta nella vita una forma di violenza, in cui si calcolano centinaia di prigioniere politiche sottoposte ad abusi quotidiani (tre di loro condannate alla pena capitale), ora Il Cairo sta lavorando a un arretramento dei diritti delle donne.
Sul tavolo ci sono una serie di emendamenti al diritto di famiglia che riducono le donne a soggetti meno capaci degli uomini nella gestione della propria vita e di quella dei figli.
Nella bozza della riforma fatta trapelare alla stampa è infatti prevista la figura del guardiano, un uomo che dovrà dare il proprio consenso alla donna - che sia la figlia, la moglie o la sorella - che intende viaggiare, sposarsi o prendere decisioni sulla salute dei figli.
Quarantacinque pagine che hanno provocato la sollevazione delle organizzazioni per i diritti umani e le associazioni femministe che descrivono la bozza una riforma «arcaica» che riporta il paese indietro di 200 anni.
Tra gli articoli più controversi, c’è quello che riconosce al guardiano il diritto di annullare il matrimonio della figlia, della sorella o della nipote entro un anno se ritiene che il coniuge non sia di pari livello sociale o di suo gradimento, o se l’unione è avvenuta senza il suo consenso.
Una forma legale di oppressione, l’hanno definita sulla stampa araba svariati analisti, «che ribadisce la cultura patriarcale dominante della classe dirigente». A nulla serve avere otto ministre nel governo o quote rosa in parlamento se la stragrande maggioranza delle donne egiziane è legalmente considerata incapace di decidere per sé.
Lo mette nero su bianco un altro articolo della riforma che toglie potestà alla madre in merito alla salute e l’educazione dei figli, fino alla registrazione dei nuovi nati, possibile solo in presenza del padre.
C’è poi il capitolo poligamia: l’uomo potrà sposare un’altra donna limitandosi a informare la moglie, pena l’arresto. Alla moglie viene tolto il diritto di rigettare il secondo matrimonio e di divorziare, le condizioni previste dall’islam.
Unica nota positiva è l’«assicurazione» a favore della donna in caso di divorzio non consensuale, una previsione apprezzata soprattutto dalle classi più basse, dove un divorzio può costare alla donna che non lavora l’unica fonte di sopravvivenza economica.
Ma se la legge non è stata ancora approvata, 50 organizzazioni di donne egiziane si sono già mobilitate con una dichiarazione congiunta che chiede il rispetto dei diritti umani fondamentali e della stessa Costituzione: alla base sta la richiesta, basilare, di riconoscere l’uguaglianza legale di donne e uomini, nella società come in famiglia.
«Rigettiamo totalmente questa legge - il commento dell’Egyptian Centre for Women’s Rights - Abbiamo donne ministre che firmano contratti milionari in nome dello Stato, ma che con questa riforma non potrebbero nemmeno sposarsi liberamente o viaggiare, nemmeno per lavoro, senza il permesso del guardiano».
-
> "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE --- “Gli ultimi giorni di Maometto”. Parla la studiosa tunisina Hela Ouardi, autrice del libro-inchiesta (di Karima Moual).8 dicembre 2018, di Federico La Sala
Indagine sulla fine del Profeta
Parla La studiosa tunisina Hela Ouardi, autrice del libro-inchiesta “Gli ultimi giorni di Maometto”: «Un crimine? Non lo sapremo mai. Ma qui nasce il malessere islamico»
di Karima Moual (La Stampa, 08.12. 2018)
Hela Ouardi, tunisina, insegna letteratura francese all’Istituto Superiore di Scienze Umane dell’Università di Tunisi ed è ricercatrice presso il Laboratorio di Studi sul Monoteismo al Cnrs di Parigi. Il suo libro Gli ultimi giorni di Maometto (Enrico Damiani editore) è la ricostruzione di uno degli eventi più misteriosi della storia dell’islam: la morte del Profeta. Con un taglio da romanzo la studiosa cerca di far emergere l’uomo sepolto sotto la leggenda eroico-religiosa per restituirlo alla storia. E lo fa, provando a porre le domande giuste che ancora coprono di mistero e leggenda quell’evento che segnerà per sempre la comunità musulmana. Ad arricchire l’inchiesta sono le numerose fonti tradizionali sunnite e sciite, studiate e approfondite da restituirci il ritratto di un uomo indebolito e minacciato da più parti.
«La prima generazione dei musulmani probabilmente non considerava Maometto un personaggio sacro. Lui stesso ha rivendicato di essere solo un mortale tra i mortali», scrive Hela Ouardi». Oggi l’adorazione dei musulmani per il Profeta è spinta a un tale parossismo che al personaggio si accompagna una vera e propria ossessione per la blasfemia. In un certo senso, la venerazione di cui è oggetto lo ha fossilizzato».
Un’inchiesta su Maometto, figura per molti fedeli intoccabile, non è un po’ rischiosa?
«Se prima di scrivere un libro sull’islam prendessimo in considerazione ciò che pensano i fedeli, non scriveremmo più una riga su questa religione. Non mi sento di aver preso un rischio particolare, perché da anni ormai vediamo bene che il fanatismo è un mostro cieco che non distingue le sue vittime. Colpisce tutti e dappertutto (anche i musulmani nelle moschee non vengono risparmiati!). Tuttavia, l’indagine sulla morte del Profeta è una vera e propria sfida intellettuale che mi sono prefissata: il lavoro su un argomento così delicato, la minuziosa esplorazione di decine di fonti della Tradizione, il lavoro di riferimento e di confronto dei diversi racconti, la raccolta dei pezzi del “puzzle” è stata un’avventura scientifica al tempo stesso difficile e appassionante».
Dal suo lavoro emergono elementi interessanti proprio perché contrastanti rispetto alla storia comunemente accolta dai fedeli musulmani. Scricchiola fortemente quel racconto divulgato da secoli sul ruolo del Profeta e sui suoi compagni più fidati, tutt’altro che «ben guidati». Com’è stata accolta questa lettura dal pubblico musulmano?
«Quando si pubblica un libro, si getta una sorta di bottiglia in mare, non sappiamo chi la prenderà e cosa ne farà. Ma posso dire che il libro è stato accolto molto bene. Ha incontrato molti lettori e non ho ricevuto alcuna minaccia. C’è una ragione molto semplice per questo, ed è che il mio libro è pieno di riferimenti alla Tradizione musulmana. Il lettore vede immediatamente che non sto inventando nulla e che questa immagine poco gloriosa dei Compagni del Profeta non viene fuori dalla mia immaginazione ma dai libri più ortodossi dell’islam».
L’immagine dei personaggi e anche degli eventi che li interessano è molto più politica che spirituale, il Corano stesso, come lo conosciamo oggi, è frutto di una redazione fatta molto tempo dopo la morte del Profeta. Quasi a perdere quella sua infallibilità, come autentica parola di Dio e di Dio solo. E così?
«Ci sono due modi di percepire il Corano: i credenti ci vedono la parola di Dio, infallibile e miracolosa; gli storici, i filologi eccetera lo vedono come un oggetto storico che ha subito un’evoluzione e in cui è intervenuta la mano dell’uomo. Da sempre (non solo oggi) sappiamo che il Corano, così come fu rivelato al Profeta, è perduto per sempre e che circolano molteplici versioni differenti di questo libro. L’argomento è stato trattato da diversi autori della Tradizione come Ibn Abî Dawûd, nel IX-X secolo, nel suo libro Kitâb al-Masâhif (il Libro dei manoscritti del Corano), dove passa in rassegna le diverse versioni del testo sacro. Penso che l’esistenza di diverse versioni del Corano non sia totalmente incompatibile con la fede: il musulmano può credere che sia un testo di ispirazione divina e ammettere che la compilazione e la trasmissione di questo testo sia un’opera umana quindi imperfetta».
Sappiamo però che un cospicuo numero di fedeli è invece convinto che il Corano sia opera perfetta, e quindi fuori da ogni discussione. Approfondire le incongruenze sulla morte del Profeta cosa potrebbe comportare non solo tra gli studiosi ma anche tra intellettuali e uomini di fede musulmana?
«In nessun momento la Tradizione dice categoricamente che la morte del Profeta è stata naturale; al contrario, la maggior parte delle fonti afferma che è stato avvelenato da una donna ebrea; altre versioni dicono che è morto di pleurite. Io non metto in dubbio nulla, non difendo alcuna ipotesi: espongo le storie della Tradizione, le commento, sottolineo le contraddizioni. E quando è di fronte a narrazioni contraddittorie dei testimoni che interroga, un investigatore inizia ad avere dubbi. Quindi per me la morte del Profeta è semplicemente misteriosa: c’è stato un crimine? La sua morte è stata naturale? Io non lo so e non lo saprà nessuno (a meno che non apriamo la sua tomba!), ma quello di cui sono sicura è che aveva dei sospetti sulla sua cerchia e pensava che potessero ucciderlo. Ne parlo a lungo nel mio libro».
Qual è l’obiettivo della sua inchiesta?
«Lo scopo di ogni indagine è la ricerca della verità. Ma la verità che stavo cercando non erano le circostanze della morte fisica del Profeta. Quella è una storia antica e ora è in prescrizione. La verità che stavo cercando sono le profonde cause storiche del malessere dell’islam nella storia moderna».
Ci sono sicuramente molte ombre su cui far luce nella storia dell’islam. I tabù sono tanti e la censura è molto forte, ma, oltre agli ultimi giorni del Profeta, quali sono i personaggi o gli eventi che meriterebbero una nuova rilettura storica?
«Vorrei rispondere: tutto nella storia dell’islam meriterebbe una nuova rilettura, perché la storia dell’islam è stata schiacciata troppo a lungo sotto il peso della leggenda che mostra personaggi santificati, idealizzati. Ora è necessario rileggere - e riscrivere - tutto, in modo tale da riportare quei personaggi alla loro umanità e mostrare che hanno un lato glorioso e un lato poco glorioso, come in fondo tutti i protagonisti della storia. L’islam sfortunatamente ha per troppo tempo confuso la mitologia e la storia, ed è giunto il momento di distinguerle».
Ha già avuto proposte per una edizione del suo libro in lingua araba?
«La traduzione in arabo è all’ordine del giorno. Probabilmente verrà pubblicato presto».
-
> DIO, UOMINI E DONNE -- "Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria (di Paolo Rodari). A ribadire il "no" del Vaticano all’ipotesi dell’ordinazione presbiterale femminile è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.11 giugno 2018, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE....
"Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria
Il cardinale prefetto dell’ex Sant’Uffizio: "La dottrina è definitiva, sbagliato creare dubbi tra i fedeli. Cristo conferì il sacramento ai 12 apostoli, tutti uomini"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 maggio 2018)
CITTÀ DEL VATICANO - Si tratta "di una verità appartenente al deposito della fede", nonostante sorgano "ancora in alcuni paesi delle voci che mettono in dubbio la definitività di questa dottrina". A ribadire il "no" del Vaticano all’ipotesi dell’ordinazione presbiterale femminile è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il neo-cardinale gesuita Luis Ladaria, in un lungo e argomentato articolo pubblicato sull’Osservatore Romano. Intitolato "Il carattere definitivo della dottrina di ’Ordinatio sacerdotalis’", il testo è scritto per fugare "alcuni dubbi" in proposito.
Evidentemente, il ritorno di proposte aperturiste circa le donne-prete avanzate soprattutto in alcuni paesi sudamericani in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre dedicato all’Amazzonia, ha allarmato la Santa Sede che attraverso la sua massima autorità gerarchica ha voluto ribadire ciò che anche per Francesco sembra essere assodato: "Sull’ordinazione di donne nella Chiesa l’ultima parola chiara è stata data da Giovanni Paolo II, e questa rimane", ha detto Papa Bergoglio tornando nel novembre del 2016 dal suo viaggio lampo in Svezia.
Durante il Sinodo sull’Amazzonia uno dei temi centrali sarà quello della carenza di preti. Come superare il problema? In proposito, da tempo, si parla dell’opportunità di ordinare i cosiddetti viri probati, uomini sposati di una certa età e di provata fede che possano celebrare messa nelle comunità che, appunto, hanno scarsità di sacerdoti e dove è difficile che un prete possa recarsi con regolarità. Altri uomini di Chiesa fanno altre proposte: propongono, come ad esempio ha recentemente fatto monsignor Erwin Krautler della prelatura territoriale di Xingu in Amazzonia, che oltre ai viri probati si proceda con l’ordinazione delle diaconesse. Mentre altri ancora, invece, hanno parlato direttamente di donne-prete.
Ladaria ricorda che "Cristo ha voluto conferire questo sacramento ai dodici apostoli, tutti uomini, che, a loro volta, lo hanno comunicato ad altri uomini". E che per questo motivo la Chiesa si è riconosciuta "sempre vincolata a questa decisione del Signore", la quale esclude "che il sacerdozio ministeriale possa essere validamente conferito alle donne".
Già Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis del 22 maggio 1994, disse che "la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa". Mentre la Congregazione per la dottrina della fede, in risposta a un dubbio sull’insegnamento di Ordinatio sacerdotalis, ha ribadito che "si tratta di una verità appartenente al deposito della fede".
Chi vuole le donne-prete argomenta che la dottrina in merito non è stata definita ex cathedra e che, quindi, una decisione posteriore di un futuro Papa o concilio potrebbe rovesciarla. Dice, tuttavia, Ladaria che "seminando questi dubbi si crea grave confusione tra i fedeli" perché, Denzinger-Hünermann alla mano (l’autorevole volume che raccoglie simboli di fede, decisioni conciliari, provvedimenti di sinodi provinciali, dichiarazioni e scritti dottrinali dei Pontefici dalle origini del cristianesimo all’epoca contemporanea) la Chiesa riconosce che l’impossibilità di ordinare delle donne appartiene alla "sostanza del sacramento" dell’ordine. Una sostanza, dunque, che la Chiesa non può cambiare. "Se la Chiesa non può intervenire - dice ancora Ladaria - è perché in quel punto interviene l’amore originario di Dio".
Ladaria parla anche dell’infallibilità e del suo significato. Essa non riguarda solo pronunciamenti solenni di un concilio o del Papa quando parla ex cathedra, "ma anche l’insegnamento ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo, quando propongono, in comunione tra loro e con il Papa, la dottrina cattolica da tenersi definitivamente". A questa infallibilità si è riferito Giovanni Paolo II in "Ordinatio sacerdotalis?, un testo che Wojtyla scrisse dopo un’ampia consultazione portata avanti a a Roma "con i presidenti delle conferenze episcopali che erano seriamente interessati a tale problematica". "Tutti, senza eccezione - ricorda Ladaria - hanno dichiarato, con piena convinzione, per l’obbedienza della Chiesa al Signore, che essa non possiede la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
Federico La Sala
-
> PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". - Islam a testa bassa. La vita delle ragazze musulmane, cresciute in Italia ma costrette a fronteggiare le loro famiglie, pronte alla violenza per imporre la tradizione.25 maggio 2018, di Federico La Sala
Donne sospese tra due mondi
Islam a testa bassa
La vita delle ragazze musulmane, cresciute in Italia ma costrette a fronteggiare le loro famiglie, pronte alla violenza per imporre la tradizione: dai vestiti fino ai matrimoni combinati.
 Una sfida che può avere un prezzo altissimo. Che però molte riescono a vincere. Ecco le loro storie
Una sfida che può avere un prezzo altissimo. Che però molte riescono a vincere. Ecco le loro storiedi Francesca Caferri (la Repubblica, 25.05.2018)
- Già da piccola, Alison non amava i vestiti lunghi. «È uno dei miei primi ricordi. Con la mamma andavamo dal sarto e gli chiedevo di accorciare i miei shalwar kameez, le lunghe tuniche che in Pakistan donne e bambine indossano sopra i pantaloni. Lui diceva sempre che avevo un bel caratterino, poi ci mettevamo tutti a ridere e mi accorciava gli abiti. Ero una bambina, mi lasciavano fare». Afgana, gli occhi a mandorla tipici degli hazara, la minoranza sciita del Paese, Alison, 20 anni, parla dell’infanzia senza troppi rimpianti. «Ricordo solo Peshawar: era orribile». Come tanti altri afgani in fuga dalla guerra visse anni nel limbo della città pachistana approdo di migliaia di profughi: poche scuole, pessimi servizi, razzismo.
 Cui si aggiunse la morte del padre: non stupisce che non abbia voglia di ricordare: «La mia vita, quella vera, iniziò quando avevo 12 anni e con mamma venimmo in Italia per raggiungere mio fratello». Alison non poteva di certo immaginare che da quel momento la passione per gli abiti le sarebbe quasi costata la vita. «Arrivai nel 2010. Portavo il velo e lo shalwar kameez: quando vidi le ragazze italiane, i loro vestiti colorati e i capelli al vento tutto mi parve bellissimo. E iniziai a sognare: volevo studiare, lavorare, avere la mia macchina un giorno. Come loro». Lentamente, la ragazzina prese a portare i jeans insieme al velo e ad uscire con le amiche. Cambiamenti innocui, che però non sfuggirono al fratello: «Cominciò a farmi il lavaggio del cervello. Dovevo portare il velo, pregare e non mettere piede fuori di casa da sola». Passarono anni carichi di tensione: quando Alison iniziò a lavorare la situazione esplose: «Mi disse che mi dovevo sposare, che non potevo vivere così. Ma io non facevo niente di male: non frequentavo nessun ragazzo, nessuna cattiva compagnia. Lavoravo e basta. Provai a parlare con mia madre, ma lei non diceva nulla. A mio fratello consentiva tutto: l’alcool, le droghe. Due o tre volte prese il coltello e disse che voleva ammazzarmi: mi misi tantissima paura. Poi una sera tornai in ritardo dal lavoro: lui era fuori di sé, mi disse che mi avrebbe rispedito a Kabul per farmi sposare. O che mi avrebbe bruciata viva: era pronto a farlo, era solo questione di tempo, glielo lessi negli occhi. Il giorno dopo presi il telefono, i pochi soldi che avevo, lo zaino e invece di entrare a scuola andai via, con l’aiuto di una assistente sociale.
Cui si aggiunse la morte del padre: non stupisce che non abbia voglia di ricordare: «La mia vita, quella vera, iniziò quando avevo 12 anni e con mamma venimmo in Italia per raggiungere mio fratello». Alison non poteva di certo immaginare che da quel momento la passione per gli abiti le sarebbe quasi costata la vita. «Arrivai nel 2010. Portavo il velo e lo shalwar kameez: quando vidi le ragazze italiane, i loro vestiti colorati e i capelli al vento tutto mi parve bellissimo. E iniziai a sognare: volevo studiare, lavorare, avere la mia macchina un giorno. Come loro». Lentamente, la ragazzina prese a portare i jeans insieme al velo e ad uscire con le amiche. Cambiamenti innocui, che però non sfuggirono al fratello: «Cominciò a farmi il lavaggio del cervello. Dovevo portare il velo, pregare e non mettere piede fuori di casa da sola». Passarono anni carichi di tensione: quando Alison iniziò a lavorare la situazione esplose: «Mi disse che mi dovevo sposare, che non potevo vivere così. Ma io non facevo niente di male: non frequentavo nessun ragazzo, nessuna cattiva compagnia. Lavoravo e basta. Provai a parlare con mia madre, ma lei non diceva nulla. A mio fratello consentiva tutto: l’alcool, le droghe. Due o tre volte prese il coltello e disse che voleva ammazzarmi: mi misi tantissima paura. Poi una sera tornai in ritardo dal lavoro: lui era fuori di sé, mi disse che mi avrebbe rispedito a Kabul per farmi sposare. O che mi avrebbe bruciata viva: era pronto a farlo, era solo questione di tempo, glielo lessi negli occhi. Il giorno dopo presi il telefono, i pochi soldi che avevo, lo zaino e invece di entrare a scuola andai via, con l’aiuto di una assistente sociale.
 Avevo appena compiuto 19 anni. E non sono più tornata».
Avevo appena compiuto 19 anni. E non sono più tornata».
 Il destino a cui Alison (il nome è di fantasia) fuggì quella mattina avrebbe potuto essere simile a quello di altre donne e ragazze di fede musulmana nate o cresciute in Italia che per ragioni simili a quelle di questa giovane afgana sono state punite, a volte con la morte: Hina Salem, 21 anni, origini pachistane, accoltellata nel 2006 dal padre a Sarezzo, in provincia di Brescia, per punirla di uno stile di vita troppo indipendente.
Il destino a cui Alison (il nome è di fantasia) fuggì quella mattina avrebbe potuto essere simile a quello di altre donne e ragazze di fede musulmana nate o cresciute in Italia che per ragioni simili a quelle di questa giovane afgana sono state punite, a volte con la morte: Hina Salem, 21 anni, origini pachistane, accoltellata nel 2006 dal padre a Sarezzo, in provincia di Brescia, per punirla di uno stile di vita troppo indipendente.
 Begm Shnez, pachistana, 46 anni, uccisa a bastonate a Novi di Modena nel 2010 per aver cercato di difendere la figlia da nozze combinate. Sana Cheema, cittadina italiana di origine pachistana sgozzata qualche settimana fa da padre e fratello, in una vicenda ancora piena di punti da chiarire. O Jessica - un altro nome di fantasia - ventenne arrivata a Roma quando aveva pochi mesi e cresciuta qui, oggi tenuta prigioniera a suon di botte e frustate a Dacca, in Bangladesh, dalla famiglia che non vuole che torni in Italia: su Facebook posta le foto dei lividi e disperate richieste di aiuto, ma finora nessuno è riuscito a fare nulla per lei.
Begm Shnez, pachistana, 46 anni, uccisa a bastonate a Novi di Modena nel 2010 per aver cercato di difendere la figlia da nozze combinate. Sana Cheema, cittadina italiana di origine pachistana sgozzata qualche settimana fa da padre e fratello, in una vicenda ancora piena di punti da chiarire. O Jessica - un altro nome di fantasia - ventenne arrivata a Roma quando aveva pochi mesi e cresciuta qui, oggi tenuta prigioniera a suon di botte e frustate a Dacca, in Bangladesh, dalla famiglia che non vuole che torni in Italia: su Facebook posta le foto dei lividi e disperate richieste di aiuto, ma finora nessuno è riuscito a fare nulla per lei.
LE storie di queste ragazze non sono certo una fotografia esaustiva dell’Islam italiano: una comunità composta, fra l’altro, da migliaia di giovani che studiano, lavorano e vivono senza problemi in questo Paese, spesso da cittadine. Ma sono un angolo della fotografia: quello che racconta della parte minoritaria della comunità che fatica ad integrarsi in una società con regole diverse da quelle a cui è abituata. Così, se è sbagliato puntare il dito contro un intero gruppo, è un fatto che negli ultimi anni il fenomeno delle violenze, anche mortali, contro le donne di religione musulmana sia arrivato sotto i riflettori anche qui. «Il problema è molto più esteso di quanto non si creda», sostiene Tiziana Del Pra, presidente dell’associazione Trama di Terre di Imola, che si occupa di sostegno alle donne vittime di violenza. « Le bambine arrivate quando l’onda migratoria era al picco sono diventate grandi. Tante altre sono nate qui. Sono ragazze diventate adulte in un Paese che non è quello dei genitori, dentro a una cultura diversa, con sogni differenti da quelli delle madri o dei padri. Non tutti sanno accettarlo».
 Secondo gli ultimi dati, in Italia ci sono circa 150mila musulmani fra i 15 e i 24 anni: più di 300mila sono gli under 15. La metà sono ragazze. «È impossibile dire quante di loro entreranno in conflitto con la famiglia. Tantomeno capire che risposta potranno avere questi conflitti: dipende dalle famiglie, dai Paesi di origine, dal modo in cui si è inseriti nella comunità qui in Italia», spiega Renata Pepicelli, docente di Storia dei Paesi islamici all’università di Pisa e una delle maggiori esperte della questione in Italia. « Non si può generalizzare, ma è un dato di fatto che le Seconde generazioni oggi pongano delle questioni. Siamo di fronte a giovani donne piene di sogni, di speranze e di aspirazioni: che risposte troveranno?».
Secondo gli ultimi dati, in Italia ci sono circa 150mila musulmani fra i 15 e i 24 anni: più di 300mila sono gli under 15. La metà sono ragazze. «È impossibile dire quante di loro entreranno in conflitto con la famiglia. Tantomeno capire che risposta potranno avere questi conflitti: dipende dalle famiglie, dai Paesi di origine, dal modo in cui si è inseriti nella comunità qui in Italia», spiega Renata Pepicelli, docente di Storia dei Paesi islamici all’università di Pisa e una delle maggiori esperte della questione in Italia. « Non si può generalizzare, ma è un dato di fatto che le Seconde generazioni oggi pongano delle questioni. Siamo di fronte a giovani donne piene di sogni, di speranze e di aspirazioni: che risposte troveranno?».Le aspirazioni di cui parla Pepicelli hanno diverse facce, ciascuna potenzialmente portatrice di tensioni: proseguire o no lo studio, indossare o meno il velo, quali luoghi e quali compagnie è lecito frequentare, chi scegliere come compagno di vita. Una risposta univoca su questi temi non c’è, neanche nei Paesi di origine: il Marocco non è il Pakistan, il Bangladesh non è l’Egitto, solo per citare i luoghi di provenienza di alcune fra le comunità più numerose. E anche lì la vera questione non è tanto la religione - che sulle donne dice molte cose e molto diverse, anche all’interno dello stesso Corano - quanto il modo in cui viene interpretata: la tradizione, dunque. Ma è innegabile che in alcuni casi a queste domande nelle società di origine degli immigrati musulmani si diano risposte considerate inaccettabili nel mondo occidentale. E che spesso la diaspora complica ulteriormente il quadro, spingendo le comunità a chiudersi in se stesse per paura di perdere la loro identità.
«Dici che la mia voce è haram (proibita ndr) perché ti eccita. Ma forse sei tu quello che ha bisogno di calmarsi, forse sei tu quello che ha bisogno di rileggersi il Corano. Io ho il velo in testa: tu sei l’assetato, tu sei l’eccitato, tu nel tuo completo da signore importante. Pensi che solo tu puoi dirmi cosa fare. Pensi che solo tu sai cosa è giusto: ma sei solo un cane», canta in Dog (Cane), singolo da milioni di hit su YouTube, Mona Haydar, 28 anni, rapper siriano-americana, velata e femminista: uno dei simboli di una generazione di ragazze poco disposte a sentirsi dire in silenzio cosa dovrebbero e non dovrebbero fare.
Una nuova vita
Dal giorno in cui si è chiusa la porta di casa alle spalle, tutto nella vita di Alison è cambiato. Ha lasciato la città dove viveva, non ha potuto dire a nessuno dove si trova né contattare la famiglia. Le operatrici cui è stata affidata le hanno tolto il cellulare: il rischio è che in un momento di debolezza possa inviare un messaggio, fare una telefonata o postare sui Social network una foto che faccia capire dove si trova. Allora l’incubo tornerebbe: « Mio fratello vuole ancora uccidermi, ne sono certa - dice mentre si tormenta le mani - ogni volta che prendo il treno ho paura di trovarmelo davanti». Incontriamo Alison in un luogo segreto: a prima vista sembra una ragazza come tante, ma appena parla il suo bagaglio di dolore torna a galla: « Vorrei sentire mia madre, spiegarle: ma non posso chiamarla. Ho scritto una lettera alla mia migliore amica: solo per dirle che non deve preoccuparsi per me. Spero glielo abbia detto».
Oggi Alison vive con una famiglia italiana. Con il nome falso, è tornata a scuola: i nuovi amici non sanno nulla della sua storia. «Quando guardo la famiglia in cui vivo e la normalità del loro affetto, come si parlano, come si trattano, mi torna in mente tutto. E sono triste. Ma poi penso ai pigiama party, che avevo tanto sognato nella mia vecchia città e a cui ora posso andare: sono bellissimi!». Non fa in tempo a terminare questa frase che le lacrime le salgono agli occhi.
A passarle un fazzoletto è una ragazza poco più bassa di lei, vestita in jeans e maglietta, con lunghi capelli neri. Per raccontare la sua storia sceglie il nome di Zoya: come Alison è una fuggitiva, come lei ha scelto un nome falso per parlare con noi. Fino a qualche mese fa le due non si conoscevano nemmeno: ma il fatto di condividere la stessa sorte le ha unite al di là dei caratteri diversi.
Anche Zoya ha vent’anni: nata in Pakistan, è arrivata a Roma quando ne aveva tre. È una ragazza sveglia, si capisce subito, e non c’è da dubitare quando dice che sin dai primi giorni di scuola ha capito di essere diversa dalle altre bambine. « Ero costretta a indossare il velo e gli abiti pachistani, non potevo giocare con i maschi né uscire: nessu na festa, nessun parco giochi - racconta - Non facevo che chiedere perché a tutti: maestre, bidelle, amici». Jeans strappati, unghie laccate, voce decisa, Zoya ha un look da ribelle: o forse solo da una che è diventata brava a mascherare quello che ha vissuto. «Ho preso tantissime botte. Sono cresciuta in un clima di oppressione: se infrangevo le regole mi picchiavano, minacciavano di uccidermi, di darmi fuoco. Ma non non mi sono mai arresa: odiavo essere presa in giro per i miei vestiti, volevo essere libera».
Dai sei anni in su, la sua vita è tutta uno stratagemma: un trucchetto per poter restare fuori un po’ di più, un altro per fare quello che fanno le altre ragazzine. Essere brava a scuola è fondamentale: le fa conquistare un po’ di spazio, qualche libertà in più. E a 15 anni, in un momento di gloria scolastica, un cellulare. «Me lo comprò mio padre - racconta - mio fratello lo controllava ogni sera, ma i nomi degli amici maschi erano salvati al femminile e i messaggi cancellati. Così nessuno poteva dirmi nulla. Non si accorsero neanche quando mi iscrissi a Facebook: passavo dal motore di ricerca e cancellavo la cronologia » . Sul Social network Zoya incontra un ragazzo di origini pachistane che abita in Italia: iniziano a parlare, a flirtare, poi lui prende un treno e va a trovarla. La loro storia inizia quel giorno. «Veniva quando poteva: io fingevo di andare a scuola, ma passavo la giornata con lui. Durante una di queste fughe incontrai mia cugina: quella che rispettava sempre le regole, era devota e veniva additata ad esempio per tutte noi. Anche lei era in giro con il suo fidanzato clandestino, un ragazzo che mai la nostra famiglia avrebbe accettato. Le dissi che se non mi copriva avrei detto tutto agli zii. Da allora tutto fu più semplice: mia madre era felice che passassi del tempo con lei, pensava che mi avrebbe fatto bene. Invece quando uscivamo lei era con il suo fidanzato e io con il mio».
La vita di Zoya andò avanti così per anni, fino all’appuntamento che nella vita di altre ragazze, per ultima Sana Cheema, si è rivelato decisivo: una vacanza nel Paese di origine, il Pakistan per entrambe. Lì la giovane si trova di fronte ad un matrimonio organizzato dalla madre: uno zio che arriva a casa con il cugino per chiederla in sposa e un corredo che conteneva « tutte le cose bellissime che mia madre non mi aveva mai comprato: trucchi, gioielli, abiti » . Zoya disse no, davanti a tutti, in modo plateale. «Mi presentai di fronte a mio zio senza velo e senza trucco. Presi a urlare contro mia madre. Fu un dramma: lei mi diede due schiaffi e mi trascinò in camera. Mi conficcò le unghie nel viso. Mi picchiava e gridava: “ Parla, parla! Se c’è qualcuno ti ammazzo”. Quando venne a sapere del mio fidanzato prese un bastone e iniziò a picchiarmi così forte che alla fine il bastone si spezzò. Avevo sangue sulla schiena, non riuscivo a muovermi, ma lei prese un altro bastone e ricominciò. Nessuno faceva nulla. Mio fratello di dieci anni pur di fermarla mi si gettò addosso. Lei lo colpì e lui svenne: dovettero portarlo in ospedale. Solo così la violenza cessò. Anche io avrei dovuto essere curata, ma mi rinchiusero in camera per una settimana. Quando la porta si aprì mia madre mi disse che ero la vergogna della famiglia. Che avrei dovuto sposare subito il mio fidanzato visto che era chiaro che non ero più vergine. E che comunque per lei ero morta. Io ero vergine: provai a dirlo, ma lei non volle neanche ascoltarmi. Alla fine celebrammo le nozze per procura: lui era in Italia, io in Pakistan. La famiglia di mia madre si presentò in lacrime e vestita di nero ».
Il rientro in Italia non fu semplice: dopo qualche mese di serenità il matrimonio si trasformò in un incubo fatto di violenza e di tradimenti. Senza possibilità di chiedere aiuto alla famiglia, Zoya fuggì. Solo l’incontro fortuito con una ufficiale di polizia le permise di entrare nello stesso percorso di accoglienza che ha salvato Alison.
Come la sua amica, ha cambiato tutto. E come lei sta cercando di ricostruirsi la vita con un nome falso e in una città lontana. Ma le conseguenze delle sue scelte non le danno pace. « Nessuno nella mia famiglia ha davvero capito perché ho fatto quello che ho fatto, nessuno ha ragionato sugli errori che hanno commesso. Mia sorella, che ha 12 anni, ha qualche libertà più di me. Non è obbligata ad indossare abiti pachistani, per esempio. Studia moltissimo, vorrebbe diventare dottoressa: ma mia madre l’ha già fidanzata con il fratello minore del cugino che avrei dovuto sposare io, per cancellare l’onta. E le dice sempre che se la scopre a parlare con dei ragazzi la farà infibulare. Lei mi chiama disperata, è in trappola: e io non so come aiutarla. Mia cugina è stata scoperta e rispedita in Pakistan: non è mai più tornata».
È solo a questo punto che la voce di Zoya si incrina: lo smalto sulle unghie è rovinato, da quando ci siamo sedute non hai mai smesso di giocarci. « Dicono che l’Islam impone tutte queste regole ma non è così. L’Islam dice che non puoi forzare tua figlia a sposare una persona senza il suo consenso. L’Islam non dice che le donne sono merce. Io sono orgogliosa di essermi ribellata, di aver lottato. C’è stato tanto dolore, ma spero che mia sorella possa avere una vita più facile della mia».
Alison e Zoya sono un’eccezione: protette dalla promessa di non rivelare dove vivono e chi le ha aiutate, hanno accettato di raccontare la loro storia. Ma trovare donne disposte a parlare per questa inchiesta è stato difficilissimo. Come la maggior parte delle vittime di violenze e di soprusi in qualunque parte del mondo, le musulmane italiane preferiscono rimanere in silenzio. Per paura e anche per solitudine. È un silenzio comune a tante donne abusate, qualunque religione pratichino, in qualunque Paese vivano. Una realtà che in Italia, dove i tassi di violenza sulle donne sono altissimi, conosciamo bene. Ma è anche una realtà che in questo caso si carica di un peso maggiore, quello legato alla religione e allo stigma che - a torto - l’Islam si porta dietro. « Avrei voluto morire piuttosto che esporre la mia famiglia alla condanna pubblica. Anche quando mi picchiavano - ha detto una ragazza di origine siriana - non avrei sopportato un solo sguardo in più su di loro: ci giudicano già abbastanza perché siamo musulmani, perché mamma è velata».
Più delle italiane doc dunque, le figlie della migrazione rischiano di sentirsi sole: per questo anche quelle di loro che a un certo punto trovano il coraggio di denunciare rischiano di non farcela, di tornare indietro. È quello che è accaduto a Nosheen, 28 anni, che otto anni fa vide la madre massacrata a colpi di bastone a Novi di Modena perché voleva salvarla da nozze combinate. Quel giorno anche lei fu ferita gravemente: ma dopo i due processi in cui padre e fratello sono stati condannati è rientrata nella comunità con cui aveva tagliato i ponti.È tornata a indossare il velo che aveva tolto uscita dall’ospedale e ha chiuso i rapporti con l’avvocato che l’aveva rappresentata.
CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". - Islam a testa bassa. La vita delle ragazze musulmane, cresciute in Italia ma costrette a fronteggiare le loro famiglie, pronte alla violenza per imporre la tradizione.25 maggio 2018, di Federico La Sala
ISLAM A TESTA BASSA. La vita delle ragazze musulmane...
CONTINUAZIONE
La catena di solidarietà
In un contesto così difficile, gli “angeli custodi”, le figure incontrate lungo il percorso che offrono sostegno e aiuto alle ragazze, hanno un ruolo fondamentale. Naima Daoudagh è una di loro: in 17 anni di lavoro non ricorda neanche quante donne ha aiutato. «A un certo punto ho smesso di contare » , dice di fronte a un caffè nella sua Brescia. « Alcune neanche le conosco di persona. Ricevo telefonate dalla Calabria, dal Veneto, dal Piemonte. Io faccio quello che posso: ma il passo più grande, dire basta, spetta a loro».
Nata in Marocco, Naima è arrivata in Italia quasi 30 anni fa, quando ne aveva 16. «Eravamo i primi marocchini a stabilirsi in Sardegna - ride - ci guardavano come qualcosa di raro. Ma furono tutti molto gentili » . Qui si è trasferita nel 1995, per seguire il marito, bresciano doc. Dopo poco ha iniziato a lavorare come mediatrice transculturale, poi si è specializzata nell’ambito sanitario e ha cominciato a lavorare in ospedale. «Ho aiutato a partorire donne con mutilazioni genitali. Assistito signore che hanno abortito a causa delle botte ricevute dai mariti. E tenuto per mano adolescenti con il naso e le costole spaccate da padri-padroni che le picchiavano per punirle di uno stile di vita “troppo occidentale”. Quando dico che siamo di fronte a un problema in aumento parlo per esperienza. C’è una questione aperta nella comunità musulmana in Italia oggi. Nei Paesi di origine delle migrazioni si discute sull’interpretazione storica del Corano, di come sposare le regole della religione e quelle della vita contemporanea: qui non si parla, e chi solleva questi temi viene accusato di offrire il fianco agli islamofobi».
Più si passa del tempo con Naima più diventa chiaro che quello di cui discute non è solo il suo lavoro, ma la sua vita: l’amore per un uomo italiano e cristiano che ha rifiutato l’ipocrisia di una conversione finta per sposarla. La difficoltà di crescere la figlia in una famiglia con due culture e due religioni, l’inflessibile volontà di parlare a nome di un Islam che, rivendica con forza, «non è fatto solo di donne con il velo. Non ha una visione unica » . « Non mi si può tacciare di ignoranza perché non mi sono mai coperta la testa: sono musulmana anche io. Prego anche io. E conosco il Corano», spiega.
«Se dico che c’è un problema - insiste - è perché lo vedo. Queste ragazze sono straniere per legge ma italiane nei fatti: nate e cresciute qui, nelle nostre scuole, accanto ai nostri figli. Molte di loro conducono un’esistenza tranquilla, in armonia con il mondo esterno e con la famiglia. Ma per altre la storia è diversa. I genitori vogliono che mantengano l’identità delle origini, ma le loro origini sono qui: non hanno ricordi dei Paesi di origine delle famiglie, ma di Brescia. Siamo nella città di Hina, la ragazza uccisa nel 2006. Noi abbiamo ben presente dove può portare la tensione».
Parole profetiche: qualche settimana dopo questa conversazione, c’è stata la morte in Pakistan, presumibilmente per mano di padre e fratello, di Sana Cheema, che a Brescia era cresciuta e viveva, apparentemente felice. La notizia ha devastato Naima: «Siamo sotto choc: dodici anni dopo ci ritroviamo allo stesso punto. È il segno di un fenomeno che è stato sottovalutato. Non sto dicendo che va tutto male: ci sono giovani realizzate e famiglie felici. Ma c’è anche altro: e non bisogna vergognarsi a dirlo, non bisogna essere buonisti. C’è una zona grigia e va affrontata: perché se non lo facciamo crescerà».
In teoria Naima e Amina Alzeer stanno dalla stessa parte: entrambe combattono contro la violenza, entrambe si spendono anima e corpo nel loro lavoro, entrambe sono diventate un punto di riferimento nazionale. Eppure rappresentano due mondi che si guardano da lontano, a tratti con diffidenza. «Nei confronti di noi donne con il velo c’è un certo pregiudizio » , sospira Amina. « Le femministe e le laiche spesso non ci apprezzano perché proponiamo un approccio anche religioso alla questione della violenza. Allo stesso tempo alcuni esponenti della comunità musulmana ci danno addosso perché dicono incoraggiamo le donne a ribellarsi. Ma se tutti ci criticano, vuol dire che stiamo facendo bene».
Quarantadue anni, italopalestinese, madre di sei figli, Amina è la vicepresidente di Aisha, un progetto che prende il nome dalla moglie preferita del Profeta Maometto il cui scopo è contrastare la violenza e la discriminazione contro le donne. Aisha è un’iniziativa unica in Italia, nata a Milano due anni fa: le donne che vivono una violenza possono rivolgersi al gruppo e avere consulenza legale, terapia di coppia e individuale e, se richiesta, assistenza religiosa. La sua peculiarità è quella di operare all’interno delle comunità, coinvolgendo Imam e moschee. «Tutto nasce da una constatazione semplice: noi musulmane non siamo esenti dal problema della violenza » , dice Amina. Che rifiuta con forza di etichettare la questione come un problema religioso. «È una questione trasversale. Certo da noi c’è da fare uno sforzo in più, quello della consapevolezza: parliamo spesso con donne che non conosco i propri diritti, giuridici, personali e anche sessuali. E per questo sono passive di fronte alla violenza. Ma la religione non c’entra nulla: al massimo, viene usata come scusa».
Il progetto Aisha non è il mio primo impegno pubblico di Amina: da tempo nel Caim - il coordinamento delle associazioni islamiche di Milano e Monza - è abituata a dover difendere le sue scelte. «Sono stanca di ripetere sempre le stesse cose: che velo non vuol dire sottomissione, che chi dice che l’Islam autorizza la violenza sulle donne mente, che siamo parte della società come gli uomini. Uno si aspetterebbe che dopo tanti anni il dibattito in Italia si fosse un po’ evoluto. Ma così non è». Dopo un lancio un po’ faticoso, finora Aisha ha aiutato una ventina di donne: «Parlando anche con i mariti quando abbiamo potuto. Accompagnandole ai centri anti-violenza pubblici quando necessario. E facendole parlare con un imam, quando ce lo chiedono».
La religione
« Non discuteremo di velo, vero? » . Mohammed Ben Mohammed accompagna la frase con un sorriso bonario. Nato in Tunisia, dopo più di venti anni in Italia e alla testa di una comunità, come quella di Centocelle a Roma, che ha attraversato diverse tempeste, l’Imam vorrebbe davvero parlare di qualcosa che non fosse polemico. Se accetta di discutere della questione della violenza di genere è perché la considera «un problema vero». Ma prima di rispondere alle domande ci tiene a chiarire un punto. « L’Islam sta attraversando una fase delicata. La gente fatica a capire come vanno applicate le regole del Corano. Continuo a ripetere che conservare la visione del Profeta non significa vivere come ai suoi tempi, ma nel tempo le diverse interpretazioni della parola sacra hanno creato tradizioni che non rispettano i veri valori. Questo è valido in particolare per la situazione della donna. Con Maometto, le donne avevano un ruolo di primo piano nella società, a cominciare dalle sue mogli. Avevano anche massima libertà nella scelta dello sposo. Adesso siamo lontani anni luce da tutto questo, molto spesso le ragazze non possono dire “no”. Sono tradizioni difficili da cambiare. Ma non è la religione a prescrivere tutto questo».
L’Imam di Centocelle sa per esperienza che quella di cui parliamo è una sfida centrale per il futuro: sua figlia, Takoua Ben Mohammed, 26 anni, vignettista, è uno dei volti emergenti della comunità. Intraprendente, articolata, spiritosa. Una delle poche in grado di raccontare, con la leggerezza del suo tocco di matita e la profondità di chi ha respirato religione e politica sin da bambina, il complesso rapporto fra i giovani musulmani e la società italiana.
«Gestire i ragazzi e le ragazze al crocevia fra due mondi e due culture è difficile», sospira l’uomo. «Nascono, crescono, studiano qui ma i genitori spesso insegnano loro un’altra cultura. Bisogna capire e aiutare. Capita che le famiglie vengano a chiedere aiuto: cerco di spiegare che non si possono imporre cose ai figli. Spesso i genitori restano in silenzio: non sanno affrontare tutto questo. C’è chi non capisce che si possono conservare i nostri valori e vivere nell’Europa di oggi. È la nostra sfida».
Davanti alle storie di Alison e Zoya, di Jessica e a ai racconti delle tante altre donne con cui abbiamo parlato, Ben Mohammed stringe gli occhi e per la prima volta sembra perdere la serenità: «Non si può imporre la religione. E neanche il velo. Sono scelte. Chi sarà costretto a subirle non sarà coerente né sereno. Non è questo che ci ha chiesto il Profeta».
- La scuola
Dalla moschea di Centocelle al quartiere di Torpignattara ci vogliono circa 20 minuti: quattro fermate del tram che attraversa via Casilina, zona popolare della città, portano nei pressi della Pisacane, la scuola che è uno dei cuori pulsanti del quartiere. Qui gli insegnanti si trovano di fronte a problemi simili a quelli che affronta l’imam Ben Mohammed. Torpignattara è una delle zone con il tasso di immigrati più alti di Roma: da anni fra i banchi del suo istituto ci sono allievi di origine bengalese, egiziana, marocchina, ma anche dell’Europa dell’Est.
* la Repubblica, "Le storie al rallentatore" (inserto), 25.05.2018, pp. 1-8 (ripresa parziale, pp. 1-6, senza immagini).
- Già da piccola, Alison non amava i vestiti lunghi. «È uno dei miei primi ricordi. Con la mamma andavamo dal sarto e gli chiedevo di accorciare i miei shalwar kameez, le lunghe tuniche che in Pakistan donne e bambine indossano sopra i pantaloni. Lui diceva sempre che avevo un bel caratterino, poi ci mettevamo tutti a ridere e mi accorciava gli abiti. Ero una bambina, mi lasciavano fare». Afgana, gli occhi a mandorla tipici degli hazara, la minoranza sciita del Paese, Alison, 20 anni, parla dell’infanzia senza troppi rimpianti. «Ricordo solo Peshawar: era orribile». Come tanti altri afgani in fuga dalla guerra visse anni nel limbo della città pachistana approdo di migliaia di profughi: poche scuole, pessimi servizi, razzismo.
-
> PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE --- La danza di ONE BILLION RISING è cominciata! (#riseinsolidarity #1billionrising)12 febbraio 2017, di Federico La Sala
SCOPRI LE ASSOCIAZIONI CHE PARTECIPANO ALL’EVENTO ONE BILLION RISING DEL 14 FEBBRAIO 2017!
Il 14 febbraio si avvicina e sarà una giornata che vedrà gli attivisti One Billion Rising ancora una volta affermare, sulle note di “Break The Chain”, il proprio NO alla violenza su donne e bambine e l’urgenza di una rivoluzione che scardini mentalità e pratiche basate su abuso, omertà e sopraffazione.
Ci stiamo muovendo verso una presa di coscienza collettiva che ci auguriamo porti nuovi risultati a fronte di un’emergenza che non può essere rinviata oltre, a livello globale e locale.
Quest’anno la parola d’ordine di One Billion Rising è SOLIDARIETÀ: solidarietà contro lo sfruttamento delle donne, solidarietà contro il razzismo e il sessismo ancora presente in tutto il mondo. Infatti non c’è nulla di più potente della solidarietà globale, perché questa ci fa sentire più al sicuro nell’esprimere quello che pensiamo e ci dà più coraggio nell’intraprendere quello che ci impegniamo a fare. L’obiettivo diventa quindi ottenere l’attenzione, il coinvolgimento e l’impegno delle istituzioni affinché attuino forme di prevenzione e controllo oltre che politiche sociali ed educative per contrastare il fenomeno della violenza in ogni sua declinazione.
Ancora quest’anno, alla sua quinta edizione, il 14 Febbraio diventa una giornata che One Billion Rising e le sue sostenitrici e sostenitori dedicano ad un impegno concreto per raggiungere questo obiettivo e il tuo sostegno è fondamentale .. più siamo, meglio è!
Alcune associazioni in diverse città italiane hanno iniziato ad organizzarsi. Puoi unirti a loro o scegliere di partecipare insieme ad un gruppo di persone!
Cosa puoi fare? Qui trovi l’elenco, in costante aggiornamento, degli eventi che avranno luogo nella giornata del 14 febbraio (o nei giorni prima o dopo). Clicca sui vari link per sapere cosa fanno, dove e quando e, perché no, unisciti a noi, diffondi la notizia o crea il tuo evento! Qui scopri le linee guida per aiutarti a realizzarne uno: http://bit.ly/partecipa_a_OBR2017 e per ogni necessità puoi contattarci all’indirizzo email obritalia@gmail.com .
ASCOLTA! AGISCI! PARTECIPA!
Ti aspettiamo per danzare insieme contro la violenza sulle donne!
ELENCO ASSOCIAZIONI/GRUPPI CHE ORGANIZZERANNO EVENTI IL 14 FEBBRAIO (in continuo aggiornamento)
*
Il Coordinamento One Billion Rising Italia
Nicoletta B., Nicoletta C., Silvia, Elena
http://www.onebillionrising.org/
https://www.facebook.com/obritalia
http://onebillionrisingitalia.tumblr.com/
email: obritalia@gmail.com
twitter: @OBRItalia
-
> PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". --- Giornata contro le mutilazioni genitali femminili: un portale web per fermare le violenze.6 febbraio 2017, di Federico La Sala
DIRITTI
Giornata contro le mutilazioni genitali femminili: un portale web per fermare le violenze
Il portale "United to End Female Genital Mutilation", in otto lingue, si prefigge di informare ed essere una guida per i professionisti. Perché il problema delle mutilazioni ormai riguarda riguarda anche gli Stati europei e l’Italia che con le ondate dei flussi migratori, si trovano ad accogliere le donne che ne sono state vittime
di Silvia Bia (Il Fatto, 6 febbraio 2017)
Parlare delle mutilazioni genitali femminili, informare gli operatori e i professionisti che vengono a contatto con le donne che le hanno subite, creare una rete internazionale per cercare di combattere un fenomeno frutto di retaggi del passato che oggi è tutt’altro che marginale ed è diffuso in tutto il mondo. È l’obiettivo di Aidos (Associazione italiana Donne per lo Sviluppo), che il 6 febbraio 2017, in occasione della giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, lancia una piattaforma web europea per cercare di porre fine a questa forma di violenza sulle donne e fornire un supporto alle vittime attraverso la formazione di operatori sanitari, personale dei centri di accoglienza e comunicatori che si trovano ad affrontare la tematica da vicino.
Perché il problema delle mutilazioni non riguarda più soltanto i paesi in cui vigono queste tradizioni, ma tutti quelli che, come gli stati europei e l’Italia, con le ondate dei flussi migratori, si trovano ad accogliere le donne che ne sono state vittime, quelle che fuggono proprio per questo motivo dai loro paesi di origine o quelle che ancora devono sottostare a queste disumane imposizioni. Da qui l’idea della piattaforma Uefgm - United to End Female Genital Mutilation, presentata insieme ai rappresentanti di realtà che si battono per i diritti umani, tra cui Unhcr, Oms e il Dipartimento di Pari Opportunità.
Il portale, in otto lingue, si prefigge di informare ed essere una guida per i professionisti che si interfacciano al problema delle mutilazioni genitali femminili, affinché il sistema di accoglienza, il mondo sanitario e sociale, quello legale e i sistemi di istruzione e di comunicazione degli stati europei possano rispondere alle esigenze delle ragazze vittime delle pratiche escissorie attraverso percorsi di formazione, interazione online, dibattiti e confronti tra i vari settori.
“Vogliamo creare una rete tra donne e tra associazioni per iniziare a rispondere senza stigmatizzazioni, stereotipi e preconcetti a una serie di quesiti sull’argomento e per fare chiarezza sulle mutilazioni genitali femminili, che continuano a essere un fenomeno poco conosciuto. - spiega Serena Fiorletta di Aidos - Finora c’era una mancanza di informazioni anche per le persone che prendono in carico donne che hanno subito queste pratiche. Era un limite, che ora cercheremo di colmare con questo lavoro”.
I numeri nel mondo e in Italia - Secondo i dati forniti dall’associazione, in tutto il mondo le donne che hanno subito pratiche escissorie sono più di 200 milioni, di cui oltre 500mila in Europa e circa 57mila in Italia. Ma ogni anno a rischio ci sono 3 milioni di bambine. Secondo il rapporto di Aidos, nel 2010 si stimava che in Italia vivessero circa 57mila donne e ragazze straniere tra i 15 e i 49 che erano state sottoposte al trattamento. Cifre che non sono cambiate nel 2016, in cui si contano in Italia tra le 46mila e le 57mila donne che hanno subito tali abusi. Tra le comunità più colpite, quella nigeriana, che rappresenta circa il 35 per cento del totale delle donne con mutilazioni in Italia, pari a circa 20mila persone. A seguire le egiziane, che rappresentano il 32,5 per cento con 18.600 donne coinvolte, mentre il 15 per cento di esse è originario del Corno d’Africa (dall’Etiopia 3.200 donne pari al 5,5 per cento). Infine l’Eritrea, con 2.800 donne per un totale del 4,9 per cento e la Somalia con il 4 per cento e 2.300 donne.
Cifre importanti, anche se per il momento non esiste un sistema di raccolta sistemico e coordinato che faccia un’analisi del fenomeno in tutto il territorio italiano. Secondo i dati Istat nel 2015 le donne residenti in Italia provenienti da paesi a tradizione escissoria erano 161.457, pari al 6,1 per cento sul totale delle donne straniere, anche se non sono comprese quelle con cittadinanza italiana e non ci sono dati certi, per esempio, sulle migranti irregolari o richiedenti asilo, che secondo l’Unhcr provengono per la maggioranza da Eritrea, Somalia e altri paesi dove la pratica è diffusa (Gambia, Sudan, Guinea, Senegal, Mali, Nigeria). Tra le migranti residenti, le principali comunità interessate dal fenomeno delle mutilazioni sono quella egiziana, senegalese, nigeriana e ghanese.
Cosa dice la legge - In Italia le pratiche escissorie sono un reato penale da una decina di anni che prevede la reclusione dai 3 ai 12 anni, con aggravanti se il reato è commesso su minori. La legge n.7 del 2006 vieta l’esecuzione di tutte le forme di mutilazione genitale femminile, fra cui la clitoridectomia, l’escissione, l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che causa effetti dello stesso tipo o malattie psichiche o fisiche.
Inoltre il reato è punibile anche al di fuori del paese, se è commesso da cittadino italiano o uno straniero residente in Italia, o se l’intervento viene fatto su una cittadina italiana o donna residente in Italia. Con la legge 172 del 2012 poi, l’Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale che contempla pene più severe per una serie di reati tra cui anche le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Dal 2007 inoltre chi subisce o è sotto la minaccia di mutilazioni genitali femminili può fare domanda di asilo per fuggire dal proprio paese. Le mutilazioni genitali femminili sono infatti comprese tra gli atti di persecuzione (sia passati che futuri) per cui si può fare domanda di asilo, poiché le pratiche escissorie sono considerate una forma di violenza morale e fisica discriminatoria di genere legata all’appartenenza al genere femminile per cui è stata riconosciuta la protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato.
-
> LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. -- "AMICA GENIALE". Elena Ferrante tradotta in arabo è un’ottima notizia per la cultura (di Chiara Comito).17 gennaio 2017, di Federico La Sala
- [FOTO.] Rana Idriss, direttrice della casa editrice libanese Dar al Adab che ha pubblicato la traduzione in arabo dell’Amica geniale di Elena Ferrante. La foto è stata scattata alla fiera del libro di Beirut nel dicembre del 2016. (Giacomo Longhi)
Elena Ferrante tradotta in arabo è un’ottima notizia per la cultura
di Chiara Comito, arabista *
- “Il 31 dicembre del 1958 Lila ebbe il suo primo episodio di smarginatura. Il termine non è mio, lo ha sempre utilizzato lei forzando il significato comune della parola. Diceva che in quelle occasioni si dissolvevano all’improvviso i margini delle persone e delle cose”.
È così che Elena Ferrante introduce il concetto di smarginatura ai lettori della tetralogia dell’Amica geniale: è il capodanno del 1958 a Napoli e gli amici e le famiglie di Lila ed Elena, le due protagoniste, si sono radunati sul terrazzo a lanciare fuochi di artificio. Gli amici intrecciano con gli abitanti del palazzo davanti una battaglia all’ultimo sangue, che accende gli animi e li trasforma in combattenti astiosi e violenti. Guardando suo fratello Rino mischiarsi alla lotta, Lila sperimenta la smarginatura: i margini del Rino che conosceva prima si dissolvono con violenza e dalla spaccatura delle ossa, del corpo e della faccia del fratello emerge una seconda natura, più violenta, più crudele, plasticamente ripugnante agli occhi di Lila. Le smarginature per Lila coincidono sempre con dei violenti momenti di passaggio nella sua vita: quando le avverte, il suo mondo precostituito va in pezzi e la sintesi tra l’esterno e l’interno delle cose si rompe, liquefacendosi. Da quella poltiglia di cose e forme, Lila vede emergere la vera natura delle persone, spaventosa e perturbante.
Questo termine, smarginatura, mi ha sempre affascinata. Il suo campo semantico originale è quello della tipografia, ma nel particolarissimo lessico di Ferrante assume tutto un altro significato. Mentre seguivo con orgoglio e interesse il successo internazionale dell’Amica geniale, mi sono chiesta come i traduttori lo avessero reso nelle altre lingue. Ann Goldstein, la traduttrice che ha curato la versione in inglese, così ha risposto alla domanda in un’intervista pubblicata sul Corriere canadese:
- ‘Smarginatura’ è una parola della tipografia che significa ‘togliere le marginature alle forme stampate’ o ‘tagliare i margini delle pagine’. Non è una parola comune, neanche in italiano. Ho cominciato con una traduzione letterale, ‘trimming the edges’, quindi ‘losing the edges’. Ho provato con ‘dissolving the margins’ o ‘dissolving the boundaries’ e alla fine ho deciso che ‘dissolving margins’ esprimeva sia il contenuto emotivo sia il senso originario della parola.
Quando ho saputo che la tetralogia era in corso di traduzione anche in arabo, non ho potuto fare a meno di porre la stessa domanda al suo traduttore, Muauia Abdelmagid, siriano di Damasco, laureato in lingua e cultura italiana all’università per stranieri di Siena, un master in culture letterarie europee a Bologna e già traduttore in arabo - tra gli altri - di Erri de Luca, Niccolò Ammaniti e Italo Svevo.
 Muauia mi ha dato più o meno la stessa risposta: “Si sa che questo termine viene spesso usato per indicare la consumazione dei margini dei libri. Quindi in arabo viene più o meno descritto come ‘disfacimento dei margini’ (inhilal al hawamish). Questo termine arabo mi sembrava perfetto, perché da un lato rispecchia il modo con cui le cose si dissolvono, e dall’altro allude metaforicamente a una dissoluzione morale. Una scelta difficile, ma responsabile direi, e - alla Eco - ‘sembra dire quasi la stessa cosa’”.
Muauia mi ha dato più o meno la stessa risposta: “Si sa che questo termine viene spesso usato per indicare la consumazione dei margini dei libri. Quindi in arabo viene più o meno descritto come ‘disfacimento dei margini’ (inhilal al hawamish). Questo termine arabo mi sembrava perfetto, perché da un lato rispecchia il modo con cui le cose si dissolvono, e dall’altro allude metaforicamente a una dissoluzione morale. Una scelta difficile, ma responsabile direi, e - alla Eco - ‘sembra dire quasi la stessa cosa’”.Il traduttore a dura prova
“Smarginatura” non è stato l’unico termine di Ferrante che ha messo a dura prova la bravura della traduzione di Muauia: i nomi di luoghi sconosciuti al lettore arabofono, i vari Rino, Gino, Nino, difficili da ricordare per un orecchio non abituato a memorizzare e a distinguere questi suoni (e d’altronde, non è mica facile neanche per noi mandare a mente i nomi propri arabi della letteratura araba o quelli russi della letteratura russa).
 Ma, mi dice Muauia: “Il rione popolare di Napoli della Ferrante può essere paragonato, in un certo senso, a quello popolare del Cairo di Nagib Mahfuz”, lo scrittore egiziano premio Nobel per la letteratura nel 1988, che descrisse i quartieri della sua città in diverse opere, tra cui la Trilogia del Cairo e Il rione dei ragazzi.
Ma, mi dice Muauia: “Il rione popolare di Napoli della Ferrante può essere paragonato, in un certo senso, a quello popolare del Cairo di Nagib Mahfuz”, lo scrittore egiziano premio Nobel per la letteratura nel 1988, che descrisse i quartieri della sua città in diverse opere, tra cui la Trilogia del Cairo e Il rione dei ragazzi.La traduzione in arabo dell’Amica geniale, pubblicata dalla prestigiosa casa editrice libanese Dar al Adab, è stata presentata ufficialmente in anteprima a dicembre, nel corso dell’ultima fiera internazionale del libro di Beirut, e ha già registrato un buon successo di pubblico.
 La notizia dell’ottima traduzione aveva già fatto il giro dei lettori che, alla precedente fiera del libro di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, in soli due giorni si erano accaparrati un centinaio di copie. Ho scritto “ottima traduzione” perché così l’ha definita Rana Idriss, direttrice di Dar al Adab, che mi ha confermato: “Muauia ha fatto un lavoro eccellente, tanto che alcuni lettori cercano il libro facendo il suo nome”.
La notizia dell’ottima traduzione aveva già fatto il giro dei lettori che, alla precedente fiera del libro di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, in soli due giorni si erano accaparrati un centinaio di copie. Ho scritto “ottima traduzione” perché così l’ha definita Rana Idriss, direttrice di Dar al Adab, che mi ha confermato: “Muauia ha fatto un lavoro eccellente, tanto che alcuni lettori cercano il libro facendo il suo nome”.- Possiamo rimarcare una sostanziale pigrizia ‘traduttiva’ sia dall’italiano all’arabo sia viceversa
Dar al Adab ha un catalogo dove la letteratura internazionale in traduzione occupa una bella fetta accanto alla letteratura araba e prima di Ferrante aveva già pubblicato Alberto Moravia. Ma i lettori arabi conoscono bene anche Pier Paolo Pasolini, lo stesso Umberto Eco, Italo Calvino, Antonio Tabucchi, Valeria Parrella e molti altri.
Tra il 1970 e il 2010 sono state tradotte in arabo 199 opere di narrativa italiana. Lo rivela una ricerca del 2012 condotta da specialisti di traduzione, nell’ambito del programma Mapping of translation in the Euro-Mediterranean, coordinato dalla rivista francese Transeuropéennes e sostenuto dalla fondazione Anna Lindh. Il dato è citato dall’arabista e traduttrice Elisabetta Bartuli in un articolo sulle traduzioni dall’italiano in arabo pubblicato su Books in Italy qualche anno fa. Bartuli, a ragione, sottolinea come il numero sia fondamentalmente “congruo” con quello delle traduzioni effettuate dall’arabo verso l’italiano nello stesso arco di tempo. Il che evidenzia una sostanziale pigrizia “traduttiva” da entrambi i fronti.
Nel frattempo il primo volume dell’Amica geniale è già in distribuzione, oltre che nel Libano e negli Emirati Arabi Uniti, anche in Egitto, in Iraq e in Arabia Saudita. Il secondo volume sarà invece presentato alla prossima fiera internazionale del libro di Abu Dhabi che si terrà ad aprile, a distanza di qualche mese, rivela Rana, così da “creare la necessaria suspense tra i lettori”.
La traduzione dei romanzi di Elena Ferrante in arabo è quindi un’ottima notizia per il nostro mercato editoriale. Ma non solo. Lo è anche per le relazioni culturali tra Italia e mondo arabo, in un momento in cui la fiducia e la comprensione degli italiani verso gli arabi sono ai minimi storici.
Volendo forzare un po’ il concetto, potremmo dire che è in atto una “smarginatura”, o uno scollamento, tra le due comunità. Ma sapere che dall’altra parte del Mediterraneo esiste un pubblico numeroso di lettori arabofoni che legge e apprezza la nostra letteratura non può che aiutarci a sfatare qualche malinteso e rafforzare la reciproca identificazione. E, forse, può contribuire a riannodare i fili sfilacciati di quel rapporto umano e culturale che da secoli lega profondamente l’Italia alla riva sud del Mediterraneo.
* Internazionale, 16 GEN 2017 (ripresa parziale).
-
> PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE -- Il futuro del mondo? Dipende dalle bambine. Rapporto sullo Stato della popolazione nel mondo 2016 di UNFPA.12 novembre 2016, di Federico La Sala
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
Il futuro del mondo? Dipende dalle bambinedi MICHELA CANZIO (La Stampa, 12/11/2016)
È stato lanciato l’ultimo rapporto sullo Stato della popolazione nel mondo 2016 di UNFPA (Fondo Nazioni Unite per la popolazione) “Avere 10 anni: il nostro futuro dipende da queste bambine”, la cui versione italiana è a cura di AIDOS. L’atteso report demografico analizza annualmente la situazione della popolazione mondiale, attraverso una specifica angolazione, che solitamente vede al centro la salute e i diritti di donne e bambine. Quest’anno il grande framework di riferimento non poteva non essere l’Agenda 2030 e i suoi relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs nel più conosciuto acronimo inglese).
Questi ultimi, definiti ormai una anno fa, nel settembre 2015 a New York, presso le Nazioni Unite e sottoscritti da ben 193 paesi, sono la meta a cui il pianeta vuole arrivare per realizzare uno sviluppo mondiale sostenibile. Ciò che si propone in sintesi è un modello di sviluppo diverso che non sia più solo economico ma che comprenda anche la dimensione ambientale, sociale e umana. Soprattutto la crescita del pianeta non può più permettersi di trascurare la parte svantaggiata di umanità che ancora non era stata raggiunta dai cosiddetti precedenti Obiettivi di sviluppo del millennio. Tra coloro che sono state lasciate indietro ci sono sicuramente, dati delle Nazioni Unite alla mano, le donne e la ragazze, in particolare le giovanissime. Fascia particolarmente fragile è rappresentata da coloro che si affacciano alla pubertà, una zona liminale tra l’infanzia e l’adolescenza vera e propria. Sono queste bambine la chiave della nuova strategia di sviluppo mondiale secondo UNFPA, non solo perché sono il potenziale del pianeta ma perché osservare e progettare per chi ha oggi l’età cruciale di 10 anni ci permetterà tra 15 anni, al termine degli SDGs, di valutare il successo o il fallimento dell’Agenda di sviluppo 2030. Nel 2015 si è raggiunto il più alto numero mai registrato di giovani, 1,8 miliardi e di questi ben 125 milioni hanno dieci anni. Le bambine sono 60 milioni.
“Quando una bambina compie 10 anni il suo mondo cambia. La vita la spinge in tante direzioni, quale strada prenderà dipende dal supporto che riceverà e dalla possibilità di scegliere il proprio futuro. In alcuni posti del mondo, una bambina ha infinite possibilità davanti a sé e inizia a fare scelte importanti per quando sarà adulta. Ma in altre parti del mondo l’orizzonte si restringe. All’ingresso nella pubertà, una combinazione di fattori e discriminazioni possono ostacolare il suo cammino. A soli 10 anni ci sono bambine forzate a sposarsi. Costrette ad abbandonare la scuola a causa di gravidanze precoci”, come si legge nella premessa del Rapporto. Il documento UNFPA quindi non fornisce solo gli ultimi dati demografici ma lancia anche la sfida di seguire la vita di dieci bambine di dieci anni di età, provenienti da diversi paesi, per vedere cosa accadrà nelle loro vite. Ci si concentra quindi in particolar modo sull’obiettivo 5 che è il raggiungimento della parità di genere, meta specifica ma anche obiettivo trasversale per la realizzazione di tutti gli altri.
Le bambine che oggi hanno 10 anni - più della metà in paesi dell’Asia e del Pacifico - sono il punto di partenza per la realizzazione dell’Agenda 2030. I dati che UNFPA ci fornisce sono evidenze che non possiamo più trascurare: ogni giorno circa 47.700 ragazze che hanno meno di 17 anni si sposano, andando incontro a un alto rischio di gravidanze precoci. Circa 9 bambine su 10 abitano in regioni poco sviluppate del mondo e nonostante i passi avanti fatti in questi anni, il numero di quelle escluse dall’educazione primaria è più alto di quello dei coetanei maschi. Un divario che aumenta esponenzialmente se si considera l’educazione secondaria. Inoltre, indipendentemente dal continente in cui è nata, una bambina di 10 anni ha il doppio delle possibilità di suo fratello di doversi occupare di lavori domestici non remunerati. Condizioni di disparità che concorrono ad alimentare un altro altro dato allarmante: oggi, nel mondo, il suicidio è la principale causa di morte tra le adolescenti comprese tra i 15 e i 19 anni.
“Queste bambine sono il volto del nostro futuro - spiega Mariarosa Cutillo, Chief of Strategic Partnerships di UNFPA - La piega che le loro vite prenderanno dipenderà dalle potenzialità che potranno esprimere se noi, organizzazioni internazionali e non governative, attori pubblici e privati e soprattutto i governi del mondo, le metteremo in condizioni di farlo. La loro storia misurerà l’efficacia dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Non avremo una seconda opportunità. È un appuntamento che non possiamo mancare “.
-
> PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. --- Turchia, la Neolingua di Erdogan. "Quel dizionario deve essere cambiato". Interv. a Elif Shafak (di Marco Ansaldo)9 maggio 2016, di Federico La Sala
- PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO.
“Quel dizionario deve essere cambiato così un potere arcaico maltratta la cultura”
Parla la scrittrice Elif Shafak. “È un testo che va in mano ai giovani nelle scuole”
intervista di Marco Ansaldo (la Repubblica, 09.05.2016)
«COME scrittore, ho esaminato il dizionario. E come scrittrice- donna, sono furibonda che il dizionario della lingua turca contenga descrizioni arcaiche e sessiste». Elif Shafak non solo è la figura di narratrice impegnata che i lettori italiani ormai conoscono per i tanti suoi romanzi tradotti, l’ultimo “La città ai confini del cielo” (Rizzoli). Ma è un’autrice pubblicata in più di trenta lingue, e sempre molto attenta all’uso della parola. I suoi ultimi testi, ad esempio, li ha scritti direttamente in inglese.
Lei ha già twittato la sua rabbia per quello che è uscito sul dizionario. Come spiega quanto è successo?
«Facciamo degli esempi concreti. Prendiamo la parola “sporco”. Il dizionario descrive il termine come proprio “di una donna che ha le mestruazioni”. Ecco, lo trovo inaccettabile. Quello che mi fa indispettire di più è che questo testo venga usato nelle scuole, all’università. Mi chiedo: è questo che insegniamo ai nostri giovani?».
Ma non trova singolare che questo slittamento di termini arrivi adesso, in un periodo in cui la Turchia è in preda a tensioni? Fare operazioni di questo tipo è tipico dei regimi.
«È chiaro, la Turchia è un Paese sessista e patriarcale. E così è il suo dizionario ufficiale. Il testo dell’Accademia della lingua turca deve essere assolutamente riformato. E ad essere cambiati devono essere entrambi: sia la mentalità dominata dal maschilismo, sia il dizionario che la rispecchia».
Senta, Elif, quello che stiamo vedendo in Turchia è un momento di grande turbolenza, culminato la scorsa settimana con le dimissioni del premier Ahmet Davutoglu in contrasto con il Presidente, Tayyip Erdogan. Lei come lo vive?
«A proposito dei qui pro quo sulle parole le faccio questo altro esempio di che cosa accade proprio in Parlamento. Nei giorni scorsi un membro del Partito democratico dei popoli, curdo, ha detto di voler fare una citazione da Oscar Wilde. Un parlamentare del partito conservatore di ispirazione religiosa è saltato su contestando l’idea di citare qualcuno che non fosse né musulmano né turco: “Lei non ha esempi di questa cultura, di questa civiltà?”, gli ha obiettato. E in quel frangente un altro esponente della formazione al potere confondeva l’autore irlandese con gli Oscar, quelli di Hollywood. A quel punto una deputata dello schieramento curdo ha chiarito: “Ma è Oscar Wilde. Non è un premio, è una persona”. Ecco, siamo a questo punto».
La Turchia, dunque, continua a essere un Paese spaccato?
«In modo totale. Sono due pianeti diversi: chi sostiene e continua ad appoggiare il capo dello Stato, Recep Tayyip Erdogan; e chi invece, per una serie di altre ragioni, è contro. E lui, che teoricamente dovrebbe essere al di sopra delle parti, si rivela come il politico più divisivo della storia moderna della Turchia».
Dal comico tedesco Jan Boehmermann al giornalista Can Dundar. In questo periodo gli intellettuali sono sotto il tiro del potere turco. Che reazione c’è nel Paese?
«In passato avevamo una solida tradizione di humour nero. La politica era sempre un ambiente rude, ma la gente poteva ridere dei politici, poteva criticare. Ora non più».
E il modello turco, su cui in Occidente si sperava tanto?
«Quel miscuglio unico di democrazia occidentale, secolarismo, cultura islamica e società pluralistica, oggi è una retorica vuota. E in Turchia milioni di persone meravigliose sono profondamente depresse, demoralizzate, sole».
Ma poi, quella citazione su Oscar Wilde, in Parlamento?
«È caduta come tra i sordi. Era sulla volgarità del potere».
Turchia, la Neolingua di Erdogan
L’Istituto che si occupa del linguaggio è sotto accusa per aver attribuito definizioni imbarazzanti e sessiste a termini di uso comune nel vocabolario ufficiale. Protesta delle ong e dei gruppi femministi
di Marco Ansaldo (la Repubblica, 09.05.2016)
UNA “NEOLINGUA” in salsa islamica. Un esperimento di imposizione delle parole in senso conservatore e patriarcale. È l’ultima novità che viene dalla Turchia di Tayyip Erdogan. Il dizionario ufficiale della lingua turca definisce le donne nel loro periodo mestruale come «sporche». Il testo elaborato dall’Istituto di lingua turca (Tdk) è accusato di sessismo e più termini si trovano adesso sotto il tiro di una petizione lanciata da donne e da esponenti laici in Turchia e all’estero, che si battono perché le spiegazioni di diverse parole siano cambiate.
L’Istituto illustra la parola “kirli”, sporco, dando come esempio «una donna che ha le mestruazioni». Gli altri due significati forniti sono «non pulito» e un moralistico «contrario ai valori della società». Non è la prima volta che l’istituzione - il cui scopo è la difesa di una lingua che ha origini uralo-altaiche, dunque nobili e antiche - finisce sotto accusa. Sostenuta dal governo conservatore di ispirazione musulmana che governa il paese dal 2002 a oggi, il Tdk starebbe coniando una sorta di “Neolingua” di orwelliana memoria, in linea con il clima liberticida che si respira negli ultimi anni nel paese.
L’Istituto era stato già criticato per aver usato definizioni giudicate come sessiste. La parola “ musait”, che è un termine turco proveniente dall’arabo, significa «disponibile». Ma nel dizionario il secondo esempio che viene dato è quello di una donna «pronta a flirtare», e che può «flirtare facilmente». In Turchia, un gruppo chiamato “Collettivo di femministe Istanbul” si chiede ora, sul suo profilo Facebook, «Non possono essere “disponibili” anche gli uomini?».
Il presidente dell’Associazione per la lingua turca, Mustafa Kacalin, risponde alle critiche dicendo che «disponibile» è un termine entrato nel dizionario nel 1983. Tuttavia la petizione chiede che proprio questa parola venga adesso rivista, sostenendo che l’atto di flirtare è comune ai due sessi e non deve essere attribuito solo alle donne.
L’associazione è contestata anche per un altro termine, che associa un uomo o una donna cattiva all’esempio di “prostituta”. Ma ancora altre parole sono sotto tiro.
Il Tdk è nato nel 1932 . Negli Anni ‘30 e ‘40 si è impegnato per rimpiazzare le parole che contaminavano la sfera dell’ormai decaduto Impero ottomano, provenienti dall’arabo, dal persiano, dal greco e dal francese.
-
> DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. ---15 marzo 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO.
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- Resta un problema più vasto del misero maschilismo dei politici, che dovrebbero avere la furbizia di pensare ogni nequizia ma di non dirla. Se le femmine sono femministe coscienti di esserlo in gruppi privilegiati ma non oceanici, i maschi sono per natura da sempre maschilisti. Lo sono stati per secoli, per legge, religione, natura, cultura, storia, denaro, potere e mamme adoranti (Natalia Aspesi).
Caro maschio ci fai ridere
di Natalia Aspesi (la Repubblica, 15.03.2016)
E se il vecchio e scaltro Bertolaso avesse ragione? Se a ogni donna incinta, operaia, amministratrice delegata, mendicante, diva, escort, quindi anche sindaca, fosse consigliato di lasciare il lavoro, con un bello stipendio da parte ovviamente dello Stato?
PER fare solo la pre-mamma e la mamma, non per qualche mese soltanto ma almeno per qualche anno, ritrovando poi il suo lavoro e il suo stipendio? Permesso anche alla casalinga stessa, che smettendo di cucinare, rifare i letti, fare il suo dovere di sposa, sostituita da una casalinga statale in tutte le mansioni, potesse dedicarsi solo a questo mestiere solo a lei femmina consentito, per seguirlo a tempo pieno.
In questo caso essere donna e madre potrebbe essere in sé una libera professione al servizio della Patria e anche l’incinta Meloni potrebbe usufruirne senza infastidire Bertolaso e compagni, evitando di vomitare durante la campagna elettorale e di perdere le acque durante una manifestazione di piazza. Ma soprattutto togliendo all’aspirante sindaco almeno un motivo per dichiarazioni sceme, che purtroppo lo aiuterebbero a vincere le elezioni, con ovvi danni alla città già molto danneggiata. Un sindaco che allatta durante una accesa battaglia in giunta renderebbe invece la Meloni sempre vincente, perché anche i suoi più duri antagonisti maschi arrossirebbero guardando altrove: ma anche in questo caso a perdere sarebbe di nuovo Roma, e non a causa di mamma Meloni, ma semplicemente della Meloni.
Essendo da almeno cinquant’anni femminista, non vorrei essere giudicata maschilista se oso dichiarare che la signora Patrizia Bedori ha fatto molto bene a ritirare la sua candidatura, che non avrebbe neppure dovuto proporre, per molte ragioni. Perché se una può diventare sindaco perché in 74 l’hanno votata online, non pare proprio un furor di popolo, anche nel suo stesso noiosissimo movimento già molto antiquato. Perché ha smascherato definitivamente il finto giovanilismo democratico dei suoi compagni elettronici che l’hanno insultata perché “casalinga e disoccupata” come milioni di altre donne e ormai molti uomini disoccupati e casalinghi in quanto soli. Che l’hanno definita «brutta, grassa e obesa», come molti rispettati onorevoli maschi, quindi di meritare di essere «buttata fuori a calci in culo». Bastava dire che, come la maggior parte dei suoi compagni, non sembrava preparata al difficilissimo ruolo di sindaco di Milano, soprattutto dopo Pisapia.
Del resto, anche in passato i ragazzi Cinque Stelle avevano dimostrato la loro paura delle donne, come Massimo De Rosa che ha onorato le colleghe del Pd con un complimento forse invidioso: «Voi siete qui solo perché siete brave a fare i pompini!». Brutte non le vogliono quegli incontentabili, ma neanche belle. Nicola Morra, senatore M5S: «La ministra Boschi sarà ricordata più per le forme che per le riforme» (per saperne di più c’è il libro Stai zitta e va’ in cucina di Filippo Maria Battaglia).
Resta un problema più vasto del misero maschilismo dei politici, che dovrebbero avere la furbizia di pensare ogni nequizia ma di non dirla. Se le femmine sono femministe coscienti di esserlo in gruppi privilegiati ma non oceanici, i maschi sono per natura da sempre maschilisti. Lo sono stati per secoli, per legge, religione, natura, cultura, storia, denaro, potere e mamme adoranti.
Da anni cercano di correggersi, da quando negli anni Settanta si misero persino a fare autocoscienza come le ragazze. Ma non ce la fanno sino in fondo. Ogni tanto il maschio militante salta fuori, lancia un’ingiuria sempre fisica e sessuale, o, se è molto nervoso, taglia la gola della donna che non fa finta di adorarlo comunque e di essere certa della sua superiorità. Che fare? Niente, stare zitte, ridere a ogni bertolasata, che più o meno sempre ci sarà, e prendersi tutto quello che ci spetta non tanto come donne quanto come esseri umani.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO.
-
> PICCHIARE LE DONNE?! DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". --- Da Gesù a Maometto. Una serie di documenti sulle origini misconosciute dell’Islam (di Akram Belkaid)11 gennaio 2016, di Federico La Sala
Una serie di documenti sulle origini misconosciute dell’Islam
Da Gesù a Maometto
La recente attualità dimostra l’urgenza di una rilettura dei testi sacri islamici mediante un’analisi del contesto della rivelazione. Poco conosciuto e molto poco diffuso sui media, lo studio del Corano, portato avanti da ricercatori interdisciplinari, potrebbe contribuire a lottare contro il radicalismo religioso, testimoniando i lavori sulla posizione essenziale di Gesù nei primi tempi dell’Islam.
di Akram Belkaid (Le Monde Diplomatique, dicembre 2015, pag. 23)
(traduzione dal francese di José F. Padova)
Non è per niente facile affrontare la questione dell’Islam e delle sue origini sfuggendo all’attualità e alle tematiche ricorrenti che questa impone, fra le quali l’imprescindibile «jihad». Quindi è un vero e proprio tour de force il documentario realizzato da Gérard Mordillat e Jérôme Prieur in sette episodi e dedicato all’influsso del Cristianesimo sull’Islam, per lo meno di quello dei primi tempi dalla Rivelazione (1).
I documentari di cui si tratta sono reperibili su Arte (molto interessanti, ma purtroppo soltanto in francese):
Jésus et l’Islam - La série, en VOD, DVD - ARTE Boutique
http://boutique.arte.tv/f10576-jesus_et_islam_serie
Il primo merito di questo lavoro è di dimostrare che lo studio interdisciplinare del Corano- vale a dire, quello che si estende al di là del solo commento teologico - è una scienza in divenire. Il Libro sacro dei musulmani è spesso presentato come un «testo senza contesto», a causa della sua complessa struttura letteraria e dell’impossibilità di datare le sue sure (capitoli) o anche di determinare l’insieme dell’ordine cronologico della loro rivelazione. La posta in gioco è importante, perché una conoscenza migliore del contesto storico e sociale nel quale è comparsa l’ultima delle tre grandi religioni monoteiste aiuterebbe a superare le sfide politico-religiose contemporanee.
Il dialogo fra cristiani e musulmani, così come la separazione fra il temporale e lo spirituale, non possono che trarre beneficio dal richiamo della vicinanza originaria fra la croce e la mezzaluna. Come il documentario, nel corso del quale intervengono numerosi ricercatori di nazionalità e d’orizzonti diversi, illustra nei dettagli, l’Islam fa di Gesù un personaggio tanto essenziale quanto lo è Adamo, il primo uomo. Aissa ibn Mariam, ovvero Gesù, figlio di Maria, è colui che viene alla fine dei tempi per uccidere l’Anticristo. Ora, un buon numero di musulmani, pur sapendo bene che colui che designano con il termine di massih, detto altrimenti «il Messia», è effettivamente uno dei «loro» profeti, non hanno consapevolezza del posto fondamentale, unico, che egli occupa nel Corano. Egli vi è presentato come «lo spirito», «il soffio» e «il verbo» di Dio. È un uomo bello, fuori dal comune e capace di fare miracoli. Al contrario il Libro Sacro è quanto mai laconico per tutto quanto riguarda Maometto (Mohammad) il quale, uomo comune - non compie miracoli - non è «altro che» il messaggero (rassul) di Allah e un profeta (nabi), uno fra i tanti. Questa prossimità fra le due religioni si dimostra anche per l’importanza accordata a Maria che, nel Corano, è la sola donna designata con il suo nome e ricordata più volte, la sura XIX le è dedicata.
Una semplice talea del cristianesimo?
Quando si diffonde un vocabolario dividente - si pensi in particolare al ricorrere della parola «crociati» usata dagli islamisti radicali per designare i cristiani, o alla confusione fra Islam e islamismo politico da parte di un buon numero di Occidentali - l’evidenziazione di una parentela di questo genere potrebbe placare i rapporti tesi. Allo stesso modo, in una società europea occidentale, segnata da una scomparsa progressiva del fatto religioso, questa affinità smentisce gli abituali discorsi sull’alterità dell’Islam in rapporto al sistema di riferimento giudaico-cristiano.
 Beninteso, si potrà obiettare che le differenze teologiche sono notevoli. Così il Corano rifiuta la natura divina di Gesù, affermando che Dio «non saprebbe partorire o essere partorito». Ugualmente nega che Gesù sia morto crocifisso. D’altra parte il documentario riserva ampio spazio a queste problematiche, ricordando due versetti (157 e 158) della sura IV, dove è scritto che coloro che hanno creduto di vedere il Messia sulla croce sono stati vittime di un’illusione. Inoltre l’Islam fustiga il cristianesimo, che accusa di aver rotto con uno stretto monoteismo associando (chirk) Gesù e lo Spirito Santo a Dio (2).
Beninteso, si potrà obiettare che le differenze teologiche sono notevoli. Così il Corano rifiuta la natura divina di Gesù, affermando che Dio «non saprebbe partorire o essere partorito». Ugualmente nega che Gesù sia morto crocifisso. D’altra parte il documentario riserva ampio spazio a queste problematiche, ricordando due versetti (157 e 158) della sura IV, dove è scritto che coloro che hanno creduto di vedere il Messia sulla croce sono stati vittime di un’illusione. Inoltre l’Islam fustiga il cristianesimo, che accusa di aver rotto con uno stretto monoteismo associando (chirk) Gesù e lo Spirito Santo a Dio (2).Queste divergenze hanno alimentato innumerevoli polemiche e una quantità di conflitti. Un altro aspetto interessante del lavoro di Mordillat e Prieur: riferiscono, citandone i testi, che diversi ricercatori hanno dimostrato come l’Islam non è nato in opposizione al cristianesimo, ma come una certa forma di continuazione, perfino come un tentativo di riforma. In effetti, la religione musulmana riprende o riformula le dottrine cristiane, che continuavano a essere diffuse nel VII secolo. È il caso del docetismo, un’eresia dei primi tempi del cristianesimo, secondo la quale era impossibile che sulla croce Cristo fosse morto. E la posizione di Maria nel Corano si chiarisce alla lettura di certi testi apocrifi, che cioè si oppongono a quelli, canonici, riconosciuti dalla Chiesa, che neppure ne fa menzione.
Sul piano storico, l’Islam nascente non è quindi estraneo ai dibattiti teologici della sua epoca. In un certo qual modo finisce per chiudere le interminabili dispute sulla natura di Cristo. La preminenza dunque di Gesù nel Corano fa quindi addirittura pensare che Maometto si rivolga anche ai cristiani, e non soltanto unicamente ai politeisti della Mecca e della Penisola Arabica, allo scopo di convincerli alla sua causa. Si tratta d’altronde di una delle ragioni - e non della sola - della folgorante velocità con la quale le popolazioni cristiane del Levante adottano questa nuova religione.
Allora l’Islam non sarebbe altro che una talea del cristianesimo? Certamente è dubbio che una risposta puntellata sui piani scientifico e storico sia possibile. Rimane il fatto che, come affermano gli esperti in materia qui interrogati, vi è proprio una «intertestualità» fra l’Islam nascente e il cristianesimo come esisteva nel VII secolo.
Il documentario imbocca un’altra pista in grado di consolidare un dialogo interreligioso altrettanto importante, se non addirittura più urgente. Esiste oggi nel mondo musulmano un sentimento antiebraico alimentato dalla situazione dei Palestinesi, ma che non si può negare si fondi anche su una certa lettura del Corano (3).
 Da qui la necessità di tenere nel debito conto il contesto nel quale sono apparsi i versetti coinvolti. Quando accusa gli ebrei di aver rivendicato la morte di Cristo il Corano riprende, anche qui, idee cristiane molto diffuse nel VII secolo e che avranno vita dura. Effettivamente sarà necessario attendere il 1963 perché Papa Giovanni XXIII chieda in una preghiera: «Perdonaci la maledizione con cui abbiamo ingiustamente oppresso gli ebrei. Perdonaci per averti crocifisso una seconda volta con il nostro peccato (4)».
Da qui la necessità di tenere nel debito conto il contesto nel quale sono apparsi i versetti coinvolti. Quando accusa gli ebrei di aver rivendicato la morte di Cristo il Corano riprende, anche qui, idee cristiane molto diffuse nel VII secolo e che avranno vita dura. Effettivamente sarà necessario attendere il 1963 perché Papa Giovanni XXIII chieda in una preghiera: «Perdonaci la maledizione con cui abbiamo ingiustamente oppresso gli ebrei. Perdonaci per averti crocifisso una seconda volta con il nostro peccato (4)».
 Allo stesso modo, un certo numero di esperti, interrogati nel documentario, ricordano che il conflitto che oppose Maometto alle due tribù ebree di Medina, città nella quale trovò rifugio dopo la sua fuga da La Mecca (l’egira, nel 622, ovvero dodici anni dopo l’inizio della rivelazione) era d’ordine politico ma anche teologico. Sul piano storico il Profeta, allineandosi sulla scia di Mosè e di Gesù e intendendo riformare l’ebraismo e il cristianesimo, considerati nel Corano come un’alterazione della religione originale, si è probabilmente urtato contro i rabbini. Questo porta gli specialisti ad affermare oggi che questo libro non è antiebraico, ma antirabbinico.
Allo stesso modo, un certo numero di esperti, interrogati nel documentario, ricordano che il conflitto che oppose Maometto alle due tribù ebree di Medina, città nella quale trovò rifugio dopo la sua fuga da La Mecca (l’egira, nel 622, ovvero dodici anni dopo l’inizio della rivelazione) era d’ordine politico ma anche teologico. Sul piano storico il Profeta, allineandosi sulla scia di Mosè e di Gesù e intendendo riformare l’ebraismo e il cristianesimo, considerati nel Corano come un’alterazione della religione originale, si è probabilmente urtato contro i rabbini. Questo porta gli specialisti ad affermare oggi che questo libro non è antiebraico, ma antirabbinico.Un secolo dopo la sua apparizione l’Islam, in piena espansione territoriale, si affrancherà a poco a poco dalla figura tutelare di Gesù e darà spazio preponderante a Maometto. La divergenza con il cristianesimo si accentuerà sul filo dei secoli. Ma si nota bene l’interesse di una rilettura del Corano alla luce del contesto storico e sociale nel quale è stato rivelato. Si tratta qui di una tappa indispensabile per portare a buon fine un’esegesi ambiziosa, destinata a rinnovare il pensiero islamico. Congelata dall’XI secolo questa ijtihad, in altre parole l’interpretazione dei testi, così ricca nel corso dei secoli che seguirono la morte del Profeta nel 632, non è più che un ciclo iterativo, nel quale si succedono i medesimi commentari di commentari del Libro Sacro.
La linguistica - per lo studio approfondito e dettagliato dell’arabo coranico e dei suoi numerosi prestiti da altre lingue, in particolare dal siriaco, una lingua semitica derivata dall’aramaico - così come l’antropologia sono preziosi strumenti per questa necessaria revisione. Vi si aggiunga l’archeologia, le cui scoperte permetterebbero di comprendere meglio il contesto storico della rivelazione - a condizione però che l’Arabia Saudita autorizzi un maggior numero di scavi sul suo suolo. In seguito si tratterà di diffondere gli insegnamenti ottenuti dalla reinterpretazione del testo coranico, nel modo seguito da questa serie documentaria. Si può presumere che ciò non si farà senza problemi.
(1) Gérard Mordillat e Jérôme Prieur, Jesus et l’Islam, sette documentari da 52 minuti, diffusi su Arte 8, 9 e 10 dicembre 2015.
(2) Questa esigenza di uno stretto monoteismo è uno dei fondamenti del wahabismo e spiega l’iconoclastia (opposizione all’adorazione delle immagini sacre) da parte di certe correnti radicali.
(3) Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias (sotto la direzione di -), Juifs et musulmans, retissons les liens! [Ebrei e musulmani, riannodiamo i legami], CNRS Editions, Paris, 2015.
(4) Citato dagli Autori nella loro opera.
-
>DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". --- Il tempo della guerra e il tempo della storia - e il tempo della parresia (di Massimo Campanini)23 novembre 2015, di Federico La Sala
Il tempo della guerra e il tempo della storia
di Massimo Campanini (Il Mulino, 23 novembre 2015])
È venuto il tempo della guerra, pare, ma è venuto anche il tempo della parresia. Del dire la verità. Michel Foucault, nella prolusione di apertura dei suoi corsi al Collège de France nel 1970, come sempre avanzava un’idea geniale ma, come al solito, non arrivava a trarne tutte le conseguenze. Da una parte, infatti, notava giustamente che uno dei più potenti meccanismi di controllo e di esclusione esercitati dal potere nella società contemporanea è quello della manipolazione del discorso e del controllo sulla parola. D’altro canto, l’esigenza che sottende al dire, l’esigenza che spinge gli uomini a parlare è la volontà di verità, ma questa volontà di verità - e qui Foucault sbagliava - avrebbe l’implicazione negativa di alimentare l’esclusione, grazie al suo stesso essere assertivo. In parte ciò è vero, ma se non si cerca la verità, o almeno “una” verità provvisoria, per manifestarla con la parola, come si può riuscire a smascherare il meccanismo del controllo e dell’esclusione?
È quello che accade oggi con l’islam su cui l’unico discorso veramente lecito è quello dell’esecrazione e del sospetto, sulla base della convinzione che si tratti di un pericolo mortale per la civiltà (dell’Occidente ovviamente, come se ce ne fosse una sola). Se volessimo applicare la parresia che viene stimolata dalla volontà di verità, potremmo ritornare alla conoscenza e alla storia, e accorgerci che ciò che sta accadendo a partire dagli anni Novanta del secolo scorso non è l’erompere irrazionale di forze magmatiche che risalgono dalle profondità dell’inferno, di un inferno dove Maometto veniva atrocemente punito da Dante come seminatore di scisma (nel Medioevo l’islam era spesso dipinto come un’eresia cristiana). Il jihadismo invece ha una storia, un perché.
L’opinione pubblica in Occidente si ferma attonita davanti ai suoi morti, ma deve imparare a ragionare freddamente, deve imparare a individuare le radici della malattia per combatterla. E queste radici non stanno nell’intrinseca violenza dell’islam come farneticano alcuni intellettuali, politici e opinion makers. Anche se ci volessimo fermare al testo base, il Corano, disconoscendo le conquiste di scienza, d’arte e di pensiero dell’islam lungo quindici secoli, il Corano contiene sì versetti bellicosi, ma anche versetti come il seguente: «O uomini, invero Noi [è Dio che parla, NdA] vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù perché vi conosceste a vicenda» (49,13). Dunque, il pluralismo e il rispetto reciproco sono voluti da Dio, sono insiti nell’islam.
Pertanto non vale richiamare ridicoli parallelismi tra il Corano e il Mein Kampf, se non si dice la verità storica, se non si formula un discorso storico che smaschera il meccanismo dell’esclusione. Perciò è necessario cominciare col colonialismo tra Ottocento e Novecento, con l’espropriazione violenta della libertà e della cultura dei popoli afro-asiatici (e musulmani) in seguito all’espansione imperialistica. L’impatto violento, attraverso il colonialismo, sulla visione del mondo musulmana da un lato le ha fatto (in parte) smarrire l’identità, dall’altro ha suscitato reazioni di antagonismo anche radicale.
L’atteggiamento colonialista dell’Occidente in realtà non è mai finito, anche dopo che i Paesi musulmani hanno conquistato l’indipendenza. La pesante ingerenza euro-americana in Medioriente, fino agli ultimi anni, dall’Afghanistan all’Iraq alla penisola araba, ha dato una motivazione a Bin Laden nell’organizzare al-Qaeda. Il jihadismo si è poi alimentato nel marasma delle dissoluzioni delle statualità mediorientali, come in Libia, in cui la caduta di Gheddafi è stata determinata decisivamente dall’intervento franco-britannico.
Nello stesso orizzonte si colloca naturalmente la questione israelo-palestinese, una ferita mai sanata dal 1948 (nascita dello Stato di Israele) fino ad oggi, con tutto quanto ha comportato in termini di guerre, destabilizzazione regionale, sradicamento di popoli, fronti del “rifiuto”.
Sul piano interno ai Paesi arabi-musulmani, i regimi dittatoriali - per decenni sostenuti proprio dall’Occidente che ipocritamente predica una democrazia a suo uso e consumo - hanno annientato la società civile, rendendola fragile e incapace di sviluppare anticorpi efficaci contro la negazione dei diritti. E infine, last but not least, una devastante crisi economica e sociale, favorita dall’applicazione di un liberismo selvaggio, iniziata già a partire dalla fine degli anni Settanta, ha depauperato le classi medio-basse.
In questo humus, la propaganda aggressiva di predicatori estremisti, il richiamo al jihad di organizzazioni spesso, se non create, alimentate per fini egemonici da Paesi strategicamente importanti (leggi l’Arabia Saudita), l’insipienza della strategia occidentale (leggi la miope emarginazione dell’Iran) e le stesse divisioni interne tra i Paesi chiave (come gli Stati Uniti e la Russia) hanno preparato il terreno a un incancrenirsi del jihadismo che rischia di affascinare ampi settori di popolazione, soprattutto giovanile, disadattata e in cerca di un Welfare che la società di mercato non offre più.
La parresia storica dunque fornisce una chiave di interpretazione credibile e non semplicistica. La ponderazione degli elementi che compongono questo quadro, la correzione delle storture che ne emergono sono gli unici veri mezzi per andare alle radici di quello che chiamiamo, con un termine che non spiega nulla, ma si limita ad accrescere spavento e insicurezza, “terrorismo”. A ciò dovranno aggiungersi la conoscenza e l’educazione, nelle scuole, nelle università, nei mass-media che plasmano l’opinione pubblica ma che finora consentono, come diceva Foucault, un solo tipo di discorso lecito.
-
> PICCHIARE LE DONNE. DIO, UOMINI E DONNE --- I pugni, Francesco e tutti gli altri, imparate a tenerli in tasca (di Monica Lanfranco - La mamma, Dio e la nonviolenza).18 gennaio 2015, di Federico La Sala
Società
La mamma, Dio e la nonviolenza
di Monica Lanfranco (Il Fatto, 18 gennaio 2015)
Avevamo bisogno, dopo il bagno di sangue e le puntualizzazioni su chi è o non è Charlie, dell’esternazione del Papa circa l’onore della mamma da difendere?
No, purtroppo. Pur sapendo che ogni evento, notizia ed emozione viene triturata nella turbina social che nulla sedimenta qualche pulviscolo resta impresso, e il pugno papale è memorabile, quindi doppiamente dannoso.
Usando l’ottimo stile comunicatore tanto caro a Berlusconi e a Renzi (la scanzonata mescolanza di pop e friendly, con selfie, corna, barzellette e frasi a effetto) il campione della fede Papa Francesco smentisce la sobrietà manifestata nella scelta del suo nome e mette ko qualche decennio di faticosa costruzione di pratiche politiche collettive nonviolente e antisessiste.
Proprio lui che, pochi mesi fa, sull’omosessualità affermava ‘chi sono io per giudicare’, oggi sostiene che chi insulta la mamma si deve aspettare un pugno. Seguono interpretazioni della sottile metafora da parte di autorevoli uomini: Eugenio Scalfari scrive che non si può chiedere al Papa di essere volterriano, visto che la ‘mamma’ di Bergoglio è la chiesa cattolica, e Moni Ovadia trova l’esternazione lungimirante, plaudendone l’iniziativa, perché manda un messaggio di forza della comunità dei credenti cattolici, pronti anche loro a difendere la chiesa così come gli islamici han dimostrato di difendere la loro fede. Si profila dunque l’annuncio di una simpatica nuova crociata che, date le premesse, sarà la fine della vita sulla terra nel nome di una entità (dio) che non ha ancora manifestato la sua esistenza. Non era meglio morire nel nome di qualcosa di più sostanzioso? Pubblicità
Qui e ora, in attesa di sviluppi io, modestamente donna, madre e attivista nonviolenza e femminista, trovo che la frase così lungimirante mi scaraventi in un angolo per tre volte: come attivista, come donna e come madre.
I pugni non sono simboli, sono carne e ossa contro altra carne e ossa, chi ne ha fatto esperienza lo sa, e con buona pace dell’epos letterario che racconta di amicizie virili cementate dai cazzotti essi restano un gesto d’aggressione e di violenza, che raramente non ha conseguenze.
Nelle scuole in cui vado a fare formazione sulla violenza di genere affronto ogni volta la semplificazione da parte dei ragazzi e delle ragazze verso lo schiaffo, la spinta, il pugno, gesti spesso vissuti come ‘inevitabili’, ‘naturali’, giustificati dalla gelosia e dalla necessità di far rispettare onore, gerarchia, proprietà: lei guardava un altro, lui guardava un’altra, lei è mia, lui è mio, che hai da guardare, che cosa hai detto di mia sorella, di mia madre, della mia ragazza?
Clima da rissa, da stadio, da caserma, (ma siamo a scuola) inarginabile facendo sottili distinguo: un pugno non è peggio di uno schiaffo, di una spinta.
Le mani o si alzano o si tengono abbassate: la bella campagna di Intervita lo dice con efficacia, ma evidentemente al Papa è sfuggita. Dietro e prima del pugno c’è la visione delle donne come esseri da difendere, ma solo se e quando sono in una relazione di proprietà: non è forse vero che tutte le donne sono puttane, tranne mia madre e mia sorella? Eccolo il desolante riassunto dell’ancestrale, brutale logica (e pratica) del patriarcato globale, che spesso risuona nei nostri cortili con i proclami pro famiglia della subcultura leghista e fascista (donne e buoi dei paesi tuoi, un orrore senza fine).
Sono atea, e credo con passione che alla violenza di qualunque tipo si debba opporre altro, diametralmente lontano da ogni eco di aggressione.
Non possiamo smantellare la casa del padrone con gli attrezzi del padrone, scrive Audre Lorde. O s’insegna in famiglia, scuola, chiesa e dopolavoro una cultura del rispetto, del ripudio della violenza (dalle parole ai gesti), o presto si arriva a superare quella soglia, quel limite, che trasforma il faticoso ma fecondo terreno del conflitto nella rapida e mortale guerra.
Guerra tra le persone, le comunità, i popoli, il mondo. E’ una certezza, oggi: dal pugno alla guerra santa il passo non è lungo.
I pugni, Francesco e tutti gli altri, imparate a tenerli in tasca.
-
> PICCHIARE LE DONNE. DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". ---- "WOMAN2DRIVE" - LA BATTAGLIA PER LA PARITA’ Settemila donne saudite al volante Successo della protesta. Finora nessuna è stata arrestata.17 giugno 2011, di Federico La Sala
 LA BATTAGLIA PER LA PARITA’
LA BATTAGLIA PER LA PARITA’ Settemila donne saudite al volante
Settemila donne saudite al volante
 Successo della protesta Woman2drive
Successo della protesta Woman2drive Velate alla guida di auto
per sfidare il divieto e lottare
Velate alla guida di auto
per sfidare il divieto e lottare
 per l’emancipazione in un Paese in cui è proibito anche il voto
per l’emancipazione in un Paese in cui è proibito anche il voto
 Finora nessuna è stata arrestata
Finora nessuna è stata arrestataROMA Iniziano a circolare in queste ore sul sito di micro-blogging Twitter le prime testimonianze di donne saudite che, sfidando il divieto di guida in vigore nel regno di Re Abdullah, oggi si sono messe al volante rispondendo all’appello rivolto da "Women2drive". Il gruppo ha lanciato nei giorni scorsi una mobilitazione attraverso i social network per spingere le donne della monarchia del Golfo a mettersi alla guida di un’auto, pratica vietata nel regno dove le donne non possono neppure votare o scegliere il marito. Secondo gli organizzatori, 7 mila donne avrebbero sfidato il divieto mettendosi oggi al volante.
Uno dei primi tweet "targati" Women2drive apparsi sul social network è stato scritto dall’utente "monaeltahawy". «Mona Eltahawy, prima! Siamo appena ritornati dal supermarket, ho deciso di iniziare la giornata guidando fino al negozio». Scrive un’altra utente: «Non ho visto altre donne al volante oggi, comunque io ho guidato per 15 minuti». Su Twitter si riferisce anche di decine di donne al volante sul lungomare di Damman, città dell’Arabia Saudita orientale.
L’iniziativa di oggi nasce anche come segno di solidarietà con l’attrice saudita Wajanat Rahabini, fermata sabato dalla polizia stradale di Gedda perchè guidava. E’ stata portata in commissariato e dopo alcune ore è stata rilasciata mentre la vettura si trova ancora sotto sequestro. L’attrice ha evitato il carcere sostenendo di essere stata costretta a mettersi alla guida a causa del ricovero del marito in ospedale e dell’assenza del suo autista personale.
In settemila, su Facebook, avevano preso l’impegno di partecipare alla protesta, che proseguirà - promette il comitato di "Women2drive" - fin quando le autorità saudite non estenderanno il diritto di guida alla popolazione femminile. Testimonianze e filmati di cittadine saudite che raccontano, con entusiasmo e determinazione, la loro esperienza alla guida stanno intasando i social network.
Al momento, secondo quando riferiscono le protagoniste della disobbedienza civile, la polizia ha chiuso uno o entrambi gli occhi sulle guidatrici, e non ci sono stati fermi. Una donna di Riad racconta su Twitter di aver superato due macchine della sicurezza, mentre accompagnava in auto i figli a scuola, e di non aver avuto alcun problema.
Un vademecum, diffuso nei giorni scorsi, invitava le donne ad usare l’auto solo per le proprie necessità quotidiane, in modo normale, senza strafare o partecipare a cortei. La protesta è dunque molto fluida, diluita. Impossibile da quantificare, così come da verificare, in un Paese immenso e di difficile lettura come è la penisola arabica. Tuttavia il senso di gioia e di liberazione è stato evidente sin dalle prime ore: a notte ancora fonda, 2Nassaf, questo il suo pseudonimo su Youtube, ha messo sul sito di condivisione un filmato che la ritrae coperta dal niqab (velo nero che lascia intravedere solo gli occhi) mentre guida per le strade semideserte di Riad. Safarzo, su Twitter, invita le compatriote ad evitare le provocazioni, mentre Hendny ricorda che la fede e la convinzione in una causa «possono smuovere le montagne».
Molti uomini, tra cui scrittori e intellettuali, si sono schierati al fianco della battaglia femminile. Altri però hanno organizzato siti e blog in cui invitano, in nome di un Islam ultraortodosso, a bloccare la protesta delle donne, anche ricorrendo alla violenza fisica. La battaglia, che per ora non sembra essere scoppiata per le strade, infuria quindi sui social network. Gli integralisti sembrano privilegiare twitter, dove non mettono i loro volti, ma si nascondono dietro l’icona a forma di uovo. Per questo sono stati chiamati per scherno dagli avversari i «saudieggs», le uova saudite.
* La Stampa, 17/06/2011
-
> PICCHIARE LE DONNE. --- ITALIA: CASO CERONI. Picchiare la moglie, secondo i nostri politici, si può. Nessuno, opposizione inclusa (di Beatrice Borromeo - Picchiare le donne? Non è poi così grave).28 aprile 2011, di Federico La Sala
Picchiare le donne? Non è poi così grave
Non solo Ceroni: 3 milioni di vittime subiscono e non denunciano
di Beatrice Borromeo (il Fatto, 27.04.2011)
Picchiare la moglie, secondo i nostri politici, si può. Nessuno, opposizione inclusa, ha avuto nulla da ridire sulla notizia data dal Fatto Quotidiano: l’onorevole Pdl Remigio Ceroni ha menato la consorte. Anche dopo la pubblicazione del referto medico del Pronto soccorso, che dimostra inequivocabilmente quanto accaduto, le scuse non arrivano: appare invece su Libero un’intervista al deputato Pdl in cui, poco elegantemente, Ceroni insinua che a pestare la compagna sia stato il padre (che non può replicare perché è deceduto). Il deputato, racconta, ha ricevuto tanta solidarietà, soprattutto dai colleghi di partito. E Ceroni conta anche sulla solidarietà della moglie: “Io non presenterò querela al Fatto, sarà lei ad agire nelle sedi opportune”. Ma una donna che prende le difese del marito non dimostra granché. Se i parlamentari studiassero i dati sulla violenza che si consuma tra le mura domestiche, quasi mai denunciata, forse sarebbero meno solidali con Ceroni e sentirebbero la necessità di fare (almeno) qualche dichiarazione.
IO NON PARLO. Nel mondo, oltre il 90 per cento delle violenze perpetrate su una donna dal suo partner non vengono denunciate. E, anche se in Italia mancano dati ufficiali, la tendenza a tacere sembrerebbe essere la stessa: lo confermano al Fatto sia il ministero delle Pari opportunità che le associazioni. Racconta Antonella Faieta, avvocato del Telefono Rosa: “Le donne che vengono da noi per essere aiutate lo fanno, in media, dopo oltre dieci anni di violenze subìte in silenzio”. E, per lo più, si recano nei centri di assistenza per informarsi: “Se mio marito mi prende a schiaffi dopo una lite, può considerarsi reato?”. In Italia oltre 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni ha subito, almeno una volta nella vita, un episodio di violenza fisica o sessuale.
I legali del Telefono Rosa spiegano che non passa giorno senza che si presentino ragazze con occhi neri e nasi rotti: “Non si tratta di persone deboli. É un fenomeno trasversale”. Perché il pensiero spesso corre ai piccoli paesi, dove l’emancipazione, se è arrivata, non ha attecchito. Invece, dati alla mano, le storie che leggiamo sui giornali potrebbero capitare al nostro vicino di casa: basti pensare che il 36 per cento delle vittime di stupri, che spesso accompagnano le botte, ha una laurea. Il 64 per cento vive al Centro-Nord, il 42 per cento abita in aree metropolitane. E, soprattutto, nel 70 per cento dei casi l’autore della violenza è il convivente: ci sono circa 3 milioni di donne, in Italia, che sono state picchiate dal marito o dal compagno. Però non parlano, e in alcuni casi la legge è dalla parte degli aggressori.
Prendiamo il caso (vero) di Maria, che arriva al pronto soccorso con il labbro rotto da un pugno e un ematoma sulla fronte. É la prima volta, racconta ai medici, che il marito la picchia. Però non vuole sporgere denuncia, perché con lui ha due figli, perché lui minaccia di portarglieli via e perché, ne è certa, non capiterà più. In questa situazione non si può fare nulla: il reato di lesioni si persegue solo se la vittima sporge querela. E se denuncia e poi ritira non c’è possibilità di punire il marito. Diverso è se i maltrattamenti sono continuati (in questi casi, come per lo stalking, la denuncia presentata non si può più ritirare): allora si può agire d’ufficio, il medico chiama la polizia e il giudice decide se allontanare il violento dalla famiglia. Oggi i divieti di avvicinamento in atto in Italia sono 2.629.
Ma quali garanzie ci sono che l’uomo non si vendichi sulla compagna che l’ha esposto? “L’allontanamento del violento - spiega l’avvocato Faieta - è una misura cautelare. Se lui torna, sta alla donna chiamare la polizia: anche per questo è nata la legge sullo stalking, così da mettere in carcere chi viola l’ordine restrittivo”.
BOTTE E STALKING. Quando una donna trova la forza di denunciare, capita spesso che subisca poi episodi di stalking (a proposito: su Ceroni il ministro Carfagna non ha nulla da dire?). Ogni mese, informa il ministero delle Pari opportunità, 547 persone vengono denunciate o arrestate per questo reato. L’85 per cento sono italiani e quasi il 90 per cento sono uomini. Le minacce e gli insulti, raccontano nei centri di assistenza, sono sempre uguali: “Ti spezzo le gambe, ti porto via i figli, non farai più niente senza di me, quando ti vedo ti uccido”. E di solito sortiscono effetti proprio perché arrivano dopo anni di violenze.
L’iter, spiega il Telefono Rosa, è questo: le botte cominciano da giovani, quando i due sono ancora fidanzati. Il periodo in cui l’uomo diventa più aggressivo è durante la gravidanza: la donna incinta è più vulnerabile, non vuole crescere un figlio da sola. Si abitua quindi più facilmente a essere picchiata, per motivi spesso futili: non ha apparecchiato la tavola, ha parlato troppo durante una cena, si è messa l’abito sbagliato. Seguono periodi di calma, ma la rabbia - dicono gli assistenti sociali - si manifesta di nuovo”.
La ribellione avviene, di solito, “quando vengono coinvolti nelle liti anche i figli che prendono le difese della madre”. Denunciare conviene. E non solo perché la violenza domestica è la prima causa di morte accidentale (nel 2009 la Banca mondiale ha anche dichiarato che “il rischio di subire violenze domestiche o stupri è maggiore del rischio di cancro o incidenti”). I tempi della giustizia, almeno per questi reati, si sono accorciati e la prima udienza viene solitamente fissata entro un anno. In quattro o cinque si può avere una sentenza di Cassazione. Nel frattempo la vittima viene assistita: il piano nazionale antiviolenza varato a gennaio ha stanziato 20 milioni di euro per aprire 80 nuovi centri distribuiti in tutta Italia.
-
> PICCHIARE LE DONNE. DIO, UOMINI E DONNE --- Il Corano che nessuno in Italia conosce (di Pietro Citati).18 ottobre 2010, di Federico La Sala
 Il libro sacro che inventa la parola di Dio
Il libro sacro che inventa la parola di Dio
 Il Corano che nessuno in Italia conosce
Il Corano che nessuno in Italia conosce Secondo la tradizione, la rivelazione avvenne nel corso di una sola notte, detta "la notte del destino" e poi comunicata in ventitré anni
Secondo la tradizione, la rivelazione avvenne nel corso di una sola notte, detta "la notte del destino" e poi comunicata in ventitré anni
 Esce una nuova traduzione con commento del testo che è alla base dell’Islam e che contiene il messaggio rivelato da Allah a Maometto. Molte le sorprese di questa edizione
Esce una nuova traduzione con commento del testo che è alla base dell’Islam e che contiene il messaggio rivelato da Allah a Maometto. Molte le sorprese di questa edizione
 Non obbedisce a una struttura logica, non segna un percorso continuo e rettilineo. È vagabondo, errabondo, labirintico. Procede ad onde
Non obbedisce a una struttura logica, non segna un percorso continuo e rettilineo. È vagabondo, errabondo, labirintico. Procede ad onde
 La scrittura è chiarissima e, stando al Profeta, essa porta alla luce ciò che stava celato nella Bibbia, nei Vangeli e nelle tradizioni apocrife
La scrittura è chiarissima e, stando al Profeta, essa porta alla luce ciò che stava celato nella Bibbia, nei Vangeli e nelle tradizioni apocrifedi Pietro Citati (la Repubblica, 18.10.2010)
Gli italiani non leggono Il Corano. Le traduzioni italiane sono poche e cattive: i commenti non sono migliori. La traduzione di Ida Zilio-Grandi, che esce in questi giorni, è bellissima (Il Corano, a cura di Alberto Ventura, Mondadori, collezione Islamica, pagg. LXXII-912, euro 20,00): dal principio alla fine mantiene il tono giusto, quella semplicità sublime, con cui Maometto ha evocato la voce di Dio. Tutto il libro è eccellente: l’introduzione di Alberto Ventura, di squisita intelligenza, e i commenti di Mohammad Ali Amir-Moezzi, Alberto Ventura, Mohyddin Yahia, Ida Zilio-Grandi sono ampli e scrupolosi. Tra i commentatori, due appartengono alla tradizione islamica, sebbene vivano ed insegnino a Parigi; e questo conferisce al loro testo una qualità di maggiore vicinanza al libro sacro, senza offendere mai il rispetto per la verità scientifica. A partire da ora, dunque, gli italiani potranno leggere Il Corano, abbandonandosi a quell’onda solenne e tumultuosa. Credo che le sorprese saranno moltissime.
Il Corano è un singolarissimo libro sacro. Discorre di sé, si interpreta, si analizza, si descrive, dubita di sé, si esalta, con una eloquenza che non viene mai meno. Parla delle proprie origini. Il Corano non è soltanto il volume che oggi teniamo nelle mani, e nemmeno le fibre e le foglie d’albero sulle quali Maometto e i suoi amici incisero la rivelazione, ma è innanzi tutto il proprio archetipo celeste. Prima che il tempo avesse inizio, Dio incise le proprie parole, in caratteri di luce, su una materia incorruttibile.
Questa tavola è custodita: cioè sta al riparo di ogni minaccia di alterazione; non muterà né si deformerà mai, immutabile come i veri libri. Mentre Il Corano stava lassù, fermissimo e invisibile, oltre il settimo cielo, cioè prossimo a Dio, cominciava la sua lenta ed incessante discesa, che da principio comprese la Torà e i Vangeli. La Torà e i Vangeli non sono Il Corano, ma lo contengono in potenza, e come in enigma. Il Corano comprende la Torà e i Vangeli, perché è il libro del ricordo: richiama innumerevoli luoghi della Bibbia ed esalta i profeti ebraici: ciò che là è racconto diventa qui predicazione divina; e viene interpretato, chiarito, confermato. «Il seme produce un germoglio che poi si rafforza, si irrobustisce e si alza saldo sul gambo».
Poi Il Corano si sposta verso il futuro e la fine. Comprende l’ultima ora, che verrà all’improvviso come nei Vangeli, e anzi è già avvenuta, nelle pagine di Maometto, dove echeggia il boato della tromba celeste, il cielo si spacca, rosso come cuoio lucidato, le stelle si offuscano, i monti sono rimossi, i mari ribollono, e le donne gravide abortiscono. Appaiono «i giardini alle cui ombre scorrono i fiumi», dove i fedeli resteranno in eterno: il Paradiso, che è il leitmotiv musicale del grande testo. Così Il Corano è sia il primo libro inciso nella luce prima dei tempi, sia l’ultimo libro, che noi leggiamo mentre crediamo di abitare nel presente. Niente, a rigore, potrebbe essere scritto dopo Il Corano: o infiniti commenti, chiose, analisi e interpretazioni, contenuti dentro Il Corano come il gheriglio dentro la noce. Questo archetipo celeste, questa "tavola custodita", Dio la fece discendere su Maometto: sebbene fosse un uomo, nient’altro che un uomo, capace di mancanze e di errori. Come disse Aisha, l’ultima delle sue mogli, «la natura di Maometto era intera Il Corano». Dio gli rivelò tutto il libro nel corso di un’unica notte, detta "la notte del destino". Poi, via via che gli anni passavano, ripeté la sua rivelazione nel tempo, sotto la forma di versetti comunicati - soffio dopo soffio, tocco dopo tocco - durante ventitré anni.
Se usiamo le parole dei moderni, Maometto compì un’impresa prodigiosa, alla quale si rifiutarono sempre gli ebrei e i cristiani. I Vangeli non sono la trascrizione diretta delle parole di Gesù: sono immensamente più discreti, perché si accontentano di raccogliere le tradizioni, che avevano trascritto e ricordato le sue parole. Maometto, invece, ha inventato la parola di Dio, senza alcun timore di compiere un atto empio. Ha trasformato la sua voce umana in una voce dettata dal cielo. Così ora sentiamo, attraverso di lui, la parola di Dio, letta, proclamata, predicata ad alta voce. La sentiamo mentre si rivolge in primo luogo a Maometto, il suo "servo", il suo intermediario, e poi a tutti gli uomini, fedeli o miscredenti. La sentiamo vicinissima, come risuonasse, accanto a noi, sulla terra, nel tempo presente. Ne sentiamo il suono, il ritmo, il timbro, il calore, il movimento. Questo è il primo, straordinario effetto del Corano: sopratutto su lettori non musulmani, o che non hanno sensibilità religiosa.
Il Corano non obbedisce mai ad una struttura logica: non segna un percorso continuo e rettilineo. Esso è vagabondo, errabondo, labirintico. Procede ad onde, a balzi: avanza, si ritrae, si sposta, si contraddice, ritorna, arretra, accumula; questa struttura così discontinua è il segno, forse, del suo carattere intenzionalmente sacro. Dio, dice stupendamente, Maometto, «scaglia la verità»: non vuole farla conoscere o spiegarla, ma la scaglia come si può scagliare un fulmine, o la erutta e la fa esplodere come un vulcano. Tutto vi è frattura, intermittenza, abisso, formula apocalittica. Oppure Dio segue il metodo opposto: si ripete e torna a ripetersi. Quante volte ci parla dei fiumi del Paradiso. Quante volte ci dice: «Egli è colui che mi ha creato e mi guida. Egli è colui che mi nutre e mi disseta e quando mi ammalo mi guarisce. Egli è colui che mi fa morire e poi mi risuscita».
Qualche volta, Il Corano è chiarissimo e - dice Maometto - porta alla luce ciò che stava celato nella Bibbia, nei Vangeli e nelle tradizioni apocrife. È facile e semplice. Qualche volta, al contrario, è oscuro e misterioso: Maometto parla dei «rotoli di pergamena che fate vedere e in gran parte tenete nascosti». In ogni caso, Il Corano rifiuta di spiegarsi. Quando Maometto veniva interrogato sul suo significato, rispondeva: «Dio ha detto qui ciò che ha voluto dire». Con qualche eccezione, il tono è sempre lo stesso: anche dove parla di questioni giuridiche o di eventi politici, Il Corano raggiunge un tono sublime che lo Pseudo-Longino avrebbe ammirato: «la sublime lingua di verità». Questa lingua ha un effetto fisico-ipnotico fortissimo: tanto che, come dice un passo, la pelle di chi lo ascolta «si raggrinza e poi si raddolcisce».
Il Corano che noi leggiamo e sopratutto ascoltiamo, non è il vero Corano: quello che, alle origini del mondo, è stato scritto sulla tavola custodita. La parola di Dio, che è divenuta "linguaggio e suoni articolati", è stata avvolta da un tenuissimo e oscurissimo velo. Per scoprire "lo spirito e il significato profondo", che anima quei suoni e quei segni, dobbiamo risalire al mondo celeste, verso la tavola custodita. Questa operazione è insieme necessaria e impossibile: può compierla solo Dio, perché Lui solo sa cogliere nella sua essenza la "parola puramente interiore" che costituisce il cuore del libro. Così ogni lettura, che facciamo del Corano, anche quest’ultima che compiamo aiutati da una buonissima traduzione e da un buonissimo commentario, è un fallimento. Il Corano resta incomprensibile all’occhio e all’orecchio umani.
Questo libro incomprensibile ruota attorno a un Dio egualmente incomprensibile. Dio è unico: "è colui che basta a sé stesso"; non ha eguali, né secondi, né compagni, né figli, né associati, né ministri. Non ha alcun bisogno degli uomini, delle loro opere, delle loro preghiere, e del mondo di animali e piante che ha foggiato. «Se non li avessi creati - Egli disse - non ne avrei alcun danno: ora che li ho creati, se non faranno quello che ho prescritto loro, e se non eseguono i miei ordini, non me ne viene alcun detrimento e, se obbediscono ai miei ordini, non me ne viene alcuna utilità». «Se volessi - Egli insiste - vi farei sparire, e vi sostituirei con chi voglio». Ciò che è tipico del mondo islamico è appunto questa ebbrezza, questa vertigine di unità, dalle quali sono nate meravigliose pagine teologiche e mistiche. Col suo concetto di Trinità alla quale si è aggiunta la divinità di Maria, il Cristianesimo è infinitamente più complicato. Anche il Divino e l’Uno, per noi, sono molteplici.
Siccome è unico, Dio è onnipresente, onnisciente, onnipossente. Comprende in sé tutte le opposizioni e le antitesi: il giorno e la notte, il morto e il vivo, il bene e il male. Quindi sa tutto per natura e per esperienza. «Egli conosce quel che è sulla terra e quel che è nel mare, non cade foglia senza che egli non voglia, e non c’è granello nelle tenebre della terra, nulla di umido o di secco che non si è registrato in un libro». Non c’è segreto che egli non conosca: quelli delle coscienze, del passato, dell’avvenire e dell’invisibile. Nulla, mai, gli è nascosto. Sebbene il suo linguaggio preferisca l’immenso, ha uno sguardo microscopico e molecolare: non gli sfugge il peso di una formica, né quello di un granello di polvere, o di un granello di senape, o di una tarma, o la pellicina del nocciolo di un dattero, perché nel minimo si cela il mistero. In qualsiasi momento del tempo, Egli ci spia: non è mai assente; non si distrae dall’osservare; e in qualunque situazione ci troviamo, Egli assiste a ciò che facciamo, diciamo e pensiamo. Se è dappertutto, vive anche nei corpi: a tratti è visibilmente antropomorfo; e noi abbiamo violenti rapporti fisici con lui, perché dobbiamo afferrarci tutti alle sue funi. Dunque Dio abita anche il male: ciò che fa Iblis, l’angelo della Tenebra, esce dalle sue mani.
Quando foggia la terra, la fantasia di Dio è immensamente creativa e feconda. È la Provvidenza. Rende stabili le terre, dispone i fiumi per irrigarle, dà loro cime montagnose, divide i mari con una barriera, manda i venti a portare le voci, fa discendere la pioggia per gli uomini, gli armenti, il frumento, l’ulivo, le palme, le viti, i melograni. Tutto è fresco, fertile e luminoso, come nei primi capitoli della Genesi. Se vuole creare una cosa, Dio pronuncia lo stesso Fiat della Bibbia. Oltre alla terra, crea altri mondi e altre città, che stanno ai piedi della smeraldina montagna di Qaf. Crea quelle cose trasparenti e stranissime che sono le ombre. E, se nella Bibbia, la creazione prende una fine, qui è continua: Dio può prolungarla e rinnovarla e moltiplicarla, perché - per Lui - nulla è difficile e definitivo.
Tutto ciò che noi vediamo è una immagine di Dio. La sterminata regione dei corpi, gli alberi, gli uomini, le luci, le ombre sono sembianze del suo unico volto. Dio è il chiostro dove si rifugia il monaco cristiano, il tempio dove vengono venerati gli idoli, il prato dove brucano le gazzelle, la Ka’ba dove si prostra il pellegrino, le Tavole dove è stata scritta la legge mosaica, Il Corano ispirato a Maometto. Ma il Dio islamico non si è incarnato come Gesù. Egli è soltanto entrato nelle forme create, come l’immagine entra e si riflette dentro lo specchio. Chi contempla le cose, non contempla la luce divina: la scorge deformata e trasformata, come la luce che penetra in un filtro di vetro colorato viene tinta dal giallo e dal rosso. Il nostro mondo è l’ombra rispetto alla persona, la figura specchiata rispetto all’immagine, il frutto rispetto all’albero. Così il credente, che si slancia verso le forme create per conoscere Dio, incontra la delusione: giacché il mondo è un velo che ci nasconde il suo volto. Non sappiamo se ce lo nasconde perché è un velo troppo spesso: o perché la manifestazione di Dio è così intensa, la rivelazione così luminosa da accecare i nostri occhi. Sebbene Dio si manifesti in tutte le cose, Egli è nascosto ed assente e noi seguiamo invano la sua rivelazione.
Il Corano comincia: «Nel nome di Dio, il Clemente». Clemente non è un aggettivo, un attributo del nome di Dio, ma un suo sinonimo. Dio e Clemente significano esattamente la stessa cosa. Così, se sfogliamo Il Corano, lo scorgiamo donare, senza badare a meriti umani (che non esistono), o a una qualsivoglia giustizia, ma obbedendo soltanto alla propria volontà e al proprio capriccio. Come sappiamo, Egli è l’Unico, che contiene in sé tutte le qualità; e quindi non dobbiamo meravigliarci se, sia pure in modo indiretto, egli compia il Male. Induce i miscredenti a farlo: "Dio ha sigillato loro il cuore e l’udito, e sui loro occhi c’è un velo", che li rende ciechi. Se qualcuno possiede "una malattia del cuore", Dio non la cura e non la mitiga, ma la accresce. Qualche volta travia, induce in errore, insidia, tende tranelli, trama inganni: come Zeus, il grande ingannatore della religione greca.
Travolto da questa forza divina troppo grande, l’uomo si copre di peccati, di cui è innocente. Eppure, egli ne è colpevole. Dio vuole appunto questo: un mondo tessuto di peccati e di peccatori, che gli permetta l’atto divino del Perdono. Ibrahim, un asceta, girava attorno alla Ka’ba: presso la porta del santuario si fermò e disse: «Mio Signore, preservami dal peccato, affinché io non mi ribelli al tuo desiderio». Una voce che proveniva dal cuore della Ka’ba gli sussurrò: «O Ibrahim, mi chiedi di preservarti dal peccato. Tutti i miei servitori mi chiedono questo. Ma, se ti preservassi dal peccato, voi sareste privati della mia misericordia. Se tutti gli uomini fossero innocenti, a chi accorderei la mia grazia?».
-
> PICCHIARE LE DONNE. DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". ---- I fondamentalisti hanno un vero problema con la donna e la sua sessualità. Vale per l’ebraismo, per il cristianesimo come per l’islam (di TAHAR BEN JELLOUN - Le donne cancellate).10 aprile 2009, di Federico La Sala
Le donne cancellate
di TAHAR BEN JELLOUN *
Ah, se si potessero soddisfare i complessi e perversi desideri dei fanatici del mondo! Questi vogliono prendere le donne contro la loro volontà.
Quelli vietano contraccezione e preservativi. Tutti sono ossessionati dalla femminilità.
Se nel mondo le donne lottano per la loro dignità e per migliorare le loro condizioni di vita, ci sono Stati come l’Afghanistan che vanno in soccorso degli uomini proponendo una legge che obblighi la donna a soddisfare il desiderio del marito anche se è un eiaculatore precoce o ha l’alito cattivo o più semplicemente se non stimola in alcun modo la sua libido. Contro il rifiuto, la violenza.
I fondamentalisti hanno un vero problema con la donna e la sua sessualità. Vale per l’ebraismo, per il cristianesimo come per l’islam: l’integralismo trema davanti al corpo femminile, ha paura del suo sesso e reagisce con la violenza alla frustrazione o al turbamento. Tutto ruota lì attorno. Non si capisce nulla delle motivazioni degli integralisti se non si considera questa dimensione essenziale della loro psicologia e della loro esistenza.
Ciò si traduce nell’imposizione del velo, del burqa o della djellabah. La donna deve essere celata, invisibile, deve essere allontanata dagli sguardi e dalla vita. L’uomo dice: «Non toccare mia moglie, mia figlia, mia sorella, mia madre». Ovvero, detto altrimenti «Questi corpi mi appartengono e nessuno ha il diritto di avvicinarsi!». Bisogna veramente avere un cattivo rapporto con se stessi per appropriarsi il corpo degli altri. E per giustificare questa mentalità si ricorre alla religione che di per sé non dà affatto un simile diritto. Anche se tutte le religioni in genere non sono molto giuste nei confronti delle donne.
I taleban, ad esempio, immaginano un mondo dove la donna è assente. Esiste, ma è segregata in casa e non ha il diritto di uscirne. Questo non vuol dire che disprezzino il piacere sessuale, anzi, lo amano a tal punto da voler essere certi di essere i soli a gioirne. È il senso del progetto di legge presentato dal presidente Hamid Karzai. Un progetto che voleva rendere legale lo stupro compiuto sulla propria moglie e vietarle di uscire di casa senza l’autorizzazione del marito. Questo provvedimento avrebbe riguardato le donne sciite, che rappresentano il 10% della popolazione. Karzai contava su questo disegno di legge per attirarsi le simpatie e i voti degli sciiti alle prossime elezioni. Dopo le proteste di molti Stati, Karzai ha finito col ritirare il progetto, ma gli uomini continueranno a comportarsi da bruti con le donne, con o senza legge.
In ogni caso, questa ipotesi legislativa, degna dell’epoca della jahilya (il periodo preislamico quando alcuni beduini seppellivano vive le loro figlie per evitare che il loro onore un giorno potesse essere macchiato) è stupida e grottesca. Che va a fare la legge nella camera da letto di una coppia? Cosa può aggiungere all’intimità tra un uomo e una donna? Che piacere ne ricaverà l’uomo che si sentirà forte grazie a questa legge?
Un piacere dettato dalla norma e una violenza legittimata da un diritto che ha un senso dell’equità e della realtà ben singolare. In Afghanistan ci sono donne che si battono, che si organizzano e sono aiutate dalle femministe di diversi Paesi. Ma che un uomo come Hamid Karzai abbia potuto mettere la propria firma su questo progetto di legge la dice lunga sulla fame di potere, sull’ambizione divorante che lo possiede. Con che faccia può presentarsi agli occidentali che frequenta avendo aperto la porta allo stupro legale nel matrimonio? Vorrebbe forse che i taleban lo considerassero vicino a loro? Ma i taleban vogliono di più. Non si accontentano di una legge sulla pratica sessuale. Vorrebbero spadroneggiare su tutta la società e introdurvi una barbarie che va al di là dell’immaginabile. Dunque Karzai ha fatto un passo falso e ha sbagliato i suoi calcoli. E quindi ha fatto marcia indietro. Per ora, almeno.
Una donna che prova piacere è una «porca», è pari a una prostituta (tranne il fatto che le poverette che fanno sesso per mestiere non ne godono affatto, è un lavoro, una fatica necessaria per guadagnarsi da vivere). Sarebbe interessante far leggere agli uomini che parlano di questo godimento qualcuna tra le testimonianze di queste donne che raccontano la loro vita sessuale. Ma non arriveremo a tanto.
L’importante è far sentire la propria voce contro questa iniziativa afghana che non farebbe altro se non aggravare la situazione nel Paese e potrebbe favorire il ritorno sulla scena politica dei taleban. Perché quel che è in gioco in questa regione martoriata da troppe guerre è una scelta di società e anche di epoca.
Sfortunatamente io sono pessimista: gli eserciti occidentali non riusciranno a eliminare il pericolo talebano. Il terreno è difficile, i metodi asimmetrici e la popolazione divisa. Solo gli afghani medesimi potranno farla finita con i taleban. Ma fino a che questa guerra è legata al traffico di oppio, fino a che il guadagno facile è a portata di mano, la lotta sarà dura e impari.
Nel film dell’afghano Siddiq Barmak Opium War (2008) si vede una lunga fila di donne coperte dal burqa avanzare all’orizzonte dirette verso un campo di papaveri da oppio. Quando arrivano al campo sollevano il velo e si scopre che sono taleban armati venuti a prendere la loro parte sull’incasso della vendita di droga. I contadini pagano per non essere uccisi. Questa immagine riassume la situazione: la guerra in Afghanistan ruota attorno all’oppio e alle donne. Bisogna controllarli entrambi, pena la fine di una tragedia innescata dalla barbarie nel nome di un islam totalmente estraneo a queste pratiche.
© Le Monde
* La Stampa, 10.04.2009
-
> PICCHIARE LE DONNE. DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. ---- Forum cattolico-musulmano - testo della dichiarazione comune firmata a conclusione dell’incontro7 novembre 2008, di Federico La Sala
Firmata al termine dell’incontro
La dichiarazione conclusiva del primo seminario del forum cattolico-musulmano
Pubblichiamo in una nostra traduzione italiana il testo della dichiarazione comune firmata a conclusione dell’incontro del forum cattolico-musulmano. *
Il forum cattolico-musulmano è stato creato dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e da una Delegazione dei 138 firmatari musulmani della Lettera aperta intitolata Una Parola Comune, alla luce di tale documento e della risposta di Sua Santità Benedetto XVI tramite il suo segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone.
Il suo primo seminario si è svolto a Roma dal 4 al 6 novembre 2008. Sono intervenuti 24 partecipanti e cinque consiglieri di ciascuna delle due religioni. Il tema del seminario è stato "Amore di Dio, amore del prossimo". Il dibattito, condotto in un caldo spirito conviviale, si è concentrato su due grandi temi: "fondamenti teologici e spirituali", "dignità umana e rispetto reciproco".
Sono emersi punti di similitudine e di diversità che riflettono lo specifico genio distintivo delle due religioni.
1. Per i cristiani la fonte e l’esempio dell’amore di Dio e del prossimo è l’amore di Dio per suo Padre, per l’umanità e per ogni persona. "Dio è amore" (1 Giovanni, 4, 16) e "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna" (Giovanni, 3, 16). L’amore di Dio è posto nel cuore dell’uomo per mezzo dello Spirito Santo. È Dio che per primo ci ama permettendoci in tal modo di amarlo a nostra volta. L’amore non danneggia il prossimo nostro, piuttosto cerca di fare all’altro ciò che vorremmo fosse fatto a noi (cfr. 1 Corinzi, 13, 4-17). L’amore è il fondamento e la somma di tutti i comandamenti (cfr. Galati, 5, 14). L’amore del prossimo non si può separare dall’amore di Dio, perché è un’espressione del nostro amore verso Dio. Questo è il nuovo comandamento "che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati" (Giovanni, 15, 12). Radicato nell’amore sacrificale di Cristo, l’amore cristiano perdona e non esclude alcuno. Quindi include anche i propri nemici. Non dovrebbero essere solo parole, ma fatti (cfr. 1 Giovanni, 4, 18). Questo è il segno della sua autenticità.
Per i musulmani, come esposto nella lettera Una Parola Comune, l’amore è una forza trascendente e imperitura, che guida e trasforma il rispetto umano reciproco. Questo amore, come indicato dal Santo e amato profeta Maometto, precede l’amore umano per il Dio uno e trino. Un hadit mostra che la compassione amorevole di Dio per l’umanità è persino più grande di quella di una madre per il proprio figlio (Muslim, Bab al-Tawba: 21). Quindi esiste prima e indipendentemente dalla risposta umana dell’unico che è "amorevole". Questo amore e questa compassione sono così immensi che Dio è intervenuto per guidare e salvare l’umanità in modo perfetto, molte volte e in molti luoghi, inviando profeti e scritture. L’ultimo di questi libri, il Corano, ritrae un mondo di segni, un cosmo meraviglioso di maestria divina, che suscita il nostro amore e la nostra devozione assoluti affinché "coloro che credono hanno per Allah un amore ben più grande" (2: 165) e "in verità il Compassionevole concederà il suo amore a coloro che credono e compiono il bene" (19: 96). In un hadit leggiamo che "Nessuno di voi ha fede finquando non ama il suo prossimo come ama se stesso" (Bukhari, Bab al-Iman: 13).
2. La vita umana è un dono preziosissimo di Dio a ogni persona, dovrebbe essere quindi preservata e onorata in tutte le sue fasi.
3. La dignità umana deriva dal fatto che ogni persona è creata da un Dio amorevole per amore, le sono stati offerti i doni della ragione e del libero arbitrio e, quindi, le è stato permesso di amare Dio e gli altri. Sulla solida base di questi principi la persona esige il rispetto della sua dignità originaria e della sua vocazione umana. Quindi ha diritto al pieno riconoscimento della propria identità e della propria libertà di individuo, comunità e governo, con il sostegno della legislazione civile che garantisce pari diritti e piena cittadinanza.
4. Affermiamo che la creazione dell’umanità da parte di Dio presenta due grandi aspetti: la persona umana maschio e femmina e ci impegniamo insieme a garantire che la dignità e il rispetto umani vengano estesi sia agli uomini sia alle donne su una base paritaria.
5. L’amore autentico del prossimo implica il rispetto della persona e delle sue scelte in questioni di coscienza e di religione. Esso include il diritto di individui e comunità a praticare la propria religione in privato e in pubblico.
6. Le minoranze religiose hanno il diritto di essere rispettate nelle proprie convinzioni e pratiche religiose. Hanno anche diritto ai propri luoghi di culto e le loro figure e i loro simboli fondanti che considerano sacri non dovrebbero subire alcuna forma di scherno o di irrisione.
7. In quanto credenti cattolici e musulmani siamo consapevoli degli inviti e dell’imperativo a testimoniare la dimensione trascendente della vita attraverso una spiritualità alimentata dalla preghiera, in un mondo che sta diventando sempre più secolarizzato e materialistico.
8. Affermiamo che nessuna religione né i suoi seguaci dovrebbero essere esclusi dalla società. Ognuno dovrebbe poter rendere il suo contributo indispensabile al bene della società, in particolare nel servizio ai più bisognosi.
9. Riconosciamo che la creazione di Dio nella sua pluralità di culture, civiltà, lingue e popoli è una fonte di ricchezza e quindi non dovrebbe mai divenire causa di tensione e di conflitto.
10. Siamo convinti del fatto che cattolici e musulmani hanno il dovere di offrire ai propri fedeli una sana educazione nei valori morali, religiosi, civili e umani e di promuovere una attenta informazione sulla religione dell’altro.
11. Professiamo che cattolici e musulmani sono chiamati a essere strumenti di amore e di armonia tra i credenti e per tutta l’umanità, rinunciando a qualsiasi oppressione, violenza aggressiva e atti terroristici, in particolare quelli perpetrati in nome della religione, e a sostenere il principio di giustizia per tutti.
12. Esortiamo i credenti a operare per un sistema finanziario etico in cui i meccanismi normativi prendano in considerazione la situazione dei poveri e degli svantaggiati, siano essi individui o nazioni indebitate. Esortiamo i privilegiati del mondo a considerare la piaga di quanti sono colpiti più gravemente dall’attuale crisi nella produzione e nella distribuzione alimentare, e chiediamo ai credenti di tutte le denominazioni e a tutte le persone di buona volontà di cooperare per alleviare la sofferenza di chi ha fame e di eliminare le cause di quest’ultima.
13. I giovani sono il futuro delle comunità religiose e delle società in generale. Vivranno sempre di più in società multiculturali e multireligiose. È essenziale che siano ben formati nelle proprie tradizioni religiose e ben informati sulle altre culture e religioni.
14. Abbiamo concordato di prendere in considerazione la possibilità di creare un Comitato cattolico-musulmano permanente, che coordini le risposte ai conflitti e ad altre situazioni di emergenza, e di organizzare un secondo seminario in un Paese a maggioranza musulmana ancora da definire.
15. Attendiamo dunque il secondo seminario del Forum cattolico-musulmano che si svolgerà entro due anni, in un Paese a maggioranza musulmana ancora da definire.
Tutti i partecipanti sono stati grati a Dio per il dono di questo tempo trascorso insieme e per questo scambio proficuo. Alla fine del seminario, Sua Santità Papa Benedetto XVI e, dopo gli interventi del professor Seyyed Hossein Nasr e del Grand Mufti Mustafa Ceric, ha parlato al gruppo. Tutti i presenti hanno espresso soddisfazione per i risultati del seminario e la loro aspettativa di un dialogo più proficuo.
*
-
> PICCHIARE LE DONNE. DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. --- Nel mondo islamico cade un baluardo maschile: le fatwa che riguardano le questioni femminili potranno essere emesse dalle donne. L’apertura, destinata a suscitare non poche contestazioni, arriva dalla massima autorità religiosa della Siria: il Gran Mufti Sheikh Ahmed Badriddin Hassun15 giugno 2008, di Federico La Sala
L’editto religioso per voce di donna, la rivoluzione dell’islam
di ConboniFem
Nel mondo islamico cade un baluardo maschile: le fatwa che riguardano le questioni femminili potranno essere emesse dalle donne. L’apertura, destinata a suscitare non poche contestazioni, arriva dalla massima autorità religiosa della Siria: il Gran Mufti Sheikh Ahmed Badriddin Hassun
 Riprendiamo questo articolo dal sito
Riprendiamo questo articolo dal sito
 http://www.combonifem.it/articolo.aspx?a=480&t=N *
http://www.combonifem.it/articolo.aspx?a=480&t=N *12.06.2008:
La voce dalla quale arriva il lasciapassare al mondo femminile islamico è influente: si tratta della massima autorità religiosa della Siria, il Gran Mufti Sheikh Ahmed Badriddin Hassun. La decisione storica, destinata di certo a far discutere, riguarda una vera e propria rivoluzione nel mondo religioso: anche le donne potranno svolgere una funzione di guida nell’islam ed emettere editti religiosi ufficiali.
Il proclama è arrivato direttamente dai canali della tivù satellitare Al Arabiya. Il Gran Mufti ha scelto un mass media di grande impatto per segnare questo passaggio importante non solo in campo religioso ma anche sociale. Il privilegio di emettere la fatwa (secondo il diritto islamico è una sorta di sentenza emessa, solitamente, da un esperto religioso e generalmente vincolante per l’individuo e per tutti) finora era una prerogativa riservata ai soli imam maschi. Ma il Gran Mufti non ha dubbi: «Il Profeta stesso ha permesso ad alcune madri e discepole di recitare lezioni di fede di fronte a migliaia di uomini», per questo sovrintenderà personalmente a questo importante progetto che porterà alcune donne a diventare membri effettivi del Consiglio della fatwa.
Rimane però una cosa da dire: gli editti religiosi emessi dalle donne riguarderanno solo questioni femminili. E se gli uomini storcono il naso, temendo che questa “concessione” faccia perdere loro potere sul mondo femminile, le donne accolgono l’editto con entusiasmo. La predicatrice Huda Habash, che insegna il Corano alle 5mila studentesse della moschea di Al Zahra a Damasco, ha commentato: «Benvenuto questo editto, finalmente toglierà dall’imbarazzo le donne nell’andare a chiedere lumi sulle loro vicende a imam maschi».
-
> PICCHIARE LE DONNE. DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO.8 agosto 2007, di Federico La Sala
Marziani, state a casa
di Maria G. Di Rienzo *
Tanti anni fa (io ero una bimba, per cui sono proprio tanti), fu inviata nello spazio una sonda, chiamata Pioneer 13 se non ricordo male, destinata a perdersi oltre i confini della nostra galassia. Recentemente ho letto che il suo viaggio procede senza intoppi, in cieli distanti, fra stelle sconosciute. Questa sonda reca un messaggio inciso su una lastra di metallo, le figure di un uomo e di una donna ed alcuni simboli: il suo scopo è indicare alle eventuali forme di vita che lo ricevessero che l’umanità è pacifica e pronta ad accoglierle. Io non posso lanciare questo articolo dietro alla Pioneer per avvisare che si tratta di un’enorme menzogna, ma so che devo scriverlo e sperare nel miracolo: alieni, chiunque voi siate, non credeteci e restate sui vostri pianeti. Pacifici? Una cinquantina di guerre insanguina la culla dell’umanità, giorno dopo giorno, anno dopo anno, milioni di morti, milioni di mutilati. Accoglienti? Abbiamo confini sempre più militarizzati che “difendono” aree sempre più piccole, di territorio o di idee. Non accogliamo neppure i nostri fratelli e sorelle di specie quando fuggono da povertà, conflitti armati e disastri ambientali, chi vogliamo prendere in giro? Amici di altre galassie, portate pazienza e ascoltatemi. Ho scelto un paese a caso, sul Pianeta Azzurro, per spiegarvi a cosa andreste incontro venendo qui. Non è interessato da guerre, al momento, per lo meno sul territorio nazionale, ma questo non lo rende meno pericoloso. Ecco perché non è bene metterci piede:
1. Le bambine, di qualunque gruppo sociale, religione o provenienza geografica, in questo paese della Terra non sono al sicuro. Figuriamoci se lo sarebbero bambine verdi con le antenne, originarie di Proxima Centauri.
Bambine di undici anni vengono violentate dal vicino di casa-affettuoso baby sitter (21 aprile 2007) Gli abusi, secondo la ricostruzione degli investigatori, andavano avanti da oltre due anni e sono continuati fino a quando un’amichetta delle due undicenni, che si trovava in casa con il vicino insieme a loro, si è accorta dei comportamenti strani dell’uomo. Così la piccola ha convinto le due amiche a raccontare tutto ai genitori e lei stessa ha riferito quello che aveva visto a sua madre. Le mamme hanno poi accompagnato le figlie all’ospedale dove nel corso di una visita sono state riscontrate le violenze subite.
Se appena ne compi dodici, di anni, ci pensano i tuoi parenti a prostituirti (sempre 21 aprile). Dopo un paio d’anni si scopre che è tua madre a venderti: il costo delle prestazioni variava dai quindici ai trenta euro e i video degli incontri venivano conservati dai “clienti” sui cellulari, per fare pressione sulla ragazzina. Se quest’ultima opponeva resistenza, veniva ricattata con i filmati che mostravano i precedenti incontri sessuali, “Ti sei andata a coricare” si sente in una delle intercettazioni telefoniche, “e mi hai chiuso il telefono. Guarda che ti ricatto, ho le cose per ricattarti.” In un’altra telefonata, uno degli uomini chiede alla ragazza se le si erano rimarginate le ferite provocate da un loro rapporto sessuale.
Oppure trovi qualche brav’uomo, sposato con tutti i crismi e padre di due bambini, che dopo essersi portato a letto una dodicenne testimonia giulivo davanti al giudice: “Scherzavamo. C’è stato solo qualche scambio di affettuosità.” (24 luglio 2007) E se soffri il peso di una disabilità (in questo caso specifico motoria, e grave), non pensare che il violentatore di turno si farà scrupoli, anzi, l’età si abbassa pure. Otto anni ha la bambina disabile costretta a prestazioni sessuali per un parente stretto, che le ha pure riprese con il videocellulare e passate agli amici. (2 giugno 2007)
2. Le donne, sempre con la stessa puntigliosa trasversalità, sono trattate come pezzi di carne sul bancone di un macellaio.
Durante una lite, un uomo di 35 anni inizia a picchiare la sua compagna, 30enne, incinta di quattro mesi, con calci e pugni. Fino a procurarle un aborto. Poi ha prelevato il feto, e lo ha seppellito nella campagna vicina. La donna ha chiamato un’ambulanza per chiedere soccorso e, in un primo momento, ha raccontato ai medici solo dell’aggressione, senza menzionare l’aborto che tuttavia è stato diagnosticato dai sanitari. Solo allora la donna ha riferito tutti i particolari dell’accaduto. Rintracciato l’aggressore, che si era nascosto in un casolare isolato, si è potuto recuperare il corpicino da una fossa. (8 luglio 2007)
Ma non importa che tu riesca a metterli al mondo, i tuoi e suoi bambini. Ne puoi partorire persino quattro, e se lui pensa che tu lo tradisca ti sgozzerà davanti a loro. La donna di cui parlo è morta in questo modo orribile, a 48 anni, per: “Un storia inesistente”, dicono gli investigatori, “forse resa reale per l’uxoricida dal suo stato depressivo.” L’uomo ha poi tentato il suicidio ferendosi all’addome con lo stesso coltello, una lesione giudicata dall’ospedale guaribile in pochi giorni. Il maggiore dei figli, che ha dato l’allarme ed è fuggito da casa con gli altri fratelli, ha 16 anni. (26 luglio 2007)
E sappiate anche che il denunciare le violenze da parte delle donne è inaccettabile ed è immediatamente punito con violenze ulteriori. Un pensionato viene arrestato per reiterate violenze sessuali ai danni di un quattordicenne. Dopo un periodo di detenzione, ottiene gli arresti domiciliari per motivi di salute. Cerca di far ritrattare le proprie dichiarazioni ad una testimone dell’accusa, ma costei si rifiuta: l’uomo la picchia e la stupra. (6 luglio 2007) Non va meglio se la protesta contro la violenza è collettiva, pubblica e organizzata, ne’ importa che il motivo per cui si protesta sia l’omicidio insensato di una giovane (questioni di “onore”): la ritorsione è solo differita, per motivi di opportunità. Si aspetta che una delle organizzatrici si trovi da sola, e la si insulta e minaccia di morte. Le prime parole che gli aggressori dicono rivelano tutto: “Devi smettere di parlare...” (29 giugno 2007)
3. In questa specifica nazione del pianeta Terra si sta allevando una generazione di giovanissimi spacciando loro per valori la sopraffazione, l’arroganza e la “legge della giungla”.
Due studenti quindicenni portano di forza un loro coetaneo nei bagni della scuola: qui il ragazzino viene violentato da uno dei compagni mentre l’altro riprende la scena con il telefonino. La vittima, che ha un piccolo deficit di apprendimento ed è seguito da un insegnante di sostegno, ha poi raccontato tutto, settimane dopo, alla madre, quando un familiare aveva avuto la notizia dell’esistenza di quelle immagini. (26 maggio 2007)
Molti episodi, che siano meno cruenti o analoghi, non raggiungono la stampa, ma la loro crescita è ampiamente testimoniata. Il bullismo comincia ad uccidere anche in questo paese (almeno una vittima si è data la morte per sfuggirvi, quest’anno), e in più abbiamo spacciatori dodicenni di droghe leggere provenienti da rinomate e benestanti famiglie, e bambine di dieci anni che “tirano” coca perché fa dimagrire. Per non parlare dei filmati “shock” che vengono allegramente messi in internet e dove si può ammirare la cricca dei bulli minorenni che tormenta la vittima di turno.
4. La sanità mentale, in questo paese, è uno stato ampiamente minoritario. Soprattutto fra chi ha potere decisionale o autorità di qualche tipo.
Prendete i sindaci. Uno si sveglia la mattina e decide che i bambini “nazionali” hanno più diritti dei bambini immigrati. Nelle graduatorie per gli asili nido comunali, passeranno avanti grazie alla cittadinanza di mamma e papà. E badate bene: “Qualora gli istituti non volessero accogliere la richiesta, il sindaco è pronto a intervenire con un’ordinanza.” Chi viene da “fuori” è un problema, tuona il primo cittadino, e perciò ha in progetto di realizzare un sistema di monitoraggio tramite telecamere piazzate su tutto il territorio comunale: scuole, parchi, piazze, periferie, frazioni... Il Grande Fratello in perpetuo, ventiquattrore su ventiquattro, è semplicemente geniale, no? (27 luglio 2007)
Un altro sindaco si trova con un caso di stupro sul proprio territorio, otto minorenni che violentano una coetanea e cosa fa? Tira fuori dal bilancio comunale le spese legali per gli accusati, forse ignorando che la difesa legale è garantita d’ufficio anche agli indigenti (ma i fanciulli non sarebbero indigenti, pare che abbiano parenti in giunta, invece). Di fronte alle reazioni provenienti da membri autorevoli del suo partito, gli dà dei “talebani.”, ricorda che sono loro ad aver bisogno di lui e non viceversa, e si organizza una micro manifestazione di sostenitrici per far vedere a tutto il mondo che le donne non sono schifate e offese dal suo comportamento, anzi. (18 luglio 2007) Cos’abbiamo, ancora? Parlamentari tristi e stanchi, consumati dalla lotta alla droga, dalla tolleranza zero e dal “family day” che sono costretti, causa lontananza dall’amata moglie, a festini a base di cocaina e prostitute. Sacerdoti con una fedina penale notevolmente sporca che, nei guai con la legge per l’ennesima volta, denunciano “complotti” giudaico-massonici. (Questa dichiarazione mi ricorda qualcuno, qualcuno con baffetti e divisa, ma no, non è Chaplin). Ministri della Repubblica che prontamente assicurano loro “vigilanza” sui complotti...
Miei cari ET, cosa devo dirvi di più? Di qualsiasi costellazione siate originari, restateci. O almeno non mettete piede in Italia, fino a che non diventiamo un paese civile.
Maria G. Di Rienzo
P.S. Gli episodi di cronaca succintamente narrati sono avvenuti nelle province o nella città di: Roma, Palermo, Manfredonia, Foggia, Catania, Civitavecchia, Milano, Ferrara, Lucca, Viterbo. Gli autori degli atti di violenza erano cittadini italiani e cittadini immigrati; le vittime pure.
-
> "Picchiare le donne è tradizione siculo-pakistana"(Amato). DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla ancora e solo di "guai ai vinti" e di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls13 luglio 2007, di Federico La Sala
Chi picchia le donne
di Lidia Ravera é
La prima frase era veramente carina: «Nessun Dio autorizza un uomo a picchiare la donna». Sacrosanta, ben detta (io avrei usato l’articolo indeterminativo, nessun dio autorizza un uomo a piacchiare una donna, ma sono sfumature). La seconda frase era - nelle intenzioni - umoristica: «È una tradizione siculo-pachistana, che vuole far credere il contrario», e lì il ministro dell’Interno è scivolato in una trappola. Voleva dire che l’Italia non è la Svezia, che fino a qualche decina d’anni fa se un uomo tradiva la moglie erano fatti suoi se una donna tradiva il marito era la galera, voleva dire che in Sicilia se una ragazza veniva rapita a scopo di libidine poi doveva lasciarsi sposare se no era disonorata, voleva dire che ancora oggi gli uomini godono di libertà, rispetto, potere ben maggiori di quelli di cui godono le donne.
Voleva dire che se un uomo è scapolo è desiderato e conteso, se una donna è zitella è disprezzata e derisa, voleva dire che anche nel nostro sud, trent’anni fa, vent’anni fa, si usava la copertura della religione per discriminare le ragazze. Casta, pura, illibata, scortata dalle zie, condannata, condizionata oppure velata, infibulata, lapidata.
Sono variazioni significative ma sono variazioni di una stessa musica: Dio ha fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza, la donna, invece, è uguale sputata al demonio, sotto forma di Eva tentatrice. L’uomo ha il peccato originale che poverino non era poi neanche colpa sua, la donna è titolare di tutti i duplicati: è corrotta e corrompe, se ha il ciclo fa appassire i fiori, se sgarra la fai nera, se la sposi diventa roba tua.
Subisce, la donna, ancora oggi, buona parte degli effetti collaterali del suo statuto di oggetto, di cosa rosa, puttana e graziosa, di essere inferiore alla persona. Da noi, fra pizza tanga e chiese, come da loro, fra montone stufato burka e moschee.
Voleva dire tutto questo, il dottor Sottile? Certo che no. Voleva dire molto meno, ma ha commesso l’errore di nominare una regione. E questo, nell’Italia disunita delle suscettibilità locali, non si può fare. Non puoi dire falso e cortese a un piemontese, come non puoi dire che abita una terra di mafia a un siciliano. Ci sarà sempre un torinese che si dichiara sincero e cafone e un siciliano che si dichiara onesto e legalitario. E avranno assolutamente ragione. Peccato che, negando la base di realtà che corre sotto le barzellette (l’umorismo per questo è crudele), rinuncino a prendere atto del problema e a darsi da fare per risolverlo. Così è con le donne, ahimè. Tutte insorgono, attrici e politiche, damine e ministre, su base locale e sessuale, ma nessuna dice che lo specchio dell’Islam più integralista e arretrato riflette una tendenza ancora operante anche nel primo mondo: discriminare le donne con l’alibi della religione. Anche cattolica. Basta prestare ascolto a Benedetto sedicesimo, che le donne le vuole al servizio della specie, senza diritto di interrompere una gravidanza indesiderata come di farsi aiutare dalla scienza per ottenere una gravidanza desiderata e impossibile per vie naturali.
Le grandi religioni monoteiste non amano le donne. Gli interpreti integralisti di tutte le grandi religioni monoteiste non amano l’amore. Sono, gli integralisti, quei personaggi così certi di essere nel giusto e così bisognosi di coltivare questa certezza, che, di regola, finiscono di essere chiusi all’altro da sé, nemici di chiunque sia diverso, intransigenti, sordi per scelta e volontariamente ciechi, sepolti nella loro presunzione di innocenza, immodificabili. Una battaglia collettiva, bipartisan e cattomusulmana, contro gli integralismi, farebbe un gran bene a tutto il nostro paese, da Bolzano a Siracusa. Una battaglia contro quelli che picchiavano le donne e non le picchiano più, ma vorrebbero picchiarle ancora. Contro quelli che continuano a picchiare le donne ma non lo dicono più. Contro quelli che picchiano quelli che picchiano le donne, pur di picchiare qualcuno.
* l’Unità, Pubblicato il: 13.07.07, Modificato il: 13.07.07 alle ore 7.49
-
> "Picchiare le donne è tradizione siculo-pakistana"?!! DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla ancora e solo di "guai ai vinti" e di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls13 luglio 2007, di Federico La Sala
LE BOTTE DEL MINISTRO AMATO
di Norma Rangeri (il manifesto, 12.07.2007)
"Sono in troppi, anche in Italia, a respingere l’Islam in nome dell’identità cristiana, mentre anche le parrocchie dovrebbero discutere al loro interno e operare per l’integrazione". Un discorso serio, pronunciato dal ministro Amato in un convegno su Islam e integrazione. Poi il ministro osserva come gli opposti integralismi religiosi brillino per misoginia: "Nessun dio autorizza a picchiare la donna. E’ una tradizione siculo-pakistana che vuole far credere il contrario", spiega con riferimento alla sua origine siciliana, ricordando "come ancora negli anni ’70 in Sicilia si trovavano costumi e tradizioni non molto distanti da quelle che ora sono importate da certi gruppi musulmani". Non l’avesse mai detto. Si è scatenata la riffa delle dichiarazioni, con la squadra dei politici siciliani alla testa della crociata, capitanati dalla siracusana Prestigiacomo ("io lo denuncio!"), con seguito di leghisti e forzisti, impegnati a citare sure e versetti.
Il primo premio va all’ineffabile Totò Cuffaro, il campione della giornata. Il governatore della Sicilia fa sapere che "la pari dignità tra uomo e donna risulta teologicamente attestata dalla consolidata esegesi biblica dell’episodio di Eva tratta dalla costola di Adamo". Farci nascere da una costola deve essergli sembrato il massimo della parità. Accontentiamoci, in fondo è sempre meglio che essere generate da altri organi maschili.
Al ministro quello spericolato link siculo-pakistano sarà venuto anche male, ma ha detto un’ovvietà. Le tradizioni isolane sul delitto d’onore non sono mai state un vanto dell’Italia civile.
-
> DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla ancora e solo di "guai ai vinti" e di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls9 luglio 2007, di Federico La Sala
Il giorno del processo di Hina
Il 28 giugno a Brescia davanti al tribunale le donne dell’Acmid (Associazione Donne Marocchine) si riuniscono per chiedere la costituzione di parte civile al processo contro gli assassinio della ventenne pakistana Hina Salem,uccisa un anno fa perchè non voleva vivere secondo la legge religiosa e patriarcale della sua famiglia. La rivista di donne MAREA ha girato questa testimonianza.
Visita il sito: www.mareaonline.it
Arcoiris TV - Per vedere il filmato clicca qui!
-
> DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla ancora e solo di "guai ai vinti" e di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls5 luglio 2007, di Federico La Sala
comunicato di solidarietà a Dounia Ettaib
L’ Associazione Italiana Giuristi Democratici :
 esprime il proprio sconcerto per gli episodi misogini che hanno seguito la manifestazione pacifica contro il femminicidio svoltasi in occasione dell’udienza del relativo processo, davanti al Tribunale di Brescia;
esprime il proprio sconcerto per gli episodi misogini che hanno seguito la manifestazione pacifica contro il femminicidio svoltasi in occasione dell’udienza del relativo processo, davanti al Tribunale di Brescia; esprime la propria sentita solidarietà a Dounia Ettaib, vice presidente lombarda dell’Associazione donne marocchine in Italia, per l’aggressione e le minacce rivolte nei suoi confronti, perché questo atto di violenza patriarcale non affievolisca il Suo impegno per l’autodeterminazione delle donne marocchine;
esprime la propria sentita solidarietà a Dounia Ettaib, vice presidente lombarda dell’Associazione donne marocchine in Italia, per l’aggressione e le minacce rivolte nei suoi confronti, perché questo atto di violenza patriarcale non affievolisca il Suo impegno per l’autodeterminazione delle donne marocchine; auspica che venga fatta luce su tali episodi di negazione violenta della dignità e del diritto all’autodeterminazione delle donne;
auspica che venga fatta luce su tali episodi di negazione violenta della dignità e del diritto all’autodeterminazione delle donne; si auspica che le Istituzioni si impegnino per garantire il diritto delle donne a manifestare pubblicamente per il riconoscimento dei propri diritti, e sostengano iniziative di carattere sociale e culturale volte a promuovere ogni forma di manifestazione di libertà di espressione, di pensiero, di azione da parte delle donne migranti.
si auspica che le Istituzioni si impegnino per garantire il diritto delle donne a manifestare pubblicamente per il riconoscimento dei propri diritti, e sostengano iniziative di carattere sociale e culturale volte a promuovere ogni forma di manifestazione di libertà di espressione, di pensiero, di azione da parte delle donne migranti. Respinge ogni tentativo di strumentalizzazione dell’episodio da parte di forze politiche razziste per le loro campagne antiislamiche e antiarabe.
Respinge ogni tentativo di strumentalizzazione dell’episodio da parte di forze politiche razziste per le loro campagne antiislamiche e antiarabe.Roma, 2 luglio 2007
-
> DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla ancora e solo di "guai ai vinti" e di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls4 luglio 2007, di Federico La Sala
MONICA LANFRANCO: UNA LETTERA DI SOLIDARIETA’ ALLE DONNE MAROCCHINE DOPO L’AGGRESSIONE AD UNA DI LORO
[Riceviamo e diffondiamo. Dounia Ettaib e’ la presidente della sezione lombarda (e vicepresidente nazionale) dell’Associazione delle donne marocchine Acmid-donna; ha subito un’aggressione e gravissime minacce all’indomani della manifestazione contro la violenza sulle donne in occasione dell’apertura del processo per l’uccisione di Hina Saleem; attualmente e’ costretta a vivere sotto scorta] *
Care tutte, care Souad,
vorrei esprimere tutta la mia solidarieta’, e quella della redazione di "Marea" per l’aggressione contro Dounia Ettaib, vostra attivista appassionata e coraggiosa per i diritti delle donne. Vorrei dire che il vostro impegno e’ il nostro, da sempre e per il futuro; finche’ non si afferma, forte e chiaro, che va spezzata la connesione tra patriarcato, sessismo e fondamentalismo religioso tutte le donne, e anche gli uomini che le sostengono, saranno in pericolo dovunque. Cosi’ come in pericolo saranno la liberta’ e l’autodeterminazione di tutte, che possono prosperare solo con l’aiuto di una societa’ laica e condivisa.
Grazie per il vostro lavoro, pur nella paura e nello sgomento per la doppia violenza subita (la non ammissione di parte civile al processo contro gli assassini di Hina e l’intimidazione a Dounia) vi prego: non smettete di alzare la voce.
* NOTIZIE MINIME DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO Numero 140 del 4 luglio 2007
Notizie minime della nonviolenza in cammino proposte dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it
-
> DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla ancora e solo di "guai ai vinti" e di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls1 luglio 2007, di Federico La Sala
Processo per la morte di Hina, manifestazione in tribunale
Il presidio è stato orrganizzato dall’Associazione delle donne marocchine. Adesioni trasversali. La presidente dell’Acmid Souad Sbai: «Nessuna strumentalizzazione politica»
di Cinzia Gubbini (il manifesto, 28.06.2007)
Si apre stamattina a Brescia l’udienza preliminare per l’omicidio di Hina Saleem, la ventiduenne pachistana uccisa e sepolta nel giardino dell’abitazione dei suoi genitori e per il quale sono imputati suo padre, suo zio e due cognati. Hina, che conviveva da qualche tempo con il suo fidanzato italiano, fu uccisa perché si ribellava al codice comportamentale che la sua famiglia voleva imporle.
Il caso di Hina è stato il più eclatante tra le molte storie di violenze a carico delle donne straniere che vivono in Italia, e ha infuocato il dibattito politico. Stamattina davanti al tribunale, a mostrare solidarietà e a protestare contro la violenza sulle donne, ci saranno anche molte altre donne, italiane e straniere, che arriveranno da diverse città d’Italia.
Ad organizzare il presidio - l’appuntamento è alle 8,30 in via Moretto 78 - è stata l’Associazione delle donne marocchine, presieduta da Souad Sbai, che ha anche chiesto di potersi costituire parte civile al processo in corso. Stessa cosa ha annunciato il ministero delle Pari opportunità.
Inutile negare che la associazione guidata da Sbai non raccoglie molte simpatie a sinistra: l’associazione svolge un lavoro giudicato meritorio con le donne straniere, ma contemporaneamente si schiera a favore di questioni di tutt’altro tenore, come la Carta dei Valori, o addirittura il recente Family Day. Tra le maggiori «sponsor» dell’Acmid la deputata di Alleanza nazionale Daniela Santanchè, che ha partecipato all’organizzazione del presidio. Proprio per questo è interessante osservare come l’iniziativa dell’Associazione donne marocchine sull’omicidio di Hina Saleem ha raccolto adesioni trasversali. Un esempio, una volta tanto, della politica che si fa sui contenuti, aldilà delle appartenenze. Alla decisione di costituirsi come parte civile sono arrivate le adesioni - tra l’altro - dell’Associazione usciamo dal silenzio, e il sostegno dell’Unione delle donne italiane (Udi).
Stamattina, davanti al tribunale, ci sarà anche una delegazione del centro interculturale Trama di Terre di Imola. Spiega la sua presidente, Tiziana Dal Pra: «Lavorando anche nell’accoglienza abitativa tocchiamo con mano quanto sia serio il problema della violenza sulle donne straniere, ma anche il problema della loro solitudine, della mancanza di punti di riferimento. La questione della violenza riguarda certamente e in larga parte le donne italiane, ma non c’è dubbio che le donne straniere vivono una doppia discriminazione - dice Dal Pra - per questo abbiamo trovato debole la mobilitazione del movimento femminile italiano di fronte all’atroce morte di Hina. E abbiamo deciso di esserci. Inutile dire che una come me non ha nulla a che spartire con Daniela Santanchè o con chi va al Family Day ma questo non ci può impedire di esserci. Io sono stufa di partecipare ai dibattiti. Penso sia arrivato il momento di trovare forme di mobilitazione per un femminismo interculturale. Non saremo strumentalizzate se avremo le idee chiare, e le abbiamo: la violenza sulle donne non ha né colore né religione. Ma ha un sesso: quello maschile».
Sulla stessa linea la direttrice del centro interculturale di Torino Alma Mater, Anna Ciciaco: «Non ci saremo più che altro perché non ne sapevamo nulla. Ma abbiamo parlato molto del caso di Hina, la violenza sulle donne è in aumento in modo preoccupante e tutte le forme di mobilitazione che ci aiutino ad uscire dal silenzio sono importanti e vanno sostenute». Non ha ricevuto comunicazioni sul presidio neanche la deputata del Prc Mercedes Frias, donna di origine straniera e impegnata da anni sul fronte delle questioni femminili: «Tenere l’attenzione alta è fondamentale. Anche se, dalla mia visuale nel "palazzo", non posso non osservare come sul caso di Hina ci sia stata una reazione che purtroppo non spetta ai tanti altri casi di violenza. Trovo mortale la volontà di focalizzare il problema sulla cultura: non ci sono culture che dicono di ammazzare le donne, ma in tutte le culture è presente l’idea del dominio e del controllo sul corpo della donna». Per quanto riguarda il presidio di stamane, spiega Souad Sbai: «La nostra non è una battaglia religiosa. E non vogliamo essere strumentalizzate politicamente, perché tra le nostre fila ci sono donne di tutti gli orientamenti politici».
Hina: aggredita esponente di Acmid
Dounia Ettaib spinta e minacciata vicino a viale Jenner *
(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Dounia Ettaib, vice presidente lombarda dell’Acmid ha denunciato un’aggressione a Milano nei pressi della moschea di viale Jenner. La circostanza e’ in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’associazione delle donne marocchine in Italia, proprio ieri, aveva chiesto senza ottenerlo di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio di Hina Saleem, la ragazza pakistana uccisa dai famigliari. Due connazionali avrebbero spinto la donna minacciandola pesantemente.
* ANSA Notizia del 29 giugno 2007 - 21:15
 Hina: marocchina Ettaib scortata
Hina: marocchina Ettaib scortata
 ’Ho paura ma portero’ avanti il mio impegno’ *
’Ho paura ma portero’ avanti il mio impegno’ *
(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Dounia Ettaib, la marocchina aggredita da due connazionali, verra’ scortata. ’Ho paura - dice - ma portero’ avanti il mio impegno’. Tra le donne che avevano partecipato alla manifestazione davanti al palazzo di giustizia di Brescia per la vicenda di Hina, la ragazza pakistana uccisa nel bresciano dal padre e da altri parenti, c’era anche Dounia, vice presidente lombarda dell’Associazione donne marocchine in Italia. Proprio il suo attivismo sarebbe stato all’origine delle minacce.
* ANSA » 2007-07-01 14:00
-
> DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla ancora e solo di "guai ai vinti" e di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls1 luglio 2007, di Federico La Sala
HINA, PROCESSO RINVIATO AL 24 OTTOBRE *
BRESCIA - Hanno chiesto di essere giudicati tutti e quattro con il rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena, il padre e altri tre parenti di Hina Saleem, la ragazza pachistana uccisa l’11 agosto dell’anno scorso a Sarezzo, in Val Trompia, nel bresciano. Il giudice Silvia Milesi ha pertanto rinviato il processo al 24 ottobre prossimo per la discussione nel merito.
DECINA IN ATTESA DAVANTI AL TRIBUNALE
Decine di persone hanno atteso, davanti al tribunale di Brescia, l’inizio dell’udienza preliminare per l’omicidio di Hina Saleem, la ragazza pachistana di 20 anni, uccisa nell’agosto scorso nel Bresciano e per il cui delitto sono imputati il padre e altri tre suoi familiari. Un gruppo di donne ha esposto uno striscione con la scritta: ’Io sono Hina’ mentre alcuni dei presenti hanno portato bandiere della Lega Nord. Presente anche l’on. Daniela Santanché, presidente dei circoli D-Donna ed esponente di An. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il delitto maturò dopo il cosiddetto ’consiglio di famiglia’ durante il quale la ragazza fu condannata per i suoi costumi troppi liberi. Il fidanzato di Hina, un giovane bresciano, ha manifestato l’intenzione di costituirsi parte civile.
PULLMAN DA TUTTA ITALIA
Sono almeno tre i pullman giunti da Milano, Roma e Torino con a bordo donne musulmane dell’ associazione Acmid giunte a Brescia per l’udienza preliminare per l’omicidio di Hina Saleem, la pachistana uccisa nel Bresciano l’11 agosto scorso. In aula è presente il padre della giovane ammazzata a Sarezzo, in Valle Trompia. Le donne musulmane dell’Acmid hanno manifestato l’intenzione di costituirsi parte civile, così come il fidanzato di Hina, Giuseppe Tempini.
IMAM: VITTIMA IGNORANZA DI SUO PADRE
Per Abdellah Mechnoune, imam itinerante residente a Torino, Hina Saleem, la ragazza pachistana uccisa nel Bresciano, è stata "vittima dell’ ignoranza del padre" e non ha contravvenuto ad alcuna regola del Corano. "Sono qui per appoggiare la manifestazione e condannare questo gesto - ha detto l’imam mentre è in corso a Brescia l’udienza preliminare per l’omicidio che vede imputato il padre di Hina, reo confesso, e tre suoi parenti - si tratta di un assassino che ha ucciso sua figlia perché aveva costumi occidentali". "Avere costumi occidentali non viola nessuna norma del Corano - ha spiegato l’imam - ’io vedo cosa avete nel vostro cuore, non cio’ che avete all’esternò, recita il Corano". In mattinata c’era stato qualche momento di tensione tra i musulmani presenti e alcuni esponenti della Lega Nord che avevano esposto uno striscione con la scritta: ’Hina vittima dell’Islam’. Lo striscione è stato poi fatto togliere.
PM: SI’ A PARTE CIVILE FIDANZATO E ACMID
Il pm di Brescia Paolo Guidi si è detto favorevole alla costituzione di parte civile di Giuseppe Tempini, fidanzato di Hina Saleem, la ragazza pachistana uccisa nel bresciano l’anno scorso, e della Acmir, l’associazione donne musulmane oggi presente all’udienza preliminare, davanti al Gip Silvia Milesi, che vede imputati il padre della giovane uccisa e tre suoi familiari. Lo ha spiegato, fuori dall’aula, l’avvocato dell’Acmir Sandro Meregalli il quale ha parlato di "atmosfera pacata" nel corso dell’udienza che si svolge a porte chiuse e che vede la presenza del padre di Hina e di un suo zio, mentre gli altri due imputati hanno rinunciato a presenziare. "Quello che può apparire inquietante - ha commentato il legale - è l’indifferenza dei due, mentre la madre è entrata piangendo".
NO A COSTITUZIONE PARTE CIVILE ACMID
Il gup Silvia Milesi non ha ammesso la costituzione di parte civile dell’associazione di donne marocchine Acmid nel procedimento per l’omicidio di Hina Saleem, la ragazza pachistana uccisa dal padre, reo confesso, l’11 agosto dell’anno scorso.
SANTANCHE’: DA PADRE ATTEGGIAMENTO MINACCIOSO
L’onorevole Daniela Santanché, presente oggi all’udienza preliminare per l’omicidio di Hina Saleem, ha riferito che il padre della ragazza pachistana uccisa, in aula ha avuto un atteggiamento minaccioso. La parlamentare ha riferito che quando lei e Anselma Dall’Olio, moglie di Giuliano Ferrara, sono entrate in aula l’imputato ha cominciato a gesticolare per spiegare che non le voleva presenti. Ha avuto toni molto critici l’onorevole Daniela Santanché (An) nel commentare la decisione del giudice Silvia Milesi di non accogliere la richiesta di costituzione di parte civile dell’associazione di donne marocchine Acmid nel processo per l’omicidio per la ragazza pakistana Hina Saleem. "E’ una pagina orrenda della giustizia - ha detto la parlamentare -. Un pessimo esempio per le future generazioni. Qui non ha vinto Hina, ma chi l’ha sgozzata e, in aula, ha mostrato un atteggiamento di orgogliosa rivendicazione di quel terribile gesto". A chi le faceva notare che la decisione era stata presa da un giudice donna, Santanché ha commentato: "Le donne non hanno ancora capito che si vince in squadra, che se non si è unite si perde". Alcune delle donne presenti davanti al tribunale di Brescia hanno gridato "vergogna" non appena appreso della decisione.
* ANSA » 2007-06-28 13:58
-
> DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". ---- La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Mohamed Saleem, il padre di Hina, la ragazza pachistana uccisa l’11 agosto 2006.5 dicembre 2008, di Maria Paola Falqui
Ansa» 2008-12-05 14:58
HINA: CONFERMATI 30 ANNI AL PADRE, 17 ANNI AI COGNATI
BRESCIA - La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Mohamed Saleem, il padre di Hina, la ragazza pachistana uccisa l’11 agosto 2006.
Ha invece ridotto da 30 a 17 anni la pena per i due cognati della vittima, considerati complici nell’omicidio.
Come al termine del processo di primo grado, la madre di Hina, ha accolto con urla di disperazione la conferma della condanna del marito. E si è rifiutata di lasciare il palazzo di giustizia
-
> DIO, UOMINI E DONNE: "DARABA". ---- La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Mohamed Saleem, il padre di Hina, la ragazza pachistana uccisa l’11 agosto 2006.5 dicembre 2008, di Maria Paola Falqui
La madre, dopo la lettura della sentenza, è scoppiata in lacrime
Hina, confermata condanna a 30 anni per il padre
Pena ridotta invece a 17 anni per i due cognati della giovane. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’Appello di Brescia. La ragazza pakistana è stata sgozzata l’11 agosto 2006 a Sarezzo perché voleva vivere all’occidentale. L’Istituto culturale islamico di Milano: ’’Hanno fatto bene’’. Souab Sbai all’Adnkronos: ’’Verdetto esemplare’’
ultimo aggiornamento: 05 dicembre, ore 17:53
Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Trent’anni di reclusione. Nessuno sconto per il padre di Hina Saleem (nella foto), la ragazza pakistana sgozzata l’11 agosto 2006 a Sarezzo, nel bresciano, perché voleva vivere all’occidentale. Pena invece ridotta da 30 a 17 anni per i due cognati della vittima, considerati complici dell’omicidio. E’ questa la sentenza emessa oggi dalla Corte d’Assise d’Appello di Brescia. Ad assistere alla sentenza anche la madre di Hina che, dopo la lettura della sentenza, è scoppiata in lacrime ed è stata assistita dai paramedici del 118. Quella madre che, il giorno dell’omicidio, era in Pakistan.
Hina è stata attirata con una trappola: è stata una telefonata del padre a convincerla a tornare a casa. "Vieni a trovarmi, è arrivato il nostro amico dalla Francia", le ha detto. Un raggiro per seguire, forse, una sentenza di morte già decisa. E’ stata uccisa attorno alle 6 del pomeriggio, ha stabilito l’autopsia, con un taglio alla gola inferto con un grosso coltello da cucina. Tenuta ferma a terra e sgozzata, poi il corpo è stato portato giù per le scale fino al pianterreno, fatto uscire dalla finestra e sepolto nella fossa già scavata nell’orto. Solo diverso ore dopo i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di chi voleva vivere all’occidentale.
Oggi, come già nei mesi scorsi, Mohammed Saleem, il padre di Hina, si era pentito di quell’atroce delitto. "Quel pomeriggio - aveva dichiarato già in passato - non capivo più niente. Se Hina non fosse venuta a casa ma fosse andata con sua mamma in Pakistan non sarebbe successo niente. Quel giorno non ho saputo controllarmi, ho perso la testa e ho ucciso mia figlia".
Abdel Hamid Shaari, presidente dell’istituto culturale islamico di Milano, commenta: "Hanno fatto bene". Per Shaari i giudici "non potevano fare altro". Del resto, conclude "in Italia c’è una legge che punisce chi ammazza. Lui ha ammazzato e giustamente è stato condannato".
Soddisfazione anche da Souab Sbai, Presidente dell’Associazione Donne Marocchine in Italia. ’’Siamo contenti - dichiara all’ADNKRONOS - perché questa è una condanna eccellente ed esemplare, che ridà fiducia nella giustizia e soprattutto più fiducia alle donne ". Il presidente dell’associazione rivolge parole di conforto e di comprensione anche alla madre di Hina a cui dice" oggi può iniziare il suo lutto e sentirsi liberata dal peso del processo".
-
-
-
> ISLAM, DONNE E UOMINI: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla solo di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls19 giugno 2007, di Federico La Sala
L’Islam è votato al dialogo
di MUHAMMAD HOSNI MUBARAK (La Repubblica, 17-06-2007)
In un’epoca in cui predomina il discorso sullo scontro invece del discorso sul dialogo tra le civiltà, può essere opportuno tornare indietro ed esaminare come l’Islam, una delle più grandi religioni dell’umanità, considera i suoi rapporti con gli altri. Da questa considerazione potrebbe emergere uno strumento diverso, e sicuramente più positivo, per la coesistenza delle civiltà, delle culture e delle religioni.
Componenti insite nella fede islamica sono l’accettazione, il riconoscimento e la credenza nella verità delle due religioni celesti che hanno preceduto l’Islam: il Giudaismo e il Cristianesimo. Una delle prime lezioni che apprendiamo dal Corano è che non possiamo essere veri Musulmani se non crediamo in "Dio, nei suoi Angeli, nei suoi Libri e nei suoi Profeti"(2: 2851).
Il Corano va oltre e afferma che i veri credenti non fanno differenza alcuna tra i profeti di Dio. Per esempio, per i musulmani, Abramo, patriarca di tutte le tre religioni che portano il suo nome, è musulmano come Muhammad, il Profeta dell’Islam, perché era un vero credente, come lo erano, secondo il Corano, Noè, Giacobbe e i suoi figli, Mosè e Gesù.
In questo senso, nell’Islam, l’interazione, la coesistenza e il dialogo tra le religioni e le civiltà sono più di una semplice necessità dettata dalla prossimità geografica di nazioni che il nostro mondo moderno rende sempre più vicine. Sono invece un prerequisito per l’autorealizzazione dei veri Musulmani, come afferma il sacro Corano: "O voi umani, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina, e vi abbiamo diviso in nazioni e tribù perché facciate reciproca conoscenza"(49: 131)
Questa natura dell’Islam, aperta a tutta la conoscenza, è riassunta in uno dei detti più famosi del Profeta dell’Islam: "seguite la via della conoscenza, dovreste per questo andare fino in Cina". Seguendo il detto del Profeta, i primi scienziati e studiosi musulmani hanno potuto sia assimilare l’eredità delle civiltà precedenti sia arricchire l’umanità con la loro civiltà basata sulla creatività e sull’inventiva in campi come la medicina, l’astronomia, la poesia, la matematica, ecc.
Oggi, questi principi dell’Islam - il riconoscimento e il rispetto della fede e della cultura dell’altro e la ricerca di un’interazione, - sono forse lo strumento migliore per la coesistenza nel nostro mondo moderno in cui alcuni sono più interessati allo scontro di civiltà che al dialogo e alla cooperazione tra i loro popoli. Il 24 luglio 1219, San Francesco d’Assisi intraprese la prima delle sue numerose azioni coraggiose. Nel mezzo delle Crociate, partì con i suoi compagni per la Palestina, poi raggiunse Damietta, in Egitto. Lì ammonì i Crociati che assediavano la città da più di un anno: seguendo la via della morte e della distruzione si allontanavano sempre più dalla via di Dio. San Francesco predicò che alla fine, sarebbero stati sconfitti e scacciati dall’Egitto ed ebbe ragione. San Francesco continuò la seconda parte della sua missione - convincere i Musulmani che non tutti i cristiani erano Crociati. Nel mezzo del caos della guerra, circondato da violenza e morte, si arrischiò a chiedere un incontro con il Sultano d’Egitto al-Malik-al-Kamil. Il Sultano accettò di incontrare il coraggioso monaco e trascorse con lui alcuni giorni.
Questa ricca esperienza fu sicuramente il primo esempio di dialogo musulmano-cristiano della storia. Da Damietta, San Francesco proseguì alla volta di Gerusalemme dove incontrò Aissa, Sultano di Damasco al quale consegnò una lettera di raccomandazione del Sultano d’Egitto. Con il suo senso di compassione e la sua dottrina pacifista, San Francesco riuscì laddove erano fallite le armi.
A mio avviso, non esiste uno scontro di civiltà o di religioni, ma uno scontro di interessi. I conflitti ai quali assistiamo oggi trovano la loro motivazione nei gruppi politici alla ricerca di dominio e distruzione che prendono in ostaggio le religioni e le strumentalizzano per realizzare i loro obiettivi. Guardando indietro alla storia di San Francesco e di chi ha seguito il suo esempio nel XIII Secolo, possiamo sentire una speranza. Oggi, in tutte le religioni c’è ancora chi segue l’esempio del Santo e decide di costruire ponti tra i seguaci di religioni diverse e di promuovere la pace tra le civiltà. (questo articolo è contenuto nel libro che verrà donato oggi al Papa dai frati francescani di Assisi)
-
> ISLAM, DONNE E UOMINI: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla solo di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls19 giugno 2007, di Federico La Sala
IL VIAGGIO DEL PAPA *
Vivere da convertiti segno che parla a tutti
L’omelia alla Messa davanti al Sacro Convento «Il peccato impediva a Francesco di vedere nei lebbrosi i propri fratelli: l’incontro con Cristo lo aprì a una misericordia più grande della filantropia»
Benedetto Xvi
Pubblichiamo ampi stralci dell’omelia tenuta dal Papa domenica ad Assisi.
Cari fratelli e sorelle,
che cosa ci dice oggi il Signore, mentre celebriamo l’Eucaristia nel suggestivo scenario di questa piazza? Oggi tutto qui parla di conversione, come ci ha ricordato monsignor Domenico Sorrentino (...). La Parola di Dio appena proclamata ci illumina, mettendoci davanti agli occhi tre figure di convertiti. La prima è quella di Davide. Il brano che lo riguarda, tratto dal secondo libro di Samuele, ci presenta uno dei colloqui più drammatici dell’Antico Testamento. Al centro di questo dialogo c’è un verdetto bruciante, con cui la Parola di Dio, proferita dal profeta Natan, mette a nudo un re giunto all’apice della sua fortuna politica, ma caduto pure al livello più basso della sua vita morale. (...) L’uomo è davvero grandezza e miseria (...). «Tu sei quell’uomo»: è parola che inchioda Davide alle sue responsabilità. Profondamente colpito da questa parola, il re sviluppa un pentimento sincero e si apre all’offerta della misericordia. Ecco il cammino della conversione.
Ad invitarci a questo cammino, accanto a Davide, si pone oggi Francesco. Lui stesso (...) guarda ai suoi primi venticinque anni come ad un tempo in cui «era nei peccati» (cfr 2 Test 1: FF 110). Al di là delle singole manifestazioni, peccato era il suo concepire e organizzarsi una vita tutta centrata su di sé, inseguendo vani sogni di gloria terrena.(...) Gli sembrava amaro vedere i lebbrosi. Il peccato gli impediva di dominare la ripugnanza fisica per riconoscere in loro altrettanti fratelli da amare. La conversione lo portò ad esercitare misericordia e gli ottenne insieme misericordia. Servire i lebbrosi, fino a baciarli, non fu solo un gesto di filantropia, una conversione, per così dire, «sociale», ma una vera esperienza religiosa, comandata dall’iniziativa della grazia e dall’amore di Dio (...).
Nel brano della Lettera ai Galati, emerge un altro aspetto del cammino di conversione. A spiegarcelo è un altro grande convertito, l’apostolo Paolo. (...) «D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo» (6,17). (...) Nella disputa sul modo retto di vedere e di vivere il Vangelo, alla fine, non decidono gli argomenti del nostro pensiero; decide la realtà della vita, la comunione vissuta e sofferta con Gesù, non solo nelle idee o nelle parole, ma fin nel profondo dell’esistenza, coinvolgendo anche il corpo, la carne. (...) Francesco di Assisi ci riconsegna oggi tutte queste parole di Paolo, con la forza della sua testimonianza. (...) Egli si innamorò di Cristo. Le piaghe del Crocifisso ferirono il suo cuore, prima di segnare il suo corpo sulla Verna. Egli poteva veramente dire con Paolo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me».
E veniamo al cuore evangelico dell’odierna Parola di Dio. Gesù stesso, nel brano appena letto del Vangelo di Luca, ci spiega il dinamismo dell’autentica conversione, additandoci come modello la donna peccatrice riscattata dall’amore. (...) A scanso di equivoci, è da notare che la misericordia di Gesù non si esprime mettendo tra parentesi la legge morale. Per Gesù, il bene è bene, il male è male. La misericordia non cambia i connotati del peccato, ma lo brucia in un fuoco di amore. Questo effetto purificante e sanante si realizza se c’è nell’uomo una corrispondenza di amore, che implica il riconoscimento della legge di Dio, il pentimento sincero, il proposito di una vita nuova. (....) Che cosa è stata la vita di Francesco convertito se non un grande atto d’amore? Lo rivelano le sue preghiere infuocate, ricche di contemplazione e di lode, il suo tenero abbraccio del Bimbo divino a Greccio, la sua contemplazione della passione alla Verna, il suo «vivere secondo la forma del santo Vangelo» (2 Test 14: FF 116), la sua scelta della povertà e il suo cercare Cristo nel volto dei poveri. È questa sua conversione a Cristo, fino al desiderio di «trasformarsi» in Lui, diventandone un’immagine compiuta, che spiega quel suo tipico vissuto, in virtù del quale egli ci appare così attuale anche rispetto a grandi temi del nostro tempo, quali la ricerca della pace, la salvaguardia della natura, la promozione del dialogo tra tutti gli uomini. Francesco è un vero maestro in queste cose. Ma lo è a partire da Cristo. È Cristo, infatti, «la nostra pace» (cfr Ef 2,14). (...)
Non posso dimenticare, nell’odierno contesto, l’iniziativa del mio predecessore di santa memoria, Giovanni Paolo II, il quale volle riunire qui, nel 1986, i rappresentanti delle confessioni cristiane e delle diverse religioni del mondo, per un incontro di preghiera per la pace. Fu un’intuizione profetica e un momento di grazia, come ho ribadito alcuni mesi or sono nella mia lettera al vescovo di questa città in occasione del ventesimo anniversario di quell’evento. La scelta di celebrare quell’incontro ad Assisi era suggerita proprio dalla testimonianza di Francesco come uomo di pace, al quale tanti guardano con simpatia anche da altre posizioni culturali e religiose. Al tempo stesso, la luce del Poverello su quell’iniziativa era una garanzia di autenticità cristiana, giacché la sua vita e il suo messaggio poggiano così visibilmente sulla scelta di Cristo, da respingere a priori qualunque tentazione di indifferentismo religioso, che nulla avrebbe a che vedere con l’autentico dialogo interreligioso.
Lo «spirito di Assisi», che da quell’evento continua a diffondersi nel mondo, si oppone allo spirito di violenza, all’abuso della religione come pretesto per la violenza. Assisi ci dice che la fedeltà alla propria convinzione religiosa, la fedeltà soprattutto a Cristo crocifisso e risorto non si esprime in violenza e intolleranza, ma nel sincero rispetto dell’altro, nel dialogo, in un annuncio che fa appello alla libertà e alla ragione, nell’impegno per la pace e per la riconciliazione. Non potrebbe essere atteggiamento evangelico, né francescano, il non riuscire a coniugare l’accoglienza, il dialogo e il rispetto per tutti con la certezza di fede che ogni cristiano, al pari del Santo di Assisi, è tenuto a coltivare, annunciando Cristo come via, verità e vita dell’uomo (cfr Gv 14,6), unico Salvatore del mondo. (...)
Ai giovani: «Come il Poverello, cercate la vera felicità»
Il discorso tenuto a Santa Maria degli Angeli: «Siamo qui per imparare a incontrare Cristo. Anche noi siamo chiamati a riparare la Chiesa» «Centrare la vita su se stessi è una trappola mortale: possiamo essere noi stessi solo se ci apriamo, nell’amore, a Dio e ai fratelli»
Benedetto Xvi
Pubblichiamo ampi stralci delle parole rivolte da Benedetto XVI ai giovani sul piazzale della basilica di Santa Maria degli Angeli.
Carissimi giovani, grazie per la vostra accoglienza, così calorosa, sento in voi la fede, sento la gioia di essere cristiani cattolici. Grazie per le parole affettuose e per le importanti domande che i vostri due rappresentanti mi hanno rivolto. (...)
Questo momento del mio pellegrinaggio ha un significato particolare. San Francesco parla a tutti, ma so che ha proprio per voi giovani un’attrazione speciale. (...) La sua conversione avvenne quando era nel pieno della sua vitalità, delle sue esperienze, dei suoi sogni. Aveva trascorso venticinque anni senza venire a capo del senso della vita. Pochi mesi prima di morire, ricorderà quel periodo come il tempo in cui «era nei peccati» (cfr. 2 Test 1: FF 110).
A che cosa pensava, Francesco, parlando di peccati? Stando alle biografie, ciascuna delle quali ha un suo taglio, non è facile determinarlo. Un efficace ritratto del suo modo di vivere si trova nella Leggenda dei tre compagni, dove si legge: «Francesco era tanto più allegro e generoso, dedito ai giochi e ai canti, girovagava per la città di Assisi giorno e notte con amici del suo stampo, tanto generoso nello spendere da dissipare in pranzi e altre cose tutto quello che poteva avere o guadagnare» (3 Comp 1,2: FF 1396). Di quanti ragazzi anche ai nostri giorni non si potrebbe dire qualcosa di simile? Oggi poi c’è la possibilità di andare a divertirsi ben oltre la propria città. (...) Si può «girovagare» anche virtualmente «navigando» in internet. Purtroppo non mancano - ed anzi sono tanti, troppi! - i giovani che cercano paesaggi mentali tanto fatui quanto distruttivi nei paradisi artificiali della droga. Come negare che sono molti i ragazzi, e non ragazzi, tentati di seguire da vicino la vita del giovane Francesco, prima della sua conversione? Sotto quel modo di vivere c’era il desiderio di felicità che abita ogni cuore umano. Ma poteva quella vita dare la gioia vera? Francesco certo non la trovò. (...) La verità è che le cose finite possono dare barlumi di gioia, ma solo l’Infinito può riempire il cuore. Lo ha detto un altro grande convertito, Sant’Agostino: «Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te» (Confess. 1,1).
Sempre lo stesso testo biografico ci riferisce che Francesco era piuttosto vanitoso. (...) Nella vanità, nella ricerca dell’originalità, c’è qualcosa da cui tutti siamo in qualche modo toccati. Oggi si suol parlare di «cura dell’immagine», o di «ricerca dell’immagine». (...) In certa misura, questo può esprimere un innocente desiderio di essere ben accolti. Ma spesso vi si insinua l’orgoglio, la ricerca smodata di noi stessi, l’egoismo e la voglia di sopraffazione. In realtà, centrare la vita su se stessi è una trappola mortale: noi possiamo essere noi stessi solo se ci apriamo nell’amore, amando Dio e i nostri fratelli.
Un aspetto che impressionava i contemporanei di Francesco era anche la sua ambizione, la sua sete di gloria e di avventura. (...) La stessa sete di gloria lo avrebbe portato nelle Puglie, in una nuova spedizione militare, ma proprio in questa circostanza, a Spoleto, il Signore si fece presente al suo cuore, lo indusse a tornare sui suoi passi, e a mettersi seriamente in ascolto della sua Parola. È interessante annotare come il Signore abbia preso Francesco per il suo verso, quello della voglia di affermarsi, per additargli la strada di un’ambizione santa, proiettata sull’infinito (...).
Cari giovani, mi avete ricordato alcuni problemi della condizione giovanile, della vostra difficoltà a costruirvi un futuro, e soprattutto della fatica a discernere la verità. Nel racconto della passione di Cristo troviamo la domanda di Pilato: «Che cos’è la verità?» (Gv 18,38). (...) Anche oggi, tanti dicono: «ma che cosa è la verità? Possiamo trovarne frammenti, ma la verità come potremmo trovarla?» È realmente arduo credere che questa sia la verità: Gesù Cristo, la Vera Vita, la bussola della nostra vita. E tuttavia, se cominciamo, come è una grande tentazione, a vivere solo secondo le possibilità del momento, senza verità, veramente perdiamo il criterio e perdiamo anche il fondamento della pace comune che può essere solo la verità. E questa verità è Cristo. La verità di Cristo si è verificata nella vita dei santi di tutti i secoli. I santi sono la grande traccia di luce nella storia che attesta: questa è la vita, questo è il cammino, questa è la verità. (...).
Sostando questa mattina a San Damiano, e poi nella Basilica di Santa Chiara, dove si conserva il Crocifisso originale che parlò a Francesco, ho fissato anch’io i miei occhi in quegli occhi di Cristo. È l’immagine del Cristo Crocifisso-Risorto, vita della Chiesa, che parla anche in noi se siamo attenti, come duemila anni fa parlò ai suoi apostoli e ottocento anni fa parlò a Francesco. La Chiesa vive continuamente di questo incontro.
Sì, cari giovani: lasciamoci incontrare da Cristo! Fidiamoci di Lui, ascoltiamo la sua Parola. (...) Ad Assisi si viene per apprendere da san Francesco il segreto per riconoscere Gesù Cristo e fare esperienza di Lui. (...)
Proprio perché di Cristo, Francesco è anche uomo della Chiesa. Dal Crocifisso di San Damiano aveva avuto l’indicazione di riparare la casa di Cristo, che è appunto la Chiesa. (...) Noi tutti siamo chiamati a riparare in ogni generazione di nuovo la casa di Cristo, la Chiesa. (...) E come sappiamo, ci sono tanti modi di riparare, di edificare, di costruire la casa di Dio, la Chiesa. Si edifica poi attraverso le più diverse vocazioni, da quella laicale e familiare, alla vita di speciale consacrazione, alla vocazione sacerdotale. (...) Se il Signore dovesse chiamare qualcuno di voi a questo grande ministero, come anche a qualche forma di vita consacrata, non esitate a dire il vostro sì. Sì non è facile, ma è bello essere ministri del Signore, è bello spendere la vita per Lui! (...)
Sono felice, carissimi giovani, di essere qui, sulla scia dei miei predecessori, e in particolare dell’amico, dell’amato Papa Giovanni Paolo II. (...)
Se oggi il dialogo interreligioso, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, è diventato patrimonio comune e irrinunciabile della sensibilità cristiana, Francesco può aiutarci a dialogare autenticamente, senza cadere in un atteggiamento di indifferenza nei confronti della verità o nell’attenuazione del nostro annuncio cristiano. Il suo essere uomo di pace, di tolleranza, di dialogo, nasce sempre dall’esperienza di Dio-Amore. (...)
Cari giovani, è tempo di giovani che, come Francesco, facciano sul serio e sappiano entrare in un rapporto personale con Gesù. È tempo di guardare alla storia di questo terzo millennio da poco iniziato come a una storia che ha più che mai bisogno di essere lievitata dal Vangelo. Faccio ancora una volta mio l’invito che il mio amato Predecessore, Giovanni Paolo II, amava sempre rivolgere, specialmente ai giovani: "Aprite le porte a Cristo". Apritele come fece Francesco, senza paura, senza calcoli, senza misura. Siate, cari giovani, la mia gioia, come lo siete stati di Giovanni Paolo II. Da questa Basilica dedicata a Santa Maria degli Angeli vi do appuntamento alla Santa Casa di Loreto, ai primi di settembre, per l’Agorà dei giovani italiani.
* Avvenire, 19.06.2007
-
> ISLAM, DONNE E UOMINI: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla solo di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls15 luglio 2007, di Federico La Sala
 L’accusa del Financial Times: "Dimenticato il femminismo"
L’accusa del Financial Times: "Dimenticato il femminismo"
 Per il giornale sono trattate peggio solo a Cipro, Egitto e Corea
Per il giornale sono trattate peggio solo a Cipro, Egitto e Corea "L’Italia un paese di veline
"L’Italia un paese di veline
 le donne sono solo oggetti"
le donne sono solo oggetti"dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
LONDRA - Fin dal titolo, è un’accusa senza mezzi termini: "La terra che ha dimenticato il femminismo", sovraimpresso sul noto cartellone pubblicitario di Telecom Italia in cui Elisabetta Canalis, seduta a gambe incrociate con un telefonino in mano, piega il busto in avanti, in una posizione non proprio comodissima, rivelando una generosa scollatura. E’ la copertina dell’inserto patinato del Financial Times di ieri, che in un articolo di quattro pagine denuncia severamente il trattamento riservato alle donne nel nostro paese: l’uso di vallette seminude in ogni genere di programma televisivo, gli spot pubblicitari dominati da allusioni sessuali, il prevalere della donna come oggetto, destinata a stuzzicare "i genitali dell’uomo, anziché il cervello". Non solo: secondo l’autore del servizio, Adrian Michaels, corrispondente da Milano dell’autorevole quotidiano finanziario, potrebbe esserci un legame fra l’onnipresenza di maggiorate in abiti discinti sui nostri mezzi di comunicazione e la scarsità di donne ai vertici della politica, del business, delle professioni in Italia.
Arrivato a Milano tre anni fa da New York insieme alla moglie, Michaels ammette di essere rimasto stupefatto dal modo in cui televisione e pubblicità dipingono le donne; e ancora più sorpreso dal fatto che apparentemente nessuno protesta o ci trova qualcosa di male. Come esempi del fenomeno, oltre al cartellone della Canalis per la Telecom, cita le vallette del gioco a quiz di Rai Uno L’eredità, la pubblicità dei videofonini della 3, le vallette di Striscia la notizia, l’abbigliamento della presentatrice sportiva Ilaria D’Amico di Sky Italia.
L’articolo considera quindi una serie di dati da cui risulta che le donne italiane sono fra le più sottorappresentate d’Europa nelle stanze dei bottoni: il numero delle parlamentari, 11 per cento, è lo stesso di trent’anni fa; nelle maggiori aziende italiane le donne rappresentano solo il 2 per cento dei consigli d’amministrazione (rispetto al 23 per cento nei paesi scandinavi e al 15 negli Stati Uniti); e un sondaggio internazionale rivela che la presenza di donne in politica, nella pubbica amministrazione e ai vertici del business è più bassa che in Italia soltanto a Cipro, in Egitto e in Corea del Sud. "La mia sensazione è che il femminismo, dopo importanti battaglie per il divorzio e l’aborto, da noi non esista più", gli dice il ministro Emma Bonino, interpellata sul tema.
Altri fattori aumentano le difficoltà delle donne ad avere una diversa posizione sociale, osserva il quotidiano londinese: il lavoro part-time è raro in Italia (15 per cento della forza lavoro rispetto al 21 in Germania e al 36 in Olanda), cosicché le donne che cercano di giostrarsi tra famiglia e carriera sono spesso costrette a scegliere l’una o l’altra. L’articolo ricorda un discorso del governatore della Banca d’Italia Draghi secondo cui il nostro è uno dei paesi europei in cui meno donne tornano all’occupazione dopo la maternità.
Un altro motivo è che gli orari dei negozi ("impossibile fare la spesa il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio, la sera e la domenica") complicano la vita della donna che lavora, su cui continua comunque a pesare la responsabilità di casa. La lettera di Veronica Berlusconi pubblicata da Repubblica, in cui chiedeva le pubbliche scuse di Silvio per il suo comportamento con le donne, potrebbe segnalare l’inizio di un cambiamento, ipotizza Michaels. Ma uno dei pubblicitari da lui intervistati avverte: "L’Italia è indietro nel modo in cui sono trattate le donne rispetto ad altri paesi, ma abbiamo un metro per giudicare cos’è accettabile diverso dal vostro. Gli uomini e le donne italiani non saranno mai come gli uomini e le donne britannici".
* la Repubblica, 15 luglio 2007
-
> ISLAM, DONNE E UOMINI: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla solo di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls17 luglio 2007, di Federico La Sala
LA LETTERA
Una lettrice risponde all’articolo del Financial Times che critica il trionfo di veline e donne nude in Italia
 "Se il mio fondoschiena
"Se il mio fondoschiena
 vale più di due lauree"
vale più di due lauree"di MILA SPICOLA *
CARO DIRETTORE, ad Adrian Michaels che sul Financial Times critica il trionfo di veline e donne nude in Italia vorrei dire che il problema non è femminile. Non è tanto il femminismo ad aver fatto passi da gigante però all’indietro, semmai è il maschilismo italo-pakistano (per parafrasare una recente affermazione di Giuliano Amato) che ormai troneggia da tutte le parti.
Per come la vedo io, la signorina Canalis ha raggiunto benissimo il suo obiettivo e cioè successo e soldi e alzi la mano chi tra le donne non rinuncerebbe al proprio stipendiuccio e ad un po’ di amor proprio femminile se gli mettessero sul piatto un milione di euro per mostrarsi sorridente... ma anche un uomo direi, no? Della serie: chi è più scemo signor Michaels, la Canalis o chi gli va dietro?
Per quel che mi riguarda sono problemi che vivo ogni giorno, ma davvero ogni giorno. Ho 39 anni, sono single, due lauree, (una in architettura e una in conservazione dei beni architettonici), due master, uno in economia e uno in studi storici, una specializzazione in consolidamento, un dottorato di ricerca e ... un gran bel fondoschiena.
Ebbene sì, signori miei, il mio primo impatto con la classe "maschio italico" è sempre il suo sguardo insistente su quella "qualità" (a meno che non mi metto un bel burka) della quale io non ho nessun merito; nonostante il mio quoziente intellettivo, la mia cultura, la mia ironia, eccetera... ho un bel affannarmi a parlar di politica, a ricostruire le tappe del disfacimento etico della nostra attuale società, a discutere dei massimi sistemi, di pensioni, di Mozart, di cuneo fiscale, di travi in precompresso... La replica , nel migliore dei casi, è sempre "pure intelligente..." e sorrisino, nel peggiore uno sbadiglio.
E io penso: ma davvero sono così poveri di spirito? Poveri di argomenti con l’altro sesso? Assolutamente incapaci di confrontarsi su altri terreni che non siano quelli delle schermaglie sessuali? o anche amorose? In ogni caso la mia idea è, tranne qualche valida eccezione, "penso di te che sei solo uno scemo" e dio solo sa quanto vorrei essere smentita, visti i problemi che vivo. So anche che chi legge questa mail, se è un uomo, ha già alzato il ciglio. Potrei metterci la mano sul fuoco, così come lui poserebbe felice la mano su un mio gluteo. Scusatemi se sono sfrontata.
Allora io mi chiedo, cosa dovremmo fare noi mamme italiane con questi ragazzini maschi? perché il problema sono fondamentalmente loro; annegarli da piccoli? buttarli giù dalla rupe tarpea della selezione intellettuale? fargli sistemare la cameretta già a 8 anni così da capire che la parola "maschio" andrebbe sostituita con quella di "persona"?
Delle donne italiane caro signore, mi preoccuperei di meno. Le statistiche le danno sempre più brave nei risultati a scuola, sempre più agguerrite, più flessibili, più forti, forse sempre meno fornite di scrupoli... ma lei mi insegna: in una giungla di uomini davvero poco evoluti almeno tentano di ottenere qualcosa sfruttando le armi che rimangono loro. Quasi tutte le signorine svestite sono ben più consapevoli di quello che fanno , sicuramente il doppio anche del preparato professore che fa zapping in tv e si sofferma ad ammirarle. "Che male c’è?", direbbe la ragazza, ma anche il professore.
Ovviamente ho esagerato, ovviamente sono d’accordo con lei nel giudicare davvero orrendo, mortificante dell’intelligenza umana, un tale costume, un tale andazzo... ma toglierei da parte sua l’accento solo sulle donne e lo sposterei su ragioni e cause ben più complesse e variegate.
Lo sposterei sulla totale deriva di tutti i media italiani. Lasciamo perdere la tv, sulla quale si aprirebbe il baratro da lei già prospettato, ma, se lei si connette con la home page di un qualunque quotidiano sul web, a partire anche da Repubblica, troverà sempre una bella ragazza, possibilmente svestita, ben in vista. Immagino anche chi le sceglie tali foto: si tratterà di un solerte giornalista... di sesso maschile, al quale la redazione avrà detto "una bella fighetta ci sta benissimo, attira l’attenzione"; ancora troppo sfrontata? Del resto in Italia i giornali non fanno giornalismo, fanno mercato, e la domanda di tette e fondoschiena in vista è altissima.
Qua, caro signor Michaels, si tratta di vendere. Mica roba da poco. E gli uomini sono davvero come i bimbi mi sa, sembra un luogo comune e mi vergogno quasi a scriverlo. Del resto in Francia ha destato scalpore il servizio realizzato su una rivista di moda su una brava donna politica. Siamo alle solite: è più facile il compartimento stagno della bella/elegante/scema e brutta/malvestita/autorevole ergo intelligente. Bambini, indubbiamente. La complessità, signori miei è sempre più bandita, è sempre più difficile da accettare, da comunicare, da vendere.
Se io vado in cantiere con i tacchi a spillo attiro l’attenzione... non perché vado contro il decreto sulla 494, ma perché ho pur sempre una bella caviglia... e mi sogno di poter essere presa sul serio nel dare indicazioni sull’impianto elettrico. Se dico queste cose ad un uomo, o affronto un discorso del genere il meno che mi replica, è già successo del resto, è "cavolo quanto sei acida". Ma io non sono acida, sono peggio: furiosa. E a quel punto sapete come diventerei? petulante e nevrotica.. o meglio... magari oggi ho il ciclo. E festa finita.
* la Repubblica, 17 luglio 2007
-
-
-
> ISLAM, DONNE E UOMINI: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla solo di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls24 luglio 2007, di Federico La Sala
PIANETA ISLAM
Perché l’islam potrebbe non aprirsi al «moderno»
di Samir Khalil Samir (Avvenire, 24.07.2007)
Il 12 luglio si è tenuto al Senato di Parigi, su iniziativa di quattro gruppi senatoriali, un convegno intitolato «Europa-Oriente: dialogo con l’islam», sotto il patrocinio del presidente del Senato. Cinque temi erano affrontati, ognuno con tre interventi di 15 minuti e un dibattito con la sala (circa 300 persone): Corano, islam e modernità; esegesi islamica; cristiani in Paesi musulmani; islam ed Europa; pluralismo e democrazia. Gli intervenenti erano studiosi francesi, musulmani e no, tunisini, siriani, libanesi ed egiziani. Un convegno denso, ricchissimo, che ha aperto tante piste di ricerca da approfondire. Vorrei fermarmi sull’intervento di Abdel Majid Charfi (Tunisi) intitolato: «L’islam è compatibile con la modernità?». L’autore, emerito, è stato professore di civiltà araba e del pensiero islamico, decano della facoltà di Lettere e titolare della cattedra Unesco delle religioni comparate. È membro di vari comitati di redazione di riviste accademiche. A questa domanda sono tre le risposte possibili.
La prima, categorica, è quella di Bernard Lewis ed altri: contrariamente al cristianesimo e all’ebraismo, l’islam è assolutamente incompatibile con la modernità, tenuto conto della sua natura beduina, fatalista, bellicosa. Questa posizione si ritrova con quella degli islamisti per i quali la modernità è il male assoluto (depravazione etica, edonismo, materialismo) che si deve combattere con tutti i mezzi per conservare la purezza dell’islam. Questa posizione, in contraddizione con i dati storici, è diffusa sia in Occidente sia nella letteratura islamista e le tv arabe finanziate dalla penisola arabica. La seconda è quella dei riformisti salafiti della fine dell’Ottocento: la modernità ha degli aspetti positivi che i musulmani devono acquistare, e degli aspetti negativi, in particolare materialismo ed immoralità. Loro non vedono la radicalità dei cambiamenti intervenuti sotto l’effetto della modernità, né la relazione tra i fondamenti filosofici della modernità e le realizzazioni materiali che ne derivano. Pensano che basta tornare ai «pii anziani» (salaf) per conquistare il mondo come nel settimo secolo. Questa posizione è stata scartata sia dai movimenti nazionalisti che da quelli islamisti, in particolare dai Fratelli Musulmani nati in Egitto nel 1928.
Queste due posizioni sono sorpassate. Le difficoltà originate dall’interpretazione dell’islam sono aumentate a causa del ritardo storico delle società musulmane in tutti i settori della vita. La secolarizzazione effettiva delle coscienze e delle istituzioni, la tendenza all’individualismo, la crisi dei valori ereditati, sono altrettanti segni del crescente problema. In questo contesto la religione fornisce dei riferimenti e delle strutture di sociabilità che tranquillizzano.
La terza è una riflessione che mira a liberare le menti dal dogmatismo e a promuovere un pensiero libero e responsabile, mentre l’integralismo invadente propone delle risposte prefabbricate ed è incoraggiato dai Paesi petroliferi. L’insufficienza della riflessione ha varie cause.
La prima è la situazione internazionale. È inutile fare appello alla ragione, quando le masse musulmane si sentono umiliate dall’occupazione dei loro territori, in particolare in Palestina e nell’Iraq. Quest’occupazione esaspera il ripiegamento identitario e l’attaccamento ai simboli religiosi (hijab, barba).
La seconda riguarda i regimi politici arabi autocratici e dispotici, i quali ricorrono alla religione per legittimare le loro posizioni.
La terza: il livello bassissimo dei programmi scolastici, basati sulla memoria e la ripetizione, senza spirito critico né riflessione.
La quarta: la situazione della donna musulmana mantenuta in uno stato d’inferiorità giuridica: poligamia, ripudio, matrimonio forzato, imposizione del velo, disuguaglianza nell’eredità sono piaghe del sistema islamico.
La quinta: la struttura patriarcale delle società islamiche tradizionali è causa di molti guai. Ma per cambiarla ci vuole la scienza, la tecnica e l’industrializzazione, e più ancora la diffusione dei valori dei diritti umani. Paradossalmente, la ricchezza petrolifera, lungi da risolvere i problemi, li ha solo nascosti.
Sesta e ultima causa: la modernità materiale può coesistere con il pensiero religioso tradizionale. Perciò occorrono sia il rinnovo del pensiero religioso sia la modernità materiale. La globalizzazione sta diffondendo in modo insensibile l’emergenza di una società secolarizzata, con una reazione religiosa identitaria per resisterle. Speriamo che quest’analisi aiuti gli uni e gli altri ad agire per armonizzare islam e modernità.
-
> ISLAM, DONNE E UOMINI: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla solo di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls27 luglio 2007, di Federico La Sala
Un appello contro le liste di proscrizione di Magdi Allam
Appello publicato dalla rivista Reset
Senza entrare nel merito delle accuse specifiche rivolte nell’ultimo libro di Magdi Allam a singoli colleghi noti a chiunque si interessi di questioni relative al Medio Oriente e all’islam non solo come ricercatori seri e qualificati, ma persino come persone coinvolte in svariate forme di impegno civile, intendiamo pro testare fermamente davanti alla sfrontatezza di chi afferma che le università italiane «pullulano» di docenti «collusi con un’ideologia di morte profondamente ostile ai valori e ai principi della civiltà occidentale e all’essenza stessa della nostra umanità».
Ci pare davvero eccessivo che quanti, in sede di dibattito scientifico e civico, esprimono posizioni differenti da una pretesa unica «verità interpretativa» divengano automaticamente estranei a universali valori di civiltà o, addirittura, alieni dalla comune umanità. Una tale impostazione non solo è lontanissima dallo spirito e dai valori di una democrazia costituzionale - e molto più in linea con ideologie totalitarie - ma si pone anche a siderale distanza dal senso critico che sta alla base della ricerca storica e scientifica e dalla stessa, difficile ma essenziale, missione dell’informazione giornalistica in una società plurale. Tutto ciò rischia di contribuire, purtroppo, al preoccupante imbarbarimento dell’informazione in un paese come il nostro che già si trova a pagare un prezzo troppo alto alle varie forme di partigianeria che lo travagliano. Già abbiamo visto sentenze discutibili coinvolgere colleghi noti per la loro serietà ed equilibrio nell’affrontare il tema dell’islam, con addirittura condanne penali che prevedono la pena detentiva.
Il giornalismo rischia di cadere in una logica da tifo calcistico piuttosto che analitica e razionale, soprattutto quando si toccano temi delicati e sensibili come quelli religiosi e, in particolare, relativi all’islam ed alle questioni legate all’ area medio-orientale. La libertà di ricerca ne paga il prezzo, schiacciata tra opposti estremismi interpretativi, e non solo. Ci auguriamo che tali tendenze trovino presto voci più equilibrate e meno partigiane a contrastarle, e che queste trovino a loro volta ascolto nel mondo dell’informazione, in quello politico, in quello culturale e in quello religioso.
Le adesioni
 Paolo Branca
Paolo Branca
 David Bidussa
David Bidussa
 Giancarlo Bosetti
Giancarlo Bosetti
 Enzo Bianchi
Enzo Bianchi
 Gadi Luzzatto Voghera
Gadi Luzzatto Voghera
 Angelo d’Orsi
Angelo d’Orsi
 Paolo De Benedetti
Paolo De Benedetti
 Nasr Hamid Abu Zayd
Nasr Hamid Abu Zayd
 Nina zu Fürstenberg
Nina zu Fürstenberg
 Giovanni Miccoli
Giovanni Miccoli
 Marco Varvello
Marco Varvello
 Alberto Melloni
Alberto Melloni
 Agostino Giovagnoli
Agostino Giovagnoli
 Ombretta Fumagalli Carulli
Ombretta Fumagalli Carulli
 Patrizia Valduga
Patrizia Valduga
 Michelguglielmo Torri
Michelguglielmo Torri
 Pippo Ranci Ortigosa
Pippo Ranci Ortigosa
 Anna Bozzo
Anna Bozzo
 Dario Miccoli
Dario Miccoli
 Isabella Camera D’Aff l i t t o
Isabella Camera D’Aff l i t t o
 Francesca Corrao
Francesca Corrao
 Ugo Fabietti
Ugo Fabietti
 Brunello Mantelli
Brunello Mantelli
 Sumaya Abdel Qader
Sumaya Abdel Qader
 Diego Abenante
Diego Abenante
 Giorgio Acquaviva
Giorgio Acquaviva
 Roberta Adesso
Roberta Adesso
 Claudia Alberico
Claudia Alberico
 Marco Allegra
Marco Allegra
 Massimo Alone
Massimo Alone
 Daniela Amaldi
Daniela Amaldi
 Maurizio Ambrosini
Maurizio Ambrosini
 Sara Amighetti
Sara Amighetti
 Lubna Ammoune
Lubna Ammoune
 Michael Andenna
Michael Andenna
 Giancarlo Andenna
Giancarlo Andenna
 Carlo Annoni
Carlo Annoni
 Caterina Arcidiacono
Caterina Arcidiacono
 Barbara Armani
Barbara Armani
 Monica Bacis
Monica Bacis
 Pier Luigi Baldi
Pier Luigi Baldi
 Anna Baldinetti
Anna Baldinetti
 Giorgio Banti
Giorgio Banti
 Gianpaolo Barbetta
Gianpaolo Barbetta
 Roberto Baroni
Roberto Baroni
 Elena Lea Bartolini
Elena Lea Bartolini
 Annalisa Belloni
Annalisa Belloni
 Giovanni Bensi
Giovanni Bensi
 Michele Bernardini
Michele Bernardini
 Giovanni Bernardini
Giovanni Bernardini
 Francesca Biancani
Francesca Biancani
 Giovanna Biffino Galimbert i
Giovanna Biffino Galimbert i
 Valentino Bobbio
Valentino Bobbio
 Giuliana Borello
Giuliana Borello
 Franco Brambilla
Franco Brambilla
 Daniela Bredi
Daniela Bredi
 Alberto Burgio
Alberto Burgio
 Paola Busnelli
Paola Busnelli
 Maria Agostina Cabiddu
Maria Agostina Cabiddu
 Fabio Caiani
Fabio Caiani
 Alfredo Canavero
Alfredo Canavero
 Paolo Cantù
Paolo Cantù
 Fanny Cappello
Fanny Cappello
 Franco Cardini
Franco Cardini
 Paola Caridi
Paola Caridi
 Lorenzo Casini
Lorenzo Casini
 Fabrizio Cassinelli
Fabrizio Cassinelli
 Paolo Ceriani
Paolo Ceriani
 Maria Vittoria Cerutti
Maria Vittoria Cerutti
 Francesco Cesarini
Francesco Cesarini
 Michelangelo Chasseur
Michelangelo Chasseur
 Antonio Chizzoniti
Antonio Chizzoniti
 Franca Ciccolo
Franca Ciccolo
 Cornelia Cogrossi
Cornelia Cogrossi
 Chiara Colombo
Chiara Colombo
 Annamaria Colombo
Annamaria Colombo
 Silvia Maria Colombo
Silvia Maria Colombo
 Alessandra Consolaro
Alessandra Consolaro
 Giancarlo Costadoni
Giancarlo Costadoni
 Antonio Cuciniello
Antonio Cuciniello
 Giovanni Curatola
Giovanni Curatola
 Irene Cusmà
Irene Cusmà
 Cinzia Dal Maso
Cinzia Dal Maso
 Monia D’Amico
Monia D’Amico
 Laura Davì
Laura Davì
 Francesco D’Ayala
Francesco D’Ayala
 Fulvia De Feo
Fulvia De Feo
 Fulvio De Giorgi
Fulvio De Giorgi
 Paolo di Giannatonio
Paolo di Giannatonio
 Miriam Di Paola
Miriam Di Paola
 Rosita Di Peri
Rosita Di Peri
 Maria Donzelli
Maria Donzelli
 Camille Eid
Camille Eid
 Fabrizio Eva
Fabrizio Eva
 Guido Federzoni
Guido Federzoni
 Alessandro Ferrari
Alessandro Ferrari
 Valeria Ferraro
Valeria Ferraro
 Nicola Fiorita
Nicola Fiorita
 Francesca Flores d’Arcais
Francesca Flores d’Arcais
 Filippo Focardi
Filippo Focardi
 Daniele Foraboschi
Daniele Foraboschi
 Guido Formigoni
Guido Formigoni
 Ersilia Francesca
Ersilia Francesca
 Annalisa Frisina
Annalisa Frisina
 Carlo Galimberti
Carlo Galimberti
 Enrico Galoppini
Laura Galuppo
Enrico Galoppini
Laura Galuppo
 Antonella Ghersetti
Antonella Ghersetti
 Mauro Giani
Mauro Giani
 Aldo Giannuli
Aldo Giannuli
 Manuela Giolfo
Manuela Giolfo
 Fabio Giomi
Fabio Giomi
 Emanuele Giordana
Emanuele Giordana
 Demetrio Giordani
Demetrio Giordani
 Gianfranco Girando
Gianfranco Girando
 Elisa Giunghi
Elisa Giunghi
 Carlo Giunipero
Carlo Giunipero
 Anna Granata
Anna Granata
 Francesco Grande
Francesco Grande
 Fabio Grassi
Fabio Grassi
 Maria Grazia Grillo
Maria Grazia Grillo
 Laura Guazzone
Laura Guazzone
 Rachida Hamdi
Rachida Hamdi
 Abdelkarim Hannachi
Abdelkarim Hannachi
 Ali Hassoun
Ali Hassoun
 Alexander Hobel
Alexander Hobel
 Giuseppina Igonetti
Giuseppina Igonetti
 Virgilio Ilari
Virgilio Ilari
 Massimo Jevolella
Massimo Jevolella
 Massimo Khairallah
Massimo Khairallah
 Chiara Lainati
Chiara Lainati
 Giuliano Lancioni
Giuliano Lancioni
 Filippo Landi
Filippo Landi
 Angela Lano
Angela Lano
 Clemente Lanzetti
Clemente Lanzetti
 Paolo La Spisa
Paolo La Spisa
 Raffaele Liucci
Raffaele Liucci
 Claudio Lojacono
Claudio Lojacono
 Silvia Lusuardi Siena
Silvia Lusuardi Siena
 Monica Macchi
Monica Macchi
 Paolo Maria Maggiolini
Paolo Maria Maggiolini
 Paolo Magnone
Paolo Magnone
 Roberto Maiocchi
Roberto Maiocchi
 Diego Maiorano
Diego Maiorano
 Gabriele Mandel Khan
Gabriele Mandel Khan
 Patrizia Manduchi
Patrizia Manduchi
 Ermete Mariani
Ermete Mariani
 Annamaria Martelli
Annamaria Martelli
 Paola Martino
Paola Martino
 Elisabetta Matelli
Elisabetta Matelli
 Vincenzo Matera
Vincenzo Matera
 Gabriella Mazzola Nangeroni
Gabriella Mazzola Nangeroni
 Carlo Maria Mazzucchi
Carlo Maria Mazzucchi
 Alessandro Mengozzi
Alessandro Mengozzi
 Alvise Merini
Alvise Merini
 Saber Mhadhbi
Saber Mhadhbi
 Ferruccio Milanesi
Ferruccio Milanesi
 Stefano Minetti
Stefano Minetti
 Marco Mozzati
Marco Mozzati
 Vincenzo Mungo
Vincenzo Mungo
 Beniamino Natale
Beniamino Natale
 Enrica Neri
Enrica Neri
 Sergio Paiardi
Sergio Paiardi
 Francesco Pallante
Francesco Pallante
 Monica Palmeri
Monica Palmeri
 Simona Palmeri
Simona Palmeri
 Maria Elena Paniconi
Maria Elena Paniconi
 Irene Panozzo
Irene Panozzo
 Michele Papasso
Michele Papasso
 Daniela Fernanda Parisi
Daniela Fernanda Parisi
 Antonio Pe
Antonio Pe
 Fausto Pellegrini
Fausto Pellegrini
 Claudia Perassi
Claudia Perassi
 Alessio Persic
Alessio Persic
 Marta Petricioli
Marta Petricioli
 Martino Pillitteri
Martino Pillitteri
 Daniela Pioppi
Daniela Pioppi
 Paola Pizzo
Paola Pizzo
 Alessandro Politi
Alessandro Politi
 Paola Pontani
Paola Pontani
 Antonietta Porro
Antonietta Porro
 Gianluca Potestà
Gianluca Potestà
 Rossella Prandi
Rossella Prandi
 Elena Raponi
Elena Raponi
 Savina Raynaud
Savina Raynaud
 Riccardo Redaelli
Riccardo Redaelli
 Giuseppe Restifo
Giuseppe Restifo
 Michele Riccardi
Michele Riccardi
 Franco Riva
Franco Riva
 Marco Rizzi
Marco Rizzi
 Maria Adele Roggero
Maria Adele Roggero
 Maria Pia Rossignani
Maria Pia Rossignani
 Ornella Rota
Ornella Rota
 Monica Ruocco
Monica Ruocco
 Rassmeya Salah
Rassmeya Salah
 Ruba Salih
Ruba Salih
 Brunetto Salvarani
Brunetto Salvarani
 Giovanni Sambo
Giovanni Sambo
 Marco Sannazaro
Marco Sannazaro
 Paolo Santachiara
Paolo Santachiara
 Milena Santerini
Milena Santerini
 Maria Elena Santomauro
Maria Elena Santomauro
 Cinzia Santomauro
Cinzia Santomauro
 Giovanni Sarubbi
Giovanni Sarubbi
 Federico Ali Schuetz
Federico Ali Schuetz
 Giovanni Scirocco
Giovanni Scirocco
 Deborah Scolart
Deborah Scolart
 Lucia Sgueglia
Lucia Sgueglia
 Ritvan Shehi
Ritvan Shehi
 Rita Sidoli
Rita Sidoli
 Stefano Simonetta
Stefano Simonetta
 Piergiorgio Simonetta
Piergiorgio Simonetta
 Lucia Sorbera
Lucia Sorbera
 Carlo Spagnolo
Carlo Spagnolo
 Salvatore Speziale
Salvatore Speziale
 Stefania Stafutti
Stefania Stafutti
 Oriella Stamerra
Oriella Stamerra
 Giovanna Stasolla
Giovanna Stasolla
 Piero Stefani
Piero Stefani
 Alessandra Tarabochia
Alessandra Tarabochia
 Dario Tarantini
Dario Tarantini
 Maurizio Tarocchi
Maurizio Tarocchi
 Andrea Teti
Andrea Teti
 Massimiliano Trentin
Massimiliano Trentin
 Emanuela Trevisan Semi
Emanuela Trevisan Semi
 Lorenzo Trombetta
Lorenzo Trombetta
 Michele Vallaro
Michele Vallaro
 Marisa Verna
Marisa Verna
 Marco Francesco Veronesi
Marco Francesco Veronesi
 Fabrizio Vielmini
Fabrizio Vielmini
 Edoardo Villata
Edoardo Villata
 Franco Zallio
Franco Zallio
 Patrizia Zanelli
Patrizia Zanelli
 Francesco Zappa
Francesco Zappa
 Luciano Zappella
Luciano Zappella
 Boghhos Levon Zekiyan
Boghhos Levon Zekiyan
 Ida Zilio Grandi
Ida Zilio Grandi
 Raffaello Zini
Raffaello Zini-
> ISLAM, DONNE E UOMINI: "DARABA". LALEH BAKHTIAR TRADUCE IL CORANO E SPOSTA LE MONTAGNE DEL SIGNIFICATO. Mentre il cattolicesimo-romano parla solo di "caro prezzo" (=caritas), il mondo islamico ri-scopre l’amore (= charitas) della Parola e illumina il mondo - a cura di pfls22 febbraio 2009, di Nour Eddine Khaidoune-EducatoreCammino solitario e muto,con ilcuore stretto,perché provo disgusto, di questa complessità del mondo, di questo rumore sordo. Tutto si confonde, stampa, sondaggi, notizie e sfide, e come possono testimoniare? Quando tutti sembrano sapere. Allora continuate et fate pure, ma senza essere come i camerieri. Leggo i giornali ogni giorno, sempre una storia di un barbaro Caino,molte crudele e inumano. C’e anche un biglietto falso di condoglianze,ma chiedo qual è la differenza?. Io, ho stretto il mio pugno, contro questi millantatori che non mancano, parlavano e parlano. Altri giocano all’assassino.Ma io, non sono cretino come quell’uomo. Il buon nemico, fianco a fianco,la polarizzazione di odio reciproco, il paradosso del linguaggio mediatico,disperato e tragico.Come lo sapete, c’e un divorzio fra memoria e storia, e ogni razza è degna della sua gloria. E alla gente piace mangiare la gente.Si, lo slogan è efficace e purtoppo vero, ahimé! Cosa dire l’uomo del suo futuro?
-
-
-