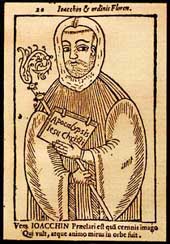
"IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. Un discorso pronunciato presso la cattedrale di Notre-Dame a Parigi l’8.3.2009 - a cura di Federico La Sala
- [...] mano a mano che la percezione dell’economia della salvezza nel tempo storico si appanna nella Chiesa, si vede l’economia stendere il proprio dominio cieco e derisorio su tutti gli aspetti della vita sociale. Allo stesso tempo, l’esigenza escatologica che la Chiesa ha trascurato ritorna sotto una forma secolarizzata e parodistica nei saperi profani, che sembrano fare a gara per profetizzare in tutti i campi delle catastrofi irreversibili. Lo stato di crisi e d’emergenza permanente che i governi del mondo proclamano oggi è proprio la parodia secolarizzata del perpetuo aggiornamento del giudizio ultimo nella storia della Chiesa.
 All’eclissi dell’esperienza messianica del compimento della legge e del tempo corrisponde un’ipertrofia inaudita del diritto, che pretende di legiferare su tutto, ma che tradisce con un eccesso di legalità la perdita di ogni vera legittimità. Qui e ora affermo, misurando le parole: oggi sulla terra non vi è più alcun potere legittimo, e i potenti del mondo stessi sono tutti rei di illegittimità [...]
All’eclissi dell’esperienza messianica del compimento della legge e del tempo corrisponde un’ipertrofia inaudita del diritto, che pretende di legiferare su tutto, ma che tradisce con un eccesso di legalità la perdita di ogni vera legittimità. Qui e ora affermo, misurando le parole: oggi sulla terra non vi è più alcun potere legittimo, e i potenti del mondo stessi sono tutti rei di illegittimità [...]
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Chiesa e secolarizzazione
La vocazione messianica
di Giorgio Agamben *
L’ indirizzo di saluto di uno dei testi più antichi della Tradizione ecclesiale, la Lettera ai Corinzi di Clemente, comincia con queste parole: «La Chiesa di Dio che si trova a Roma alla Chiesa di Dio che si trova a Corinto». La parola greca paroikousa, (tradotta nell’originale francese «en séjour», letteralmente «in soggiorno », e resa nella versione corrente italiana con «che si trova»; ndt) indica il soggiorno dell’esilio, del colono o dello straniero, in contrapposizione al dimorare del cittadino, che si dice in greco katoikein. Paroikein, vivere in esilio, definisce sia l’abitare del cristiano nel mondo sia la sua esperienza del tempo messianico.
È un termine tecnico, o quasi tecnico, poiché la Prima lettera di Pietro (1,17) chiama il tempo della Chiesa ho chronos tes paroikias: il tempo della parrocchia, si potrebbe tradurre, purché ci si ricordi che parrocchia qui significa «soggiorno da straniero».
Il termine «soggiorno» non dice nulla riguardo alla durata cronologica. Il soggiorno della Chiesa sulla terra può durare - e di fatto è durato - secoli e millenni, senza che ciò cambi alcunché della speciale natura della sua esperienza messianica del tempo. Ci tengo a sottolineare ciò, contro un’opinione spesso ripresa dai teologi, a riguardo del preteso «ritardo della parusia».
Secondo questa opinione, che mi è sempre sembrata quasi blasfema, quando la comunità cristiana delle origini, che attendeva il ritorno del Messia e la fine dei tempi considerandoli imminenti, si è resa conto che vi era un ritardo di cui non si vedeva la fine, avrebbe allora cambiato orientamento per darsi un’organizzazione istituzionale e giuridica stabile. Ossia avrebbe smesso di essere paroikein, di soggiornare da straniero, e si sarebbe disposta a katoikein, a dimorare da cittadino, come tutte le altre istituzioni di questo mondo.
L’esperienza del tempo messianico
Se fosse vero, ciò implicherebbe che la Chiesa avrebbe perduto l’esperienza del tempo messianico che le è consustanziale. Il tempo del Messia, come vedremo, non è un periodo cronologico, ma innanzitutto una trasformazione qualitativa del tempo vissuto. E in questo tempo qualcosa come un ritardo cronologico - come si dice di un treno che è in ritardo - non è nemmeno concepibile. Esattamente come l’esperienza del tempo messianico è tale per cui è impossibile dimorarvi, così qualcosa come un ritardo non si può produrre. È ciò che Paolo ricorda ai tessalonicesi: «Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore viene come un ladro di notte» (1 Ts 5,1-2).
«Venire (erchetai)» è al presente, proprio come il Messia è chiamato nei Vangeli ho erchomenos, colui che viene, che non cessa di venire. Un filosofo del XX secolo, che aveva ascoltato la lezione di Paolo, lo ripete a suo modo: «Ogni istante è la porta stretta attraverso la quale può passare il Messia» (W. Benjamin).
È dunque della struttura di questo tempo, che è il tempo del Messia come lo descrive Paolo, che vorrei trattare. Un primo malinteso che occorre evitare a questo riguardo è quello di confondere il tempo e il messaggio messianici con il tempo e il messaggio apocalittici.
L’apocalittica si situa nell’ultimo giorno, il giorno della collera: vede la fine dei tempi e descrive ciò che vede. Il tempo che vide l’Apostolo, al contrario, non è la fine dei tempi. Se si volesse esprimere con una formula la differenza fra il messianico e l’apocalittico, si dovrebbe dire che il messianico non è la fine dei tempi, ma il tempo della fine.
Messianico non è la fine dei tempi, ma la relazione di ogni istante, di ogni kairos, con la fine dei tempi e con l’eternità. Così ciò che interessa Paolo non è l’ultimo giorno, l’istante nel quale il tempo finisce, ma il tempo che si contrae e che comincia a finire. O, se si preferisce, il tempo che resta fra il tempo e la sua fine.
Una trasformazione radicale dell’esistenza
La Tradizione giudaica conosceva la distinzione tra due tempi o due mondi: l’olam hazzeh, ossia il tempo che va dalla creazione del mondo sino alla sua fine, e l’olam habba, il tempo che viene dopo la fine del mondo. Questi due termini, nella loro traduzione greca, sono presenti nel testo delle epistole: ma il tempo messianico, il tempo che l’Apostolo visse e il solo che gli interessa, non è né l’olam hazzeh né l’olam habba: è il tempo che resta fra questi due tempi, quando si verifica nel tempo la cesura dell’avvenimento messianico (il quale, per Paolo, è la risurrezione).
Come possiamo rappresentarci questo tempo? In apparenza, se lo si trasferisce come si fa in geometria con un segmento su una linea, la definizione che ho dato ora - il tempo che resta fra la risurrezione e la fine del tempo - non pone difficoltà. Ma è tutt’altra cosa se lo si cerca di pensare sul piano dell’esperienza del tempo che questo implica. Va da sé infatti che vivere nel «tempo che resta» o vivere il «tempo della fine» non possono che significare una trasformazione radicale dell’esperienza e anche della rappresentazione abituali del tempo.
Non è più la linea omogenea e infinita del tempo cronologico profano (rappresentabile ma vuoto di qualunque esperienza), né l’istante puntuale e altrettanto impensabile della sua fine. Ma non è nemmeno un semplice segmento prelevato sul tempo cronologico e che andrebbe dalla risurrezione alla fine del tempo.
È un tempo che pulsa all’interno del tempo cronologico, che lo lavora e lo trasforma dall’interno. È, da una parte, il tempo che il tempo impiega per finire, dall’altra il tempo che ci resta, il tempo di cui abbiamo bisogno per fare finire il tempo, per giungere alla meta, per liberarci della nostra rappresentazione ordinaria del tempo.
Mentre quest’ultima, in quanto tempo entro il quale crediamo di essere, ci separa da ciò che siamo e ci trasforma in spettatori impotenti di noi stessi, al contrario il tempo del Messia, in quanto tempo operativo (kairos) nel quale cogliamo per la prima volta il tempo (il chronos), è il tempo che noi stessi siamo. È chiaro che questo tempo non è un altro tempo, che avrebbe il suo luogo in un altrove improbabile e venturo. È, al contrario, il solo tempo reale, il solo tempo che abbiamo, e fare esperienza di questo tempo implica una trasformazione integrale di noi stessi e del nostro modo di vivere.
È ciò che Paolo dice in un passaggio straordinario, che è forse la più bella definizione che egli abbia dato della vita messianica: «Vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve (ho kairos synestalmenos esti: il verbo systello indica sia il fatto di calare le vele sia il modo in cui un animale si abbassa caricandosi per spiccare un salto); d’ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l’avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli che comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente» (1 Cor 7,29-31).
Qualche riga prima, Paolo aveva detto, a proposito della vocazione messianica: «Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato da schiavo? Non ti preoccupare; anche se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della tua condizione!» (1 Cor 7,20-21). Hos me, «come se non» ci dice ora che il senso ultimo della vocazione messianica è di essere la revoca di ogni vocazione. Proprio come il tempo messianico trasforma dall’interno il tempo cronologico, così la vocazione messianica, grazie a l’hos me, al «come se non», è la revoca di ogni vocazione, che cambia e vuota dall’interno ogni esperienza e ogni condizione fattuale per aprirle a un nuovo uso.
È un punto importante, poiché ci permette di pensare correttamente questa relazione fra le cose ultime e le cose penultime che definisce la condizione messianica.
Può un cristiano vivere soltanto di cose ultime? Un grande teologo protestante, Dietrich Bonhoeffer, ha denunciato la falsa alternativa fra radicalismo e compromesso, che parte per entrambi i casi dal separare nettamente le realtà ultime e le realtà penultime, quelle cioè che definiscono la nostra condizione sociale e umana di tutti i giorni. Ora, come il tempo messianico non è un altro tempo, ma una trasformazione del tempo cronologico, così vivere le cose ultime è prima di tutto vivere in modo altro le cose penultime.
La vera escatologia forse non è altro che la trasformazione dell’esperienza delle cose penultime. Poiché le realtà ultime hanno prima luogo dentro le penultime, queste - contro ogni radicalismo - non si possono semplicemente rifiutare; ma - per la stessa ragione, e contro ogni possibilità di compromesso - le cose penultime non si possono considerare come ultime. È con il verbo katargein che non vuol dire «distruggere», ma rendere inoperante, letteralmente «dis-operare» - che Paolo esprime la relazione fra ciò che è ultimo e ciò che non lo è. La realtà ultima disattiva, sospende e trasforma la realtà penultima, ma è tuttavia al suo interno che essa entra in gioco interamente.
Ciò permette di comprendere la situazione propria del Regno in Paolo. Al contrario della corrente rappresentazione escatologica, va ricordato che per lui il tempo del Messia non può essere un tempo futuro. L’espressione con la quale indica questo tempo è sempre «ho nyn kairos», il tempo dell’adesso. Come scrive in 2 Cor 6,2: «[Idou nyn] Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!».
Paroikia e parousia, soggiorno da straniero e presenza del Messia, hanno la stessa struttura che è espressa in greco con la preposizione para: quella di una presenza che distende il tempo, di un già che è anche un non ancora, di un ritardo che non è un rimando a più tardi, ma uno scarto e una disgiunzione all’interno del presente, che ci permette di cogliere il tempo.
Si vede bene dunque che l’esperienza di questo tempo non è qualcosa che la Chiesa possa scegliere di fare o di non fare. Non vi è Chiesa, se non in questo tempo e per mezzo di questo tempo.
La Chiesa e i segni dei tempi
Che ne è di questa esperienza del tempo del Messia, nella Chiesa di oggi? Infatti il riferimento alle cose ultime sembra a tal punto sparito dal discorso della Chiesa, che si è potuto dire non senza ironia che la Chiesa di Roma ha chiuso l’Ufficio escatologico. Ed è con un’ironia senza dubbio ancora più amara che un teologo francese ha potuto scrivere «si attendeva il Regno ed è arrivata la Chiesa». È un’immagine potente, sulla quale dovremmo riflettere.
Considerando quanto detto sopra sulla struttura del tempo messianico, è chiaro che non si tratta di rimproverare alla Chiesa il compromesso in nome del radicalismo. Non si tratta nemmeno, come ha fatto il più grande teologo ortodosso del XIX secolo, Fëdor Dostoevskyi, di presentare la Chiesa di Roma sotto la figura del Grande inquisitore. Si tratta di un’altra cosa, ossia della capacità della Chiesa di cogliere ciò che Matteo 16,3 chiama i segni dei tempi, ta semeia ton kairon.
Quali sono questi segni, che il Vangelo oppone al vano desiderio di interpretare l’aspetto del cielo? Se la storia è penultima in riferimento al Regno, questo - si è visto ha il suo luogo prima di tutto e sopra tutto nella storia. Vivere nel tempo del Messia esige dunque la capacità di leggere i segni della sua presenza nella storia, di riconoscere nel suo corso il sigillo dell’economia della salvezza. Agli occhi dei padri - ma anche per i filosofi che hanno riflettuto sulla filosofia della storia, che è e resta (anche in Marx) una disciplina essenzialmente cristiana - la storia si presentava come un campo di tensioni, percorso da due correnti opposte: la prima - che Paolo, in un celebre ed enigmatico passaggio della Seconda lettera ai Tessalonicesi, chiama to catechon - che ritiene e differisce senza sosta la fine del mondo lungo la linea del tempo cronologico, infinito e omogeneo; l’altra che, mettendo in tensione l’origine e la fine, non cessa di interrompere e portare a termine il tempo.
Chiamiamo legge o stato la prima polarità, votata all’economia, ossia al governo infinito del mondo; e chiamiamo Messia o Chiesa la seconda, la cui economia - l’economia della salvezza - è essenzialmente finita. Una comunità umana non può sopravvivere se queste due polarità non sono compresenti, se non esiste fra di esse una tensione e una relazione dialettica.
Ora, è esattamente questa tensione che oggi è spezzata. A mano a mano che la percezione dell’economia della salvezza nel tempo storico si appanna nella Chiesa, si vede l’economia stendere il proprio dominio cieco e derisorio su tutti gli aspetti della vita sociale. Allo stesso tempo, l’esigenza escatologica che la Chiesa ha trascurato ritorna sotto una forma secolarizzata e parodistica nei saperi profani, che sembrano fare a gara per profetizzare in tutti i campi delle catastrofi irreversibili. Lo stato di crisi e d’emergenza permanente che i governi del mondo proclamano oggi è proprio la parodia secolarizzata del perpetuo aggiornamento del giudizio ultimo nella storia della Chiesa.
All’eclissi dell’esperienza messianica del compimento della legge e del tempo corrisponde un’ipertrofia inaudita del diritto, che pretende di legiferare su tutto, ma che tradisce con un eccesso di legalità la perdita di ogni vera legittimità. Qui e ora affermo, misurando le parole: oggi sulla terra non vi è più alcun potere legittimo, e i potenti del mondo stessi sono tutti rei di illegittimità. La giuridicizzazione e l’economicizzazione integrale dei rapporti umani, la confusione fra ciò che possiamo credere, sperare, amare e ciò che siamo tenuti a fare o a non fare, dire o non dire segna non soltanto la crisi del diritto e degli stati, ma anche e soprattutto quella della Chiesa. Poiché la Chiesa non può vivere se non tenendosi, in quanto istituzione, in relazione immediata con la fine della Chiesa.
E - non bisogna dimenticarlo - nella teologia cristiana vi è una sola istituzione che non conoscerà la fine e il dissolvimento: ed è l’inferno. Qui si vede bene - mi sembra - che il modello della politica di oggi - che aspira a un’economia infinita del mondo - è propriamente infernale. E se la Chiesa spezza la sua relazione originale con la paroikia, essa non può che perdersi nel tempo.
Ecco perché la domanda che pongo, senza di certo avere alcuna autorità per farla se non quella di un’abitudine ostinata a leggere i segni dei tempi, si riassume in questa: si deciderà la Chiesa a cogliere la sua occasione storica e a riprendere la sua vocazione messianica? Poiché il rischio è che essa stessa sia trascinata nella rovina che minaccia tutti i governi e tutte le istituzioni della terra.
Giorgio Agamben
* Il contributo del filosofo Giorgio Agamben, docente di Filosofia teoretica all’Istituto universitario di architettura di Venezia, qui proposto in una nostra traduzione dal francese, è stato pronunciato presso la cattedrale di Notre-Dame a Parigi l’8.3.2009.
* Il Regno-attualità., n.22, 2009, pp.784-786
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
RIPARARE IL MONDO. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.
L’AMORE VINCE SEMPRE!!! BERLUSCONI, PAPA RATZINGER, E LA FINE DELLA TEOLOGIA POLITICA ’PAOLINA’.
FLS
Forum
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO": CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR HUGO, 1831).27 dicembre 2024, di Federico La Sala
CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR #HUGO, 1831):
MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO" (O, DIVERSAMENTE, L’INIZIO DEL "CONTRORINASCIMENTO").
- In memoria di #Michelangelo Buonarroti, Marcel #Proust, e Walter #Benjamin
L’ ARCHITETTURA E IL LIBRO: L’INVENZIONE DELLA #STAMPA. Victor Hugo, in "Notre-Dame de Paris 1482", pubblicato nel 1831, in poche pagine sottolinea tutta l’importanza dell’#apertura di infiniti occhi, connessa al grande "occhio" che si apre nel #cielo culturale dell’#Europa #moderna con la invenzione di Gutenberg.
Nel cap. II del L. VII dell’opera, Hugo così inizia:
- "Le nostre lettrici ci scuseranno se ci fermiamo un momento per cercare quale potesse essere il pensiero che si celava sotto le enigmatiche parole dell’arcidiacono: Questo ucciderà quello. Il libro ucciderà l’edificio. A nostro avviso, quel pensiero aveva due facce. Era innanzitutto un pensiero da prete. Era il terrore del sacerdozio di fronte ad un elemento nuovo, la stampa. Era lo spavento e lo sbalordimento dell’uomo del santuario di fronte al torchio luminoso di Gutenberg. Erano la cattedra ed il manoscritto, la parola parlata e la parola scritta, che si allarmavano per la parola stampata [...].
- In effetti, dall’origine delle cose fino al quindicesimo secolo dell’era cristiana compreso, l’architettura è il grande libro dell’umanità, l’espressione principale dell’uomo ai suoi diversi stadi di sviluppo, sia come forza che come intelligenza.
- [...] Così, fino a Gutenberg, l’architettura è la scrittura principale, la scrittura universale. [...]
- [...] a partire dalla scoperta della stampa [...] a partire dal sedicesimo secolo, la malattia dell’architettura è visibile; essa ormai non esprime più in modo essenziale la società; si fa miserevolmente arte classica [...].
- È proprio questa decadenza che prende il nome di Rinascimento. È questo tramonto che noi scambiamo per un’aurora [...]
- Michelangelo, che fin dal sedicesimo secolo aveva senz’altro avvertito la sua morte, aveva avuto un’ultima idea, un’idea dettata dalla disperazione. Questo titano dell’arte aveva eretto il Pantheon sul Partenone e aveva fatto San Pietro di Roma. Morto Michelangelo, che fa questa miserabile architettura che sopravviveva a se stessa allo stato di spettro e di ombra? Prende San Pietro di Roma, lo ricalca, ne fa la parodia. È una mania. È una cosa pietosa. Ogni secolo ha il suo San Pietro di Roma; nel diciassettesimo secolo il tempio di Val-de-Grâce, nel diciottesimo Sainte-Geneviève. Ogni paese ha il suo San Pietro di Roma. Londra ha il suo. Pietroburgo ha il suo. Parigi ne ha due o tre. Testamento insignificante, ultimo vaneggiamento di una grande arte decrepita che rimbambisce prima di morire." (V. Hugo, cit.).
- Nota: "Cupola di San Pietro".
- NOTE:
- PIANETATERRA: UN #PANTHEON DA RIPENSARE E IL #SOLSTIZIO D’#INVERNO. UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "#SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "#TERRA" ALLA #LUCE DEL #SOLE... In memoria di Andrea #Vesalio, Niccolò #Copernico, #Galileo #Galilei ....
- PER LA #PACEPERPETUA. ALLA #RICERCA DEL #TEMPO PERDUTO....
 MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...
"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".
MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...
"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- FRANCIA (CORSICA, AJACCIO 2024) E I MUTAMENTI EPOCALI: "Il Papa vede Macron, il presidente regala al Pontefice un libro su Notre Dame".17 dicembre 2024, di Federico La Sala
CULTURA E#SOCIETA’: FRANCIA (CORSICA, AJACCIO 2024) E I MUTAMENTI EPOCALI IN CORSO NELL’#EUROPA DEL XIX E DEL XXI SECOLO*.
A MARGINE DEGLI EVENTI, UNA PAGINA DAL #LIBRO DEL 1831 DI #VICTOR #HUGO, "#NOTRE DAME DE #PARIS 1482" (Libro V):
"CAPITOLO II.
QUESTO UCCIDERA’ QUELLO.
Le nostre lettrici ci scuseranno se ci fermiamo un momento per cercare quale potesse essere il pensiero che si celava sotto le enigmatiche parole dell’arcidiacono: Questo ucciderà quello. Il libro ucciderà l’edificio. A nostro avviso, quel pensiero aveva due facce. Era innanzitutto un pensiero da prete. Era il terrore del sacerdozio di fronte ad un elemento nuovo, la stampa. Era lo spavento e lo sbalordimento dell’uomo del santuario di fronte al torchio luminoso di Gutenberg. Erano la cattedra ed il manoscritto, la parola parlata e la parola scritta, che si allarmavano per la parola stampata; qualcosa di simile allo stupore di un passero che vedesse la Legione angelica aprire i suoi sei milioni di ali. Era il grido del profeta che sente già il rumore e l’agitazione dell’umanità emancipata, che vede un avvenire in cui l’intelligenza scalzerà la fede, l’opinione detronizzerà la credenza, il mondo scuoterà Roma. Pronostico del filosofo che vede il pensiero umano, volatilizzato dalla stampa, dileguarsi dal recipiente teocratico. Terrore del soldato che esamina l’ariete di bronzo e dice: «La torre crollerà». Ciò significava che una potenza stava per avvicendarsi ad un’altra potenza. Ciò voleva dire: «Il torchio ucciderà la chiesa». Ma sotto questo pensiero, senza dubbio il più immediato e il più semplice, ce n’era a nostro avviso un altro, più nuovo, un corollario del primo, meno facile da capire e più facile da contestare, un modo di vedere altrettanto filosofico, e non più soltanto del prete, ma del saggio e dell’artista. Era il presentimento che il pensiero umano, cambiando di forma, stesse per cambiare modo di esprimersi, che l’idea capitale di ogni generazione non si sarebbe scritta più con la medesima materia e nello stesso modo di prima, che il libro di pietra, così solido e così durevole, avrebbe fatto posto al libro di carta, ancora più solido e duraturo. Da questo punto di vista, la vaga formula dell’arcidiacono aveva un secondo senso; significava che un’arte stava per detronizzare un’altra arte. Voleva dire: «La stampa ucciderà l’architettura». In effetti, dall’origine delle cose fino al quindicesimo secolo dell’era cristiana compreso, l’architettura è il grande libro dell’umanità, l’espressione principale dell’uomo ai suoi diversi stadi di sviluppo, sia come forza che come intelligenza. [...]" (https://www.writingshome.com/ebook_files/230.pdf ).
- NOTA:
- #STORIA E #MITO. #DANTE, ERNST R. #CURTIUS E LA CRISI DELL’#EUROPA. Note per una riflessione storiografica.
- L’EUROPA IN CAMMINO. GIASONE, "L’OMBRA D’#ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI #LETARGO...
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- L’ENIGMA DEL DESTINO DELLA NECESSITA’ ("ANANKE"). IN MEMORIA DI VICTOR HUGO E DELLA SUA "NOTRE-DAME DE PARIS 1482".9 dicembre 2024, di Federico La Sala
IL "BATTESIMO" DEL "NATALE" E L’ENIGMA DEL DESTINO DELLA NECESSITA’ ("ANANKE"): "MA COSA HANNO SCRITTO SULLA TUA TESTA?!". UNA NOTA SUL PERCHE’ E’ NECESSARIO RILEGGERE IL "CORSO DI #LINGUISTICA GENERALE" (#SAUSSURE), RIPARTIRE DALLA #MEMORIA ERODOTEA DI #ISTIEO, E RIPORTARE #LACAN SULLA #DIRITTA VIA DI #FREUD E DI #DANTE ALIGHIERI. Una ipotesi di lavoro
IN #MEMORIA DI VICTOR HUGO E DELLA SUA "NOTRE-DAME DE PARIS 1482"
- Un omaggio a Gianfranco Ricci per la condivisione del suo testo sull’enigma del destino:
"L’ENIGMA DEL DESTINO. Lo storico Erodoto di Alicarnasso racconta nelle celebre opera “Storie” che nell’anno 499 a.C., Istieo, avventuriero e tiranno di Mileto, si trovava alla corte del re Dario I e non aveva modo di mettersi in contatto con il suo compatriota e tiranno della città Aristagora.
In quel tempo le città ioniche preparavano la grande ribellione contro il dominio persiano e Istieo voleva comunicargli che era il momento di dare il via alla sollevazione.
Alla fine ebbe un’idea: fece rasare la testa al suo schiavo più fedele e gli tatuò sul cuoio capelluto il messaggio che desiderava trasmettere, poi aspettò che i capelli ricrescessero, in modo da nascondere il messaggio.
Solo allora inviò lo schiavo a Mileto, dove gli rasarono nuovamente la testa e poterono leggere il messaggio. Il procedimento aveva diversi vantaggi, perché neppure il latore del messaggio ne conosceva il contenuto e pertanto non avrebbe potuto rivelarlo neanche se fosse stato sottoposto a interrogatorio o tortura.
Già Freud nello scritto “Isteria” (1888) aveva notato come i sintomi isterici seguissero una logica diversa da quella della mera anatomia. Tra il sintomo e la base organica non vi era un legame diretto, bensì l’emergere di una sorta di “dialetto”, di fenomeno linguistico.
Lacan porterà all’estremo la lettura freudiana, parlando di “crivellatura” del corpo per effetto del significante. Le parole, osserva Lacan, possono essere veri e propri “proiettili” che toccano, feriscono e perforano il corpo.
Abbiamo qui l’aspetto centrale della psicoanalisi: il rapporto fondamentale tra corpo e parola.
Il soggetto viene al mondo parlato dall’Altro, prima ancora di accedere direttamente al linguaggio.
Il primo significante che incontra è spesso il nome proprio, intraducibile per definizione, presente quindi nella sua dimensione di significante che si sgancia da ogni significato.
Tuttavia sappiamo bene che il significato è presente nel luogo dell’Altro e per questo può divenire come un “destino” per il soggetto che lo porta: il nome proprio può essere un destino.
Perché un certo nome? Perché non altri? Nel nostro nome e nelle parole che circolano nella nostra infanzia è evidente l’effetto di scrittura, di incisione che il significante opera su di noi.
Ciascuno di noi assomiglia quindi allo schiavo della storia di Erodoto: portiamo su di noi le tracce di un messaggio che non conosciamo e che ci resta enigmatico, misterioso, inaccessibile.
Compito dell’analisi è svelare questo messaggio inconscio: far emergere il discorso che l’Altro ha fatto per noi e su di noi, per assumere questo discorso e farlo nostro, riformularlo alla luce del nostro desiderio. [...]" (cit.).
- NOTE:
- PSICOANALISI E #STORIA: "L’ENIGMA DEL DESTINO" (Gianfranco Ricci - Psicologo)
- ANTROPOLOGIA E STORIA. #PianetaTerra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi...... LO SPIRITO CRITICO E L’ AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89)... "[...] Benché occasionali e velocissime, le riflessioni qui presentate questo tentano: fare luce sull’ombelico del sogno (#Freud) della ragione (#Hegel) del re (#Platone). Per tutti e per tutte, ciò che è in giuoco è proprio l’aprire gli occhi (nel doppio senso di nascere e conoscere) su quel crocevia di relazioni chiasmatiche da cui emergiamo, che ci costituiscono e strutturano, e che ci legano alla stessa realtà in cui viviamo - in grande e pericolosa ignoranza. [...]" (cit.).
- PSICOANALISI E #RELIGIONE: FREUD O JUNG? (EDWARD GLOVER, 1967). In memoria di Elvio #Fachinelli.
- ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA), NASCITA (#NATALE), E PRESEPE (#FRANCESCO D’#ASSISI, 1223). ALLA RICERCA DEL "TEMPO PERDUTO" (HERMANN #HELMHOLTZ - MARCEL #PROUST): QUALE IL #NOME DEL "FIGLIO DELL’#UOMO" E QUALE IL NOME DEL "FIGLIO DI #DIO"?! Evangelicamente, e filologicamente, #GIUSEPPE dà a suo Figlio, il NOME del Suo "Dio": #GESÙ ("Dio" salva), e Gesù rivela che il Nome del "Dio" di sua madre e di suo padre, di "Maria e Giuseppe", è "#Amore", con e al di là dell’#Eros e dell’#Agape, è - "teocriticamente" - #Charitas (1 Gv. 4.8).
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- LA "EDITIO PRINCEPS" (1472) DELLA "COMMEDIA" DI DANTE ALIGHIERI E LA "NOTRE-DAME DE PARIS 1482" DI VICTOR HUGO. (1831).30 novembre 2024, di Federico La Sala
STORIA #FILOSOFIA #LETTERATURA E #STORIOGRAFIA: DANTE ALIGHIERI.
Una nota a margine della presentazione sull’Editio Princeps della Commedia:
FILOLOGIA E #CRITICA. PARTIRE DALLA #DIVINA COMMEDIA DEL 1472, E’ PROPRIO UN BRILLANTE #SEGNAVIA DI RIFERIMENTO CHE SI "AGGANCIA" ALL’OPERA DI #VICTORHUGO, "NOTRE-DAME DE PARIS 1482" (PUBBLICATA NEL 1831) E ALLA RIAPERTURA DELLA CATTEDRALE DI NOTRE-DAME, L’#8DICEMBRE 2024, ED E’ ANCHE [UN GRANDE AUGURIO A TUTTA L’#EUROPA, AFFINCHE’ SIA CAPACE DI USCIRE DAL #LETARGO (Par. XXXIII, 94) E DALLA "#AIUOLA CHE CI FA TANTO FEROCI" (Par. XXII, 151) E SAPPIA RITROVARE LA #DIRITTA VIA DELLA ##PACE E DEL #RISPETTO CON TUTTE LE GENTI DEL #PIANETATERRA.
 NOTE:
NOTE:- MEMORIA STORIA E LETTERATURA: VICTOR HUGO,
 "ÉCRIT SUR UN EXEMPLAIRE DE LA «DIVINA COMMEDIA»": *
"ÉCRIT SUR UN EXEMPLAIRE DE LA «DIVINA COMMEDIA»": *
 Un soir, dans le chemin je vis passer un homme
Un soir, dans le chemin je vis passer un homme
 Vêtu d’un grand manteau comme un consul de Rome,
Vêtu d’un grand manteau comme un consul de Rome,
 Et qui me semblait noir sur la clarté des cieux.
Et qui me semblait noir sur la clarté des cieux.
 Ce passant s’arrêta, fixant sur moi ses yeux
Ce passant s’arrêta, fixant sur moi ses yeux
 Brillants, et si profonds qu’ils en étaient sauvages,
Brillants, et si profonds qu’ils en étaient sauvages,
 Et me dit : - J’ai d’abord été, dans les vieux âges,
Et me dit : - J’ai d’abord été, dans les vieux âges,
 Une haute montagne emplissant l’horizon ;
Une haute montagne emplissant l’horizon ;
 Puis, âme encore aveugle et brisant ma prison,
Puis, âme encore aveugle et brisant ma prison,
 Je montai d’un degré dans l’échelle des êtres,
Je montai d’un degré dans l’échelle des êtres,
 Je fus un chêne, et j’eus des autels et des prêtres,
Je fus un chêne, et j’eus des autels et des prêtres,
 Et je jetai des bruits étranges dans les airs ;
Et je jetai des bruits étranges dans les airs ;
 Puis je fus un lion rêvant dans les déserts,
Puis je fus un lion rêvant dans les déserts,
 Parlant à la nuit sombre avec sa voix grondante ;
Parlant à la nuit sombre avec sa voix grondante ;
 Maintenant, je suis homme, et je m’appelle Dante.
Maintenant, je suis homme, et je m’appelle Dante.
 Maintenant, je suis homme, et je m’appelle Dante.
Maintenant, je suis homme, et je m’appelle Dante.
 (Juillet 1843)
(Juillet 1843)
- STORIAELETTERATURA, TEOLOGIA-POLITICA E #STORIOGRAFIA: HUGO E DANTE. Nel libro quinto di "Nôtre-Dame de Paris 1482"), in due capitoli, viene affrontato il tema del crollo figurato e simbolico della cattedrale (e di ciò che essa ha rappresentato e rappresenta nella storia d’Europa).
 Se si contestualizza e si considera il rapporto tra il 1472 (la ripresa della lettura di Dante) e il 1453 (la presa di Costantinopoli da parte dei Turchi) e, in analogia, tra il 1482 (la ripresa della "lettura" della "Cattedrale" da parte di Hugo) e la Francia del 1831 all’indomani della Rivoluzione del 1830 (la Seconda rivoluzione francese, e la nascita della monarchia costituzionale), la lettura del primo capitolo del Libro V dell’opera, “Abbas beati Martini”, permette di capire non solo perché nel 1472 in Italia si riprende a leggere Dante (morto nel 1321), e, nel 1831, in Francia, Hugo sollecita a "rileggere" la "Notre-Dame de Paris 1482".
Se si contestualizza e si considera il rapporto tra il 1472 (la ripresa della lettura di Dante) e il 1453 (la presa di Costantinopoli da parte dei Turchi) e, in analogia, tra il 1482 (la ripresa della "lettura" della "Cattedrale" da parte di Hugo) e la Francia del 1831 all’indomani della Rivoluzione del 1830 (la Seconda rivoluzione francese, e la nascita della monarchia costituzionale), la lettura del primo capitolo del Libro V dell’opera, “Abbas beati Martini”, permette di capire non solo perché nel 1472 in Italia si riprende a leggere Dante (morto nel 1321), e, nel 1831, in Francia, Hugo sollecita a "rileggere" la "Notre-Dame de Paris 1482".
 La situazione storica, evidentemente, sollecita a interrogarsi sulle dinamiche tempestose in corso e a cercare di capire come procedere e affrontarle creativamente e, al tempo stesso, a rianalizzare in parallelo sia come la cultura italiana ha letto Dante a partire dal 1472 sia anche come lo stesso Hugo "legge" la "Cattedrale" di Dante, la "Divina Commedia": un nesso formidabile è data dalla citazione (nel primo cap. del L. V) dell’opera del teologo medioevale, #PierLombardo, che non a caso rimanda anche al giudizio critico di Dante, nella "Monarchia" (III. VII. 6), sulla posizione a favore delle pretese cosmoteandriche paoline del Papa "Cristo-Re".
La situazione storica, evidentemente, sollecita a interrogarsi sulle dinamiche tempestose in corso e a cercare di capire come procedere e affrontarle creativamente e, al tempo stesso, a rianalizzare in parallelo sia come la cultura italiana ha letto Dante a partire dal 1472 sia anche come lo stesso Hugo "legge" la "Cattedrale" di Dante, la "Divina Commedia": un nesso formidabile è data dalla citazione (nel primo cap. del L. V) dell’opera del teologo medioevale, #PierLombardo, che non a caso rimanda anche al giudizio critico di Dante, nella "Monarchia" (III. VII. 6), sulla posizione a favore delle pretese cosmoteandriche paoline del Papa "Cristo-Re".
DOC.:
- L’arcidiacono Claude Frollo illustra al suo amico Jacques Coictier, medico di corte di Luigi XI, e al suo amico, compare Tourangeau, la struttura della Cattedrale:
- «Dedalo è il basamento,Orfeo la parete, Ermete l’edificio. È il tutto. «Siete voi che sbagliate», replicò gravemente l’arcidiacono. «Dedalo è il basamento, Orfeo la parete, Ermete l’edificio. È il tutto. Voi potete venire quando lo vorrete», proseguì rivolgendosi a Tourangeau, «vi mostrerò le particelle d’oro rimaste nel fondo del crogiolo di Nicolas Flamel, e voi le confronterete con l’oro di Guglielmo di Parigi. Vi insegnerò levirtù segrete della parola greca peristera. Ma prima di tutto, vi farò leggere una dopo l’altra le lettere di marmo dell’alfabeto, le pagine di granito del libro. Andremo dal portale del vescovo Guglielmo e di San Giovanni Rotondo alla Sainte-Chapelle, poi alla casa di Nicolas Flamel, in rue Marivaulx, alla sua tomba, che si trova ai Saints-Innocents, ai suoi due ospedali in rue Montmorency. Vi farò leggere i geroglifici di cui sono coperti i quattro grandi alari in ferro del portale dell’ospedale Saint-Gervais e di rue de la Ferronerie. Compiteremo ancora insieme la facciata di Saint-Côme, di Sainte-Geneviève-des-Ardents, di Saint-Martin, di Saint-Jacques-de-la-Boucherie...».
 Era già da un pezzo che Tourangeau, per quanto intelligente fosse il suo sguardo, sembrava non comprendere più don Claude. Lo interruppe.«Per la Pasqua di Dio! Ma che cosa sono dunque i vostri libri?».
Era già da un pezzo che Tourangeau, per quanto intelligente fosse il suo sguardo, sembrava non comprendere più don Claude. Lo interruppe.«Per la Pasqua di Dio! Ma che cosa sono dunque i vostri libri?».
 «Eccone uno», disse l’arcidiacono. Aprendo la finestra della cella, indicò col dito l’immensa chiesa di Notre-Dame che, stagliando contro il cielo stellato la sagoma nera delle sue due torri, dei suoi fianchi di pietra e della sua groppa mostruosa, sembrava un’enorme sfinge a due teste seduta al centro della città. L’arcidiacono contemplò per qualche istante in silenzio il gigantesco edificio, poi, stendendo con un sospiro la mano dÊstra verso il libro stampato che era aperto sul suo tavolo, e la mano sinistra verso Notre-Dame, e volgendo uno sguardo triste dal libro alla chiesa, disse: «Ahimè! Questo ucciderà quello».
«Eccone uno», disse l’arcidiacono. Aprendo la finestra della cella, indicò col dito l’immensa chiesa di Notre-Dame che, stagliando contro il cielo stellato la sagoma nera delle sue due torri, dei suoi fianchi di pietra e della sua groppa mostruosa, sembrava un’enorme sfinge a due teste seduta al centro della città. L’arcidiacono contemplò per qualche istante in silenzio il gigantesco edificio, poi, stendendo con un sospiro la mano dÊstra verso il libro stampato che era aperto sul suo tavolo, e la mano sinistra verso Notre-Dame, e volgendo uno sguardo triste dal libro alla chiesa, disse: «Ahimè! Questo ucciderà quello».
 Coictier, che si era avvicinato al libro con sollecitudine, non poté trattenersi dall’esclamare: «Mah! che c’è dunque di così temibile in questo: GLOSSA IN EPISTOLAS D. PAULI. Norimbergae, Antonius Koburger, 1474? Non è nuovo. È un libro di Pietro Lombardo, il Maestro delle sentenze. Forse perché è stampato?».
Coictier, che si era avvicinato al libro con sollecitudine, non poté trattenersi dall’esclamare: «Mah! che c’è dunque di così temibile in questo: GLOSSA IN EPISTOLAS D. PAULI. Norimbergae, Antonius Koburger, 1474? Non è nuovo. È un libro di Pietro Lombardo, il Maestro delle sentenze. Forse perché è stampato?».
 «L’avete detto», rispose Claude, che sembrava assorto in una meditazione profonda e stava in piedi, appoggiando l’indice ripiegato sull’in-folio uscito dai famosi torchi di Norimberga. Poi aggiunse queste parole misteriose: «Ahimè! ahimè! le piccole cose trionfano sulle grandi; un dente ha la meglio su una massa. Il topo del Nilo uccide il coccodrillo, il pesce spada uccide la balena, il libro ucciderà l’edificio!».
«L’avete detto», rispose Claude, che sembrava assorto in una meditazione profonda e stava in piedi, appoggiando l’indice ripiegato sull’in-folio uscito dai famosi torchi di Norimberga. Poi aggiunse queste parole misteriose: «Ahimè! ahimè! le piccole cose trionfano sulle grandi; un dente ha la meglio su una massa. Il topo del Nilo uccide il coccodrillo, il pesce spada uccide la balena, il libro ucciderà l’edificio!».
- Il secondo capitolo, intitolato appunto "Questo uccide quello" ("Ceci tuera cela"), è un capitolo in cui Hugo riprende ed analizza la frase apparentemente oscura dell’arcidiacono Frollo e dice la "sua":
- [...]sotto questo pensiero, senza dubbio il più immediato e il più semplice, ce n’era a nostro avviso un altro, più nuovo, un corollario del primo, meno facile da capire e più facile da contestare, un modo di vedere altrettanto filosofico, e non più soltanto del prete, ma del saggio e dell’artista. Era il presentimento che il pensiero umano, cambiando di forma, stesse per cambiare modo di esprimersi, che l’idea capitale di ogni generazione non si sarebbe scritta più con la medesima materia e nello stesso modo di prima, che il libro di pietra, così solido e così durevole, avrebbe fatto posto al libro di carta, ancora più solido e duraturo. Da questo punto di vista, la vaga formula dell’arcidiacono aveva un secondo senso; significava che un’arte stava per detronizzare un’altra arte. Voleva dire: «La stampa ucciderà l’architettura». (cit.).
- MEMORIA STORIA E LETTERATURA: VICTOR HUGO,
-
> "IL TEMPO CHE RESTA". --- Victor Hugo, nel 1831, fa "un gesto" nei confronti dei parigini e pubblica un libro, intitolato "Notre-Dame de Paris 1482".25 novembre 2024, di Federico La Sala
25 NOVEMBRE 2024: #DONNE, #UOMINI, #FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA #STORIA, #LETTERATURA, E #STORIOGRAFIA.
- In ricordo di #Elvio #Fachinelli, un omaggio a #Lea #Melandri
Nella "ricorrenza" della #giornatainternazionalecontrolaviolenzasulledonne, una #domanda, una #questione #hamletica: #achegiocogiochiamo?, a che #giogo si continua ad #aggiogare?!
La "memoria" di una denuncia della "infamia #originaria, di un #tradimento strutturale della #fiducia di #lungadurata, "biblico".
- Nota:
- STORIA #LETTERATURA #ARCHEOLOGIA #PSICOANALISI E #ANTROPOLOGIA (#NEXOLOGIA #CHIASMATICA): L’#INDICAZIONE DI #ELVIOFACHINELLI.
 Pensare antropologica-mente permette di essere lungimiranti, in anticipo sui tempi (brevi e lunghi). Credo che, a questo punto (oggi, #24novembre), sia da segnalare anche (e ancora) l’opera di Elvio Fachinelli, "La mente #estatica" (Adelphi, 1989), e, ricordare, in occasione del prossimo #8dicembre, che Victor Hugo, nel 1831, fa "un gesto" nei confronti dei parigini e pubblica un libro, intitolato "Notre-Dame de Paris 1482"; questo stesso "gesto", una "subliminale" sollecitazione a ripensare a quel "libro di pietra", lo fa Sigmund Freud, il 14 giugno 1912, che manda in regalo una copia del "Notre-Dame de Paris" di #Hugo a Ludwig #Binswanger! Forse è è proprio il caso di svegliarsi dal #sonnodogmatico (#Kant), liberarsi dalla "claustrofilia" (#Fachinelli, 1983) e nascere, rinascere!
Pensare antropologica-mente permette di essere lungimiranti, in anticipo sui tempi (brevi e lunghi). Credo che, a questo punto (oggi, #24novembre), sia da segnalare anche (e ancora) l’opera di Elvio Fachinelli, "La mente #estatica" (Adelphi, 1989), e, ricordare, in occasione del prossimo #8dicembre, che Victor Hugo, nel 1831, fa "un gesto" nei confronti dei parigini e pubblica un libro, intitolato "Notre-Dame de Paris 1482"; questo stesso "gesto", una "subliminale" sollecitazione a ripensare a quel "libro di pietra", lo fa Sigmund Freud, il 14 giugno 1912, che manda in regalo una copia del "Notre-Dame de Paris" di #Hugo a Ludwig #Binswanger! Forse è è proprio il caso di svegliarsi dal #sonnodogmatico (#Kant), liberarsi dalla "claustrofilia" (#Fachinelli, 1983) e nascere, rinascere!
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO --- "SONO" O NON "ONOS"?! RIPRENDERE I SENTIERI INTERROTTI, E PORTARSI OLTRE LA TRAGEDIA.25 novembre 2024, di Federico La Sala
"SONO" O NON "ONOS"?! IDENTITA’ E DIFFERENZA: RICOMINCIARE A PENSARE CON L’ASINO,
RIPRENDERE I SENTIERI INTERROTTI, E PORTARSI OLTRE LA TRAGEDIA...
Se si considera che la #parola #àsino "(lat. asĭnus, der. da un vocabolo preindoeuropeo affine al sumerico #anśu «asino», come il gr. ὄνος «asino»"), in greco è "#onos", guardando-si allo #specchio e "ragliando" in italiano, "onos" diventa "#sono" (nel doppio senso del verbo "#essere" e del verbo "#sonare") e si ritrova (a ben voler-si) l’altra "faccia" di sé... "lO" come "sé" e "I-O" (a mal voler-si), "I-O", "I-O" come "asino".
Non è il caso e il tempo, con #Dante-#Ulisse e #Kant e Nietzsche, andare oltre "Scilla e Cariddi" e oltre le colonne d’Ercole del "bene e del male", e, "imparare ad amare" "sé come un altro" (Paul Ricoeur)?!
Per ripensare la #hamletica questione, forse, è bene rileggere L’asino d’oro", "Le metamorfosi" di #Apuleio, ecc. ecc. fino a passare, poi, dalla strada dell’asino alla strada dell’auto (con Le Corbusier), si cfr. GiordanoBruno, "Cabala del Cavallo Pegaseo con l’aggiunta dell’Asino cillenico"; e, anche, l’ articolo "Una forza umile e inquieta / Giordano Bruno tra asinità e conoscenza" di Ugo Morelli (Doppiozero, #17febbraio 2018).
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E TEOLOGIA-POLITICA, OGGI (12 SETTEMBRE 2023). La neve in Romania (di Giorgio Agamben)12 settembre 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E TEOLOGIA-POLITICA, OGGI (12 SETTEMBRE 2023).
Memoria di Paolo di Tarso, del "sapiente" di tutti i "sapienti", per i secoli dei secoli: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
LA FEDE DI UNA RAGAZZA BERBERA, LA PAOLINA "LETTERA AI ROMANI", E IL SIMBOLO NICENO DI #COSTANTINO (NICEA 325 d. C.), E "LA NEVE IN ROMANIA".
UN "INVITO ALLA LETTURA" di una breve annotazione di Giorgio Agamben (Quodlibet, 30 agosto 2023) sulla "fede" e sulla "esperienza della parola":
La neve in Romania
di Giorgio Agamben (Quodlibet, 30 agosto 2023)
A che cosa siamo fedeli, che cosa significa aver fede? Credere in un codice di opinioni, in un sistema di idee formulate in un’ideologia o in un «credo» religioso o politico? Se così fosse, fedeltà e fede sarebbero una triste faccenda, nient’altro che il tetro, compiaciuto dovere di eseguire prescrizioni dalle quali per qualche ragione ci sentiamo vincolati e obbligati. Una tale fede non sarebbe qualcosa di vivo, sarebbe lettera morta come quella che il giudice o lo sbirro ritengono di applicare nello svolgimento delle loro funzioni. L’idea che il fedele sia una specie di funzionario della sua fede è così ripugnante, che una ragazza, che aveva sopportato la tortura pur di non rivelare il nome dei suoi compagni, a coloro che elogiavano la sua fedeltà alle proprie idee rispose semplicemente: «non l’ho fatto per questo, l’ho fatto per capriccio».
Che cosa intendeva dire la ragazza, che esperienza della fedeltà voleva esprimere con le sue parole? Una riflessione su quella fede per eccellenza, che fino a qualche decennio fa era ancora considerata la fede religiosa, può fornirci indizi e riscontri per una risposta. Tanto più che proprio in questo ambito la Chiesa a partire dal Simbolo niceno (325 d.C.) ha ritenuto di dover fissare in una serie di dogmi, cioè di proposizioni vere, il contenuto della fede, ogni discordanza rispetto alle quali costituiva un’eresia condannabile. Nella lettera ai Romani Paolo sembra dirci anzi esattamente il contrario. Egli lega innanzitutto la fede alla parola («la fede viene dall’ascolto attraverso la parola di Cristo») e descrive l’esperienza della parola che è in questione nella fede come una immediata vicinanza di bocca e cuore: «Vicina (eggys, letteralmente alla mano) a te è la parola, nella tua bocca e nel tuo cuore, questa è la parola della fede... Col cuore infatti si crede nella giustizia, con la bocca si professa per la salvezza». Paolo riprende qui un passo del Deuteronomio che affermava questa stessa prossimità: «la parola è vicinissima nella tua bocca e nel tuo cuore ed è nelle tue mani attuarla».
L’esperienza della parola che è in questione nella fede non si riferisce al suo carattere denotativo, al suo corrispondere a dei fatti e a delle cose esteriori: è, piuttosto, esperienza di una vicinanza che ha luogo nell’intima corrispondenza tra bocca e cuore. Testimoniare della propria fede non significa fare delle affermazioni fattualmente vere (o false) come si fa in un processo. Non siamo fedeli, come nel credo o nel giuramento, a una serie di enunciati che corrispondono o non corrispondono a dei fatti. Siamo fedeli a un’esperienza della parola che sentiamo così vicina, che non c’è spazio per separarla da ciò che dice.
 La fede è, cioè, innanzitutto un’altra esperienza della parola rispetto a quella di cui crediamo di servirci per comunicare dei messaggi e dei significati ad essa esterni. A questa parola siamo fedeli perché, nella misura in cui non possiamo separare la bocca e il cuore, viviamo in essa e essa vive in noi. È una tale esperienza che doveva avere in mente quella ragazza berbera che, mentre un giorno le chiedevo che cosa la legava così fortemente a un uomo che diceva di aver amato e con il quale era vissuta per un anno in una capanna nelle montagne rumene, rispose: «io non sono fedele a lui, sono fedele alla neve in Romania».
La fede è, cioè, innanzitutto un’altra esperienza della parola rispetto a quella di cui crediamo di servirci per comunicare dei messaggi e dei significati ad essa esterni. A questa parola siamo fedeli perché, nella misura in cui non possiamo separare la bocca e il cuore, viviamo in essa e essa vive in noi. È una tale esperienza che doveva avere in mente quella ragazza berbera che, mentre un giorno le chiedevo che cosa la legava così fortemente a un uomo che diceva di aver amato e con il quale era vissuta per un anno in una capanna nelle montagne rumene, rispose: «io non sono fedele a lui, sono fedele alla neve in Romania».
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- La metamorfosi sulla via di Damasco: la fortuna contemporanea di Paolo di Tarso e della sua opera (di Massimo Recalcati)..10 agosto 2023, di Federico La Sala
La metamorfosi sulla via di Damasco
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 3 agosto 2023
Due studi recentissimi prolungano la fortuna contemporanea di Paolo di Tarso e della sua opera. Si tratta di Vincenzo Vitiello, Nel silenzio del padre (Salerno Editrice) e Metamorfosi necessaria di JoséTolentino de Mendoça (Vita e pensiero). Essi si aggiungono a una già ricca serie di lavori apparsi all’inizio del nuovo secolo che hanno visto impegnati autori del calibro di Badiou, Agamben e Zizek, per citare solo i più noti.
Ma cosa significa rileggere oggi San Paolo? Innanzitutto ripensare la figura di Gesù non tanto come una figura storica o come un personaggio letterario, ma come evento. Se c’è, infatti, un tema cruciale che viene ripreso da questi due testi è il seguente: non si può comprendere la parola di Gesù se non a partire dalla sua incidenza su chi la ascolta. Per questo Paolo assimila Gesù a un evento. Ma cos’è un evento? È qualcosa che scompagina le leggi consuete del mondo, è un taglio nel loro ordine, una frattura, un trauma. Più di preciso, per Paolo l’“evento Gesù” è stato innanzitutto un incontro.
Questo incontro precede il pensiero, precede la traduzione militante del messaggio cristiano, precede la vita stessa di Paolo perché la istituisce come nuova. Il libro di Tolentino dedica pagine toccanti a questo evento che la leggenda racconta come una caduta di cavallo di Saul, persecutore accanito dei cristiani, e della perdita della sua vista. Accecamento dell’Ego, destituzione del suo prestigio, caduta con la faccia a terra. Passaggio brusco da Saul - che nel suo etimo significa “il più grande” - a Paolo - che nel suo etimo significa “il più piccolo”. Tolentino lo descrive come un “drammatico contromano”.
Ma è solo dall’incontro con l’evento-Cristo che Paolo diventa Paolo. È, più in generale, solo da questo incontro che il cristiano diventa cristiano. Il credere sorge, dunque, da una esperienza di metamorfosi. Prima è l’incontro e poi la fede, non il contrario. È quello che scrive Vitiello quando parla della sovversione cristiana del rapporto tra uomo e Dio: non dall’uomo a Dio, ma da Dio all’uomo. Paolo lo afferma nella Lettera ai Filippesi evocando la kenosis di Dio: Gesù è l’esito dello svuotamento (abbassamento, indebolimento) di Dio, del suo farsi uomo. Il Verbo, come recita il prologo del Vangelo di Giovanni, si è fatto carne. Nondimeno, compito dell’uomo, per Paolo, resta quello di vivere nel nome della Legge perché il suo rispetto per la Torah non viene mai meno.
Il suo martirio, come ricorda Vitiello, rovescia quello di Antigone. Se l’eroina sofoclea, col suo gesto di rivolta nei confronti della Legge, intende denunciarne il carattere disumano, Paolo assume la propria morte non per negare ma per istituire la Legge. Prima dell’incontro con Cristo - prima del tempo della sua conversione - egli era un esecutore irreprensibile della Legge. Ebreo, figlio di ebrei, il suo Dio è il Dio dell’Antica alleanza che ha parlato per via dei profeti, dunque, come si descrive nella prima Lettera ai Galati, «ero molto più zelante delle mie stesse tradizioni patrie». Poi accade l’evento dell’incontro che sposta irreversibilmente la direzione della propria vita e con essa il senso stesso della Legge. In gioco è una esperienza mistica che ruota attorno a una chiamata.
La conversione provocata dalla chiamata, come ricorda Tolentino, attraverso le parole di Paolo stesso, si differenzia sia dalla domanda greca di sapere, sia da quella giudea dei “segni”. L’universo simbolico del sapere e quello immaginario dei segni vengono disarticolati dalla centralità che Paolo attribuisce alla dimensione reale dell’incontro, dell’evento-Cristo. Si tratta di una metamorfosi, dell’acquisizione di una nuova forma di vita. Per Tolentino la parola chiave alla quale apre la conversione è speranza: la speranza che la morte non sia l’ultima parola sulla vita, la speranza che s’incarna nella resurrezione di Cristo, nel dare morte alla morte. Ma questa speranza non assume mai le forme della rassicurazione o del rifugio. Sarà questa invece la lettura freudiana della religione come fuga dalla realtà, regressione infantile della vita, rifiuto della sua asprezza. Nella speranza, come viene sostenuta da Paolo, è tutto il contrario.
La fede non è affatto rifugio, ma tribolazione, non è rassicurazione ma angoscia, non è accasamento ma esodo. È quello che ha sottolineato anche Heidegger nella sua lettura di Paolo: «per la vita cristiana - scrive - non c’è alcuna sicurezza».
È il valore che Paolo nella Lettera ai romani riconosce alla testimonianza di Abramo. La speranza che egli incarna è “la speranza contro ogni speranza”, la “speranza che non vede” poiché se vedesse quello che spera, scrive Paolo, come potrebbe sperarlo?
Più di preciso, la lettura di Vitiello fa emergere come l’esperienza paolina della conversione implichi non solo una trasformazione del soggetto, ma anche del senso del tempo. L’evento del Messia modifica il suo ordine: il passato è morto, l’età del peccato e della morte è scaduta per sempre; l’avvenire si apre come giorno della resurrezione e della vita eterna.
È la differenza profonda tra la concezione ebraica del tempo e quella cristiana: nella cristologia paolina l’adesso - il “grande Oggi” di Rosenzweig -, è il Kairos rivelato dall’evento-Cristo. «L’ora viene, ed è adesso», recita il Vangelo di Giovanni: la salvezza del Regno non è domani, ma adesso, accade oggi e non in un futuro sempre a venire. Nessuno più di Paolo ha avuto l’idea del Messia come evento, incontro, contingenza che si rivela “adesso”, nella vita individuale come in quella collettiva.
È quello che Kierkegaard indicava come compito di ogni cristiano: essere contemporaneo a Cristo. Per questo cristianesimo e gnosticismo risultano, come fa notare Vitiello, radicalmente eterogeni. Se il figlio di Dio si è fatto carne è perché la carne di cui si è fatto onora il mondo, è “carne sacra”, ricorda ancora giustamente Vitiello, come sacro è il mondo.
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Sul mentitore che non sa di mentire (di Giorgio Agamben)24 febbraio 2023, di Federico La Sala
POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA... *
Sul mentitore che non sa di mentire
di Giorgio Agamben, 22 febbraio 2023
«Stalin e i suoi sottoposti mentono sempre, in ogni istante, in ogni circostanza; e poiché mentono sempre, non sanno nemmeno più di mentire. E quando ognuno mente, nessuno più mente mentendo». Vorrei riflettere su questa frase di Boris Souvarine del suo libro su Stalin, perché ci riguarda da vicino. ------
Menzogne da parte dei governi e dei loro media e collaboratori ci sono sempre state, ma decisiva mi pare la considerazione che Souvarine aggiunge alla sua diagnosi: la menzogna può raggiungere un grado così estremo, che i mentitori non sanno più di mentire e, pur continuando a mentire, nessuno più mente.
È questo che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo negli ultimi tre anni ed è questo che rende la situazione presente in Italia non soltanto grave e oppressiva, ma tale che è possibile che sfugga a ogni controllo e finisca in un disastro senza precedenti. Nulla è infatti più pericoloso di un mentitore che non sa di mentire, perché le sue azioni perdono ogni contatto con la realtà. Verità e menzogna, buona fede e mala fede si confondono nella sua mente fino a diventare indiscernibili.
Così negli anni del Covid, i ministri, i medici e gli esperti che mentivano hanno finito col credere a tal punto alle loro menzogne che, smarrendo ogni coscienza della verità, hanno potuto calpestare senza alcuno scrupolo i principi più elementari dell’umanità. Una società che perde ogni coscienza della soglia che separa il vero dal falso diventa letteralmente capace di tutto, anche di distruggersi. È quanto sta avvenendo per la guerra in Ucraina, rispetto alla quale vengono diffuse soltanto notizie false. Il rischio è qui che governi che mentono non sapendo più di mentire possono scatenare una guerra atomica che credevano di non volere, ma che le loro stesse menzogne li obbligano ora a credere di volere.
 22 febbraio 2023
22 febbraio 2023
 Giorgio Agamben
Giorgio Agamben
* STORIA D’ITALIA (1994-2010): IL GIOCO ISTITUZIONALIZZATO DEL "MENTITORE" DI UN PARTITO E IL SILENZIO DEL COLLE, DELLA CORTE COSTITUZIONALE, E DEGLI INTELLETTUALI. Un Paese sull’orlo del Baratro...
- immersi in un letargo profondo, dentro interi millenni di labirinto (Nietzsche), molto "sorprendenti" le riflessioni di Giorgio Agamben per capire quello che "abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo negli ultimi tre anni". Ma, da cittadini e cittadine d’Italia, non si ha più memoria da quanto tempo il Nome dell’intero Paese è di un solo Partito, così come pure l’Inno Nazionale?
CHE LE ISTITUZIONI DEL NOSTRO PAESE ABBIANO PERMESSO UN PARTITO CON IL NOME DI "FORZA ITALIA" PRIMA, E CON IL "POPOLO DELLA LIBERTA’" POI, SIGNIFICA CHE E’ GIA MORTO!!!
 Un Paese sull’orlo del Baratro - di Nadia Urbinati
Un Paese sull’orlo del Baratro - di Nadia UrbinatiFederico La Sala
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- IL POLITTICO DI GAND E L’APOCALISSE: SOTTO GLI OCCHI DELL’AGNELLO. Il silenzio degli agnelli (di Antonio Gnoli).17 aprile 2022, di Federico La Sala
Religioni e civiltà.
Il silenzio degli agnelli
L’autore dedicò le sue ultime riflessioni all’animale che rappresenta la potenza del sacrificio di Cristo. Spiegato attraverso il contrasto con i temi e i toni dell’Apocalisse
di Antonio Gnoli (la Repubblica, 14 Aprile 2022)
- [Foto] Miniatura fiamminga con l’Apocalisse e l’Anticristo assiso nel Tempio (1400 circa)
Il libro Sotto gli occhi dell’Agnello di Roberto Calasso (Adelphi, pagg. 107, euro 13)
Nelle ultime settimane che gli restavano Roberto Calasso rilesse l’Apocalisse. Quel testo, chiuso tra catastrofe e rivelazione, gli si rivelò in una forma inaspettata. Lesse quelle pagine, spesso oscure, immaginifiche, terrificanti avendo negli occhi l’immagine nitida e folgorante del Polittico di Gand, un dipinto, oggi diremmo hollywoodiano, di scene sacre di Jan van Eyck (con la collaborazione del fratello Hubert). Al centro vi è la figura dell’agnello, l’animale più mite e misterioso che l’iconografia religiosa ci abbia consegnato. Tanto da suggerire a Calasso il titolo del nuovo libro: Sotto gli occhi dell’Agnello.
Cosa intercetta l’autore in quello sguardo che improvvisamente diviene imprescindibile per la storia che sta per raccontare? La prima cosa che mi è venuta in mente è La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Non perché la relazione sia immediata, ma perché, molti anni prima, dedicando alcune pagine al film di Hitchcock e ai Veda, Calasso rimarcava la centralità dell’occhio del fotografo, interpretato da James Stewart. Con questa differenza: l’occhio dell’Agnello mistico, cioè del Cristo, sembra osservarci con sovrana e remota indifferenza, indotta da un cristianesimo che ha tradito le aspettative e si è ridotto a uno stanco rituale liturgico. Mentre lo sguardo "immobile" del fotografo inviterebbe (nella lettura di Calasso) a uscire dal cristianesimo, per incrociare quel mondo vedico le cui dottrine aprono varchi interessanti nell’Occidente ampiamente secolarizzato.
Ad alcuni potrà risultare arbitrario il passaggio fulmineo dalla dottrina vedantica a Hitchcock. Ma nel ridisegnare - con la sua opera - il grande affresco delle civiltà, e le relative religioni che lo sostengono, Calasso forza i confini spazio-temporali e rigetta la concezione lineare della storia. Credo che una tale impostazione valga anche per la lettura dell’Apocalisse, per il modo diretto e spiazzante con cui interviene sulle cesure e le articolazioni del testo. Fino a farne la chiave (o almeno una delle chiavi) per comprendere il nostro debole e rinunciatario rapporto con il sacro. Niente di quello che i numerosi commenti hanno offerto, tra l’allegorico e il liturgico, si ritrova qui. Volutamente si ignora la tenace fortuna che il testo avrà nei secoli, fino a imporsi come il "Libro" al quale ricorrere ogni qualvolta un mondo, una civiltà, una storia sembrano destinati al dissolvimento e alla distruzione (quanto cinema e quanta letteratura si sono nutriti dei suoi effetti speciali e terrificanti!).
Movimenti millenaristici di ogni epoca e latitudine hanno interpretato l’Apocalisse come se quei fatti che vi sono raccontati fossero veri. Come se davvero Dio abbia stabilito un inizio traumatico (la caduta) e una fine contraddistinta dal trionfo e dalla salvezza dei giusti.
La lettura di Calasso si discosta dalla visione escatologica e rigetta l’idea che il testo di Giovanni (o più probabilmente di qualche allievo) sia la prosecuzione e il compimento dei Vangeli. Al contrario, come già sospettava Lutero, ne rappresenta la rottura. Il messaggio che l’Apocalisse diffonde sarebbe dunque il tentativo del cristianesimo di autodistruggersi. Ma perché mai una religione ancora giovane, erede della tensione giudaica e già proiettata a riscriverne la visione, compirebbe un gesto così autolesionistico? Cosa nasconde e poi rivela quel testo che sembra scritto da un dinamitardo?
Nell’Apocalisse cristiana - diversamente da quella giudaica - il Messia è giunto. La sua presenza nel mondo, descritta dalla dolcezza dei Vangeli, non ha tuttavia prodotto i risultati sperati. Egli ha fallito il compito di far coincidere il cambiamento annunciato con il trionfo della salvezza. Precarietà e delusione circolano nelle prime comunità cristiane. Gesù stesso è consapevole che il nuovo che comincia a farsi imperiosamente strada sta prendendo una direzione sbagliata. Invoca un successore, un altro messia, un "consolatore" in grado di rimettere l’umanità sulla retta via.
Ma dov’è un successore che sappia portare a termine il compito escatologico? Dal ruggito dell’Apocalisse si può dedurre solo che un essere molto potente in grado di domare il nuovo stia arrivando: "Quel demone del nuovo che usualmente viene attribuito al mondo secolare e alla scienza che lo innerva ha un’origine cristiana o più precisamente paolina".
Paolo prepara il futuro al culto della novità, ne sposa i segni della rivoluzione più che della rivelazione. È il depositario di una sapere antico e di un ordine nuovo. Fornito di un pensiero militante, si pone alla testa di una rivoluzione che nel nome della novitas liquida l’intero mondo antico: "Nessun Lenin del futuro avrebbe saputo parlare (e agire) con altrettanta concisione e vigore", commenta con lieve sarcasmo l’autore. Il nuovo che avanza travolgente non ha più bisogno del cosmo e delle sue storie. E se, per avventura, fa appello a qualcosa di remoto, tende a sfigurarlo e a tradirne la legittimità.
Sotto gli occhi dell’Agnello prende spunto da un’immagine potente dove la distanza dello sguardo animale sembra ignorare che qualcuno l’ha trafitto e che una lunga storia sacra - cominciata prima di Abele e giunta fino a Gesù - lo riguarda. Davanti a quella immagine si può solo constatare che senza quel sacrificio la potente macchina del mondo non si sarebbe più messa in moto. Ma le scritture non dicono a quale folle velocità essa è lanciata. Niente prefigura davvero cosa accade dopo che "l’innominabile attuale", sotto il cui segno il nuovo agisce, ha preso il sopravvento.
Sotto gli occhi dell’Agnello non appartiene all’oggi, ma al passato che convive col domani. Alcuni versi dell’Apocalisse sigillano il finale, ma l’autore li fa precedere da un preciso richiamo al senso intimo, starei per dire sacro, del leggere: quasi un’identificazione genetica tra chi scrive e l’idea stessa del libro: "Leggere è qualcosa che si misura con le potenze del mondo".
Cosa c’è di più commovente e rischioso di questa frase? Che cosa può frenare il dissolversi dell’esperienza artistica e religiosa se non il libro? Per tutta la vita Roberto Calasso ha cercato di dare un nome, o meglio ancora un libro, all’innominabile attuale. Quel libro - dove poter ammassare, avrebbe detto Baudelaire, le proprie collere - non è il mondo, così come l’Apocalisse non ne è la fine. È una grande finestra spalancata sul fluire della vita e sulle decisioni da prendere anche quando è giunto il tempo di congedarsi. Un tempo non già scandito dalla rassegnazione ma dallo scegliere da che parte stare, perché le battaglie celesti non finiscono mai.
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- Sulla lettera dei filosofi contro Agamben (di Luca Illetterati - "Le parole e le cose").19 ottobre 2021, di Federico La Sala
Sulla lettera dei filosofi contro Agamben
di Luca Illetterati (Le parole e le cose, 19 ottobre 2021)
Il difetto principale dei filosofi, diceva Hegel - che un po’ se ne intendeva - è la pretesa che essi hanno di insegnare al mondo come il mondo dovrebbe essere. Come se il mondo fosse ogni giorno lì ad aspettare che arrivasse il pensatore di turno a dirgli che vestito indossare al sorgere del sole. Questa malefica tentazione sembra diventata tanto più evidente all’interno del periodo di crisi pandemica che stiamo vivendo. E non si sta qui parlando solo delle posizioni oramai notissime di Giorgio Agamben contro le quali chi scrive ha anche aspramente e pubblicamente polemizzato ritenendole posizioni che rischiano di sfociare in forme di complottismo populistico, o che comunque dimostrano quanto gli occhiali ideologici dei dispositivi che si sono elaborati per leggere il mondo rischino di deformare radicalmente ciò che il mondo mostra di sé.
A leggere infatti la lettera ‘contro Agamben’ firmata da un numero considerevole di filosofi italiani e pubblicata il giorno 16 ottobre sul “Fatto quotidiano” viene davvero da pensare che questi oppositori filosofici delle posizioni agambeniane siano forniti di occhiali perlomeno altrettanto deformanti e, verrebbe da dire, anche un po’ più dozzinali di quelli di cui vorrebbero mostrare la debolezza e gli effetti distorcenti. La lettera muove da un tono scandalizzato per il fatto che Giorgio Agamben è stato audito in una commissione al Senato sulla questione Green Pass.
Scandalo, evidentemente, del tutto immotivato. Agamben non è stato invitato in quanto rappresentante di una comunità filosofica che andrebbe perciò difesa dal rischio di essere confusa con le posizioni assai controverse di un singolo filosofo, ma in quanto persona autorevole - piaccia o meno, rientri o meno nelle pagelline che pretendono di dare patenti di filosoficità, è il filosofo italiano più noto al mondo - che ha una posizione molto discutibile (e forse anche per questo interessante) sulla questione del Green Pass. Una posizione che taluni pensano sia un bene che chi legifera abbia presente. Non necessariamente per accoglierla, ma ad esempio anche solo per capire se offra argomenti che possono essere tenuti presente per fare poi, con maggiore consapevolezza, magari il contrario di quello che Agamben vorrebbe. Dopo di che la lettera entra nel merito di ciò che Agamben ha sostenuto in quella audizione (e in generale in questi mesi).
In primis, dicono i filosofi che sembrano certi di abitare dalla parte giusta del mondo e della storia, è falso sostenere, come ha fatto Agamben nell’audizione, che i vaccini anti-covid19 siano in una fase sperimentale. Giusto. I vaccini sono stati infatti testati. Ribadendolo, però, forse non sarebbe fuori luogo dire che è altrettanto vero che la somministrazione dei vaccini è iniziata - a mio parere giustamente e per un atto di responsabilità politica che andrebbe esplicitamente rivendicato e non nascosto - prima che tutti gli step cui solitamente viene sottoposto un farmaco fossero conclusi.
Come noto, infatti, solo nell’agosto del 2021 (quando cioè il vaccino era già in uso) la Food and Drug Administration americana ha fatto uscire il vaccino Pfizer-Biontech da quella che non a caso viene chiamata - con un termine che fa evidentemente gioco ad Agamben - emergency use authorization, ovvero approvazione emergenziale. E infatti solo da quel momento un governo che si volesse assumere quella responsabilità potrebbe introdurre l’obbligo vaccinale. Per l’Agenzia Europea del Farmaco, invece, i vaccini sono ancora sottomessi a CMA (Conditional Marketing Authorisation), ovvero ad autorizzazione al commercio condizionata, la quale è lo strumento utilizzato per accelerare l’approvazione dei medicinali durante un’emergenza sanitaria pubblica o per affrontare esigenze mediche non soddisfatte. Non dire queste cose e far credere che la somministrazione del vaccino abbia seguito una prassi standard vuol dire o non voler riconoscere l’eccezionalità decisionale che la situazione ha richiesto o voler far credere qualcosa che non corrisponde al vero.
Il secondo punto su cui si sofferma la lettera dei filosofi che non vogliono essere confusi con Agamben è che sarebbe improprio sostenere che ci troviamo in un’epoca in cui l’eccezionalità è diventata la regola al fine di esercitare da parte dello Stato un controllo sulla cittadinanza, sul modello di quanto fatto da forme di dispotismo come quello sovietico. Le analogie sono sempre pericolose, tanto più quando mettono di mezzo la storia e il dolore che la attraversa. E Agamben su questo è spesso fastidiosamente e gravemente fuori luogo. Tuttavia, non riconoscere che c’è una parte importante della riflessione filosofico-politica contemporanea che insiste sulla giustificazione sempre più emergenziale delle forme del potere politico, vuol dire aver deciso a priori che c’è in tutto il mondo una discussione che non dovrebbe trovare in realtà ospitalità nel mondo. Il che o rientra nella patologia denunziata da Hegel, o è una posizione frutto di ignoranza, o, più probabilmente, è, ancora una volta, una posizione banalmente ideologica.
Il terzo e il quarto punto della lettera sono forse i più delicati. Contro quanto sostenuto da Agamben, i filosofi che si vogliono corretti e informati sostengono che l’adozione del Green Pass non induce nessuna discriminazione tra classi di cittadini e non è, di conseguenza, in alcun modo una forma di repressione delle libertà individuali. Sostenere il contrario - dicono - sarebbe come sostenere che l’istituzione della patente di guida, fatta per limitare il più possibile il numero e l’entità degli incidenti stradali, determini una distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, ovvero che l’obbligo della patente sia anch’esso una forma di lesione delle libertà dell’individuo. L’argomento della patente, come è noto, è uno degli argomenti preferiti sui social media, in particolare su Facebook, e francamente da una così prestigiosa comunità scientifica ci si poteva forse attendere qualcosa di più. In realtà è ovvio che il Green Pass produce una forma - niente affatto banale - di discriminazione. A cittadini che non stanno trasgredendo nessuna legge (perché non vaccinarsi è legale e legittimo) è di fatto impedita una forma di vita sociale minima degna di questo nome: essi, infatti, se non muniti di Green Pass non possono entrare in un’aula universitaria, in una biblioteca, in un teatro, nel luogo di lavoro, su un treno ad alta velocità, a una riunione di partito, a un’assemblea condominiale, in un locale pubblico. E tutto questo non sarebbe discriminatorio? Certo che lo è! All’argomento di Agamben che denunzia le implicazioni discriminatorie del Green Pass non si dovrebbe rispondere negando l’evidenza, ovvero, detto altrimenti, contrapponendo ideologia a ideologia. Una risposta forse un po’ più seria dovrebbe dire: sì, il Green Pass è una norma discriminatoria della quale dobbiamo farci carico, è una forma di ‘ingiustizia’ della quale una società degna di questo nome in certi momenti è chiamata a farsi problematicamente carico, sapendo e dicendo che sta facendo una cosa del tutto fuori dalla norma. Una società responsabile è una società che riconosce esplicitamente le situazioni di deviazione che la sua sopravvivenza richiede. Si chiama - verrebbe da dire - politica, ossia capacità di assumere decisioni non garantite circa il loro esito, di intraprendere azioni che escono dagli automatismi di ciò che è già deciso. Dire ad Agamben, come dicono i tanti filosofi che hanno firmato la lettera, che non è vero che c’è discriminazione, significa, di fatto, dare ragione ad Agamben, fornire cioè argomenti ancora più forti alla sua narrazione.
Il filosofo - è sempre Hegel che lo dice - è colui che è chiamato a problematizzare l’ovvio, a mostrare le implicazioni che abitano in esso, a evidenziare le conseguenze che la sua mera assunzione produce. Forse è questo quello che ci si attende dalla filosofia nel momento in cui entra nel dibattito pubblico. Non che ci dica, cioè, quali sono gli occhiali buoni per vedere “davvero” il mondo; ma che ci aiuti invece a capire cosa un certo tipo di occhiali o un altro ci impediscono di fatto di vedere.
NOTA:
DANTE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
SE è VERO CHE "Il difetto principale dei filosofi, diceva Hegel - che un po’ se ne intendeva - è la pretesa che essi hanno di insegnare al mondo come il mondo dovrebbe essere" E AL CONTEMPO che " [....] Il filosofo - è sempre Hegel che lo dice - è colui che è chiamato a problematizzare l’ovvio, a mostrare le implicazioni che abitano in esso, a evidenziare le conseguenze che la sua mera assunzione produce" (Luca Illetterati, "Sulla lettera dei filosofi contro Agamben", cit.. - sopra),
forse, è bene in via preliminare chiedersi
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA
rimeditare sul "concetto di gusto" e ripensare al "mitolegma di Eros" e all’ intelletto d’amore (cfr. Giorgio Agamben, "Gusto", Enciclopedia Einaudi, 6, Torino 1979, p. 1036),
e
decidersi se si vuole proseguire sonnambulicamente sulla strada di Hegel o svegliarsi e riprendere il cammino di Dante (cfr. Note per una riflessione storiografica).
La crisi è epocale ed è antropologica.
Kant alla fine del suo percorso l’ha ben chriarito. Urgente e necessario rispondere alla "domanda" e mettere in moto un processo di ristrutturazione planetaria.
Federico La Sala
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- Che cos’è la paura, nella quale oggi gli uomini sembrano a tal punto caduti, da dimenticare le proprie convinzioni etiche, politiche e religiose? (di G. Agamben).28 luglio 2020, di Federico La Sala
Una voce
Che cos’è la paura?
di Giorgio Agamben (Quodlibet, 13 luglio 2020)
Che cos’è la paura, nella quale oggi gli uomini sembrano a tal punto caduti, da dimenticare le proprie convinzioni etiche, politiche e religiose? Qualcosa di familiare, certo - eppure, se cerchiamo di definirla, sembra ostinatamente sottrarsi alla comprensione.
Della paura come tonalità emotiva, Heidegger ha dato una trattazione esemplare nel par. 30 di Essere e tempo. Essa può esser compresa solo se non si dimentica che l’Esserci (questo è il termine che designa la struttura esistenziale dell’uomo) è sempre già disposto in una tonalità emotiva, che costituisce la sua originaria apertura al mondo. Proprio perché nella situazione emotiva è in questione la scoperta originaria del mondo, la coscienza è sempre già anticipata da essa e non può pertanto disporne né credere di poterla padroneggiare a suo piacimento.
 La tonalità emotiva non va infatti in alcun modo confusa con uno stato psicologico, ma ha il significato ontologico di un’apertura che ha sempre già dischiuso l’uomo nel suo essere al mondo e a partire dalla quale soltanto sono possibili esperienze, affezioni e conoscenze. «La riflessione può incontrare esperienze solo perché la tonalità emotiva ha già aperto l’Esserci». Essa ci assale, ma «non viene né dal di fuori né dal di dentro: sorge nell’essere-al-mondo stesso come una sua modalità».
La tonalità emotiva non va infatti in alcun modo confusa con uno stato psicologico, ma ha il significato ontologico di un’apertura che ha sempre già dischiuso l’uomo nel suo essere al mondo e a partire dalla quale soltanto sono possibili esperienze, affezioni e conoscenze. «La riflessione può incontrare esperienze solo perché la tonalità emotiva ha già aperto l’Esserci». Essa ci assale, ma «non viene né dal di fuori né dal di dentro: sorge nell’essere-al-mondo stesso come una sua modalità».
 D’altra parte questa apertura non implica che ciò a cui essa apre sia riconosciuto come tale. Al contrario, essa manifesta soltanto una nuda fatticità: «il puro “che c’è” si manifesta; il da dove e il dove restano nascosti». Per questo Heidegger può dire che la situazione emotiva apre l’Esserci nel «essere-gettato» e «consegnato» al suo stesso «ci». L’apertura che ha luogo nella tonalità emotiva ha, cioè, la forma di un essere rimesso a qualcosa che non può essere assunto e da cui si
cerca - senza riuscirci - di evadere.
D’altra parte questa apertura non implica che ciò a cui essa apre sia riconosciuto come tale. Al contrario, essa manifesta soltanto una nuda fatticità: «il puro “che c’è” si manifesta; il da dove e il dove restano nascosti». Per questo Heidegger può dire che la situazione emotiva apre l’Esserci nel «essere-gettato» e «consegnato» al suo stesso «ci». L’apertura che ha luogo nella tonalità emotiva ha, cioè, la forma di un essere rimesso a qualcosa che non può essere assunto e da cui si
cerca - senza riuscirci - di evadere.
 Ciò è evidente nel malumore, nella noia o nella depressione, che, come ogni tonalità emotiva, aprono l’Esserci «più originariamente di ogni percezione di sé», ma anche lo chiudono «più recisamente di qualsiasi non-percezione». Così nella depressione «L’Esserci diventa cieco nei confronti di se stesso; il mondo ambiente di cui si prende cura si vela, la previsione ambientale si oscura»; e, tuttavia, anche qui l’Esserci è consegnato a un’apertura da cui non può in alcun modo liberarsi.
Ciò è evidente nel malumore, nella noia o nella depressione, che, come ogni tonalità emotiva, aprono l’Esserci «più originariamente di ogni percezione di sé», ma anche lo chiudono «più recisamente di qualsiasi non-percezione». Così nella depressione «L’Esserci diventa cieco nei confronti di se stesso; il mondo ambiente di cui si prende cura si vela, la previsione ambientale si oscura»; e, tuttavia, anche qui l’Esserci è consegnato a un’apertura da cui non può in alcun modo liberarsi.È sullo sfondo di questa ontologia delle tonalità emotive che occorre situare la trattazione della paura. Heidegger comincia con l’esaminare tre aspetti del fenomeno: il «davanti a che» (wovor) della paura, l’«aver paura» (Furchten) e il «per-che» (Worum) della paura. Il «davanti a che», l’oggetto della paura è sempre un ente intramondano. Ciò che spaventa è sempre - quale che sia la sua natura - qualcosa che si dà nel mondo e che, come tale, ha il carattere della minacciosità e della dannosità. Esso è più o meno noto, «ma non per questo rassicurante» e, quale che sia la distanza da cui proviene, si situa in una determinata prossimità. «L’ente dannoso e minaccioso non è ancora a distanza controllabile, ma si avvicina. Man mano che esso si avvicina, la dannosità si intensifica e produce così la minaccia... In quanto si avvicina, il dannoso diventa minaccioso, possiamo esserne colpiti o no. Nel farsi più vicino si accresce questo «è possibile ma forse anche no”... l’avvicinarsi di ciò che è nocivo ci fa scoprire la possibilità di essere risparmiati, del suo passar oltre, ma questo non sopprime né diminuisce la paura, anzi l’accresce» (pp. 140-41). (Questo carattere per così dire «certa incertezza» che caratterizza la paura è evidente anche nella definizione che ne dà Spinoza: una «tristezza incostante», in cui «si dubita dell’evento di qualcosa che si odia»).
Quanto al secondo carattere della paura, il temere (lo stesso «aver paura»), Heidegger precisa che non viene prima previsto razionalmente un male futuro, che poi, in un secondo tempo, viene temuto: fin dall’inizio, piuttosto, la cosa che si avvicina è scoperta come temibile. «Solo avendo paura, la paura può, osservando espressamente, rendersi conto di ciò che fa paura. Ci si accorge di ciò che fa paura, perché ci si trova già nella situazione emotiva della paura. Il temere, in quanto possibilità latente dell’essere-al-mondo emotivamente disposto, la paurosità, ha già scoperto il mondo in modo tale, che da esso possa avvicinarsi qualcosa che fa paura» (p. 141). La paurosità, in quanto apertura originaria dell’Esserci, precede sempre ogni determinabile paura.
Quanto, infine, al «per-che», al «per chi e per che cosa» la paura ha paura, in questione è sempre l’ente stesso che ha paura, l’Esserci, quest’uomo determinato. «Solo un essere per il quale nel suo esistere, ne va del suo stesso esistere, può spaventarsi. La paura apre questo ente nel suo essere in pericolo, nel suo essere abbandonato a se stesso» (ibid.). Il fatto che a volte si prova paura per la propria casa, per i propri beni o per gli altri non è un’obiezione contro questa diagnosi: si può dire di «aver paura» per un altro, senza per questo veramente spaventarsi e, se si prova effettivamente paura, è per noi stessi, in quanto temiamo che l’altro ci venga strappato.
La paura è, in questo senso, un modo fondamentale della disposizione emotiva, che apre l’essere umano nel suo essere già sempre esposto e minacciato. Di questa minaccia si danno naturalmente diversi gradi e misure: se qualcosa di minaccioso, che ci sta davanti col suo «per ora non ancora, ma tuttavia in qualsiasi momento», piomba improvvisamente su questo essere, la paura diventa spavento (Erschrecken); se il minaccioso non è già noto, ma ha il carattere dell’estraneità più profonda, la paura diventa orrore (Grauen). Se esso unisce in sé entrambi questi aspetti, allora la paura diventa terrore (Entsetzen). In ogni caso, tutte le diverse forme di questa tonalità emotiva, mostrano che l’uomo, nella sua stessa apertura al mondo, è costitutivamente «impaurito».
La sola altra tonalità emotiva che Heidegger esamina in Essere e tempo è l’angoscia ed è all’angoscia - e non alla paura - che viene attribuito il rango di tonalità emotiva fondamentale. E, tuttavia, è proprio in relazione alla paura che Heidegger può definirne la natura, distinguendo innanzitutto «ciò davanti a cui l’angoscia è angoscia da ciò davanti a cui la paura è paura» (p. 186). Mentre la paura ha sempre a che fare con qualcosa, il «“davanti a che” dell’angoscia non è mai un ente intramondano». Non solo la minaccia che qui si produce non ha il carattere di un possibile danno ad opera di una cosa minacciosa, ma «il “davanti a che” dell’angoscia è completamente indeterminato. Questa indeterminatezza non solo lascia del tutto indeciso da quale ente intramondano venga la minaccia, ma sta a significare che, in generale, l’ente intramondano è “irrilevante”» (ibid.). Il «davanti a che» dell’angoscia non è un ente, ma il mondo come tale. L’angoscia è, cioè, l’apertura originaria del mondo in quanto mondo (p. 187) e «solo perché l’angoscia determina già sempre latentemente l’essere-al-mondo dell’uomo, questi... può provare paura. La paura è un’angoscia caduta nel mondo, inautentica e nascosta a se stessa» (p. 189).
 È stato non senza ragione osservato che il primato dell’angoscia rispetto alla paura che Heidegger afferma può essere facilmente rovesciato: invece di definire la paura come un’angoscia diminuita e decaduta in un oggetto, si può altrettanto legittimamente definire l’angoscia come una paura privata del suo oggetto. Se si toglie alla paura il suo oggetto, essa si trasforma in angoscia. In questo senso, la paura sarebbe la tonalità emotiva fondamentale, in cui l’uomo è già sempre a rischio di cadere. Di qui il suo essenziale significato politico, che la costituisce come ciò in cui il potere, almeno a partire da Hobbes, ha cercato il suo fondamento e la sua giustificazione.
È stato non senza ragione osservato che il primato dell’angoscia rispetto alla paura che Heidegger afferma può essere facilmente rovesciato: invece di definire la paura come un’angoscia diminuita e decaduta in un oggetto, si può altrettanto legittimamente definire l’angoscia come una paura privata del suo oggetto. Se si toglie alla paura il suo oggetto, essa si trasforma in angoscia. In questo senso, la paura sarebbe la tonalità emotiva fondamentale, in cui l’uomo è già sempre a rischio di cadere. Di qui il suo essenziale significato politico, che la costituisce come ciò in cui il potere, almeno a partire da Hobbes, ha cercato il suo fondamento e la sua giustificazione.Proviamo a svolgere e proseguire l’analisi di Heidegger. Significativo, nella prospettiva che qui ci interessa, è che la paura si riferisca sempre a una «cosa», a un ente intramondano (nel caso presente, al più piccolo degli enti, un virus). Intramondano significa che esso ha smarrito ogni relazione con l’apertura del mondo ed esiste fattiziamente e inesorabilmente, senza alcuna possibile trascendenza. Se la struttura dell’essere-al-mondo implica per Heidegger una trascendenza e un’apertura, è proprio questa stessa trascendenza a consegnare l’Esserci alla sfera della cosalità. Essere-al-mondo significa infatti essere cooriginariamente rimesso alle cose che l’apertura del mondo rivela e fa apparire. Mentre l’animale, privo di mondo, non può percepire un oggetto come oggetto, l’uomo, in quanto si apre a un mondo, può essere assegnato senza scampo a una cosa in quanto cosa.
 Di qui la possibilità originaria della paura: essa è la tonalità emotiva che si dischiude quando l’uomo, perdendo il nesso fra il mondo e le cose, si trova irremissibilmente consegnato agli enti intramondani e non può venire a capo del suo rapporto con una «cosa», che diventa ora minacciosa. Una volta smarrita la sua relazione al mondo, la «cosa» è in se stessa terrorizzante. -La paura è la dimensione in cui cade l’umanità quando si trova consegnata, come avviene nella modernità, a una cosalità senza scampo. L’essere spaventoso, la «cosa» che nei film del terrore assale e minaccia gli uomini, non è in questo senso che una incarnazione di questa inaggirabile cosalità.
Di qui la possibilità originaria della paura: essa è la tonalità emotiva che si dischiude quando l’uomo, perdendo il nesso fra il mondo e le cose, si trova irremissibilmente consegnato agli enti intramondani e non può venire a capo del suo rapporto con una «cosa», che diventa ora minacciosa. Una volta smarrita la sua relazione al mondo, la «cosa» è in se stessa terrorizzante. -La paura è la dimensione in cui cade l’umanità quando si trova consegnata, come avviene nella modernità, a una cosalità senza scampo. L’essere spaventoso, la «cosa» che nei film del terrore assale e minaccia gli uomini, non è in questo senso che una incarnazione di questa inaggirabile cosalità.Di qui anche la sensazione di impotenza che definisce la paura. Chi prova paura cerca di proteggersi in ogni modo e con ogni possibile accorgimento dalla cosa che lo minaccia - ad esempio indossando una mascherina o chiudendosi in casa -, ma questo non lo rassicura in alcun modo, anzi rende ancora più evidente e costante la sua impotenza a far fronte alla «cosa». -Si può definire, in questo senso, la paura come l’inverso della volontà di potenza: il carattere essenziale della paura è una volontà di impotenza, il voler-essere-impotente di fronte alla cosa che fa paura. Analogamente, per rassicurarsi ci si può affidare a qualcuno cui si riconosce una qualche autorità in materia - ad esempio a un medico o ai funzionari della protezione civile - ma questo non abolisce in alcun modo la sensazione di insicurezza che accompagna la paura, che è costitutivamente una volontà di insicurezza, un voler-essere-insicuro. E questo è tanto vero che gli stessi soggetti che dovrebbero rassicurare intrattengono invece l’insicurezza e non si stancano di ricordare, nell’interesse degli impauriti, che ciò che fa paura non può essere vinto e eliminato una volta per tutte.
 Come venire a capo di questa tonalità emotiva fondamentale, nella quale l’uomo sembra costitutivamente sempre in atto di precipitare? Dal momento che la paura precede ed anticipa la conoscenza e la riflessione, è inutile cercare di convincere l’impaurito con prove e argomenti razionali: la paura è innanzitutto l’impossibilità di accedere a un ragionamento che non sia suggerito dalla stessa paura. Come scrive Heidegger, la paura «paralizza e fa perdere la testa» (p. 141). Così di fronte all’epidemia si è visto che la pubblicazione di dati e opinioni certi provenienti da fonti autorevoli era sistematicamente ignorata e lasciata cadere in nome di altri dati e opinioni che non provavano nemmeno a essere scientificamente attendibili.
Come venire a capo di questa tonalità emotiva fondamentale, nella quale l’uomo sembra costitutivamente sempre in atto di precipitare? Dal momento che la paura precede ed anticipa la conoscenza e la riflessione, è inutile cercare di convincere l’impaurito con prove e argomenti razionali: la paura è innanzitutto l’impossibilità di accedere a un ragionamento che non sia suggerito dalla stessa paura. Come scrive Heidegger, la paura «paralizza e fa perdere la testa» (p. 141). Così di fronte all’epidemia si è visto che la pubblicazione di dati e opinioni certi provenienti da fonti autorevoli era sistematicamente ignorata e lasciata cadere in nome di altri dati e opinioni che non provavano nemmeno a essere scientificamente attendibili.
 Dato il carattere originario della paura, si potrebbe venirne a capo solo se fosse possibile accedere a una dimensione altrettanto originaria. Una tale dimensione esiste ed è la stessa apertura al mondo, nella quale soltanto le cose possono apparire e minacciarci. Le cose diventano spaventose perché dimentichiamo la loro coappartenenza al mondo che le trascende e, insieme, le rende presenti.
Dato il carattere originario della paura, si potrebbe venirne a capo solo se fosse possibile accedere a una dimensione altrettanto originaria. Una tale dimensione esiste ed è la stessa apertura al mondo, nella quale soltanto le cose possono apparire e minacciarci. Le cose diventano spaventose perché dimentichiamo la loro coappartenenza al mondo che le trascende e, insieme, le rende presenti.
 L’unica possibilità di recidere la «cosa» dalla paura da cui sembra inseparabile è ricordarsi dell’apertura in cui essa è già sempre esposta e rivelata. Non il ragionamento, ma la memoria - il ricordarsi di sé e del nostro essere al mondo - può restituirci l’accesso a una cosalità libera dalla paura. La «cosa» che mi atterrisce, per quanto invisibile allo sguardo, è, come tutti gli altri enti intramondani - come quest’albero, questo torrente, quest’uomo - aperta nella sua pura esistenza. Solo perché io sono al mondo, le cose possono apparirmi e, eventualmente, farmi paura. Esse fanno parte del mio essere al mondo, e questo - e non una cosalità astrattamente separata e eretta indebitamente a sovrano - detta le regole etiche e politiche del mio comportamento. Certo, l’albero può spezzarsi e cadermi addosso, il torrente straripare e allagare il paese e quest’uomo improvvisamente colpirmi: se questa possibilità diventa improvvisamente reale, un giusto timore suggerisce le opportune cautele senza cadere nel panico e senza perdere la testa, lasciando che altri fondi il suo potere sulla mia paura e, trasformando l’emergenza in una stabile norma, decida a suo arbitrio quello che io posso o non posso fare e cancelli le regole che garantivano la mia libertà.
L’unica possibilità di recidere la «cosa» dalla paura da cui sembra inseparabile è ricordarsi dell’apertura in cui essa è già sempre esposta e rivelata. Non il ragionamento, ma la memoria - il ricordarsi di sé e del nostro essere al mondo - può restituirci l’accesso a una cosalità libera dalla paura. La «cosa» che mi atterrisce, per quanto invisibile allo sguardo, è, come tutti gli altri enti intramondani - come quest’albero, questo torrente, quest’uomo - aperta nella sua pura esistenza. Solo perché io sono al mondo, le cose possono apparirmi e, eventualmente, farmi paura. Esse fanno parte del mio essere al mondo, e questo - e non una cosalità astrattamente separata e eretta indebitamente a sovrano - detta le regole etiche e politiche del mio comportamento. Certo, l’albero può spezzarsi e cadermi addosso, il torrente straripare e allagare il paese e quest’uomo improvvisamente colpirmi: se questa possibilità diventa improvvisamente reale, un giusto timore suggerisce le opportune cautele senza cadere nel panico e senza perdere la testa, lasciando che altri fondi il suo potere sulla mia paura e, trasformando l’emergenza in una stabile norma, decida a suo arbitrio quello che io posso o non posso fare e cancelli le regole che garantivano la mia libertà. -
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. - La medicina come religione (di G. Agamben)3 maggio 2020, di Federico La Sala
La medicina come religione
di Giorgio Agamben (Quolibet, 02 maggio 2020
Che la scienza sia diventata la religione del nostro tempo, ciò in cui gli uomini credono di credere, è ormai da tempo evidente. Nell’Occidente moderno hanno convissuto e, in certa misura, ancora convivono tre grandi sistemi di credenze: il cristianesimo, il capitalismo e la scienza. Nella storia della modernità, queste tre «religioni» si sono più volte necessariamente incrociate, entrando di volta in volta in conflitto e poi in vario modo riconciliandosi, fino a raggiungere progressivamente una sorta di pacifica, articolata convivenza, se non una vera e propria collaborazione in nome del comune interesse.
Il fatto nuovo è che fra la scienza è le altre due religioni si è riacceso senza che ce ne accorgessimo un conflitto sotterraneo e implacabile, i cui esiti vittoriosi per la scienza sono oggi sotto i nostri occhi e determinano in maniera inaudita tutti gli aspetti della nostra esistenza. Questo conflitto non concerne, come avveniva in passato, la teoria e i principi generali, ma, per così dire, la prassi cultuale. Anche la scienza, infatti, come ogni religione, conosce forme e livelli diversi attraverso i quali organizza e ordina la propria struttura: all’elaborazione di una dogmatica sottile e rigorosa corrisponde nella prassi una sfera cultuale estremamente ampia e capillare che coincide con ciò che chiamiamo tecnologia.
Non sorprende che protagonista di questa nuova guerra di religione sia quella parte della scienza dove la dommatica è meno rigorosa e più forte l’aspetto pragmatico: la medicina, il cui oggetto immediato è il corpo vivente degli esseri umani. Proviamo a fissare i caratteri essenziali di questa fede vittoriosa con la quale dovremo fare i conti in misura crescente.
1) Il primo carattere è che la medicina, come il capitalismo, non ha bisogno di una dogmatica speciale, ma si limita a prendere in prestito dalla biologia i suoi concetti fondamentali. A differenza della biologia, tuttavia, essa articola questi concetti in senso gnostico-manicheo, cioè secondo una esasperata opposizione dualistica. Vi è un dio o un principio maligno, la malattia, appunto, i cui agenti specifici sono i batteri e i virus, e un dio o un principio benefico, che non è la salute, ma la guarigione, i cui agenti cultuali sono i medici e la terapia. Come in ogni fede gnostica, i due principi sono chiaramente separati, ma nella prassi possono contaminarsi e il principio benefico e il medico che lo rappresenta possono sbagliare e collaborare senza rendersene conto con il loro nemico, senza che questo invalidi in alcun modo la realtà del dualismo e la necessità del culto attraverso cui il principio benefico combatte la sua battaglia. Ed è significativo che i teologi che devono fissarne la strategia siano i rappresentanti di una scienza, la virologia, che non ha un luogo proprio, ma si situa al confine fra la biologia e la medicina.
2) Se questa pratica cultuale era finora, come ogni liturgia, episodica e limitata nel tempo, il fenomeno inaspettato a cui stiamo assistendo è che essa è diventata permanente e onnipervasiva. Non si tratta più di assumere delle medicine o di sottoporsi quando è necessario a una visita medica o a un intervento chirurgico: la vita intera degli esseri umani deve diventare in ogni istante il luogo di una ininterrotta celebrazione cultuale. Il nemico, il virus, è sempre presente e deve essere combattuto incessantemente e senza possibile tregua. Anche la religione cristiana conosceva simili tendenze totalitarie, ma esse riguardavano solo alcuni individui - in particolare i monaci - che sceglievano di porre la loro intera esistenza sotto l’insegna «pregate incessantemente». La medicina come religione raccoglie questo precetto paolino e, insieme, lo rovescia: dove i monaci si riunivano in conventi per pregare insieme, ora il culto deve essere praticato altrettanto assiduamente, ma mantenendosi separati e a distanza.
3) La pratica cultuale non è più libera e volontaria, esposta solo a sanzioni di ordine spirituale, ma deve essere resa normativamente obbligatoria. La collusione fra religione e potere profano non è certo un fatto nuovo; del tutto nuovo è, però, che essa non riguardi più, come avveniva per le eresie, la professione dei dogmi, ma esclusivamente la celebrazione del culto. Il potere profano deve vegliare a che la liturgia della religione medica, che coincide ormai con l’intera vita, sia puntualmente osservata nei fatti. Che si tratti qui di una pratica cultuale e non di un’esigenza scientifica razionale è immediatamente evidente. La causa di mortalità di gran lunga più frequente nel nostro paese sono le malattie cardio-vascolari ed è noto che queste potrebbero diminuire se si praticasse una forma di vita più sana e se ci si attenesse a una alimentazione particolare. Ma a nessun medico era mai venuto in mente che questa forma di vita e di alimentazione, che essi consigliavano ai pazienti, diventasse oggetto di una normativa giuridica, che decretasse ex lege che cosa si deve mangiare e come si deve vivere, trasformando l’intera esistenza in un obbligo sanitario. Proprio questo è stato fatto e, almeno per ora, la gente ha accettato come se fosse ovvio di rinunciare alla propria libertà di movimento, al lavoro, alle amicizie, agli amori, alle relazioni sociali, alle proprie convinzioni religiose e politiche.
Si misura qui come le due altre religioni dell’Occidente, la religione di Cristo e la religione del denaro, abbiano ceduto il primato, apparentemente senza combattere, alla medicina e alla scienza. La Chiesa ha rinnegato puramente e semplicemente i suoi principi, dimenticando che il santo di cui l’attuale pontefice ha preso il nome abbracciava i lebbrosi, che una delle opere della misericordia era visitare gli ammalati, che i sacramenti si possono amministrare solo in presenza. Il capitalismo per parte sua, pur con qualche protesta, ha accettato perdite di produttività che non aveva mai osato mettere in conto, probabilmente sperando di trovare più tardi un accordo con la nuova religione, che su questo punto sembra disposta a transigere.
4) La religione medica ha raccolto senza riserve dal cristianesimo l’istanza escatologica che quello aveva lasciato cadere. Già il capitalismo, secolarizzando il paradigma teologico della salvezza, aveva eliminato l’idea di una fine dei tempi, sostituendola con uno stato di crisi permanente, senza redenzione né fine. Krisis è in origine un concetto medico, che designava nel corpus ippocratico il momento in cui il medico decideva se il paziente sarebbe sopravvissuto alla malattia. I teologi hanno ripreso il termine per indicare il Giudizio finale che ha luogo nell’ultimo giorno. Se si osserva lo stato di eccezione che stiamo vivendo, si direbbe che la religione medica coniughi insieme la crisi perpetua del capitalismo con l’idea cristiana di un tempo ultimo, di un eschaton in cui la decisione estrema è sempre in corso e la fine viene insieme precipitata e dilazionata, nel tentativo incessante di poterla governare, senza però mai risolverla una volta per tutte. È la religione di un mondo che si sente alla fine e tuttavia non è in grado, come il medico ippocratico, di decidere se soppravviverà o morirà.
5) Come il capitalismo e a differenza del cristianesimo, la religione medica non offre prospettive di salvezza e di redenzione. Al contrario, la guarigione cui mira non può essere che provvisoria, dal momento che il Dio malvagio, il virus, non può essere eliminato una volta per tutte, anzi muta continuamente e assume sempre nuove forme, presumibilmente più rischiose.
L’epidemia, come l’etimologia del termine suggerisce (demos è in greco il popolo come corpo politico e polemos epidemios è in Omero il nome della guerra civile) è innanzi tutto un concetto politico, che si appresta a diventare il nuovo terreno della politica - o della non-politica - mondiale. È possibile, anzi, che l’epidemia che stiamo vivendo sia la realizzazione della guerra civile mondiale che secondo i politologi più attenti ha preso il posto delle guerre mondiali tradizionali. Tutte le nazioni e tutti i popoli sono ora durevolmente in guerra con sé stessi, perché il nemico invisibile e inafferrabile con cui sono in lotta è dentro di noi.
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO -- LA FINE DI UN MONOTEISMO CIECO E ZOPPO E LA COMUNITA’ CHE VIENE14 aprile 2020, di Federico La Sala
LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO, LA FEDELTA’ ALL’ AMORE DI HEIDEGGER ED HANNAH ARENDT, LA FINE DI UN MONOTEISMO CIECO E ZOPPO E LA COMUNITA’ CHE VIENE ... *
A) - UNA CASA DI CURA, UN OSPEDALE DA CAMPO: [...] Proprio un totalitarismo apolitico ed economico - fondato su una idea di soggetto come arbitrario e indefinito dispiegamento delle proprie potenzialità - ha impedito sinora di far fronte a tali questioni. Come la pandemia, si tratta di sfide che minano la sopravvivenza. Il virus ha scoperchiato il tetto e ci ha rigettato nella storia. Si può dunque iniziare da qui: dalla condizione storica in cui ci troviamo, che non è regredibile, e che è quella che la biopolitica analizza con acume. Se è vero che il potere sovrano si rivolge sempre più ai corpi, trovando un paradigma nell’oikos o nel campo, allora la “comunità che viene”, costituita da libertà non pure e astratte, ma malate e inchiodate a questi corpi, non potrà che iniziare a costituirsi nella forma di una casa di cura, o di un “ospedale da campo.” ( Francesco Valerio Tommasi, “Curarsi di. Una libertà inchiodata al corpo e alla storia”, Le parole e le cose, 14 aprile 2020);
B) - “UN NUOVO INIZIO”: “[...] Ma rimane altresì vero che ogni fine della storia contiene necessariamente un nuovo inizio; questo inizio è la promessa, l’unico «messaggio» che la fine possa presentare. L’inizio, prima di diventare avvenimento storico, è la suprema capacità dell’uomo; politicamente si identifica con la libertà umana. «Initium ut esset, creatus est homo», dice Agostino. Questo inizio è garantito da ogni nuova nascita; è in verità ogni uomo” (Hannah Arendt, “Le origini del totalitarismo”, Edizioni di Comunità, Milano 1996);
C) - ANTROPOLOGIA: KANT E LA RISCOPERTA DEL CORPO, LA RICERCA DI ENZO PACI SULLA NASCITA e la “fedeltà all’amore” di HEIDEGGER e ARENDT;
D) - CORONAVIRUS O SOVRANITA’ ( “CORONA VIRTUS”) ?! FILOLOGIA: ECCE HOMO! Ad evitare problemi di un cieco e zoppo monoteismo teologico-politico e biologico e uscire dal letargo e dalla caverna, ricordare che Ponzio Pilato disse: “«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)”;
E) - LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
*
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- SCIENZA, STORIA E MEMORIA. PORTARSI DOPO DEWEY.4 aprile 2020, di Federico La Sala
SCIENZA, STORIA E MEMORIA. PORTARSI DOPO DEWEY ....
***
ALLA LUCE DEL GRANDE “SUCCESSO” NELLA CAPACITA’ DI ANALISI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS mostrato dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (“Coronavirus. Rischio basso, capire condizioni vittime”, 22/02/2020), e della condivisione dei suoi “risultati” da parte di Giorgio AGAMBEN (”Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata”, il manifesto, 26/02/2020) , CONDIVIDENDO l’urgenza di accogliere “La sfida del Covid-19 alle scienze umane”, mi sia lecito rinviare ad alcune note dell’anno scorso (2019) proprio sul tema del “processo di apprendimento nelle due culture”. Forse, è proprio ora di uscire dal letargo e riprendere la navigazione “sotto coverta” e “il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” con Galileo Galilei. O no?!
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- RIFLESSIONI SULLA PESTE: CORONAVIRUS E PACE PERPETUA.31 marzo 2020, di Federico La Sala
LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT. Nota ... *
- Riflessioni sulla peste
- di Giorgio Agamben Quodlibet,27 marzo 2020
- Le riflessioni che seguono non riguardano l’epidemia, ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa. Si tratta, cioè, di riflettere sulla facilità con cui un’intera società ha accettato di sentirsi appestata, di isolarsi in casa e di sospendere le sue normali condizioni di vita, i suoi rapporti di lavoro, di amicizia, di amore e perfino le sue convinzioni religiose e politiche. Perché non ci sono state, come pure era possibile immaginare e come di solito avviene in questi casi, proteste e opposizioni? L’ipotesi che vorrei suggerire è che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già, che, evidentemente, le condizioni di vita della gente erano diventate tali, che è bastato un segno improvviso perché esse apparissero per quello che erano - cioè intollerabili, come una peste appunto. E questo, in un certo senso, è il solo dato positivo che si possa trarre dalla situazione presente: è possibile che, più tardi, la gente cominci a chiedersi se il modo in cui viveva era giusto.
- E ciò su cui occorre non meno riflettere è il bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo. È come se il bisogno religioso, che la Chiesa non è più in grado di soddisfare, cercasse a tastoni un altro luogo in cui consistere e lo trovasse in quella che è ormai di fatto diventata la religione del nostro tempo: la scienza. Questa, come ogni religione, può produrre superstizione e paura o, comunque, essere usata per diffonderle. Mai come oggi si è assistito allo spettacolo, tipico delle religioni nei momenti di crisi, di pareri e prescrizioni diversi e contraddittori, che vanno dalla posizione eretica minoritaria (pure rappresentata da scienziati prestigiosi) di chi nega la gravità del fenomeno al discorso ortodosso dominante che l’afferma e, tuttavia, diverge spesso radicalmente quanto alle modalità di affrontarlo. E, come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure.
- Un’altra cosa che dà da pensare è l’evidente crollo di ogni convinzione e fede comune. Si direbbe che gli uomini non credono più a nulla - tranne che alla nuda esistenza biologica che occorre a qualunque costo salvare. Ma sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata.
- Per questo - una volta che l’emergenza, la peste, sarà dichiarata finita, se lo sarà - non credo che, almeno per chi ha conservato un minimo di lucidità, sarà possibile tornare a vivere come prima. E questa è forse oggi la cosa più disperante - anche se, com’è stato detto, «solo per chi non ha più speranza è stata data la speranza».
* Nota:
LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT...
CONSIDERATO, PURTROPPO, CHE ” Le riflessioni” di Agamben non riguardano l’epidemia del CORONAVIRUS, “ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa”, ACCOLTA “L’ipotesi [...] che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già [...]”
 E CONDIVISA L’IDEA CHE BISOGNA RIFLETTERE SUL “[...] bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo [...]”
E CONDIVISA L’IDEA CHE BISOGNA RIFLETTERE SUL “[...] bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo [...]”
 E, ANCORA, CHE “come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure. [....] sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata” (cf. G. Agamben, “Riflessioni...” : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste),
E, ANCORA, CHE “come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure. [....] sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata” (cf. G. Agamben, “Riflessioni...” : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste),
 PER NON PERDERE IL “FILO” DI “SOFIA” E, CON ESSA, ANCHE LA VITA E LA “SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL SUO “SAPERE AUDE!”, IO RIPRENDEREI IL DISCORSO dalla citazione evangelica, utilizzata anche dallo stesso Agamben in “Pilato e Gesù” (nottetempo 2013), relativa al problema dell’ ECCE HOMO (cfr. RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO ... http://www.leparoleelecose.it/?p=37854#comment-426632) e dalla LEZIONE DI KANT sull’UOMO SUPREMO DI EMANUEL SWEDENBORG (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) E SULLA “fine di tutte le cose” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5026). O no?! Boh e bah?!
PER NON PERDERE IL “FILO” DI “SOFIA” E, CON ESSA, ANCHE LA VITA E LA “SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL SUO “SAPERE AUDE!”, IO RIPRENDEREI IL DISCORSO dalla citazione evangelica, utilizzata anche dallo stesso Agamben in “Pilato e Gesù” (nottetempo 2013), relativa al problema dell’ ECCE HOMO (cfr. RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO ... http://www.leparoleelecose.it/?p=37854#comment-426632) e dalla LEZIONE DI KANT sull’UOMO SUPREMO DI EMANUEL SWEDENBORG (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) E SULLA “fine di tutte le cose” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5026). O no?! Boh e bah?!Federico La Sala
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- CORONAVIRTUS: UNA MEDITAZIONE “SAMASATI”,1 aprile 2020, di Federico La Sala
IN SPIRITO DI “AMISTAD” (Steven Spielberg.)! UNA MEDITAZIONE “SAMASATI” .... *
“CORONAVIRTUS” - NOTE A MARGINE DELLE “TESI DI APRILE”, PER USCIRE DALL’ABISSALE VORTICE DEL “MULINO D’AMLETO” (http://www.leparoleelecose.it/?p=38023#comment-427595):
 LENIN PRIMA
(http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2372),
LENIN PRIMA
(http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2372),
 GRAMSCI SUBITO DOPO ( http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5154),
GRAMSCI SUBITO DOPO ( http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5154),
 PASOLINI E FACHINELLI POCO FA (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4352#forum3157066 ).
PASOLINI E FACHINELLI POCO FA (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4352#forum3157066 ). CHE ASPETTIAMO ANCORA?! DAVVERO IL MESSIA?! Nelson Mandela ci può insegnare ancora qualcosa, mi sembra ( http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5269)!
CHE ASPETTIAMO ANCORA?! DAVVERO IL MESSIA?! Nelson Mandela ci può insegnare ancora qualcosa, mi sembra ( http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5269)! “SAMASATI”: RICORDATI CHE SEI UN “BUDDHA”. “Ecce Homo. Come si diventa ciò che si è” (Nietzsche): Dante ha segnato la strada (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2958)!
“SAMASATI”: RICORDATI CHE SEI UN “BUDDHA”. “Ecce Homo. Come si diventa ciò che si è” (Nietzsche): Dante ha segnato la strada (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2958)!Franco Fortini sapeva convivere con “le contraddizioni della verità”, perché sapeva che per comprendere Dante bisognava cominciare a leggere la “Commedia” dal “Paradiso”, non dall’ “Inferno”. Forse sapeva, come sapeva una mia amica che, “per conoscere, bisogna essere già felici” .... O no?! Boh e bah!?
*
 Cfr. “Dal contagio alla vita. E ritorno. Ancora in margine alle parole di Agamben”.
Cfr. “Dal contagio alla vita. E ritorno. Ancora in margine alle parole di Agamben”.-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN --- CORONAVIRTUS: UNA MEDITAZIONE “SAMASATI” -- MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO.E CARITÀ3 aprile 2020, di Federico La Sala
MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO...
- “In questo senso, lo stato della musica (includendo in questo termine tutta la sfera che imprecisamente definiamo con il termine ‘arte’) definisce la condizione politica di una determinata società meglio e prima di qualsiasi altro indice e, se si vuole mutare veramente l’ordinamento di una città, è innanzitutto necessario riformarne la musica. La cattiva musica che invade oggi in ogni istante e in ogni luogo le nostre città è inseparabile dalla cattiva politica che la governa.” (Giorgio Agamben, Che cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata, 2016 p. 140)
PER CARITÀ...
MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO: RIATTIVARE LA MEMORIA della TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE, della “Wohl-tätigkeit”, della carità! “THE SHAWSHANK REDEMPTION” : LA “MOS-ART” (“arte di Mosé”)! Una breve sequenza dal film “Le Ali della Libertà”.
-
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. ---E’ DA DIRE che, nonostante “La veglia per Finnegan” (James Joyce), la “Storia notturna” (Carlo Ginzburg) continua!21 marzo 2020, di Federico La Sala
QUESTIONE EPOCALE. Quando il dito indica la luna, lo stolto guarda il dito....
Nota a margine “Su Agamben e il contagio. Il ruolo della filosofia e la comune umanità” *
E’ DA DIRE che, nonostante “La veglia per Finnegan” (James Joyce), la “Storia notturna” (Carlo Ginzburg) continua: “Ulisse” prosegue il suo “folle volo” ancora nel mare eracliteo (“la stessa cosa sono Ade e Dioniso”)! E, nell’orizzonte cartesiano-heideggeriano, la traccia della “fanciulla straniera” è perduta e, con essa, ogni possibilità di distinguere tra “charitas” e “caritas” (“virus” e “virtus”, “Forza, Italia” e “Forza Italia”, ecc.)!!! Il tempo scorre ... e Dante Alighieri è già oltre!
Non è forse ora di svegliar-si e uscire fuori dall’ inferno epistemologico paolino-hegeliano e dallo “stato di eccezione” schmittico-agambeniano?! Non si è ancora capita la “battuta” di Ponzio Pilato (“Ecce Homo”), di Giuliano l’Apostata e di Keplero (“Vicisti, Galilaee”, 1610)?! Ennio Flaiano , nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, così scrive: “L’ Amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galileo”! Che dire?! In tempi di “peste”, non è male ricordare Manzoni, i “Promessi sposi”, e la sua “ardua sentenza” su Napoleone. Credo che sia meglio, ora e subito, uscire dal let-argo! O no?!
*
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN ... - PENSARE DENTRO L’EMERGENZA, CON BENJAMIN - E CON PONZIO PILATO.3 marzo 2020, di Federico La Sala
CON BENJAMIN (NON AGAMBEN), RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO E RIASCOLTARE IL SUO “ECCE HOMO”! *
Pensare dentro l’emergenza
di Igino Domanin (Le parole e le cose, 1 Marzo 2020)
Mi trovo a una piccola riunione tra amici, è sabato 22 febbraio, arrivano le prime notizie, ormai le conferme, sul Coronavirus. Ha fatto la sua apparizione improvvisa e contagiosa a Codogno, nel Lodigano, in realtà un centro vicinissimo a Milano. Non sono molto cosciente di cosa sta per succedere, ma uno dei convitati mi ha appena detto di essere passato al supermercato per una spesa fuori del normale. Provviste di scatolame, qualche pacco di pasta, non sia mai che scarseggino. Ammetto che questa situazione mi coglie impreparato, fino a quel momento la visione della città cinese, dove tutto è nato, appariva lontana e virtuale. Mi faceva venire in mente la miniserie su Chernobyl.
Gran parte delle nostre percezioni sono rivolte a costrutti, artefatti, manipolazioni, cose che non esistono come fatto naturale ed esterno alla nostra azione. Siamo parecchio abituati a pensare che la nostra condizione di fondo sia in realtà un prodotto, qualcosa che esiste, in fondo, solo per noi e che dipende da noi. Un forte anestetico che allenta la necessità di avere dolorose reazioni empatiche alle catastrofi quotidiane che appaiono nel nostro mondo mediatizzato. La Natura sembra non preoccupare molto, si muore sempre più tardi, molte malattie si curano e si prevengono. Anche se qualche giorno prima di quel famoso sabato, un assicuratore mi ha proposto una polizza per cure a lungo termine. In pratica, mi dice: lo sai che ti toccherà vivere a lungo e ti pare bello, ma la vita, quando invecchi peggiora, e può essere costosissimo viverla se diventi dipendente da qualcuno che si occupi di te. Ho visto gente distruggere il patrimonio, forse è meglio che ci pensi adesso a pararti con una bella polizza. Quando ti capiterà (ed è statistico), che ti becchi una invalidità, l’assicurazione ci pensa. Ah ecco, siamo dentro il crepuscolo della probabilità, inchiodati in un corpo destinato a una lentissima malattia, ma ostinatamente sopravvivente. Non è mica tanto vero, quindi, che non ci attende la natura, che possiamo vivere anestetizzati come una sorta di parodia della sostanza pensante cartesiana. Dobbiamo preoccuparci in modo opaco della nostra corporeità, impegnati in un lavorio assiduo, dipendente da circostanze accidentali e fortuite, ma potenzialmente incombenti.
Ed eccomi alla domanda che mi sono posto, rispetto a certa abitudine filosofica tardonovecentesca d’infilare tutta la realtà nella finzione, nella mediatizzazione, nel dispositivo e finanche nelle baggianate dello storytelling. Cosa succede, invece, quando arriva un pericolo esterno, un’aggressione della nostra natura umana, che non è in nostro potere e che sconvolge quella idea molto radicata per cui il tratto fondamentale della condizione umana parrebbe determinato da questa onnipotenza del volere, da una supposta artificializzazione assoluta, da una decisione a cui è appesa l’intera possibilità della realtà? In effetti, il disagio che provoca la situazione dell’epidemia di Coronavirus, in me e in molti altri, è la mancanza di risposte. Un’alterità insorta naturalmente, che si rapporta a me e che non dipende da me e che mi condiziona in modo radicale fino a minacciare sordamente la mia stessa esistenza. Un’alterità che non è costrutto, che esorbita dalla mia decisione, che è un Fuori, una Esteriorità senza ancora un linguaggio in grado di descriverla, ma posso solo nominarla: Covid 19.
Questa premessa per rispondere a un articolo di Giorgio Agamben che pretende d’inquadrare nel paradigma dello “stato d’eccezione” la dimensione sociale dell’epidemia di Coronavirus. Non mi convince affatto, perché cala dall’alto la certezza di un modello storico novecentesco senza metterlo alla prova. Si parte dall’idea che l’epidemia, l’evento virale e patogeno e tutte le sue conseguenze siano appunto un costrutto, una macchinazione politica, un “dispositivo” che produce un certo tipo di realtà fondata sulla necessità del controllo e della normalizzazione medica. Insomma tutta la pesante assiomatica che ruota intorno a questa surrettizia metafisica della decisione, non a caso dipendente da una teologia politica, che ignora la cogenza ontologica della natura e dei suoi eventi. Una natura, cioè, che è irriducibile all’uomo, al sapere, al linguaggio, ma che entra prepotentemente in relazione con noi fino a provocare il trauma: l’assenza di altra parola certa che non sia l’ostinazione del nome, dell’evocazione costante e ripetuta del “coronavirus”, una realtà ancora non spiegabile eppure esistente in modo drammatico e incombente.
Abbiamo scoperto di essere esposti costitutivamente al rischio, in modo massivo e imprevedibile. In realtà, a ben vedere, la nostra società è calata nell’azzardo e nella esposizione continua a rischi catastrofici, con i quali deve convivere, pena la regressione e l’annientamento. In altri termini, non abbiamo scelta in termini metafisici, siamo destinati storicamente a rapportarci con una esteriorità che c’invade e ed entra in contatto, che può contaminarci fino ad ucciderci, ma che possiamo però rendere ospitale e convivente. Non possiamo stare nei nostri confini senza un po’ di barbarie. Non esistono fondamenti metafisici ai quali riferirsi, non ci sono evidenze scientifiche, nemmeno principi etici inderogabili ed assiomatici. L’indecidibilità, il rischio, l’incertezza, la vulnerabilità ed altro ancora disegnano una nuova figura storica della condizione umana.
Jean-Luc Nancy ha giustamente insistito in una replica, piuttosto secca, ad Agamben che si tratta appunto di aprire un rapporto positivo con l’esteriorità, con ciò che resta esterno e non assimilabile, venire a patti con un’alterità che si sa minacciosa e inconoscibile, ma che appunto impone nuove forme di convivenza su cui scommettere. Negli anni Ottanta, prima la discussione sul Principio di Responsabilità formulato da Hans Jonas, poi la Società del rischio teorizzata da Ulrich Beck e le ricerche antropologiche di Mary Douglas su Purezza e Pericolo, misero in campo una nuova prospettiva. La condizione umana è immersa in rischi potenziali insondabili e opachi, non possiamo uscire dalla esposizione alla catastrofe. In fondo Gunther Anders si era spinto a pensare a una ormai definitiva immanentizzazione dell’escatologia. La catastrofe è il nostro presente attuale, la nostra quotidianità, il nostro rischio costante. Nessuno può ritenersi protetto da un’immunità già stabilita, tutti devono fare i conti con nuovi modi contingenti e flessibili di pensare la sicurezza. Tra gli eccessi euforici dell’ordoliberismo e dell’accelerazione capitalistica dei flussi transnazionali e la paranoia sovranista che promette una sicurezza basata sulla mera reazione, forse si dovrebbe mettere in pratica pazientemente una nuova etica della responsabilità, che a mio avviso resta importante ancora oggi e dentro l’attualità di questa emergenza. Se l’epidemia del Coronavirus ci costringe a pensare dentro l’emergenza, dentro la contingenza spoglia e radicale dell’evento, allora possiamo riprendere confidenza con alcune virtù antiche, ma illuminanti. La prudenza, l’attesa, la pazienza sono l’antidoto morale a una visione paranoica e complottistica del male e della malattia, risorse morali cui attingere senza pretendere di uscire dall’incertezza.
*
CON BENJAMIN (NON AGAMBEN), RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO E RIASCOLTARE IL SUO “ECCE HOMO”!
APPUNTI SULLA “ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE... *
[...] PER IMPARARE “a vivere meglio senza lasciarci condizionare dalla paura della morte, cioè dalla religione, qualunque essa sia”, CREDO CHE SIA NECESSARIO riconsiderare il problema di “come nascono i bambini” (a tutti i livelli)! [...] Ci siamo addormentati nella tradizione cattolico-costantiniana e illuministica acritica (contro Kant), e abbiamo finito per “concepire” noi stessi e noi stesse secondo la bio-logia e l’andro-logia “unidimensionale” dell’omuncolo!
L’«ECCE HOMO» di Ponzio Pilato, al contrario!, ci dice proprio questo - la fine delle “favolette” e di ogni “illusione di un altro Messia”. Il discorso è di diritto e di fatto, romanamente universale, vale a dire, antropologico (non limitato all’«omuncolo» di qualche “uomo supremo” o “superuomo”!):
PONZIO PILATO «disse loro: “Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa”. Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: “«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)”. Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: “Crocifiggi! Crocifiggi!” Disse loro Pilato: “Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa”. Gli risposero gli Ebrei: “Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio”» (Gv. 19, 4-7).
SE SIAMO ANCORA CAPACI DI LEGGERE, COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA LEZIONE DI PONZIO PILATO?! Non è una lezione critica contro i “sovranisti” laici e religiosi di ieri e di oggi ( http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5269)?!
Che vogliamo fare? Continuare a riportare noi stessi e noi stesse davanti a Pilato e ripetere da scemi e da sceme la stessa scena, riascoltare il suo “Ecce Homo” e non capire una “H” (acca)?!
* Per ulteriori precisazioni, mi sia consentito, cfr. “Dal “che cosa” al “chi”: nuova ermeneutica e nuovo principio di “carità” ( http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5728#forum3156994).
Federico La Sala (Le parole e le cose,, 02 marzo 2020)
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- PENSARE DENTRO L’EMERGENZA, CON BENJAMIN - E CON PONZIO PILATO. ... Chiarimenti (di Giorgio Agamben).20 marzo 2020, di Federico La Sala
Chiarimenti
di Giorgio Agamben 17 marzo 2020
Un giornalista italiano si è applicato, secondo il buon uso della sua professione, a distorcere e falsificare le mie considerazioni sulla confusione etica in cui l’epidemia sta gettando il paese, in cui non si ha più riguardo nemmeno per i morti. Così come non mette conto di citare il suo nome, così nemmeno vale la pena di rettificare le scontate manipolazioni. Chi vuole può leggere il mio testo Contagio sul sito della casa editrice Quodlibet. Piuttosto pubblico qui delle altre riflessioni, che, malgrado la loro chiarezza, saranno presumibilmente anch’esse falsificate.
La paura è una cattiva consigliera, ma fa apparire molte cose che si fingeva di non vedere. La prima cosa che l’ondata di panico che ha paralizzato il paese mostra con evidenza è che la nostra società non crede più in nulla se non nella nuda vita. È evidente che gli italiani sono disposti a sacrificare praticamente tutto, le condizioni normali di vita, i rapporti sociali, il lavoro, perfino le amicizie, gli affetti e le convinzioni religiose e politiche al pericolo di ammalarsi. La nuda vita - e la paura di perderla - non è qualcosa che unisce gli uomini, ma li acceca e separa. Gli altri esseri umani, come nella pestilenza descritta da Manzoni, sono ora visti soltanto come possibili untori che occorre a ogni costo evitare e da cui bisogna tenersi alla distanza almeno di un metro. I morti - i nostri morti - non hanno diritto a un funerale e non è chiaro che cosa avvenga dei cadaveri delle persone che ci sono care. Il nostro prossimo è stato cancellato ed è curioso che le chiese tacciano in proposito. Che cosa diventano i rapporti umani in un paese che si abitua a vivere in questo modo non si sa per quanto tempo? E che cosa è una società che non ha altro valore che la sopravvivenza?
L’altra cosa, non meno inquietante della prima, che l’epidemia fa apparire con chiarezza è che lo stato di eccezione, a cui i governi ci hanno abituati da tempo, è veramente diventato la condizione normale. Ci sono state in passato epidemie più gravi, ma nessuno aveva mai pensato a dichiarare per questo uno stato di emergenza come quello attuale, che ci impedisce perfino di muoverci. Gli uomini si sono così abituati a vivere in condizioni di crisi perenne e di perenne emergenza che non sembrano accorgersi che la loro vita è stata ridotta a una condizione puramente biologica e ha perso ogni dimensione non solo sociale e politica, ma persino umana e affettiva. Una società che vive in un perenne stato di emergenza non può essere una società libera. Noi di fatto viviamo in una società che ha sacrificato la libertà alle cosiddette “ragioni di sicurezza” e si è condannata per questo a vivere in un perenne stato di paura e di insicurezza.
Non stupisce che per il virus si parli di guerra. I provvedimenti di emergenza ci obbligano di fatto a vivere in condizioni di coprifuoco. Ma una guerra con un nemico invisibile che può annidarsi in ciascun altro uomo è la più assurda delle guerre. È, in verità, una guerra civile. Il nemico non è fuori, è dentro di noi.
Quello che preoccupa è non tanto o non solo il presente, ma il dopo. Così come le guerre hanno lasciato in eredità alla pace una serie di tecnologie nefaste, dai fili spinati alle centrali nucleari, così è molto probabile che si cercherà di continuare anche dopo l’emergenza sanitaria gli esperimenti che i governi non erano riusciti prima a realizzare: che si chiudano le università e le scuole e si facciano lezioni solo on line, che si smetta una buona volta di riunirsi e di parlare per ragioni politiche o culturali e ci si scambino soltanto messaggi digitali, che ovunque è possibile le macchine sostituiscano ogni contatto - ogni contagio - fra gli esseri umani.
 Giorgio Agamben
Giorgio Agamben
-
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- Notre-Dame. La preghiera di san Bernardo alla Vergine (Dante Alighieri, "Paradiso", XXXXIII).16 aprile 2019, di Federico La Sala
PianetaTerra
Europa Francia Parigi
"Notre-Dame"
La preghiera di san Bernardo alla Vergine
(Dante Alighieri, Paradiso, Canto XXXIII)
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- Il progetto dell’"Homo sacer" e una possibile economia politica dell’inoperosità (di Dario Gentili)29 gennaio 2019, di Federico La Sala
Politica e inoperosità
di Dario Gentili (Alfabeta-2, 27.01.2019)
L’edizione integrale pubblicata da Quodlibet rappresenta di Homo sacer, per usare i termini dello stesso Giorgio Agamben, l’edizione «definitiva, aumentata e corretta». Per quanto Agamben abbia in più occasioni precisato che il progetto ventennale di Homo sacer sia da considerare concluso in quanto «abbandonato», ciò non toglie che l’edizione Quodlibet è definitiva quantomeno poiché consente di considerare l’opera nella sua unitarietà. È invece ancora presto per dire quale contributo specifico questa edizione possa apportare alla ricezione di Homo sacer, che, nei più di vent’anni trascorsi dalla pubblicazione del primo libro del progetto (col sottotitolo Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi 1995), ha già una propria storia. Infatti, le figure di pensiero di Homo sacer - solo per nominarne alcune: la nuda vita, lo stato d’eccezione, la teologia economica, la forma di vita, l’uso - hanno caratterizzato già diverse fasi della sua ricezione. Fasi diverse per quanto diversa era la congiuntura storica, politica ed economica su cui ognuno dei nove volumi del progetto è intervenuto, portandola a «leggibilità». Insomma, difficile se non impossibile è stabilire ora come un’edizione definitiva possa configurare ed eventualmente modificare o spingere a riconsiderare la storia della ricezione di Homo sacer. Per questo, ci sarà tempo - un tempo che, come un’edizione definitiva esige, non può essere esclusivamente quello della congiuntura attuale. Preferibile è allora soffermarsi sull’altro termine con cui Agamben contraddistingue questa edizione: «aumentata».
Due sono le integrazioni che l’edizione Quodlibet di Homo sacer presenta: la nota in conclusione di L’uso dei corpi (l’ultimo volume del progetto: IV, 2) e il capitolo Nota sulla guerra, il gioco e il nemico, che diventa l’ultimo di Stasis. La guerra civile come paradigma politico (II, 2). È su quest’ultima integrazione che intendo soffermarmi, non soltanto perché è la più corposa, ma anche perché può rappresentare un approfondimento che concerne gli esiti filosofici dell’intero progetto (vale la pena rammentare che, sebbene L’uso dei corpi sia l’ultimo volume di Homo sacer, tuttavia è Stasis a essere stato pubblicato per ultimo; da Bollati Boringhieri un anno dopo, nel 2015). Inoltre, a riprova di ciò sta il fatto che il capitolo tratta del ben noto «criterio del politico» quale relazione conflittuale tra amico e nemico, teorizzato da Carl Schmitt, uno degli autori in assoluto più ricorrenti di tutto Homo sacer (basti consultare l’Indice dei nomi, che con i Riferimenti bibliografici compone l’utilissima sezione di apparati posta alla fine dell’edizione integrale).
L’analisi di Agamben delle pagine schmittiane si basa sull’implicarsi reciproco di inimicizia e guerra nella definizione del politico. L’argomentazione di Schmitt infatti oscilla nel fare una volta del nemico e un’altra della guerra il presupposto della relazione costitutiva che determina il concetto di politico: se il nemico assume una preminenza «politica» rispetto all’amico, è tuttavia nella «possibilità reale dell’uccisione fisica», cioè nella guerra, che ciò viene definitivamente a manifestazione.
L’opposizione amico-nemico quale criterio del politico svolgerebbe dunque la funzione di celare o mitigare la crudezza del fondamento ultimo della politica, la guerra, facendo così dell’inimicizia la protagonista unilaterale della politica. È a partire da qui, dalla massima stringenza del dispositivo schmittiano, che Agamben procede per disattivarlo. Non procede pertanto dal suo interno, dal concetto di amicizia (come in fondo ha fatto Jacques Derrida in Politiche dell’amicizia), sostanzialmente catturato e neutralizzato dal primato dell’inimicizia nel caso - decisivo per determinare la situazione politica - della guerra.
Agamben procede invece dal concetto di guerra che Schmitt assume, ovvero da ciò che un ambito del politico definito dalla guerra effettivamente «esclude». Si ribadisce così quella che è la modalità propria di pensiero di Agamben in Homo sacer: è l’esclusione - ad esempio della «nuda vita» e della «vita sacra» nel primo volume dell’opera - a consentire, fin dalle origini della tradizione occidentale, la costituzione dell’ambito - o, detto altrimenti, del «campo» - della politica. Nel caso della guerra, a essere escluso dall’ambito della politica è il «gioco».
Agamben riprende la critica che Leo Strauss mosse nel 1932 al Concetto del politico, mettendo l’accento sul «divertimento» che, tra le altre cose, per Schmitt caratterizzerebbe il mondo qualora venisse meno la distinzione tra amico e nemico - e, con essa, la politica stessa. Nella riedizione del 1963 dello scritto, Schmitt risponde alla critica di Strauss, precisando che, per «divertimento», bisognerebbe intendere appunto «gioco». La politica è una cosa seria, come «serio» è il caso di eccezione in cui la sovranità è chiamata a «decidere».
 Agamben prende molto sul serio l’avversione di Schmitt nei confronti del gioco - o, meglio, della riduzione della politica a gioco - e vi riconosce la vera posta in palio della politica in quanto tale. Per Agamben, infatti, non soltanto il gioco corrisponde a ciò che una politica per costituirsi come guerra deve escludere, ma rappresenta anche la possibilità di un concetto alternativo di politica. Alternativo come è quello configurato, in Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi (nottetempo 2015), dalla forma-di-vita di Pulcinella, che «annuncia ed esige un’altra politica»: una politica della commedia piuttosto che quella della tragedia cara a Schmitt. E, in effetti, come la commedia è più antica della tragedia, così lo è il gioco rispetto alla guerra quale forma e dinamica del conflitto.
Agamben prende molto sul serio l’avversione di Schmitt nei confronti del gioco - o, meglio, della riduzione della politica a gioco - e vi riconosce la vera posta in palio della politica in quanto tale. Per Agamben, infatti, non soltanto il gioco corrisponde a ciò che una politica per costituirsi come guerra deve escludere, ma rappresenta anche la possibilità di un concetto alternativo di politica. Alternativo come è quello configurato, in Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi (nottetempo 2015), dalla forma-di-vita di Pulcinella, che «annuncia ed esige un’altra politica»: una politica della commedia piuttosto che quella della tragedia cara a Schmitt. E, in effetti, come la commedia è più antica della tragedia, così lo è il gioco rispetto alla guerra quale forma e dinamica del conflitto.Prendendo le mosse da Homo ludens di Huizinga, Agamben riconduce il conflitto all’ambito greco dell’agon, più prossimo alla sfera del gioco, piuttosto che all’ambito, bellico, del polemos. Diverse sono le fonti a cui Agamben fa riferimento per asserire l’originarietà del conflitto agonale nella Grecia antica, fino a sostenere con Vernant l’«intima solidarietà fra il conflitto e l’associazione», che - aggiungo io sulla scorta di Nicole Loraux - si può riscontrare addirittura nell’etimo di agorà, lo spazio per eccellenza del confronto politico nella polis. È dunque come agon che il conflitto sposta sull’amicizia il fuoco del criterio del politico: «possiamo allora proporre l’ipotesi - opposta a quella formulata da Schmitt - che in origine la guerra sia un aspetto della funzione agonale-giocosa, consustanziale alla convivenza fra gli uomini, attraverso la quale vengono costruiti rapporti di integrazione e di philía fra gruppi estranei o, all’interno della stessa comunità, fra diverse classi di età».
 Per dirla con i termini che appartengono al lessico dell’intero Homo sacer: se la guerra è la messa in opera del conflitto, il gioco è l’inoperosità del conflitto. E tuttavia, pur sempre di politica si tratta - è per questo che il capitolo Nota sulla guerra, il gioco e il nemico getta una luce significativa sulla portata politica dell’intero progetto di Homo sacer, spesso tacciato di impoliticità quanto agli esiti che categorie come «potenza destituente» e, appunto, «inoperosità» sembrano profilare.
Per dirla con i termini che appartengono al lessico dell’intero Homo sacer: se la guerra è la messa in opera del conflitto, il gioco è l’inoperosità del conflitto. E tuttavia, pur sempre di politica si tratta - è per questo che il capitolo Nota sulla guerra, il gioco e il nemico getta una luce significativa sulla portata politica dell’intero progetto di Homo sacer, spesso tacciato di impoliticità quanto agli esiti che categorie come «potenza destituente» e, appunto, «inoperosità» sembrano profilare.Di altro segno rispetto alla deriva impolitica è invece la problematicità che intendo qui rilevare. Pur tenendo ferma la distinzione tra conflitto e guerra, tale che il gioco apre a un uso politico del conflitto - legato all’associazione e all’integrazione dello straniero nella comunità - alternativo a quello bellico, bisogna tuttavia ricordare come l’agorà non è solo «piazza politica», ma è anche «mercato». Non a caso, nella Nota, si cita la definizione che Vernant fornisce di agon: «competizione organizzata». È un gioco, infatti, anche quello che ha luogo sul mercato: il gioco instaurato dallo scambio e dal commercio. Ed è un gioco che prevede la sospensione dell’inimicizia politica, razziale, religiosa, accogliendo così lo straniero in quanto partner commerciale (per secoli, infatti, il mercato è stato uno spazio ex lege). Ne è ben consapevole Friedrich von Hayek, uno dei pensatori di riferimento del neoliberalismo, quando definisce catallassi la sua concezione dell’ordine spontaneo del mercato, a cui attribuisce una evidente funzione politica, anch’essa alternativa al criterio del politico di Schmitt: «Propongo di chiamare questo ordine spontaneo di mercato catallassi, in analogia con il termine “catallattica”, che è stato spesso proposto come sostituto del termine “economia” (entrambe le espressioni, “catallassi” e “catallattica”, derivano dall’antico verbo greco Katallattein che, significativamente, vuol dire non solo “barattare” e “scambiare”, ma anche “ammettere nella comunità” e “diventare amici da nemici”)».
Certo, anche Hayek presuppone il nemico; ma il suo non è il nemico politico in guerra come per Schmitt, bensì il concorrente sul mercato, con il quale si possono stringere, seppur temporaneamente, accordi di amicizia. C’è allora da chiedersi se non sia stato proprio il gioco del mercato ad aver soppiantato la seriosa politica della guerra di Schmitt. Homo sacer provvede a delineare dell’economia la genealogia teologica (in Oikonomia, nuovo titolo del Regno e la Gloria nell’edizione Quodlibet); ma si potrebbe risalire a un’altra e complementare genealogia dell’economico, lungo un’ulteriore linea di ricerca che potrebbe aprirsi oggi da una rilettura, magari contropelo, di Homo sacer: una linea di ricerca genealogica, altrettanto contrassegnata da quelle ambivalenze che Agamben magistralmente ci ha insegnato a rintracciare, che faccia emergere una economia politica dell’inoperosità.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
I SEGNI DEI TEMPI. L’ECONOMIA DELLA SALVEZZA ("Deus charitas est": 1 Gv., 4.8) E L’ECONOMIA DELLA RICCHEZZA, DI "MAMMONA" E "MAMMASANTISSIMA" ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006): UNA TENSIONE SPEZZATA ...
 "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO.
"IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO.VERITA’ E VERIDIZIONE: PAROLE PER UNA NUOVA POLITICA. Agamben fa un passo innanzi con Foucault, ma cento passi indietro senza Kant.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.11 giugno 2018, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE....
"Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria
Il cardinale prefetto dell’ex Sant’Uffizio: "La dottrina è definitiva, sbagliato creare dubbi tra i fedeli. Cristo conferì il sacramento ai 12 apostoli, tutti uomini"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 maggio 2018)
CITTÀ DEL VATICANO - Si tratta "di una verità appartenente al deposito della fede", nonostante sorgano "ancora in alcuni paesi delle voci che mettono in dubbio la definitività di questa dottrina". A ribadire il "no" del Vaticano all’ipotesi dell’ordinazione presbiterale femminile è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il neo-cardinale gesuita Luis Ladaria, in un lungo e argomentato articolo pubblicato sull’Osservatore Romano. Intitolato "Il carattere definitivo della dottrina di ’Ordinatio sacerdotalis’", il testo è scritto per fugare "alcuni dubbi" in proposito.
Evidentemente, il ritorno di proposte aperturiste circa le donne-prete avanzate soprattutto in alcuni paesi sudamericani in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre dedicato all’Amazzonia, ha allarmato la Santa Sede che attraverso la sua massima autorità gerarchica ha voluto ribadire ciò che anche per Francesco sembra essere assodato: "Sull’ordinazione di donne nella Chiesa l’ultima parola chiara è stata data da Giovanni Paolo II, e questa rimane", ha detto Papa Bergoglio tornando nel novembre del 2016 dal suo viaggio lampo in Svezia.
Durante il Sinodo sull’Amazzonia uno dei temi centrali sarà quello della carenza di preti. Come superare il problema? In proposito, da tempo, si parla dell’opportunità di ordinare i cosiddetti viri probati, uomini sposati di una certa età e di provata fede che possano celebrare messa nelle comunità che, appunto, hanno scarsità di sacerdoti e dove è difficile che un prete possa recarsi con regolarità. Altri uomini di Chiesa fanno altre proposte: propongono, come ad esempio ha recentemente fatto monsignor Erwin Krautler della prelatura territoriale di Xingu in Amazzonia, che oltre ai viri probati si proceda con l’ordinazione delle diaconesse. Mentre altri ancora, invece, hanno parlato direttamente di donne-prete.
Ladaria ricorda che "Cristo ha voluto conferire questo sacramento ai dodici apostoli, tutti uomini, che, a loro volta, lo hanno comunicato ad altri uomini". E che per questo motivo la Chiesa si è riconosciuta "sempre vincolata a questa decisione del Signore", la quale esclude "che il sacerdozio ministeriale possa essere validamente conferito alle donne".
Già Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis del 22 maggio 1994, disse che "la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa". Mentre la Congregazione per la dottrina della fede, in risposta a un dubbio sull’insegnamento di Ordinatio sacerdotalis, ha ribadito che "si tratta di una verità appartenente al deposito della fede".
Chi vuole le donne-prete argomenta che la dottrina in merito non è stata definita ex cathedra e che, quindi, una decisione posteriore di un futuro Papa o concilio potrebbe rovesciarla. Dice, tuttavia, Ladaria che "seminando questi dubbi si crea grave confusione tra i fedeli" perché, Denzinger-Hünermann alla mano (l’autorevole volume che raccoglie simboli di fede, decisioni conciliari, provvedimenti di sinodi provinciali, dichiarazioni e scritti dottrinali dei Pontefici dalle origini del cristianesimo all’epoca contemporanea) la Chiesa riconosce che l’impossibilità di ordinare delle donne appartiene alla "sostanza del sacramento" dell’ordine. Una sostanza, dunque, che la Chiesa non può cambiare. "Se la Chiesa non può intervenire - dice ancora Ladaria - è perché in quel punto interviene l’amore originario di Dio".
Ladaria parla anche dell’infallibilità e del suo significato. Essa non riguarda solo pronunciamenti solenni di un concilio o del Papa quando parla ex cathedra, "ma anche l’insegnamento ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo, quando propongono, in comunione tra loro e con il Papa, la dottrina cattolica da tenersi definitivamente". A questa infallibilità si è riferito Giovanni Paolo II in "Ordinatio sacerdotalis?, un testo che Wojtyla scrisse dopo un’ampia consultazione portata avanti a a Roma "con i presidenti delle conferenze episcopali che erano seriamente interessati a tale problematica". "Tutti, senza eccezione - ricorda Ladaria - hanno dichiarato, con piena convinzione, per l’obbedienza della Chiesa al Signore, che essa non possiede la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. -- Atena tra passato e presente (di G. Agamben).21 gennaio 2018, di Federico La Sala
Atena tra passato e presente
di Giorgio Agamben (Il Sole-24 Ore, Domenica, 21.01.2018)
Nel museo dell’Acropoli in Atene si conservano tre statue provenienti dal frontone del vecchio tempio di Atene polias, che sorgeva sull’Acropoli accanto al luogo dove si trovano ora i resti dell’Erechteion. Impressionante è, al centro, l’immagine, in apparenza perfettamente conservata, della dea Atena, raffigurata in piedi nell’atto di atterrare il gigante Engelados. La dea indossa il mantello detto aegis, il cui lembo estremo è formato da serpenti attorcigliati, con i quali la mano sinistra protesa in avanti minaccia il gigante ormai prostrato al suolo.
 Se lo spettatore si avvicina di qualche passo, si accorge, però, che della scultura originale restano in verità solo frammenti: il viso, insieme infantile e feroce, la spalla sinistra coperta dal mantello, il piede destro e un pezzo del chitone.
Se lo spettatore si avvicina di qualche passo, si accorge, però, che della scultura originale restano in verità solo frammenti: il viso, insieme infantile e feroce, la spalla sinistra coperta dal mantello, il piede destro e un pezzo del chitone.
 Tutto il resto è stato pazientemente ricostruito dagli archeologi con un materiale neutro, di color ocra chiaro, che solo da lontano può confondersi col marmo, ma allo sguardo ravvicinato denuncia senza infingimenti la sua modernità. Ancora più frammentario è il corpo del gigante: dell’originale restano qui solo un frammento del collo, un pezzo del ginocchio e del calcagno destro e, curiosamente ben conservato, il sesso che pende verso il basso.
Tutto il resto è stato pazientemente ricostruito dagli archeologi con un materiale neutro, di color ocra chiaro, che solo da lontano può confondersi col marmo, ma allo sguardo ravvicinato denuncia senza infingimenti la sua modernità. Ancora più frammentario è il corpo del gigante: dell’originale restano qui solo un frammento del collo, un pezzo del ginocchio e del calcagno destro e, curiosamente ben conservato, il sesso che pende verso il basso.Dov’è Atena? Dove situare nel tempo questo torso che sembra invece così integro e vivo? Nella dea passato e presente sono inestricabilmente e funzionalmente congiunti in modo che l’occhio, smentendo la sua percezione, esita a separarli. Essa è letteralmente fatta di passato e presente, quasi che i duemila e cinquecento anni che dividono i frammenti scolpiti da Endaios e le parti integrate dagli archeologi non fossero altro che la pulsazione che ne anima la svelta figura. Il volto sorridente crudelmente reclinato sulla sua vittima, le dita che stringono il collo esiguo del rettile, le poche pieghe della veste, il piede saldamente poggiato al suolo bastano a dar vita all’insieme - e, tuttavia, senza l’ora presente, non meno provvida nel disporre i frammenti del passato che docile nell’obbedire al loro comando, la figura non risulterebbe così viva.
È possibile, allora, che questa statua ci offra il paradigma del rapporto fra passato e presente, l’ esempio di una giusta situazione del passato. Poiché è evidente che il passato non ha luogo che nel presente, che esso non vive che nella sua epifania nell’istante che si presta ad accoglierlo.
Une vecchia fotografia in bianco e nero mostra il ritrovamento nel 1894 di una statua di efebo quasi intatta, appena liberata dalla terra che la ricopriva. Accanto ad essa, gli operai e gli archeologi la guardano soddisfatti e visibilmente eccitati. Così il passato affiora nel presente, convive con esso, in esso ha luogo. E nel punto in cui appare, la falsa continuità della cronologia si spezza e depone la sua pretesa irrevocabilità. Il remoto bruscamente si fa vicinissimo, due momenti lontani nel tempo sono di colpo a contatto, si danno agio e vita a vicenda.
Che cosa è avvenuto, che cosa ha avuto luogo in questo punto? È nota la tesi di Benjamin secondo cui il presente - l’ “ora”- non si dà mai soltanto in un punto isolato della continuità cronologica, ma sempre nella costellazione fra un momento del passato e il presente. Ciò significa che il problema della relazione col passato non è psicologico e individuale, ma politico e collettivo. Ogni decisione sul presente implica la relazione a un momento preciso del passato, con cui esso deve fare i conti.
 Senza questa costellazione critica, il presente è inaccessibile e opaco, perché si riduce, come il discorso del potere non si stanca di suggerire, a un insieme di fatti e di cifre che devono essere accettati senza possibilità di revocarli in questione. Per questo l’archeologia, che risale a contropelo il passato, inseguendo l’ombra che il presente getta su di esso, è l’unica via di accesso al presente.
Senza questa costellazione critica, il presente è inaccessibile e opaco, perché si riduce, come il discorso del potere non si stanca di suggerire, a un insieme di fatti e di cifre che devono essere accettati senza possibilità di revocarli in questione. Per questo l’archeologia, che risale a contropelo il passato, inseguendo l’ombra che il presente getta su di esso, è l’unica via di accesso al presente.Se questo è vero, se ciò di cui ne va nella relazione col passato è il presente, si comprende allora perché le forze che governano l’occidente lavorino con tanta solerzia a rendere impossibile questa relazione. E lo fanno demolendo le università - cioè i luoghi in cui il passato dovrebbe essere trasmesso come cosa viva - e, insieme, moltiplicando i musei, intesi come dispositivi in cui il passato viene mantenuto separato dal presente.
 Il passato che è qui in questione non è né un’origine intemporale né ciò che è stato una volta per tutte, la serie di fatti irrevocabili che si tratta di accumulare e custodire negli archivi: esso è, piuttosto, qualcosa che può ancora avvenire e che, per questo, deve essere ogni volta strappato dalla rappresentazione in cui lo ha imprigionato l’ideologia dominante.
Il passato che è qui in questione non è né un’origine intemporale né ciò che è stato una volta per tutte, la serie di fatti irrevocabili che si tratta di accumulare e custodire negli archivi: esso è, piuttosto, qualcosa che può ancora avvenire e che, per questo, deve essere ogni volta strappato dalla rappresentazione in cui lo ha imprigionato l’ideologia dominante.
 Al passato - cioè al presente - non si accede né al di là della storia, in un’origine intemporale, né lungo la linea continua della cronologia, ma solo attraverso la sua interruzione. La memoria è, cioè, una pratica storica distruttiva e il suo compito - l’archeologia come accesso al presente - è di natura essenzialmente politica.
Al passato - cioè al presente - non si accede né al di là della storia, in un’origine intemporale, né lungo la linea continua della cronologia, ma solo attraverso la sua interruzione. La memoria è, cioè, una pratica storica distruttiva e il suo compito - l’archeologia come accesso al presente - è di natura essenzialmente politica.Ciò è vero anche per l’individuo. Quando questi, vincendo le proprie paure, regredisce al passato - cioè al presente che non ha potuto o saputo vivere - ciò che egli porta in questo modo alla luce non è qualcosa di privato e di incomunicabile. Si tratta, piuttosto, di un’immagine o di un fantasma che, come la statua ignuda dell’ efebo esumato dagli archeologi, non gli appartiene in proprio, ma lo convoca e apostrofa insieme ad altri corpi fuori del tempo cronologico, in un non-luogo che è, però, indiscutibilmente presente. A questo punto, come la Atena polias del museo dell’acropoli, egli scopre di essere fatto di pezzi del passato e del presente tenuti inestricabilmente insieme dalla forza distruttrice-costruttrice della memoria. Ogni presente è, in questo senso, sempre il frammento di un passato e il torso è la figura più autentica della storia.
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
5 risposte a “Semaforo # 5 - dicembre 2017”:
“C’ERA UNA VOLTA”. Ripensare al lavoro di Propp prima e Italo Calvino e Gianni Rodari dopo: lo sguardo della schizofrenia della salute è solo dell’orizzonte della fiaba. Su questa strada erano già anche Dante (in particolare) e (Nietzsche e) Benjamin... Quello che sfuggì a Benjamin (nonostante l’avesse grandemente intuito) che lo sguardo dell’Angelus Novus non è altro che lo sguardo mortifero dei “dannati del XX dell’Inferno” (G.B.Zorzoli) dello Spirito Assoluto della Fenomenologia di Hegel-Napoleone!
P.S.: Sul tema (Dante, Nietzsche, Benjamin e, in particolare, su Hegel che ha “lasciato il «mondo nuovo» con la testa in giù nel Cerchio dei cerchi”, l’Inferno), mi sia permesso, si cfr. il capitolo III (Le “regole del gioco” dell’Occidente e il divenire accogliente della mente) della Terza parte di “La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica” (Antonio Pellicani Editore, Roma, 1991). Federico La Sala
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- RIPENSARE L’ EUROPA. "La città divisa": "Stasis. La guerra civile come paradigma politico".22 giugno 2016, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986):
- LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
SCHEDA *
La città divisa
Nicole Loraux
Neri Pozza Editore, pagg.448, Euro 40,00
IL LIBRO - Questo libro è il capolavoro di Nicole Loraux, la grande antichista francese da poco scomparsa. Esso tenta di ripensare da capo la polis greca, questo modello prestigioso di tutta la tradizione politica occidentale. La scoperta della Loraux è che a fondare la città greca, a fungere da paradigma alla democrazia, non sono né la libertà, né l’unità, né la comunità, ma qualcosa come un paradossale legame attraverso la divisione. Si tratta, cioè, di ripensare Atene sotto il segno della “stasis”, della guerra intestina, che divide e insanguina non solo la città, ma anche, l’”oikos”, la famiglia -o, piuttosto, circola, in un movimento incessante, dalla famiglia alla città, dai fratelli rivali ai cittadini nemici. La guerra civile non è, però, soltanto rottura e anomia, ma costituisce il legame politico segreto che anima e segna profondamente la vita e le istituzioni della democrazia greca, dal giuramento all’amnistia, dalla vendetta alla riconciliazione. Una città divisa deve essere, infatti, capace non solo di ricordare, ma anche di dimenticare, di ricomporre attraverso l’oblio (l’amnistia) l’unità perduta. E a poco a poco, come in ogni grande libro di storia, l’analisi del passato permette di guardare in una nuova luce le divisioni e i conflitti, la memoria e la smemoratezza della società in cui viviamo.
DAL TESTO - “La città degli antropologi [...] non agisce nel tempo dell’evento, ma in quello ripetitivo delle pratiche sociali - il matrimonio, il sacrificio -, in cui fare è ancora un modo di pensare. Di pensare se stessi assegnando (tentando di assegnare) un posto all’altro, a tutti gli altri e, di conseguenza, al medesimo: ricollegando i margini al centro, a quegli “andres” che sono la città ma hanno bisogno, per esempio, delle donne per costituirla veramente. Così il matrimonio fonda la città assicurandone la riproduzione. Dopodiché, una volta costituitasi la “polis” in società umana, la si può situare in rapporto a un altrove. O meglio: di questo altrove, tempo degli dei, mondo selvaggio delle bestie, la città proclama la distanza per meglio farlo, mettendolo al posto opportuno. La città ha assorbito il suo fuori, e il sacrificio fonda la “polis”: lontani dagli dei, ma dotati della cultura, gli uomini sacrificano loro un animale, e questo gesto distribuisce il sistema di esplosioni e integrazioni intorno al nucleo degli “andres”. Dal taglio sacrificale e della sua interpretazione in atto nascerebbe a ogni cerimonia il politico: ugualitario come la condivisione, isomorfo... Diremo anche neutralizzato? Il politico come circolazione immobile, o la città a riposo”.
L’AUTORE - Nicole Loraux (1943-2003) ha insegnato «Histoire et anthropologie de la cité greque» presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales dal 1981 al 1994. Dei suoi numerosi libri, in italiano sono apparsi: “Come uccidere tragicamente una donna” (Laterza, 1988), “Il femminile e l’uomo greco” (Laterza, 1991), “Le madri in lutto”(Laterza, 1991), “Nati dalla terra. Mito e politica ad Atene” (Meltemi, 1998) e “La voce addolorata. Saggio sulla tragedia greca”(Einaudi, 2001).
INDICE DELL’OPERA - Introduzione, di Gabriella Pedullà - Prefazione - La città divisa: sopralluoghi - I. L’oblio nella città - II. Ripoliticizzare la città - III. L’anima della città - Sotto il segno di Eris e di alcuni suoi figli - IV. Il legame della divisione - V. Giuramento, figlio di Discordia - VI. Dell’amnistia e del suo contrario - VII. Su un giorno vietato del calendario ateniese - Politiche della riconciliazione - VIII. La politica dei fratelli - IX. Una riconciliazione in Sicilia - X. Della giustizia come divisione - XI. E la democrazia ateniese dimenticò il “kratos” - Ringraziamenti - La guerra nella famiglia
* http://www.archiviostorico.info/Rubriche/Librieriviste/recensioni6/Lacittadivisa.htm Rispondere al messaggio
- FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT
LA RISATA DI KANT
Giorgio Agamben - Stasis. La guerra civile come paradigma politico.
Recensione di Mauro Balestrieri *
Nell’opera complessiva del filosofo italiano Giorgio Agamben emerge con singolare nettezza l’articolato e celeberrimo progetto che va sotto il nome di Homo sacer. È questa un’opera densa e articolata, avviatasi verso la metà degli anni ‘90 con l’omonimo saggio (Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, 1995) e definitivamente conclusasi di recente con il volume L’uso dei corpi (Neri Pozza, 2014). Eppure, nella mente e nella penna dell’Autore sembra permanere ancora lo spazio per un’ulteriore incursione nel politico - un’incursione, forse, tra le più problematiche e complesse finora affrontate dall’intellettuale italiano. È questo il caso del recentissimo saggio Stasis. La guerra civile come paradigma politico, che raccoglie i contributi di due conferenze tenutesi presso l’Università di Princeton nel 2001; etichettato con la dicitura Homo sacer, II, 2 il testo si frappone tra il precedente Stato di eccezione ed il successivo Il Regno e la Gloria.
A un primo sguardo, i temi del nuovo volume appaiono collegati e opposti nel medesimo frangente. Da un lato, si assiste a un breve esame critico della nozione greca di stasis, che sinteticamente va a indicare la guerra civile combattuta all’interno di una stessa comunità politica tra fratelli e concittadini. Dall’altro, trova invece spazio un originale e innovativo studio sull’opera più nota del filosofo inglese Thomas Hobbes (Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, 1651), ossia su quella costruzione filosofico-giuridica che ergendosi al di sopra della moltitudine sociale scongiura per l’appunto il rischio del conflitto sociale.
Ciò che va fin d’ora notato, tuttavia, è che l’approccio prescelto dall’Autore non è tanto quello di chiosare le note affermazioni che tradizionalmente si ripetono negli studi di settore, né quello di elaborare ex novo una teoria della guerra civile. L’interesse scaturente dalle pagine del breve scritto nasce dal desiderio di tracciare un nuovo filone critico sotteso allo studio della cd. stasiologia, e di sopperire in tal modo alla lacunosità del dibattito filosofico e giuridico attuali.
Secondo Agamben, ciò che manca oggi è propriamente uno studio ragionato e consapevole sul conflitto civile, ossia un tentativo di pensare filosoficamente la crisi e lo scontro. Un tentativo, deve aggiungersi, che ben al contrario si attualizza nel desiderio compulsivo di gestire, risolvere e se possibile anticipare il caso serio, al fine di evitarne ogni possibile problematicità. Proprio alla luce di questa ansia di risoluzione, il dato intellettuale tristemente si smarrisce: a riprova di ciò stanno tanto l’assenza di testi giuridici e politologici di riferimento, quanto la crisi stessa del termine guerra civile, sintagma che nell’ambito internazionale si riduce oramai a fattispecie invocante il mero intervento regolativo degli organismi internazionali. Ecco dunque che di fronte alle civil (o, come sembra ormai consuetudine etichettarle, uncivil) wars non si elabora più una teoria volta alla loro comprensione, bensì si mira a un management delle medesime, ossia a un articolato sistema di iniziative che si esplicita nelle plurime attività «della gestione, della manipolazione e dell’internazionalizzazione dei conflitti interni» (p. 11).
Per colmare questa sorprendente mancanza, il breve saggio di Agamben si incarica di mostrare due eclatanti manifestazioni storiche di tale paradigma, ricorrendo alla tradizione politica della Grecia classica e al pensiero filosofico di Thomas Hobbes. La convinzione che muove l’Autore in questo particolare percorso è infatti che entrambi i momenti rappresentino «le due facce di uno stesso paradigma politico, che si manifesta da una parte nell’affermazione della necessità della guerra civile e, dall’altra, nella necessità della sua esclusione» (p. 12). Tale opposizione, in altri termini, è il segno concreto di una loro intima vicinanza, che il consueto stile espositivo agambeniano chiarisce nelle sue plurime implicazioni.
Prima di tutto, il doppio e opposto significato del termine stasis, che va ad indicare tanto il concetto di immobilità, stabilità e mantenimento dello status quo, quanto quello di sedizione, rivolta e infine rivolgimento politico. Nella sua prima accezione, il termine giunge fino ai nostri giorni nelle forme note di stato ed istituzione (entrambi derivando, come lo stesso termine stasis, dal radicale “-sta” del verbo greco hìstemi). Nel suo secondo senso, il lemma sembra invece essersi dissipato, permanendo solo come antica vox media di un paradigma politico più ampio e quasi sotterraneo.
Attraverso un’analisi delle sue molteplici ricorrenze sia in Tucidide sia in Platone, Agamben arguisce che in realtà l’emblematica indeterminatezza della voce ricade di fatto in una forma di ambiguità concettuale, in base alla quale la guerra civile esulerebbe tanto dall’oikos (ossia dal focolare domestico), quanto dalla pòlis (ossia dalla collettività urbana). Essa sarebbe quindi la zona di indifferenza tra lo spazio impolitico della famiglia e quello politico della città: «nel sistema della politica greca, la guerra civile funziona come una soglia di politicizzazione o di depoliticizzazione, attraverso la quale la casa si eccede in città, e la città si depoliticizza in famiglia» (p.24).
In definitiva, la stasis opera come un reagente che rivela l’elemento politico nel caso estremo, ossia come una soglia di politicizzazione che determina di per sé il carattere politico o impolitico di un certo essere. Ulteriore conseguenza è che questa stessa indeterminatezza concettuale si riverbera nel formante giuridico, così come mostrato dall’istituto penalistico dell’amnistia. Se infatti il prendere parte alla guerra civile era nell’antica Grecia politicamente necessario, a conclusione del conflitto interveniva comunque la pacificazione sociale, che attraverso le forme dell’oblio (amnistia - da amnestèo - indica appunto la dimenticanza) sanava retroattivamente la partecipazione attiva dei suoi componenti. In questo senso, la stasis non è qualcosa che semplicemente deve essere rimosso, ma è «l’indimenticabile che deve restare sempre possibile nella città e che, tuttavia, non deve essere ricordato attraverso processi e risentimenti» (p. 29).
Nella Grecia classica, possiamo allora concluderne, non si dà una sostanza politica omogenea, ma un manifestarsi irregolare e continuo di correnti tensionali e instabili, esprimentesi in ultimo grado nelle forme della politicizzazione e della depoliticizzazione, ossia nella commistione belluina della famiglia e della città.
Ora, è precisamente per sconfiggere questo scenario mortifero e abissale che Hobbes costruirà il suo Leviatano, quell’immenso automa o “Dio mortale” composto da una moltitudine di piccole figure umane tradizionalmente intese come sudditi.
Com’è facile scorgere esaminando i due diversi frontespizi dell’opera (l’uno vede rappresentati i sudditi con il viso rivolto verso il lettore; l’altro, coevo al primo, li coglie al contrario di spalle), gli esserini che compongono l’immenso meccanismo artificiale si uniscono saldamente gli uni agli altri. La spiegazione traslata è che ciò avviene per mezzo del loro reciproco accordo, che consente metaforicamente di compattarli dando luogo a quell’ideale corpo politico (body political) così caro al pensatore inglese.
Proprio la nozione di corpo politico, però, si presta alle più dure contestazioni: data la sua sfuggente consistenza, per Hobbes il popolo esiste solo nell’istante in cui si riunisce per nominare un leader o un’assemblea rappresentativa - ma in questo stesso istante svanisce improvvisamente. Il corpo politico, in altri termini, è qualcosa di altro e di impossibile, destinato continuamente a comporsi e subitaneamente a dissolversi nella costituzione del governo effettivo.
È in questo preciso passaggio che Agamben ricerca un’affinità con il summenzionato meccanismo di esclusione/inclusione visto a proposito della guerra civile nella Grecia antica: «se il popolo, che è stato costituito da una moltitudine disunita, si dissolve nuovamente in una moltitudine, allora questa non soltanto preesiste al popolo/re, ma, come multitudo dissoluta, continua a esistere dopo di questo [...] La moltitudine non ha un significato politico, essa è l’elemento impolitico sulla cui esclusione si fonda la città; e, tuttavia, nella città vi è soltanto la moltitudine, perché il popolo è già sempre svanito nel sovrano» (p. 55).
Hobbes, rendendosi conto di tale aporia, oblitera il paradosso della moltitudine/corpo politico risolvendolo, com’è noto, con il ricorso immediato al pactum subiectionis. Ma se ciò ha il pregio di spezzare il circolo che dalla guerra civile conduce alla riconfigurazione della multitudo dissoluta, permane quale operazione problematica e nient’affatto ultimativa - un’operazione che lascia scoperto l’enorme problema di una possibile ripresentazione dello stato di natura e quindi del conflitto generalizzato.
Senza dubbio, è in questi termini che fino a oggi è stato pensato il fine ultimo del Leviatano: la posticipazione indefinita del conflitto civile. Il covenant alla base della sua formazione agirebbe, si sostiene, quale forza frenante rispetto all’avvento della discordia intestina, ossia quale meccanismo giuridico in grado di disinnescare a priori la fine dei tempi rappresentata dal collasso politico. In fondo, si può anche dire, il Leviatano fa paura proprio per questa ragione: se come si è visto la multitudo dissoluta può effettivamente frammentarsi in ogni istante e generare quindi un nuovo conflitto, lo Stato deve continuativamente incutere timore, un timore rivolto all’impedimento immediato di ogni sua concreta demolizione.
Con un doppio ribaltamento, Agamben costruisce invece la propria conclusiva argomentazione accentuando la dimensione messianica e decisamente escatologica dell’intero pensiero hobbesiano. In tal senso il filosofo inglese, in accordo con il messaggio evangelico, configurerebbe il Leviathan quale “capo” di un political body, con ciò adoperando la nota immagine paolina che predica Cristo stesso quale “capo” dell’ekklesìa, ossia dell’assemblea dei fedeli.
Se Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, allora il Leviathan è il capo del corpo politico. Questo rispecchiamento profano del messaggio paolino conduce però a una precisa conseguenza: «nello stato attuale, Cristo è il capo del corpo dell’assemblea, ma, alla fine dei tempi, nel Regno dei cieli, non vi sarà più distinzione fra la testa e il corpo, perché Dio sarà tutto in tutti [...] Ciò significa che alla fine dei tempi la finzione cefalica del Leviatano potrebbe essere cancellata e il popolo ritrovare il suo corpo. La cesura che divide il body political - soltanto visibile nella finzione ottica del Leviatano, ma di fatto irreale - e la moltitudine reale, ma politicamente invisibile, sarà alla fine colmata nella Chiesa perfetta» (p. 72).
Un nuovo messaggio sembra allora profilarsi quale cifra complessiva di questa antica filosofia: lo Stato (di matrice hobbesiana) non ha affatto la funzione e il ruolo di una forza frenante o catecontica. Esso non vuole in alcun modo posticipare la fine dei tempi, ma al contrario avvicinarla escatologicamente, in modo da rendere reali l’avvento del Regno e la consumazione dei tempi. Buffamente, lo Stato-Leviatano - che nell’immaginario di tutti predicava la garanzia per la pace e la sicurezza dei sudditi - partecipa invece a una visione apocalittica del potere, in cui l’avvento catastrofico del Giorno del Signore è la lettera conclusiva dell’intera esperienza politica occidentale.
Diverse tradizioni sembrano allora confrontarsi nell’immagine storica di questa figura: da un lato quella terrifica di uno Stato assoluto e indomabile, che ingloba senza esitazione le anime di chi tenta di impossessarsene (come sottolinea vividamente Bodin nella sua Daemonomania). Dall’altro, quella cabalistica e messianica che intravede al contrario il grande monstrum scomparire nel festivo banchetto delle sue carni.
Ma se la storia del pensiero politico sembra confinare tali interpretazioni all’archeologia del pensiero storico, una terza e parimenti inquietante forma di manifestazione è stata ben presente nella concezione dello Stato moderno. Una concezione che vedeva il Leviatano quale meccanismo artificiale e impersonale, in cui attraverso la generale neutralizzazione del politico si perveniva a una concezione del diritto quale strumento tecnico neutrale.
L’annoso conflitto tra legalità e legittimità, che oggi prende le forme degli imperativi tecnici e della logica economica, produce ancora manifestazioni assolutizzanti e dotate di un vero e proprio carattere normativo, quali è facile incontrare nelle forme atipiche della soft law e della governance mondiale. Tali istanze scompaginano le categorie giuridiche fondamentali, costruendo e decostruendo lo stesso simbolo del Leviatano, e agendo come operatori eccezionali in grado di (ri)fondare l’ordine politico mondiale.
È forse attraverso la secolarizzazione di questa remota provenienza che sembra giunta allora l’epoca della stasis globale - un’epoca, suggerisce Agamben, in cui la politica contemporanea ricerca il proprio senso teologico senza riuscire pienamente a coglierlo, perché preda di una dimenticanza remota e inquietante che rimonta alle origine stesse della propria costituzione. Il contributo di Agamben, pur nell’estemporaneità della sua trattazione, è allora un piccolo ma denso tassello di un’opera ancora da scrivere e, forse, ancora da pensare.
*
Philosophy Kitchen, Recensioni / giugno 2015
- FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT
LA RISATA DI KANT
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- E IL "DIVERTIMENTO DEI RAGAZZI". La filosofia è un segreto di nome Pulcinella (di Melania Mazzucco)7 novembre 2015, di Federico La Sala
Giorgio Agamben dedica il nuovo saggio alla maschera e ai suoi significatiLa filosofia è un segreto di nome Pulcinella
di Melania Mazzucco (la Repubblica, 7.11.2015)
- IL LIBRO Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi di Giorgio Agamben (nottetempo, pagg. 144 euro 27) Sopra, Pulcinella innamorato di Giambattista Tiepolo
Negli ultimi anni della sua vita, il pittore Giandomenico Tiepolo, che aveva soggiornato nelle corti d’Europa (in Germania e in Spagna) insieme al padre Giambattista, si trasferì nella villa che questi gli aveva lasciato in eredità, nella terraferma veneziana: a Zianigo, presso Mirano. Aveva decorato quella modesta villetta con la massima libertà - che un pittore del XVIII secolo poteva regalarsi solo dipingendo per se stesso. Aveva iniziato affrescando scene vagamente neoclassicheggianti di satiri e centauri, e quindi scene di vita contemporanea. Col Mondo Novo nel portego, la sala grande del pianterreno (1791), si offrì una meditazione sorridente e malinconica sul tempo tumultuoso che stava vivendo. La folla si accalca davanti al baraccone in cui un ciarlatano promette di mostrare le immagini del ‘mondo novo’; egli incombe su di loro, come il burattinaio sulle marionette. Tutti mostrano le spalle agli spettatori, ignari della nostra presenza (e della nostra ironia). Soltanto uno di essi ci guarda: un bambino che in quel mondo novo vivrà.
Ma tre di loro, raffigurati di profilo, sembrano immuni dalle illusioni e dal rumore del mondo: un uomo anziano in cui si è sempre riconosciuto Giambattista Tiepolo, Giandomenico stesso, e Pulcinella. Il pittore manovra il suo occhialino: disorientato, ha bisogno di una lente, ma non rinuncia a capire. Infine (1793-97), Giandomenico affrescò le pareti della stanza di nord est - forse il suo studiolo - con una serie di scene aventi un solo protagonista: Pulcinella, che volle come unico compagno e alter ago dei suoi anni estremi.
Fra il 1797 e la morte, avvenuta nel 1804, Giandomenico creò il Divertimento per li regazzi - un album di disegni in 104 fogli, un “incunabolo del fumetto”, interamente dedicato a Pulcinella. L’enigmatico napoletano di bianco vestito, dal cappello a cono mozzato e dal volto nero a becco di uccello, da quasi due secoli stregava gli spettatori, nobili, borghesi e plebei, di tutta Europa. Ma veniva da ancor più lontano, dalle atellane, dai drammi satireschi. Animato da una irresistibile energia vitale, disponibile a ogni avventura, citrullo per natura e strategia di sopravvivenza, refrattario a ogni autorità, dovere, morale, sempre bastonato e però invincibile, sostanzialmente immortale, il proteiforme Pulcinella era diventato la maschera più popolare del teatro all’italiana. Era comparso in numerose pitture. Lo stesso Tiepolo padre ne era stato ossessionato (disegnandolo per lo più come un gobbo, nano e mostruoso, mentre mangia, digerisce, orina ed evacua). Ma nessuno come Giandomenico ne fece il proprio riflesso spettrale.
Che Pulcinella fosse per lui assai più di una comica maschera di Carnevale lo svela già il frontespizio del Divertimento, quasi blasfema citazione di quello della giovanile raccolta di incisioni La Via Crucis: al sepolcro vuoto di Cristo e alle insegne della Passione, sostituisce il sepolcro vuoto di Pulcinella, e le sue insegne (la pentola, i maccheroni), contemplate da lui stesso. In questo povero Cristo senza miracoli, chino sull’assurdità della propria vita e di quella di tutti, si riconobbe: ne disegnò nascita, crescita, amori, avventure, erranze, lavori, gozzoviglie, morte - facendone lo specchio di ogni esistenza umana.
Alla straordinaria impresa artistica del Divertimento - poco conosciuta, perché sventuratamente smembrata fra troppe collezioni sparse in vari continenti - il filosofo Giorgio Agamben, tra i principali pensatori del nostro tempo, dedica la sua ultima opera: “ilare e scherzevole” ma solo apparentemente meno densa e “laboriosa” delle altre sue. Giacché, come fin dalla prima pagina ci ricorda, la commedia è filosofia: Platone teneva sotto il cuscino i mimi di Sofrone, e la commedia è più antica e profonda della tragedia. Nell’“oscurità dei tempi” in cui a entrambi è stato dato vivere - il pittore veneziano costretto ad assistere alla dissoluzione ingloriosa della Repubblica di Venezia, il filosofo italiano e cosmopolita a quella della nostra e dell’occidente - Pulcinella si rivela l’interlocutore più stimolante per una ricapitolazione, una “sobria meditazione sulla fine”. Non sarà futile notare che entrambi lo scelgono dopo aver valicato la soglia dei settanta anni.
Diviso in quattro scene scandite da corsivi ora autobiografici ora storicizzanti, e da frammenti di un’operetta morale (fulminanti dialoghi in napoletano fra Pulcinella e Tiepolo, ma in realtà fra Pulcinella e Agamben), accompagnato da alcuni disegni dell’album nonché da illustrazioni di altri quadri e ritratti (impaginate con finezza, in modo anti- didascalico, cosa di cui va reso merito anche alla casa editrice Nottetempo), costruito per brevi capitoli e divagazioni dotte che spaziano dall’antropologia al folclore, alla filosofia classica, alla linguistica, alla storia del teatro, dal dettaglio tecnico all’astrazione teoretica, il Divertimento delizierà i lettori abituali del filosofo Agamben, ma forse potrà avvicinargli anche qualcuno dei ‘regazzi’ che ha esitato davanti all’Homo sacer o Nudità. Regazzi si intenda in senso lato - come del resto intendeva Tiepolo: ché il suo album non era dedicato ai bambini, o ai fanciulli, ma agli spiriti liberi dalle costrizioni e dai conformismi.
Il Divertimento di Agamben è insomma una lezione socratica sul significato di una maschera che è insieme singola e solitaria, e plurima come gli angeli e la plebe (una “masnada”, un popolo, una collezione di repliche). Né personaggio né carattere né tipo, Pulcinella è un’idea: «che qualcuno o qualcosa sia irreparabilmente com’è; questo è Pulcinella» (l’idea dell’irreparabile, apparentemente tragica, riflette Agamben, è invece in se stessa comica).
Non sostantivo ma un avverbio: Pulcinella «non è un che ma soltanto un come »; non ha scelto di essere com’è, o di fare qualcosa, non ha volontà alcuna e le sue azioni, lungi dal mirare a un fine, sono insensate, lazzi senz’altro scopo che interrompere l’azione e vanificarla. Perfino il suo corpo, gallinaceo, ornitomorfo, non del tutto umano, cessa ogni rapporto col “logos”. Vivere la propria vita come Pulcinella può solo significare «per ogni uomo - afferrare la propria impossibilità di vivere ».
Tuttavia Agamben ci consegna anche la risposta a una domanda che tutti ci siamo posti. Qual è, alla fine, il segreto di Pulcinella? Non, come l’uso comune del linguaggio induce a credere, la cosa che tutti sanno. Ma che «nella commedia della vita non vi è un segreto, ma solo, in ogni istante, una via d’uscita».
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- GUARIRE LA NOSTRA TERRA. Pensare un altro Abramo.21 gennaio 2015, di Federico La Sala
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- Viviamo in una guerra civile globale. Un’analisi di Giorgio Agamben (di Donatella Di Cesare)23 febbraio 2015, di Federico La Sala
Viviamo in una guerra civile globale
Un’analisi di Giorgio Agamben che prende le mosse dall’antichità ed evoca le riflessioni di Carl Schmitt e di Thomas Hobbes
I nuovi conflitti hanno perso ogni legame con un territorio. Il terrore avanza, come le lotte fratricide nella polis greca
L’interrogativo. Se la politica è abitata sempre dalla guerra, che si presenta quale fenomeno ricorrente, come si può riuscire a pensare la pace?
La minaccia inedita. Si affaccia sulla scena una figura di combattente irregolare con il quale la radicalizzazione dello scontro non ha più limiti
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera - La Lettura, 22.02.2015)
Che guerra è quella che si combatte in Libia? In Siria? In Ucraina? E nelle numerose aree di conflitto del mondo? Sebbene in alcuni casi gli Stati nazionali svolgano ancora un ruolo di rilievo, appare chiaro che la guerra coinvolge direttamente la popolazione civile. Questo vuol dire che civili sono non soltanto le vittime inermi, ma anche i combattenti. Basti pensare ai miliziani jihadisti, ai peshmerga curdi, agli indipendentisti filo-russi.
La guerra civile sembra essersi diffusa ovunque negli ultimi anni, persino entro i confini europei. Il che conferma una delle grandi intuizioni di Carl Schmitt, formulata in un testo pubblicato a Berlino all’inizio degli anni Sessanta e intitolato Teoria del partigiano (Adelphi). L’autore parla di un nuovo ordine mondiale in cui viene meno il reciproco riconoscimento fra gli Stati sovrani e perciò la guerra non è più né circoscritta né regolamentata. Il nuovo «nomos della terra», la nuova politica dello spazio, deve considerare questo mutamento epocale. Il duello fra gli Stati viene sostituito dalla guerra senza limiti e senza regole, una guerra che criminalizza il nemico fino a volerne l’annientamento. Nella figura del «partigiano», il combattente irregolare, Schmitt vede emergere questo mutamento. Con le sue rappresaglie, il ricorso a ogni mezzo per sopperire alla sua inferiorità militare, il partigiano piega l’esercito regolare alle proprie modalità belliche; così radicalizza la contrapposizione amico-nemico. Per Schmitt non vi è alcun dubbio: guerra e nemico sono due concetti che si sono trasformati, assumendo tratti estremi. Dopo le due grandi guerre mondiali l’«ostilità assoluta» è destinata a divenire fenomeno planetario.
Quel che ha inciso profondamente sulla guerra, sul suo carattere e sulle sue forme, è la tecnica. L’apocalisse nucleare è lo sfondo minaccioso delle tante guerre, ammantate di delega, e dissimulate con la procura, che si combattono nell’intento paradossale di prevenire all’infinito la catastrofe. Ma la tecnica ha modificato anche condizioni e modi dell’intervento militare. Si può combattere a distanza, e colpire su scala globale, senza neppure venire in contatto con il nemico. Il drone è oggi il simbolo del nuovo high tech che ha inaugurato la guerra senza volto.
Che ne è allora del partigiano di Schmitt? La tecnica ne recide il legame con la terra, ma non ne cancella la figura: il partigiano autentico, una volta sradicato, diventa il combattente che può operare ovunque e la cui irregolarità, prima mitigata dalla difesa del proprio territorio, diventa aggressività senza fine. Schmitt non poteva sapere del terrorista. Eppure intuì quel che sarebbe avvenuto di lì a poco: mentre si legittimava, anche giuridicamente, il partigiano, si affacciava sulla scena della storia un’altra figura di combattente irregolare, il terrorista, con il quale la radicalizzazione dello scontro sarebbe giunta a una guerra senza limiti.
Non si esagera dicendo che la globalizzazione è il mondo in guerra. Nell’epoca del terrore la guerra si diffonde; non ha più frontiere. Gli eventi bellici si moltiplicano, realizzandosi in spazi e tempi differenti.
Ogni conflitto potrebbe dar luogo a una deflagrazione cosmica, perché si accende nel disordine planetario che non lo contiene, ma piuttosto lo asseconda. La guerra globale fa saltare i confini fra militare e civile, esterno e interno, criminale e nemico. Al punto che, sotto il profilo concettuale, diventa difficile distinguere persino tra guerra e terrorismo.
Stasis. La guerra civile come paradigma politico (Bollati Boringhieri) è il titolo del libro di Giorgio Agamben uscito in questi giorni. Il volume, che fa parte dell’opera complessiva Homo sacer (II, 2), contiene i testi di due seminari tenuti all’Università di Princeton. Che cos’è la guerra civile? Per rispondere a questa domanda, Agamben risale per un verso al pensiero greco, per l’altro alla riflessione di Thomas Hobbes.
Le guerre degli ultimi anni, che non sono più conflitti internazionali, hanno indotto molti studiosi a parlare di internal wars o di uncivil wars - guerre interne o «incivili». Perché sembrano dirette non alla trasformazione del sistema politico, ma solo a rendere più acuto e esteso il disordine. Mentre si è affermata l’esigenza di gestire i conflitti, è stata trascurata la questione della guerra civile.
Non si può dire che i filosofi non abbiano mai riflettuto su questo tema. Tuttavia manca una dottrina della guerra civile. Il che è tanto più eclatante di fronte al diffondersi della «guerra civile mondiale» - un’espressione usata sia da Schmitt sia da Hannah Arendt. Proprio Arendt, che distingue la rivoluzione dalla stasis, cioè dalla «discordia civile che tormentò la polis greca», nel suo libro Sulla rivoluzione (Einaudi) ha contribuito a mettere in ombra la guerra civile.
La stasis, nella Grecia classica, ha un suo luogo preciso: si situa tra la famiglia e la città, fra l’oikos e la polis. La «guerra familiare» - come la chiama Platone - investe tragicamente la città; non viene dall’esterno, ma nasce dai legami di parentela. Questo vuol dire che l’ordine politico della città è costantemente minacciato dall’interno, dalla discordia tra fratelli, dalla «guerra in casa».
Agamben, però, non accetta di vedere nella guerra civile un semplice segreto di famiglia. Altrimenti non sarebbe un paradigma politico. Ecco perché la sposta, ne fa la soglia tra la famiglia e la città. Quando la discordia si scatena, il fratello uccide il fratello come se fosse un nemico. La guerra civile non permette più di distinguere l’intimo e l’estraneo, il dentro e il fuori, la casa e la città, la parentela di sangue e la cittadinanza. In tal modo «il legame politico si trasferisce all’interno della casa nella stessa misura in cui il vincolo familiare si estranea in fazione». La stasis non è allora guerra in famiglia. Piuttosto funziona «in modo simile allo stato di eccezione», lo stato, cioè, in cui il diritto è sospeso. Così Agamben salvaguarda la irregolarità della guerra civile.
Ciò appare chiaro anche nella lettura dei testi di Hobbes, in particolare del Leviatano. Che cos’è un popolo? A questa domanda, molto dibattuta nella filosofia contemporanea, Agamben risponde con Hobbes: una volta unito nel sovrano, o nell’assemblea democratica, il popolo resta infatti moltitudine. Non è la moltitudine disunita, che precede il patto, ma è piuttosto la «moltitudine dissolta» dal cui interno può scaturire il conflitto. Sta qui la minaccia della guerra civile, che è quindi sempre possibile.
Per Agamben la forma che la guerra civile ha assunto oggi è il terrorismo. Proprio quando la città prende le sembianze rassicuranti della famiglia, la «casa Europa» o «il mondo come assoluto spazio della gestione economica globale», la guerra civile diventa il paradigma di ogni conflitto e assume la figura del terrore.
Molti sono gli interrogativi che restano aperti. Pur se accomunate dalla violenza planetaria, come differiscono le varie forme di terrorismo globale? Esiste una peculiare teologia politica della guerra civile che - come ha suggerito lo storico Dan Diner - influisce sull’islam radicale? E se la politica è abitata sempre dalla guerra, che si presenta come un fenomeno ricorrente, come può essere pensata in modo non ingenuo la pace?
-
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" --- LEGITTIMITA’ E LEGALITA’. La Chiesa in questione fin dalla sua radice (di G. Agamben - Cosa insegna alla politica la rinuncia di Ratzinger).20 febbraio 2013, di Federico La Sala
Cosa insegna alla politica la rinuncia di Ratzinger
di Giorgio Agamben (la Repubblica, 16 febbraio 2013)
La decisione di Benedetto XVI deve essere considerata con estrema attenzione da chiunque abbia a cuore le sorti politiche dell’umanità.
Compiendo il “gran rifiuto”, egli ha dato prova non di viltà, come Dante scrisse forse ingiustamente di Celestino V, ma di un coraggio, che acquista oggi un senso e un valore esemplari. Deve essere evidente per tutti, infatti, che le ragioni invocate dal pontefice per motivare la sua decisione, certamente in parte veritiere, non possono in alcun modo spiegare un gesto che nella storia della Chiesa ha un significato del tutto particolare.
E questo gesto acquista tutto il suo peso, se si ricorda che il 4 luglio 2009, Benedetto XVI aveva deposto proprio sulla tomba di Celestino V a Sulmona il pallio che aveva ricevuto al momento dell’investitura, a prova che la decisione era stata meditata.
Perché questa decisione ci appare oggi esemplare? Perché essa richiama con forza l’attenzione sulla distinzione fra due principi essenziali della nostra tradizione etico-politica, di cui le nostre società sembrano aver perduto ogni consapevolezza: la legittimità e la legalità.
Se la crisi che la nostra società sta attraversando è così profonda e grave, è perché essa non mette in questione soltanto la legalità delle istituzioni, ma anche la loro legittimità; non soltanto, come si ripete troppo spesso, le regole e le modalità dell’esercizio del potere, ma il principio stesso che lo fonda e legittima.
I poteri e le istituzioni non sono oggi delegittimati, perché sono caduti nell’illegalità; è vero piuttosto il contrario, e cioè che l’illegalità è così diffusa e generalizzata, perché i poteri hanno smarrito ogni coscienza della loro legittimità.
Per questo è vano credere di potere affrontare la crisi delle nostre società attraverso l’azione - certamente necessaria - del potere giudiziario: una crisi che investe la legittimità, non può essere risolta soltanto sul piano del diritto. L’ipertrofia del diritto, che pretende di legiferare su tutto, tradisce anzi, attraverso un eccesso di legalità formale, la perdita di ogni legittimità sostanziale.
Il tentativo della modernità di far coincidere legalità e legittimità, cercando di assicurare attraverso il diritto positivo la legittimità di un potere, è, come risulta dall’inarrestabile processo di decadenza in cui sono entrate le nostre istituzioni democratiche, del tutto insufficiente.
Le istituzioni di una società restano vive solo se entrambi i principi (che, nella nostra tradizione, hanno anche ricevuto il nome di diritto naturale e diritto positivo, di potere spirituale e potere temporale) restano presenti e agiscono in essa senza mai pretendere di coincidere.
Per questo il gesto di Benedetto XVI è così importante. Quest’uomo, che era a capo dell’istituzione che vanta il più antico e pregnante titolo di legittimità, ha revocato in questione col suo gesto il senso stesso di questo titolo. Di fronte a una curia che, del tutto dimentica della propria legittimità, insegue ostinatamente le ragioni dell’economia e del potere temporale, Benedetto XVI ha scelto di usare soltanto il potere spirituale, nel solo modo che gli è sembrato possibile: cioè rinunciando all’esercizio del vicariato di Cristo. In questo modo, la Chiesa stessa è stata messa in questione fin dalla sua radice.
Non sappiamo se la Chiesa sarà capace di trarre profitto da questa lezione: ma sarebbe certamente importante che i poteri laici vi trovassero occasione per interrogarsi nuovamente sulla propria legittimità.
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- LA "DONAZIONE DI PIETRO": SAN PAOLO, IL ’PARTITO’ SACERDOTALE RICOSTITUITO E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO.29 gennaio 2013, di Federico La Sala
 ARMIAMOCI E PARTITE: CONQUISTATE LA TERRA! SAN PAOLO, IL ’PARTITO’ SACERDOTALE RICOSTITUITO E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO ROMANO.
ARMIAMOCI E PARTITE: CONQUISTATE LA TERRA! SAN PAOLO, IL ’PARTITO’ SACERDOTALE RICOSTITUITO E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO ROMANO.
 LA "DONAZIONE DI PIETRO" - PAOLO: "come Platone (...), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli, delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo dei pagani e, da cittadino romano, la porta e consegna nelle mani di Roma (...)
LA "DONAZIONE DI PIETRO" - PAOLO: "come Platone (...), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli, delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo dei pagani e, da cittadino romano, la porta e consegna nelle mani di Roma (...)
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA E A TUTTA LA TERRA..21 novembre 2012, di Federico La Sala
CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione... e anche la maschera
 IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA. Una nota su un incontro del 2005 e sugli eventi successivi, fino ad oggi
IL PAPATO DI BENEDETTO XVI: SETTE ANNI DI OFFESE ALLA CHIESA E ALL’ITALIA. Una nota su un incontro del 2005 e sugli eventi successivi, fino ad oggiCOSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
IL SOGNO DI UNA "COSA" DI BENEDETTO XVI: UNA CHIESA "PER MOLTI", NON "PER TUTTI".
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA .... IN COSA CREDIAMO? Giorgio Agamben segue Foucault ma, senza Kant, rimane nella trappola di San Paolo (di Franco Marcoaldi - intervista).9 febbraio 2011, di Federico La Sala
 VITA, VERITA’, E VIA: METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO: IL RITORNO A KANT (A UN ALTRO KANT - MAI CONOSCIUTO). UN OMAGGIO ALLA MEMORIA DI MICHEL FOUCAULT ..
VITA, VERITA’, E VIA: METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO: IL RITORNO A KANT (A UN ALTRO KANT - MAI CONOSCIUTO). UN OMAGGIO ALLA MEMORIA DI MICHEL FOUCAULT ..
 UNA NUOVA ETICA PER UNA NUOVA POLITICA E UNA NUOVA TEOLOGIA. Giorgio Agamben segue Foucault ma, senza Kant, rimane nella trappola di San Paolo. Un’intervista di Franco Marcoaldi - con note,di Federico La Sala
Riscopriamo l’etica. Agamben: "L’etica non significa obbedire a un dovere, significa mettersi in gioco: in ciò che si pensa, si dice e si crede".
UNA NUOVA ETICA PER UNA NUOVA POLITICA E UNA NUOVA TEOLOGIA. Giorgio Agamben segue Foucault ma, senza Kant, rimane nella trappola di San Paolo. Un’intervista di Franco Marcoaldi - con note,di Federico La Sala
Riscopriamo l’etica. Agamben: "L’etica non significa obbedire a un dovere, significa mettersi in gioco: in ciò che si pensa, si dice e si crede".
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. Un discorso pronunciato presso la cattedrale di Notre-Dame a Parigi l’8.3.2009 - a cura di Federico La Sala26 dicembre 2010
 ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E TEOLOGICA: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS". ITALIA, NATALE 2010: AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2010).
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E TEOLOGICA: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS". ITALIA, NATALE 2010: AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2010).
 ITALIA, NATALE 2010 d. C.: ARCHEOLOGIA EVANGELICA E COSTITUZIONALE.
ITALIA, NATALE 2010 d. C.: ARCHEOLOGIA EVANGELICA E COSTITUZIONALE.
-
> "IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- LA CHIESA AL BIVIO (di Goffredo Fofi - Una predica per la chiesa).16 maggio 2010, di Federico La Sala
Una predica per la chiesa
di Goffredo Fofi (l’Unità, 16 maggio 2010)
Nei confronti della chiesa, credo che gli italiani, anche i più esigenti, oscillino da sempre tra una superficiale riverenza e una superficiale irriverenza, e che in ogni caso molti non sappiano farne a meno e tutti la considerino una presenza storicamente inevitabile. Fa parte del nostro paesaggio, da secoli, volere o volare, e fa parte, direttamente e indirettamente, dell’esperienza di tutti o quasi tutti, i credenti come i non credenti. Credenti? Secondo la dottrina, mi pare che per dirsi tali bisognerebbe almeno credere nella presenza vera del corpo di Cristo nell’ostia e nella resurrezione dei corpi. E quanti italiani potrebbero onestamente dire di crederlo?
Nelle società antiche, i membri della tribù, della comunità o di una più ampia società si distinguevano, dicono etnologi e antropologi, secondo un tripartizione classica: i contadini, i guerrieri, i sacerdoti (di essa trovo tracce perfino nella festa del mio paese, nella Corsa dei Ceri che si svolge da non so quanti secoli a Gubbio, il 15 di maggio e cioè ieri, e a correre c’ero anch’io).
Ogni società aveva e ha bisogno di coloro che «amministrano i sacramenti» e cercano di dare un senso all’esistenza dei singoli, che danno verticalità - non so dire altrimenti - alla nascita e morte e alle altre scadenze dell’umano tragitto, alle scelte dei singoli e dei gruppi, ai momenti di festa e di lutto dei singoli e dei gruppi. Una ragion d’essere della chiesa dovrebbe dunque essere di accompagnare nel corso dell’esistenza, rispondendo ai bisogni di senso che singoli e comunità esprimono inevitabilmente, tanto più quanto meno ci pensano gli altri - i governanti, i politici, i «guerrieri».
Anni fa, discutendo del fallimento del comunismo e parlando di Pasolini e di Testori si disse che un errore primario di quella storia fu il rifiuto di considerare nel loro enorme peso i due aspetti fondamentali del corpo e del sacro. È opinabile che la chiesa si occupi oggi seriamente di questo, basti pensare all’accumulo di pregiudizi e chiusure che ne caratterizza il confronto con le novità dei comportamenti creati dalle mutazioni che abbiamo dovuto subire. Per dire: alla crisi della famiglia si risponde invece che sacralizzando le nuove forme che cercano di sostituirla «di fatto» perpetuandola, demonizzandole; al problema della sovrappopolazione si risponde con l’ossessione anti-pillola; alle sante richieste dell’ecologia, con il disprezzo, per esempio, per il vegetarianesimo e per altre cose che conseguono all’ossessione antropocentrica per cui tutto il creato e tutte le creature hanno per scopo la soddisfazione dei presunti bisogni dell’uomo che, manipolati dall’economia e dai suoi poteri, vengono spinti oggi verso una crescente turpitudine; eccetera.
Ciò di cui siamo grandemente debitori nei confronti della chiesa, è invece che essa ricordi al mondo, sempre, il rispetto dei poveri, che in Italia vuol dire oggi, per esempio, il rispetto per gli immigrati. Se non lo facesse, tradirebbe la sua matrice cristiana. E se non ci fosse, l’Italia in mano oggi ai politici e ai mascalzoni dell’impresa pubblica e privata, sarebbe perfino peggiore di ciò che è. La chiesa esiste da secoli e secoli, e se ha retto a mille trasformazioni una ragione ci dovrà pur essere, anche per chi non considera la provvidenza...
Se non ci fosse la chiesa, staremmo molto peggio, io credo. Ma la chiesa è a un bivio, che è proprio di civiltà, di assunzione chiara di responsabilità verso il futuro. È forse la sola istituzione, qui, che nonostante tutto sembra preoccuparsi delle cose gravi e di fondo. Lo fa male per mille motivi, primo fra tutti una certa scarsità morale e non solo culturale della maggior parte di chi vi comanda, cardinali e vescovi.
Per questo mi ha impressionato e convinto l’opuscolo edito da Nottetempo di cui consiglio la lettura, «La Chiesa e il Regno», che è una specie di predica tenuta dall’autore dentro Notre Dame a Parigi su richiesta di quei parrocchiani. Costa tre euro, l’ha scritto Giorgio Agamben, che è il più noto e apprezzato dei nostri filosofi all’estero (meno in Italia, per ragioni che sarebbe lungo elencare). È - rispettoso ed esigente - di una chiarezza, di una misura, di una radicalità ammirevoli. Così conclude: «La domanda che sono venuto qui a porvi, senza avere, per farlo, altra autorità se non un’ostinata abitudine a leggere i segni del tempo, è questa: la Chiesa si deciderà finalmente a cogliere la sua occasione storica e a ritrovare la sua vocazione messianica? Il rischio, altrimenti, è che sia trascinata nella rovina che minaccia tutti i governi e tutte le istituzioni della terra».
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA (EMIL FACKHENEIM, 1970). "TIQQUN. RIPARARE IL MONDO" (EMIL FACKENHEIM, 1982).18 febbraio 2010, di Federico La Sala
 “È fatto divieto agli ebrei di concedere a Hitler vittorie postume”
“È fatto divieto agli ebrei di concedere a Hitler vittorie postume”
 614ma norma del canone ebraico istituita da Emil Fackenheim, in La presenza di Dio nella storia
614ma norma del canone ebraico istituita da Emil Fackenheim, in La presenza di Dio nella storiaAuschwitz: una sfida per la fede di Israele
La presenza di Dio nella Storia, di Emil Fackenheim, uscì nel 1970. Al centro della riflessione dell’autore sta la crisi di tutte le precedenti categorie utilizzabili, per spiegare la sofferenza di Israele. Ciò nonostante, Fackenheim conclude in modo imperativo affermando che non si deve abbandonare la fede dei Padri: chi lo facesse, concederebbe a Hitler una clamorosa vittoria postuma. *
È chiaro che il lungo silenzio teologico era necessario. Il silenzio sarebbe forse la cosa migliore anche se non fosse per il fatto che le barriere tra le nazioni sono infrante e che per questa sola ragione il tempo del silenzio teologico è irrimediabilmente passato.
Ma cominciare a parlare significa mettere radicalmente in questione alcune dottrine midrashiche [= tipiche della tradizione ebraica - n.d.r.] onorate nel tempo; e tra queste una è immediatamente sconvolta. Come abbiamo visto, anche gli antichi rabbini furono costretti a sospendere il biblico “siamo puniti per i nostri peccati”, forse non in risposta alla distruzione del tempio da parte di Tito ma alla paganizzazione di Gerusalemme da parte di Adriano. Anche noi possiamo al più lasciare momentaneamente in sospeso la dottrina biblica solo per il fatto che, come i rabbini, non possiamo né negare i nostri peccati né isolarli dalla storia. Eppure dobbiamo sospenderla. Perché, comunque noi giriamo e rigiriamo tale dottrina in risposta ad Auschwitz, essa diventa un’assurdità religiosa e addirittura un sacrilegio.
“Peccato” ed “espiazione” devono assumere una connotazione individuale? Che idea sacrilega, quando si pensi che tra le vittime dei nazisti vi furono più di un milione di bambini! Dobbiamo dar loro una connotazione collettiva? Che idea terribile, se si pensa che non furono le nostre comunità ebraiche, occidentali, agnostiche, infedeli e ricche, ma quelle più povere, devote e fedeli che furono più duramente colpite! Quando nel nostro tormento ci rivolgiamo in un ultimo tentativo alla dottrina tradizionale per cui tutti gli israeliti di tutte le generazioni sono responsabili l’uno per l’altro, noi continuiamo a sentirci completamente sconcertati perchè non un solo dei sei milioni morì perché esso non mantenne il patto divino-ebraico: essi morirono tutti perché i loro nonni lo avevano rispettato, al limite solo per aver allevato bambini ebrei. Ecco il punto in cui tocchiamo l’assurdo religioso radicale. Ecco lo scoglio contro il quale naufraga senza rimedio l’idea che “siamo puniti per i nostri peccati”.
Ma allora gli ebrei morirono forse ad Auschwitz per i peccati degli altri? Il fatto è evidentemente abbastanza ovvio, ed è sempre più evidente che questi atti corrispondevano ai criminali nazisti. Il problema sta però nel sapere se si può scoprire in questo fatto un significato religioso, se noi, come tante generazioni precedenti, possiamo far ricorso all’idea del martirio. [...] Può ancora confortare la coscienza ebraica dopo Auschwitz? Quando le bande dei crociati si scatenarono contro gli ebrei delle città renane di Worms e Magonza (1096 d. C.) esse offrirono loro in teoria, se non in pratica, la scelta tra morte e conversione permettendogli quindi di scegliere il martirio. Ad Auschwitz, invece, non ci fu scelta; vecchi e giovani, fedeli e non fedeli furono sterminati senza discriminazione. Vi può essere martirio quando non vi è scelta? [...] Auschvitz fu il tentativo supremo, il più diabolico che sia mai stato fatto di uccidere lo stesso martirio e di privare ogni morte, compreso il martirio, della sua dignità. [...]
Che cosa comanda la voce di Auschwitz?
Gli ebrei non hanno il diritto di concedere a Hitler delle vittorie postume. Essi hanno il dovere di sopravvivere come ebrei, perché il popolo ebreo non abbia a perire. Essi non hanno il diritto di disperare dell’uomo e del suo mondo e di trovare rifugio sia nel cinismo sia nell’aldilà, se non vogliono contribuire ad abbandonare il mondo alle forze di Auschwitz. Infine essi non hanno il diritto di disperare del Dio di Israele, perché l’ebraismo non perisca. Un secolarista ebreo non può trasformarsi in un credente per un semplice atto di volontà, né gli si può imporre di farlo... Ed un ebreo religioso che è stato fedele al suo Dio può essere costretto ad un nuovo rapporto magari rivoluzionario con lui. Una possibilità comunque è del tutto impensabile. Un ebreo non può rispondere al tentativo di Hitler di distruggere l’ebraismo cooperando egli stesso a tale distruzione. Nei tempi antichi il peccato impensabile per gli ebrei era l’ateismo. Oggi consiste nel rispondere a Hitler compiendo la sua opera.
* E. L. Fackenheim, La presenza di Dio nella storia. Saggio di teologia ebraica, Brescia, Queriniana, 1977, pp. 97-99 e 111-112
 Esce in Italia il saggio di Emil Fackenheim che indaga come ricucire le ferite provocate nella storia dai totalitarismi
Esce in Italia il saggio di Emil Fackenheim che indaga come ricucire le ferite provocate nella storia dai totalitarismi
Riparare il mondo dopo la Shoah
Non serve a nulla demonizzare il pensiero anti-umano: quel che occorre è salvarlo, purificarlo dalle sue patologie in un vasto programma educativo
di PAOLA RICCI SINDONI (Avvenire, 13.02.2010)*.
Strani destini regolano, a volte, la vita dei libri, messaggeri potenti e silenziosi dei loro creatori: alcuni messi rapidamente nel circolo dell’industria editoriale che ne segna la fama, altri, meno fortunati e trascurati, anche se grandi, rischiano di cadere nell’oblio. È questo il caso di Emil Fackenheim (1916-2003), filosofo ebreo-tedesco di altissimo livello, rifugiatosi - dopo la persecuzione e l’internamento - in Canada, dove visse per quarant’anni prima di trasferirsi nel 1983 a Gerusalemme. Solo nel 1977 è apparso in Italia un piccolo e denso saggio, La presenza di Dio nella storia, e poi nulla, sino ad oggi quando esce nelle librerie, per i tipi della Medusa di Milano, il suo capolavoro del 1982: Tiqqun - Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah.
Un libro splendido, ricco di suggestioni e di sane provocazioni alla filosofia e alla teologia, opera che non si può che avvicinare ad altri classici del ’900, come La stella della redenzione di Franz Rosenzweig o Totalità e infinito di Emmanuel Lévinas, come giustamente nota Massimo Giuliani nella sua intensa prefazione. Né si pensi che queste riflessioni che intrecciano filosofia, storia, politica e teologia, appartengano solo all’ebraismo, siano cioè circoscritte ai superstiti e alla loro capacità di sopravvivenza, dal momento che sono legate alla grande questione di come curare le ferite della ragione, del pensiero, della cultura umanistica e della civiltà occidentale, che non solo non hanno previsto Auschwitz, ma che non possono passare indenni dentro quell’immane disastro.
È lo stesso Fackenheim a chiamare in causa, in questo serrato confronto con alcuni protagonisti del pensiero filosofico, da Kant a Hegel, da Spinoza a Rosenzweig e a Heidegger, la necessità di una riprova storica non tanto con la memoria ferita dei sopravvissuti, quanto con la responsabilità dei loro carnefici, quei tedeschi, in prevalenza cristiani, che hanno collaborato consapevolmente alla costruzione dell’orribile macchina burocratica e tecnologica dell’annientamento degli ebrei.
L’urgenza di ’riparare’ questa enorme frattura dentro il mondo consiste perciò non nel demonizzare quel pensiero cercando altre alternative, ma nel doverlo salvare, purificare dalle sue stesse patologie, coinvolgendo in un vasto programma educativo e culturale cristiani, ebrei e tedeschi delle nuove generazioni, insieme volti a neutralizzare quelle spinte negative, culminate ad Auschwitz, luogo simbolico del nichilismo fattosi esperienza storica antiumana per milioni di persone e per lunghi anni. Per evitare il ripetersi di simili tragedie, che oggi potrebbero ancora colpire Israele nella sua stessa necessità di sopravvivenza come Stato, bisogna in primo luogo stare dentro la storia, sfuggendo ad ogni tentazione teoretica di leggerla con gli occhi impoveriti del pensiero astratto.
Da qui la tensione etica che promana da questo libro, in cui finalmente Fackenheim riesce a trovare una sintesi coraggiosa e sofferta fra le due anime che lo abitavano, i due ’cappelli’, che di volta in volta era chiamato ad indossare (come icasticamente dirà nella sua Autobiografia, fra poco in uscita per Giuntina): da una parte l’esigenza di redimere l’’età d’oro’ della filosofia classica tedesca che da Kant sino a Hegel ha disegnato il volto della cultura umanistica occidentale, ma che è apparsa impotente a fornire antidoti contro l’inumano che ha avvolto i lager, dall’altro la teologia ebraica, custodita negli anni durante gli studi a Berlino per il rabbinato e che sembrava rappresentare l’unica forma di custodia di sé, oltre gli orrori della storia.
Questi due ’cappelli’ non potevano che rinvenire un momento di felice sintesi in questa opera, dove la forma simbolico-cabalista del tikkun (secondo cui al momento della creazione scintille divine si sono sperdute nel mondo, fuoriuscite dalla rottura dei vasi che le contenevano) riesce a disegnare la forza d’urto del bene che va ricostruito dentro le oscurità del pensiero e della storia.
Quando nel 1967, durante la Guerra dei Sei giorni, gli israeliani hanno tremato ancora per la loro sopravvivenza, si è tragicamente compreso come ancora ’tutto’ poteva accadere di nuovo, che il male sconfitto covava dentro la storia, che i morti nei lager rischiavano davvero di essere morti invano, che il nazismo poteva guadagnare la sua vittoria postuma.
Nasce da questo nuovo sussulto del male storico l’esigenza a moltiplicare le energie morali per una nuova opera di resistenza verso tutte le forme di disumanizzazione dell’umano, per costruire un fronte comune dove ebrei e cristiani, soprattutto, lavorino insieme per aggiustare il mondo e renderlo più abitabile per tutti.
Molta letteratura ebraica sulla Shoah sembra ancora incapace di individuare forme di identità comune, oscillando fra la soluzione ’confessionale’ della comunità religiosa, unita nell’identità del Patto che ancora vive fra Israele e il suo Signore, e la soluzione ’politica’ e laica che oggi sostiene lo Stato e le sue istituzioni. Per Fackenheim però né supremazia né contraddizione fra questi due poli, perché è la storia, ancora una volta, a dettare il suo verdetto.
Ricorda al riguardo un drammatico episodio, avvenuto il giorno dello scoppio della Guerra dei Sei giorni. Era la festa di Yom Kippur e moltissimi si trovavano in sinagoga a pregare, quando i giovani, richiamati immediatamente alle armi, correvano per raggiungere le loro postazioni. Fu allora che alcuni anziani a Gerusalemme interruppero le loro preghiere, corsero fuori e strappando i loro libri sacri, donarono fogli sparsi ai soldati in partenza. Da parte loro - nota Fackenheim - i militari non esitarono ad accettare il dono, sia che fossero religiosi o laici: «A Yom Kippur alcuni combatterono perché altri potessero pregare, e alcuni pregarono perché altri potessero combattere». Un modo intenso e tragico per ridire la forza della volontà di sopravvivere insieme e di restituire al mondo una lezione di resistenza al male, oltre le divisioni, oltre le ricadute.
*
 Emil Fackenheim
Emil Fackenheim
 TIQQUN
TIQQUN
 Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah
Riparare il mondo. I fondamenti del pensiero ebraico dopo la Shoah
 Medusa. Pagine 300. Euro 24,50.
Medusa. Pagine 300. Euro 24,50.-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- NEGARE AL FARAONE LA VITTORIA POSTUMA. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.21 aprile 2010, di Federico La Sala
-
> "IL TEMPO CHE RESTA" ---- --- "OLOCAUSTO" DI EMIL FACKHENEIM. La sofferta e incerta conoscenza di un genocidio da collocare nella Storia (di Marco Pacioni).27 gennaio 2012, di Federico La Sala
La sofferta e incerta conoscenza di un genocidio da collocare nella Storia
di Marco Pacioni (il manifesto, 27 gennaio 2012)
La filosofia occidentale si è sempre nutrita della propria voce, come ha criticamente ribadito, non da ultimo, Jacques Derrida in Timpano. Gli eventi esterni hanno potuto fare poco per distoglierla dall’ascoltare soprattutto se stessa. La Shoah, anche in questo specifico argomento, segna una rottura. Non solo rende difficile rintonare il pensiero alla malia della propria voce, ma mette addirittura in discussione la stessa possibilità della filosofia e, in modo specifico, dell’etica. Sul rapporto del pensiero al cospetto della Shoah si è sviluppata un’ampia ricerca che ha all’attivo una consistente bibliografia.
In questo ambito, di particolare importanza sono i testi nei quali chi svolge la riflessione è anche la persona che ha fatto esperienza diretta del campo di concentramento come accade con il sopravvissuto, filosofo e teologo Emil L. Fackenheim, del quale ci si è iniziato ad interessare anche in Italia come attestano le recenti pubblicazioni di Tiqqun. Riparare il mondo (Medusa) e Un epitaffio per l’ebraismo tedesco(Giuntina). A questi libri si deve ora aggiungere il testo Olocausto (Morcelliana, a cura di Massimo Giuliani, pp. 55, euro 8) nel quale Fackenheim (1916 - 2003) affronta in modo più sintetico temi svolti in maniera più distesa ed elaborata in Tiqqun.
La questione di come pensare la Shoah coinvolge argomenti quali la memoria, la testimonianza, la rappresentazione, la divinità. Tutti questi aspetti vengono affrontati lungo un crinale che spesso cede alle idee d’indicibilità, unicità, impensabilità di cui Auschwitz è diventato il luogo per eccellenza e che in ragione di ciò è spesso utilizzato del tutto fuori contesto ogni qualvolta che si deve evocare un inarrivabile culmine di mostruosità. Il paradigma dell’indicibilità non è soltanto evocato, ma anche altrettanto spesso utilizzato contro quelle ricognizioni storiografiche, filosofiche nonché contro opere letterarie e film che invece cercano di trovare un modo per parlare della Shoah.
Sotto questo profilo, il libro di Fackenheim può essere considerato come una riflessione che esprime una posizione moderata da inserire nel versante che vede con favore la rappresentabilità e dunque la pensabilità della Shoah. Fackenheim ritiene che la Shoah sia un «evento unico» nella e non della storia, tale da configurare una sorta di sommità metafisica con tutto ciò che ne consegue in termini religiosi e sacrali. A tal proposito il filosofo scrive che «non si può negare, certo, che Auschwitz sia stato "un altro pianeta", ossia che si sia trattato di un mondo a parte con leggi, codici di comportamento e persino un linguaggio in proprio. Con tutto ciò, e pur essendo senza precedenti, piuttosto che unico, esso va fermamente situato nella storia».
Proprio perché è un evento nella storia, per l’autore la Shoah può essere definita come «un genocidio». (È da notare che questa espressione compare significativamente anche come sottotitolo del recente e importante libro dello studioso americano Donald Bloxham, Lo sterminio degli Ebrei, Einaudi). Per Fackenheim, la Shoah manterrà sempre degli elementi difficili da comprendere e immaginare, ma ciò non inficia completamente la possibilità per noi e le generazioni future di rapportarsi a essa. Anzi, su questo aspetto sta uno degli spunti più importanti del libro di Fackenheim e cioè che la Shoah vada affrontata anche prendendo in considerazione proprio il «noncomprendere», ossia un capire non totalizzante, un conoscere che non vuole chiudersi in un sapere assoluto. Qui Fackenheim sembra raccogliere la critica alla forza soffocante del comprendere di Bataille, Lévinas, Jankélévitch e trattare paradossalmente come una risorsa positiva anziché come un ostacolo lo stesso non-comprendere: forma aperta che proprio grazie alla sua impersuasione agisce come pungolo della memoria che stimola a colmare e non solo a subire le lacune della conoscenza.
Se per Fackenheim conoscere non è sinonimo di sapere, è però certamente sinonimo di costruire, riparare e cioè agire per il futuro. In questa idea sta l’altro elemento cospicuo della conoscenza applicata alla Shoah di Fackenheim che sottolinea l’importanza di proiettare nel futuro gli elementi che si hanno a disposizione dal passato e non risospingerli soltanto indietro con il rischio di allontanarli troppo dal presente.
Meno audaci invece e pericolosamente ancora tentate dall’orizzonte della sacralità della Shoah, sono le sue argomentazioni teologiche che sfociano poi nella politica: «Dopo tali eventi, porre fine all’esilio significa esprimere una volontà e fedeltà alla vita. Il prodotto di tale fedeltà - lo Stato ebraico - è ancora fragile e in un mondo che fatica comunque a capire. Se sull’onda dell’Olocausto non fosse già sorto uno Stato ebraico, sarebbe una necessità religiosa crearlo ora».
-
-
> A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- Liliana Cavani e Emma Fattorini chiedono una marcia ("sin-odo") sul corpo della donna!!!29 dicembre 2009, di Federico La Sala
Un sinodo sulla donna?
di Liliana Cavani e Emma Fattorini (Il Sole-24 Ore, 27 dicembre 2009)
Una domanda pacata ma radicale: perché le diverse componenti che animano la chiesa, divise su tanti aspetti, hanno però in comune uno stupefacente silenzio sulla donna? Un richiamo stanco e di maniera, frutto più di rivendicazioni esterne che non di una convinzione vera, quale sarebbe logico di fronte a un così evidente segno dei tempi?
Le ragioni sono tante e come sempre quasi tutte dettate da paura. Forse però non aiuta una fìdes che, pur riconoscendo giustamente le «ragioni della ratio», finisce con il trascurare troppo la dimensione dell’esperienza, della relazione personale e in ultimo del corpo e della sua vita. Nella sua concreta incarnazione nell’uomo e nella donna, come ci ricordava Wojtyla, nei troppo dimenticati discorsi sul corpo che teneva i mercoledì mattina. Con quale «ragione», con quale pensiero laico e razionale il cristiano oggi è invitato ad aprirsi e a misurarsi?
Con una ragione e una teologia troppo disincarnata che non vede la verità nell’esperienza religiosa fatta dall’incontro con Cristo come persona. La paura del soggettivismo-relativismo rischia di fare perdere la ricchezza spirituale che c’è nell’entrare in contatto con il Signore anche con il corpo, con le emozioni, con tutta la propria persona e non solo con la testa, non solo con il pensiero. E così si perde quell’unità della persona che deve unificare e non separare le diverse esperienze umane.
Non si può certo dire che siano state onorate le aspettative suscitate dalle parole che Giovanni Paolo II aveva dedicate alle donne, parlando di «genio femminile», una visione poi approfondita da Joseph Ratzinger. La grande novità delle affermazioni contenute nella Mulieris dignitatem, non stava tanto nel riconoscere la parità della donna con l’uomo, ma nel capire finalmente che la donna, senza più camuffare la sua più profonda identità, poteva e doveva essere protagonista, con pari dignità alla costruzione di un mondo condiviso: questa la straordinaria novità di quelle bellissime parole. Non dunque l’ennesimo riconoscimento retorico di una idealizzata e disincarnata essenza femminile, ma la sua concreta promozione nella società senza svisarne la sua intima identità. Tutto ciò avrebbe richiesto un maggiore "investimento" sulle donne e non il contrario. Non c’entra nulla la rivendicazione del sacerdozio femminile. Non è questo che le donne chiedono. E altra la loro influenza e diverse le loro aspettative, esse mirano direttamente a Dio e non a diventare preti. Non trarre tutte le conseguenze pratiche di come il “genio femminile" possa agire nel mondo non solo impoverisce la chiesa cattolica ma finisce con il tradirne la sua stessa vocazione di civilizzazione; il ruolo della donna infatti è oggi e sarà sempre di più il cuore dei grandi cambiamenti di tutte le culture del mondo, la cartina di tornasole dei loro processi di democratizzazione e di umanizzazione.
Che fare perché ai pur autorevoli riconoscimenti del Magistero seguano finalmente atti di grande portata e concretezza? E troppo ingenuo pensare all’urgenza addirittura di un Sinodo sulla donna?
-
> A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO. --- KARMAN". Giorgio Agamben: "Il vero Karma dell’Occidente" - "(il Dio cristiano non agisce per necessità, come il dio di Aristotele, ma per arbitrium voluntatis)".6 agosto 2023, di Federico La Sala
Giorgio Agamben: "Il vero Karma dell’Occidente" *
Nel suo nuovo libro, “Karman”, il filosofo affronta il tema del rapporto tra un’azione e le sue conseguenze. Un saggio che analizza i fondamenti dell’etica e del diritto, della teologia e delle filosofie orientali
di Chiara Valerio (la Repubblica, 27 agosto 2017)
Se, in questa vita, rispondiamo delle nostre azioni attraverso il sistema delle leggi, e nell’altra ne rispondiamo, secondo il buddismo, attraverso reincarnazioni successive, il motivo sta - scrive Giorgio Agamben nel saggio Karman - nel fatto che morale religiosa, diritto ed etica fondano sul principio per cui ogni azione è legata alle sue conseguenze, e noi, a tale principio, soggiaciamo. Qualche anno fa Agamben ha diviso il mondo in due gruppi. Gli esseri viventi e l’insieme di istituzioni, saperi e pratiche che controllano e orientano i gesti e i pensieri degli esseri viventi: i dispositivi.
- Professore, il diritto - le cui porte, se fosse un edificio sarebbero la causa e la colpa - è un dispositivo al quale sottrarsi?
"Il diritto è una parte troppo essenziale della nostra cultura perché ci si possa semplicemente sottrarre a esso. Altrettanto vero è, però, che la nascita del cristianesimo coincide con una critica implacabile della Legge. È difficile immaginare una obiezione più radicale di quella contenuta nelle affermazioni di Paolo secondo cui senza la legge non ci sarebbe stato il peccato e il messia è la fine e il compimento (il telos) della legge. E, tuttavia, come lei sa, la Chiesa ha pazientemente ricostruito quell’edificio della legge che il cristianesimo primitivo intendeva mettere in questione, anche se puntualmente fenomeni come il francescanesimo hanno rivendicato ogni volta la possibilità di una vita al di fuori del diritto. Io penso che una società vivibile possa risultare solo dalla dialettica di due principi opposti e, in qualche modo, coordinati: il diritto e l’anomia, un polo istituzionale e uno non istituzionale o anarchico - o, per usare le sue espressioni, gli esseri viventi e i dispositivi storici.
 Ciò è evidente nel linguaggio: una lingua viva risulta dalla relazione armonica fra spontaneità (il "parlar materno" di Dante) e regola (la lingua "grammatica" di Dante). Mi sembra che oggi questa dialettica sia dovunque - nella lingua come nei rapporti sociali - distorta o spezzata".
Ciò è evidente nel linguaggio: una lingua viva risulta dalla relazione armonica fra spontaneità (il "parlar materno" di Dante) e regola (la lingua "grammatica" di Dante). Mi sembra che oggi questa dialettica sia dovunque - nella lingua come nei rapporti sociali - distorta o spezzata".- Lei scrive " la volontà agisce come un dispositivo il cui scopo è quello di rendere padroneggiabile ciò che l’uomo può fare". Anche la volontà è un dispositivo al quale sfuggire?
"Nel libro ho cercato appunto di mostrare che il concetto di volontà (quasi sconosciuto al mondo antico) è il dispositivo attraverso il quale la teologia cristiana ha inteso fondare l’idea di un’azione libera e responsabile e quindi imputabile a un soggetto: è il "libero arbitrio", che definisce l’azione umana non meno di quella divina (il Dio cristiano non agisce per necessità, come il dio di Aristotele, ma per arbitrium voluntatis). La volontà è il mistero insondabile che sta alla base di quel concetto di azione legalmente sanzionabile (il crimen- karman) senza il quale l’etica e la politica moderna crollerebbero. Se l’uomo antico è un uomo che può, l’uomo moderno è invece un uomo che vuole. Nel mio libro la critica del primato del concetto di azione procede pertanto di pari passo a una critica del concetto di volontà. Mi ha sempre stupito che da Aristotele a Hannah Arendt l’idea di azione sia sempre rimasta immutabilmente al centro della tradizione dell’occidente. Non so se ci sono riuscito, ma ho comunque provato a spostare altrove il luogo dell’etica e della politica".
- Restiamo sull’evoluzione de " l’uomo che può" ne " l’uomo che vuole". Marina Cvetaeva osservava "Non posso" è il superamento di tutti i miei "non voglio", il correttivo di tutti i miei voleri. Che rapporto dovrebbe esserci tra volontà e potenza, oggi?
"Le rispondo con le parole di un’altra grande poetessa russa. Anna Achmatova racconta che mentre negli anni delle persecuzioni faceva da mesi la fila davanti alla prigione di Leningrado dove era recluso suo figlio, una donna un giorno la riconobbe e le chiese: "può dire questo"? La poetessa tacque per un istante e poi, senza sapere come e perché, sentì affiorarle alle labbra la risposta: "sì, io posso". Che cosa intendeva dire? Non certo che aveva un così grande talento o una così grande padronanza della lingua da poter dire tutto ciò che voleva dire. Quell’"io posso" non si riferiva ad alcuna certezza o abilità e tuttavia la impegnava e metteva integralmente in gioco. È qualcosa del genere che aveva in mente Spinoza quando definisce la letizia più grande accessibile a un uomo come la contemplazione di ciò che egli può fare.
 Per questo la trasformazione cristiana e moderna della potenza in volontà mi sembra deleteria".
Per questo la trasformazione cristiana e moderna della potenza in volontà mi sembra deleteria".- Landau ne " La Fisica per tutti" osserva " Se all’improvviso il fermacarte fa un salto, penserete di avere le traveggole. Se si ripete, vi metterete di lena a cercare la causa che toglie questo corpo dallo stato di quiete. Perciò è naturale considerare razionale il punto di vista secondo cui i corpi in quiete non si spostano senza l’intervento di una forza". È razionale pensare che i corpi umani non si spostino, non compiano azioni, senza l’intervento di un fine?
"Nel libro la critica del fine è inseparabile da quella dell’azione. Uno dei presupposti che siamo abituati a dare per scontati è che ogni azione sia rivolta a un fine e che questo fine sia il bene che l’agente ogni volta necessariamente si propone. In questo modo, poiché il fine è concepito come qualcosa di trascendente o comunque di esterno, il bene viene separato dall’uomo. Come mi sembra più convincente l’idea epicurea secondo la quale nessun organo del corpo umano è stato creato in vista di un fine e ogni cosa che nasce genera nell’uso il suo bene! A furia di gesticolare, la mano trova la sua delizia e il suo uso, l’occhio a furia di guardare si innamora della visione e le gambe, piegandosi a tentoni, inventano la passeggiata. Del resto è quel che vediamo avvenire nei bambini ed è quello che ci suggeriscono le arti come la danza, che non hanno altro fine che la pura esibizione di un gesto, di ciò che un corpo può fare. Per questo ho cercato di sostituire al paradigma dell’azione rivolta a un fine quella del gesto sottratto a ogni finalità".
- Un filosofo ha detto che definire i termini è il momento poetico del pensiero. Come definirebbe il fine?
"Le dò una risposta insieme stoica e zen: il fine è ciò che si raggiunge solo a condizione di non porselo mai".
- Se "agisce contro la legge, chi fa ciò che la legge proibisce" e se " non c’è pena senza colpa", cos’è nata prima, la colpa, la legge o la sanzione?
"Come Paolo aveva capito ("la legge è venuta perché la colpa abbondasse"), ogni giurista intelligente sa che il principio secondo cui "non c’è pena senza colpa" va in realtà rovesciato in quello secondo cui "non c’è colpa senza pena". "Non c’è pena senza colpa" significa che la pena può essere inflitta solo in conseguenza di un certo atto, ma la colpa esiste solo in virtù della pena che la sancisce. La sanzione non è accessoria alla legge: la legge consiste essenzialmente nella sanzione".
- Ne "Il Nome della Rosa", Eco racconta che il volume riguardante la commedia di Aristotele non ci è mai giunto perché trattava del riso e il riso crea disordine. In "Karman", lei (come già Guglielmo da Baskerville) lo deduce dal volume sulla tragedia e ipotizza pure che Aristotele non lo abbia mai scritto per muovere una critica a Platone. Quale?
"In Grecia il concetto di un’azione colpevole viene elaborato per la prima volta attraverso una riflessione sull’eroe tragico. È quello che fa Aristotele nella Poetica quando scrive che la felicità consiste nell’azione e che nella tragedia gli uomini non agiscono per imitare i caratteri, ma assumono liberamente il loro personaggio attraverso le azioni. Anche se Aristotele non ha completato la sua trattazione della commedia, possiamo dedurne che il personaggio comico agisce invece per imitare il suo carattere e che per questo le sue azioni non possono essergli mai imputate come una colpa. Platone, che teneva sotto il cuscino non le tragedie, ma i mimi di Sofrone, fa dire al suo eroe antitragico, Socrate, che "nessuno fa il male volontariamente", il che implica l’impossibilità della tragedia".
- La filosofia s’interessa prima di tutto dell’essere, ma l’essere appare subito con le sue "qualità": possibilità, contingenza e necessità. Lei osserva che è necessario riflettere sull’utilizzo che la filosofia fa dei verbi modali: " posso", " voglio", " devo". Mi segua in un passaggio di certo azzardato. La lingua della politica, aderendo (talvolta pure nei corpi) a quella televisiva, ha progressivamente abolito le subordinate, le " qualità" della frase: modali, temporali, causali. Senza queste "qualità" siamo costretti a un parlare ( e a un agire) privi di conseguenze. C’è modo di mantenere la complessità del linguaggio e non rimanere chiusi nel presente indicativo (e televisivo) dello stare al mondo?
"Se la sua domanda è di ordine poetico-letterario, allora le rispondo con le tarde poesie di Hölderlin, in cui i nessi sintattici sono aboliti e sospesi e nel verso sembrano sopravvivere solo i nomi nel loro isolamento (a volte, anche solo una particella: aber, che significa "ma"). Vi è nella poesia una tradizione, da Arnaut Daniel a Mallarmé, che tende ostinatamente non alla frase, ma al nome - anzi, forse in ultima analisi ogni poesia non è che una tensione verso il nome, che per definizione è sottratto a ogni articolazione modale. Se la sua domanda è di ordine etico-politico, le risponderei allora che si tratta di disfare il nesso perverso tra i tre verbi modali che Kant ha messo a fondamento della sua etica: "si deve poter volere". Questa frase mostruosa è il condensato parodico dei dispositivi che il mio libro cerca di disattivare".
- Sulla quarta di copertina si legge "Giorgio Agamben ha insegnato Filosofia teoretica... è stato visiting professor...". Se le chiedessi cenni biografici al tempo presente?
"Le risponderei spinozianamente: "contempla ciò che può e ciò che non può fare". Ho sempre amato il motto meraviglioso di van Eyck: "Als ich kann", "come posso". Conoscere i propri limiti significa conoscere la misura della propria potenza e della propria impotenza".
*
SCHEDA EDITORIALE
- GIORGIO AGAMBEN
- KARMAN
- BREVE TRATTATO SULL’AZIONE, LA COLPA E IL GESTO
«Il soggetto dell’azione non è che l’ombra portata che il fine getta dietro di sé». Azione e colpa sono concetti-soglia, a tal punto fondativi del pensiero giuridico, morale e politico dell’Occidente da rimanere oscurati dalla loro stessa costitutività. Il carattere liminare di entrambi viene però in luce non appena si rifletta sulla corrispondenza stringente tra il latino crimen, che designa l’azione umana in quanto imputabile e sanzionata, ossia chiamata in causa nell’ordine della responsabilità e del diritto, e il sanscrito karman, che contrassegna l’agire generatore di conseguenze.
 Con mossa disvelatrice, Giorgio Agamben individua nel karman/crimen la chiave di volta indoeuropea senza la quale crollerebbero sia l’edificio dell’etica e della politica occidentali sia il soggetto libero e responsabile che ne è il presupposto e l’effetto. Questa archeologia pragmatica, più che gnoseologica, della soggettività, rende evidente quanto la presa dell’azione sanzionata sull’agente si rinsaldi sempre più proprio nel momento in cui - con la patristica - la nozione di libero arbitrio intende assicurare la sovranità della volontà, spodestando il primato aristotelico della potenza.
Con mossa disvelatrice, Giorgio Agamben individua nel karman/crimen la chiave di volta indoeuropea senza la quale crollerebbero sia l’edificio dell’etica e della politica occidentali sia il soggetto libero e responsabile che ne è il presupposto e l’effetto. Questa archeologia pragmatica, più che gnoseologica, della soggettività, rende evidente quanto la presa dell’azione sanzionata sull’agente si rinsaldi sempre più proprio nel momento in cui - con la patristica - la nozione di libero arbitrio intende assicurare la sovranità della volontà, spodestando il primato aristotelico della potenza.
 Secondo Agamben, non si riuscirà a inceppare il dispositivo volontà-azione-imputazione se non si uscirà dal paradigma della finalità: contro la signoria dei fini va ripensata una politica di mezzi puri, che già Benjamin affidava al gesto inoperoso, capace di disattivare le opere umane e destinarle «a un nuovo, possibile uso».
Secondo Agamben, non si riuscirà a inceppare il dispositivo volontà-azione-imputazione se non si uscirà dal paradigma della finalità: contro la signoria dei fini va ripensata una politica di mezzi puri, che già Benjamin affidava al gesto inoperoso, capace di disattivare le opere umane e destinarle «a un nuovo, possibile uso».
-